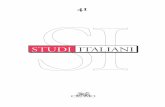CASTIGLIA 2015b, "Scavi della regione di Orfeo. I reperti ceramici", in Rivista di Archeologia...
Transcript of CASTIGLIA 2015b, "Scavi della regione di Orfeo. I reperti ceramici", in Rivista di Archeologia...
SCAVI DELLA REGIONE DI ORFEO:I REPERTI CERAMICI
PREMESSA
I lavori di consolidamento eseguiti nel 2012 e lo scavo con-dotto nell’estate del 2013 presso le catacombe di Priscilla, sotto la direzione della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, nella figura del professor Fabrizio Bisconti, hanno restituito un discre-to quantitativo di reperti ceramici, che vengono qui presentati in maniera preliminare.
Ne consegue una breve premessa sull’articolazione che il pre-sente contributo avrà, rimandando comunque alle considerazioni (proposte in questi stessi atti dal dott. Matteo Braconi, direttore scientifico sul campo dello scavo stratigrafico) inerenti sia la natu-ra dell’intervento archeologico che la struttura della pubblicazione delle differenti classi di materiali: dal momento che si tratta, per tutte le tipologie di rinvenimento, di una pubblicazione, si tiene a ribadirlo, di carattere preliminare, non verranno di seguito pro-poste schede dettagliate dei singoli pezzi, ma, piuttosto, si mirerà ad offrire una panoramica generale sugli stessi, tentando di in-quadrare quegli elementi che possano fornire un appiglio crono-logico inerente sia le stratigrafie in deposizione primaria che quel-le in deposizione secondaria. Ciononostante, i frammenti ritenuti particolarmente diagnostici verranno presentati anche con dei di-segni, in modo da avere primi importanti riferimenti crono-tipo-logici, preparatori per una futura ed auspicata pubblicazione dei materiali e dello scavo tout court.
IL CORREDO CERAMICO: UN PANORAMA ETEROGENEO
L’aspetto che, fin da subito, appare caratterizzante la natura della cultura materiale intercettata è quello di uno spettro di pro-duzioni assolutamente vario ed eterogeneo, che presenta non so-lo una forchetta cronologica estremamente ampia, ma anche una gamma tipologica molto varia ed articolata: questo aspetto è sicu-ramente dettato dal fatto che nel corso dello scavo sia stato possi-bile documentare numerosi sconvolgimenti nel deposito stratigra-fico primario, apportati sia in età moderna-contemporanea, che,
RACr 90 (2014), pp. 225-240.
226 GABRIELE CASTIGLIA
come sembrerebbe dallo studio iniziale del corredo ceramico, an-che alle soglie dell’alto medioevo1.
Il primo elemento su cui è importante porre risalto è legato al-la decisa preponderanza percentuale di elementi pertinenti a con-tenitori anforici, che costituiscono circa il 60% del totale dei re-perti, proponendo un’interessante e stringente analogia con il de-posito intercettato nella regione della “Velata”, nella stessa cata-comba di Priscilla, ove le anfore costituivano il 65% dei frammenti ceramici2.
Risultano, però, essere quantitativamente ridotti i cocci di ca-rattere chiaramente diagnostico, quantunque interessanti conside-razioni possano essere proposte anche per quelli che apparente-mente sembrerebbero avere un’identificazione più problematica: il panorama dei contenitori da trasporto, infatti, risulta afferente pre-cipuamente a produzioni di matrice nord-africana, la cui natura è desumibile in alcuni casi dalle peculiarità morfologiche (laddo-ve si abbia la presenza di orli, fondi o anse) ed in altri dalla na-tura degli impasti, che, in un ambito che potremmo definire “ma-ghrebino”, emergono come aspetti molto caratterizzanti e al tem-po stesso caratteristici della regione stessa.
Tra le anfore che si possono identificare con certezza, si an-novera la parte terminale di un contenitore (con fondo a puntale piatto), afferente alla tipologia Africana 1 Piccolo (fig. 1-C) (nota anche, secondo altri sistemi di classificazione, come Beltrán 57, Keay 3, Ostia 4 o Peacock, Williams 33), prodotta in numerose of-ficine dislocate nei pressi di Hadrumetum, Leptiminus, Sullecthum, Acholla, Thaenae, solo per citare i contesti più importanti3. Questo contenitore, la cui destinazione primaria era connessa al traspor-to di olio d’oliva4, ha una cronologia compresa tra il II ed il IV sec. d.C. e, in areale romano-laziale, se ne documentano impor-tanti quantitativi ad Ostia presso le Terme del Nuotatore5.
Ad una produzione del medesimo comparto territoriale sem-brerebbero appartenere alcune pareti (rinvenute frammentarie, ma comunque pertinenti al medesimo reperto, in quanto contigue tra loro), ascrivibili al tipo Africana 2C Grande (nota anche come Keay
1 Per quanto concerne la relazione inerente la sequenza stratigrafica si ri-manda al contributo del dott. Matteo Braconi in questi stessi Atti.
2 BISCONTI, NUZZO 2001, p. 19.3 Per le officine produttive di tali contenitori si rimanda a BONIFAY 2004, in
particolar modo alle pp. 9-44.4 Per le notazioni sulla natura del contenuto di questa tipologia anforica si
veda PANELLA 1982.5 PANELLA 1973; MANACORDA 1977.
SCAVI DELLA REGIONE DI ORFEO: I REPERTI CERAMICI 227
6), le cui officine si attestano principalmente nella Zeugitana6: que-sta tipologia è di dimensioni piuttosto ingenti e di forma cilindri-ca, probabilmente destinata allo stoccaggio e trasporto di salse di pesce (garum) e si muove in un ambito cronologico che abbrac-cia il III ed il IV secolo d.C.7, pertanto coevo a quello della Afri-cana 1 Piccolo (vedi supra). Sempre tra le tipologie inquadrabili secondo la denominazione di “Africana” si riscontra la presenza di un bordo (e di parte delle pareti), conservato per circa il 50% del proprio diametro, di un Africana 2C Grande (fig. 1-B), pro-dotta principalmente nella Zeugitana8, da indirizzare in una crono-logia di pieno III secolo d.C.
Restando in Nord Africa, un ulteriore reperto sembrerebbe ri-mandare a tale bacino produttivo: il frammento si preserva sola-mente nel fondo e in parte nelle pareti e, pertanto, la sua identi-ficazione non può essere considerata diagnostica al cento per cen-to, ma morfologia e caratteristiche dell’impasto lascerebbero ipo-tizzare con poco scarto di errore una sua pertinenza alla tipologia Dressel 30 (Keay 1b), anch’essa attinente ad officine maghrebine (sebbene allo stato attuale degli studi non siano state ancora iden-tificate archeologicamente delle fornaci ad essa dedicate) e, anco-ra una volta, circoscrivibile in un contorno cronologico di III-IV sec. d.C., finalizzata al trasporto di vino. In particolar modo, que-st’anfora (che ancora una volta si palesa in numerosi esemplari ad Ostia, alle Terme del Nuotatore9) può essere attribuita alla provin-cia della Mauretania Caesarensis, dal momento che, sovente, nelle anse (ove si preservino), si rileva l’iscrizione ex provinc/Mauretan/Caes10, che lascia pochi dubbi sulla zona di origine del contenitore.
Un altro esemplare anforico di tipologia cilindrica e grandi di-mensioni è denunciato dalla sussistenza di un’ansa, ben conservata, che sembrerebbe essere paradigma indiziario di un altro prodotto africano, ossia la Keay 40, anch’essa di origine tunisina11 e desti-nata a contenere probabilmente olio d’oliva, sebbene con una cro-nologia leggermente più bassa rispetto alle classificazioni sinora do-
6 BONIFAY 2004, pp. 9-44.7 PANELLA 19738 BONIFAY 2004, pp. 9-44; è però importante sottolineare come studi più re-
centi abbiano identificato centri produttivi, sebbene di minor scala, della mede-sima tipologia in Baetica, in particolar modo nella valle del Guadalquivir (KEAY, CREIGHTON, REMESAL RODRIGUEZ 2001, p. 118).
9 PANELLA 1973; MANACORDA 1977.10 KEAY 1984, p. 96: lo studioso rileva inoltre come sia frequente anche la
dizione ex provinc/Mauretan/Caes. Tub, interpretando la parola Tub. come rife-rimento alla città di Tubusuptu nella Mauretania Caesarensis, attuale Tiklat, in Algeria.
11 BONIFAY 2004, pp. 9-44.
228 GABRIELE CASTIGLIA
cumentate nelle stratigrafie, dal momento che in questo caso la sua produzione e diffusione si certifica nel corso del IV-V sec. d.C.12.
Proseguendo nell’analisi dei reperti ceramici, e rimanendo nel-l’ambito delle anfore, risulta essere ancora oltremodo ficcante e preponderante la presenza di manufatti africani, circoscrivibili nel-la loro quasi totalità al medesimo ambito cronologico, come di-mostrato anche da un frammento di Keay 27 (fig. 1-A) (la quale,
12 KEAY 1984, pp. 251-252.
Fig. 1 – A) Frammento di Keay 27; B) Frammento di Africana 2C Grande; C) Frammento di Africana 1 Piccolo.
SCAVI DELLA REGIONE DI ORFEO: I REPERTI CERAMICI 229
invero, gode di una diacronia piuttosto ampia, articolata tra IV e VI sec. d.C.13). Sempre di ambito africano, quantunque non chia-ramente attribuibile ad un modello ben preciso, risulta essere il puntale di un anfora, pieno, stretto ed allungato, terminante con base cosiddetta “a bottone”, che denuncia strette affinità morfolo-giche con produzioni tunisine databili nel IV-V secolo d.C.14.
Per concludere con i contenitori da trasporto, due pareti, con-servate invero in dimensioni piuttosto limitate, sembrano affac-ciarsi verso gli estremi lidi orientali del Mediterraneo, discostan-dosi dunque dal trend maggioritario delle officine africane: en-trambe sono presumibilmente da ricollegare alla tipologia Late Roman 1 (è molto plausibile che i due frammenti, sebbene non siano contigui, fossero afferenti alla medesima forma), manifattu-ra di origine cipriota, con fornaci note anche in Cilicia15, con cro-nologia più bassa rispetto agli altri frammenti rinvenuti nel cor-so dello scavo, inquadrandosi tra V e VI secolo d.C. Si vuole ri-marcare come, però, si tratti, come già evidenziato, solamente di due frammenti che non risultano essere completamente diagno-stici (non trattandosi di orli, fondi o anse) e che, dunque, la loro attribuzione alla tipologia Late Roman 1 debba essere comunque affrontata con una certa prudenza, sebbene l’impasto e le carat-teristiche scanalature esterne siano abbastanza identificative del-la produzione in questione.
Distaccandosi dai contenitori anforici, si ravvisa tuttavia il persistere dell’ulteriore e significativa presenza di vasellame afri-cano, esemplificato in particolar modo da un bordo, ben preser-vato, di una scodella in sigillata africana: si tratta della tipologia Hayes 68 (fig. 2), forma piuttosto rara, attribuibile alla produzio-ne D16, e databile molto precisamente tra il 370 ed il 425 d.C.17, sulla quale si ritornerà brevemente in seguito, nelle considerazio-ni conclusive.
Fino ad ora, come ben desumibile dai materiali descritti, è chiaramente percepibile che il contorno cronologico in cui si artico-la il contesto si circoscriva nell’ambito del IV secolo d.C., più se-
13 Il Peacock propende per una maggiore diffusione nel corso del V sec. d.C. (PEACOCK 1982).
14 Un confronto stringnete, anche per il livello di conservazione del frammen-to, si ha in DE MARINIS 1990, p. 265 (tipologia A. 57), tav. 65, n. 111.
15 Per una recente ed aggiornata sintesi si veda DEMESTICHA 2014.16 Si veda POLITO 2000, in particolar modo alle pp. 32 e 42, ove si conferma
la rarità dell’attestazione di tale forma, nonché l’oscillazione della sua attribu-zione alternativamente alla produzione D o alla E.
17 HAYES 1972, fig. 20, n. 7.
230 GABRIELE CASTIGLIA
gnatamente nella sua seconda metà e verso il suo traguardo, ma, come già suggerito all’inizio di questo contributo, sia dalla lettura delle stratigrafie che dalla preliminare analisi dei corredi ceramici, risultano essere significativi anche gli interventi che andarono a sconvolgere la giacitura primaria del deposito. Essi possono esse-re inquadrati in due grandi blocchi cronologici (quantunque uno studio più avanzato dei reperti datanti potrà essere foriero di ulte-riori e più ristrette scansioni diacroniche), uno attestabile in epo-ca altomedievale e un altro in epoca moderna-contemporanea.
Per quanto concerne la frequentazione attribuibile ai secoli im-mediatamente post-romani, essa viene denunciata dall’orlo di un contenitore da cucina, in acroma grezza, plausibilmente un’olla (fig. 3), che per confronti tipologico-morfologici, rimanda ad un ambito di VI-VII secolo d.C.18. A tal proposito, però, si ritiene op-
18 In ambito romano-laziale confronti morfologici affini si attestano alla Crypta Balbi (RICCI 1998, p. 354, fig. 2, n. 9), e a Portus (COLETTI 1998, p. 405, fig. 8, n. 6).
Fig. 3 – Olla da fuoco, databile al VI-VII secolo d.C.
Fig. 2 – Frammento di sigillata africana, tipologia Hayes 68.
SCAVI DELLA REGIONE DI ORFEO: I REPERTI CERAMICI 231
portuno fare una breve digressione inerente le problematiche re-lative alle attribuzioni crono-tipologiche della ceramica da cucina, in quanto, sebbene gli studi sulle acrome grezze siano ormai am-piamente sviluppati, non sia sempre possibile circoscriverne con precisione assoluta la pertinenza cronologica, sia perché le forna-ci note siano scarsamente conosciute, sia perché si configurino come prodotti tecnologici sovente ancorati ad officine regionali o sub-regionali, ormai sganciati da un sistema produttivo su lar-ga scala e, di conseguenza, forieri di una limitata ampiezza nella gamma dei confronti; ciononostante, però, grazie allo stato avan-zato delle pubblicazioni inerenti questa classe19, è possibile pro-porre un’attribuzione di questo frammento al contorno cronologi-co sopra proposto che, pertanto, si attesta nei secoli iniziali del-l’altomedioevo, consentendo di documentare una frequentazione, sebbene non ancora ben definibile nei propri assetti, seriore alla prima utilizzazione del contesto indagato. Un ulteriore indizio che sembrerebbe andare a confermare un utilizzo dell’area nei secoli iniziali dell’altomedioevo è proposto dal rinvenimento di una cas-seruola in acroma grezza, preservata quasi interamente, che ad un primo studio indicherebbe la sua pertinenza alla medesima forbice diacronica dell’olla già descritta (vedi supra), ossia in uno spazio descritto tra VI e VII sec. d.C.
Lo stesso ambito cronologico viene testimoniato da un fiasca in acroma depurata (fig. 4) che, seppur non conservata in toto, è ben definibile grazie all’identificazione del collo e del bordo, resti-tuiti nella loro interezza, con la caratteristica morfologia tronco-conica (lisciata all’esterno e con scanalature interne), che trova stringenti confronti con i depositi di VII secolo d.C. della Crypta Balbi, ove tali tipologie sono ben presenti: nel caso del frammento rinvenuto a Priscilla si documentano quasi esclusivamente il collo ed il bordo, mentre ben poco rimane del corpo che, solitamente, si distingue, soprattutto nelle spalle, per modelli decorativi incisi a pettine, sia orizzontali che ondulati20.
Il secondo momento di grandi interventi viene a discostarsi da una vera e propria “frequentazione”, nel senso in cui viene normal-mente intesa nella letteratura archeologica, dal momento che alcu-
19 Sebbene si tratti in entrambi casi di pubblicazioni abbastanza datate, pun-ti di riferimento ancora imprescindibili sono SAGUÌ 1998 e PATITUCCI UGGERI 2004, in particolar modo il secondo per quanto concerne la ceramica da fuoco.
20 RICCI 1998, pp. 374-375: in questo contributo l’autore sottolinea come gli esemplari con collo troncoconico e spalla/corpo ovoidali possano essere attribu-ti a produzioni legate all’Italia meridionale, precipuamente rilevabili nella zona dello stretto di Messina, dunque di ambito calabrese/siculo.
232 GABRIELE CASTIGLIA
ni dei materiali sembrerebbero rimandare alle prime attività di ri-scoperta del cimitero (escludendo quelle di Pomponio Leto nel XV secolo21), avvenute con le esplorazioni del De Winghe e del Ciac-conio a partire dal 1590 d.C., seguite da quelle del Bosio, passan-do per quelle del Boldetti e del Marangoni, fino al de Rossi22.
Il rinvenimento di un discreto quantitativo di maiolica post-medievale, segnatamente di epoca rinascimentale23, potrebbe essere afferente a tali frequentazioni, sebbene se ne debba attendere uno studio più approfondito per una miglior scansione delle cronologie e delle tipologie; di grande interesse è inoltre la presenza di un’ansa di un contenitore, probabilmente un boccale, afferente alla classe ceramica nota come slip ware (fig. 5), caratterizzata da elementi decorativi molto semplici, in ingobbio giallo, sotto invetriatura24. Questa produzione si attesta in un contorno cronologico piuttosto vasto, abbracciando, seppur, come ovvio, con differenze a seconda
21 GIULIANI 2013, p. 8.22 Per una sintetica storia degli studi sulle prime indagini nel complesso pri-
scilliano si veda ancora GIULIANI 2013, pp. 8-9.23 Per una panoramica sulla maiolica rinascimentale e moderna si rimanda
a RICCI 1985.24 Testo di riferimento per questa classe ceramica è ancora COOPER 1968.
Fig. 4 – Fiasca in acroma depurata, databile al VII secolo d.C.
SCAVI DELLA REGIONE DI ORFEO: I REPERTI CERAMICI 233
dei secoli e delle zone, una produzione-diffusione che spazia dal XVI fino al XIX-XX secolo d.C.25. Se ne rilevano centri produttivi dislocati soprattutto nell’Italia centro-settentrionale, con una no-tevole concentrazione nella zona del delta del Po, in Toscana, ma anche in areale romano26 e si desidera porre in rilievo il rinveni-mento di questo (seppur limitato) frammento perché nel dibattito italiano, perlomeno sino agli anni Settanta-Ottanta del XX secolo, la slip ware ha goduto di un’attenzione alquanto settoriale.
RIFLESSIONI A MARGINE SU UN VASETTO MINIATURISTICO
Alcune riflessioni a parte merita un vasetto di limitatissime di-mensioni (fig. 6), che rientra con pieno diritto nella macro-catego-ria che, in letteratura, viene definita dei “vasetti miniaturistici”27.
Anche in tal caso si ritiene opportuno affermare la natura an-cora del tutto introduttiva di questo studio, che verrà approfondito
25 COOPER 1968.26 Si vedano PANNUZI 2000 e PANNUZI 2001.27 Per quanto concerne l’identificazione del pezzo, desidero ringraziare, per i
loro preziosi consigli, il dott. Massimo Brando (archeologo libero professionista, tra i massimi esperti italiani sulla ceramica romana, nonché fondatore e coordi-natore del gruppo “Ceramica in archeologia – Pottery in Archaeology”) ed il dott. Alessandro Bona, specializzando presso l’Università Cattolica di Milano.
Fig. 5 – Frammento di ansa di slip ware.
234 GABRIELE CASTIGLIA
e raffinato in seguito, ma, nonostante ciò, questo reperto merita alcune rilevanti osservazioni: la tipologia del vasetto, caratterizzato da due piccole anse e da piede svasato, troncoconico, ricorda per certi aspetti i cosiddetti vasetti ovoidi o piriformi di Ostia28, sebbene questi ultimi si distinguano per la costante assenza di prese o anse e per la mancanza di rivestimento che, invece, nel caso del nostro esemplare, è presente sotto forma di ingobbio arancione piuttosto evanide, di bassa qualità e poco coprente. Gli esemplari ostiensi29 rimandano inoltre ad una cronologia piuttosto ampia, che si estende dall’epoca tiberiana fino al III secolo d.C., mentre il rinvenimento documentato a Priscilla sembra, ad una prima analisi, attestarsi in una fase più tarda, plausibilmente di IV-V secolo d.C.: tale esegesi è confortata dalla minor qualità realizzativa del pezzo, piuttosto asimettrico, nonché dalla scadente peculiarità della patina di in-gobbio, che si riallaccia ad un orizzonte tipicamente tardoantico; inoltre, esemplari simili, sovente afferenti a contesti funerari (come del resto risulta essere anche nel caso sotto esame), si documenta-no con cronologia analoga in numerosi contesti di area romana30.
28 PAVOLINI 1980.29 PAVOLINI 1980 e Ostia XIII.30 Si rimanda in generale a Roma dall’antichità al medioevo.
Fig. 6 – “Vaso miniaturistico” rinvenuto nel corso dello scavo.
SCAVI DELLA REGIONE DI ORFEO: I REPERTI CERAMICI 235
CONSIDERAZIONI FINALI
Ribadendo il principio per cui si tratti di un’analisi ancora ad uno stadio assolutamente preliminare, ne deriva che risultereb-be fuorviante, nonché metodologicamente scorretto, proporre del-le considerazioni conclusive, ad ora ancora premature. Nonostan-te ciò, però, i dati a nostra disposizione si rivelano depositari di un bacino informativo di notevole spessore, in primis dal punto di vista cronologico, ma anche per quanto concerne l’articolazione dei corredi.
L’elemento preponderante e caratterizzante i materiali cerami-ci provenienti dai livelli in deposizione primaria è costituito dalla netta predominanza delle anfore (come già evidenziato) che nel-la maggior parte dei casi afferiscono a produzioni di origine nord africana: l’aspetto di maggior interesse, soprattutto per finalità di datazione del bacino stratigrafico, è però indubbiamente costituito dallo spettro cronologico denunciato dagli stessi contenitori anfo-rici, che oscilla prevalentemente nel IV-V secolo d.C. (con spora-diche e limitate puntate nel VI) ma che, grazie al frammento di scodella in sigillata africana tipo Hayes 68, vero e proprio fossile guida (come del resto la stragrande maggioranza del vasellame di questa classe), consente di essere ristretto e tarato nella seconda metà del IV secolo, più precisamente nei suoi decenni finali (for-se fino ai primissimi anni del V).
Se le considerazioni di ordine cronologico sembrano parlare un linguaggio abbastanza omogeneo ed univoco, rimane da spie-gare il perché dell’assoluto tasso maggioritario delle anfore rispet-to alle altre classi, che trova un’analogia, già valorizzata nella par-te inziale di questo intervento, con le restituzioni materiali testi-moniate dalle indagini archeologiche, sempre nel cimitero di Pri-scilla, nella zona della “Velata”31. Se tale aspetto, da un lato, po-trebbe sembrare scontato ed in qualche modo poco rilevante nel-le dinamiche deposizionali del contesto, a parere di chi scrive, in realtà, sarebbe un fenomeno da approfondire, sia a livello sito-cen-trico che a livello più ampio: infatti, purtroppo, lo stato di avan-zamento degli studi dei reperti ceramici nelle catacombe romane è, dal punto di vista meramente quantitativo, ad un punto piut-tosto arretrato, mentre un’analisi dettagliata delle forme utilizzate nei cimiteri costituirebbe una banca dati “in potenza” di enorme varietà ed efficacia informativa sulle modalità di fruizione “quoti-diana” delle gallerie e dei cubicoli.
31 BISCONTI, NUZZO 2001, p. 19.
236 GABRIELE CASTIGLIA
Ritornando brevemente sul frammento di sigillata africana, for-ma Hayes 68, può essere proposta un’interessante analogia con un altro contesto, se non altro, perlomeno dal punto di vista crono-logico: come già evidenziato, la forma in questione gode di una possibilità di datazione piuttosto precisa, articolandosi tra il 370 ed il 425 d.C. (vedi supra), proponendo una significativa simme-tria diacronica con il piatto, sempre in sigillata africana, rinvenu-to nella mensa del cubicolo Ib di Pretestato32, di tipologia Hayes 61 (Lamboglia 54), databile tra 355 e 420 d.C.33. Il reperto rin-venuto nel cimitero della Via Appia è legato, con malta, diretta-mente alla faccia superiore della mensa e, dunque, ne consegue una sua immediata attribuzione funzionale come elemento diret-tamente connesso con il refrigerium; stessa cosa, ovviamente, non si può affermare per l’esemplare rinvenuto a Priscilla, ma si ri-tiene lecito proporre alcune riflessioni al riguardo, riallacciandosi alla problematica, già suggerita tra le righe, di una scarsa atten-zione prestata (non sempre, ma sovente) all’approfondimento del-la funzionalità e dei vettori di utilizzazione del vasellame “quoti-diano” nei contesti funerari ipogei. Il frammento di Hayes 68 in-tercettato nelle stratigrafie del nostro scavo, rispetto a quello di Pretestato, innanzitutto non è integro e, in secundis, non è diret-tamente messo in opera su una mensa, né tantomeno sembra pre-sentare tracce di malta nella sua faccia inferiore. Cionondimeno, però, la cronologia delle due stoviglie è assolutamente analoga e, in un’ottica di percezione funzionale dei reperti più “umili”, come sono spesso considerati quelli ceramici, non sembra così fuorvian-te ritenere che, probabilmente, la presenza di elementi come piat-ti e scodelle potesse essere afferente alle pratiche del refrigerium, pista interpretativa che si vuole suggerire, sebbene con prudenza, anche per il reperto qui identificato.
La cultura materiale è inoltre spia di stadi di frequentazione che andarono ad insistere sul deposito nel corso del VI-VII secolo d.C., quantunque si debba rilevare come le forme e i modi di tale antropizzazione in queste fasi, ormai segnatamente altomedievali, debbano ancora essere chiariti e compresi, non tanto dal punto di vista della cultura materiale in se, che, sebbene in quantitativi piuttosto modesti, parla chiaramente un linguaggio già post-anti-co, quanto piuttosto per quanto concerne gli assetti, le motivazio-ni, le modalità, insomma la fenomenologia evenemenziale. Non si può escludere invero che la presenza di reperti di questa cronolo-gia possa essere di natura “intrusiva”, ma anche in tal caso que-
32 SPERA 2004, pp. 240-241; p. 246; figg. 241-242.33 Atlante I, Tav. XXXV.
SCAVI DELLA REGIONE DI ORFEO: I REPERTI CERAMICI 237
sta eventuale traccia esegetica andrebbe spiegata e compresa con maggior chiarezza, onde comprendere, se di intrusioni si trattò, da dove derivarono.
Un ragionamento analogo potrebbe essere affrontato per quan-to concerne le stratificazioni contenenti cultura materiale ampia-mente post-medievale (come la maiolica rinascimentale) oppure già post-rinascimentale (la slip ware) che, se è pur vero che potrebbe-ro essere di natura intrusiva, sembrerebbe più plausibile riconnet-terle a quei momenti di riscoperta del cimitero (vedi supra) che a tutti gli effetti andarono a costituire vere e proprie “frequentazio-ni”, lasciando tracce tangibili anche dal punto di vista più stret-tamente “quotidiano”.
Per concludere (o meglio, vista la natura programmatica del contributo, per tracciare le fila di idee ancora in fase embrionale) si ritiene di poter affermare che l’aspetto di maggior rilievo che si può evincere dai corredi ceramici sia indubbiamente la presen-za, chiara, di una fase ben definita (anche dalla stratigrafia e dal contesto in generale, come si vedrà negli altri contributi presenti in questi atti inerenti il complesso priscilliano) di fine IV-inizi V secolo d.C., testimoniata dagli ingenti quantitativi di anfore ben databili, dalla sigillata africana, ma anche dall’articolazione di tut-to il contesto topografico (elemento di significativa rilevanza per un inquadramento in tale cronologia è fornito anche da due cri-stogrammi incisi sui nastri di malta, per cui si rimanda agli altri contributi, che vanno a configurarsi come un terminus post quem di indubbia affidabilità), che si viene ad innestare, dunque, in un momento piuttosto tardo, all’interno di uno dei contesti cimiteriali di più antica frequentazione della Roma christiana tutta.
GABRIELE CASTIGLIA
238 GABRIELE CASTIGLIA
BIBLIOGRAFIA
Atlante I = Atlante delle forme ceramiche, I. Ceramica fine romana nel bacino me-diterraneo (medio e tardo Impero), suppl. all’Enciclopedia dell’arte antica, Roma, 1981.
BISCONTI, NUZZO 2001 = F. BISCONTI, D. NUZZO, Scavi e restauri nella regione della “Velata” in Priscilla, in RACr, 77 (2001), pp. 7-95.
BISCONTI, GIULIANI, MAZZEI 2013 = F. BISCONTI, R. GIULIANI, B. MAZZEI (ed.), La cata-comba di Prisicilla. Il complesso, i restauri, il museo, Todi 2013.
BONIFAY 2004 = M. BONIFAY, Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique, Oxford 2004.
COLETTI 1998 = C. M. COLETTI, Ceramiche comuni dai contesti di Porto (VI e VII secolo), in L. PAROLI, A. MARTIN, C. PAVOLINI, B. CIAROCCHI, C. M. COLETTI, Ceramica comune tardoantica da Ostia e Porto (V-VII secolo), pp. 401-417, in L. SAGUÌ (ed.), Ceramica in Italia. VI-VII secolo, Atti del convegno in ono-re di John W. Hayes (Roma, 11-13 maggio 1995), Firenze 1998, pp. 383-420.
COOPER 1968 = G. COOPER, English slipware dishes. 1650-1850, London 1968.
DE MARINIS 1990 = G. DE MARINIS, Archeologia urbana a Fiesole. Lo scavo di Via Marini-Via Portigiani, Firenze 1990.
DEMESTICHA 2014 = S. DEMESTICHA, Late Roman Amphora tipology in context, in N. POULOU-PAPADIMITRIOU, E. NODAROU, V. KILIKOGLOU (ed.), LRCW4. Late Ro-man Coarse Wares, Cooking wares and amphorae in the Mediterranenan. Ar-chaeology and Archaeometry. The Mediterranean: a market without frontiers, Oxford 2014, pp. 599-606.
FULFORD, PEACOCK 1982 = M. G. FULFORD, D. P. S. PEACOCK (ed.) Excavations at Carthage. The British Mission: The Avenue du President Habib Bourguiba, Sa/ambo: The Pottery and Other Ceramic Objectsfrom the Site, Sheffield 1982.
GIULIANI 2013 = R. GIULIANI, Il complesso di Priscilla, in F. BISCONTI, R. GIULIANI, B. MAZZEI (ed.), La catacomba di Prisicilla. Il complesso, i restauri, il museo, Todi 2013, pp. 3-36.
HAYES 1972 = J. W. HAYES, Late Roman Pottery, Rome 1972.
KEAY 1984 = S. J. KEAY, Late Roman amphorae in the Western Mediterranean. A typology and economic study: the Catalan evidence, Oxford 1984.
KEAY, CREIGHTON, REMESAL RODRIGUEZ 2001 = S. KEAY, J. CREIGHTON, J. REMESAL RO-DRIGUEZ, Celti (Peñaflor): la arqueologia de una ciudad Hispanorromana en la Baetica: Prospecciones y excavaciones 1987-1992, Seville 2001.
MANACORDA 1977 = D. MANACORDA, Anfore, in Ostia IV in Studi Miscellanei, 23 (1977), pp. 117-254.
MANACORDA 1985 = D. MANACORDA (ed.), Il giardino del conservatorio di Santa Ca-terina della Rosa (Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi 3/1-2), Firenze 1985.
Ostia XIII = C. PAVOLINI, G. PREDIERI, S. SFRECOLA (ed.), Scavi di Ostia. Vol. XIII: la ceramica comune. Le forme in argilla depurata dell’antiquarium, Roma 2000.
SCAVI DELLA REGIONE DI ORFEO: I REPERTI CERAMICI 239
PANELLA 1973 = C. PANELLA, Appunti su un gruppo di anfore della prima, media e tar-da età Imperiale, in Ostia III, in Studi Miscellanei, 21 (1973), pp. 460-633.
PANELLA 1982 = C. PANELLA, Le anfore africane della prima, media e tarda età im-periale: tipologia e problemi, in Actes du colloque sur la céramique antique (Carthage, 23-24 juin 1980), Tunisi 1982, pp. 71-186.
PANNUZI 2000 = S. PANNUZI, Produzione e consumo a Roma di ceramica invetriata da fuoco tra XVI e XVIII secolo, in II Congresso Nazionale di Archeologia Me-dievale (Brescia, 28 settembre - 1 ottobre 2000), Firenze 2000, pp. 453-461.
PANNUZI 2001 = S. PANNUZI, Una fornace per ceramica invetriata a Roma tra XVII e XVIII secolo: “la fornace delle Pile” in via della Consolazione, in Archeolo-gia Postmedievale, 5 (2001), pp. 169-201.
PATITUCCI UGGERI 2004 = S. PATITUCCI UGGERI, La ceramica altomedievali in Italia. Atti del V congresso di Archeologia Medievale (Roma, CNR, 26-27 novembre 2001), Firenze 2004.
PAVOLINI 1980 = C. PAVOLINI, Appunti sui “vasetti ovoidi e piriformi” di Ostia, in MEFR, Antiquité, 92 (1980), pp. 993-1020.
PEACOCK 1982 = D. P. S. PEACOCK, The Amphorae: Typology and Chronology, in M. G. FULFORD, D. P. S. PEACOCK (ed.) Excavations at Carthage. The British Mis-sion: The Avenue du President Habib Bourguiba, Sa/ambo: The Pottery and Other Ceramic Objectsfrom the Site, Sheffield 1982, pp. 116-140.
POLITO 2000 = A. POLITO, La ceramica sigillata africana da Agrigento e dal territo-rio, Agrigento 2000.
POULOU-PAPADIMITRIOU, NODAROU, KILIKOGLOU 2014 = N. POULOU-PAPADIMITRIOU, E. NODAROU, V. KILIKOGLOU (ed.), LRCW4. Late Roman Coarse Wares, Cooking wares and amphorae in the Mediterranenan. Archaeology and Archaeometry. The Mediterranean: a market without frontiers, Oxford 2014.
RICCI 1985 = M. RICCI, Maiolica di età rinascimentale e moderna, in D. MANACORDA (ed.), Il giardino del conservatorio di Santa Caterina della Rosa (Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi 3/1-2), Firenze 1985, pp. 303-424.
RICCI 1998 = M. RICCI, La ceramica comune dal contesto di VII secolo della Crypta Balbi, in L. SAGUÌ (ed.), Ceramica in Italia. VI-VII secolo, Atti del convegno in onore di John W. Hayes (Roma, 11-13 maggio 1995), Firenze 1998, pp. 351-382.
Roma dall’antichità al medioevo = M. S. ARENA, P. DELOGU, L. PAROLI, M. RICCI, L. SAGUÌ, L. VENDITTELLI (ed.), Roma dall’antichità al medioevo. Archeologia e storia, Firenze 2001.
SAGUÌ 1998 = L. SAGUÌ (ed.), Ceramica in Italia. VI-VII secolo, Atti del convegno in onore di John W. Hayes (Roma, 11-13 maggio 1995), Firenze 1998.
SPERA 2004 = L. SPERA, Il complesso di Pretestato sulla Via Appia: storia topogra-fica e monumentale di un insediamento funerario paleocristiano nel suburbio di Roma, Città del Vaticano 2004.
240 GABRIELE CASTIGLIA
Riassunto
Il presente articolo intende offrire una prima panoramica generale sui reper-ti ceramici rinvenuti nel recente scavo presso le catacombe di Priscilla. Le con-siderazioni che verranno fatte saranno di ordine preliminare, visto lo stadio an-cora iniziale dello studio del contesto e delle sue componenti: cionondimeno, è già possibile presentare un significativo inquadramento cronologico e tipologico della cultura materiale preservatasi nelle stratigrafie indagate.
Abstract
This article aims to provide an initial overview on the pottery found in the recent excavation at the Catacombs of Priscilla. The considerations that will be made will be just preliminary, given the early stage of the study of the context and of its components: nevertheless, it is already possible to present a signifi-cant chronology and typology of the material culture preserved in the investi-gated stratigraphy.