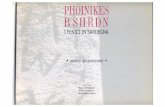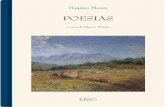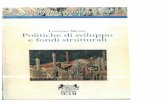Analisi di facies della successione triassico-giurassica di Porto Pino (Sardegna sud-occidentale)
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950 - 2008), in Sistemi museali e musei...
Transcript of Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950 - 2008), in Sistemi museali e musei...
Politiche ed esperienze
Sistemi museali e musei in Sicilia e in Sardegna
Scuola Normale Superiore di Pisa - Fondazione Banco di Sardegna
a cura di Cristina Borgioli, Denise La Monica ed Elisabetta Stinco
I edizione 2013
© LARTTE - Scuola Normale Superiore© 2013 - Felici Editore Srl via Carducci 60 - 56010 Ghezzano (PI) tel. 050 878159 - fax 050 8755897 www.felicieditore.it
ISBN: 978-88-6019-392-6
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAII, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.Le riproduzioni per uso differente da quello personale sopracitato potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall’editore.
Credits: questo volume è stato pubblicato con il contributo della Fondazione Banco di Sardegna e della Scuola Normale Superiore di Pisa.Il progetto è stato realizzato con il contributo della Fondazione Banco di Sardegna per quanto
riguarda la ricerca sulla Sardegna e con il contri-buto della Scuola Normale Superiore di Pisa per quanto riguarda la ricerca sulla Sicilia. La direzione scientifica del progetto di ricerca è stata condotta dal prof. Salvatore Settis.
Si ringraziano tutti gli Enti e le Istituzioni che hanno agevolato la ricerca.Progetto a cura del LARTTE (Laboratorio Analisi Ricerca Tutela Tecnologie Economia per il patrimonio culturale) - Scuola Normale Superiore di Pisa
http://lartte.sns.ithttp://sistemimuseali.sns.it
Indice
Premessa di Denise La Monica 5
Parte prima. SardegnaMusei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008), di Cristina Borgioli 9
Schede dei sistemi sardi, di Cristina Borgioli e Giuseppina Deligia 109
Parte seconda. SiciliaAnalisi delle politiche per i musei e i sistemi museali della Regione Siciliana, di Elisabetta Stinco 263
Schede dei sistemi siciliani, di Elisabetta Stinco 381
Parte terza. Un confrontoL’uniformità in materia culturale delle Regioni speciali: i casi della Sicilia e della Sardegna, di Stefania Mabellini 505
Un confronto tra Sicilia e Sardegna, di Denise La Monica 531
Bibliografia generale 547
Elenco degli autori
Cristina Borgioli, storica dell’arte, ha collabora-
to con il Lartte della Scuola Normale sui temi
della legislazione per il patrimonio culturale, con
particolare attenzione al rapporto tra musei e
Regioni
Denise La Monica, archeologa, tecnico di labo-
ratorio umanistico presso la Scuola Normale, si
occupa di temi di storia dell’archeologia, di storia
della tutela e della legislazione per il patrimonio
culturale italiano
Stefania Mabellini, ricercatrice universitaria per il
settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzio-
ni di Diritto pubblico - presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata, si occupa abitualmente dell’ordi-
namento regionale e della connessa produzione
legislativa.
Maria Giuseppina Deligia, storica dell’arte, ha
collaborato con il Lartte della Scuola Normale
sul tema della organizzazione dei sistemi museali
in Sardegna
Elisabetta Stinco, archeologa, ha collaborato con
il Lartte della Scuola Normale sui temi della le-
gislazione per il patrimonio culturale, con parti-
colare attenzione al rapporto tra musei e Regioni
Elenco delle abbreviazioni
L = legge
LC = legge costituzionale
DPR = decreto Presidente della Repubblica
DPCM = decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri
LR = legge regionale
RDL = regio decreto legge
RD = regio decreto
Dlgs = decreto legislativo
DdL = disegno di legge
DA = decreto assessoriale
DGR = Delibera Giunta regionale
DP = decreto presidenziale (riferito al Presidente
di Regione)
DL = decreto legge
DD = delibera dirigente
DCP = delibera consiglio provinciale
DCR = delibera consiglio regionale
DCC = delibera consiglio comunale
DR = decreto rettorale
DM = decreto ministeriale
9
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008)
Cristina Borgioli
1. Introduzione e note metodologiche
Lo scopo della ricerca è stato la ricostruzione e l’analisi delle politiche della Regione Autonoma della Sardegna volte alla gestione del comparto museale e alla sua organizzazione in forme sistemiche e reticolari. Lo studio si è basato sia sulla documentazione ufficiale (atti e norme) prodotta dalla Regione dalla sua nascita, sia sulla ricognizione e la schedatura dei sistemi culturali e delle aggregazioni assimilabili operanti sul territorio.
Per la schedatura dei sistemi culturali è stato stabilito come punto di parten-za l’Allegato C alla delibera di Giunta regionale n. 29/11 del 2008 – che appro-vava la proposta di Piano regionale triennale per i beni culturali1 – poiché tale documento contiene, tra l’altro, programmi e proposte provenienti dagli enti locali in materia di sistemi museali; ciò ha permesso di comprendere quanto già esistesse a livello territoriale e quanto si andasse programmando in chiave sistemica al momento dell’avvio della nostra ricerca2. L’elenco di sistemi de-ducibile dall’analisi del documento regionale è stato integrato con altre realtà di gestione sistemica o parasistemica riscontrate in ambito comunale e sovra comunale. Pertanto, oltre alle esperienze ufficialmente denominate “sistema”, “rete”, “itinerario”, sono state prese in esame anche alcune realtà che, pur in assenza di simili definizioni, di fatto realizzano, o mirano a concretizzare, at-tività assimilabili a quelle delle tipologie di aggregazione menzionate. Data la
1 DGR 29/11 del 22 maggio 2008, Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. Norme in mate-ria di beni culturali, istituti e luoghi della cultura. Art. 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura.
2 La ricerca pone il proprio limite cronologico alla fine del 2008.
10
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
complessità del panorama museale sardo, si è reso necessario stabilire alcuni criteri per individuare le esperienze di gestione coordinata da analizzare. Tali criteri sono stati: la presenza di almeno due strutture museali pubblicamente fruibili, l’esistenza di un accordo tra i soggetti coinvolti (enti proprietari, gestori etc.), la realizzazione di attività condivise.
Sebbene l’espressione “sistema museale” compaia nella normativa regiona-le sarda solo in tempi piuttosto recenti, la disamina dell’attività legislativa, di programmazione e indirizzo della Regione è stata condotta su un arco crono-logico più ampio: per quanto riguarda la normativa regionale, infatti, è stato ricomposto il quadro di tutte le leggi promulgate aventi a oggetto musei e beni culturali dagli anni Cinquanta, mentre per gli atti ufficiali di programmazione, indirizzo e sostegno al comparto museale la ricerca si è concentrata soprattutto sugli ultimi due decenni.
Nonostante la prima legge regionale sui musei (1958) prevedesse l’elabora-zione di un piano annuale, di fatto una compiuta programmazione regionale per i musei non si è avuta se non a partire dagli anni Duemila3. In realtà alla metà degli anni Novanta si è assistito a un più energico interesse da parte della Regione per il patrimonio culturale nella sua accezione materiale e immateriale e questa attenzione si è sviluppata, nel decennio successivo, con la volontà di avviare una concreta pianificazione in materia di musei, sia pur con qualche difficoltà nella sua concreta attuazione. Pertanto fino al 2000, ovvero al momen-to dell’emanazione della legge finanziaria regionale 4/2000 e della relativa deli-bera di attuazione, l’Amministrazione regionale della Sardegna ha sostenuto il comparto museale di ente locale attraverso l’erogazione di risorse economiche senza una puntuale programmazione in materia4.
I primi atti ufficiali regionali che testimoniano una concreta volontà di “ra-zionalizzare” il comparto dei musei di ente locale, in particolare attraverso la promozione di reti e sistemi a diversa estensione territoriale, risalgono alla metà degli anni Duemila. Nel luglio del 2005 fu approvato l’atto d’indirizzo regionale dal titolo Sistema regionale dei musei, Piano di razionalizzazione e sviluppo cui seguì, nel 2006, l’emanazione della legge regionale n. 14 Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura5.
3 LR n. 1 del 7 febbraio 1958, Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti e l’ecologia.
4 LR n. 4 del 20 aprile 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000).
5 DGR n. 36/5 del 26 luglio 2005, Sistema regionale dei Musei. Piano di razionalizzazione e
11
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
Alla prolungata assenza di attività di pianificazione si deve il ritardo e la fatica coi quali il concetto di “sistema” è stato applicato in Sardegna. Tuttavia forme sistemiche di gestione per musei e patrimonio culturale non possono dirsi una realtà estranea al contesto sardo. Se, infatti, negli atti ufficiali della Regione l’espressione “sistema museale” è entrata solo negli ultimi anni, da più tempo si registrano nell’Isola esperienza che possiamo definire “parasiste-miche” o che comunque recano al loro interno modalità di gestione o attività di promozione e valorizzazione assimilabili a quelle proprie dei sistemi. Si fa rife-rimento, per esempio, alla presenza di consorzi intercomunali o alla stipula di accordi tra enti diversi mirati alla valorizzazione del patrimonio. Non rare sono state, infatti, le intese tra Comuni e, talvolta, tra enti locali e Uffici periferici del Ministero; queste ultime, in particolare, risultano solitamente finalizzate all’at-tivazione di servizi per le aree archeologiche di competenza statale. Da questa indagine risulta che tali esperienze sono state avviate molto spesso prima della normativa regionale del 20066. Specialmente per quanto riguarda il patrimo-nio archeologico, si riscontra spesso sul territorio la presenza di aree attrezzate per la visita associate a musei e antiquaria appositamente allestiti per ospitare i reperti emersi dagli scavi: pur non potendo definire “sistemi” tali esperienze, è evidente, comunque, la presenza di interrelazioni più o meno profonde tra beni (musei, monumenti, siti archeologici), sorte in maniera spontanea a livello locale fin dagli anni Settanta.
2. I musei in Sardegna: una panoramica
Prima di analizzare diacronicamente lo sviluppo delle politiche regionali per i sistemi museali, è opportuno fornire un quadro d’insieme del panorama sardo dei musei7.
sviluppo. Documento d’indirizzo politico-amministrativo. LR n. 14 del 20 settembre 2006, Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.
6 LR 14/2006 cit.7 Per questa sintetica panoramica sui musei sardi sono stati utilizzati come fonti: Corte
dei Conti – Sezione del controllo per la Regione Autonoma della Sardegna, Relazione approvata con delibera n. 7 del 4 maggio 2005, Ricognizione e indagine sulla gestione dei musei locali della Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna, Federculture, Rapporto finale Innovacultura. Progetto di monitoraggio e valutazione delle iniziative progettuali avviate in attuazione della normativa di cui all’art. 92 L.R. 11/1988 e all’art. 38 della LR 4/2000, Cagliari 2005; M. IorIo, Musei, siti archeologici e turismo in Sardegna: alla ricerca di una integrazione, “Quaderni di lavoro CRENOS”, 2004, 04. Sistema regionale dei musei.
12
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Il numero di istituti e siti archeologici attrezzati per la visita in Sardegna è cresciuto dagli anni Ottanta e in particolare nel corso degli ultimi venti anni; se, infatti, negli anni precedenti quanto rinvenuto negli scavi veniva per lo più accolto in pochi musei di riferimento, come il Museo Archeologico di Cagliari, negli ultimi tre decenni vi è stata la tendenza a rendere fruibili i reperti diretta-mente sul luogo del ritrovamento, allestendo appositi spazi espositivi. Questa pratica ha visto come principali attori i Comuni che, anche grazie alle risorse rese disponibili dall’Amministrazione regionale, hanno realizzato sia le sedi museali che i servizi per la visita.
Anche laddove non vi fossero aree di scavo, gli enti locali si sono adoperati per la creazione di musei, spesso di tipo etnografico e antropologico, con lo sco-po di preservare e far conoscere le tradizioni del territorio o divulgare episodi o personaggi della storia locale. La vivace volontà dei Comuni di conservare e comunicare i tratti caratteristici della propria cultura e della storia locale si è esplicitata dunque nella nascita – soprattutto nelle aree escluse dai flussi di visita legati al turismo balneare – di numerose realtà museali, per lo più di ridotte dimensioni, spesso accomunate dalla medesima tipologia di raccolte, soprattutto nel caso di quelle etnografiche.
A testimonianza di questa esuberante attività degli Enti locali sardi, la mag-gior parte dei musei esistenti nell’Isola risulta essere di proprietà comunale e si trova dislocata prevalentemente nelle aree interne dell’isola. Per quanto ri-guarda le tipologie, i più numerosi sono i musei etno-antropologici, seguiti da quelli archeologici, da quelli storico-artistici e, con numero molto più esiguo, da quelli scientifico-naturalistici. Talvolta ai Comuni spetta anche la gestione dei servizi per i monumenti e le aree archeologiche statali come avviene, per esempio, per la Reggia nuragica di Barumini (dei cui servizi si occupa l’omoni-ma Fondazione partecipata dal Comune) e il sito di Tharros gestito dal Comune di Cabras8.
Piano di razionalizzazione e sviluppo. Documento di indirizzo politico-amministrativo allegato deliberazione di Giunta regionale n. 35/5 del 26 luglio 2005. Per le notizie sulle singole realtà museali, le aree archeologiche e i monumenti si è fatto principale riferimento alla banca dati regionale consultabile sul sito web Sardegna Cultura, all’indirizzo http://www.sardegnacultura.it/index.html.
8 Tra le altre strutture di proprietà statale ricordiamo a Cagliari la Basilica di San Sa-turnino, il Chiostro di San Domenico, il Museo Archeologico Nazionale, la Grotta della Vipera e la Pinacoteca Nazionale; il Museo Archeologico Nazionale di Nuoro, il Compendio Garibaldino di Caprera, l’Area archeologica Nuraghe Losa ad Abbasan-ta, l’Antiquarium Turritano, il Museo Nazionale Archeologico – Etnografico Sanna, la Pinacoteca Mus’à al Canopoleno a Sassari. Si veda l’elenco completo all’indirizzo:
13
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
A fronte della forte diffusione di musei comunali, sono invece solo due gli istituti che fanno capo alla Regione: il Museo Etnografico della Sardegna con sede a Nuoro, presso l’Istituto Etnografico della Sardegna (ISRE), e il più recen-te Museo per l’Arte del Novecento e del contemporaneo di Sassari. Nel corso degli ultimi anni sono state avviate azioni per la realizzazione di diversi musei a carattere regionale: in particolare, la progettazione regionale della metà degli anni Duemila ha prospettato l’istituzione di altri sei musei regionali, pensati come “poli” di riferimento per le realtà museali territoriali e capisaldi di un sistema a dimensione regionale9.
Le esperienze sistemiche registrate dal nostro censimento si sono sviluppate prevalentemente negli ultimi dieci anni e sono nate “dal basso”, per iniziativa cioè degli enti locali, sebbene molto spesso comprendano anche musei e monu-menti con diversa proprietà giuridica, mentre il fenomeno dei cosiddetti “circu-iti museali” comprensivi di musei statali, che si sviluppa in anch’esso nel primo decennio degli anni Duemila, rimane sostanzialmente marginale10.
La maggior parte dei sistemi museali sardi nasce per volontà degli enti locali e dalla loro aggregazione; risultano essere piuttosto dinamici, con frequente nascita di nuovi musei al loro interno e ciò conferma la presenza di una vivace progettualità sul territorio che stenta però a essere regolata in maniera unitaria.
3. La normativa regionale sui musei dallo Statuto agli anni Settanta
Lo Statuto regionale della Sardegna, approvato con Legge costituzionale n. 3 del 194811, riconosceva alla Regione competenza legislativa primaria in materia di biblioteche e musei di enti locali. Riguardo invece alle «antichità e belle arti» alla Regione veniva riconosciuta soltanto la facoltà di «adattare alle sue partico-
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrinci-pale/LuoghiDellaCultura/Musei-in-evidenza/index.html#sardegna).
9 Si fa riferimento al documento di indirizzo regionale Sistema Regionale dei Musei cit. 2005, di cui tratteremo diffusamente più avanti.
10 Sui circuiti museali di musei statali in Sardegna si veda quanto rilevato dall’Istat in merito agli Indicatori regionali per le politiche di sviluppo QSC 2000-2006 e QSN 2007-2013 consultabili sul sito web dell’Istat all’indirizzo http://www.istat.it/ambiente/contesto/infoterr/azioneB.html; si veda anche Numeri del Sud. Indicatori Regionali del QCS 2000-2006, Bollettino semestrale a cura dell’Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici DPS-MEF, giugno 2008 p. 2 consultabile all’indirizzo http://www.dps.teso-ro.it/documentazione/docs/numeridelsud/newsletter_n12_giugno%2008.pdf.
11 LC n. 3 del 26 febbraio 1948, Statuto speciale per la Sardegna.
14
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
lari esigenze, emanando norme di integrazione e di attuazione» le norme stata-li12. Più chiaramente, la potestà legislativa primaria è concessa – tra l’altro – per l’edilizia e l’urbanistica, il turismo, le biblioteche e i musei di ente locale, ma-terie per le quali la Regione esercita anche le funzioni amministrative, mentre per le antichità e le belle arti la Regione ha una competenza di tipo integrativo.
Ciò significa che la Sardegna, a differenza di altre Regioni a statuto speciale, ha avuto autonomia di governo limitatamente al comparto dei musei e delle biblioteche di ente locale13.
Lo Statuto diviene operativo per i musei e le biblioteche di ente locale solo nel 1965, con il DPR n. 1532 del 24 novembre, che trasferì alla Regione le funzio-ni amministrative prima intestate al Ministero della Pubblica Istruzione14. Nel Decreto si specifica che la soluzione dei problemi tecnici connessi all’istituzione e allo sviluppo dei musei di ente locale viene adottata dalla Regione di concerto con le Soprintendenze pertinenti e che rimangono salve le attribuzioni ammini-strative statali per la «tutela delle cose di interesse storico ed artistico» (articoli
12 LC 3/1948, art. 5.13 Lo stesso Statuto sardo è stato del resto definito «“meno speciale” dello Statuto
siciliano», sebbene sia forse lo Statuto della Sicilia a essere “più speciale” rispetto alle altre Regioni autonome. Cfr. G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Tomo I, Le Regioni, le Province, i Comuni, Zanichelli, Bologna 1985 pp. 75-77. c. Bodo, Rapporto sulla politica culturale delle Regioni. Le leggi, la spesa, gli interventi, le prospettive, Franco Angeli Editore, Milano 1982, p. 508. Sul rapporto tra competenze regionali in materia di beni culturali e Statuti speciali di Sardegna e Sicilia si rimanda al saggio di Stefania Mabellini in questo volume; si veda anche: S. MaBellInI, Potestà legislativa in materia di beni culturali tra Stato e Regioni speciali in c. BorGIolI, d. la MonIca (a cura di), Sistemi museali e musei in Sardegna. Politiche ed esperienze, Atti del convegno (Sassari, 26 marzo 2010), Felici Editore, Pisa 2012, pp. 31-58.
14 DPR n. 1532 del 24 novembre 1965, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sar-degna in materia di Biblioteche e di musei di Enti locali. «Art. 1. Le funzioni amministrati-ve esercitate dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli organi da esso dipendenti nei confronti delle biblioteche e dei musei di enti locali sono trasferiti, in Sardegna, all’amministrazione regionale. Art. 2. L’amministrazione regionale può avvalersi, per le funzioni di propria competenza, della Sopraintendenza bibliografica per la Sarde-gna e delle Soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della Sardegna. La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e con lo sviluppo dei musei e delle biblioteche degli enti locali è adottata dalla amministrazione regionale, di concerto, rispettivamente, con le soprintendenze alle antichità, ai monumenti e alle gallerie e con la soprintendenza bibliografica. Art. 3. Restano salve le attribuzioni am-ministrative dello Stato in ordine alla tutela delle cose di interesse storico ed artistico […]». Cfr. A. MareSca coMpaGna (a cura di), Gestione e valorizzazione dei Beni culturali nella legislazione regionale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1998, p. 89. Corte dei Conti, Ricognizione e indagine, cit. 2005.
15
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
2, 3). L’articolo 2 del DPR del 1965 fu modificato con il DPR 22 maggio 1975 n. 480, che integrò le competenze regionali per la tutela bibliografica. Sempre nel 1975, con il DPR n. 348 del 22 maggio, furono trasferite alla Regione Sardegna anche le funzioni amministrative relative alle «istituzioni culturali di interesse locale» (art. 36) che rimasero però da individuare in un secondo momento.
Per quanto riguarda la competenza per l’ambiente, invece, la Sardegna do-vrà attendere fino al 1979, quando fu emanato il DPR n. 348, attuativo dello Statuto speciale regionale. Il decreto delega alla Regione le funzioni ammini-strative esercitate dallo Stato riguardo la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene la loro individuazione, la tutela e le relative sanzioni (art. 57); inoltre trasferisce all’amministrazione regionale le funzioni concernenti gli in-terventi per la protezione della natura, le riserve e i parchi (art. 58), anche se la Regione comincerà a legiferare sul patrimonio naturale circa dieci anni dopo la promulgazione del DPR, alla fine degli anni Ottanta15.
Già alla fine degli anni Cinquanta, in attesa dell’emanazione delle norme di attuazione, la Regione Sardegna aveva prodotto la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 1958, dal titolo Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti e l’ecologia.
Con la legge regionale 1/1958 la Sardegna è stata la prima Regione a sta-tuto speciale a legiferare sul tema dei musei e dei beni culturali: le altre Re-gioni speciali, infatti, hanno prodotto le proprie norme di settore, con margini potestà legislativa diversa, tra gli anni Settanta e Ottanta16. Attraverso questa
15 DPR n. 348 del 19 giugno 1979 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975 n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La delega riguarda tra l’altro le funzioni amministrative concernenti l’individuazione delle “bellezze naturali” «salvo il potere del Ministro per i Beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed il comitato regionale per i beni culturali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalla regione (art. 57).
16 Nel 1976 legifera in proposito il Friuli Venezia Giulia, nel 1980 la Sicilia, nel 1977 la Provincia Autonoma di Trento, nel 1988 quella di Bolzano. La Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno potestà legislativa esclusiva e competenza amministrativa su: antichità e belle arti, biblioteche, musei, edilizia e urbanistica, tutela del paesaggio; la Val d’Aosta detiene competenze amministrative su tutte le materie citate, potestà legislativa esclusiva su biblioteche e musei di enti locali, edilizia e urbanistica, turismo e tutela del paesaggio, competenza legislativa di tipo integrativo su antichità e belle arti; il Friuli Venezia Giulia ha competenza amministrativa e competenza legislativa esclusiva su biblioteche e musei locali e regionali, edilizia e urbanistica. d. Jalla, Il museo contemporaneo. Introduzione al nuovo
16
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
legge si disciplina l’esercizio della competenza primaria dell’Amministrazione regionale sui musei di ente locale e quella integrativa sulle antichità e le bel-le arti; si autorizzano finanziamenti per la costruzione di musei regionali e la concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di nuovi musei, le ristrutturazioni degli esistenti, l’incremento e la dotazione di attrezzature (art. 3). La norma definì inoltre i compiti dell’Assessorato alla pubblica istruzio-ne: provvedere alla vigilanza sui musei di ente locale (articolo 1) e autorizzare eventuali trasferimenti o restauri dei beni ivi conservati (articolo 2). Per quan-to riguarda le competenze regionali integrative alla tutela dello Stato, sancite dall’articolo 9 della Costituzione e dalla legislazione in materia allora vigente, la legge regionale del 1958 stabilisce come compiti dell’Assessorato la vigilanza sul patrimonio storico, artistico, archeologico, etnografico e speleologico della Sardegna, la facoltà di finanziare lavori di ricerca e di sistemazione «intesi a sviluppare e valorizzare» il patrimonio sulla base di un piano annuale propo-sto dallo stesso Assessorato (articolo 4) e la facoltà di finanziare l’esecuzione di «opere urgenti» per assicurare la conservazione di monumenti e altri beni «di riconosciuto interesse archeologico, artistico, storico, etnografico, numismatico e speleologico» (articolo 5).
Gli enti locali sono obbligati a provvedere all’amministrazione, alla conser-vazione e all’incremento dei musei di loro pertinenza, mentre è proibito loro alienare, cedere, modificare e restaurare i beni posti sotto la loro amministrazio-ne senza aver ottenuto un’autorizzazione regionale (articolo 2).
È evidente che la norma non contiene alcun riferimento a forme sistemiche di gestione del patrimonio, tuttavia un elemento che, per certi versi, si collega a un tipo di gestione congiunta oggi frequente in Sardegna, si trova all’artico-lo 4, che inerisce il materiale ritrovato nelle ricerche archeologiche. La norma stabilisce che i reperti debbano essere depositati in prima istanza nei musei «di più agevole accesso» e, successivamente, distribuiti tra i musei geograficamen-te più vicini al luogo di reperimento (articolo 4, comma 3). Questa disposizione, che denota un’attenzione particolare a mantenere sul territorio il patrimonio, si tradurrà concretamente nella nascita di molte sedi museali in corrisponden-za delle aree di scavo, con una duplice conseguenza: sarà limitata la diaspora di oggetti verso i musei preesistenti lontani dal luogo del ritrovamento e sarà realizzata un’offerta museale diffusa. La maggior parte dei musei archeologici comunali, nati soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, sorge infatti general-
sistema museale italiano, Utet, Torino 2003, pp. 99-100; Gestione e valorizzazione dei beni culturali cit. 1998, tabella 1 p. 705.
17
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
mente in corrispondenza di aree di scavo attrezzate per la visita, con le quali essi hanno instaurato un legame non solo di tipo culturale − ospitando i reperti da lì provenienti − ma talvolta anche gestionale, attraverso, per esempio, l’affi-damento dei servizi a un unico soggetto17.
La nascita dei musei archeologici diffusi sul territorio si lega ai numerosi cantieri di scavo avviati in Sardegna negli anni Settanta, che si aggiunsero a quelli già intrapresi negli anni Cinquanta grazie alla legge nazionale per l’occu-pazione n. 264 del 1949. Tali attività di scavo produssero un’ingente quantità di reperti che mal poteva essere assorbita dai preesistenti musei archeologici; nac-que così l’esigenza di allestire spazi idonei presso gli enti locali per conservare e rendere fruibile il materiale ritrovato. A questo proposito vale la pena ricordare che la maggior parte degli scavi iniziati dopo la metà degli anni Sessanta ha beneficiato solo marginalmente dei finanziamenti della legge regionale 1/1958, gravando invece, e in maniera consistente, sui finanziamenti regionali del Fon-do Sociale della Regione Sarda (l.r. 10/1965), gestito dall’Assessorato al Lavoro e finalizzato a combattere la disoccupazione18. In sintesi questi cantieri – che hanno permesso importanti indagini come quelle di Nora e Barumini – hanno preso le mosse più dalla volontà di creare lavoro che da una puntuale pianifi-cazione culturale. Come vedremo, nel contesto sardo le politiche per l’occupa-zione e le politiche per i beni culturali si intrecceranno ancora, specie negli anni Ottanta, soprattutto nella gestione dei musei di ente locale19.
Nella legge 1/1958 è comunque evidente l’intenzione di pianificare tutte le iniziative di settore: secondo la norma l’Assessorato doveva predisporre an-nualmente un piano relativo alle attività di ricerca e valorizzazione del patri-monio, contenente anche i finanziamenti da destinarvi. Questa parte del det-tato di legge è stata però sostanzialmente disattesa nel corso dei decenni: gli strumenti di pianificazione e programmazione per le attività regionali per il
17 Le aree archeologiche sono state spesso concesse in gestione dal Ministero agli enti locali proprietari a loro volta degli adiacenti musei comunali e, a partire dagli anni Ottanta, a seguito delle leggi per l’occupazione, la gestione di moltissimi di questi siti e musei è stata affidata a terzi.
18 Gli scavi da effettuare venivano proposti dalla Soprintendenza all’Assessorato regionale al lavoro, al tempo competente in materia, mediante un Piano. La legge regionale n. 10 del 7 aprile 1965, Istituzione del Fondo Sociale della Regione Sarda (articolo 2, comma 4), pose a carico del Fondo sociale anche le spese per la realizzazione di opere di interesse locale per la valorizzazione del patrimonio naturale ed archeologico da attuarsi quando fosse rilevata la necessità di un intervento a fini occupazionali.
19 Si veda anche c. Bodo, Rapporto sulla politica, cit. 1982 pp. 515-516.
18
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
patrimonio culturale non sono stati elaborati almeno fino all’emanazione della successiva legge regionale sui musei, la legge regionale n. 14 del 2006, la quale prevede la produzione di un Piano triennale regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura.
L’assenza di una programmazione regionale, ovvero di una cabina di regia per il coordinamento delle azioni per il comparto museale, ha creato i presup-posti per uno sviluppo del settore senza coordinamento, talvolta ripetitivo dal punto di vista dell’offerta culturale, e disomogeneo dal punto di vista dei ser-vizi. Su queste criticità la Regione avvierà una seria riflessione solo a partire dal 2000.
Sulle competenze integrative della Regione, in particolare per quanto ri-guarda il delicato aspetto del restauro, la legge del 1958 presenta alcuni aspetti ambigui. Come osservato da Maresca Compagna, la legge regionale descrisse probabilmente per la Sardegna un «ventaglio più ampio di competenze rispetto a quello esplicitato dalle norme attuative» e a questo proposito c’è da sottoline-are che proprio il testo di legge inerente l’esecuzione dei restauri sarà modifica-to da due successive leggi regionali20.
L’articolo 7 della legge regionale 1/1958 ordinava infatti che per l’esecuzione dei lavori «di cui alla presente legge» − comprese le opere urgenti in materia di conservazione oggetto dei finanziamenti dell’articolo 5 − l’Assessorato avrebbe dovuto richiedere l’assistenza delle Soprintendenze nel caso in cui fossero state necessarie particolari competenze tecniche. Si presupponeva cioè che potesse essere l’Assessorato a decidere la qualità e il tipo di intervento necessario, in via prioritaria rispetto alla Soprintendenza, e che potesse essere lo stesso As-sessorato, eventualmente, a determinare l’intervento di quest’ultima. L’articolo 5 dà poi facoltà alla Regione di finanziare opere urgenti per la conservazione di monumenti e altri beni senza fare alcun riferimento né alla proprietà giuri-dica di tali beni né al tipo di interesse a essi attribuibile se, ad esempio, locale o nazionale. Infine il primo comma dell’articolo 7 ribadisce comunque che, salve le competenze attribuite alla Regione dalla stessa legge, niente viene innovato rispetto a quanto sancito dalle leggi statali in materia di tutela e di competenze del Ministero e dei propri organi periferici.
La prima modifica al testo di legge della 1/1958 si ebbe nel 1969, dopo il trasferimento di competenze per i musei locali avvenuto attraverso il DPR 1532/1965, con la legge regionale n. 2, che mutò il secondo comma dell’articolo 7 della norma. Secondo l’articolo unico della nuova legge, la Regione non può
20 Gestione e valorizzazione cit. 1998, p. 89.
19
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
più eseguire lavori nel comparto dei beni di interesse storico e artistico soggetti alla tutela dello Stato − pur seguendo il parere tecnico delle Soprintendenze competenti, come precedentemente stabilito dalla legge regionale 1/1958 − ma deve limitarsi alla sola erogazione di finanziamenti, poiché la progettazione e l’esecuzione degli interventi sono demandate esclusivamente alle Soprinten-denze21.
Alla fine degli anni Settanta la legge regionale 1/1958 subisce una nuova modifica, disposta questa volta con la legge regionale 49/1979 che abroga la precedente 2/1969: il secondo comma − già mutato nel 1969 − e il terzo comma dell’articolo 7 della legge del 1958 vengono infatti sostituiti:
Per l’esecuzione delle opere indicate negli articolo 4 e 5 della presente legge, l’amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, ai Consorzi dei Comuni, alle Comunità montane, agli or-ganismi comprensoriali, nonché ad altri Organismi pubblici interessati.
La nuova norma stabilisce che gli Enti locali possano beneficiare di finanzia-menti regionali, disposti dall’Assessorato competente, sulla base di un piano annuale approvato dalla Giunta regionale e finalizzati allo sviluppo, alla va-lorizzazione (art. 4 l.r. 1/1958) e alla conservazione del patrimonio e dei mo-numenti del territorio. Nel caso tali soggetti risultino inadempienti, la legge sancisce che sia la Regione stessa a «provvedere direttamente all’esecuzione delle predette opere» mediante l’Assessorato competente.
Per quanto riguarda il restauro quindi la Regione legifera alla fine degli anni Cinquanta in maniera piuttosto approssimativa assegnando all’Assessorato competente la funzione di finanziare opere di restauro urgenti − non specifi-cando proprietà giuridica o livello di interesse dei beni − e obbligando lo stesso assessorato a chiedere l’assistenza degli organi periferici del Ministero solo nei casi in cui sia necessaria la loro competenza tecnica.
Dopo un decennio, alla fine dei Sessanta, una nuova norma stabilisce che la Regione debba limitarsi al solo finanziamento per i lavori relativi a beni sogget-ti alla tutela dello Stato, erogando contributi alle Soprintendenze che effettue-ranno le opere. Alla fine del decennio successivo infine, nel 1979, la legge pre-cedente viene abrogata e si dà alla Regione non solo la possibilità di finanziare gli Enti locali per l’esecuzione di restauri ma anche di provvedere in prima persona ai lavori qualora detti enti risultino inadempienti.
21 LR n. 2 del 14 gennaio 1969, Modifica alla Legge Regionale 7 febbraio 1958, n. 1, concernente disposizioni per i musei degli Enti Locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti. Cfr. Gestione e valorizzazione cit. 1998, p. 90.
20
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Ancora precisazioni sulla suddivisione delle competenze tra Regione e Stato si trovano poi nel DPR n. 480 del 1975, recante Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, che modificò l’articolo 2 del precedente DPR n. 1532/1965: se per quest’ultimo infatti «la soluzione dei problemi tecnici» connessi all’istituzione e allo sviluppo dei musei di ente lo-cale veniva adottata dalla Regione «di concerto» con le Soprintendenze alle antichità, ai monumenti e alle gallerie, il Decreto del 1975 sancisce che tali at-tività debbano essere svolte dall’amministrazione regionale «sentite» le stesse Soprintendenze; viene cioè precisata la funzione consultiva degli organi perife-rici del ministero e la funzione decisionale della Regione.
Nello stesso anno, inoltre, con l’articolo 35 del DPR n. 805 relativo alla or-ganizzazione del Ministero, si prevedeva in ogni capoluogo l’istituzione dei Comitati Regionali per i Beni Culturali, con funzione di raccordo tra Stato e Regio-ni22. Il decreto, cui seguì una circolare ministeriale nel luglio 1976, era ispirato a una visione di decentramento che mirava a una maggiore partecipazione alle esigenze locali da parte degli organi periferici del Ministero e a una politica regionale per i beni culturali da esercitare tramite attività di programmazione.
Il Comitato sardo, istituitosi nel novembre del 1976, da subito cercò di inserire il proprio piano di attività all’interno della programmazione economica della Regione e realizzò un’indagine conoscitiva sulle risorse umane e strutturali per il comparto dei beni culturali dell’Isola.
Nonostante l’assenza di un Assessorato competente sui beni culturali, il Co-mitato realizzò – nei primi due anni di attività – una ricognizione del personale degli uffici statali e di quello impiegato attraverso la legge sull’occupazione giovanile 285/1977, riscontrando una certa inadeguatezza per le esigenze della tutela. I risultati dell’indagine misero in evidenza la necessità di corsi di aggior-namento e perfezionamento, anche in relazione alla crescita della fruizione dei beni alla quale sarebbe dovuto «corrispondere l’offerta di sussidi moderni»23.
22 DPR n. 805 del 3 dicembre 1975, Organizzazione del Ministero per i Beni culturali e ambientali: «Art. 35. In ogni capoluogo di Regione è istituito un comitato regionale per i beni culturali composto dai capi degli uffici che costituiscono la conferenza regionale di cui all’art. 32 e da un numero pari di membri rappresentanti della Regione e da questa eletti o nominati secondo propri provvedimenti […]». Il Comitato poteva chiamare a partecipare alle proprie riunioni amministratori ed esperti. Le principali funzioni del Comitato erano quelle di collegamento informativo e conoscitivo tra Stato e Regioni, di coordinamento delle iniziative e delle attività dello Stato, delle Regioni, degli enti infraregionali, di proporre e promuovere interventi.
23 G. lIllIu, Il Comitato paritetico Stato-Regione. Ruolo e attività, in Cultura e Ambiente. Atti della I conferenza regionale sui beni culturali e ambientali (Cagliari 16 -18 febbraio 1984),
21
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
La ricerca denunciò soprattutto le difficili condizioni in cui si trovavano a ope-rare le Soprintendenze − quella di Cagliari-Oristano, per esempio, cessò l’atti-vità nel 1979 a causa della mancanza di locali − e lo stato, spesso di degrado anche estremo, nel quale versavano molti monumenti. Il rapporto del Comitato circa la situazione del patrimonio culturale dell’Isola spinse la Regione a inter-venire e fu avanzata la proposta di creare un Centro Regionale di Documentazione ove far confluire i molti inventari e censimenti prodotti, senza alcun coordina-mento, da Soprintendenze, Università e dai numerosi gruppi di volontariato presenti sul territorio. Di fatto solo con la Lege Regionale 1/1977 furono for-malizzate e attribuite all’Assessorato alla pubblica istruzione le competenze in materia di «beni culturali, biblioteche e musei, antichità e belle arti, tutela delle bellezze naturali, promozione e diffusione della cultura», attraverso la legge regionale n. 124.
4. Gli anni Ottanta
Nel corso degli anni Settanta, quando nascono le Regioni a statuto ordinario e vengono loro trasferite le funzioni amministrative per i musei e le biblioteche di ente locale, si intensifica su tutto il territorio nazionale l’attività legislativa inerente il patrimonio museale. Il decentramento prefiguratosi con la nascita delle Regioni faceva auspicare la realizzazione di migliori forme di governo per il patrimonio museale locale, grazie a una maggiore flessibilità, a una pro-grammazione mirata e all’aumento delle risorse da destinare al comparto. In questi stessi anni si diffonde dunque in Italia un articolato dibattito sul tema dei musei, come dimostra il grande numero di pubblicazioni, seminari e conve-gni dedicati all’argomento25.
Mentre negli anni Settanta le altre Regioni, ordinarie e a statuto speciale, producono specifiche leggi di settore per i musei, in Sardegna gli interventi sono ancora fondati su una legge emanata negli anni Cinquanta e su leggi fi-
Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari 1986, p. 45-49.24 Le competenze dell’Assessorato riguardano: a) istruzione di ogni ordine e grado ed
ordinamento degli studi; b) scuola materna; c) assistenza scolastica; d) beni culturali; e) biblioteche e musei; f) antichità e belle arti; g) tutela delle bellezze naturali; h) problemi della gioventù; i) promozione e diffusione della cultura; l) problemi dell’ informazione e delle comunicazioni di massa; m) spettacolo e sport. LR n. 1 del 7 gennaio 1977, Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali, art. 20.
25 d. Jalla , Il museo cit. 2003, p. 102 con riferimenti bibliografici.
22
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
nanziarie annuali. Questa prassi permarrà anche negli anni successivi e, come recentemente riconosciuto dalla stessa Regione, impedirà a lungo l’esercizio di una reale funzione di coordinamento e indirizzo per i musei da parte dell’Am-ministrazione regionale26.
Malgrado ciò, anche in Sardegna tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta comincia a farsi sentire la necessità di una legge organica di settore. Al 1980 risalgono in particolare tre proposte di legge presentate da DC, PSDI, e PCI alla Giunta regionale e rispettivamente intitolate: Sullo sviluppo e il potenzia-mento dei musei degli Enti locali; Norme in materia di musei di Enti locali o di interesse locale e istituzione del Centro regionale di restauro; Norme in materia di musei di Enti locali o di raccolte e di istituzioni che meritino interesse e valorizzazione da parte degli Enti locali27.
Nei primi anni Ottanta, come enunciato in occasione della Prima conferenza regionale sui beni culturali e ambientali tenutasi a Cagliari nel 1984, la legge re-gionale allora in vigore, la n. 1 del 1958, veniva ormai percepita come obsoleta e soprattutto limitata alla mera erogazione di fondi per il comparto museale; lo stesso Assessorato competente aveva, in effetti predisposto in quegli anni un disegno di legge sui musei che prevedeva, tra l’altro, la «creazione di un sistema museale integrato» senza però giungere a una conclusione concreta28.
Le relazioni della Conferenza di Cagliari del 1984 presentano giudizi sostan-zialmente negativi sulle coeve politiche regionali per i musei, denunciando una normativa superata, finanziamenti irrisori, scarsa attività di coordinamento. La stessa facoltà di istituire musei regionali, sancita dalla legge regionale 1/1958, rimaneva sostanzialmente disattesa, eccezion fatta per l’Istituto superiore regiona-le etnografico (ISRE), fondato nel 1972 con sede a Nuoro, cui fu annesso il Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde, già presente col nome di Museo del costu-me di Nuoro. Il museo, che è rimasto a lungo l’unico istituto museale di diretta emanazione della Regione Sardegna, nacque con un’apposita legge regionale, la quale stabiliva, tra le altre cose, che l’Amministrazione regionale erogasse un contributo ordinario annuale all’ISRE non inferiore a 100 milioni di lire29.
26 Sistema regionale dei musei cit. 2005.27 Si veda l’intervento dell’allora presidente della Commissione Istruzione, Cultura,
Sport e Formazione professionale del Consiglio Regionale: e. orrù, s.t. in Cultura e ambiente cit. 1986 pp. 33 - 42.
28 Si veda l’intervento dell’allora Assessore alla Pubblica Istruzione: F. Fadda, Stato attuale e nuove prospettive di una politica di salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della Sardegna, in Cultura e ambiente, cit. 1986, pp. 11-26.
29 LR n. 26 del 5 luglio 1972 Istituzione con sede in Nuoro dell’Istituto superiore regionale
23
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
Nello stesso anno (1972) la Regione concesse inoltre un versamento straor-dinario pari a 30 milioni di lire per la creazione di un altro museo, anch’esso da collegare all’ISRE, nella casa natale di Grazia Deledda. La missione culturale dell’ISRE fu da subito individuata nello studio e nella documentazione «della vita sociale e culturale della Sardegna, nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni»30. Nel corso degli anni l’Istituto è divenuto il princi-pale punto di riferimento dell’Isola per le attività legate alla storia delle tra-dizioni sarde e all’etnografia regionale. L’ISRE, infatti, oltre a occuparsi della gestione e della cura delle strutture annesse (il Museo regionale della vita e delle tradizioni popolari sarde, la Casa-museo di Grazia Deledda, la Biblioteca speciali-stica demoetnoantropologica, la fototeca e la cineteca), assiste scientificamente le amministrazioni locali per le iniziative museali d’interesse etnografico, rea-lizza mostre, convegni, rassegne e studi, svolge attività editoriali e di formazio-ne e coordina il progetto di catalogazione dei beni demoetnoantropologici della Sardegna. Possiamo quindi ritenere l’ISRE il centro del “sistema” virtuale dei musei etnografici sardi che, come anticipato, costituiscono una larga fetta del patrimonio museale locale dell’Isola essendo numericamente preponderanti.
Le principali attività della Regione rivolte al settore musei per gli anni Ot-tanta sono riconducibili agli interventi finanziari predisposti a sostegno dell’oc-cupazione giovanile, con i quali si sono avviate le prime esperienze di gestione del patrimonio con affidamento a terzi (cooperative, società giovanili) da parte degli Enti proprietari. Nello stesso decennio si assiste inoltre a una maggiore disponibilità economica della Regione per il patrimonio culturale. Si intensifi-cano i finanziamenti statali per le regioni del Mezzogiorno, in particolare grazie al progetto relativo ai cosiddetti Itinerari Turistico-Culturali deliberati dal CIPE nel 1982, mediante i quali in Sardegna si è provveduto soprattutto al ripristino di strutture esistenti e alla creazione di infrastrutture di interesse turistico31.
A tal proposito dobbiamo precisare che negli anni Settanta la spesa per la cultura della Sardegna era stata inferiore addirittura a quella di molte Regioni a statuto ordinario; se confrontate poi con le Regioni autonome le spese per la
etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda.
30 LR 26/1972 art.1.31 Il progetto speciale dedicato agli itinerari nel Mezzogiorno fu inserito all’interno del
programma quinquennale 1976-1980 (Delibera n. 29 CIPE del 13 maggio 1982).
24
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
cultura risultano in quegli anni molto basse e pari solo allo 0,47% della spesa complessiva regionale della fine degli anni Settanta32.
Negli anni Ottanta la Regione prende atto del difficile quadro nel quale si andavano a inserire i possibili interventi regionali per il settore del patrimonio culturale. I punti critici maggiormente avvertiti riguardavano la competenza diversificata della Regione − ovvero primaria solo per musei e biblioteche di ente locale, integrativa per “antichità e belle arti” − che presupponeva una con-cezione non unitaria di “bene culturale”, la penuria di risorse economiche da destinare al comparto musei, la mancanza di personale qualificato, l’assenza di una programmazione organica per gli interventi di settore. In particolare, nella relazione dell’assessore alla Pubblica istruzione riportata nella Delibera di giunta 19/56 del 1983, si legge33:
Dall’esame dello Statuto emerge una competenza diversificata della Regione in materia di beni culturali dovuta alla assenza di una conce-zione unitaria di bene culturale, quale, invece si è venuta delineando in questi ultimi anni. Si rileva che, a fronte di una competenza primaria in materia di musei e biblioteche di Enti Locali, lo Statuto riserva alla Regione una competenza integrativa in materia di antichità e belle arti. Si arguisce che rimane riservata allo Stato la competenza in ordine alla
32 In questo periodo, se paragonata, per esempio, con quella del Friuli Venezia Giulia − Regione con analoghe competenze in materia di patrimonio culturale − la spesa della Sardegna è pari a un terzo. Agli inizi degli anni Ottanta si registrò invece un incremento della spesa regionale sarda per la cultura, dovuto sia ai potenziamenti del settore biblioteche e musei che al trasferimento degli oneri per i centri di servizi culturali dalla Cassa del Mezzogiorno alla Regione; il settore patrimonio storico-artistico e musei assorbì quasi integralmente la quota di spesa destinata agli investimenti. La gestione della spesa, erogata “a pioggia” e senza controllo democratico per lungo tempo, era regolata dalla legge n. 33 del 1975, relativa ai compiti della Regione nella programmazione, la quale sanciva (art. 25) che gli interventi regionali dovessero essere approvati dalla giunta, dagli assessori competenti in concerto con l’assessore al bilancio e alla programmazione, previa consultazione del Comitato per la programmazione, formato da 15 membri: 9 eletti dal Consiglio regionale, 3 dai sindacati e 3 esperti nella materia oggetto di programmazione. Secondo la Bodo, il punto di debolezza di tale iter risiedeva nella preponderanza di economisti in seno al Comitato, ovvero membri con scarse o nulle competenze in materia di cultura e dunque incapaci di entrare nel merito dei provvedimenti dell’assessorato competente. Tuttavia la legge sulla programmazione ha avuto il merito di migliorare i criteri per l’erogazione dei finanziamenti: infatti dal 1977 gli stanziamenti furono decisi con una sola delibera annuale per ogni settore, cosa che permise anche la pubblicità dei finanziamenti e dunque un controllo a posteriori. Si rimanda a c. Bodo, Rapporto sulla politica, cit. 1982, pp. 512- 514.
33 DGR n. 19/56 del 5 maggio 1983, Linee programmatiche per un censimento generale del patrimonio e delle risorse culturali e ambientali esistenti nel territorio della Regione.
25
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
tutela di beni ambientali […]. Gli interventi della Regione hanno avuto finora una scarsa incidenza per la inadeguatezza dei mezzi finanziari, per mancanza di personale qualificato negli organici regionali e per ca-renza di una programmazione nella materia in esame.
La Regione esprime quindi la volontà di una maggiore efficacia nel campo della conservazione, della promozione e della fruizione dei beni culturali: que-sto proposito si traduce in diverse iniziative, come la proposta di un rinnova-mento legislativo e la programmazione di un’azione di censimento “globale” del patrimonio culturale dell’Isola.
Se per il rinnovamento legislativo dovremmo attendere ancora molti anni, il censimento si avvia invece già nel 1983, quando la Regione assume la neces-sità di conoscere il proprio patrimonio per concorrere concretamente alla sua salvaguardia.
Grazie alla legge nazionale sull’occupazione 285/1977, erano stati istituiti dei gruppi di lavoro per il censimento dei beni archeologici che operavano sulla base di un programma quadriennale sviluppato con le competenti soprinten-denze. L’attività, svolta in diciassette Comuni, permise l’acquisizione di infor-mazioni sull’assetto del territorio sardo nell’antichità e comportò l’apposizione di vincoli da parte delle Soprintendenze su aree di particolare interesse. Furo-no effettuati interventi di scavo e i risultati delle ricerche furono divulgati con attività nelle scuole, pubblicazioni e mostre temporanee34. Il limite di questo lavoro però, sebbene molto proficuo, fu l’impostazione strettamente territoriale e settoriale delle ricerche: queste, infatti, erano state svolte in maniera subor-dinata agli Enti locali − e dunque Comune per Comune − e solo in ambito archeologico: non era stato quindi possibile collegare in una visione più vasta le emergenze archeologiche studiate con quelle del territorio limitrofo o con le testimonianze del tessuto storico-culturale dei secoli successivi35. Un con-temporaneo progetto di censimento, attuato all’interno dell’Assessorato alla Pubblica istruzione, riguardò invece beni architettonici e monumentali ma fu sostanzialmente circoscritto alla città di Cagliari36.
Al termine dei progetti nati con la legge per l’occupazione, fu chiara la ne-cessità di procedere alla classificazione organica della mole di informazioni ot-tenute e di proseguire l’esperienza conclusasi con un nuovo censimento più ampio, capace di porre in relazione le diverse tipologie di beni presenti sul territorio.
34 a. Frau, Esperienze, realtà e prospettive nell’ambito dei beni culturali: dai progetti speciali per l’occupazione giovanile alla programmazione in Cultura e Ambiente cit. 1986, pp. 75-76.
35 DGR n. 19/56 del 5 maggio 1983 cit.36 Ibidem.
26
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Nel 1983 la Regione approvò dunque le linee programmatiche per un cen-simento globale del patrimonio archeologico e storico-artistico della Sardegna. Lo scopo fu di affiancarsi nella tutela agli organi statali e creare un archivio fru-ibile dei dati prodotti dal censimento; al contempo si volevano individuare an-che quelle aree territoriali le cui caratteristiche «patrimoniali e storiche richie-dano e consentano l’istituzione di musei locali» nonché le strutture di interesse storico da poter adibire a «spazi culturali»37. Si intraprendeva così un progetto molto ambizioso che, per la prima volta, contemplava anche il censimento dei musei esistenti e delle rispettive collezioni. Se nella conoscenza del patrimo-nio risiedono le basi imprescindibili per la sua conservazione e promozione culturale, possiamo dire che negli anni Ottanta si muovono i primi passi delle politiche regionali sarde direttamente rivolte ai musei.
Al contempo, a partire dal 1984, la Regione avvia una serie di finanziamenti destinati a specifici progetti finalizzati alla fruizione e alla gestione di musei di ente locale, monumenti, aree archeologiche, biblioteche e archivi. Tali progetti nascono a seguito di un’altra norma per l’occupazione, stavolta regionale – la legge 28/1984 recante Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione – e prose-guono fino al 199938. Malgrado la 28/1984 non sia stata una legge specificamen-te rivolta al comparto cultura, essa ha comunque segnato in maniera consisten-te il concreto sviluppo del settore musei e patrimonio culturale di pertinenza regionale, soprattutto per quanto attiene la gestione demandata agli enti locali.
La norma regionale ha avuto come primario obiettivo il contrasto alla di-soccupazione attraverso l’inserimento nel modo del lavoro di giovani, donne e categorie svantaggiate, mediante la promozione di attività di formazione professionale e l’adozione di misure straordinarie (art. 1) da attuare in diversi settori, tra i quali quello dei beni culturali. La 28/1984 ha avuto pertanto un ruolo fondamentale nell’assetto della gestione e della produzione di servizi per musei, aree archeologiche e monumenti per un periodo di circa quindici anni: grazie alla legge sull’occupazione, e ai relativi e successivi interventi finanziari, è maturata l’attenzione degli enti locali per il patrimonio culturale di spettanza, sono stati realizzati i primi servizi, è stato sperimentato l’affidamento a terzi di questi ultimi e, in alcuni casi, sono nate alcune realtà di gestione che potremmo definire di tipo “parasistemico”.
La legge mirava a creare forme di occupazione attraverso l’affidamento a terzi − in particolare cooperative e società giovanili costituitesi ad hoc − della
37 Si veda la relazione allegata alla DGR 19/56 del 1983 cit.38 LR n. 28 del 7 giugno 1984, Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione.
27
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
gestione del patrimonio culturale di proprietà degli Enti locali. Le provvidenze regionali per favorire l’occupazione sancite con la 28/1984 furono destinate in particolare: alle cooperative composte da giovani (dai 18 ai 35 anni), donne, emigranti di ritorno e cassaintegrati in numero non inferiore al 50% dei soci, alle società costituite da giovani disoccupati e agli Enti locali per la realizzazio-ne di piani di opere pubbliche e di interventi socialmente utili39.
Con l’articolo 11 la norma prevedeva un contributo agli Enti locali − Comuni singoli o associati, Province, Comunità montane − pari al 70% dei costi necessa-ri per avviare attività nei settori «dei servizi sociali e della tutela e valorizzazio-ne dei beni ambientali e culturali», da affidare in convenzione a cooperative o società giovanili rispondenti ai requisiti stabiliti all’articolo 1 della legge. La Re-gione si rendeva cioè disponibile a sostenere l’avvio dell’occupazione in manie-ra capillare, supportando le iniziative intraprese e controllate dagli enti locali.
Il patrimonio culturale degli Enti locali è interpretato dalla Regione come un’opportunità di sviluppo occupazionale per aree particolarmente svantag-giate; grazie al sostegno regionale le amministrazioni locali sono sollecitate ad affidare a terzi la gestione dei servizi ed è evidente che, in questo modo, si mira ad un duplice obiettivo: incentivare la nascita di cooperative e società attive sul territorio e sviluppare il settore turistico-culturale, potenziando i servizi delle strutture di quelle aree geografiche escluse dal turismo balneare ma ricche di testimonianze culturali. Chiaramente questi due obiettivi sono riconducibili, più che alla promozione del patrimonio, alla volontà di creare occupazione nelle zone dell’Isola economicamente depresse mediante la “messa in valore” delle risorse culturali di potenziale attrazione turistica.
Ispirato alla politica di promozione dell’occupazione è poi il capo VI del-la legge finanziaria regionale per l’anno 1988 (legge regionale 11/1988), che stanziava (art. 92) per il triennio 1988-1990 la somma di 160 miliardi di lire, all’anno, per l’attuazione di un programma di progetti speciali atti a favorire il lavoro40. Tale programma, secondo la legge, doveva articolarsi per aree territo-
39 Altre categorie furono: giovani e donne disoccupati, cassaintegrati e emigranti di ritorno che avviassero nuove imprese; imprese turistiche, artigiane e commerciali. LR 28/1984, articolo 1.
40 LR n. 11 del 4 giugno 1988, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988). Attraverso la legge regionale 11/1988, per il settore «Progetti Speciali 7 a/1 Gestione di Beni culturali» sono state avviate le seguenti gestioni: Sito di Giara (Comunità Montana XXV); Aree monumentali e panoramiche e Museo Etnografico di Ortacesus; Museo Civico Archeologico di Ozieri; Museo Civico Archeologico e Tophet di Sant’Antioco; Area archeologica Sa Carcaredda –
28
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
riali ed esplicitarsi sulla base dei relativi tassi di disoccupazione stabiliti dalle rilevazioni Istat. I progetti speciali della Regione, da attuarsi preferibilmente attraverso convenzioni con soggetti pubblici e privati (art. 3), riguardavano azioni mirate all’attivazione di servizi culturali, alla riqualificazione urbana e ambientale, al censimento, alla catalogazione e al restauro del patrimonio cul-turale (art. 6). I progetti dovevano prevedere l’utilizzazione del finanziamento secondo specifici parametri, ovvero: una quota, non inferiore all’ 80%, in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare, una quota non superiore al 15 % per la dotazione delle attrezzature e una quota non superiore al 5% per oneri di assistenza per la predisposizione e realizzazione dei progetti.
La legge stabiliva inoltre che, sulla base delle proposte giunte dai soggetti interessati, la Regione dovesse redigere un programma di progetti speciali da finanziare − previa verifica della rispondenza ai requisiti specifici − con risorse regionali ma anche statali e comunitarie.
Grazie alla legge regionale 28/1984, ai programmi finanziati sulla base degli articoli 92 e 93 della legge finanziaria regionale per il 1988 e alla successiva legge regionale 37/1998 sullo sviluppo produttivo dell’Isola, furono avviati in Sardegna, e portati avanti nel corso degli anni Novanta, molti progetti, per i quali gli Enti locali affidarono a società e cooperative giovanili la gestione dei musei e di altre strutture di loro spettanza41. La legge regionale 11/1988 è stata più volte rimodulata, a partire dalla legge finanziaria regionale del 1989 con la quale furono cambiati i parametri di spesa42. Nuovi stanziamenti per i
Serra Troculu di Villagrande Strisaili; Museo Civico Archeologico e Sito archeologico Su Mulinu di Villanovafranca. Cfr. Tabella 1, allegato alla deliberazione n. 61/30 del 20 dicembre 2005, Linee di indirizzo relative all’erogazione di contributi agli Enti Locali pubblici territoriali della Sardegna per concorrere agli oneri d’esercizio dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito culturale. LR 21.4.2005 n. 7 art. 12 comma 3. UPb S 11027 Capitolo 11212, UBP S 11 0 33 Capitolo 11247. Con la legge finanziaria per il 1987 (LR 6 del 24 febbraio 1987) fu approvato il Piano straordinario triennale per favorire l’occupazione: «Al fine di incentivare l’occupazione l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, tramite il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, la somma di lire 60.000.000.000 per ciascun anno 1987, 1988 e 1989 (sulla base del programma di ripartizione predisposto dall’ Assessore del lavoro approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall’ entrata in vigore della presente legge)».
41 LR n. 37 del 24 dicembre 1998, Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio. A queste leggi si era aggiunta la n. 6 del 24 febbraio 1987.
42 Una quota non inferiore al 70% in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare; una quota non superiore al 23% per la dotazione di attrezzature; una quota
29
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
musei si ebbero poi per il triennio 1992-1994 con la legge finanziaria regionale 6/1992 che, all’articolo 86, concedeva fondi per il riattamento, le dotazioni di attrezzatura e l’incremento dei musei di interesse locale, estendendo dunque i contributi regionali anche a quelle realtà con proprietà giuridica diversa (altri enti pubblici, ecclesiastici o soggetti privati)43.
La legge sull’occupazione del 1984 e i successivi interventi finanziari regio-nali a sostegno dei musei locali sono stati, senza dubbio, un essenziale stru-mento di rinnovamento per le realtà museali del territorio, stimolando gli enti pubblici e locali sul terreno della gestione dei beni di propria competenza: con l’affidamento a terzi di servizi museali pur essenziali, come l’apertura delle strutture, sono maturate le competenze in loco ed è aumentata l’offerta di un settore fino ad allora rimasto in ombra. Tuttavia la messa in pratica di politiche di tipo, per così dire, “assistenzialistico” − riconoscibili, per esempio, nei finan-ziamenti agli enti locali; finalizzati alla creazione di occupazione e non tanto alla elaborazione di modalità virtuose di gestione − ha inibito il pieno sviluppo del settore. Su questo aspetto la Regione proporrà una importante riflessione a partire dai primi anni Duemila, cercando di produrre indirizzi capaci di miglio-rare gli strumenti di gestione fino ad allora attuati e destinare l’erogazione delle risorse solo a quelle realtà in grado di soddisfare speciali requisiti44.
Di certo, emerge la tendenza, da parte dell’Amministrazione regionale, a portare avanti i progetti per il patrimonio culturale non in maniera organica
non superiore al 7% per l’assistenza tecnica alla predisposizione e l’attuazione dei progetti. LR n. 18 del 30 maggio 1989, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione, articolo 63.
43 Rispetto alla LR 1/1958 (art. 3) che autorizzava le spese regionali per i musei di ente locale, tra i destinatari dei contributi sono contemplati ora anche ai musei di “interesse locale”. LR n. 6 del 28 aprile 1992, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992), art. 86. Altre norme inerenti i progetti speciali per l’occupazione sono state le leggi regionali 27/1993 e 37/1998, quest’ultima con disposizioni relative allo sviluppo del sistema produttivo sardo. Per i finanziamenti ai musei di interesse locale furono varati specifici criteri: i contributi dovevano infatti essere utilizzati per il miglioramento e l’incremento dei musei esistenti e finanziare iniziative particolarmente qualificanti ed utili al «riequilibrio territoriale della rete museale dell’Isola». DGR n. 25/49 del 30 luglio 1992 recante criteri e modalità di concessione dei contributi a favore dei titolari dei musei di interesse locale.
44 Su questo aspetto la Regione lavorerà in particolare con la legge finanziaria per l’anno 2000, indirizzando enti locali e cooperative coinvolte nella gestione del patrimonio culturale verso il miglioramento di servizi e verso logiche gestionali finalizzate all’“auto-sostentamento”. Si veda, infra, paragrafo 6.
30
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
− seguendo cioè una programmazione puntuale in materia − ma attraverso finanziamenti stabiliti di anno in anno con leggi finanziarie.
¬ 4.1 Prime riflessioni sul concetto di sistema museale in Sardegna
Il rinnovato interesse per lo sviluppo del settore dei beni culturali, soprat-tutto in funzione occupazionale, è confermato dall’organizzazione della prima Conferenza Regionale sui beni culturali e ambientali, tenutasi a Cagliari nel 1984, che offrì l’occasione di un confronto sul tema della gestione del patrimonio culturale sardo45. Dalle relazioni tenute alla Conferenza, si capisce quali fossero i problemi sentiti come più urgenti e quali le soluzioni ritenute più consone: malgrado si tratti nella maggior parte dei casi di pure dichiarazioni d’intenti, che non troveranno cioè immediata attuazione, la Conferenza di Cagliari mo-stra cosciente ponderazione sul tema della gestione dei museiche mette in luce problemi ancor’oggi esistenti.
Ripercorrere i progetti presentati in quel contesto dall’allora assessore uscente alla Pubblica istruzione Fausto Fadda, può essere utile per compren-dere come il quadro complesso della gestione del comparto museale fosse già abbastanza nitido al tempo e come si andassero enucleando soluzioni apposite, la cui realizzazione si è concretizzata molti anni dopo.
I punti cardine del discorso di Fadda riguardano tre aspetti: la necessità per la Sardegna di una rivendicazione di maggiori poteri e competenze nel settore dei beni culturali, l’inadeguatezza delle allora vigenti norme regionali su musei e biblioteche di enti locali e la visione del patrimonio culturale come fonte di sviluppo occupazionale alternativa a quella industriale in crisi46.
Nella sua prolusione l’assessore regionale affermò la necessità di reclamare per la Sardegna maggiori poteri e competenze nel settore dei beni culturali, così come avveniva da anni in altre Regioni a statuto speciale e in particolare in Sicilia; inoltre, considerando lo stretto vincolo esistente tra patrimonio storico-artistico, archeologico e monumentale da un lato e patrimonio linguistico ed ambientale dall’altro, Fadda auspicava una competenza regionale primaria per ambiente, monumenti, beni archeologici, demoetnoantropologici e patrimonio linguistico, mentre per il patrimonio storico-artistico e archivistico promuove-
45 I lavori della conferenza furono pubblicati nel volume Cultura e Ambiente, cit. 1986.46 F. Fadda, Stato attuale cit. 1986, pp. 11-26.
31
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
va una competenza regionale di tipo concorrente47. Stigmatizzate l’assenza di leggi regionali organiche sulla gestione del patrimonio culturale e la penuria di risorse economiche destinate agli interventi di settore, nella relazione si sottoli-neava poi l’urgenza di una programmazione regionale pluriennale, da attuare con piani annuali, per evitare sprechi di risorse48.
Il patrimonio culturale viene interpretato − alla luce della crisi che colpiva il «fragile apparato industriale» dell’Isola − come una «risorsa» capace di svilup-pare effetti positivi sull’occupazione locale: in questo senso, quindi, le politiche regionali per i beni culturali avrebbero dovuto assumere anche «precise finalità di carattere economico»49.
Come anticipato, nel tentativo di rinnovare la normativa regionale relativa a musei e alle biblioteche, la Giunta allora uscente aveva predisposto due distinti disegni di legge: nel disegno di legge per i musei, in particolare, si dettavano norme sulla classificazione, sugli standard minimi degli organici e si prevede-va la creazione di un sistema museale integrato50. Nel discorso dell’assessore Fadda si legge:
[…] anche in questo settore, come per le biblioteche, è importante il concetto di sistema. Occorre puntare cioè al sistema museale regionale integrato, come mezzo che consenta sia un contenimento di costi, sia una giustificazione e valorizzazione di strutture museali anche minime, che altrimenti avrebbero scarsa incidenza e scarso rilievo. È essenziale al riguardo, specie per queste raccolte museali, il collegamento con la biblioteca ed altri centri culturali eventualmente esistenti nel Comune.
L’assessore, infine, si sofferma sulla questione della creazione di nuovi mu-sei, che giudica attività fino ad allora lasciata all’iniziativa dei Comuni e che invece necessiterebbe di essere incardinata nella programmazione regionale.
Esiste dunque in Sardegna, già nei primi anni Ottanta, l’idea di organizzare il comparto museale mediante l’applicazione di standard, la razionalizzazione del numero dei musei e la creazione di un sistema museale regionale «integra-to». Dalle parole di Fadda, il modello di sistema prospettato ha per obiettivo non solo il risparmio di risorse economiche, ma anche la valorizzazione cultu-
47 Ibidem p. 14.48 La necessità della pianificazione era stata sottolineata anche nel «Piano di Sviluppo
approvato con la delibera di Giunta regionale del 23 novembre 1982», Ibidem p. 19. 49 F. Fadda, Stato attuale cit. 1986 p. 20.50 Cfr. e. orrù in Cultura e ambiente cit. 1986, pp. 38-40.
32
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
rale di musei e strutture “minori” attraverso la messa in rete di questi ultimi con altri centri culturali presenti sul territorio, come peraltro già avveniva per le biblioteche.
Per comprendere come si orientassero gi Enti locali, è utile analizzare un’al-tra relazione tenuta alla conferenza, relativa al caso del museo di interesse comprensoriale denominato Genna Maria nel comune di Villanovaforru (Medio Campidano), uno dei primi tentativi di approccio sistemico alla gestione muse-ale in Sardegna. Il Museo di Villanovaforru fu definito di interesse comprenso-riale dal XXV Comprensorio (poi XXV Comunità Montana) già prima della sua apertura: l’obiettivo era quello di creare un museo − nel territorio degli scavi archeologici del villaggio nuragico di Genna Maria appunto, emerso nel 1969 − capace di connettere questa e le altre emergenze archeologiche e ambientali diffuse nell’area geografica limitrofa, la Marmilla Inferiore, tra le quali spicca, a poca distanza, il noto complesso nuragico Su Nuraxi a Barumini. La prima idea per la conservazione e la promozione del patrimonio culturale di quest’area è stata quindi quella di istituire un museo unico, di riferimento per tutti i comuni del comprensorio, dove custodire i reperti provenienti dal territorio. È interes-sante notare che nella relazione tenuta al convegno del 1984 da Ubaldo Badas, al tempo curatore del Parco e del Museo archeologico di Genna Maria, ricorre proprio il termine «sistema museale» e ciò fa capire come la prima intenzione fosse stata quella di creare, appunto, una sorta di sistema che immaginiamo articolato nelle diverse aree archeologiche e con un “centro” nel museo di Villa-novaforru. Il progetto di “sistema” non si realizzò − almeno al tempo − a causa di mancate adesioni da parte di alcuni enti locali e mutò, invece, nel torno di pochi anni nella realizzazione di un consorzio turistico intercomunale. Il man-cato raggiungimento di un accordo viene collegato da Badas a uno spiccato campanilismo e all’assenza di politiche mirate: «La colpa, è chiaro, non è solo della politica culturale dei comprensori, che non esiste, coloro che vogliono co-struire sistemi museali integrati e con senso della democrazia vogliono consul-tare gli enti intermedi, farebbero bene a tener conto della incapacità di superare i municipalismi51».
Il museo di Villanovaforru nasceva con un preciso intento: quello di fungere da «presidio di tutela, studio e valorizzazione dei beni culturali non solo di ambito comunale ma comprensoriale e sostenere l’attività degli istituti preposti giuridicamente alla tutela e alla ricerca nel settore, cioè le Soprintendenze e le
51 u. BaldaS, Musei di interesse comprensoriale: esperienze e proposte in Cultura e ambiente cit. 1986, pp. 275-278.
33
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
Università»52. Questa volontà riflette pienamente il clima culturale di quegli anni e, in particolare, la concezione di museo come “presidio” che si stava af-fermando anche grazie al lavoro di ricognizione sul territorio in Regioni come Lazio, Umbria ed Emilia Romagna e alle analisi di Andrea Emiliani e Bruno To-scano: il museo è il centro di un sistema territoriale di beni culturali e il motore propulsore di attività scientifiche e di controllo sul territorio; il sistema museale quindi viene interpretato non solo come strumento gestionale, ma come rete di collegamenti culturali tra beni presenti in una stessa area, accomunata da manifestazioni di significato storico e culturale condiviso53.
Questo virtuoso modello di sistema non si è realizzato, quasi mai, né in Sar-degna né nel resto d’Italia ma le logiche municipalistiche che ne arrestarono la concretizzazione nella Marmilla non impedirono la nascita di un Consorzio intercomunale di tipo turistico. Il Consorzio di valorizzazione turistica e ambientale della Marmilla nacque infatti nel 1982 e vi parteciparono inizialmente i Comu-ni di Collinas, Lunamatrona, Siddi e Villanovaforru. Il Consorzio – successi-vamente denominato Sa Corona Arrùbia – individuò la propria missione nella promozione e nella gestione di tutte le iniziative volte «allo sviluppo turistico, artigianale, industriale, agricolo, commerciale nonché della valorizzazione dei beni ambientali, archeologici, architettonici, storici, demo antropologici» della zona54. Nel corso degli anni hanno aderito al Consorzio molti altri enti locali: oggi vi partecipano venti Comuni con sedici musei, sei aree archeologiche e un parco di interesse ambientale. Oltre ad alcune strutture private, come il Castello giudicale di Sanluri, in tempi recenti sono state inserite nella sfera d’azione del Consorzio anche le strutture di proprietà di quest’ultimo. Il Consorzio, infatti, nel corso degli anni ha acquistato terreni privati attrezzandoli per la visita, re-alizzando così il Parco dei Monumenti Nuragici che include oggi oltre trenta siti archeologici.
Anche grazie alla capacità di intercettare risorse economiche messe a di-sposizione da bandi pubblici, ai quali il Consorzio partecipa come “operatore collettivo”, l’esperienza del Consorzio appare oggi molto positiva nell’ambito
52 Ibidem53 Questa lettura del patrimonio culturale e, in particolare, il concetto di museo locale
come “presidio” ispira in quegli anni (1979-1983) l’indagine sui musei del Lazio diretta da Bruno Toscano, pubblicata come supplemento al Bollettino d’Arte nel 1985. I Musei locali del Lazio, supplemento a “Bollettino d’Arte” 30, 1985.
54 Dallo Statuto del Consorzio Turistico della Marmilla “Sa Corona Arrùbia”, approvato successivamente alla costituzione del Consorzio il 10 dicembre del 1999. Si veda in questo stesso volume la scheda dedicata al Consorzio.
34
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
della promozione culturale del patrimonio locale e, in questo senso, si confi-gura come una delle realtà sistemiche tra le più vivaci dell’Isola. La funzione principale del Consorzio è stata, ovviamente, quella della promozione turistica ma nel corso degli anni l’ente si è impegnato nell’apertura di musei e siti arche-ologici, oltre che centri di ristoro e strutture per l’accoglienza turistica, dando luogo a un “sistema”. I musei e i siti che aderiscono al Consorzio sono gestiti da soggetti diversi: quelli di proprietà dello stesso Consorzio sono gestiti da una società per azioni a capitale misto (Consorzio e INSAR), nata appositamente nel 2000 e denominata Sa Corona Arrùbia, quelli di proprietà del Comune di Barumini sono gestiti dall’omonima Fondazione creata dall’amministrazione comunale, mentre i beni di proprietà dei Comuni sono in genere affidati a coo-perative locali55. In tempi più recenti infine, in seguito alle indicazioni regionali relative alla razionalizzazione del sistema museale sardo, anche all’interno del territorio di riferimento del Consorzio sono sorti alcuni sistemi museali a esten-sione comunale o intercomunale, che si prefiggono il raggiungimento di stan-dard museali più alti56. La complessa realtà del Sa Corona Arrùbia rappresenta piuttosto bene l’esito delle politiche regionali sarde degli anni Ottanta, mirate a creare occupazione e sviluppo economico mediante la “valorizzazione” del patrimonio culturale nelle aree escluse dal turismo balneare. Sebbene il grande numero di soggetti gestori di beni e servizi – perlopiù cooperative e società nate proprio a seguito della legge per l’occupazione del 1984 – non corrisponda all’idea di gestione unitaria che spesso − almeno teoricamente − è alla base del concetto di “sistema”, le attività operate dal Consorzio hanno, di fatto, reso fru-ibili monumenti, aree archeologiche, itinerari naturalistici, musei e collezioni travalicando quindi la semplice promozione territoriale. Tuttavia, rispetto alla primordiale idea di “sistema” – elaborata nei primi anni Ottanta e che artico-lava l’insieme dei beni locali attorno al Museo archeologico di Villanovafor-ru – nel corso degli anni si sono delineate considerevoli differenze: in primo luogo non si è realizzato un unico sistema museale per tutto il comprensorio ma sono sorti più sistemi a estensione territoriale ridotta; in secondo luogo il centro delle attività culturali del Consorzio si è spostato progressivamente dal Museo archeologico di Villanovaforru al Museo del Territorio, sorto a poca di-
55 La stessa Spa partecipata dal Consorzio affida la gestione del patrimonio di quest’ultimo a cooperative del territorio.
56 Sono il sistema museale denominato Muster, cui partecipa anche il Consorzio, attivo fino al 2008; il sistema LOGUS, progettato ma non attivato; il sistema museale della Fondazione Barumini. Si vedano in questo volume le schede relative al sistema Muster e alla Fondazione Barumini Sistema Cultura.
35
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
stanza all’inizio degli anni Novanta, grazie ai finanziamenti relativi all’accordo tra Consorzio e Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di itinerari turistici57.
¬ 4.2 I finanziamenti straordinari
Anche la Sardegna fu inserita tra le Regioni oggetto dei finanziamenti per i progetti speciali della Cassa del Mezzogiorno relativi ai cosiddetti Itinerari turistico-culturali promossi dal Ministero per gli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno in accordo con il Ministero dei Beni culturali. Alla base del pro-getto Itinerari vi erano la lettura della storia dell’Italia del Sud come insieme di correlazioni tra antiche civiltà mediterranee e la volontà di creare itinerari in grado di valorizzare questi legami. L’obiettivo era quello di rendere fruibile il grande patrimonio culturale dell’Italia meridionale attraverso itinerari tematici capaci di rendere “attrattivi” territori esclusi dal turismo.
Il progetto degli Itinerari è interessante per il nostro studio poiché rappre-senta, almeno teoricamente un tentativo di valorizzazione del patrimonio, su territori accomunati da caratteristiche storiche affini, che si accosta al concetto di “sistema”.
La delibera CIPE del 13 maggio 1982 dispose uno «stanziamento per attivare stralci funzionali dei programmati itinerari»58: vi si pianificavano interventi per il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali, la realizzazione di musei, il restauro di monumenti, l’attivazione di scavi archeologici, il potenziamento delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi connessi alle esigenze turistiche l’accrescimento della ricettività alberghiera e la formazione professionale. Con-testualmente si volevano recuperare tutte quelle manifestazioni tradizionali delle aree interessate come l’artigianato e le celebrazioni folkloristiche. L’artico-lazione territoriale degli itinerari prevedeva diverse direttrici, quella che attra-versava la Sardegna fu denominata Fenicio-cartaginese-nuragico e rappresentava un segmento di quella più ampia dedicata al mondo fenicio e cartaginese svi-luppata in Sicilia e Sardegna59.
57 Si fa riferimento alla «Convenzione 109/90 del 30 maggio 1991 tra Consorzio Sa Corona Arrùbia e Agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, regolante il finanziamento per la realizzazione di itinerari turistici per la valorizzazione delle risorse del territorio consorziale in base alla legge n. 64 del 1986 e alla Delibera CIPE del 29/03/1990». Il Museo del Territorio è infatti collegato con gli itinerari dell’area.
58 Delibera CIPE n. 29 del 13 maggio 1982, Intervento straordinario quinquennio 1976-1980, Progetto speciale Itinerari turistici culturali.
59 Le altre direttrici stabilite dalla delibera CIPE furono: Magna Grecia per Campania,
36
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Il progetto degli Itinerari in realtà ebbe diversi problemi di natura burocra-tica che portarono alla segmentazione del programma per Regioni e all’affida-mento della gestione a diversi enti che a vario titolo si occupavano al tempo di promozione turistica e di sviluppo per il Mezzogiorno60.
Con la successiva delibera CIPE del dicembre 1982 furono comunque stan-ziati in tutto cento miliardi per le Regioni e centocinquanta miliardi per i pro-grammi di competenza statale: di queste somme furono destinati alla Sardegna 9.900 milioni per le attività regionali e 4.800 per quelle statali61. Il progetto per gli itinerari meridionali suscitò grandi aspettative nell’Isola, sebbene ancora nel 1984 − al tempo cioè del citato convegno Cultura e Ambiente − la Regione atten-desse l’accreditamento dei fondi di propria competenza62. Con la legge finan-ziaria regionale del 1986 le somme non ancora impegnate sui titoli di spesa del Quinto programma esecutivo del Piano di rinascita63 − oltre agli interessi maturati
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; Appia Antica nelle regioni di Lazio, Campania, Puglia e Basilicata; la direttrice Arabo-bizantino-normanno-svevo interessava Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia; quella denominata Transumanza e civiltà sannitiche per Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. A queste si aggiungevano poi la direttrice Habitat rupestri in Puglia e Basilicata, quella denominata Capitali del Barocco in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e infine la Greci e Romani da sviluppare in Lazio e Campania. Allegato 7 alla Delibera CIPE n. 29 del 13 maggio 1982; Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 1982, Approvazione programma stralcio progetto per gli itinerari turistico culturali nel Mezzogiorno.
60 All’elaborazione del progetto per gli itinerari parteciparono vari enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno come l’INSUD, che si occupò degli interventi di promozione turistica, mentre le attività per la formazione professionale furono demandate al Formez. L’arco temporale di attuazione del progetto fu previsto nel quinquennio 1982-1987. Allegato 7 alla Delibera CIPE n. 29 del 13 maggio 1982; Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 1982, Approvazione programma stralcio progetto per gli itinerari turistico culturali nel Mezzogiorno. Cfr. anche p. lorello, Il turismo dei beni culturali nei documenti di programmazione regionali in p. BuSetta, r. ruozI (a cura di), L’isola del tesoro. Le potenzialità del turismo culturale in Sicilia, Liguori Editore, Napoli 2006, pp. 95-96.
61 Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 1982 con cui si davano 60 giorni alle Regioni per la presentazione dei singoli programmi esecutivi.
62 F. Fadda, Stato attuale cit. 1986, pp. 15-16. 63 Con la legge n. 588 del 11 giugno 1962, Piano straordinario per favorire la Rinascita
economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell’articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, il comitato dei ministri per il Mezzogiorno e la Regione Sardegna disposero la creazione di un piano straordinario di interventi per il progresso economico e sociale dell’Isola (art.1). Nell’ambito di questo piano straordinario si prevedeva anche la formulazione di programmi pluriennali e annuali la cui attuazione veniva delegata alla Regione (artt. 4 e 5). Nel 1974 il Piano di rinascita fu
37
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
al termine del 1985, ai recuperi e rimborsi non ancora utilizzati sulla relativa contabilità speciale − furono destinate, fino a un importo massimo di venticin-que miliardi di lire, a uno stanziamento integrativo per il Programma di Itinerari Turistico-Culturali previsto dal Programma straordinario di intervento per il 1985; la stessa legge inoltre autorizzò un’ulteriore spesa di venticinque miliardi per l’esecuzione del medesimo programma da iscrivere nel bilancio regionale64.
È difficile valutare oggi come abbiano inciso i finanziamenti per gli Itinerari nel Mezzogiorno in Sardegna, specialmente per il comparto museale; di fatto, nel 1987, i finanziamenti statali per la Sardegna salirono da due a più di ventisei miliardi, che furono utilizzati soprattutto per il progetto turistico-culturale “fe-nicio-cartaginese-nuragico”, mentre una minima parte fu destinata al restauro di edifici e monumenti statali65.
Sicuramente la progettazione CIPE contribuì ad aumentare le minime risor-se destinate al patrimonio culturale sardo: nella graduatoria della spesa delle Regioni autonome per i beni culturali per gli anni 1986 e 1987, infatti, la Sarde-gna risultava all’ultimo posto con una spesa di 11.645 milioni di lire a fronte, ad esempio, dei 97.224 milioni della Sicilia66.
Se la spesa regionale sarda per la cultura risulta in diminuzione nel biennio 1985-1986 appare invece in aumento nel 1987, quando si stanziarono 18 mi-liardi (oltre ai 25 per gli itinerari turistico-culturali), e tra il 1988 e 1991, quan-
rilanciato e rifinanziato attraverso la legge n. 268 del 24 giugno, Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962 n. 588, mentre le relative procedure furono normate dalla legge regionale n. 33 del 1975. La 33/1975, in attuazione al Piano di rinascita, predispose un programma straordinario di riforma per il settore agro-pastorale e stabilì che la Regione adottasse e proponesse al CIPE il Piano generale di sviluppo e i programmi pluriennali (art. 4). Nella programmazione pluriennale, in particolare, doveva essere indicato l’insieme degli interventi, coerenti con gli obiettivi di sviluppo, da realizzare in un lasso di tempo definito e inferiore ai sei anni. Nel corso degli anni la programmazione ha riguardato soprattutto interventi per le piccole e medie industrie e la valorizzazione delle risorse locali con particolare riferimento a quelle agro-pastororali, turistiche e minerarie.
64 LR n. 44 del 27 giugno 1986, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1986), artt. 13 e 14. Si veda anche Camera dei Deputati, I Beni culturali in Italia: indagine conoscitiva della Commissione cultura, scienza e istruzione (dicembre 1988-dicembre 1991) e documentazione allegata, vol. II, Camera dei Deputati, Roma 1992, p. 163.
65 Si veda I Beni culturali in Italia, vol. II cit. 1992, pp. 164-165.66 I dati si riferiscono all’anno 1986. Si veda la tabella n. 6a in I Beni culturali in Italia, vol.
II cit. 1992.
38
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
do la spesa aumenta ancora del 45% e il settore che fa registrare l’incremento maggiore (+ 74%) è quello della “tutela del patrimonio artistico”. Tali risorse risultano principalmente trasferite agli Enti locali per il restauro di centri stori-ci, edifici, chiese e monumenti ma anche per il finanziamento di cooperative di giovani attivatesi nel settore dei beni culturali. In questi anni furono destinate risorse al patrimonio culturale sardo anche attraverso i finanziamenti FIO (deli-bera CIPE 37 del 12 maggio 1988), stanziati per diversi progetti come il «restau-ro conservativo e l’adeguamento funzionale del sistema museale di Cagliari», l’intervento di recupero ambientale e museale del Parco e del Castello di San Michele e quello per il Polo museale sassarese67.
Concreti interventi regionali sul patrimonio museale degli Enti locali si regi-strano in Sardegna solo a partire dal 1977: infatti tra il 1977 e il 1983 la Regione aveva concesso finanziamenti a trentacinque Comuni con una spesa di circa due miliardi e mezzo di lire; tale cifra tuttavia risulta, stando alla relazione del funzionario regionale Antonio Sanna tenuta in occasione della Conferenza di Cagliari del 1984, «modesta, del tutto insufficiente alle richieste e alle reali esigenze per la creazione di una rete di musei locali nelle zone più ricche di testimonianze archeologiche, storiche, etnografiche e naturalistiche»68. La gran parte dei finanziamenti anche allora fu destinata al restauro di monumenti, mentre ben più esigua fu la somma di denaro rivolta agli interventi relativi a scavi archeologici e musei.
La volontà di procedere con opere di restauro e ripristino prosegue anche nei primi anni Novanta, come testimonia la legge regionale finanziaria del 1991 che prevedeva, all’articolo 20, l’esecuzione di un programma rivolto agli edifici di culto con una spesa complessiva di 14 miliardi di lire da destinare al restauro di chiese di particolare interesse storico-artistico, già vincolate ai sensi della legge 1089/193969. Contemporaneamente − tra il 1988 e il 1991 − i finanziamenti per i musei destinati ai Comuni scendono da 1,3 miliardi a 800 milioni mentre au-mentano quelli per le biblioteche (da poco meno di 3 miliardi a 4,3) così come le spese per le attività culturali consistenti prevalentemente in trasferimenti di spesa corrente ad associazioni culturali.
67 Nel caso di Cagliari, per «sistema museale» si intende l’insieme dei musei esistenti, non una forma di gestione congiunta.
68 L’unico intervento di un certo rilievo precedente al 1977 fu quello destinato al Comu-ne de La Maddalena per la costruzione del museo archeologico navale. Cfr. A. Sanna, Attività svolte nel settore dei Beni culturali in Cultura e ambiente cit. 1986, p. 64.
69 LR n. 13 del 30 aprile 1991, Disposizioni finanziarie per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991), art. 20.
39
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
Gli anni Ottanta dunque rappresentano un decennio in cui aumenta, almeno a livello propositivo, l’attenzione dell’Amministrazione regionale sul tema dei musei locali e della loro gestione; gli stessi enti locali, del resto, in questi anni sono maggiormente coinvolti nella conservazione e nella promozione del pa-trimonio culturale e ciò comporta la crescita delle domande di finanziamenti regionali. Questo fenomeno trova probabile spiegazione nella modifica appor-tata dalla legge regionale 49/1979 alla precedente 1/1958: se, infatti, fino ad allora potevano essere solo le Soprintendenze a ottenere contributi dalla Regio-ne per interventi di restauro, con la norma del 1979 si dà tale possibilità anche ai Comuni, ai Consorzi, alle Comunità montane e agli altri organismi pubblici comprensoriali70. Verso la fine degli anni Ottanta anche la spesa pubblica per il patrimonio culturale risulta in ascesa, grazie ai finanziamenti CIPE dovuti al progetto degli Itinerari nel Mezzogiorno, e si gettano così le basi per l’avvio di nuove azioni volte alla conservazione e alla valorizzazione sul territorio.
5. Gli anni Novanta
La fine degli anni Ottanta segna un momento importante anche per quanto riguarda la preservazione del patrimonio ambientale dell’Isola, un aspetto par-ticolarmente avvertito dall’associazionismo locale. Ls sensibilità al tema della tutela delle zone di interesse naturale, sia costiere che montane, e dei cosiddetti “monumenti naturali” esisteva già negli anni Settanta, come attesta la proposta per un sistema di parchi e riserve elaborata, con l’individuazione di diverse aree da proteggere, da Cassola e Tassi nel 197371.
Nel 1985 fu emanata la legge regionale n. 23 relativa al controllo dell’attività edilizia e al risanamento urbanistico, mentre nel 1989 la Regione promulgò la legge n. 45 che norma l’uso e la tutela del territorio regolando soggetti e stru-menti per la pianificazione72. Con la legge regionale n. 31 del 1989, invece, la Regione regola l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve naturali, delle
70 Nel 1984 le richieste di finanziamento di questo tipo all’Assessorato alla Pubblica Istruzione ammontavano a oltre trenta miliardi. Cfr. a. Sanna, Attività svolte cit. p. 67.
71 F. caSSola, F. taSSI, Proposta per un sistema di Parchi e Riserve Naturali in Sardegna, Bollettino Società Sarda Scientifica Naturale, Cagliari, 1973.
72 LR n. 23 del 11 ottobre 1985, Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative. LR n. 45 del 22 dicembre 1989, Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale.
40
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
aree di particolare interesse ambientale e dei «monumenti naturali» al fine di conservare il patrimonio biologico e paesaggistico dell’Isola73. Varata a quattro anni di distanza dalla cosiddetta Legge Galasso (L. 431/1985), la legge regio-nale sarda provvede in primo luogo a dare una definizione di parchi, riserve e monumenti naturali, insistendo sulla necessità di tutelare le aree caratterizzate da valori «naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici»74. All’articolo 5 si definisce il «Sistema regionale dei parchi, riserve e monumenti naturali» come il quadro di riferimento per gli interventi regionali, per la programmazio-ne regionale e locale relativa alle aree protette. Al momento dell’applicazione della legge, in attesa cioè della effettiva istituzione dei parchi, la norma sta-bilsce una perimetrazione provvisoria delle aree, specificando che questa sarà modificabile in fase di approvazione dei singoli atti istitutivi. I parchi e le riser-ve devono infatti essere istituiti con legge regionale, la cui proposta spetta alla Giunta; una volta sentite le eventuali osservazioni degli enti locali interessati, la proposta dalla Giunta passa al Consiglio regionale che determina per l’istituen-do parco o riserva l’organo di gestione, la delimitazione dell’area, le modalità di finanziamento e le attività connesse, le norme di salvaguardia, le strutture di direzione tecnica, le forme di partecipazione delle associazioni interessate a svolgervi attività, i divieti da applicare nelle aree di riserva e così via (artt. 10, 20, 21). L’istituzione dei parchi ha luogo allo scopo di tutelare, risanare, restau-rare e valorizzare ecosistemi, biotopi, paesaggi e habitat naturali, ma anche per qualificare le realtà economiche e occupazionali dell’area di interesse, mediante la promozione di attività culturali ed educative collegabili e compatibili alla fruizione dell’ambiente (art. 11). La gestione dei parchi e delle riserve naturali così costituiti viene affidata alle amministrazioni locali (Comuni, Province, Co-munità montane) o all’Azienda foreste demaniali della Sardegna, secondo la proprietà dei terreni, oppure a consorzi tra detti enti, costituiti con decreto del Presidente della Giunta75. Quale che sia, l’organismo di gestione deve attuare il Piano del parco o della riserva, che è elaborato dalla giunta regionale, e predi-sporre un regolamento che sarà approvato dall’Assessore regionale competente alla difesa per l’ambiente (art. 13). La Regione, infine, promuove il coordina-
73 LR n. 31 del 7 giugno 1989, Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale.
74 Su tale patrimonio si veda G. Barrocu, M. a. Fadda, M. l. GentIlIeSchI, e. pIcozza, S. VannellI, Monumenti naturali della Sardegna, Delfino Editore, Sassari 1996.
75 Secondo la legge gli enti locali possono decidere altresì di affidare all’Azienda foreste demaniali la gestione dei parchi insistenti su aree di propria competenza.
41
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
mento tra i parchi insistenti su territori contigui attraverso l’elaborazione di piani e atti d’intesa tra i soggetti gestori. Attualmente i parchi regionali istituiti in Sardegna sono il Parco di Porto Conte - Capo Caccia e il Parco di Molentar-gius - Saline di Cagliari entrambi nati nel 1999 con legge regionale apposita (rispettivamente LR n. 4/1999 e LR n. 5/1999); risultano invece ancora in fase di costituzione il Parco di Gutturu Mannu, l’Oasi di Tepiloro ed il Parco del Monte Arci76.
L’attività legislativa per la protezione delle aree naturali della Sardegna sem-bra nascere dunque nella seconda metà degli anni Ottanta, tuttavia da tempo appariva evidente come lo strumento dei piani paesistici non riuscisse purtrop-po a essere sufficiente a contrastare il fenomeno della cementificazione in par-ticolare nelle zone litoranee, come denunciato dai competenti uffici periferici del Ministero77.
Nonostante la legge regionale 31/1989 avesse individuato aree di interesse per ben nove parchi, in realtà occorse un decennio per giungere alla costituzio-ne di due parchi regionali. Un caso particolare di tentativo di valorizzazione, tutela e gestione di una serie di aree diverse che comprendono emergenze sia di valore naturalistico che storico-artistico e demoetnoantropologico è quello del Parco denominato Geominerario, storico e ambientale della Sardegna.
Il Parco Geominerario – pur non essendo un parco regionale – offre diversi spunti di riflessione in quanto, includendo differenti tipologie di beni, può es-sere letto come una sorta di «sistema» gestito in maniera unitaria78. La prima idea di creare un parco nell’Iglesiente risale al 1975 quando, in occasione del convegno delle Associazioni culturali e naturalistiche tenutosi ad Iglesias, Fa-bio Cassola − già promotore nel 1973 di una proposta per un sistema dei parchi regionale − avanzò l’ipotesi della creazione di un consorzio per la gestione del-la riserva di Monte Linas, Oridda e Marganai, consorzio cui avrebbero potuto partecipare l’Azienda forestale, le associazioni, gli enti territoriali, le Universi-tà. Al convegno Fabio Cassola presentava poi un programma di massima per
76 Per l’elenco dei Parchi nazionali e regionali, dei monumenti naturali e delle riserve si veda il sito web ufficiale della Regione www.sardegnaambiente.it .
77 Un caso esemplare è stato quello della Costa Smeralda, territorio sottoposto a tutela paesistica fin dal 1961. Si veda, a questo proposito, l’intervento della Soprintendente ai Beni Ambientali, Architettonici e Storici per Sassari e Nuoro alla Conferenza di Cagliari del 1984: M. dander, Tutela dei beni ambientali in Sardegna: problematiche applicative della legislazione vigente e prospettive per il trasferimento delle competenze alla Regione, in Cultura e ambiente, cit. 1986, pp. 232-236.
78 Per una trattazione diffusa del Parco si rimanda alla relativa scheda in questo volume.
42
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
regolarizzare l’accesso a dette aree e crearvi percorsi escursionistici. Nei primi anni Ottanta, anche grazie alla volontà di associazioni – tra le quali Italia No-stra, WWF, CAI, Legambiente – il progetto del parco iglesiente si rafforzò, tanto che nel 1983 fu proposto il suo inserimento nel programma UNESCO Man and Biosphere. Nel 1991 si costituì un comitato locale per l’istituzione del parco che divenne poi, redigendo un proprio statuto nel 1991, un’associazione denomi-nata Comitato permanente per il Parco geominerario, ambientale e storico dell’Igle-siente. Nel contesto della grande crisi delle attività di miniera della Sardegna meridionale, alla luce delle drammatiche conseguenze economiche e sociali per il territorio, grande importanza assunse nel 1996 la partecipazione dell’Ente Minerario Sardo (EMSA) ai progetti del Comitato promotore per il Parco. Con il Parco dunque non solo si prospettavano la cura e la conoscenza del patrimonio naturale e geologico della Sardegna sud occidentale ma si raccoglievano anche le speranze di una riqualificazione culturale e occupazionale per un’area forte-mente segnata dalla crisi. Nel 1997 grazie alla partecipazione al progetto della Regione, degli enti locali, delle associazioni e delle università, fu preparato e presentato all’UNESCO un dossier progettuale nel quale si esponevano i valori archeologici, geologici, storici e naturalistici di ben otto aree individuate come inseribili all’interno del Parco. Anche in conseguenza del successo ottenuto presso l’UNESCO, nel 1998 fu dunque firmata la Carta di Cagliari, un documen-to che fissava principi e finalità dell’istituendo Parco cui seguì uno studio di fattibilità condotto per volere della Regione dalla società Progemisa.
Per la concretizzazione del parco dobbiamo però arrivare alla fine del 2000, quando con la legge finanziaria nazionale 2001 (L. 388 del 23 dicembre 2000) viene assegnato un finanziamento di tre miliardi di lire per il 2001 e di sei mi-liardi a decorrere dal 2002. In base a questi atti e in virtù di tali finanziamenti, il Parco doveva essere istituito con decreto entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge (art. 114, c. 10). Il Parco fu dunque fondato formalmente con decreto ministeriale nel novembre 2001 e la gestione fu affidata a un Consorzio che aveva lo scopo di recuperare il patrimonio minerario dismesso della Sarde-gna valorizzandone gli aspetti storici, ambientali e culturali.
Il Consorzio è costituito dai Ministeri dell’Ambiente, delle Attività produt-tive, dell’Istruzione - dell’Università - della Ricerca, dei Beni culturali, dalla Regione Sardegna, dalle università di Cagliari e Sassari, dagli Enti locali del territorio interessato79. Gli organi principali del Consorzio sono il Presidente,
79 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, Istituzione del parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna.
43
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
il Consiglio direttivo, la Comunità del Parco, il Comitato tecnico-scientifico80. L’organo di gestione del consorzio è il Direttore, responsabile delle attività del Parco e nominato dal Consiglio direttivo, mentre quest’ultimo è formato dal Presidente del Parco e da sedici membri, ovvero: quattro in rappresentanza e su proposta dei Ministeri che partecipano, quattro in rappresentanza e su pro-posta della Regione Sardegna, quattro in rappresentanza e su proposta delle Province e altrettanti in rappresentanza e su proposta dei Comuni. I compo-nenti del Consiglio direttivo sono scelti tra persone di comprovata esperienza, sono nominati dal Ministero dell’Ambiente in concerto con gli altri ministeri e d’intesa con il Presidente della Regione.
Il Consiglio direttivo è l’organo di indirizzo, programmazione e controllo del Consorzio, così come quello della Comunità, formata da un rappresentante per ogni ente o soggetto giuridico che aderisce al Parco: ne fanno parte quindi anche tutti i sindaci dei Comuni e tutti i presidenti di Provincia partecipanti.
Ben presto emergono complessi problemi gestionali per il Consorzio: i mem-bri del Consiglio direttivo, infatti, decadono alla «cessazione del mandato am-ministrativo dell’ente di provenienza» mentre i componenti della Comunità durano in carica per un periodo «corrispondente al mandato dell’ente di pro-venienza che li ha espressi». Ciò significa che, ogni qualvolta muta l’ammini-strazione politica degli enti interessati, devono essere rinominati i relativi rap-presentanti in seno alla Comunità del Parco e nel consiglio direttivo. Lo stretto vincolo tra organi del Consorzio e mandati politici, a livello locale e non, crea una forte instabilità all’interno degli organi di direzione e controllo. Nonostan-te il Consiglio direttivo debba, da statuto, rimanere in carica per quattro anni, di fatto a ogni mutamento politico si deve provvedere a nuove nomine per la gestione del Parco. Questa prassi ha creato i presupposti per immobilizzare le attività dell’Ente, creando precarietà e discontinuità nella programmazione e nell’attuazione delle attività. Proprio a seguito di questa paralisi gestionale si arriva nel febbraio 2007 allo scioglimento del Consorzio e al commissariamento del Parco che perdura tutt’oggi.
Il Parco Geominerario rappresenta un caso piuttosto significativo di tentati-vo di valorizzazione e riconversione del patrimonio di archeologia industriale, legato al mondo delle miniere: pensato negli anni Settanta per iniziativa locale e inizialmente circoscritto a un’area geografica specifica, nel corso di un quarto di secolo viene riprogettato più volte, assumendo un’estensione regionale, e
80 Altri organi sono: il direttore del Parco, i responsabili delle sedi distaccate d’area, il collegio dei revisori dei conti.
44
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
si articola in otto zone. Pur tuttavia il Parco fallisce proprio nella sua struttura gestionale e decisionale al momento del concreto avvio delle attività.
La storia del Parco si lega poi intrinsecamente ai delicati processi di dismis-sione delle miniere e al problema del riassorbimento dei lavoratori. Questi complessi passaggi − che non approfondiamo ma esponiamo per sommi capi − si riflettono anche nelle odierne difficoltà di gestione del Parco. Negli anni Novanta fu l’Ente Minerario Sardo (EMSA) a tenere le fila della progettazione del Parco, essendo fin dal 1968 l’Ente regionale deputato alle ricerche sul pa-trimonio geologico dell’Isola. L’EMSA viene però soppresso nel 1998 con legge regionale n. 33; negli stessi anni, dalle società minerarie non più attive nasceva l’IGEA, una società per azioni che ha lo scopo di mettere in sicurezza le strut-ture inutilizzate e accompagnare la chiusura delle miniere. Nel 2001 fu creata una società consortile, la Geoparco s.c.a.r.l., finalizzata ad attività di bonifica per le miniere dismesse81. Tra i due soggetti scaturirono dunque contrasti di competenze che si risolsero con la firma di un accordo tra Regione, IGEA e Ge-oparco s.c.a.r.l. per la ripartizione dei reciproci compiti. Malgrado tali difficoltà abbiano rallentato l’avvio delle attività del Parco, nelle sue otto aree sono stati realizzati itinerari tematici legati ai diversi giacimenti minerari che caratteriz-zano il sottosuolo della Sardegna – come i percorsi del carbone, dell’ossidiana, dell’argento – e sono state create strutture museali utilizzando talvolta gli stessi complessi dismessi.
Attorno alla crisi del settore minerario e alla sua riconversione, ruotano an-che altri progetti regionali degli anni Novanta: la volontà di ripristinare con destinazioni diverse o, quantomeno, preservare dal degrado l’insieme delle strutture disseminate nell’isola legate alle attività industriali e dismesse è ben testimoniata dalle leggi regionali 38/1993 e 29/1994 volte proprio al censimen-to e al recupero del patrimonio archeologico-industriale dell’Isola82. La legge regionale n. 38 del 1993 istituiva una commissione speciale in seno al Consiglio regionale con lo scopo di appurare la consistenza e la gestione del patrimo-nio minerario della Sardegna, nonché del patrimonio già dismesso da attività mineraria; secondo la legge, la commissione avrebbe dovuto presentare, entro quattro mesi dalla sua costituzione, i risultati dell’indagine, formulando al con-
81 La Geoparco scarl nasce da una ATI che vede la partecipazione di Ifras S.p.A., Intini S.r.l. e Servizi Globali S.r.l.. Si veda il sito web di IFRAS spa : http://www.ifras-spa.it/index.html
82 Del 1993 è anche la legge nazionale n. 204, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna. Ecologia.
45
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
tempo possibili proposte per «una piena tutela a fini produttivi del patrimonio minerario per salvaguardare innanzitutto le finalità sociali e pubbliche del pa-trimonio dismesso» (art. 2)83.
La legge n. 29 del 1994 è invece direttamente volta alla riqualificazione e alla conservazione del patrimonio di archeologia industriale e ha come obiettivo il censimento, la catalogazione e l’organizzazione in strutture museali di que-sta tipologia di beni84. La legge stabilisce che venga creata una commissione specifica per la salvaguardia del patrimonio, che si proceda in accordo con le Soprintendenze a una ricognizione della consistenza e dello stato di conserva-zione dei beni e alla loro catalogazione, imponendo infine che si predispongano piani pluriennali ed annuali per l’acquisizione, il recupero e la valorizzazione delle strutture (artt. 2-8). Una volta individuati i beni da inserire nell’inventario regionale, la Regione può concedere contributi agli enti locali sia per l’acquisi-zione delle strutture sia per il loro restauro o manutenzione: nel primo caso il contributo concesso può arrivare fino al 90%, nel secondo al 70% (art. 9). Natu-ralmente gli enti interessati devono indicare la destinazione d’uso e le modalità di utilizzazione delle strutture, che devono essere coerenti con gli obiettivi della legge. La Regione, inoltre, può acquisire direttamente i beni del patrimonio ar-cheologico-industriale che ritenga di particolare interesse e concedere comples-si o singoli beni a soggetti, privati e pubblici, che garantiscano idonee attività di gestione e utilizzazione (art.10); l’amministrazione regionale ha poi il compito di favorire il collegamento tra i diversi enti territoriali e coordinare le attività di valorizzazione del patrimonio.
In merito al recupero del territorio, dobbiamo infine ricordare la legge n. 29 emanata nel 1998, volta alla conservazione e alla riqualificazione dei centri storici. Con questa legge la Regione, al fine della «valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione del consumo di risorse territoriali», considera «preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione e il riuso» dei centri storici e dei centri minori85. Viene quindi ordinata la redazio-ne di un repertorio regionale dei centri storici con l’obiettivo di costituire un quadro di riferimento per la programmazione regionale di settore. I Comuni interessati possono fare richiesta di inserimento in detto repertorio ed essere
83 LR n. 38 del 10 settembre 1993, Istituzione di una Commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio minerario della Regione.
84 LR n. 29 del 9 giugno 1994, Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Sardegna.
85 LR n. 29 del 13 ottobre 1998, Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna.
46
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
così inclusi nei programmi regionali che mirano alla riqualificazione e al rior-dino urbanistico.
In questo clima di rinnovamento degli anni Novanta, si inserisce anche la volontà di provvedere a una maggiore razionalizzazione degli interventi fi-nanziari per il comparto museale: infatti, data la mancanza di una normativa organica di settore, nel corso degli anni in Sardegna si è prodotta una «non equilibrata distribuzione territoriale» e una marcata frammentazione e ripe-titività dell’offerta museale, oltre ad un livello qualitativo dei servizi spesso inadeguato86.
Se fino agli anni Novanta la Regione ha operato soprattutto attraverso leggi finanziarie erogando anno per anno contributi per i musei, con la legge regio-nale n. 6 del 1995 si limitano tali finanziamenti solo alle iniziative già avviate: la legge circoscrive, infatti, l’erogazione di contributi per il completamento delle strutture e degli allestimenti dei musei di ente locale solo a quelli già avviati al primo giugno 1993, ovvero al momento dell’emanazione della legge regionale n. 25 del 1993 in attuazione alla legge sull’ordinamento delle autonomie locali 142/199087. Con l’articolo 86 della legge finanziaria regionale per il 1992 (legge regionale n.6 del 22 agosto 1991), invece, l’amministrazione regionale era stata già autorizzata a concedere i contributi previsti dalla norma regionale 1/1958 non solo ai musei di ente locale ma anche ai titolari dei musei di interesse locale (enti pubblici, ecclesiastici, privati), fissando i criteri per l’assegnazione delle risorse nella delibera di giunta n. 25/ 49 del 1992.
La Regione, dunque, cerca di intervenire in maniera più sistematica sul comparto musei, completando le opere già iniziate prima di avviarne di nuove, promuovendo la qualificazione dei musei diffusi sul territorio senza limitarsi a quelli di ente locale88.
Contemporaneamente, l’amministrazione regionale comincia a riflettere sui problemi relativi alla gestione del patrimonio culturale e, in questo senso, ven-gono riconosciute come principali cause del mancato sviluppo del settore mu-seale la frammentazione delle competenze tra Stato e Regione, unita a quella
86 Sistema Regionale dei Musei cit. 2005, p. 4.87 LR n. 25 del 1 giugno 1993, Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie
locali e modifiche alla legge regionale 33/1975; LR e n. 6 del 7 aprile 1995, Legge finanziaria 1995.
88 La Corte dei Conti registra una certa genericità per i criteri relativi l’assegnazione dei finanziamenti per i musei di interesse locale. Corte dei Conti, Ricognizione e indagine, cit. 2005, p. 227.
47
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
degli assessorati regionali, e la mancanza di coordinamento nella programma-zione degli interventi. Si arriva dunque alla conclusione che la programmazio-ne di spesa − suddivisa in capitoli di bilancio regionale relativi a varie azioni − debba essere maggiormente coordinata, raccordandosi anche con i contributi statali e comunitari89. Nel 1995 si fissano pertanto i criteri di attuazione degli adempimenti regionali per il settore dei beni culturali con la delibera di giunta n. 34/26, che individua anche i principali obiettivi della Programmazione re-gionale. In primo luogo viene sentita la necessità di una piena conoscenza del patrimonio culturale dell’Isola, da attuare mediante un approfondito censimen-to finalizzato a una inventariazione capillare. Un’altra fondamentale esigenza è rendere accessibili al pubblico i musei, le aree archeologiche e i monumenti attraverso una maggiore collaborazione tra Assessorato alla Pubblica istruzio-ne, competente per i musei, e gli altri organi regionali deputati alla creazione di infrastrutture capaci di migliorare la fruizione dei siti culturali, anche in un’ot-tica di potenziamento del settore turistico.
Il progetto di inventariazione fu condotto a partire dal 1996 dall’Assessorato alla Pubblica istruzione in collaborazione con l’IBACN della Regione Emilia Romagna e con l’ICCD di Roma e permise di avviare un’indagine conoscitiva sui beni culturali della Sardegna90.
Con la successiva legge regionale n. 26 del 1997, dedicata alla promozione della cultura e della lingua sarda, fu prevista l’istituzione di una rete di ser-vizi di ricognizione, catalogazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale dell’Isola (art. 4) e la realizzazione di un catalogo generale (art. 9); la medesima legge stanziava, inoltre, i fondi necessari a queste attività ai quali si aggiungevano quelli della precedente legge regionale 29/1994 relativi all’in-ventario dei beni di archeologia industriale91. Il lavoro di ricognizione e cata-logazione − cui hanno partecipato oltre ad ICCD e IBACN anche le Università e le Soprintendenze di Cagliari e Sassari e l’Istituto Superiore Regionale Etno-
89 Si veda la DGR n. 34/26 del 1 agosto 1995, Programma triennale 1995/1997: Salvaguardare e valorizzare i beni culturali. Capitoli 11106, 11107-02 e capitolo di nuova istituzione (ai sensi dell’art.12 comma 3 della L 537/1993) del Bilancio regionale. Approvazione dei criteri di attuazione degli adempimenti regionali e programmazione ai sensi della L 14 gennaio 1994 n. 20.
90 Si veda Indagine conoscitiva sui beni culturali della Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e sport in collaborazione con IBCN Regione Emilia Romagna, Cagliari s.d.
91 LR n. 26 del 15 ottobre 1997, Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna.
48
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
grafico − è proseguito successivamente grazie ai fondi stanziati col Piano trien-nale degli interventi per gli anni 2002-2004 dell’Assessorato e ancora nel triennio 2005-200792. Queste attività hanno permesso la creazione di un database regio-nale del patrimonio culturale: la schedatura, nata come strumento di lavoro per la Regione e i singoli soggetti coinvolti (musei, aree archeologiche etc.), è stata successivamente e parzialmente messa online mediante un apposito sito web all’indirizzo www.sardegnacultura.it, dove le emergenze culturali sono state inserite anche in percorsi e itinerari virtuali tematici (archeologici, storici, lette-rali etc.). Il Centro di catalogo che si occupa della raccolta, della informatizza-zione e della messa online delle schede del patrimonio culturale sardo è dotato di due sedi operative dislocate a Sassari e Cagliari.
¬ 5.1 La legge regionale 26/1997
Con la legge regionale n. 26 del 1997 si è cercato, per la prima volta, di ri-unire in un unico testo normativo le azioni volte alla promozione e alla va-lorizzazione della cultura sarda, intendendo per essa un complesso organico che si esprime in molteplici manifestazioni e produzioni culturali. L’identità culturale del popolo sardo viene assunta dalla Regione nel primo articolo della legge come «bene primario» da tutelare e valorizzare nella sua «evoluzione e crescita» e come presupposto di ogni attività volta allo sviluppo e al progresso sociale ed economico dell’Isola. Dunque l’oggetto della legge è la cultura sarda nei suoi aspetti materiali e immateriali: patrimonio culturale, letterario, musi-cale, linguistico93.
La legge si inserisce nel contesto di riforma nazionale dell’amministrazione pubblica e del Ministero dei Beni culturali: succede, infatti, alla legge 59 del 1997, che dispone la delega per il conferimento delle funzioni alle autonomie locali, e alla legge 352 dello stesso anno con la quale si delega al Governo l’ema-nazione di un testo unico per la normativa sui beni culturali94.
92 DGR n. 6/16 del 20 febbraio 2002, Approvazione definitiva del piano triennale degli interventi per gli anni 2002-2004 previsto dall’art.12 della legge regionale n. 26 del 15 ottobre 1997; DGR n. 21712 del 17 maggio 2005, Catalogazione del patrimonio culturale della Sardegna.funzionamento e prospettive di sviluppo del Centro Catalogo dei Beni Culturali. Approvazione attività triennio 2005 -2007.
93 La Regione assicura ai cittadini «i mezzi e le condizioni reali per l’esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine» (art. 3 c. 1).
94 Legge n. 59 del 15 marzo 1997, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione
49
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
La legge regionale 26/1997 «garantisce la tutela e la fruizione» − in partico-lare attraverso la catalogazione e la conservazione − del patrimonio culturale regionale e a questo scopo viene espressa la volontà di produrre singole leggi di settore per disciplinare il sistema bibliotecario e documentario (ovvero l’in-sieme delle biblioteche e degli archivi pubblici e privati), il sistema delle tradi-zioni popolari (avvalendosi dell’ISRE) e il «sistema museale e monumentale» dell’Isola (art. 4).
Possiamo pertanto affermare che, almeno dal punto di vista formale, la pri-ma comparsa del termine “sistema museale” nella normativa regionale della Sardegna si ha dunque con la legge n. 26 del 1997 sebbene, in realtà, la stessa norma rimandi per la regolamentazione e la puntuale definizione di tale siste-ma a una successiva e specifica legge di settore che verrà emanata solo nel 2006. La legge regionale 26/1997 stabilisce che il cosiddetto sistema museale e monu-mentale curi «la valorizzazione, la crescita e la fruizione, diffuse e coordinate, dei musei e delle pinacoteche, nonché dei beni storici, archeologici, antropolo-gici, artistici architettonici, paesaggistici ed ambientali, meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove raccolte espositive; promuove studi e ricerche sui centri storici della Sardegna, per la loro valorizzazione e tutela».
Non si tratta quindi, ancora, della creazione di un “sistema museale regio-nale” ma è interessante notare come musei, siti, monumenti, aree di interesse ambientale e centri storici siano considerati come appartenenti a un unico or-ganismo per il quale la valorizzazione e la fruizione dei singoli componenti devono essere diffuse e «coordinate».
La concreta attuazione della norma avverrà con la legge regionale n. 14 del 2006, che inerisce proprio musei e luoghi della cultura, prevedendo, tra l’altro, la realizzazione di un «sistema museale regionale»: possiamo pertanto asserire che se la prima comparsa del termine ‘sistema museale’ nella normativa regio-nale sarda si ha con la legge regionale 27/1997, è solo dopo circa un decennio che la Regione norma in merito alla creazione di un vero e proprio organismo sistemico per la gestione del comparto.
Tra le novità introdotte dalla legge del 1997 vi sono poi: la creazione di un “Osservatorio Regionale per la cultura e la lingua sarda”, quale organo consul-tivo per l’Assessorato alla Pubblica istruzione, formato da studiosi, esperti e funzionari provenienti dalle Soprintendenze e dai centri di ricerca; l’istituzione di un “Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna” organizzato
amministrativa; Legge n. 352 dell’8 ottobre 1997, Disposizioni sui Beni culturali.
50
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
in modo da favorirne la consultazione decentrata; la promozione di conferenze annuali tese a raccordare le attività della Regione con quelle dei soggetti ope-ranti nel settore cultura come gli enti locali, le soprintendenze, le università e le scuole.
Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge, viene poi stabilita l’adozione di “Piani triennali di programmazione regionale”, elaborati dalla Regione in accordo con l’Osservatorio: i piani si devono articolare per aree con specifici obiettivi al fine di equilibrare e armonizzare gli interventi regionali sul territo-rio attraverso la predisposizione di progetti-obiettivo.
Con la legge 26 del 1997 dunque la Regione Sardegna inizia un percorso con-creto per la programmazione: nel 1998 fu predisposto un “programma ponte” di attuazione della legge contenente alcuni indirizzi programmatici, cui segui-rono i piani triennali d’intervento, il primo dei quali fu quello per il 1999-200195. Per i musei non furono elaborati programmi di rilievo, eccezion fatta per la campagna catalografica del patrimonio culturale, precedentemente avviata, che ricevette ulteriori finanziamenti con il piano triennale 2002-200496. Gli in-terventi regionali si concentrano invece soprattutto sull’aspetto linguistico, che sarà anche oggetto del primo Accordo di Programma Quadro della Regione Sardegna, siglato nel 199997.
Nel giugno del 1999, la Regione firma con la Conferenza Episcopale Sarda un Protocollo d’intesa relativo alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali appartenenti a enti ecclesiastici; con questo atto l’Amministrazione regionale si impegna in particolare a collaborare e concorrere agli interventi di restauro e di catalogazione per i beni ecclesiastici, alla tutela, alla fruizione e all’incremento del patrimonio archivistico e librario, alla realizzazione e gestio-ne dei musei di arte sacra98.
95 DGR n, 24/23 del 11 maggio 1999, Piano triennale degli interventi previsto dall’art.12 della L.R. 15 – 10 – 1997 n. 26. Annualità 1999/2001. Approvazione definitiva.
96 DGR n. 23747 del 10 luglio 2001, L.R. 15-10-1997 n. 26, Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna. Piano triennale degli interventi ai sensi dell’art.12. Annualità 2002-2004.
97 Accordo di Programma Quadro per la realizzazione di un “progetto sperimentale per la valorizzazione della cultura e della lingua sarda”, datato 21 aprile 1999. Oggetto dell’accordo è una serie di attività per l’apprendimento della lingua sarda, come la formazione del personale docente e una specifica programmazione didattica.
98 Regione Autonoma della Sardegna, Conferenza Episcopale Sarda, Protocollo di Intesa tra la regione Autonoma della Sardegna e la Conferenza episcopale sarda per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali appartenenti ad enti ecclesiatici, 1 giugno 1999. L’accordo è stato pubblicato in “Conferenza Episcopale italiana. Osservatorio
51
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
6. Gli anni Duemila
A partire dal 2000, gli enti locali manifestano un atteggiamento più dinamico per il settore dei musei e la Regione appare maggiormente concentrata sui rela-tivi problemi gestionali. È proprio nel corso di questi anni che si commissiona-no ricerche specifiche e studi di settore, si provvede a una serie di modifiche per la regolamentazione degli interventi finanziari regionali, si operano le prime programmazioni, si avviano POR e APQ strettamente connessi allo sviluppo del comparto museale e si comincia a progettare un’organizzazione sistemica del settore.
Sicuramente si assiste a una decisa accelerazione delle politiche regionali, alla ricerca di nuove modalità gestionali; anche a livello nazionale, del resto, vi sono in questi anni numerosi cambiamenti che spingono verso un drasti-co rimodellamento delle politiche per il patrimonio culturale: la sollecitazione all’esercizio associato delle funzioni per i comuni più piccoli del D.lgs 112/1998 (art.3), la riorganizzazione legislativa in materia di beni culturali del Testo Unico del 1999, il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali del 2000, la definizione degli standard di funzionamento e sviluppo dei musei del DM 10 maggio 2001, la riforma del titolo V della Costituzione e infine il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio del 2004.99
In Sardegna, la data “spartiacque” per le politiche regionali in materia di beni culturali e musei − soprattutto per quanto riguarda il tema dei sistemi museali − può essere considerata il 2005 ma è interessante notare come, già all’inizio del decennio, vi siano importanti iniziative per la razionalizzazione del patrimonio locale. I due aspetti più significativi della politica regionale del primo quinquennio degli anni 2000, almeno ai fini della ricostruzione di una storia dei sistemi museali in Sardegna, sono riscontrabili nel rinnovamento del-le pratiche di finanziamento regionale per i musei locali, come si evince chia-
Giuridico Legislativo. Notiziario”, V, n. 6 1999 ed è consultabile online all’indirizzo web http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=237.
99 Dlgs 31 marzo 1998 n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 1-10, 148-155); Dlgs 29 ottobre 1999 n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali; Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; DM 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei; LC n. 3 del 18 ottobre 2001, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione; Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
52
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
ramente dall’articolo 38 della legge finanziaria regionale dell’anno 2000, e nei contenuti del secondo asse del POR Sardegna 2000-2006100.
In questi anni si avviano azioni che − così come dichiarato dalla stessa Re-gione101 − mirano a un cambiamento di indirizzo nella gestione dei finanzia-menti dedicati al settore dei beni culturali e in particolare musei, monumenti ed aree archeologiche. L’idea di fondo è che questi luoghi della cultura possano produrre reddito oltre che occupazione. Se, infatti, a partire dalla legge regiona-le sull’occupazione 28/1984 il sostegno economico della Regione Sardegna per i musei è stato sostanzialmente di tipo assistenzialistico − ovvero volto a creare occupazione sul territorio favorendo categorie svantaggiate − a partire dal 2000 prende campo l’idea che musei e strutture assimilabili di proprietà di Enti lo-cali possano e, anzi, debbano sviluppare attività finalizzate al raggiungimento dell’indipendenza economica102. Si prende coscienza del fatto che nonostante la legge regionale 28/1984 abbia avviato numerose esperienze di gestione − spe-rimentandone, con un certo anticipo rispetto ad altre Regioni, l’affidamento a privati e aumentando le competenze locali nei servizi per i beni culturali, grazie alla nascita di cooperative e associazioni locali −, dall’altro ha inibito lo svilup-po di strategie mirate alla produzione di reddito.
In altre parole si prende atto della necessità di “responsabilizzare” gli enti locali proprietari di beni culturali e i soggetti gestori di questi ultimi; inoltre, a fronte di un costante incremento da parte degli Enti locali di richieste di finan-ziamento alla Regione per la valorizzazione del patrimonio culturale di compe-tenza, l’Amministrazione regionale registra la necessità di adottare una nuova normativa, capace di rispondere in maniera migliore all’esigenza di attivare servizi qualificati e ripartire con una logica diversa, più mirata, i propri inter-venti finanziari103.
100 LR n. 4 del 20 aprile 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000).
101 Questa considerazione è espressa nella DGR n. 36/6 del 5 settembre 2000, LR n. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società mediante convenzione dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali, biblioteche e archivi. Cap 11129 del bilancio regionale. Direttive istruttorie e pubblicazione nel BURAS, a norma dell’art. 19 della LR 22- 8- 1990, n. 40.
102 Si veda: a. hInna, M. MInnutI, a. cadelano, Un nuovo approccio per la gestione dei beni culturali nella Regione Sardegna, in R. GroSSI (a cura di), Cultura tra identità e sviluppo, III Rapporto Annuale Federculture, Il Sole 24 ORE Spa, Milano 2006, p. 190.
103 Fino alla legge regionale 4/2000 la gestione dei beni culturali è stata finanziata attraverso la legge regionale 11/1988, relativa a progetti speciali finalizzati
53
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
I progetti avviati con la legge sull’occupazione del 1984 proseguirono fino al 1999 mentre altri furono finanziati dalla Regione sulla base degli articoli 92 e 93 della legge regionale 11/1988104 (legge finanziaria per l’anno 1988) e della legge regionale 37/1998105. Questa continuità di flusso di risorse regionali si sarebbe dovuta interrompere con legge finanziaria regionale del 2000 (legge regionale 4/2000), che presenta importanti elementi di novità, segnatamente all’articolo 38:
Art. 38: Beni culturali, biblioteche e archivi.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi, sino al 90 per cento della spesa prevista in progetto e rite-nuta ammissibile, per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, biblioteche ed archivi. La durata delle convenzioni non può essere inferiore ai tre anni. Nel caso di servizi a rientro tariffario il con-tributo da erogare a favore degli enti locali deve tenere conto del rientro medesimo.
all’occupazione (art. 92) che istituì, quale strumento attuativo, il “Piano di lavoro”. La legge è stata modificata più volte nel corso degli anni mediante numerose leggi regionali (18/1989; 6/1992; 54/1993; 2/1994; 9/1996; 8/1997).
104 LR n. 11 del 4 giugno 1988, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988). Con l’articolo 92 viene autorizzata, per il triennio 1988-1990, la spesa di 160 miliardi di lire, finalizzata all’attuazione di una serie di progetti speciali volti a favorire l’occupazione e articolati per settori e aree territoriali, sulla base al tasso di disoccupazione rilevato dall’ISTAT. Tra le altre, la norma prevede azioni per «censimento, catalogazione, restauro, manutenzione, ammodernamento funzionale di beni culturali e librari». I progetti vengono attuati dalla Regione preferibilmente mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Sempre secondo la norma, l’80% dei finanziamenti (regionali, statali, comunitari) sono da destinarsi alla promozione dell’occupazione, il 15% alla dotazione di attrezzature ed il restante 5% all’assistenza tecnica per la predisposizione e l’attuazione degli stessi progetti. Attraverso la legge regionale 11/1988, per il settore «Progetti Speciali 7 a/1 Gestione di Beni culturali» sono state avviate le seguenti gestioni: Sito di Giara (Comunità Montana XXV); Aree monumentali e panoramiche e Museo Etnografico di Ortacesus; Museo Civico Archeologico di Ozieri; Museo Civico Archeologico e Tophet di Sant’Antioco; Area archeologica Sa Carcaredda – Serra Troculu di Villagrande Strisaili; Museo Civico Archeologico e Sito archeologico Su Mulinu di Villanovafranca. Cfr. Tabella 1, allegato alla deliberazione n. 61/30 del 20 dicembre 2005, Linee di indirizzo relative all’erogazione di contributi agli Enti Locali pubblici territoriali della Sardegna per concorrere agli oneri d’esercizio dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito culturale. LR 21.4.2005 n. 7 art. 12 comma 3. UPb S 11027 Capitolo 11212, UBP S 11 0 33 Capitolo 11247.
105 LR n. 37 del 24 dicembre 1998, Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio.
54
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinate con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono valuta-ti in lire 15.400.000.000 per l’anno 2000, in lire 5.000.000.000 per l’anno 2001 ed in lire 2.000.000.000 per gli anni successivi (cap. 11129).
La Regione quindi concede, adesso, fino al 90% (in realtà, come vedremo, si tratta dell’80% per musei, monumenti, aree archeologiche) della spesa so-stenuta dagli Enti locali per la gestione delle strutture di competenza purché gli enti presentino progetti di gestione della durata (almeno) triennale e tali da rispettare una serie di criteri.
Alla legge fece seguito la delibera di Giunta regionale n. 36/6 del 5 settembre 2000 che ne esplicitò le direttive di attuazione e chiarì i motivi della decisione di procedere al riordino della regolamentazione dei finanziamenti regionali di settore.
In primo luogo il documento sostiene che i servizi erogati con il contributo regionale per la gestione di musei, aree archeologiche, complessi monumentali e aree di interesse ambientale «si configurano attualmente come produttori di reddito, con possibilità di copertura delle spese, anche se parziale, derivan-te dai servizi di biglietteria, visite guidate, vendita e ristorazione. Tali introiti, incamerati dagli Enti locali, possono dunque consentire la copertura di parte delle spese necessarie all’attivazione al mantenimento dei servizi»106. Allora, diversamente da quanto avviene per le biblioteche e gli archivi − «dove è ne-cessario un intervento costante nel tempo, trattandosi di servizi che non pro-ducono reddito, se non marginalmente» − per musei e strutture visitabili, la Regione ravvisa la necessità di una razionalizzazione delle assegnazioni dei propri contributi, in modo da stimolare gli enti locali e i soggetti affidatari dei servizi (associazioni, società, cooperative) «verso la predisposizione di strate-gie di intervento non più di tipo assistenzialistico, bensì in un’ottica di impresa produttrice di reddito»107.
Nell’analisi della gestione del comparto cultura dunque la Regione opera un discrimine: vi sono strutture che, per loro natura e destinazione, sono incapaci di produrre reddito, come le biblioteche e gli archivi, e pertanto devono essere
106 DGR n. 36/6 del 5 settembre 2000, cit. 107 Tutte le citazioni sono tratte dal testo della delibera di giunta 36/6 del 5 settembre
2000, cit.
55
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
sostenute in maniera continuata; altre invece, essendo fruibili da una più ampia utenza, come i musei e i monumenti visitabili, dovrebbero o potrebbero essere in grado di auto sostentarsi. Tale lettura riflette il dibattito, in corso alla metà degli anni Novanta, sulla presunta redditività dei musei e il ripensamento della gestione dei beni culturali ispirato al principio di sussidiarietà già in atto su scala nazionale.
La citata delibera stabilisce come ammissibili al finanziamento regionale le spese per la retribuzione del personale previsto dal Contratto Collettivo Nazio-nale di Lavoro per i dipendenti dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, mentre sono considerate non ammissibili quelle per le figure professionali destinate ai servizi aggiuntivi. In altre parole il contributo regionale va a coprire solo il pagamento del personale impegnato nel progetto (guide, archeologi e storici dell’arte, operatori museali) con esclusione del per-sonale impiegato per i servizi aggiuntivi come ristorazione e bookshop.
Per poter ottenere il sostegno economico regionale gli Enti locali, singoli o associati che siano, devono inoltre presentare all’Assessorato di competenza la propria istanza, completa di un progetto triennale: l’Assessore predispone poi un piano triennale di interventi sulla base delle domande pervenute e della «differente distribuzione dei beni culturali nell’isola». Tali programmi regionali sono elaborati tenendo conto, secondo il tipo di intervento, delle seguenti «pri-orità»: progetti sovra comunali, progetti integrati, progetti in grado di produr-re uno sviluppo economico verificabile entro il primo anno di funzionamento, progetti nei quali siano già presenti iniziative e servizi aggiuntivi realizzati con investimenti dell’Ente locale proponente e/o di soggetti privati.
Nello specifico settore «musei, parchi, e aree archeologiche, beni monumen-tali e ambientali singoli o associati», il contributo regionale può essere pari a un massimo dell’80% delle spese per l’affidamento di gestione al primo anno, 70% e 60% rispettivamente nella seconda e terza annualità. A corredo della doman-da presentata alla Regione vengono poi richiesti agli Enti locali: la delibera di approvazione del progetto ed un programma di gestione triennale contenente tutte le informazioni sui beni culturali, sul personale coinvolto e sulle struttu-re, oltre che sui finanziamenti già ottenuti. Viene inoltre richiesta l’attivazione della bigliettazione, che è presupposto necessario alla concessione di finanzia-menti regionali per il secondo anno.
Per il terzo anno invece l’intervento economico della Regione è subordinato all’esistenza di una comprovata capacità imprenditoriale dei progetti avviati: questi devono cioè dimostrare di aver realizzato un incremento dei servizi, de-gli introiti, del numero di visitatori e dei rientri finanziari.
56
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
L’elemento di novità introdotto dalla legge finanziaria regionale dell’anno 2000 è quindi la volontà di utilizzare lo strumento del contributo regionale come incentivo allo sviluppo del settore, vincolandolo al tempo stesso alla capacità dei musei e delle strutture assimilabili, o meglio degli Enti proprietari e dei loro gestori, di maturare quell’esperienza gestionale mirata all’autosufficienza economica. In questo senso l’attenzione della Regione si sposta dall’obiettivo del mantenimento dell’occupazione al miglioramento finanziario e gestionale dei servizi del comparto cultura.
Sulla base della legge n. 4 del 2000 – operativa fino all’entrata in vigore della legge finanziaria regionale per il 2005 che sancisce nuove direttive108 –, furono approvati tre programmi triennali (2001-2003, 2002-2004; 2003-2005) per un to-tale di 130 progetti ammessi a finanziamento109.
Poiché dei 168 progetti presentati dagli enti locali per il primo programma triennale 2001-2003 furono pochi quelli rispondenti ai requisiti di ammissibili-tà, soprattutto per quanto riguarda la presenza di «capacità progettuale», nel corso dell’istruttoria regionale vi fu una ridefinizione di quasi tutte le proposte avanzate dagli enti locali.
Questi ultimi ebbero la possibilità di presentare progetti afferenti a tre di-versi settori: biblioteche e archivi, beni culturali, servizi culturali integrati. Il maggior numero dei progetti presentati fu per le biblioteche (77 per i servizi bibliotecari e 24 per il riordino e la gestione degli archivi), 52 furono i progetti relativi al comparto beni culturali e solo 15 quelli destinati a realizzare ser-vizi culturali integrati. Tra questi ultimi, in particolare, ricordiamo l’esempio di Oristano − con il progetto di gestione unica per archivio storico comunale,
108 In particolare con il comma 3 dell’articolo 12 della Legge regionale n. 7 del 21 aprile 2005, Legge finanziaria 2005: «Fino all’approvazione della normativa regionale di trasferimento agli enti locali pubblici territoriali della Sardegna delle competenze in materia di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito culturale e del tempo libero, la Regione è autorizzata a erogare contributi agli enti interessati, per concorrere agli oneri d’esercizio dei medesimi servizi». Sulle novità introdotte da questa norma si veda, infra, p. 46-47.
109 Sulla base dell’articolo 38 della legge regionale 4/2000 sono stati finanziati 44 proget-ti nell’ambito del programma triennale 2001-2002, 16 sul programma 2002-2003 e 5 progetti su quello 2003-2005; a questi si aggiunsero altri 6 progetti avviati grazie alla legge regionale 28/1984 e operativi sulla base dell’articolo 92 della legge regionale 11/1988. I dati sono tratti dal rapporto finale di monitoraggio regionale condotto con Federculture: Regione Autonoma della Sardegna, Federculture, Progetto di mo-nitoraggio e valutazione delle iniziative progettuali avviate in attuazione della normativa di cui all’art. 92 L.R. 11/1988 e all’art. 38 della LR 4/2000, Cagliari 2005 e consultabile all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?&s=5291&v=2&c=215&t=1 .
57
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca − e quello analogo di Sant’Antioco, relativo alla gestione dell’archivio storico e delle emergenze archeologiche del territorio.
Poiché i finanziamenti a valere sull’articolo 38 della legge regionale 4/2000 sono stati il canale privilegiato per l’erogazione di contributi destinati al pa-gamento del personale impiegato nel settore musei, almeno fino alla modifi-ca della normativa del 2005, non pochi sono stati i sistemi museali che hanno usufruito di queste risorse, partecipando ai relativi bandi, o che sono nati come progetti di gestione congiunta per intercettare i finanziamenti relativi alla nor-ma del 2000. Un esempio di questo tipo è, per esempio, il sistema museale di Armungia.
Tra i sistemi che hanno beneficiato dei finanziamenti ex lege 4/2000 ricordia-mo tra gli altri: gli itinerari del sistema Territorio Museo di Alghero, il percorso museale monumentale di Seui, il sistema museale di Carbonia110. In qualche caso − come per i sistemi museali di Seui e Armungia − l’istituzionalizzazione vera e propria è avvenuta dopo la presentazione della domanda di finanzia-mento, quindi i contributi regionali hanno comportato anche l’avvio di pratiche di gestione congiunta per la creazione di strutture sistemiche111.
Nel primo programma triennale furono finanziati, oltre a numerosi sistemi bibliotecari urbani e intercomunali, diversi progetti di «gestione coordinata», per differenti strutture di un unico ente locale − per esempio quello che riunisce parco archeologico, biblioteca e museo del Comune di Viddalba, ma analoghi esempi si hanno anche a Seui e Ozieri −, o per un insieme di beni appartenenti a più Comuni come accade per Orroli, Serri e Goni.
Generalmente la gestione coordinata all’interno di un unico Comune consi-ste nell’affidamento delle strutture a un unico soggetto (Viddalba, Armungia)
110 Si vedano gli allegati n. 1 e n. 2 alla delibera n. 25/19 del 1 giugno 2006, Contributi agli Enti locali della Sardegna per concorrere agli oneri derivanti dalla gestione dei beni culturali. Art. 12 comma 3 legge regionale del 21/4/2005 n. 7. Per il sistema museale di Carbonia si veda anche il citato rapporto finale di monitoraggio Progetto di monitoraggio e valutazione, cit. 2005, pp. 143-146. Per i sistemi museali citati si rimanda alle relative schede analitiche pubblicate in questo volume.
111 I programmi triennali di attuazione alla LR 4/2000 spesso permisero la prosecuzione di progetti già finanziati tramite legge regionale 28/1984. Si vedano le delibere di Giunta Regionale n. 39/52 del 10 dicembre 2002, n. 36/32 del 23 ottobre 2001 e n. 44/37 del 30 dicembre 2002. L’elenco completo dei Comuni titolari di progetti di gestione di musei, aree archeologiche e monumentali finanziati in base alla LR 4/2000 è contenuto nella tabella 4 dell’Allegato B alla delibera di Giunta regionale n. 61/30 del 20 dicembre 2005.
58
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
oppure a più soggetti con una ripartizione omogenea degli introiti provenienti dalle diverse strutture (Ozieri).
In alcuni casi i progetti di gestione coordinata presentati sui bandi di finan-ziamento della legge regionale 4/2000 si sono trasformati in sistemi museali o itinerari culturali più articolati: a Seui nell’Ogliastra, per esempio, partendo dalla gestione coordinata del museo etnografico, della Galleria civica e dell’e-dificio del Carcere Spagnolo − affidati a un’unica cooperativa locale nell’ambi-to del primo progetto triennale relativo alla 4/2000 − si è giunti nel 2003 alla creazione di un itinerario cittadino, il Percorso Museale Monumentale Sehiuense, che raccoglie tutte le emergenze culturali del territorio di spettanza comunale recuperate dal degrado nel corso degli anni.
Le gestioni coordinate dei Comuni di Ozieri e Viddalba sono state invece assorbite nel 2006 dal sistema museale intercomunale Celeberrimi Populi quando cioè, allo scopo di adeguarsi agli indirizzi regionali – espressi nella delibera regionale 36/5 del 2005 che ebbe lo scopo di razionalizzare il settore anche me-diante la creazione di sistemi − si è reso necessario riunire in un unico organi-smo l’insieme di monumenti, musei, parchi e associazioni attive a vario titolo nel contesto culturale del comprensorio sassarese.
Diverso è invece il caso del progetto di gestione congiunta tra i Comuni di Orroli (NU), Serri e Goni (CA), accomunati dal passaggio del Flumendosa nei rispettivi territori ma soprattutto dalla presenza di importanti resti nuragici e prenuragici112. I tre Comuni parteciparono al bando di finanziamento citato con un complesso progetto per la valorizzazione congiunta del patrimonio, da ge-stire attraverso un’associazione temporanea di imprese formata, per l’occasio-ne, dalle tre società che si erano già occupate, rispettivamente, dei beni di Orroli − comune capofila del progetto − Goni e Serri. Grazie al finanziamento regio-nale ottenuto, i tre Comuni, dopo aver sottoscritto un accordo di programma e costituito un comitato tecnico, sono giunti nel 2003 alla bigliettazione unica113.
Come emerge da questi esempi, i finanziamenti ex lege 4/2000 sembrano aver sollecitato la formazione di diverse esperienze di gestione coordinata, dando luogo anche a veri e propri ‘sistemi’: tali forme di aggregazione sono sta-te probabilmente stimolate dalle «priorità» per l’assegnazione delle risorse che la Regione individuò, nelle direttive istruttorie della norma, nella «dimensione
112 Tra questi monumenti: il nuraghe pentalobato Arrubiu presso Orroli, il santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri e la necropoli con i menhir di Pranu Mutteddu presso Goni.
113 E un solo biglietto Orroli, in “L’Unione Sarda”, 6 ottobre 2003.
59
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
sovra comunale» dei progetti e nella presenza di una «gestione integrata» .Il Servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione, a conclusio-
ne del primo programma triennale, attivò in collaborazione con Federculture un monitoraggio dei progetti fino ad allora finanziati, per conoscere quali fossero state le migliori prassi gestionali adottate e quali le eventuali criticità riscontra-te nell’attuazione della nuova normativa regionale. La ricerca prese in consi-derazione i progetti allo stato più avanzato di realizzazione, monitorando 111 realtà: di queste il 40% risultò costituito da musei, il 35% da aree archeologiche, il 5% da beni di interesse ambientale ed il 20% da percorsi e itinerari114.
Dalla ricerca emerse una scarsa adesione da parte degli enti locali alla filo-sofia imprenditoriale della 4/2000 e il poco interesse degli enti per la gestione del proprio patrimonio culturale, sebbene in confronto ai progetti sulla legge regionale 11/1988, si registrasse ora un maggiore impegno. Per la scelta dei soggetti gestori il metodo più utilizzato dagli enti locali risultò essere l’asta pubblica, anche se, nella maggior parte dei casi, con una così scarsa affluenza di partecipanti da rendere minima la concorrenzialità. Sicuramente rispetto al passato risultarono in aumento le attività di promozione culturale, spesso del tutto inesistenti fino ad allora, ma il Rapporto mise in luce anche la permanenza di situazioni critiche, come il caso del progetto di «tutela e valorizzazione dei beni ambientali e del museo di Ortacesus», con cinque strutture su sei non visi-tabili e per le quali, dunque, il gestore svolgeva solo attività di manutenzione115.
I progetti finanziati dalla legge regionale 4/2000 non sortirono tuttavia l’e-sito sperato sul lungo periodo: l’autonomia finanziaria – da raggiungere nel primo triennio, secondo le direttive d’attivazione della norma – si è rivelata un miraggio e anzi, in molti casi la Regione ha continuato a elargire risorse pub-bliche prorogando i termini di scadenza dei vari progetti. Come evidenziava un altro studio, pubblicato nel 2004 dal Centro Ricerche Economiche Nord Sud (CRENOS) sui musei e i siti archeologici in rapporto al turismo in Sardegna,
114 Dei 50 progetti di gestione analizzati nel monitoraggio, 44 risultarono finanziati ex lege 4/2000 (programma triennale 2001-2003) e 6 tramite legge regionale 11/1988. La valutazione dei progetti, promossa dalla Regione Sardegna in collaborazione con Federculture, fu svolta mediante la somministrazione di questionari agli enti locali e la redazione di una serie di indicatori relativi al monitoraggio dei progetti in termini di imprenditorialità. Regione Autonoma della Sardegna, Federculture, Progetto di monitoraggio cit. 2005.
115 L’unica struttura fruibile era il museo, aperto al pubblico dal 2003. Dei 14 beni gestiti nell’ambito della l.r. 11/1988 solo 5, al momento del rilevamento, risultavano avere un servizio di bigliettazione. Ibidem p. 129.
60
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
la legge 4/2000 non è sempre riuscita a “responsabilizzare” realmente gli enti locali: molti gestori lamentavano infatti comportamenti scorretti da parte di al-cuni enti, come gonfiare le previsioni di bigliettazione – per ottenere più risorse dalla Regione e coprire le spese non finanziate dalla Regione, prendendo una percentuale sulla bigliettazione e annullare così la promozione di uno spirito imprenditoriale116.
Nel corso di oltre venti anni la Regione ha provveduto direttamente a sti-pulare convenzioni con le società che gestivano i progetti nati a seguito delle norme sull’occupazione e a liquidarne i relativi pagamenti. L’amministrazione regionale, al fine di mantenere l’occupazione, stanziava cioè i fondi ed elargiva le relative risorse dietro presentazione da parte dei gestori di semplici relazioni semestrali e rendicontazioni dei finanziamenti erogati precedentemente.
Con la legge regionale 4/2000 si destinano invece risorse direttamente agli Enti locali che, con tale contributo, provvedono a pagare il costo del persona-le impegnato nei vari progetti triennali proposti, mentre le spese per i servizi aggiuntivi devono essere coperte dagli stessi gestori delle strutture. Malgrado persistessero ancora molte difficoltà, le nuove modalità di finanziamento regio-nale continuano in questo modo fino verso la metà degli anni Duemila.
Nel 2004 però la Regione deve tener conto di un mutato contesto legislativo nazionale creatosi in materia di affidamento a terzi della gestione dei beni cul-turali da parte di enti locali. In quell’ anno, infatti, entrò in vigore il nuovo Codi-ce dei beni culturali (Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004) che, all’articolo 115, sulle forme di gestione, sanciva la possibilità di ricorrere alla concessione a terzi mediante procedure a evidenza pubblica solo per Stato e Regioni, mentre per gli Enti pubblici territoriali prevedeva una gestione dei propri beni diretta oppure indiretta ma con affidamento a soggetti privati costituiti o partecipati a prevalenza dall’amministrazione pubblica proprietaria dei beni, eliminando così la concessione a terzi della gestione117.
Ancora nel 2004, la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 dichiarava il-legittimo l’articolo 113 bis del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) approvato con Decreto legislativo 267/2000, che determinava per gli Enti locali la possibilità di affidare i servizi privi di rilevanza economica a soggetti terzi con procedure a evidenza pubblica118. La pronuncia della Corte Costituzionale
116 M. IorIo, Musei, siti cit., pp. 115-118.117 Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.118 Sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 13-27 luglio 2004. Nell’articolo 113bis del
61
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
sottraeva a Regioni ed enti locali un riferimento generale per le modalità di affidamento a terzi dei servizi privi di rilevanza economica, toccando quindi una questione che riguardava anche la concessione, da parte di enti pubbli-ci territoriali, dei servizi per musei. Come è stato osservato, si era creata una situazione in cui «il quadro di riferimento, sempre in assenza di indicazioni legislative regionali, è costituito direttamente dall’ordinamento comunitario e dagli orientamenti del giudice amministrativo, anche se al riguardo si sconta un tasso non lieve di incertezza»119. Con la sentenza n. 272 del 2004 della Corte costituzionale si determinava un allargamento delle «responsabilità regionali nella gestione dei musei» in quanto si affidava alle Regioni la disciplina della gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica120.
La Regione Sardegna con la legge n. 7 del 21 aprile 2005 (finanziaria per il 2005) ha provveduto ad adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzionale normando l’affidamento dei servizi privi di rilevanza economica per gli enti pubblici territoriali. L’articolo 37 della legge, infatti, permetteva nuovamente il ricorso a terzi per l’affidamento dei servizi, consuetudine questa estremamente diffusa nella gestione museale sarda121. La legge autorizza la gestione dei servi-zi privi di rilevanza economica da parte degli enti pubblici territoriali sia in ma-niera diretta, quando le dimensioni del servizio risultano modeste, sia in ma-niera indiretta tramite concessione a terzi «in conformità alle vigenti norme in materia di scelta del contraente, ovvero mediante affidamenti diretti a soggetti costituiti o partecipati in misura prevalente dall’ente pubblico interessato»122.
Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, la Corte ravvisò una «illegittima compressione dell’autonomia regionale e locale».
119 G. ScIullo, Gestione dei servizi culturali e governo locale dopo la pronuncia 272 del 2004 della Corte costituzionale, in “Aedon” 3, 2004, consultabile online all’indirizzo http://www.aedon.mulino.it . Si veda anche del medesimo autore Stato, regioni e servizi pub-blici locali nella pronuncia n. 272 della Consulta in “LexItalia.it” 7-8, 2004, consultabile online all’indirizzo http://www.lexitalia.it.
120 L’articolo 115 del Codice − assieme agli articoli 112 e 116 − è stato successivamente modificato con il decreto legislativo n. 156 del 24 marzo 2006, Disposizioni correttive ed integrative in materia di beni culturali e ambientali , a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, per essere allineato alla legislazione europea sui servizi pubblici, salvaguardando però il proprio impianto. A. GarlandInI, L’intervento delle regioni a favore dei musei: uno scenario in profondo cambiamento, in “Aedon” 2, 2006, consultabile online all’indirizzo http://www.aedon.mulino.it .
121 LR n. 7 del 21 aprile 2005, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005), art. 37, cc. 7-9.
122 Delibera n. 61/30 del 20 dicembre 2005, Linee di indirizzo relative all’erogazione dei con-tributi agli enti locali pubblici territoriali della Sardegna per concorrere agli oneri d’esercizio
62
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
La 7/2005 stabiliva inoltre che «fino all’approvazione della normativa regiona-le di trasferimento agli enti locali territoriali della Sardegna delle competenze in materia di gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica in ambi-to culturale e del tempo libero, la Regione è autorizzata a erogare contributi agli enti interessati» e definirne le linee di indirizzo per l’attuazione123.
Le linee di attuazione della legge 7/2005 vennero esplicitate con deliberazio-ne n. 61/30 del 20 dicembre 2005. Nel documento, oltre alle linee di indirizzo della nuova normativa, si misero in evidenza alcuni punti deboli relativi alla gestione dei beni culturali, emersi dall’analisi dei progetti finanziati negli anni precedenti.
In generale si riscontrava scarsa vocazione all’aggregazione, anche da par-te di Comuni di piccole dimensioni, una certa disattenzione al rapporto costi-benefici per i servizi e inadeguatezza delle attività di promozione. Per i musei e le aree archeologiche, inoltre, i principali problemi furono ravvisati nel ruolo degli Enti locali: alcuni di essi non partecipavano alle quote di finanziamento dei progetti, altri non reinvestivano gli introiti dei biglietti nel miglioramento dei servizi. Ancora difficoltà si rilevarono nei rapporti tra Soprintendenze ed Enti locali, soprattutto in riferimento ai numerosi casi in cui aree archeologiche o beni di proprietà statale fossero gestiti, tramite convenzioni, dagli enti locali. Tali stipule, diverse di caso in caso, creavano infatti disomogeneità tra i servizi di fruizione, tanto che in alcuni casi la combinazione bene statale – gestione comunale rendeva impossibile, per motivi burocratici, anche l’istituzione della bigliettazione.
Il documento sottolineava anche la necessità di formulare un’intesa tra Re-gione e Ministero dei Beni e delle Attività culturali, in riferimento all’articolo 112 del Codice, per permettere all’Amministrazione regionale di avere un ruolo di maggior coordinamento e incisività nella valorizzazione del patrimonio.
Per quanto concerne le nuove linee di indirizzo per l’erogazione di contribu-ti regionali agli enti locali, anche in questo caso l’Amministrazione prevedeva tre distinti settori nell’ambito dei quali gli enti avrebbero dovuto presentare i propri progetti triennali: “biblioteche”, “archivi”, “musei, aree archeologiche e
dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito culturale. LR n. 7 del 21 aprile 2005, art. 12 c. 3.
123 DGR 61/30 del 2005 cit. e n. 25/19 del 1 giugno 2005, Contributi agli enti locali della Sardegna per concorrere agli oneri derivanti dalla gestione dei beni culturali. Art. 12 comma 3 LR del 21.4.2005 n.7.
63
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
complessi monumentali”124. Il finanziamento regionale ammissibile per la ge-stione museale fu stabilito nella misura del 70% delle spese in conto esercizio per le attività di fruizione e promozione dei servizi, con un premio del 5% per quei progetti presentati da enti locali associati nei quali fossero presenti anche Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti. Agli Enti locali la Regione chiedeva di assicurare la continuità della gestione dei servizi, «la pulizia e l’or-dine» degli spazi, gli orari di apertura definiti in base alle esigenze dell’utenza. Per l’assegnazione dei contributi, la Regione adottava come criteri premianti: lo sviluppo di associazioni tra enti locali e tra enti locali e privati; l’integrazio-ne dei servizi tra musei, biblioteche, siti e archivi; il rispetto degli standard di servizio enucleati nel Piano di razionalizzazione per i musei (delibera n. 36/5 del 26 luglio 2005)125; l’adesione ai progetti regionali di bigliettazione e promozione coordinata; la fornitura di dati e informazioni sui beni di pertinenza, da inserire nel portale web della Regione dedicato ai beni culturali; la compartecipazione di risorse private.
Tali criteri risultano coerentemente in linea con gli indirizzi elaborati dalla Regione nel documento di indirizzo Sistema regionale dei musei. Piano di razio-nalizzazione e sviluppo, con il quale l’Amministrazione comincia a muoversi in maniera concreta verso la promozione dei sistemi museali nell’Isola. Da tale Piano, di cui tratteremo più avanti, le linee di indirizzo per l’assegnazione dei contributi regionali agli enti locali, approvate, con delibera 61/30 del 2005, re-cepiscono in particolare la volontà di premiare le associazioni tra enti, la bigliet-tazione integrata e la gestione coordinata, ovvero quelle attività che connotano le esperienze sistemiche di gestione per i musei.
Sei mesi prima dell’emanazione della delibera 61/30, con delibera del primo giugno 2005, l’Assessorato competente aveva chiesto e ottenuto dalla Giunta regionale una proroga per i progetti di gestione museale in scadenza a valere sulle leggi 4/2000 e 11/1988. Tale proroga era finalizzata a concedere agli enti locali il tempo sufficiente a espletare le pratiche per la presentazione dei nuo-vi progetti sui bandi della legge regionale 7/2005. In questo modo molti dei progetti precedentemente citati, i cui finanziamenti si sarebbero interrotti il 31 dicembre 2005, poterono continuare a beneficiare dei contributi regionali126.
124 Allegato A alla delibera di Giunta Regionale n. 61/30 del 20 dicembre 2005 cit.125 Su questo argomento si veda il paragrafo 6.5.126 DGR n. 25/19 del 1 giugno 2005, Contributi agli enti locali della Sardegna per concorrere
agli oneri derivanti dalla gestione dei beni culturali. Art. 12 comma 3 della LR del 21 aprile 20005 n. 7.
64
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
I nuovi bandi di finanziamento dovevano essere pubblicati entro gennaio 2006 mentre la nuova programmazione regionale sarebbe dovuta entrata in vigore per l’inizio del 2007: per evitare il rischio che i progetti in scadenza, già finanziati con le leggi regionali 4/2000 e 11/1988, potessero nuovamente rimanere “scoperti” economicamente, si predispose il trasferimento delle risor-se agli Enti locali interessati, per garantirne i servizi fino al termine del 2006, protraendo così ulteriormente la proroga già avviata con la precedente delibera del giugno 2005.
Il bando relativo all’assegnazione dei contributi sulla legge regionale 7/2005 fu pubblicato il 6 marzo 2006 mentre non è mai stata pubblicata la relativa gra-duatoria dei progetti vincitori, tanto che molti enti che avevano programmato esperienze di gestione congiunta non hanno potuto realizzare alcunché.
¬ 6.1 La programmazione regionale tra il 2000 e il 2005
In questi anni prende il via il Programma Operativo Regionale (POR) per Re-gioni Obiettivo 1, relativo al periodo 2000-2006, in tre passaggi successivi: il primo nell’agosto del 2000, il secondo nel dicembre 2004 e aggiornato nel 2005, il terzo nel 2007127. Il programma si inserisce in un contesto innovato a livello regionale: per la prima volta, infatti, le azioni della Regione sono caratterizzate da un approccio integrato tra diversi soggetti istituzionali e coinvolgono molte-plici “risorse” del territorio. Riunendo attività e beni di tipo diverso in proget-ti unitari, la Regione abbandona la politica dell’intervento destinato a singoli comparti, cercando di costruire una possibilità di sviluppo che coinvolga non solo il patrimonio culturale e ambientale ma anche le attività dell’accoglienza, i servizi di promozione turistica e la produzione artigianale.
Queste politiche si sono articolate essenzialmente attraverso tre documenti:
127 Il primo POR è stato approvato con Decisione della Commissione Europea C (2000) 2359 dell’ 8 agosto 2000, «a seguito delle indicazioni del Valutatore Indipendente e del confronto con il Partenariato istituzionale, economico e sociale è stata approvata una versione successiva con Decisione della Commissione Europea C (2004) 5191 del 15 dicembre 2004, il cui aggiornamento ha comportato una nuova Decisione del-la Commissione Europea C (2005) 4820 del 1 dicembre 2005. Un ulteriore aggiorna-mento del POR è stato approvato con Decisone C (2007) 1991 del 30 aprile 2007». I testi integrali delle diverse versioni del POR 2000-2006 della Sardegna si trovano sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/regione/programmazione_europea/2000-2006/por/ , e sul sito web del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo economico all’indiriz-zo http://www.dps.tesoro.it/qcs/qcs_por.asp .
65
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
il citato POR 2000-2006 nel suo Asse II, il documento di indirizzo regionale dal titolo Sistema regionale dei musei. Piano razionalizzazione e sviluppo, approvato con delibera di Giunta regionale n. 36/5 del 26 luglio 2005, e l’APQ − firmato il 30 settembre dello stesso anno − in materia di risorse e attività culturali, che dal citato piano riprendeva le linee di intervento.
¬ 6.2 Il POR 2000-2006
Il POR ha contato economicamente su quattro fondi strutturali dell’Unione Europea: FESR, FSE, FEAOG e SFOP128. L’Asse II del Programma, dedicato alle Risorse Culturali, inizialmente si è articolato in quattro distinte misure: la 2.1 Archeologia. Percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici, la 2.2 Archeologia industriale, la 2.3 Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo e la 2.4 Formazione per le attività culturali sviluppate nell’As-se. Nel primo documento POR, approvato nell’agosto 2000, gli obiettivi dell’as-se dedicato alle Risorse culturali sono stati individuati nella tutela, nella valo-rizzazione e nella maggior fruibilità del patrimonio oltre che nella creazione di opportunità imprenditoriali nel settore cultura. In altri termini il Programma ha voluto sviluppare le potenzialità turistiche di aree escluse dai circuiti prin-cipali legati al turismo stagionale e balneare, qualificandone l’offerta culturale. L’analisi del contesto sardo svolto in occasione dell’elaborazione del POR, met-teva infatti in evidenza un’insufficiente presenza di infrastrutture e uno stato di degrado «avanzato» per molti siti e aree di interesse culturale. Grazie al POR si prospettavano quindi azioni di salvaguardia e ripristino, miglioramento della qualità dei servizi per la valorizzazione del patrimonio e crescita delle imprese legate alla promozione dei beni culturali, che contemplava anche la formazione di professionalità specifiche per il settore.
Per quanto riguarda il recupero del patrimonio culturale degradato, le li-nee di intervento del POR prevedevano il ripristino, la dotazione di piani di gestione e servizi per le aree archeologiche; la ristrutturazione di sedi musea-
128 Con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) furono stanziati 1.155,926 milioni di euro, con il Fondo Sociale Europeo (FSE) 357,214 milioni di euro, circa 406 milioni di euro con il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG) e poco più di 27 milioni di euro con lo Strumento Finanziario di orientamento della Pesca (SFOP). In totale, il contributo comunitario per il POR Sardegna 2000-2006 fu pari a 1.946,229 milioni di euro. Decisione della Commissione C (2000)2359 dell’8 agosto 2000 recante approvazione del programma operativo “Sardegna” che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall’obiettivo n.1.
66
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
li, nonché di biblioteche, archivi e teatri; il ripristino e restauro per complessi architettonici dismessi da reimpiegare a fini culturali e di spettacolo e, infine, il recupero di emergenze architettoniche nell’ambito della riqualificazione di centri storici. Il sostegno alle iniziative imprenditoriali, invece, si doveva espli-citare mediante una maggiore integrazione tra le imprese turistiche e le «risorse culturali» del territorio, il potenziamento dell’artigianato e lo sviluppo delle infrastrutture teatrali e musicali.
Ai fini della nostra ricerca, le linee di intervento più interessanti presenti all’interno all’Asse II del POR 2000-2006 risultano essere quelle relative ai co-siddetti Servizi per l’accesso e la fruizione del patrimonio culturale, in quanto pro-prio nell’ambito dello sviluppo dei servizi museali previsti sono l’attivazione di «sistemi territoriali di gestione avanzati e il miglioramento dei servizi di fruizione»129.
129 Altri interventi riguardano il potenziamento delle attività di catalogazione e inventa-riazione e le attività formative finalizzate a creare nuova occupazione o a riqualificare le professionalità esistenti. La misura 2.2 del II Asse, che fu inizialmente dedicata all’archeologia industriale, fu accorpata alla misura 2.1 nella revisione del Program-ma del 2004, quando anche la misura 2.4 fu trasferita dall’Asse II all’Asse III relativo alle Risorse umane (a questo proposito, si veda la revisione di medio termine del POR Sardegna 2000-2006 notificata alla Commissione Europea in data 8 luglio 2005). Com-plessivamente con il POR 2000-2006 sono state attribuite risorse per circa quaranta progetti relativi all’archeologia industriale, con interventi di recupero e “messa in valore” di siti dismessi di interesse storico-industriale e minerario, trasformati in per-corsi e parchi visitabili. Dal 2005, con la sua ridefinizione, la misura 2.1 ha compreso anche il patrimonio di archeologia industriale, mediante progetti integrati che pre-vedono la realizzazione di un sistema museale regionale tematico. La misura 2.3 del POR, Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo, ha avuto lo scopo di creare una rete di attività culturali e di spettacolo con l’intento di potenziare il turismo. Con questa misura sono stati finanziati circa 130 progetti per il restauro delle strutture ospitanti biblioteche e archivi – nell’ambito della costituzione di una Rete Regiona-le di servizi bibliotecari e documentari – ed edifici destinati allo spettacolo correlati al progetto CARAS (Circuito Artistico Regionale Attività Culturali e di Spettacolo). In que-sto contesto sono stati attribuiti finanziamenti agli enti locali per l’organizzazione di eventi ed è stata bandita una gara per individuare un soggetto (team di imprese) cui affidare l’assistenza tecnica per realizzare un «sistema giuridico-economico di gestio-ne delle strutture di spettacolo» . La misura 3.15, già 2.4, inerisce invece la formazione per le competenze in materia di salvaguardia, gestione e promozione del patrimonio culturale e la produzione di servizi ed attività dello spettacolo. Per l’elenco dei pro-getti finanziati tramite POR si vedano gli allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 36/36 del primo luglio 2008, POR Sardegna 2000/2006. Aggiornamento del quadro informativo relativo ai Progetti Coerenti di prima e seconda fase. Per un quadro d’insieme sulla progettazione e la spesa del POR si veda anche la Delibera di Giunta regionale n. 5/29 del 7 febbraio 2007, Rapporto sullo stato di attuazione POR 2000-2006; Legge n.
67
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
Con la misura 2.1 del POR sono stati finanziati 220 interventi e alcuni di que-sti hanno agito su esperienze sistemiche già esistenti, come quella del Consorzio Sa Corona Arrùbia o quella della Città di Alghero130. Gli interventi della misura 2.1 del POR hanno avuto anche effetti rilevanti sui sistemi museali, soprattutto in relazione alla creazione o al potenziamento di «itinerari tematici».
Vengono progettati dal Programma una serie di itinerari culturali come le Città regie, gli itinerari di archeologia nuragica e prenuragica, gli itinerari reli-giosi ed i parchi letterari.
Il progetto denominato Città regie riguarda i centri di Iglesias, Castelsardo, Alghero, Bosa, Cagliari, Sassari e Oristano, che furono insigniti del titolo di “cit-tà” − non subordinati dunque a vincoli feudali ma direttamente sottoposti alle giurisdizioni regie − durante l’Età aragonese per particolari meriti mercantili o per le proprie posizioni strategiche. L’intenzione della serie di interventi del POR per questo progetto − che si inseriva non solo nella misura 2.1 ma anche nella 4.5 più specificamente dedicata al turismo − è stata quella di ripristinare edifici e monumenti capaci di testimoniare, in ognuna delle città coinvolte, la propria vicenda storica, ambendo a costruire così una sorta di itinerario inter-comunale tematico. Il progetto Città regie − finanziato dalla Regione grazie al POR 2000-2006 ma ideato e approvato mediante un accordo sottoscritto dai Co-muni interessati già nel 1998131 − prevedeva, oltre al recupero di antiche mura e di edifici storici, anche la creazione di box informativi, segnaletica e centri di documentazione132. Tra le iniziative realizzate vi sono state il restauro del castello di Serravalle a Bosa, il recupero dei Palazzi Ducale e di Città a Sassari, il restauro delle fortificazioni medievali a Iglesias e il sistema di illuminazione del centro storico di Alghero133.
402/1994; Programmi integrati d’area) con relativo allegato.130 Documento Strategico Regionale Preliminare della Regione Sardegna, febbraio 2006, pp.
101-105, consultabile sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sarde-gna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4750&na=1&n=10 .
131 Venti miliardi al centro storico grazie all’accordo tra le sette città regie dell’Isola, “L’Unione Sarda”, 11 gennaio 2001.
132 Determinazione n. 398 dell’Assessorato al turismo della regione Autonoma della Sardegna del 24 marzo 2005: contiene le graduatorie dei progetti presentati a finanziamento.
133 Determinazione n. 1801 del 15 luglio 2001 della Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna, Catalogo progetti POR Sardegna 2000-2006 cit., Sette città regie, pioggia di milioni sul castello che fu dei Malaspina, “L’Unione Sarda” 4 febbraio 2004.
68
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Per il cosiddetto “itinerario nuragico e prenuragico” furono impegnati quasi 19 milioni di euro per un totale di tredici progetti mirati al restauro di comples-si archeologici, al potenziamento di musei e alla creazione di centri di infor-mazione. In particolare furono restaurate le fortezze nuragiche di Barumini, il nuraghe di Orroli, il parco archeologico Su Mulino a Villanovafranca e il nura-ghe di Mogoro. Molti di questi interventi ricaddero nel territorio del Consor-zio Sa Corona Arrùbia che beneficiò delle attività finanziate dal POR non solo per i monumenti archeologici ma anche per i musei: furono infatti potenziati i musei tematici di Barumini e Sardara nonché la sezione antropica del museo del Consorzio denominata Territorio Museo, sito tra i comuni di Lunamatrona e Collinas134. Ancora grazie al POR furono realizzati centri per l’accoglienza dei visitatori, atti ad ospitare anche attività didattiche, presso l’area archeologica di Barumini. Analoghe azioni furono sviluppate in altre zone dell’Isola caratteriz-zate dalla presenza di importanti resti archeologici come Serri e Morgongiori135.
Le risorse del POR 2000-2006 sono state un utile strumento anche per lo svi-luppo del sistema museale di Alghero, progettato attorno al 1998 e realizzato, in una prima fase, grazie al programma comunitario “Terra incognita”136.
Gli obiettivi principali del progetto furono le valorizzazioni del centro sto-rico e l’implementazione sul numero di musei visitabili, per incentivare un’of-ferta turistica alternativa a quella balneare. Il Comune di Alghero progettò la costituzione di una “rete” o “museo diffuso”, denominato Territorio Museo, ca-pace di coinvolgere le emergenze culturali del proprio territorio attraverso due diverse azioni: l’apertura di nuovi musei e la predisposizione di itinerari tema-tici. Nel 1999 il Comune firmò una convenzione con la Diocesi di Alghero-Bosa, per inserire il Museo diocesano d’arte sacra di Alghero all’interno del progetto. Grazie ai finanziamenti POR 2000-2006 verso la metà degli anni Duemila, il sistema algherese si è ulteriormente sviluppato: sono stati intrapresi restauri e rifunzionalizzazione di edifici e monumenti storici al fine di creare nuove sedi museali e ampliare così il numero di centri culturali appartenenti al sistema. Negli stessi anni Alghero partecipa anche al citato circuito Città regie: nell’ambi-
134 Il POR 2000-2006 della Sardegna, nelle azioni relative all’archeologia della misura 2.1, ha riguardato anche il Consorzio Turistico Sa Perda ‘e Iddocca e il Consorzio del Parco Monte Arci, intervenendo su beni presenti nei rispettivi territorio di riferimento.
135 Si veda il documento della Regione Autonoma della Sardegna Catalogo progetti POR Sardegna 2000-2006, consultabile online nella sezione dedicata ai POR sul sito ufficiale della Regione. http://www.regione.sardegna.it/regione/programmazione_europea/2000-2006/por/comunicazione.html.
136 Si rimanda alla scheda sul sistema in questo volume.
69
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
to di questo progetto vengono realizzati un centro documentale presso il Palaz-zo Serra e un sistema di illuminazione per la valorizzazione del centro storico.
Sebbene alcuni dei progetti elaborati in occasione del POR per Alghero siano ancora in corso di realizzazione (Museo del Corallo e Museo Civico), è indubbio che questi finanziamenti abbiano concorso a potenziare uno dei pochi esempi di sistema museale sardo precedente la programmazione regionale in materia. Il sistema nasce da un progetto che, invece di destinare i fondi comunitari a singoli interventi sul patrimonio, li utilizza per un programma integrato su scala cittadina: le risorse comunitarie vengono cioè sí canalizzate in più attività ma finalizzate a un obiettivo unico ovvero la creazione di un sistema in grado di valorizzare reciprocamente i beni del patrimonio storico, artistico e archeologico di Alghero. Da notare la forte aspirazione turistica della città che, proprio per sviluppare un turismo alternativo a quello stagionale, progetta un sistema culturale che si sviluppa grazie al POR come sistema “turistico-culturale”: infatti gli interventi realizzati per il Programma, oltre che nel citato asse II misura 2.1, sono inseriti anche nell’Asse IV Sistemi locali di sviluppo alla misura 4.5 “Potenziamento e qualificazione dell’industria turistica”137. Altro elemento degno di nota, data la sua particolarità nel contesto sardo, è la gestione unitaria dei servizi che si compie nel 2007, quando cioè le tre cooperative impegnate nella gestione dei vari nuclei del sistema si sono riunite in un’Associazione temporanea di imprese. Ciò ha permesso una migliore articolazione dei servizi, tra i quali vi è la possibilità di usufruire di un biglietto cumulativo personalizzabile in base alle esigenze dei visitatori. Il sistema museale di Alghero si connota come raro caso sardo anche per gli aspetti finanziari della gestione: infatti le società che gestiscono i beni del sistema non solo non ricevono contributi regionali tramite il Comune, ma pagano a questo e alla Diocesi un canone. Le società dunque sono costrette ad autofinanziarsi per una precisa scelta dell’amministrazione comunale, che ha voluto in questo modo incentivare la qualità dei servizi prodotti dai soggetti gestori. Il caso di Alghero si pone quindi come del tutto particolare all’interno del panorama sardo dei sistemi museali e può essere considerato uno dei casi virtuosi analizzati in questa ricerca. Lo stesso sistema, del resto, ha ottenuto nel 2005 il premio Cultura di gestione di Federculture138.
137 Cfr. POR Sardegna 2000-2006, Rapporto Annuale di esecuzione al 31/12/2004, Allegato 3, Progetti esemplari.
138 Premio per le politiche di gestione e valorizzazione di beni e attività culturali: dal Territorio museo al Sistema Museale Integrato, in r. GroSSI (a cura di), Cultura tra identità e sviluppo,
70
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Nel 2007, al fine di utilizzare le risorse non ancora programmate col POR 2000-2006, la Regione ha deliberato di destinare i fondi a valere sulla misura 2.1, pari a 25 milioni di euro, a una serie di progetti volti a creare un’immagine unitaria dell’offerta culturale dell’Isola, rispondendo così alle numerose istanze provenienti dagli Enti locali, i quali lamentavano l’assenza di azioni di pro-mozione, comunicazione e marketing oltre a chiedere un potenziamento degli itinerari tematici e dei servizi per i musei. Vengono dunque predisposte quattro linee di intervento a titolarità regionale: la prima riguarda un «sistema omoge-neo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura» (Patrimonio cul-turale Sardegna), che prevede la realizzazione di un logo unico, cartellonistica, segnaletica interna, oltre a guide, brochures, locandine, postazioni multimediali, audio guide, contraddistinte dalla presenza del logo139. Il secondo intervento prevedeva la dotazione di moduli architettonici unitari per biglietteria e bo-okshop, mentre il terzo e il quarto riguardavano aiuti alle imprese operanti nel campo della promozione e gestione dei beni culturali e a quelle attive nel settore del restauro.
I contributi FESR utilizzati grazie al POR 2000-2006 hanno avuto un impatto forte nel panorama della gestione dei beni culturali in Sardegna, sebbene non siano state enucleate all’interno del programma puntuali direttive in merito alla gestione congiunta e sistemica del patrimonio. La programmazione regio-nale attuata in questa occasione mira dunque a migliorare le condizioni di fru-ibilità, a qualificare i servizi e ad attivarli laddove non siano ancora presenti, nell’ottica di una loro possibile futura integrazione e, soprattutto, a governare in maniera coordinata lo sviluppo delle strutture museali e le politiche per il turismo140. Con il POR si sono gettate le basi per quello che sarà, di lì a breve, il
cit., pp. 288-290. Si veda anche la scheda del sistema in questo volume e S. MaSIa, Gli itinerari del Territorio Museo, in Sistemi museali, cit. 2012, pp. 129-136.
139 Il progetto prevedeva anche la scannerizzazione tridimensionale dei principali reper-ti storici, la georeferenziazione dei percorsi antichi dall’età romana ai sentieri della transumanza, la ricostruzione virtuale dei monumenti più importanti. Queste attività si andavano a inserire nel programma Sardegna 3D, si veda il sito web all’indirizzo http://www.sardegna3d.it. DGR n. 4/2 del 30 gennaio 2007 POR Sardegna 2000-2006, Progettazione Integrata per lo sviluppo dei territori della Sardegna. Programma relativo ai bandi a valere sulla Misura 2.1 dell’Asse II risorse culturali, importo complessivo 25.000.000 euro; DGR n. 13/2 del 30 gennaio marzo 2006, La nuova progettazione integrata per lo sviluppo dei territorio della Sardegna: percorso e risorse per l’attuazione.
140 «[…] nell’ambito del POR Sardegna 2000-2006 la valorizzazione del patrimonio culturale è considerata strategia fondamentale di sviluppo, competitività e coesione del territorio e dei sistemi locali territoriali, anche in funzione dell’aumento dei flussi
71
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
nuovo corso della politica regionale in materia di musei, sebbene l’attenzione della Regione per il patrimonio culturale manifestata nel POR sia stata soprat-tutto connesso allo sviluppo del comparto turistico.
Tale interesse si correla a uno degli obiettivi principali della Regione in que-sti anni: lo sviluppo di un turismo nuovo, legato non solo alla attrattività delle coste e dei centri balneari ma al patrimonio culturale dell’intera Isola. Si passa cioè, con gradualità, a partire dagli anni Novanta ma con maggior vigore nel decennio successivo, da una concezione dei musei e dei monumenti come ba-cino occupazionale, da sostenere mediante attribuzione di risorse a pioggia, a un’idea del patrimonio culturale come possibile fonte di reddito e dunque di sviluppo economico per il territorio, in un momento in cui i flussi turistici della Sardegna risultano in netto aumento (soprattutto a partire dal 1994) anche gra-zie all’attuazione di politiche regionali specifiche141.
Prima del POR 2000-2006 vi erano stati già alcuni interventi volti a creare infrastrutture turistiche , specie nelle aree rurali, o a ripristinare monumenti in stato di degrado al fine di sviluppare itinerari turistici. Il Programma LEADER II 1994-1999 ha interagito con la misura 3.2 (itinerari e prodotti turistici) del PIC INTERREG II e ha permesso la realizzazione di diversi progetti presentati dai Gruppi di Azione Locale (GAL), alcuni dei quali riguardavano restauri di aree archeologiche o creazione di musei etnografici, come il Museo della civiltà contadina di Bitti142. Altri interventi sono stati supportati con i fondi del terzo asse del PIC INTEREG II Italia – Francia Isole (1994-1999), grazie ad esso sono stati restaurati i bastioni di Alghero, edifici storici e chiese di Cagliari, città per
turistici e dello sviluppo di una adeguata economia di settore». DGR n. 4/2 del 30 gennaio 2007 cit.
141 I flussi diminuiranno verso la fine del decennio; una rilevazione del Ministero dello Sviluppo Economico mostra per gli anni 2000-2004 una diminuzione del numero di turisti per abitante in Sardegna nei mesi non estivi. Il dato appare interessante tenendo conto del fatto che uno degli obiettivi più ricorrenti dei circuiti e dei sistemi museali sardi nei primi anni Duemila è stato proprio quello di incentivare il turismo fuori dalla stagione balneare. Numeri del Sud. Indicatori Regionali del QCS 2000-2006, Bollettino semestrale a cura dell’Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici DPS-MEF, Novembre 2007, p.5. consultabile all’indirizzo http://www.dps.tesoro.it/numeri_del_sud.asp?visibile1=1#vis1
142 Programma LEADER II 1994-1999 approvato con Decisione C (95) 1301 del 14 settembre 1995, modificato nel 1997 e nel 1999. Per una visione d’insieme dei progetti si consulti il Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2000. Sull’utilizzo dei fondi strutturali europei in Sardegna si rimanda inoltre a M.l. pruna, M. zurru, Come è difficile spendere. L’esperienza dei Fondi Strutturali europei in Sardegna, Franco Angeli, Milano 2001.
72
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
la quale era stato previsto anche l’allestimento del Museo del Duomo. Inoltre grazie alla misura 4.3 Sistema dei parchi naturali del Programma operativo pluri-fondo (POP 1994-1999) che riguardò, soprattutto per la costruzione di strade e campagne antincendio, oltre cento comuni della Sardegna, sono stati effettuati alcuni interventi su monumenti come quelli per l’area archeologica Montessu nel Sulcis Iglesiente143.
Lo stesso POR 2000-2006 prevedeva un’integrazione tra le misure relative alla Rete ecologica nazionale (1.4), all’Archeologia e percorsi religiosi (2.2), all’Archeo-logia industriale (2.3) alle Attività di spettacolo (2.4) e alle Politiche per le aree urbane (5.1) con la misura 4.5 Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sardegna, in-serita nell’Asse IV Sistemi locali di sviluppo. L’obiettivo era quello di riequilibrare i flussi turistici, diminuendo la pressione sulle coste – anche in virtù della loro salvaguardia – e destagionalizzando l’offerta per i visitatori mediante un suo ampliamento in aree meno sviluppate. Tra le linee di intervento proposte vi era stata anche quella di creare itinerari turistici «tesi a migliorare l’accessibilità, la visibilità e l’accoglienza delle aree di valorizzazione culturale e archeologica con particolare riferimento a quelle del periodo nuragico, prenuragico e feni-cio punico». Tali interventi, che sembrano riprendere le fila dei programmi per gli Itinerari del Mezzogiorno degli anni Ottanta, riguardavano l’allestimento di servizi per l’accoglienza, la creazione di impianti di illuminazione, parcheggi, cartellonistica, punti ristoro. I beneficiari di questi finanziamenti, previsti dal POR, furono la Regione e i soggetti controllati, gli enti locali, le società miste pubbliche e private144.
Pressoché contemporaneamente alle azioni del POR si vanno intanto a cre-are in Sardegna anche i cosiddetti Sistemi Turistici Locali (STL), istituiti dalla legge nazionale n. 135 del 2001 Riforma della legislazione nazionale del turismo per
143 Per il PIC INTERREG: Regione Autonoma della Sardegna, Programma di Inizativa Co-munitaria (PIC) INTERREG II Italia-Francia Isole, Sardegna Corsica. Decisione C(96) n. 2580 del 27 settembre 1999. Si veda anche il Rapporto annuale di esecuzione per l’anno 1999; per il POP si rimanda alla pagina web http://infoss.formez.it/poppic1994-99.html che contiene tutti i documenti relativi al Programma Operativo Plurifondo 1994-1999 della Regione Autonoma della Sardegna. Si veda anche Regione Autonoma del-la Sardegna, Manovra finanziaria 2007-2009, Stato di attuazione POR 2000-2006 e PIC – Legge n. 40271994 _Programmi Integrati d’Area e Progettazione integrata, allegato alla Delibera di giunta regionale n. 5/29 del 7 febbraio 2007.
144 Si veda il documento POR Sardegna 2000-2006 approvato con decisione della Commissione Europea C(2000) 2359 dell’8 agosto 2000 CCI n. 1999 IT 16 PO 010, consultabile alla pagina dedicata al POR nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
73
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
sviluppare in chiave turistica le diverse risorse offerte dal territorio − siano esse riferibili alla cultura, alla storia, alle produzioni tipiche, all’ambiente − median-te un’integrazione tra i diversi attori coinvolti, sia pubblici che privati, sia nella fase progettuale che in quella gestionale.
A partire dal 2002 sono stati trasferiti alle Regioni i finanziamenti per la co-stituzione dei STL e in Sardegna, sulla base delle candidature presentate alla Regione e dei relativi programmi, sono stati istituiti nel 2006 otto STL − Karalis, Medio-Campidano, Sulcis-Iglesiente, Eleonora d’Arborea, Ogliastra, Nuorese, Sardegna Nord Ovest e Gallura Costa Smeralda − che risultano coincidenti con le Province, sebbene la legge n. 135 non prevedesse limitazioni geografi-che all’estensione dei sistemi turistici, privilegiando piuttosto un’omogeneità di aree dal punto di vista paesaggistico e culturale. A ogni STL − che non co-stituisce un nuovo ente locale ma un’aggregazione di soggetti siglata tramite accordi − la Regione ha attribuito un finanziamento per realizzare il proprio programma triennale. Infatti ogni STL è composto da un’associazione di sog-getti pubblici e privati che lavorano assieme per sviluppare il turismo di un determinato territorio attraverso un progetto di durata triennale che, una volta approvato, viene cofinanziato dalla Regione. La Regione vuole in questo modo definire una riforma del turismo basata sulla cooperazione tra amministrazioni provinciali e comunali, imprese private, associazioni di settore e consorzi turi-stici. Per coordinare queste attività viene istituita, con legge regionale 4/2006, l’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione145. Oltre ai singoli si-stemi turistici locali, la Regione Sardegna lavora quindi alla creazione e alla futura gestione di una rete regionale di sistemi turistici locali. L’obiettivo che la Regione si pone è quello di creare una rete di servizi efficienti per il turismo:
145 LR n. 4 del 11 maggio 2006, Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo. Si veda anche la DGR n. 50/6 del 5 dicembre 2006, L.R. 11 maggio 2006, n. 4 art. 7. Agenzia governativa regionale di promozione economica “Sardegna Promozione”. Approvazione dello Statuto. DGR n. 34/11 del 19 luglio 2005, L. 135/2001 Riforma della legislazione nazionale del turismo. Artt. 5 e 6 sistemi turistici locali. Direttive e linee guida per il riconoscimento dei sistemi turistici locali e il finanziamento dei programmi di attività. Nel 2008 viene realizzato il marchio “Sardegna” per la valorizzazione dell’immagine unitaria della regione, che rientra nel progetto relativo al POR 2000-2006 “Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi degli istituti della cultura”: il segno, che consiste in una’elaborazione grafica della parola “Sardegna” con lettere colorate, viene quindi adottato dalla Regione e da altri organismi in occasione di manifestazioni e comunicazioni pubbliche. La sua introduzione e il suo utilizzo sono regolati dalla delibera di Giunta regionale n. 6/34 del 30 gennaio 2008, Introduzione e disciplina d’uso dei un segno istituzionale per la promozione e la valorizzazione dell’immagine unitaria della Sardegna.
74
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
in questi anni − che sono poi quelli della cosiddetta “legge salva coste” (legge regionale n. 8 del 2004) − si afferma con forza l’idea che il turismo, in quanto fondamentale aspetto dell’economia isolana, si debba fondare sulla dotazione di servizi e sulla promozione di attività non deleterie delle risorse culturali e ambientali146.
Dal punto di vista del patrimonio culturale i sistemi turistici locali hanno finora svolto un’azione di tipo sostanzialmente promozionale, anche grazie alla realizzazione dei relativi portali web, all’interno dei quali sono pubblicizzati gli eventi (mostre, spettacoli, manifestazioni), e sono date informazioni generali sui beni (musei, siti archeologici, parchi, monumenti) delle rispettive aree. In alcuni casi poi, come per il Consorzio Sa Corona Arrùbia e il Parco Geominera-rio, ad esempio, le esperienze sistemiche del territorio precedono questa fase di programmazione e partecipano direttamente ai STL, prendendo parte agli accordi tra enti e società con i quali tali sistemi turistici si formano147.
¬ 6.3 Verso una programmazione regionale per i sistemi
L’interesse della Regione per la promozione dei sistemi museali, pur se tal-volta non in maniera diretta, si può rintracciare in diversi atti a partire soprat-tutto dal 2000. L’esplicita volontà di procedere alla creazione di un sistema mu-seale regionale si individua per la prima volta nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) per il 2005-2007, approvato il 22 dicembre 2004. Nel documento si prende atto del fatto che l’assenza di strumenti normativi e indirizzi specifici, associata alla ridotta disponibilità di risorse sul bilancio, ha determinato un ridimensionamento delle attività regionali per i musei. In tal modo sono state sostanzialmente rallentate, se non addirittura bloccate, le at-
146 LR n. 8 del 25 novembre 2004, Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.
147 Il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna aderisce al Sistema turistico Lo-cale della Provincia di Carbonia Iglesias con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 13 gennaio 2006; il Consorzio Sa Corona Arrùbia partecipa al Sistema Turistico Locale del Medio Campidano. Sul tema dei Sistemi Turistici Locali, anche in rapporto alle misure POR 2000-2006 per le Regioni obiettivo 1 (Mezzogiorno d’Italia), si veda-no gli interventi presentati nel corso del Seminario I sistemi turistici locali nella realtà dei fatti: nascita, sviluppo e consolidamento, tenutosi a Roma il 28 febbraio e il 1 mar-zo 2007, nell’ambito del Progetto Formez Sviluppo dei servizi formativi e trasferimento di buone prassi nel settore del turismo e dell’ospitalità consultabili online all’indirizzo http://db.formez.it/ArchivioNews.nsf/0ad80f6adb86876fc1256f3b004ab252/e82574815b263030c1257298005b379a?OpenDocument
75
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
tività di integrazione di beni e servizi utili anche al potenziamento del turismo destagionalizzato.
Con questo documento, invece, la Regione afferma di voler procedere alla ottimizzazione degli interventi regionali nel campo dei musei e dei beni cul-turali, coordinandoli con le risorse comunitarie e statali, al fine di superare la dispersione dell’offerta culturale e le carenze, sia scientifiche che gestionali, dei musei locali finanziati dall’amministrazione regionale.
Una prima linea di azione individuata dal DPEF 2005-2007 consiste nell’in-troduzione di standard di qualità per i musei, nell’ottica della costruzione di una «rete regionale dei musei e dei siti archeologici e monumentali che possa anche essere di supporto alle realtà più deboli»148. La Regione è intenzionata poi a potenziare e migliorare le attività scientifiche e organizzative dei musei dotandoli di programmi specifici «anche attraverso forme associative e con-sortili»: si prospetta quindi, oltre alla creazione di un sistema a dimensione regionale, anche una serie di sistemi territoriali ovvero associazioni o consorzi tra enti149.
Dopo pochi mesi, con la deliberazione n. 14/1 del 31 marzo 2005, la Regione si impegna nuovamente a dare vita a una messa in rete del patrimonio cultura-le: la delibera suddivide il finanziamento CIPE in cinque programmi da attuare mediante stipula di accordi di programma quadro. Per il settore dei beni cul-turali, in particolare, sono individuate quattro linee strategiche e una di queste inerisce appunto la «creazione di un sistema dell’offerta culturale della Sarde-gna» in quanto, si legge nel documento, «si preferisce un approccio sistemico alla gestione delle istituzioni culturali tramite la creazione di sistemi integrati territoriali nel settore culturale o di “musei diffusi” su tutto il territorio». A questo proposito si programma per il 2006 uno studio di fattibilità per la messa in rete dell’offerta culturale della Sardegna e la sua effettiva realizzazione150.
148 Gli altri interventi riguardano l’incremento delle attività di catalogazione inventaria-zione e la predisposizione di una «normativa regionale organica in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali nell’ambito di un sistema museale regionale favorendone il collegamento con iniziative di carattere produttivo e di ser-vizio collegate al tessuto imprenditoriale regionale». Documento di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione Autonoma della Sardegna 2005 – 2007, approvato dal Consiglio Regionale il 22 dicembre 2004 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n.1, 8 gennaio 2005, pp. 41-42.
149 Ibidem p. 42.150 DGR n. 14/1 del 31 marzo 2005, Deliberazione CIPE n.20 del 29 settembre 2004, punto
6.1.3. Adempimenti al 31 marzo 2005.
76
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Questa volontà regionale si esplicita nel secondo semestre del 2005 attra-verso due importanti atti: un documento di indirizzo per i musei, approvato a luglio, e la stipula di un APQ dedicato ai beni culturali, approvato a settembre.
É infatti con un Documento di indirizzo politico amministrativo dal titolo Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo, approvato con delibera n. 36/5 del 26 luglio 2005, che si definiscono le linee programmatiche per la futura gestione da parte della Regione del settore musei di ente e interes-se locale, ovvero di quell’insieme di istituti che, da Statuto, competono prima-riamente all’amministrazione regionale e per i quali le innovazioni normative come la sentenza 272/2004 della Consulta e l’articolo 115 del Codice invitano ora a un intervento più energico da parte delle Regioni151. Il documento si basa sulle valutazioni relative allo stato dei servizi museali in Sardegna, prodotte da alcuni studi settoriali del primo quinquennio degli anni Duemila, come il già citato rapporto finale del progetto Innovacultura condotto dall’Assessorato assieme a Federculture, l’XI Rapporto del Crenos sull’Economia della Sardegna e l’Indagine sui musei e siti archeologici per gli esercizi finanziari 2000-2003 condotta dalla Sezione di controllo per la Regione Autonoma della Sardegna della Corte dei Conti, pubblicata nel 2005, che costituisce la presa d’atto della necessità di un profondo cambiamento nella organizzazione dell’assetto della programma-zione e della gestione dei finanziamenti regionali152.
Con queste premesse la Regione promuove una serie di linee di indirizzo per la qualificazione dei musei e invita a dare avvio alle consultazioni per la produzione di una legge «sul sistema museale regionale»153. Prima di analiz-zare queste due importanti decisioni è necessario ripercorrere per sommi capi i risultati emersi dall’indagine della Corte dei Conti, sia per conoscere quale fosse lo stato del patrimonio museale della Sardegna, sia per comprendere in quale misura le valutazioni di questo organo abbiano “spronato” la Regione verso la promozione dei sistemi.
151 Deliberazione n. 35/5 del 26 luglio 2005 cit.152 M. IorIo, Musei, siti cit., pp. 15-20. La ricerca oltre che studiare i flussi turistici e la
tipologia di visitatori nelle diverse realtà locali presenta anche un’analisi dei servizi erogati in musei e siti archeologici e dei rispettivi strumenti di gestione. A questo proposito si rileva che l’80% delle gestioni trattate dichiararono di non appartenere a reti o sistemi, nel dettaglio: il 55% delle gestioni museali e addirittura il 90% di quelle relative ad aree archeologiche risultano estranee a gestioni di tipo congiunto o integrato. Lo studio propone come possibile soluzione ai noti problemi gestionali di questo comparto − non risolti neppure in seguito all’adozione della legge 4/2000 − la creazione di sistemi integrati territoriali, prendendo ad esempio quanto avvenuto in Regioni come la Toscana o l’Umbria. Corte dei Conti, Ricognizione e indagine, cit. 2005.
153 DGR n. 36/5 del 2005 cit.
77
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
¬ 6.4 L’indagine della Corte dei Conti sui musei locali della Sardegna
La relazione della Corte dei Conti, inerente i musei di ente locale, metteva in luce una serie di problemi del panorama museale dell’Isola: si segnalava, in pri-mo luogo, l’assenza di un elenco completo dei musei esistenti in Sardegna, che venivano in questa occasione censiti tramite invio di questionari a tutti i Comu-ni154. La situazione fotografata dalla Corte dei Conti presentò 129 Comuni con musei attivi o in fase di allestimento, per un totale di 160 musei di cui 110 aperti, 46 in allestimento e 4 chiusi155. Di questi, 123 erano di proprietà pubblica, 13 di enti ecclesiastici e 24 privati. La tipologia museale prevalente (59 musei) risultò essere quella etnografica, seguita numericamente (34 musei) da quella archeo-logica156. Raramente i musei sardi hanno autonomia organizzativa e finanziaria ovvero propri regolamenti, statuti e scritture di bilancio; la gestione è affidata soprattutto a cooperative locali che sono tenute a rendicontare introiti e spese al Comune affidatario dei servizi157. Interessante notare come, per quantificare i trasferimenti finanziari regionali alle amministrazioni locali, la Corte dei Conti
154 Furono inviati questionari ai 377 Comuni della Sardegna nel marzo 2003. Dopo una prima analisi dei dati relativi all’esercizio finanziario del 2002, fu deciso di condurre un approfondimento sui musei non statali di ente locale effettivamente aperti e alle aree archeologiche per il periodo 2000-2003. Corte dei Conti, Ricognizione e indagine cit. 2005, p. 208.
155 La maggior parte dei musei, specialmente pubblici, ha un’apertura di tipo continuativo (63%), mentre il 13% ed il 6% sono rispettivamente aperti periodicamente e su richiesta. Corte dei Conti, Ricognizione e indagine cit. 2005, p. 209.
156 Ibidem, p. 212. I musei archeologici sorgono spesso nelle vicinanze di aree archeologiche. I musei archeologici sono 34, i musei storico-artistici 14, gli etnografici 59, quelli scientifici 13 e quelli con collezioni eterogenee 29. Corte dei Conti, Ricognizione e indagine cit. 2005, tabella n. 1. I beni esposti sono nel 44% dei casi di proprietà comunale e per il 19% appartengono sia all’ente pubblico che ai privati. Il 20% dei musei censiti dalla relazione della Corte dei Conti risulta avere collezioni di proprietà statale (in particolare ciò avviene nei musei archeologici) sebbene il “contenitore” ovvero la struttura museale appartenga al Comune.
157 Nell’82% dei casi i Comuni affidano la gestione dei musei a privati (cooperative) tramite gara a evidenza pubblica mentre solo il restante 18% gestisce direttamente le proprie strutture con personale comunale o regionale e provinciale. Tutti i musei analizzati si configurano come “musei-ufficio” ovvero come articolazioni del competente assessorato: solo 21 musei si dichiarano dotati di un proprio statuto o regolamento in ottemperanza a quanto raccomandato nel Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001 relativo agli standard di funzionamento per i musei. Risultano provvisti di regolamento in particolare il Museo etnografico di Arzachena, Il Museo Civico di Ozieri, il Museo MAN di Nuoro. Corte dei Conti, Ricognizione e indagine cit. 2005, p. 212.
78
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
abbia dovuto procedere a una ricognizione basata sulle dichiarazioni dei Co-muni stessi, essendo impossibile «desumerlo dai dati singolarmente trasmessi dagli Assessorati»: nel periodo dell’indagine (2002-2003) comunque l’impegno di risorse sul bilancio regionale è stato pari a 40 milioni di euro, ai quali si ag-giungevano i 20 milioni di euro relativi al POR 2000-2006158.
La conclusione cui pervenne la Corte dei Conti in merito ai dati qui breve-mente esposti fu perentoria: malgrado la potestà legislativa esclusiva detenuta dalla Regione Sardegna, si rilevava l’assenza di un «disegno unitario e organico del settore […] con conseguenze negative sulla programmazione delle scelte e delle risorse». Si riconoscevano in più come «frammentari e disorganici» gli in-terventi finanziari. La Corte ravvisava in conclusione la necessità di un «ruolo decisivo e strategico» da parte della Regione, richiamando quest’ultima «ad impiantare un ‘sistema a rete’ dei possibili percorsi culturali-museali-archeo-logici e alle complementari attività di divulgazione e pubblicizzazione»159. La stessa Corte dei Conti invitava in altre parole la Regione a percorrere la via del-la gestione sistemica per il comparto musei, al fine di raggiungere quell’auspi-cato “auto sostentamento” che dal 2000 la Regione tentava di promuovere, con alterne fortune, cercando di porre fine alle politiche assistenzialistiche messe in atto per molti decenni.
Le osservazioni della Corte dei Conti trovarono un positivo riscontro da parte delle amministrazioni locali convocate in sede di contraddittorio alla se-zione di controllo della Sardegna, e ciò conferma come gli stessi enti pubblici territoriali condividessero − anche se spesso in via ancora teorica − l’idea della necessità dell’istituzione di reti e sistemi per i musei160.
Anche in Sardegna, così come avviene in altre Regioni, la nascita delle pri-me aggregazioni di tipo sistemico sul territorio precede la programmazione regionale in materia. Il fenomeno dei sistemi e delle reti museali costituitesi in Sardegna prima del 2005, ovvero prima degli indirizzi in materia da parte delle
158 Comunicato stampa della Corte dei Conti n. 17/2005 del 20 giungo 2005.159 Ibidem.160 Nel 2004 la Regione aveva erogato finanziamenti per incentivare la gestione associata
di servizi e funzioni comunali. Le richieste da parte dei Comuni non avevano riguardato però il comparto musei ma i servizi turistici. Tra i destinatari dei contributi straordinari vi furono i consorzi turistici Sa Perda e’ Iddocca, Sa Corona Arrùbia, Due Giare. DGR n. 54/10 del 30 dicembre 2004, Incentivazione della gestione associata di servizi e funzioni comunali. Art. 7/bis LR n/ 25/1993, Art. 38 Lr 17/2000. Contributo straordinario per la fase di avvio delle unioni dei Comuni, comma 3/bis art, 7/bis Lr 25/1993 art, 7 comma 4 LR 22/04/2002 n. 7. Capitolo 04021-000, UPB S04.016. riparto 2004.
79
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
Regione, è piuttosto raro ma i pochi esempi presenti (Sa Corona Arrùbia, Alghe-ro, Carbonia, Seui, Armungia) manifestano comunque l’esistenza di una serie di istanze maturate sul territorio che tardano ad essere recepite e organizzate dalle politiche.
Nella stessa relazione della Corte dei Conti venivano censiti venti casi di gestione congiunta: non si tratta ancora, almeno nella maggior parte, di veri e propri sistemi ma di Comuni che gestiscono congiuntamente un museo e un’area archeologica o più musei, solitamente due. Questa situazione appare coerente con la stessa conformazione del patrimonio culturale isolano, forte-mente connotato dalla presenza di numerosi siti archeologici cui si affiancano musei locali atti a contenerne i reperti, nati soprattutto a partire dagli Settanta e Ottanta. Analogamente il fenomeno di gestioni unitarie per tipologie di beni anche diverse (ad esempio musei e archivi) risulta in una certa misura essere stato promosso dai programmi sulla legge regionale 4/2000.
Tra le gestioni congiunte citate dalla Corte dei Conti si riconoscono comun-que già alcuni sistemi museali piuttosto definiti che descriveremo nelle prin-cipali caratteristiche in modo da delineare la situazione nella quale la Regione sarebbe andata di lì a poco intervenire con il «piano di razionalizzazione».
I sistemi attivi registrati nel 2005 dalla Corte dei Conti in Sardegna sono quello del Comune di Seui, che come anticipato a partire dal 2003 è gestito da un’unica cooperativa, quello di Carbonia e il sistema di Armungia denominato Sa Domu de is Ainas161.
La nascita del Sistema Museale Cittadino di Carbonia si ebbe nel 1999, quan-do l’amministrazione comunale avviò la gestione unitaria per il Museo Arche-ologico Villa Sulcis, l’Area Archeologica di Monte Sirai e il Museo Paleontolo-gico e Speleologico E. A. Martel, al fine di ottimizzare le risorse economiche a disposizione. Per i primi anni i vari centri del sistema furono gestiti da una cooperativa locale; successivamente, in occasione della partecipazione del Co-mune al bando di finanziamento relativo ai progetti a valere sulla legge regio-nale 4/2000, la gestione passò a un raggruppamento temporaneo di imprese. Il Sistema si concretizza con la realizzazione della bigliettazione unica e di alcune
161 Da questa ricerca i sistemi museali attivi prima del 2005 in Sardegna risultano essere: il sistema comunale di Carbonia (1999), quello di Alghero (progettazione 1998, prima realizzazione 2000), il sistema di Seui (2001), quello di Armungia (2002). Tra le esperienze di tipo sistemico che non si autodefiniscono sistemi, percorsi o reti, segnaliamo invece, sempre come presenti prima del 2005, il Consorzio Sa Corona Arrùbia (1982), il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna (2001), il Consorzio Camù per il patrimonio di Cagliari (2004).
80
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
attività di promozione per il patrimonio: nel corso degli anni è stato predisposto anche un suo ampliamento, mediante la progettazione di un itinerario tematico dedicato alla città di fondazione e di un altro parco archeologico162. Nel 2006 il Comune di Carbonia manifestò interesse a partecipare, col proprio patrimo-nio, al costituendo sistema territoriale integrato del Sulcis Iglesiente; si tratta di un progetto elaborato dal Comune di Carbonia con i Comuni di Sant’Antioco (capofila), Santadi, Tratalias, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Villamassargia, Villaperuccio, Carloforte, Fluminimaggiore e Bugerru, che mirava all’istituzio-ne di un biglietto unico per tutte le aree coinvolte oltre a una serie di attività di marketing per la promozione di tutto il territorio. Il progetto di sistema interco-munale fu presentato nel 2006, in occasione del primo bando di finanziamento a valere sulla legge regionale 7/2005; malgrado la nomina di un comitato di programmazione nel 2007 e la presenza del sistema nei progetti contemplati all’interno del Piano regionale triennale per i musei del 2008, le azioni per la concretizzazione del sistema sembrano essersi al momento interrotte163.
Il sistema museale di Armungia invece si sviluppa da un progetto di gestio-ne congiunta presentato nel 2000 dal Comune al primo bando di finanziamento a valere sulla legge regionale 4/2000. Si compone inizialmente di strutture di spettanza sia comunale sia private e la gestione viene affidata a una cooperati-va locale tramite gara pubblica. Nel progetto presentato sul secondo program-ma triennale ex lege 4/2000, il sistema risulta ridimensionato e composto adesso solo dalle strutture comunali (il Museo Etnografico, la cosiddetta Bottega del Fabbro, ovvero la ricostruzione di una tipica bottega artigiana, e il Nuraghe), mentre quelle private (la casa natale di Emilio Lussu e la Chiesa cinquecente-sca) sono escluse dal sistema. Il Comune provvede però a creare alcuni itinerari escursionistici nei dintorni della cittadina e soprattutto a inserire nel circuito della visita guidata al sistema – compresa nel biglietto congiunto istituito nel 2002 – un percorso tra le tipiche costruzioni locali del centro storico in cui si trovano le strutture musealizzate del sistema.
Tra le gestioni congiunte citate nella relazione della Corte dei Conti si segna-la come particolarmente articolata quella del Comune di Sant’Antioco, che il-lustra i possibili effetti prodotti dalle diverse modalità di finanziamento attuati dalla Regione per il comparto dei beni culturali.
162 Tali progetti dovrebbero concludersi entro il 2009. Si veda la scheda pubblicata in questo volume.
163 Il sistema è riproposto come sistema museale provinciale nell’Allegato C alla DGR n. 29/11 del 22 maggio 2008, con cui si approva il Piano regionale triennale preliminare per i musei, i beni culturali ed i luoghi della cultura. Si veda infra paragrafo 6.8.
81
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
Nel territorio comunale si registrano − come già rilevato al momento dell’in-dagine della Corte dei Conti − due diverse gestioni congiunte. La prima riguar-da il museo archeologico e l’area archeologica del Tophet, affidati alla coope-rativa Archeotur che, fin dalla metà degli anni Ottanta, con il nulla osta della Soprintendenza competente, ha stipulato con il Comune una convezione sulla base della legge regionale 28/1984 (art. 10). Si tratta quindi di un classico esem-pio di affidamento di gestione finanziato tramite la normativa per l’occupazio-ne che, anche attraverso i fondi a valere sulla legge regionale 11/1988, realizza attività di promozione per l’area archeologica e il museo.
La seconda gestione congiunta riguarda invece il Museo etnografico, il Vil-laggio ipogeo, la Necropoli, il Forte sabaudo e il locale archivio storico. Per la gestione di tali strutture si è utilizzato invece il finanziamento relativo alla leg-ge regionale 4/2000: il soggetto che si occupa di questo secondo gruppo di beni è un’associazione temporanea di imprese, costituita ancora dalla cooperativa Archeotur e dalla cooperativa Studio 87 che, a sua volta, gestiva già l’archi-vio storico locale. Per l’insieme del patrimonio di Sant’Antioco si hanno così due distinte gestioni, congiunte ma non integrate, dato che il relativo personale è pagato su due diversi bandi di finanziamento: quello sulla legge regionale 11/1988 e quello sulla 4/2000.
Al momento della nostra ricerca (2008) si avevano così tre tipi di bigliet-tazione: un biglietto unico per il museo archeologico e il Tophet, uno per le altre strutture (escluso l’archivio storico) e uno complessivo per tutti i musei e siti comprensivo di visita guidata164. A Sant’Antioco dunque il patrimonio archeologico, museale e monumentale nelle sue principali emergenze è sostan-zialmente gestito da una sola cooperativa, peraltro molto attiva nelle iniziative di promozione, che però risulta finanziata attraverso due normative diverse su due progetti distinti laddove sarebbe stato quasi fisiologico realizzare un siste-ma che integrasse in maniera omogenea tutti i beni presenti.
¬ 6.5 Il Piano regionale di razionalizzazione e sviluppo per i musei del 2005
In risposta alle osservazioni avanzate dalla Corte dei Conti, l’Assessorato regionale espresse il proposito di razionalizzare gli interventi economici, de-stinandoli ai musei sulla base di criteri territoriali ovvero per aree «verso cui
164 Le notizie sono tratte dal sito web della cooperativa Archeotur di Sant’Antioco, che gestisce anche altre emergenze culturali dell’area del Sulcis, all’indirizzo http://www.archeotur.it .
82
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
far confluire un numero di visitatori adeguato a giustificarne l’apertura». La progettazione della messa in rete dei musei sardi era stata già avanzata, come anticipato, nella linea strategica dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) approvato nel 2005165. La Regione, che avrebbe dovuto comunicare le misu-re da adottare a seguito delle osservazioni della Corte dei Conti entro la fine 2005, predispose le linee guida per la gestione del comparto musei nel luglio di quello stesso anno, avviando, almeno in via teorica, una riconfigurazione delle politiche regionali per i musei in un’ottica profonda e ambiziosa ma, come ve-dremo, di non immediata attuabilità.
Il programma prevedeva sei interventi: il primo consisteva nella costruzione di un sistema museale regionale, articolato in reti a dimensione territoriale o di tipo tematico, con adozione di un biglietto unico o una di una card su mo-dello di quella in uso in Campania166. La seconda misura riguardava l’avvio di una procedura di riconoscimento regionale per i musei di ente locale sulla base dei criteri definiti dal decreto ministeriale del 2001. Oltre a queste due misure, sentite come prioritarie, si predisponevano poi interventi per l’aggiornamento e la formazione del personale in servizio presso i musei, la sperimentazione di distretti culturali, il riassetto della normativa regionale in materia tramite l’e-laborazione di una nuova legge e l’istituzione di sei nuovi musei regionali con funzione di “poli” sul territorio167.
L’organizzazione dei nuovi indirizzi regionali in materia di musei ruota at-torno all’idea della necessità di adottare quella che viene definita «una logica di rete» e che dovrebbe concretizzarsi nella costruzione di un sistema a dimensio-ne regionale: in questo modo si cerca di rimediare alla ripetitività dell’offerta museale e alla scarsa qualità dei servizi168.
165 DGR n. 14/1 del 31 marzo 2005 cit. 166 A partire dal 2001 in Campania sono stati realizzati diversi tipi di “card”: la prima
riguardava una bigliettazione integrata per i musei e il trasporto pubblico a Napoli, la seconda estendeva la propria validità ai Campi Flegrei per arrivare nel 2002 alla Card regionale. Si veda il sito ufficiale dedicato alla card all’indirizzo http://www.artecard.it/IT/Home.cfm; cfr. anche d. la MonIca, t. MaGGIo. Dossier Regione Campa-nia pubblicato sul sito del progetto del LARTTE – Scuola Normale Superiore dedicato ai sistemi museali all’indirizzo http://sistemimuseali.sns.it , con bibliografia e atti ufficiali di riferimento.
167 Sui distretti culturali, che si legano all’impostazione “sistemica” scelta per la revisio-ne del comparto museale, si veda anche il comunicato stampa della Regione relativa alla pubblicazione dello studio di fattibilità sui distretti del 2005 all’indirizzo web http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?v=2&t=1&c=215&s=12552.
168 La Regione censisce, nel 2005, 170 musei non statali (non tutti fruibili): in molti
83
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
Uno dei principali nodi critici per i musei sardi riguardava infatti il man-cato adeguamento da parte della maggior parte delle strutture esistenti agli standard definiti con il decreto ministeriale del 10 maggio 2001: mentre in altre Regioni italiane il recepimento di tali criteri era stato promosso anche attra-verso politiche di incentivo correlate alla distribuzione delle risorse regionali, premiando cioè le strutture che si impegnavano nel raggiungimento di alcuni standard, le iniziative adottate in Sardegna erano, ancora alla metà degli anni Duemila, sostanzialmente estranee a questo genere di soluzioni.
Con il Piano di razionalizzazione dunque la Regione prende atto della neces-sità di adeguare le realtà museali agli standard, proponendo una serie di linee guida per il riconoscimento dei musei da parte della Regione da attuare con un approccio graduale, che permettesse cioè anche ai musei minori di uniformarsi alle raccomandazioni del decreto ministeriale in tempi ragionevolmente brevi.
L’accreditamento dei musei di ente e interesse locale è il primo forte elemen-to di novità che riscontriamo nel Piano del 2005: si prendono a questo proposi-to dichiaratamente a modello Regioni come la Lombardia, la Toscana, l’Emilia Romagna e le Marche, cercando di declinarne le buone pratiche alle esigen-ze sarde. La Regione decide che per poter accedere ai finanziamenti, a partire dal 2007, i musei locali dovranno adeguarsi a dodici requisiti minimi riferiti agli otto ambiti degli standard ministeriali. In un processo di qualificazione che sarebbe stato pluriennale, la Regione conta di riuscire nel primo anno a far adeguare i musei a quattro standard minimi: la disponibilità e/o possesso di una collezione permanente e di una sede, la redazione di un atto istitutivo e di un regolamento169. Il processo di accreditamento si basa sulla presentazio-
casi i Comuni hanno istituto un proprio museo indipendentemente dall’esistenza di strutture analoghe nei Comuni limitrofi e a questa prassi consegue, come ovvio, una forte ripetitività dell’offerta culturale sul territorio, specialmente per quanto riguarda i numerosi esempi di musei di tipo etnografico consistenti in ricostruzioni di “case” tradizionali (degli artigiani, dei pastori, dei contadini) con attrezzi, utensili e suppellettili del passato. A questa moltiplicazione dell’offerta, la Regione risponde proponendo una ridefinizione degli obiettivi culturali dei singoli musei, da armonizzare reciprocamente inserendoli in un progetto unitario ma mantenendo le esperienze esistenti. Per quanto concerne invece le molte collezioni di fotografie e documenti relativi al territorio esposte in strutture paramuseali, viene avanzata l’ipotesi di un loro inserimento nelle biblioteche locali come nuclei documentari sul comprensorio.
169 In via provvisoria, infatti, la Regione riconosce i musei in possesso di questi quattro requisiti anche in assenza di uno o più degli altri otto previsti, a patto che il museo predisponga un piano con il quale, entro tre anni, si uniformi alla totalità degli standard previsti dal Piano. Nel documento si forniscono poi anche le definizioni di:
84
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
ne da parte del museo di una scheda autovalutativa e di un progetto museale da attuare successivamente; tali documenti vengono vagliati da una apposita commissione tecnica. Il riconoscimento − formalizzato con delibera della giun-ta regionale − ha una validità di tre anni dopo di che deve essere rinnovato con analoga procedura.
Il riconoscimento dei musei si lega alla creazione del sistema museale re-gionale promossa dal documento: infatti, se da una parte la Regione auspica la nascita di associazioni di enti su base territoriale o tematica finalizzata alla cre-azione di sistemi museali, dall’altra richiede che almeno uno dei musei aderenti a tali associazioni presenti i requisiti minimi per l’accreditamento regionale; la Regione concede poi incentivi a quei musei che, una volta riconosciuti, svolga-no il ruolo di centro di sistema garantendo servizi essenziali agli altri istituti partecipanti.
Nella descrizione della linea di intervento sul sistema museale regionale, denominata Creazione di una nuova mappa dei musei regionali e di strutture di pro-mozione della cultura, viene ribadito l’allineamento della Regione Sardegna alle politiche regionali toscane, lombarde, emiliane e marchigiane: si ravvisa cioè nella promozione di sistemi e reti praticata da queste Regioni una valida solu-zione per la razionalizzazione dell’esistente. Dobbiamo però considerare che, ad esempio in Toscana, la promozione di sistemi museali da parte della Regio-ne – partita nel 1996 ma già precedentemente normata nel 1980 – si motivava anche nella volontà di limitare la nascita di nuovi musei; al contrario in Sarde-gna uno degli interventi connessi alla futura istituzione del sistema museale re-gionale è la fondazione di nuovi musei come «centri nodali» del sistema regio-nale. L’architettura prospettata per il patrimonio museale sardo prevede quindi un sistema regionale formato da musei accreditati, sistemi territoriali e da una serie di musei di nuova concezione e istituzione, a carattere prevalentemente tematico, che fungono da centri di propulsione per le attività culturali e museali del territorio di riferimento e/o dell’area tematica di pertinenza. È interessante notare come lo scopo di questi nuovi musei sia assimilabile ai cosiddetti ‘pre-sidi culturali territoriali’, di cui si parlava già alla fine degli anni Settanta ad esempio nel caso del comprensorio della Marmilla. A questo proposito dobbia-mo anche rilevare l’assenza, in un documento che pone le basi per la creazione di un’organizzazione a rete del patrimonio su scala regionale, di una valutazio-ne delle esperienze di tipo sistemico che si fossero in precedenza già sviluppate nel territorio; un censimento e un’analisi di queste esperienze avrebbe potuto
museo, raccolta museale, sito culturale, ecomuseo.
85
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
consentire di raccogliere informazioni per una miglior progettazione e avreb-be potuto permettere di integrarle nel sistema in corso di organizzazione. Una sorta di ricognizione delle potenzialità offerte dal territorio fu elaborata quasi contemporaneamente in occasione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo di distretti culturali promosso dalla Regione, il quale però non analizzava detta-gliatamente i sistemi presenti nelle varie aree dell’Isola170.
Nel Piano del 2005 si progetta l’istituzione di sei nuovi musei regionali e di due centri per la promozione delle attività culturali − la Fabbrica delle arti e il Centro di Documentazione del Cinema e dello Spettacolo − da realizzare grazie al Fondo per le Aree Sottosviluppate (FAS) all’interno delle azioni program-mate dall’APQ. Ogni nuovo museo è riferibile a un ambito culturale specifi-co: dall’arte contemporanea all’archeologia industriale, dalla cultura fenicia a quella di età giudicale. Il primo di questi nuovi musei è quello dedicato all’arte nuragica e all’arte contemporanea, da allestire a Cagliari con un progetto ideato da un architetto specializzato in strutture museali, che vuole essere, nelle inten-zioni regionali, anche un’opera architettonica di forte impatto, un «Landmark», simbolo del nuovo corso delle politiche culturali della Regione.
Un secondo progetto riguarda l’archeologia industriale e si incentra su una serie di strutture allora in corso di ripristino (come il Complesso Montevecchio) all’interno del Parco Geominerario, che dovrebbe assumere il ruolo di promo-tore culturale per questa tipologia di beni a livello regionale. A Oristano, dove con la collezione Marchese d’Arcais nacque il collezionismo di archeologia feni-cia, la Regione progetta invece una rete museale provinciale dedicata ai Fenici con, al centro, un nuovo Museo della civiltà fenicia della Sardegna per il quale si prevedono due obiettivi: far conoscere tutte le emergenze collegate alla civiltà fenicia presenti nell’Isola e definire − assieme all’Antiquarium Arborense e al Museo della Sardegna Giudicale (da istituire anch’esso in questa occasione) −
170 Alla fine del 2005, la Regione pubblicò uno studio di fattibilità sui distretti culturali, realizzato per essere inserito tra le modifiche e le integrazioni all’Accordo di Pro-gramma Quadro in materia di beni culturali. Lo studio, partendo dalla rilevazione sul territorio regionale di monumenti e musei, manifestazioni, industrie creative e centri di ricerca, individuava dieci possibili distretti, sviluppabili nei comprensori di Alghero, Sassari, Olbia, Bosa, Oristano, Nuoro, Ogliastra-Quirra, Cagliari, Marmilla-Sarcidano e Sulcis-Iglesiente. Regione Autonoma della Sardegna Studio di fattibilità finalizzato ad individuare la strategia di sviluppo dei distretti culturali per le politiche cultu-rali della Regione, Sardegna. Sintesi, dicembre 2005, consultabile all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?v=2&t=1&c=215&s=12552 . DGR e n. 45/20 del 27 settembre 2005, Accordo di programma Quadro Beni culturali. Modifiche e integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 14/1 del 31 marzo 2005.
86
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
una storia a tutto tondo del comprensorio di Oristano. Altri interventi previsti sono poi il circuito museale dedicato al tema delle bonifiche e dell’elettrificazio-ne con sede ad Arborea, la creazione di una rete museale interprovinciale per integrare le esperienze museali del Nuorese e dell’Ogliastra e di un analogo si-stema per la provincia di Sassari e la Gallura, per il quale si prospetta l’apertura di due musei tematici, uno dedicato all’arte dell’Ottocento e del Novecento e l’altro all’artigianato e al design, entrambe con sede a Sassari.
La “rete” museale regionale si articola quindi attraverso la presenza di “nodi” museali, ovvero musei di riferimento per aree tematiche e territoriali e pertanto la riorganizzazione del patrimonio sardo passa quindi anche per il potenziamento di alcune strutture preesistenti e per così dire virtuose, come l’ISRE con il Museo delle tradizioni popolari a Nuoro – che già svolgeva attività di coordinamento nell’ambito dell’etnografia – il Museo Nivola di Orani e il MAN di Nuoro.
¬ 6.6 L’Accordo di Programma Quadro per i Beni culturali
Il 30 settembre 2005 viene sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali tra la Regione, il Ministero dell’Economia e delle Fi-nanze ed il Ministero per i Beni e le Attività culturali; con questo documento i tre soggetti si impegnano ad attuare una serie di interventi coerenti alle linee di indirizzo individuate nel Piano di razionalizzazione del luglio precedente, con il quale viene condiviso anche l’obiettivo generale di messa a sistema per musei e aree archeologiche e monumentali.
Nella prima stesura dell’APQ si legge171:
L’obiettivo è quello di organizzare e mettere a sistema l’attuale realtà frammentaria e disorganica nel settore e far sì così che ogni singolo in-tervento in campo culturale possa venire inquadrato in una più ampia strategia di ridefinizione dell’identità del sistema territoriale e delle co-munità che lo abitano secondo quanto previsto nella delibera di giunta 36/5 del 26 luglio 2005.
Il programma si articola in tre linee strategiche: creazione di un sistema dell’offerta culturale della Sardegna attraverso la sua messa in rete, recupero del patrimonio suddiviso in interventi per tipologie di beni, ricerca e sviluppo del capitale umano. La «rete regionale dei musei» è inserita negli interventi
171 Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la regione Autonoma della Sardegna. Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e Attività Culturali, Roma 30 settembre 2005.
87
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
inerenti il recupero del patrimonio storico, archeologico e culturale che prevede in effetti singole azione destinate alla costruzione, al ripristino o al potenzia-mento di quelle strutture museali che nel documento di indirizzo della Regione venivano individuate come nodi o centri dei sottosistemi alla base della rete museale regionale172.
Con l’APQ si prevedeva la realizzazione delle seguenti strutture: il Museo dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea da istituire nel quartiere Sant’Elia di Cagliari, allo scopo di creare un polo di riferimento per il sistema dedicato all’arte nuragica nel bacino del Mediterraneo; il Museo della Sardegna Giudica-le, inizialmente previsto con un’unica sede a Oristano e poi progettato in due sezioni – rispettivamente a Oristano e a Sanluri –, con la funzione di far cono-scere la civiltà sarda di età giudicale; il Museo delle Bonifiche e dell’elettrificazione della Sardegna con sede ad Arborea e dedicato al rapporto tra uomo e ambiente nell’ambito delle vicende delle bonifiche e dell’industria idroelettrica; il Museo del Novecento e del contemporaneo a Sassari, progettato attorno alla collezione re-gionale del pittore Giuseppe Biasi e ad una selezione di opere di proprietà pub-blica (Comune di Sassari e Provincia di Sassari) e privata (Banco di Sardegna, Camera di Commercio); il Museo e laboratori di identità – Accademia della musica e del ballo sardo – Fabbrica della creatività da istituire nell’ex officina industriale Mulino Guiso Gallisai di Nuoro e articolare mediante una serie di percorsi per la valorizzazione delle diverse espressioni della cultura popolare e tradizionale sarda; il Museo Tavolara per l’artigianato ed il design presso il Padiglione dell’arti-gianato di Sassari destinato per l’occasione ad ospitare la raccolta di manufatti provenienti dall’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano e la commercializ-zazione dell’artigianato artistico regionale; la struttura deputata a fungere da centro della Rete museale dei fenici, da realizzare nella torre costiera denominata Torre grande nell’oristanese.
Con l’APQ si avviavano poi alcuni studi di fattibilità tra i quali quelli finaliz-zati alla realizzazione del Museo delle Identità di Nuoro e al Museo dell’Arte Nuragica e dell’Arte contemporanea del Mediterraneo di Cagliari, uno studio per lo sviluppo di distretti culturali e uno sulla messa in rete dei sistemi infor-mativi relativi ai beni culturali173.
172 Tra questi interventi citiamo, ad esempio, la progettazione e la realizzazione del primo modulo per il Museo regionale dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo a Cagliari, la realizzazione e l’allestimento del Museo della Sardegna Giudicale a Oristano e del Museo delle bonifiche a Arborea. APQ in materia di Beni e Attività culturali cit. 2005, tavola 1.
173 Ibidem tavola 2. Nel 2005 la Regione bandì un concorso internazionale per la proget-
88
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
L’APQ siglato nel 2005 è stato oggetto di modifiche e rimodulazioni nel cor-so degli anni successivi, con trasferimento di finanziamenti che hanno sostan-
tazione di una nuova struttura atta a ospitare il nuovo museo regionale per l’arte contemporanea e nuragica, da costruire nell’area portuale di Cagliari o in zona li-mitrofa. Il 23 novembre 2005 la Regione, il Comune di Cagliari e l’Autorità Portuale sottoscrissero un’intesa istituzionale con cui definivano l’interesse alla realizzazione del museo, riservandosi di verificare l’ubicazione più opportuna per la realizzazio-ne dell’opera entro il 31 dicembre 2005. Il concorso fu vinto nell’ottobre 2006 dal progetto di Zaha Hadid, che fu pubblicamente presentato nel novembre successivo in occasione della mostra dedicata al concorso internazionale tenutasi a Cagliari. Il nuovo museo, denominato Bètile, doveva essere costruito sul lungomare cagliaritano nei pressi del quartiere popolare Sant’Elia, per il quale si progettava una riqualifica-zione architettonica che avrebbe coinvolto anche il porticciolo. In data 8 agosto 2006 il Presidente della Regione Sardegna e il Sindaco del Comune di Cagliari avevano sottoscritto un protocollo d’intesa avente per oggetto tre distinte linee di intervento per la città, comprensive della costruzione del Museo Bètile e della riqualificazio-ne del Quartiere Sant’Elia, cui seguì la DGR n. 416 del 26 ottobre 2006 avente ad oggetto Riqualificazione del quartiere Sant’Elia e realizzazione, nello stesso quartiere, del Museo regionale dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo - Mandato al Sindaco per l’intesa ex art. 11 norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale e per la sottoscrizione accordo di programma tra il Comune di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna - Proposta al Consiglio Comunale. La costruzione del museo compare infine all’interno dell’elenco dei grandi progetti del POR 2007-2013, ove si prevede-va l’avvio dei lavori per il gennaio 2008 (Programma Operativo Regionale Sardegna Obiettivo Competitività regionale e occupazione, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, approvato con DGR n. 23/14 del 13 giugno 2007). Nel 2007 invece si apre un contenzioso tra il Comune di Cagliari e la Regione: il municipio, infatti, vorrebbe adesso modificare il progetto del Bètile, non realizzando la struttura progettata dal-la Hadid e trasferendo il museo altrove, nell’ex Manifattura tabacchi. In un acceso dibattito che vede frapporsi opposti orientamenti politici (giunta regionale, giunta comunale) su questo e altri nodi problematici del patrimonio culturale e dell’ur-banistica cagliaritani (le lottizzazioni nell’area archeologica di Tuvixeddu, la citata riqualificazione del quartiere Sant’Elia) il progetto Bètile si arena. Nel 2008, con la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 5 marzo fu modificata la precedente 416 del 2006, eliminando i riferimenti alla necessità di avviare le procedure relative al Piano Paesaggistico Regionale per attivare l’Accordo di Programma. Nel settembre 2009, dopo una prima ipotesi di un suo reinserimento nel Piano strategico del Comune di Cagliari, il Betile viene definitivamente espunto dalla progettazione comunale. Cfr. Si al piano strategico “Ecco come sarà la città del futuro”, “Unione Sarda” del 28 settembre 2009; Il Centro destra corregge il sindaco e cancella il Betile, “Unione Sarda” del 10 set-tembre 2009; Rispunta il Betile ma Floris non ci sta, “Unione Sarda” dell’11 luglio 2009; R. Vanali, La storia infinita del Betile, “Exibart”, pubblicato online il 28 maggio 2009, http://www.exibart.com/notizia.asp?IDCategoria=44&IDNotizia=27752. Per tutti i documenti relativi alla progettazione del nuovo museo e al bando di gara inerente si rimanda alla pagina web istituzionale dedicata della Regione Autonoma della Sarde-gna http://www.regione.sardegna.it/bandi_internazionali/betile .
89
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
zialmente permesso non solo la prosecuzione dei progetti con alcune varianti alla versione iniziale, ma anche l’inserimento di nuovi174. Per quanto concerne la rete regionale e i sub sistemi territoriali, ad esempio, ricordiamo che con il primo atto integrativo all’APQ, firmato il 2 ottobre 2006, tra i nuovi interventi vi fu quello della Rete museale dei Fenici, già prevista in realtà nella delibera 36/5 del 2005 (Piano di razionalizzazione) ma non inclusa nella prima versione dell’APQ175.
¬ 6.7 La legge regionale n. 14 del 2006
Tra le priorità del citato Piano di razionalizzazione del 2005 vi era la produ-zione di una nuova legge regionale segnatamente dedicata ai musei e ai beni culturali, dato che per il settore si lamentava da tempo l’assenza prolungata di una normativa organica. I principi ispiratori di questa nuova legge regionale, approvata nel settembre 2006 col titolo Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura, si rintracciano nella Relazione di accompagnamento al dise-gno di legge. In primo luogo si ribadisce l’importanza del patrimonio culturale come aspetto fondamentale dell’identità della popolazione sarda e pertanto si ravvisa nell’assicurazione della sua salvaguardia, valorizzazione e fruizione un «interesse centrale per un’azione di governo che poggi sui fondamenti della
174 DGR n. 13/1 del 30 marzo 2006, Deliberazione CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 – punto 7.1.3: adempimenti al 31 marzo 2006, con annesse relazioni allegate; n. 9/19 dell’8 marzo 2006. APQ Beni Culturali. Modifiche alla Delibera di GR n. 45/20 del 27 settembre 2005; DGR n. 36/11 del 18 settembre 2007, Modifiche all’APQ Beni e attività culturali del 30 settembre 2005 e all’Atto integrativo all’APQ Beni e attività cultural del 2 ottobre 2006.
175 Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Autonoma della Sardegna, Ministero per i beni e le attività culturali, Primo Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali, Roma, 2 ottobre 2006. L’intervento relativo al Museo della Sardegna Giudicale e Museo delle bonifiche e dell’elettrificazione, fu annullato con in II Atto integrativo all’APQ firmato il 26 ottobre 2007, per essere poi reinserito con il III Atto integrativo del 29 novembre 2007. I nuovi interventi predisposti con gli atti integrativi hanno prevalentemente riguardato il restauro di beni. DGR n. 41/2 del 30 settembre 2006, Atto integrativo dell’Accordo di Programma quadro Beni culturali. Integrazioni e modifiche alla delibera di Giunta regionale 13/1 del 30 marzo 2006. Gli interventi di restauro sul patrimonio culturale sardo proseguivano intanto con interventi ex lege 1/1958 sul bilancio regionale ma tali stanziamenti risultavano comunque insufficienti rispetto al numero di istanze provenienti dagli enti locali. DGR n. 48/28 del 21 novembre 2006, Interventi a favore del patrimonio culturale. Programma relativo alla concessione di finanziamenti.
90
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
specialità e dell’autonomia»176. Da questa visione discende l’urgenza di nuove politiche regionali che non ripongano l’attenzione sui beni culturali in un’ottica attenta solo allo sviluppo del turismo, ma che piuttosto puntino ad accrescere la consapevolezza del loro valore e il senso di appartenenza presso la comunità locale. Tale precisazione appare importante perché fino a questo momento gli interventi di settore attuati dalla Regione, oltre a essere frammentari e spesso non coordinati, sembrano aver avuto l’obiettivo di aumentare soprattutto il tu-rismo, o meglio, di convogliare quello balneare verso altre aree regionali, un obiettivo questo che ricorre come prioritario anche per le esperienze sistemiche sorte in ambito sardo prima dell’emanazione della legge regionale 14/2006.
Con la nuova legge si vuole riaffermare il processo dell’esercizio dell’auto-nomia regionale nell’ambito dei beni culturali – le cui condizioni furono assi-curate con gli articoli 3 e 5 dello Statuto speciale e dal relativo decreto di attua-zione n. 480 del 1975 all’articolo 6 – anche alla luce del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 (articolo 8), che prende atto delle potestà delle Regioni a statuto speciale, e della riforma del titolo V della Costituzione: la Regione Sardegna persegue dunque più che un ampliamento delle proprie competen-ze – che sui beni culturali rimangono sostanzialmente immutate – un pieno governo delle proprie funzioni. Ricordiamo, infatti, che da Statuto (titolo II, articolo 3) la Regione non solo ha competenza primaria sui musei e le bibliote-che di ente locale, ma può esercitare potere sostitutivo in ordine alla tutela per i soggetti pubblici e privati detentori di beni di interesse locale in caso di loro inadempienza o inerzia: questa potestà in realtà non è mai stata esercitata com-pletamente proprio a causa della fragilità e non organicità delle disposizioni regionali in materia, concentrate soprattutto sull’erogazione di contributi. La norma del 2006 attua infine anche quanto sancito dall’articolo 4 della preceden-te legge regionale 26/1997, Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna, che prevede l’emanazione di leggi di settore per la realizzazione di una rete di servizi per la conservazione, la catalogazione e la fruizione del patrimonio culturale isolano.
L’architettura della legge si basa quindi su una serie di punti chiave attor-no ai quali dovranno articolarsi le successive politiche regionali; in particolare sono rilevanti: la definizione delle funzioni e dei compiti della Regione e degli enti locali, l’introduzione di una programmazione articolata in piani regionali
176 Relazione di accompagnamento al disegno di legge “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, allegate a DGR n. 10/4 del 14 marzo 2006, Disegno di legge concernente Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.
91
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
triennali e piani provinciali, la creazione di un sistema museale e di un sistema bibliotecario regionali, l’avvio di un processo di riconoscimento degli istituti museali basato sull’adeguamento a standard minimi di qualità, la promozione degli scavi archeologici, la valorizzazione dell’arte contemporanea e la creazio-ne di un sistema informativo per il patrimonio sardo.
Analizziamo adesso in dettaglio il testo di legge focalizzando l’attenzione sugli articoli relativi all’organizzazione sistemica del patrimonio culturale.
Il secondo comma del primo articolo Finalità e oggetto della legge, stabilisce che la Regione – per perseguire gli obiettivi di tutela, valorizzazione e frui-zione del patrimonio – favorisce l’integrazione delle funzioni e dei compiti, il coordinamento degli interventi e «promuove l’organizzazione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi e attività».
Analogamente a quanto espresso già con il Piano di razionalizzazione del 2005, il sistema museale regionale costituisce uno degli obiettivi primari della Regio-ne, assieme all’adeguamento dei musei e delle strutture assimilabili a specifici requisiti di qualità.
La legge attribuisce un ruolo attivo anche a Comuni e Province: la Regione riconosce agli enti locali funzioni di integrazione, coordinamento e gestione dei rapporti tra beni culturali e contesto paesaggistico e territoriale (articolo 3, comma 3) e promuove la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio e dell’offerta culturale sul territorio (articolo 4, comma 1, lettera q)177. Sia la Regione che gli enti locali inoltre pos-
177 Il 5 settembre 2006, con DGR n. 36/7, fu approvato il Piano Paesaggistico regionale, previsto dalla legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004, Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale. Il Piano, il primo in Italia a essere elaborato e approvato secondo le direttive fornite dal Codice dei Beni culturali, ha lo scopo di «preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità». Il documento si è sviluppato da un confronto tra gli attori coinvolti nella pianificazione e nel governo del territorio, avviatosi alla fine del 2005, quando furono creati dei laboratori territoriali per la progettazione integrata, finalizzati a produrre delle linee guida per lo sviluppo locale. La cosiddetta “legge salva coste” del 2004 e il Piano paesaggistico, che limitano le attività edilizie nelle aree costiere con il vincolo di inedificabilità per le aree intatte, sono state al centro di aspri dibattiti politici fin dalla loro progettazione: malgrado nel corso degli anni siano stati presentati numerosi ricorsi al TAR della Sardegna, la legittimità del Piano è stata confermata, oltre che dal Tribunale amministrativo sardo
92
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
sono stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici o privati titolari di raccolte di interesse culturale riconosciuto, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi possa concorrere allo sviluppo del sistema regionale (articolo 4, comma 3).
Compiti e funzioni per enti locali e Province in materia di beni culturali era-no già stati definiti all’articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006, che precede di pochi mesi la n. 14, con la quale si disciplina il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione al decreto legislativo n. 234 del 17 aprile 2001, Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997, e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l’articolo 10 della Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione178. Con questa legge le Province, oltre a programmare ed erogare risorse per i musei locali, assumevano il compito di promuovere la gestione associata dei musei e dei luoghi della cultura, di pianificare, programmare e monitorare le relative attività d’intesa con i Comuni; a questi ultimi invece spettano la valorizzazione
(sentenza 979/2009), anche dal Consiglio di Stato (sentenza 5459/2009). A partire dal 2009, con il mutamento politico del governo regionale, ci sono stati diversi tentativi di revisione del Piano, prima con un DDL relativo al cosiddetto “Piano casa” (ottobre 2009), più recentemente con la produzione di linee guida per la predisposizione del Piano per gli ambiti interni e degli atti di «aggiornamento e revisione» del Piano per le aree costiere (DGR n. 12/32 del 20 marzo 2012, LR n. 8/2004, art. 2, comma 7. Linee guida per la redazione del PPR degli ambiti interni e per la predisposizione degli atti di aggiornamento e revisione del PPR degli ambiti costieri). Su questo argomento si rimanda ai contributi pubblicati in AA.VV., La pianificazione del paesaggio in Sardegna, numero monografico di “Gazzetta Ambiente” XVII, 6, 2011.
178 La legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali (art. 77, cc. 1-2) attribuisce alle Province i seguenti compiti e funzioni: «a) programmazione ed erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio monumentale; b) programmazione ed erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale; c) promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura nonché dei relativi servizi; d) d’intesa con i comuni singoli o associati, programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel territorio provinciale; e) fruizione e valorizzazione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura che si trovano nella loro disponibilità o ad esse trasferiti.» Spettano invece ai Comuni: «la valorizzazione e tutte le funzioni per la fruizione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ricadenti nel proprio territorio dei quali abbiano la disponibilità.» Province e Comuni, anche in forma associata, partecipano infine alla programmazione regionale (art. 77, c. 3).
93
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
e in generale tutte le funzioni per la fruizione del patrimonio di spettanza. La legge regionale 14/2006 specifica, e talvolta amplia, le funzioni in materia di beni culturali per le Province e i Comuni. Alle Province spetta ora l’istituzione di sistemi museali provinciali, la promozione della didattica per i beni culturali e le attività di promozione culturale in genere (articolo 5, comma 1). I Comuni provvedono all’integrazione di musei e altre strutture di loro pertinenza nei sistemi museali e collaborano con scuole, università, associazioni del territorio oltre a partecipare alla elaborazione dei piani provinciali (articolo 6). Un altro elemento di novità introdotto dalla legge regionale 14/2006 è la pianificazione regionale in materia di «beni culturali, istituti e luoghi della cultura» attuata mediante un Piano triennale redatto sulla base delle proposte provenienti dagli enti locali (articolo 7): tali proposte, elaborate dalle Province in accordo con i Comuni, vengono trasmesse alla Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e sono poi predisposte all’interno dei singoli piani provinciali trien-nali e dei relativi programmi annuali (articolo 8). Il Piano regionale, che deter-mina obiettivi, strategie e linee d’intervento, deve prevedere in particolare: la ripartizione delle risorse e i criteri per la loro assegnazione; gli standard per il riconoscimento regionale di musei e strutture assimilabili esistenti; i parametri da rispettare per l’istituzione di nuovi musei, parchi archeologici, ecomusei179; i criteri per l’inventariazione; i requisiti professionali per il personale impiegato; le linee di intervento della Regione per la conservazione, la ricerca archeologi-ca, l’arte contemporanea, la didattica relativa ai beni culturali, la promozione e la comunicazione dei sistemi museali; i criteri per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’utilizzo delle risorse da parte dei beneficiari180.
Il primo capo del titolo III della legge regionale 14/2006 è dedicato alla de-finizione delle diverse tipologie di bene oggetto della norma come i musei, i parchi archeologici, gli ecomusei e i sistemi museali. Per comprendere in cosa consista concretamente l’organizzazione del patrimonio sardo in chiave siste-mica promosso dalla legge, risulta di fondamentale importanza l’articolo 12. Il sistema museale regionale viene qui definito come una «organizzazione di rete rivolta a favorire sul territorio regionale la fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione ai fini della conoscenza del patrimonio culturale da parte dei residenti e della promozione del turismo culturale»181.
179 Agli articoli 9-11 della legge si provvede alla definizione di ciascuna tipologia di istituto.
180 LR 14/2006, art. 8181 LR 14/2006, art. 12 c. 1.
94
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Alla base del sistema regionale (art.12, c. 2) è la cooperazione «per lo svilup-po programmato dei servizi e delle attività» su base territoriale; vi aderiscono, purché provvisti degli standard minimi definiti dal piano regionale, i musei regionali e quelli di ente locale, i parchi archeologici, gli ecomusei e i sistemi territoriali, ma possono unirsi anche altri musei privati o pubblici esistenti, pre-vio accordi e nel rispetto degli standard minimi. I sistemi museali (art. 12, c. 3-5) sono definiti «aggregazioni di musei» e «costituiscono lo strumento per mezzo del quale gli enti locali attuano la cooperazione e l’integrazione dell’offerta cul-turale, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei loro territori». I compiti di questi sistemi sono il coordinamento della programmazione degli istituti associati, l’istituzione e la gestione di servizi comuni, la promozione di attività comuni di tutela e valorizzazione, la raccolta delle rilevazioni sui servi-zi, le attività e l’utenza dei vari musei da inviare alle rispettive province, la col-laborazione con il sistema informativo regionale, la collaborazione con servizi sociali, scolastici e culturali del territorio. L’istituzione di un sistema museale deve avvenire mediante un accordo formale di cooperazione tra gli enti inte-ressati mentre il suo funzionamento sarà assicurato da un atto approvato dagli stessi soggetti che si ispiri ai principi della legge 14/2006182.
Si prevede inoltre (art. 13) l’istituzione della cosiddetta Rete museale dell’e-migrazione – da attuare in collaborazione con il Ministero degli esteri, le univer-sità, le ambasciate, le associazioni italiane e straniere – che sarà formata da ogni museo che conservi attestazioni sulle comunità di sardi emigrati allo scopo di documentare la cultura ed i valori identitari della Sardegna.
Con la legge 14/2006 si istituiva poi un Osservatorio regionale dei musei – ov-vero un organo tecnico con funzione consultiva e propositiva per la stesura del Piano regionale, l’istituzione di nuovi musei, la qualità scientifica del sistema museale regionale183 e un albo regionale dei musei e dei luoghi della cultura
182 Secondo la norma, l’accordo istitutivo di un sistema museale deve indicare l’ambito territoriale e la struttura organizzativa, le funzioni, la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e rappresentanza, i servizi tecnico-amministrativi comuni con il personale deputato, le modalità di finanziamento e il riparto degli oneri. I musei sono altresì liberi di istituire altre forme di collaborazione attraverso le reti regionali tematiche: i sistemi museali e le reti tematiche vengono riconosciute dalla Regione su proposta degli enti interessati.
183 L’Osservatorio si compone di tre direttori di musei regionali e di enti locali, un rappresentante per i musei ecclesiastici, un rappresentante per i musei privati aderenti al sistema regionale, quattro rappresentati degli enti locali, tre esperti, un rappresentante dell’ICOM, due rappresentanti di associazioni di categoria per
95
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
riconosciuti dalla Regione184. Per quanto riguarda i finanziamenti – oltre che abrogare le numerose norme regionali di finanziamento che nel corso degli anni hanno costituito lo strumento principale di erogazione di contributi per i musei, come le leggi 11/1988 e 4/2000 –, la 14/2006 prevede interventi annuali, tra i quali quelli per il Catalogo regionale, i musei regionali, la ricerca archeolo-gica, l’acquisizione di beni, le convenzioni con gli enti locali, l’aggiornamento professionale in ambito museale, i distretti culturali. Per quanto riguarda inve-ce i servizi dei musei locali e il funzionamento dei sistemi museali, la Regione trasferisce le proprie risorse alle Province, sulla base degli indirizzi del Piano regionale185.
La legge regionale 14/2006 avvia il processo di risistemazione del comples-so panorama dei beni culturali dell’Isola soprattutto grazie alla definizione di un’effettiva razionalizzazione degli interventi. Si introduce una pianificazione in programmi triennali prodotti dalla Regione sulla base delle istanze locali e gli stanziamenti vengono assegnati previa valutazione dell’innalzamento qualitativo prodotto dai singoli istituti186. Questo sembra il nodo cruciale della legge 14/2006 mentre un po’ sfuocata appare ancora la fisionomia che dovrà avere l’organizzazione sistemica del patrimonio: la norma, infatti, fornisce linee guida precise per lo sviluppo dei sistemi museali sul territorio, specificandone compiti e funzioni, ma non precisa il modo in cui tali sistemi si dovrebbero in-tegrare nella struttura sovrastante, quella dei sistemi provinciali e quella ancora superiore della rete regionale. Non si comprende chiaramente se l’architettura generale sia piramidale, con il sistema regionale all’apice, o se i diversi tipi di aggregazione di musei (locale, provinciale, regionale) mantengano una certa indipendenza gli uni dagli altri.
In realtà la legge sui musei e i luoghi della cultura del 2006 rappresenta la sintesi e la ratifica di ciò che la Regione andava progettando dal 2005, a partire
operatori museali, il dirigente del servizio beni culturali della Regione. Articolo 14, LR 14/2006.
184 LR 14/2006, art. 19.185 LR 14/2006, art. 21.186 Il primo Piano regionale triennale doveva essere approvato dalla Giunta entro il 27
giugno 2007 ma numerosi contratti di gestione per musei locali, precedentemente finanziati dalla Regione, risultavano in scadenza a dicembre 2006, pertanto la Regione provvide all’erogazione di risorse economiche ai Comuni interessati con DGR n. 49/27 del 28 novembre 2006, prorogando così il finanziamento diretto agli enti locali, e non attraverso le Province come stabilito dalla legge regionale 14/2006, fino al giugno dell’anno seguente.
96
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
cioè dalla produzione del Piano di razionalizzazione e dalla definizione degli in-terventi dell’Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali: una rete di musei regionali − in parte già esistenti, in parte da realizzare come nel caso del Betile di Cagliari − che fossero in grado non solo di rappresentare un diverso aspetto della storia e della cultura regionale ma anche di catalizzare attorno a sé gli altri istituti presenti sul territorio, una volta che questi si fossero accreditati presso la Regione, ovvero dopo il raggiungimento di alcuni stan-dard minimi qualitativi e di servizio.
Di fatto, a seguito dell’emanazione della norma si assiste in Sardegna alla nascita di diverse esperienze sistemiche, a livello comunale e intercomunale, mentre stentano a prendere corpo i sistemi provinciali.
La volontà regionale di messa a sistema espressa dalla legge regionale del 2006 è riaffermata negli anni immediatamente successivi dal Programma Regio-nale di Sviluppo 2007-2009 – in cui si prospetta la creazione di un altro polo mu-seale tematico, dedicato alla scienza e alla tecnica –, dal Documento annuale di programmazione economico finanziaria per il 2009 e dal Documento Unitario di Pro-grammazione 2007-2013187. Anche il POR Sardegna Obiettivo Competitività regiona-le e occupazione (FESR) 2007-2013, approvato nel giugno 2007, conteneva tra le attività previste «interventi volti a dare piena attuazione al Sistema regionale dei musei» nell’ambito dell’obiettivo operativo 4.2.3, Promuovere e valorizzare i beni e le attività culturali e sostenere l’imprenditorialità nel campo della valorizzazione culturale188.
Nel 2007 si avviò il processo di concertazione con gli enti locali per la predi-sposizione del piano triennale regionale per i musei; le istanze provenienti dal territorio furono raccolte e inoltrate alla Regione attraverso le Province, così come stabilito dalla 14/2006189. L’obiettivo era quello di costruire una pianifi-cazione partecipata che rispecchia uno dei principi – già enunciato nella legge regionale 14/2006 – che risulterà essere alla base dell’elaborazione del Piano re-gionale per i beni culturali, ovvero la cooperazione, intesa come strumento essen-
187 Programma Regionale di Sviluppo 2007-2009, approvato con DGR n. 5/26 del 7 febbraio 2007; Documento annuale di programmazione economico finanziaria (DAPEF) 2009, approvato con DGR n. 63/1 del 17 novembre 2008; Documento Unitario di Programmazione 2007-2013, approvato con DGR n. 52/19 del 3 ottobre 2008.
188 Programma Operativo Regionale Sardegna, Obiettivo Competitività regionale e occupazione, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, approvato con DGR n. 23/14 del 13 giugno 2007.
189 DGR n. 19/11 del 22 maggio 2008, Legge regionale 20 settembre 2006 n. 14. Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultural. Art. 7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura.
97
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
ziale per lo sviluppo locale sostenibile, che si origina anche dall’integrazione dell’offerta culturale di un territorio, come si legge stesso Piano190:
La risorsa culturale del territorio si configura come un agente attrat-tore del sistema, una formula di capitale in grado di agire su tutte le dimensioni del territorio, un capitale che amalgamandosi con una o più dimensioni (economica, sociale, ambientale) è in grado di generare nuo-ve occasioni di sviluppo […]. È necessario procedere nella progressiva integrazione delle caratteristiche storiche, culturali, economiche, sociali locali, affinché sia possibile produrre un modello prospettante processi d’ibridazione […]. Attraverso questo modello, il territorio sarà in grado di generare un tipo di sviluppo auto-portante, fondato sulle caratteristi-che locali, in una modalità che, inoltre, potrà consentire la sostenibilità del sistema, che sarà sostenibile proprio in quanto fondato sulle carat-teristiche locali.191
In fase di concertazione ogni Provincia presentò le proprie proposte, che ri-guardarono la creazione, ex novo nella quasi totalità dei casi, di un sistema o di una rete provinciale e di una serie di gestioni congiunte tra beni diversi (aree archeologiche, musei e monumenti) da attuare o potenziare nel territorio di riferimento. Tranne rarissime eccezioni – come nel caso del Sistema museale Arborense, il sistema museale della Provincia di Oristano di fatto già avviato al momento della concertazione – attualmente (ottobre 2009) nessuno dei sistemi provinciali ha ancora superato la fase progettuale.
¬ 6.8 Il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008 - 2010
Il Piano regionale triennale, che doveva essere approvato entro il giugno 2007 ma che fu prodotto solo nel novembre 2008, specifica dettagliatamente gli indirizzi regionali, già espressi sia con il Piano di razionalizzazione del 2005 sia con la legge 14 del 2006, e definisce concretamente le azioni per il raggiungi-mento degli obiettivi stabiliti a partire dal 2005192.
190 Tra le buone pratiche di pianificazione partecipata la Regione Sardegna riconosce Val di Cornia Spa e Po ferrarese – il paesaggio delle dune. La metodologia di fondo nella prospettiva di un piano integrato, Allegato A alla DGR n. 29/11 del 22 maggio 2008.
191 Piano Regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008 -2010, il tema della sostenibilità dei sistemi culturali territoriali viene a lungo analizzato nel documento all’interno della II parte dal titolo Dimensione economica e sociale della cultura.
192 Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010, approvato
98
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
La Regione pone alla base dello sviluppo locale il concetto di cooperazione, che interessa direttamente anche i musei e l’insieme dei cosiddetti “luoghi della cultura”; il Piano regionale colloca tra i presupposti alla base di una concreta co-operazione territoriale la reciproca interdipendenza tra musei e territorio, l’in-dividuazione degli attori e del loro ruolo nelle attività degli istituti culturali e, soprattutto, l’individuazione di un’organizzazione a livello territoriale, «defini-bile Sistema», che si pone come intermedia tra il singolo istituto e il «territorio regionale complessivo», descrivendola come una «rete di soggetti legati tra di loro da relazioni di interdipendenza e da meccanismi di coordinamento»193. A tale proposito la Regione favorisce in particolare l’integrazione delle funzioni e dei compiti dei musei e dei luoghi della cultura relativi alla tutela, alla valo-rizzazione e alla fruizione del patrimonio, nonché il coordinamento degli in-terventi inerenti tali funzioni e compiti, mediante la promozione di un sistema museale e di un sistema bibliotecario a dimensione regionale, che sono «intesi come forme di aggregazione tra musei regionali, di ente locale, parchi archeo-logici, ecomusei, biblioteche, archivi e altri istituti e luoghi della cultura ad essi equiparati, a livello almeno provinciale»194.
Il documento specifica che, poiché gli interventi regionali restano esplicita-mente tesi «al consolidamento e allo sviluppo dell’esistente», ogni forma di co-operazione messa in atto deve mirare alla «razionalità economica» e creare una relazione proficua tra gli ambiti territoriali coinvolti. In altre parole la messa a sistema a livello regionale e provinciale del patrimonio culturale deve provve-dere a un’effettiva razionalizzazione di quest’ultimo e delle risorse necessarie alla sua salvaguardia e fruizione, nel rispetto delle caratteristiche e delle voca-zioni endogene del territorio. In altri termini il sistema regionale vuole essere uno strumento di coordinamento capace di rimediare al problema della ripeti-tività dell’offerta museale sarda195.
con DGR n. 64/6 del 18 novembre 2008. La proposta di piano allegata alla delibera di Giunta regionale 29/11 del 22 maggio 2008 (cit.), fu sottoposta a diversi soggetti (Comuni, Province, Università di Cagliari e Sassari, Conferenza episcopale sarda, parti sociali e associazioni si settore) che dettero il proprio contributo mediante nuove proposte e integrazioni; dopo questo primo vaglio, la Proposta passò all’Osservatorio regionale per i Musei che a sua volta espresse ulteriori suggerimenti.
193 Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010, cit.194 Ibidem.195 La Regione – pur riconoscendo in tali musei una «positiva intenzionalità
nell’orizzonte del rafforzamento dell’identità culturale» – osserva come la replica dei tematismi culturali abbia prodotto l’insostenibilità economica per molti musei ,
99
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
Con il Piano triennale la Regione fornisce indicazioni su come si debba svi-luppare la cooperazione territoriale nel settore musei196.
In primo luogo ai musei e ai luoghi della cultura viene affidato un compito molto ambizioso: tali strutture non solo debbono integrarsi tra loro a livello locale dal punto di vista gestionale, ma hanno anche il compito di interagire con l’insieme degli attori presenti sul territorio, siano essi pubblici (scuole, am-ministrazioni locali, servizi sociali, trasporti) o privati (in particolare soggetti attivi nell’economia locale e nel turismo). Nello specifico il Piano individua tre diverse possibili tipologie di integrazione tra istituti e luoghi della cultura: in-terna, esterna e laterale. L’integrazione interna prevede la condivisione di prati-che di gestione che non si manifestano direttamente ai fruitori dei beni, quella esterna risulta percepibile all’utenza in quanto riguarda direttamente i servizi al pubblico e la loro qualità, mentre l’integrazione di tipo laterale è caratterizzata da una cooperazione tra istituti museali e filiere presenti sul territorio, private o pubbliche, volta allo sviluppo dell’economia locale. Quali che siano i soggetti coinvolti e il tipo di integrazione praticata, viene richiesto ai singoli musei e alle strutture assimilabili l’impegno ad assumere una serie di responsabilità, tra cui contribuire alla crescita socio-culturale della collettività locale, raffor-zare l’identità del territorio e la sua attrattività, ampliare le attività svolte dalle amministrazioni locali nel campo delle politiche culturali, sociali e di sviluppo turistico.
Sintetizzando, con il Piano triennale 2008-2010 si richiede ai musei di aggre-garsi per raggiungere i seguenti obiettivi: realizzare economie di scala e ge-stioni congiunte; uniformare l’offerta culturale locale attraverso l’adeguamento agli standard minimi qualitativi richiesti dalla Regione sulla base del Decre-to Ministeriale del 10 maggio 2001; costruire un’immagine definita e coerente del territorio per affermare l’identità locale e contribuire alla costruzione di un «prodotto turistico-culturale» utile allo sviluppo economico.
Per quanto concerne invece il sistema museale regionale, l’organizzazione
carenti sia dal punto di vista scientifico che nei servizi all’utenza. Cfr. Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010 cit., p. 102. La ripetitività dell’offerta museale sarda era già stata evidenziata dall’analisi della Corte dei Conti del 2005 (Ricognizione e indagine cit.) e individuata come uno dei principali problemi del comparto museale isolano nel documento di indirizzo regionale dello stesso anno (Sistema regionale dei musei cit.).
196 Si intende qui con “musei” anche l’insieme delle strutture assimilabili come parchi archeologici, ecomusei, monumenti fruibili. Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010 cit.
100
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
in forma sistemica di musei e luoghi della cultura a livello territoriale – e in particolare provinciale – risulta finalizzata ad una concertazione, che potrem-mo definire “dal basso”, relativa alle politiche di intervento regionali: il sistema territoriale dovrebbe cioè farsi portatore delle istanze locali concorrendo così ai processi decisionali elaborati dal governo regionale; in questa ottica i sistemi e i singoli istituti sono tenuti a fornire alla Regione, tramite le Province, tutte le informazioni relative alle attività e ai servizi attuati, in modo che vi sia un monitoraggio continuo di ciò che avviene a livello locale.
Su queste premesse il Piano regionale definisce quindi funzioni, compiti e procedure relative al «sistema museale regionale», dando decisamente meno spazio all’individuazione delle caratteristiche dei cosiddetti «sistemi museali territoriali». Di questi ultimi, infatti, il Piano si limita a dare una breve defini-zione: «articolazioni provinciali del sistema regionale, con ruoli di strumento di adeguamento dell’offerta a livello provinciale (integrazione degli standard di offerta)». Si configurano dunque sistemi museali su tre diversi livelli: il sistema museale regionale, i sistemi museali territoriali – di ambito provinciale – e i sistemi museali intesi come semplici associazioni tra enti o istituti le conforma-zioni, funzioni e compiti dei quali vengono stabilite all’articolo 12 (comma 3-6) della legge regionale 14/2006.
¬ 6.9 Il Sistema museale regionale nel Piano triennale 2008-2010
Il Sistema museale regionale si articola in sottosistemi provinciali, coinci-denti con i citati sistemi museali territoriali, e viene realizzato allo scopo di co-ordinare le attività per il patrimonio museale sardo, aumentarne e omogeneiz-zarne la qualità dei servizi e delle strutture, assicurare un’immagine unitaria, assistere e monitorare gli aderenti. Lo strumento del sistema regionale, che si profila come una cabina di regia per le attività dei musei, viene definito “essen-ziale” per la gestione del comparto, dato che «l’assenza di un’organizzazione sistemica dell’offerta limita il raggiungimento di risultati nella valorizzazione, fruizione e promozione del patrimonio»197
Come stabilito dall’articolo 12 della legge regionale 14/2006, partecipano al sistema museale regionale tutti i musei di ente locale, i dodici musei regionali previsti dal Piano di razionalizzazione del 2005 e dall’APQ in materia di beni culturali firmato nello stesso anno, i parchi archeologici, gli ecomusei, i siste-
197 Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010 cit., p. 102.
101
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
mi museali territoriali, purché tali soggetti risultino provvisti degli standard di qualità e di servizio richiesti dalla Regione198; possono aderire al sistema regio-nale anche i musei di altra natura giuridica, pubblici e privati, previa stipula di opportune intese e sempre che siano dotati degli standard regionali.
198 Cfr. Sistema regionale dei musei, Piano di razionalizzazione e sviluppo, cit. 2005. Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e Attività Culturali, Roma 30 settembre 2005 cit., con successive integrazioni e modifiche. I musei regionali compresi nel sistema museale regionale sono: Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari di Nuoro, Casa Natale di Grazia Deledda di Nuoro, Museo e laboratori dell’identità - Accademia della Musica e del Ballo Sardo – Fabbrica della creatività di Nuoro, Museo per l’Arte del Novecento e del contemporaneo di Sassari, Museo Tavolara per l’Artigianato ed il Design di Sassari, Rete Museale dei Fenici di Torregrande, Museo Regionale delle Bonifiche e dell’Elettrificazione della Sardegna di Arborea, Museo della Sardegna Giudicale di Oristano e Sanluri (due sedi), Museo Regionale dell’arte Nuragica e dell’Arte Contemporanea del Mediterraneo di Cagliari.
102
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
TABELLA A: Requisiti necessari per l’accreditamento dei musei, redatta sulla base del Piano Regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010 (Deli-bera GR 64/6 2008)
Ambito Requisiti per singolo istituto / luogo della cultura
Requisiti richiesti anche in condivisione con altri istituti / luoghi della cultura
1. Status Giuridico
Possesso o disponibilità di collezioni permanenti; proprietà o disponibilità definta della sede; atto istitutivo; statuto e/o regolamento*.
2. Assetto finanziario
Programma pluriennale di gestione.
3. Strutture Spazi espositivi attrezzati e adeguati per collezioni e depositi* *.
4. Personale Figure professionali qualificate come da delibera di Giunta regionale n. 36/5 del 2005 (Piano regionale)* * *; svolgimento di attività di ricerca finalizzate alla migliore conoscenza delle collezioni e collaborazione alla definizione delle finalità e dei programmi del museo.
Direttore: direzione del personale e delle attività, della pianificazione economica, della sicurezza; elaborazione dei programmi annuali e cura della loro attuazione; definizione, in concorso con l’Amministrazione responsabile, delle finalità del museo e elaborazione del suo statuto e della sua missione.Addetto alla segreteria organizzativa e contabilità: predisposizione dei documenti contabili ed espletamento delle mansioni di segreteria.Responsabile dei servizi educativi (figura non obbligatoria per le raccolte museali): elaborazione e gestione dei servizi di comunicazione didattica; predisposizione dei programmi relativi e cura della loro esecuzione; concorso alla definizione dei programmi e delle finalità del museo.Addetto alla sicurezza: attività dirette ad assicurare il funzionamento, la manutenzione e il controllo degli impianti (in conformità al D. Lgs. 626/1994), la sicurezza delle persone e del patrimonio.Addetto alla comunicazione e alla promozione: monitoraggio dei flussi delle visite e analisi sui livelli di gradimento e preferenze del pubblico, definizione di piani di comunicazione e marketing e loro attuazione.
5. Sicurezza Messa a norma per statica, impiantistica, profilo igienico sanitario; superamento barriere architettoniche; funzionalità e accessibilità degli spazi; sistemi anti incendio e anti intrusione; manutenzione ordinaria dell’edificio e degli allestimenti; manutenzione dell’impiantistica.
103
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
6. Gestione e cura delle collezioni
Registro di ingresso dei beni della collezione; catalogazione secondo normativa ICCD; attività di studio e di divulgazione delle ricerche condotte sulla collezione (tale requisito non è obbligatorio per le raccolte museali).
7. Rapporti con il pubblico e relativi servizi
Orario di apertura non inferiore alle 25 ore settimanali per almeno 5 giorni comprensivi di sabato e domenica per le raccolte museali.Orario di apertura di almeno 48 ore settimanali in 6 giorni, comprensivi del sabato e della domenica. Nei musei legati al turismo stagionale possono essere previste deroghe (apertura nel fine settimana o orari condivisi a livello di sistema in alcune stagioni dell’anno).Utilizzo di almeno 2 lingue comunitarie per i supporti museografici; segnaletica esterna ed interna; rilevazione delle presenze; apparati informativi e didattici; servizi aggiuntivi.
Organizzazione di attività didattiche e culturali coerenti con gli obiettivi del museo, da realizzare in spazi attrezzati, eventualmente condivisi con altre strutture (il requisito non è obbligatorio per le raccolte museali).
8. Rapporti con il territorio
Forme di collaborazione e promozione reciproca con altri istituti museali, biblioteche, associazioni culturali, realtà produttive.
* Lo statuto è obbligatorio quando il gestore sia ente di diritto pubblico o privato con personalità giuridica (fonda-zioni, consorzi, aziende speciali, enti morali, altre forme associative), mentre il regolamento è necessario per i musei gestiti da articolazioni di un ente pubblico. Il Piano triennale indica tutti i contenuti che devono essere presenti negli statuti e nei regolamenti, tra questi: finalità, principi di gestione, organi, assetto finanziario. Cfr. Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010 cit., pp. 109 -110.
**La congruità è verificata in base a specifici criteri relativi a luce, temperatura, umidità, sicurezza. Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010 cit., p. 105.
***Addetto ai servizi di sorveglianza, addetto ai servizi di accoglienza, curatore/conservatore. Per le mansioni e i compiti del personale si veda nella tabella A il campo relativo al personale nella sezione “requisiti richiesti anche in condivisione con altri istituti e luoghi della cultura”. Le figure professionali devono possedere adeguati titoli pro-fessionali, competenze ed esperienze. La presenza di un’unica figura di curatore-direttore è prevista qualora le esperienze formative e professionali dimostrino l’effettiva competenza posseduta nel campo curatoriale e della pianificazione e gestione delle risorse.
104
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Per partecipare al sistema regionale e accedere ai contributi economici della Regione, ogni museo deve dunque “accreditarsi” e per fare ciò è tenuto ad ade-guarsi ai requisiti minimi stabiliti dal Piano di razionalizzazione del 2005199. Il Pia-no regionale triennale stabilisce dettagliatamente, per ogni ambito individuato dal Decreto Ministeriale del 2001, una serie di standard da rispettare.
Alla maggior parte degli standard debbono adeguarsi tutte le strutture; mentre per alcuni ambiti, come il personale e i servizi per l’utenza, è previsto che i requisiti possano essere realizzati in condivisione tra più musei e luoghi della cultura.
Analizzando i requisiti indicati nel Piano triennale per ambito e livello di raggiungimento (Tabella A) si evince che la gestione congiunta a livello terri-toriale per i musei riguarda sostanzialmente la condivisione del personale (di-rezione, segreteria amministrativa, servizi educativi, addetti alla sicurezza, alla promozione e comunicazione) e l’organizzazione di attività relative alla didat-tica. Uno degli obiettivi prioritari dichiarati dalla Regione nel Piano triennale è, infatti, la qualificazione del personale museale, riconoscendo l’urgenza della presenza di specialisti con competenze mirate per i diversi settori: didattica, co-municazione e cura delle collezioni. La Regione valuta utile la condivisione di professionisti tra più musei sapendo che per realtà medio-piccole sarebbe stato difficile dotarsi di peronale qualificato in ognuno di questi settori.
Per lo stesso motivo la Regione ha inoltre previsto un approccio graduale per l’adeguamento dei musei agli standard, predisponendo – a partire dal 2009, cioè a distanza di un anno dalla produzione del Piano triennale – due livelli di rispetto dei criteri: l’accreditamento provvisorio e quello definitivo. Dalla fine del 2009, annualmente, i musei interessati che dimostreranno di aver raggiunto gli standard relativi agli ambiti dello status giuridico, dell’assetto finanziario, delle strutture e del personale (ambiti 1 - 4), e che avranno redatto un piano previsionale di adeguamento agli altri quattro ambiti per il triennio successivo, potranno accedere all’accreditamento provvisorio. I musei che invece si saran-no adeguati all’insieme di tutti i requisiti previsti dagli otto ambiti saranno rico-nosciuti in via definitiva dalla Regione come appartenenti al Sistema museale regionale e saranno iscritti nell’Albo regionale dei musei e dei luoghi della cul-tura appositamente istituito con provvedimento della Giunta regionale.
199 Si veda paragrafo 6.5. I processi per l’accreditamento dei parchi archeologici seguono quanto indicato all’articolo 10 della legge regionale 14/2006 inerente le condizioni necessarie per l’istituzione di detti parchi. Analogamente per quanto riguarda gli ecomusei, il riconoscimento regionale si basa sulla condivisione, per le strutture interessate, dei requisiti esposti al comma 5 dell’articolo 11 della medesima legge.
105
Musei e sistemi nelle politiche regionali della Sardegna (1950-2008) - C. Borgioli
Tale accreditamento verrà comunque sottoposto ad accertamento dopo un periodo di tre anni, onde valutare se la rispondenza agli standard richiesti sia stata mantenuta. Anche i musei riconosciuti provvisoriamente hanno accesso al Sistema regionale e, come quelli accreditati definitivamente, si avvalgono dei finanziamenti e dei contributi regionali. L’utilizzo di tali risorse, erogate non più direttamente agli enti beneficiari ma attraverso le Province (come stabilito dalla legge regionale 9/2006, artt. 76, 77), sarà valutato in termini di efficienza ed efficacia secondo criteri, da individuare con successivo atto ufficiale inerenti, ad esempio, la gestione dell’apertura delle strutture, la tipologia di fruizione, il grado di manutenzione, il numero dei servizi aggiuntivi attivati, le attività di valorizzazione (strumenti di supporto alla visita, didascalie), le iniziative culturali e di promozione svolte.200
Il piano regionale triennale 2008-2010 costituisce il primo effettivo strumen-to che la Regione adotta per riqualificare il patrimonio museale sardo e per certi versi si colloca in linea – certo in maniera ora più convinta e puntuale – con quanto si era tentato di fare ad inizio decennio con la legge regionale 4/2000 e con i relativi indirizzi di attuazione. Le risorse regionali per i musei sono ora vincolate al miglioramento delle strutture e dei servizi e alla costruzione di al-cuni poli museali la cui funzione è “trainare” l’intero patrimonio museale sardo nel processo di adeguamento agli standard.
L’insieme dei musei viene organizzato secondo un modello unitario che fa capo al Sistema museale regionale e solo se i musei vi si uniformano potranno ricevere contributi. Il Sistema regionale si articola sul territorio in ambiti che coincidono con quelli provinciali – così come accadeva per i sistemi turistici lo-cali (STL) – che dovranno raccogliere le varie realtà esistenti nel comprensorio. Nell’allegato C alla delibera n. 29/11 del 2008, che approvava il Piano triennale preliminare, furono presentate le proposte avanzate dalle singole Province: per ognuna si prevedeva l’istituzione di un sistema museale e di diverse esperienze di gestione congiunta per beni appartenenti a uno o più Comuni.
Nessun sistema provinciale risulta ancora attivo, tranne il Sistema museale Arborense (Provincia di Oristano), istituito nell’aprile 2006. Ciò è dipeso anche dai ritardi con cui sono stati avviati i procedimenti relativi al bando per i fi-nanziamenti sulla legge regionale 7/2005, che sostituiva la 4/2000 per i finan-ziamenti ai musei locali, oltre che per la mancata e definitiva approvazione
200 Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010 cit., p. 140-141.
106
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
del Piano regionale per i musei del 2008 nelle modalità stabilite dalla legge regionale 14/2006 .
In conclusione nonostante la tradizionale scarsa propensione dei Comuni della Sardegna a mettere in rete il patrimonio, l’aver vincolato l’erogazione di fondi regionali alla realizzazione di sistemi territoriali ha senza dubbio moti-vato gli enti locali a muoversi in tale direzione; per contro si riscontra anche che i procedimenti regionali non hanno avuto, fino ad adesso, quella snellez-za necessaria per proseguire con la risistemazione reticolare del patrimonio. Molto complessa appare inoltre l’architettura con cui è stato pensato il siste-ma museale regionale, la cui attuazione necessiterà indubbiamente di tempo e impegno. Alcune recenti vicende, come l’espunzione del progetto relativo al Museo dell’arte nuragica e contemporanea di Cagliari dalla programmazione locale, fanno però pensare che la struttura immaginata e progettata tra il 2005 ed il 2008 dalla Regione per il comparto museale isolano potrà subirà ulteriori e consistenti modifiche.
109
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
1 Sa Corona Arrùbia - Consorzio Turistico della Marmilla [Deligia]
Il Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia riunisce attualmente venti Comuni del comprensorio della Marmilla con l’obiettivo di raggiungere l’integrazione territoriale mediante azioni di promozione, progettazione e gestione di opere d’interesse generale a livello turistico, artigianale, industriale e commerciale1. Per quanto riguarda specificatamente il settore turistico-culturale il Consorzio propone di valorizzare il territorio di riferimento adottando una strategia co-mune per promuovere il patrimonio storico, artistico e archeologico dei Comu-ni aderenti2.
¬ 1. La storia del Consorzio
Negli anni Cinquanta e Sessanta in Marmilla vi furono da due rilevanti ri-trovamenti archeologici che attirarono l’attenzione dell’opinione pubblica e dell’ambiente accademico verso quest’area, fino a quel momento estranea ai flussi turistici. La prima di queste due scoperte risale ai primi anni Cinquanta, quando a Barumini fu scavata la reggia nuragica denominata Su Nuraxi3.
Quasi vent’anni più tardi, nel 1969, a pochi chilometri da Barumini fu effet-tuato il secondo rinvenimento, il villaggio nuragico di Genna Maria presso la cittadina di Villanovaforru. Tale ritrovamento rappresentò per l’Amministra-zione comunale di allora una concreta occasione di sviluppo turistico − e quin-di economico − per il territorio. Nei quindici anni successivi, a Villanovaforru furono realizzate alcune strutture necessarie per la fruizione del patrimonio archeologico, con l’intento di far conoscere la cittadina in ambito sia scientifico che turistico: il Parco Archeologico attrezzato, il Museo Archeologico e un gran-de deposito con annesso laboratorio di ricerca e restauro4.
1 Statuto del Consorzio Sa Corona Arrùbia registrato a Sanluri il 10 dicembre 1999, Rep. 38, art. 2. Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, Sa Corona Arrùbia e i suoi musei, s.l. 2008, p. 3. I Comuni che aderiscono al Consorzio sono: Villanovaforru, in qualità di capofila, Collinas, Lunamatrona, Siddi, Gonnostramatza, Pauli Arbarei, Sanluri, Us-saramanna e Villamar, Barumini, Furtei, Genùri, Las Plassas, Mogoro, Sàrdara, Sega-rìu, Turri e Villanovafranca, Setzu e Tuili. Sulle recenti vicende del Consorzio si veda anche a. MerIcI, Il Consorzio turistico della Marmilla Sa Corona Arrùbia, in c. BorGIolI, d. la MonIca (a cura di), Sistemi museali e musei in Sardegna, Politiche ed esperienze, atti del convegno (Sassari, 26 marzo 2010), Felici editore, Pisa 2012, pp. 121-128.
2 Statuto del Consorzio cit.3 G. lIllIu, r. zucca, Storia della scoperta, degli scavi e degli studi del nuraghe Su Nuraxi in
Su Nuraxi di Barumini, Collana «Sardegna Archeologica», Sassari 2005, con riferimenti bibliografici.
4 Il tesoro nascosto di Genna Maria, «L’Unione Sarda», 6 settembre 1997.
110
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Alla fine degli anni Settanta, la compresenza in un territorio così circoscritto di due notevoli testimonianze della cultura nuragica fece prospettare la possi-bilità di creare un unico museo di tipo ‘comprensoriale’, nel quale sarebbero confluiti i reperti provenienti non solo dai siti citati ma anche da altre aree di scavo presenti nella XXV Comunità montana (Alta Marmilla). Il museo, da isti-tuirsi a Villanovaforru con funzione di raccordo tra le diverse aree archeologi-che della Marmilla Inferiore, non fu però mai realizzato perché i due Comuni di Villanovaforru e Barumini non riuscirono a raggiungere un accordo5. Nel 1982 l’Amministrazione comunale di Villanovaforru inaugurò comunque, per proprio conto, il Museo archeologico Genna Maria. Questo Museo ospitò però solo i reperti provenienti dall’omonimo sito e non rispose quindi ai requisiti caratteristici del museo d’interesse comprensoriale6.
Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, il Comune di Villanovaforru promosse una serie di corsi di formazione professionale finaliz-zati alla creazione di figure con competenze specifiche (guide, restauratori di materiale ceramico) cui affidare la gestione del patrimonio culturale cittadino. Nacquero così diverse cooperative, alcune destinate alla gestione dei beni cul-turali, altre − formate da artigiani − rivolte alla conservazione e alla promozio-ne delle forme della produzione tradizionale locale. Contemporaneamente a queste iniziative, si svilupparono anche i primi servizi di ricettività (alberghi, ristoranti e locali commerciali) con conseguente incremento delle attività eco-nomiche locali7.
All’Amministrazione comunale di Villanovaforru fu però presto evidente che le possibilità di sviluppo turistico del paese sarebbero state maggiori se si fossero create azioni condivise e sinergiche con i Comuni limitrofi, in modo da ampliare l’offerta culturale locale, «diversificandola con nuove attrattive»8. Fu così che i Comuni di Villanovaforru (come capofila), Collinas, Lunamatro-na e Siddi si consorziarono dando origine, nel dicembre del 1982, a Sa Corona Arrùbia-Consorzio Turistico della Marmilla allo scopo di arricchire, integrandola, l’offerta turistico-culturale di ciascuno di essi9. Con l’istituzione del Consorzio
5 u. BadaS, Musei di interesse comprensoriale: esperienze e proposte in Cultura e ambiente, atti del convegno Cagliari 1984, Cagliari 1986, pp. 275-278.
6 Cfr. Scheda museo in Musei in rete nella Sardegna del Sud, <http://www.musei.provin-cia.cagliari.it>.
7 Informazioni gentilmente concesse in data 20 aprile 2009, da Giovanni Pusceddu, già sindaco del Comune di Villanovaforru e primo Presidente del Consorzio Sa Corona Arrùbia; <http://www.sacoronarrubia.it>.
8 Citazione dalla sezione Presentazione dell’ente nel sito web ufficiale del Consorzio all’indirizzo <http://www.sacoronarrubia.it>.
9 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 24 dicembre 1982.
111
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
fu approvato anche il relativo statuto, nel quale sono indicati finalità, funzioni e organi gestionali dell’Ente10. Lo scopo del Consorzio è avviare azioni congiun-te tra i partecipanti, al fine di «determinare il progresso economico e sociale» delle comunità coinvolte. Per fare ciò l’Ente si fa promotore di attività diverse: dalla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche e di interesse agrario-forestale, alla realizzazione di studi per lo «sviluppo integrale» della zona; tra le iniziative volte allo sviluppo turistico, artigianale, industriale, commerciale promosse da Statuto dal Consorzio, vi sono infine quelle dedicate «alla valoriz-zazione dei beni ambientali, archeologici, architettonici, storici, demo-antropo-logici e delle peculiarità della zona»11. La nascita e lo sviluppo del Consorzio rispondeva quindi alla volontà locale di procedere alla valorizzazione di questo patrimonio allo scopo di incentivare, anche in queste zone dell’entroterra sar-do, il settore turistico.
¬ 2. Le attività e la gestione del Consorzio
Le prime importanti e concrete azioni del Consorzio per la valorizzazione del patrimonio culturale della Marmilla si verificano nei primi anni Novanta, gra-zie ai finanziamenti relativi ai progetti di sviluppo per il Mezzogiorno. Nel 1991 il Consorzio firmò una convenzione con l’Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno per la realizzazione di itinerari turistici per la «valorizzazione delle risorse del territorio consorziale», nell’ambito del III Piano annuale di at-tuazione del Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE il 20 marzo del 199012.
Il progetto presentato dal Consorzio, dal titolo La valorizzazione delle risorse del territorio consortile, venne approvato dall’Agenzia per la promozione dello svi-luppo nel Mezzogiorno e ricevette un finanziamento di 38,7 milioni di lire che permise all’Ente di concretizzare importanti attività. Grazie al finanziamento
10 Statuto del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, Villanovaforru 1982, artt. 4-17. Gli or-gani gestionali sono così definiti: Assemblea Consorziale, Consiglio Direttivo, Presi-dente, Segretario. Lo Statuto, all’articolo 18, stabiliva anche il versamento da parte di ogni partner di contributi finanziari determinati in egual misura tra i quattro Comuni del Consorzio.
11 Ivi, art. 2.12 Convenzione 109/90 tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e il
Consorzio turistico Sa Corona Arrùbia, Rep. 7598 del 30 maggio 1991 approvata con de-libera dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno n. 2237 del 24 aprile 1991, Approvazione convenzione per il regolamento del finanziamento per assicurare la realizzazione di itinerari turistici per la valorizzazione delle risorse del territorio consorzia-le.
112
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
statale il Consorzio ha potuto acquistare terreni e realizzarvi strutture, museali e non solo, che costituiscono oggi il patrimonio di musei e servizi di diretta pro-prietà del Consorzio: il Museo del Territorio presso Lunamatrona, con l’annesso Parco geobotanico, realizzati su terreni appositamente acquistati dal Consorzio, il Centro di Ristoro e la seggiovia che collega il Museo con i siti archeologici del Parco dei Monumenti Nuragici e Prenuragici13. Quest’ultimo è stato realizzato predisponendo una serie di percorsi che collegano trentadue aree archeologi-che site in terreni che il Consorzio ha provveduto ad acquistare da privati14. Il progetto La valorizzazione delle risorse del territorio consortile prevedeva inoltre la realizzazione di strade comunali, con annessa segnaletica, che collegassero i quattro Comuni aderenti al Consorzio e che in effetti hanno reso raggiungibili le strutture di nuova apertura15.
A partire dalla metà degli anni Novanta, anche a seguito delle iniziative realizzate grazie ai menzionati finanziamenti statali per il Mezzogiorno, altri Comuni del comprensorio espressero la volontà di partecipare al Consorzio: nel 1995 aderirono all’Ente consortile i Comuni di Gonnostramatza, Pauli Arbarei, Sanluri, Ussaramanna e Villamar; successivamente, alla fine del 1999, si uniro-no i Comuni di Barumini, Furtei, Genùri, Las Plassas, Mogoro, Sàrdara, Sega-rìu, Turri e Villanovafranca e, nel 2001, quelli di Setzu e Tuili16. Attualmente il Consorzio è costituito da venti Comuni e i propri confini vanno quasi a coinci-dere con quelli della Marmilla; il crescente numero di adesioni fece avvertire la necessità di rinnovare lo Statuto consortile, di cui fu prodotta una nuova redazione nel 199917.
Una delle principali attività svolte dal Consorzio è stata quella di partecipare a bandi di finanziamento pubblico di varia natura per intercettare risorse ne-cessarie allo sviluppo turistico del comprensorio di riferimento. Alla fine degli anni Novanta, ad esempio, il Consorzio ha partecipato come “operatore colletti-vo”, per i Comuni di Collinas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Ussaraman-na, Villanovaforru e Villamar, al Programma di iniziativa comunitaria LEADER II 1994-1999, per la misura B Programmi d’innovazione rurale. I contributi ricevuti
13 Scheda Tecnica allegata alla Convenzione 109/90 cit. approvata con delibera dell’Agen-zia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno n. 2237 del 1991 cit.
14 Ivi. Le notizie sono tratte dalla Scheda informativa sulle attività del Consorzio, fornitaci dal Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia in data 6 febbraio 2009.
15 Convenzione 109/90 cit., Rep. 7598 del 30 maggio 1991 approvata con delibera dell’A-genzia per la Promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno n. 2237 del 1991 cit.
16 Convenzione per la trasformazione del Consorzio, Rep. 3/95 del 2 novembre 1995; Delibe-ra dell’Assemblea Consortile n. 21 del 7 dicembre 2001.
17 Statuto del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, Villanovaforru 1982.
113
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
hanno permesso all’Ente di realizzare, negli anni tra il 1997 e il 2002, diversi interventi finalizzati alla promozione del patrimonio culturale e delle produ-zioni tipiche della Marmilla. Tra questi ricordiamo la creazione del Centro di Turismo Culturale di Lunamatrona con il compito di occuparsi della promozione turistica del territorio, la realizzazione del marchio Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, il recupero di dodici case tipiche destinate a funzioni di accoglienza nel territorio della Marmilla, l’istituzione di laboratori artigianali aperti alla vendi-ta di prodotti tipici come la Casa del Miele e la Casa della Ceramica18.
Nel 2001 invece il Consorzio partecipò al bando regionale per l’attribuzione di risorse economiche a valere sulla legge regionale n. 4 del 2000 con un proprio progetto per la «gestione integrata» dei beni di sua proprietà19. La norma, con la relativa delibera di attuazione, prevedeva che venissero concessi finanziamenti agli enti locali per la gestione di musei, monumenti e aree archeologiche, previa predisposizione da parte dei richiedenti di opportuni piani di gestione trienna-li, ispirati ad una logica imprenditoriale e che contemplassero forme congiunte di gestione per il patrimonio, nell’ottica di realizzare le basi per un futuro auto sostentamento delle strutture musealizzate20.
Solo un anno prima, nel 2000, il Consorzio aveva istituito, insieme all’INSAR-Iniziative Sardegna S.p.A di Cagliari, una società a capitale misto, denominata
18 Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, Progetto di turismo culturale in area rurale, Piano di Azione Locale, s.d.; Regione Autonoma della Sardegna, Rapporto annuale di esecu-zione al 31/12/2000 del Programma Leader II 1994-1999. Il Centro di Turismo Culturale, allestito all’interno di un palazzo storico appositamente recuperato grazie ai finan-ziamenti relativi al programma comunitario LEADER II, è attualmente chiuso.
19 LR n. 4 del 20 aprile 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000); DGR n. 36/6 del 5 settembre 2000, L.R. n. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in ge-stione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali, biblioteche e archivi. Cap. 11129 del bilancio regionale. Direttive istruttorie e pubblicazione nel BURAS, a norma dell’art. 19 della L.R. 22.8.1990, n. 40. DGR n. 36/32, L.R. n. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archi-vi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e am-bientali, biblioteche e archivi. Programma Triennale 2001-2003. Annualità 2001. Cap. 11129 UPB S11.031 bilancio regionale del 23 ottobre 2001; DGR n. 39/52, L.R. n. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali. 1° programma. Annualità 2002. Cap. 11212 UPB S11.050 bilancio regionale 2002 del 10 dicembre 2002. Contratto tra Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia e Sa Corona Arrùbia s.p.a per l’affidamento a quest’ultima della ge-stione dei beni di proprietà del Consorzio, stipulato in data 5 novembre 2001.
20 LR n. 4 del 2000 cit.; DGR n. 36/6 del 2000 cit.
114
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Sa Corona Arrùbia Spa, con il compito di gestire direttamente i beni di proprietà effettiva dell’Ente consortile: il Museo del Territorio, la seggiovia, il Centro di Ri-storo e il Parco Geobotanico, realizzati grazie alle risorse erogate dalla Cassa per il Mezzogiorno21. Nel 2001, una volta vinto quindi il bando regionale di finan-ziamento sulla legge regionale 4/2000, il Consorzio ha provveduto ad affidare alla neonata Società per azioni la gestione delle proprie strutture, fino ad allora assegnata a diverse cooperative locali22.
Nel triennio 2003-2005 il Consorzio attivò, in via sperimentale, anche una bi-gliettazione unica (denominata Unico Museo) che offriva all’utente la possibili-tà, al costo di 20 euro, di visitare i sette principali musei presenti nel territorio e aderenti all’Ente consortile: il Museo Archeologico Genna Maria di Villanova-forru, il Museo Archeologico Villa Abbas di Sàrdara, il Museo Turcus e Morus di Gonnostramatza, il Museo delle tradizioni agroalimentari Casa Steri di Siddi, il Castello Giudicale a Sanluri e il Museo Archeologico Su Mulinu a Villano-vafranca23. Al biglietto integrato era stata conferita una valenza annuale con l’obiettivo di permettere alla comunità locale, soprattutto se direttamente coin-volta nelle attività ricettive e commerciali, di usufruire dei vantaggi connessi alla valorizzazione del patrimonio culturale. Tale esperimento, però, non ebbe il successo sperato a causa del costo elevato del biglietto e di problemi buro-cratici legati alla rendicontazione, resa difficile dalla diversa natura, pubblica e privata, dei musei coinvolti24.
21 Delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 9 febbraio 2000, Approvazione costituzione Società Mista Consorzio Turistico “Sa Corona Arrùbia” e INSAR, per la gestione delle strut-ture Museo, Seggiovia e Centro Ristoro. Il 51% delle azioni di Sa Corona Arrùbia S.p.A sono di proprietà dello stesso Consorzio Turistico, mentre il restante 49% è dell’INSAR-Iniziative Sardegna S.p.A. di Cagliari.
22 DGR n. 36/32, L.R. n. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali, bibliote-che e archivi. Programma Triennale 2001-2003. Annualità 2001. Cap. 11129 UPB S11.031 bilancio regionale del 23 ottobre 2001; DGR n. 39/52, L.R. n. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali. 1° programma. Annualità 2002. Cap. 11212 UPB S11.050 bilan-cio regionale 2002 del 10 dicembre 2002. Contratto tra Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia e Sa Corona Arrùbia s.p.a per l’affidamento a quest’ultima della gestione dei beni di proprietà del Consorzio, stipulato in data 5 novembre 2001.
23 Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, Scheda informativa sulle attività del Consorzio, inviataci in data 6 febbraio 2009.
24 A. pIntorI, Un solo biglietto per entrare in sette musei, «L’Unione Sarda», 13 luglio 2002; informazione concessa mediante comunicazione orale dal Direttore del Museo del Ter-ritorio di Lunamatrona, Dott. Paolo Sirena in data 20 maggio 2009.
115
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Il Consorzio beneficiò di ulteriori contributi economici nel 2003, grazie all’as-segnazione dei finanziamenti relativi alla misura 2.1 Itinerari di archeologia nu-ragica e prenuragica negli altopiani della Sardegna centro-occidentale del POR Sarde-gna 2000-200625. Il sostegno economico in questa occasione fu destinato in parte ai beni di proprietà giuridica dello stesso Consorzio e in parte alle strutture di proprietà di quattro Comuni consorziati: Mogoro, Sardara, Segariu e Villanova-franca. In particolare, per quanto riguarda le strutture di sua proprietà, il Con-sorzio ha realizzato il completamento del Centro di Ristoro e l’allestimento della sezione antropica all’interno del Museo del Territorio, mentre con le risorse de-stinate ai beni degli enti locali consorziati si è provveduto alla creazione di un centro di documentazione sull’uso dell’argilla in Età Nuragica e Prenuragica a Segariu e alla «valorizzazione» del Nuraghe Cuccuradda di Mogoro, dell’area archeologica di Santa Anastasia a Sardara e del parco archeologico Su Mulinu di Villanovafranca26.
Sempre nel 2003 il Consorzio ha ottenuto il Premio Cultura di Gestione di Fe-derculture nella categoria Politiche di Valorizzazione del Territorio; l’associazione Federculture nell’assegnare al Consorzio questo riconoscimento ha tenuto conto del fatto che le attività avviate da Sa Corona Arrùbia hanno innescato «un pro-cesso di rivitalizzazione di una realtà caratterizzata dal fenomeno dello spopo-lamento e della perdita di competitività economica e dal rischio del degrado dell’intera area»27.
Le attività svolte dal Consorzio non possono essere definite di tipo sistemico: sebbene esso funga da soggetto unico per la partecipazione ai bandi di finan-ziamento pubblico e abbia un ruolo di coordinamento per azioni di tipo pro-mozionale, la sua natura rimane quella di un consorzio intercomunale di tipo turistico. Tuttavia, dal 2000, sono stati manifestati un interesse maggiore per la gestione unitaria e la volontà di creare una bigliettazione. Nel 2006, sulla scorta degli indirizzi prodotti nel 2005 dalla Regione in materia di musei e sistemi museali, anche il Consorzio ha provato a dare luogo a una forma di gestione sistemica per il patrimonio culturale28.
25 Determinazione regionale (Sardegna) n. 93 del 5 febbraio 2003.26 Determinazione regionale (Sardegna) n. 93 del 5 febbraio 2003, cit.; Delibera Consi-
glio di Amministrazione del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia n. 17 del 27 aprile 2005, POR Sardegna 200/2006-Misura 2.1-Progetto “Itinerari di archeologia nuragica e pre-nuragica negli altipiani della Sardegna centro occidentale”-Approvazione proposta presenta-zione Sezione antropica.
27 Elenco dei vincitori e delle relative motivazioni del Premio Cultura di Gestione 2003 consultabile nel sito web di Federculture all’indirizzo www.federculture.it.
28 Si fa riferimento al documento regionale Sistema Regionale dei Musei. Piano di raziona-lizzazione e sviluppo. approvato con DGR n. 36/5 del 26 luglio 2005.
116
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Nel citato documento strategico del 2005 la Regione dichiarava la sua volon-tà di creare un sistema museale regionale articolato in sub sistemi a carattere territoriale o tematico distribuiti nelle diverse aree dell’Isola; all’interno di tali sub sistemi, a dimensione provinciale o intercomunale, avrebbero dovuto esse-re inseriti tutti i musei, le raccolte museali e i siti culturali presenti in un deter-minato territorio29. Il Piano di razionalizzazione e sviluppo del 2005 inoltre intro-duceva un’altra importante novità nel panorama legislativo in materia museale ovvero l’attivazione di un procedimento di accreditamento indirizzato a tutti quei beni culturali di proprietà o pertinenza degli enti locali che avessero volu-to beneficiare delle risorse economiche stanziate dalla Regione; in altri termini il Piano di razionalizzazione e sviluppo prevedeva che tutte le strutture musealiz-zate intenzionate a godere dei contributi regionali avrebbero dovuto rispettare i principali standard definiti dal Decreto Ministeriale del 10 maggio 200130. Con l’attivazione di questa procedura la Regione si poneva l’obiettivo non solo di migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti nelle strutture culturali sar-de, ma soprattutto di incentivare l’istituzione di reti museali per apportare un miglioramento all’insieme dei musei. Ciò dipendeva dal fatto che la maggior parte delle strutture museali isolane fosse di dimensioni medio-piccole e quindi necessariamente obbligata ad associarsi per riuscire ad adeguarsi ai requisiti ministeriali31.
Nel 2006 il Consorzio ha elaborato un progetto per la creazione di un sistema museale da presentare alla Regione in occasione del bando di finanziamento per la gestione dei beni culturali di ente locale, a valere sulla legge regionale n. 7 del 2005 per il triennio 2006-200832. Il progetto del Consorzio prevedeva che
29 Sistema Regionale dei Musei. cit. approvato con DGR n. 36/5 del 2005 cit.30 Ivi. DM 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di
funzionamento e sviluppo dei musei.31 DM 10 maggio 2001 cit. DGR n. 36/5 del 2005; su questo aspetto si veda anche il
saggio di Cristina Borgioli in questo volume.32 La nuova legge finanziaria regionale n. 7 del 2005 e la relativa delibera di attuazione
n. 61/30 del 2005 hanno sostituito la normativa precedente in materia di contributi agli enti locali, ossia la citata legge regionale n. 4 del 2000. Tale sostituzione avven-ne a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2004 che decretava l’illegittimità dell’articolo 113bis del Tuel e sottraeva alle Regioni e agli enti locali un riferimento generale per le modalità di affidamento a terzi dei servizi privi di rilevanza economica, toccando quindi una questione che riguardava anche la con-cessione dei servizi per musei e istituti della cultura. Con l’emanazione della legge regionale n. 7 del 2005 dunque la Regione si è adeguata al mutato contesto normativo nazionale; i commi 7 e 8 dell’articolo 37 della norma infatti permettono nuovamente il ricorso all’affidamento a terzi della gestione dei beni culturali. LR n. 7 del 21 aprile 2005, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del Regione; DGR n. 61/30 del 20 dicembre 2005, Linee di indirizzo relative all’erogazione di contributi agli enti locali; Atto del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Turistico Sa Corona
117
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
al sistema partecipassero quest’ultimo, con le strutture di proprietà, e altri sei Comuni consorziati: Gonnostramtza, Mogoro, Collinas, Lunamatrona, Segarìu, Paùli Arbarei.
Questi soggetti firmarono un’apposita convenzione il 13 settembre 2006, dando vita al Sistema museale denominato MUSTER (acronimo di MUsei del TERritorio), caratterizzato da una dimensione interprovinciale avente come centro il Museo del Territorio di Lunamatrona33. Tuttavia, poiché i contributi a valere sulla legge regionale 7/2005 non sono mai stati assegnati, nel 2008, allo scadere della convenzione tra i soggetti interessati, il sistema MUSTER si è sciolto, non essendo stato rinnovato l’accordo tra i partecipanti.
Il Consorzio, in qualità di Ente capofila del sistema MUSTER, nel 2007 e nel 2008 ha provveduto a richiedere i contributi regionali per interventi di restauro sui beni culturali previsti dalla legge regionale n. 14 del 200634. Nello specifico, nel 2007 hanno ricevuto i finanziamenti regionali i progetti di restauro presen-tati dai Comuni di Collinas, Gonnostramatza, Lunamatrona e Paùli Arbarèi. Non sono stati finanziati, invece, i progetti presentati nella medesima occasio-ne dai Comuni di Mogoro, Segariu e dal Consorzio stesso35. Nel 2008 hanno ricevuto il sostegno economico regionale gli interventi di restauro richiesti dai Comuni di Collinas, Gonnostramatza, Lunamatrona e Mogoro. Contempora-neamente all’istituzione del Sistema museale territoriale MUSTER, altri quattro Comuni aderenti al Consorzio, che non partecipavano però al Sistema (Sàrdara, Siddi, Villanovaforru e Villanovafranca), idearono un altro progetto, parallelo e indipendente sia dal MUSTER che dal Consorzio, denominato Archeologia senza frontiere con lo scopo di coordinare, gestire e valorizzare il patrimonio culturale di loro pertinenza36. Il progetto, rimasto fermo per due anni, è stato ripreso, col
Arrùbia n. 33, Approvazione Progetto Triennale di gestione dei servizi relativi ad aree e parchi archeologici, complessi monumentali, musei di ente locale. L.R. 21/04/2005 n°7 art.12 comma 3 Deliberazione G.R. 61/60 del 20.12.2005 del 6 settembre 2006.
33 Convenzione per la costituzione e la gestione associata del sistema museale territoriale MU-STER, firmata in data 13 settembre 2006. Per maggiori informazioni sul MUSTER si veda la relativa scheda in questo stesso volume.
34 LR n. 14 del 20 settembre 2006, Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura; DGR n. 28/23 Legge Regionale 20 settembre 2006, n,14, art. 4, lettere f) e art. 21, lett. c). Assegnazione contributi agli Enti Locali per interventi di restauro dei beni cultura-li. Approvazione direttive del 27 luglio 2007 e n. 36/37 Interventi di restauro sul patri-monio culturale. Programma relativo alla concessione di contributi ai sensi dell’art. 4 lett. f) e dell’art. 21 lett. c) della L.R. 20 settembre 2006, n. 14. Bilancio regionale 2008. Euro 10.000.000 del 1 luglio 2008.
35 DGR n. 49/25 del 5 dicembre 2007, Interventi di restauro sul patrimonio culturale. Pro-gramma relativo alla concessione di contributi ai sensi dell’art. 4 lett. f) e dell’art. 21 lett. c) della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, Bilancio regionale 2007. € 5.000.000.
36 Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, Sa Corona Arrùbia e i suoi musei, s.l. 2008.
118
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
nome LOGUS-Paesaggi del passato, nel 2008, quando i Comuni coinvolti hanno firmato la bozza della Convenzione37. Al progetto LOGUS aderiscono musei e siti di rilevanza archeologica e naturalistica del territorio, quali il Museo Civico Archeologico Villa Abbas e il Pozzo Sacro di Sant’Anastasia di Sàrdara, il Museo Ornitologico e la Tomba dei Giganti Sa Domu e s’Orcu di Siddi, il Museo e Parco Archeologico Genna Maria di Villanovaforru, il Museo e il Parco Archeologico Su Mulinu di Villanovafranca38.
La vicenda del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia negli anni si è intrec-ciata anche con altre e più definite realtà sistemiche del territorio: come la Fon-dazione Barumini Sistema Cultura (istituita nel 2006) ovvero il sistema museale cittadino di Barumini gestito dalla omonima Fondazione, che contempla al suo interno beni già inseriti nell’orbita di azione del Consorzio turistico Sa Corona Arrùbia (l’area archeologica Su Nuraxi, il Museo Casa Zapata, il Centro G. Lilliu). In futuro, qualora venga realmente realizzato, possiamo ipotizzare che si veri-ficherà un’ulteriore “intersezione” con il Sistema museale territoriale LOGUS-Paesaggi del passato39.
¬ 3. L’organizzazione del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia
L’obiettivo principale del Consorzio è lo sviluppo del settore turistico nel ter-ritorio di riferimento; l’azione svolta per l’insieme dei beni culturali che insi-stono nel comprensorio si ravvisa oggi non tanto nella gestione delle singole strutture quanto piuttosto nelle attività di promozione e proprio quest’ultima, in effetti, viene svolta dal Consorzio per tutto il territorio di competenza attra-verso un sito web istituzionale e la produzione di materiale cartaceo40.
37 DCC di Sardara n. 32 del 11 giugno 2008, Adesione al Sistema Museale Territoriale de-nominato “LOGUS” (Paesaggi del passato) tra i Comuni di Sàrdara, Siddi, Villanovaforru e Villanovafranca.
38 Ivi.39 Si veda la scheda su Fondazione Barumini Sistema Cultura in questo stesso volume.40 Statuto cit., registrato a Sanluri il 10 dicembre 1999, art. 2. Il Consorzio si occupa in par-
ticolare della promozione dei seguenti musei: Museo Casa Zapata di Barumini, Museo Civico G. B. Tuveri di Collinas, Museo Turcus e Morus di Gonnostramatza, Museo del Castello di Las Plassas (attualmente chiuso), Museo Demoantropologico D.E.A. Luna di Lunamatrona, Museo Archeologico del Carmine di Mogoro, Museo Etnografico della Don-na di Paùli Arbarèi, Museo Archeologico Villa Abbas di Sàrdara, Museo delle Argille di Se-garìu, Museo Archeologico di Setzu (di prossima apertura) Museo Ornitologico di Siddi, Museo archeologico Genna Maria di Villanovaforru, Museo archeologico Su Mulinu di Villanovafranca; e siti archeologici: Complesso nuragico Su Nuraxi di Barumini, Complesso nuragico Cuccurada di Mogoro (non ancora ufficialmente aperto), Pozzo Sacro di Sant’Anastasia di Sàrdara, Tomba dei Giganti Sa Domu e s’Orcu di Siddi,
119
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Il sito web è articolato in diverse sezioni che permettono al fruitore di orga-nizzare, anche a distanza, il soggiorno nell’area della Marmilla; a tale scopo il sito del Consorzio contiene informazioni riguardanti la storia e le attività dello stesso ente consortile, schede descrittive dei siti e dei musei afferenti, informa-zioni sui Comuni e sulle strutture ricettive41. La visibilità del Consorzio è inoltre garantita dalla pubblicità a mezzo stampa su testate regionali e nazionali e da materiale cartaceo di vario genere – brochure, opuscoli e manifesti – distribuite in diverse aree della Sardegna, mentre in occasione delle esposizioni tempora-nee allestite presso i locali del Museo del Territorio di Lunamatrona, il Consorzio si affida anche alla pubblicità radiofonica e televisiva su emittenti regionali42.
I beni inseriti all’interno del Consorzio sono di diversa proprietà: alcuni ap-partengono ai Comuni consorziati, altri allo stesso Ente consortile e altri infine a privati. I beni di proprietà privata, aperti alla visita solo su appuntamento, sono il Castello Giudicale Eleonora d’Arborea e il Museo Etnografico dei Cappuccini a Sanluri, il Museo delle Tradizioni Agroalimentari Casa Sterri a Siddi43; le strut-ture appartenenti al Consorzio sono il Museo del Territorio, il Parco geobotanico, la seggiovia e il Centro di Ristoro nel territorio del Comune di Lunamatrona, il Parco dei monumenti nuragici e prenuragici nella cosiddetta Giara di Siddi44.
Nel 2001 la gestione di questi ultimi beni è stata affidata dal Consorzio a un unico soggetto appositamente creato: la Sa Corona Arrùbia spa45. In questo modo l’Ente consortile è riuscito ad avviare per le strutture di sua proprietà una ge-stione unitaria che ha permesso l’introduzione di un biglietto unico valido per l’ingresso al Museo del Territorio, comprensivo di visita guidata, al Parco Geobota-nico, e l’accesso alla seggiovia, che collega il Museo alla cosiddetta Giara di Siddi, un altopiano di grande interesse geologico e botanico, dove si trovano alcuni siti inclusi nel Parco dei Monumenti Nuragici e Prenuragici, come la Tomba dei Giganti Sa Domu e s’Orcu di Siddi46. La gestione unitaria delle strutture citate e
Complesso nuragico Genna Maria di Villanovaforru, Complesso nuragico Su Mulinu di Villanovafranca.
41 Sito web ufficiale del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, all’indirizzo <http://www.sacoronaspa.it>.
42 Informazioni fornite dal dott. Paolo Sirena, Direttore del Museo del Territorio di Lu-namatrona, tramite comunicazione orale in data 17 settembre 2009
43 Scheda informativa sulle attività del Consorzio, dattiloscritto a cura della Presidenza del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, s. l., s. d..
44 Convenzione 109/90 cit. 45 Delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 2000 cit.; Contratto tra Consorzio Turisti-
co Sa Corona Arrùbia e Sa Corona Arrùbia spa cit., stipulato in data 5 novembre 2001.46 Lunamatrona, Museo del territorio “Sa Corona Arrubia”, consultabile nel sito web
<http://sardegnacultura.it>; Giara di Siddi in <http://www.sardegnaturismo.it>;
120
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
la presenza di un biglietto unico rende quest’esperienza una sorta di aggrega-zione di tipo sistemico all’interno dello stesso Consorzio.
Da contratto, l’affidamento dell’attività gestionale ha la durata di nove anni, a partire dal primo gennaio 2001, e riguarda attività diverse a seconda delle strutture47: per il Museo del Territorio e annesse pertinenze (interne: giardini, bar, bookshop, info-point, guardaroba; esterne: Parco Geobotanico, seggiovia, Centro di Ristoro, parcheggi) la Società per Azioni dovrebbe occuparsi della custodia, della sorveglianza, della pulizia, della promozione, della biglietteria e dei ser-vizi aggiuntivi (bookshop, punti ristoro, guardaroba, info point)48; di fatto la Società ha provveduto ad affidare questi compiti ad un altro gestore, la coope-rativa locale Il Lichene Rosso che si occupa anche del Centro di Ristoro49.
Analogamente, anche per quanto concerne la seggiovia, per cui la Sa Corona Arrùbia spa deve garantire il funzionamento e la dotazione di personale tecni-co particolarmente qualificato, la gestione è stata affidata a un altro soggetto, la cooperativa La Seggiovia50. In questo caso sono a carico del gestore anche le operazioni di manutenzione straordinaria, l’assicurazione verso terzi e dell’im-pianto, la vigilanza e custodia notturna51.
Per il Parco dei Monumenti Nuragici e Prenuragici, visitabile gratuitamente, la Società Sa Corona Arrùbia si occupa della pulizia e della manutenzione ma non attiva servizi aggiuntivi52. Il Direttore del Museo del Territorio è invece un diretto dipendente del Consorzio e ciò permette di mantenere un certo controllo sulle attività dell’istituto museale53. Nel 2007 alla Società per Azioni è stata affidata anche la gestione di tutte le strutture afferenti al Sistema museale MUSTER ma anche in questo caso, però, la Società Sa Corona Arrùbia si è avvalsa di alcune cooperative locali per la gestione concreta dei musei partecipanti al sistema54.
<http://www.sacoronaspa.it>.47 Contratto tra Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia e Sa Corona Arrùbia s.p.a per l’af-
fidamento a quest’ultima della gestione dei beni di proprietà del Consorzio, stipulato in data 5 novembre 2001, art. 2.
48 Ivi, artt. 3 e 4.49 Lunamatrona, Museo del territorio “Sa Corona Arrubia”, consultabile sul sito web
<http://sardegnacultura.it>.50 <http://www.sacoronaspa.it>.51 Contratto tra Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia e Sa Corona Arrùbia s.p.a cit., sti-
pulato in data 5 novembre 2001, artt. 5 e 6.52 Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, Sa Corona Arrùbia e i suoi musei, s.l. 2008, p. 11.53 Informazione fornita dal Direttore del Museo del Territorio, dott. Paolo Sirena, tramite
comunicazione scritta del 18 novembre 2009.54 Convenzione per la costituzione e la gestione cit., firmata in data 13 settembre 2006. Deli-
bera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sa Corona Arrùbia n. 17 del 21
121
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Per garantire il funzionamento delle strutture di sua proprietà, il Consorzio trasferisce puntualmente alla Società Sa Corona Arrùbia i contributi erogati da Enti pubblici e privati, o qualsiasi altra somma introitata, trattenendone per sé il 5%55. Fra questi finanziamenti vanno annoverati anche i contributi a valere sulla legge regionale n. 4 del 2000 e destinati a coprire le spese per il persona-le direttamente impiegato nei servizi culturali56; l’articolo 38 di questa norma, infatti, autorizza la Regione a concedere risorse economiche regionali agli Enti locali che presentino programmi triennali di gestione del patrimonio culturale di loro pertinenza57.
Per quel che riguarda la gestione degli altri beni culturali aderenti al Con-sorzio − ovvero quelli che non rientrano nel progetto MUSTER né sono di pro-prietà dello stesso Consorzio − si deve fare una distinzione fra quelli di pro-prietà pubblica e quelli di proprietà privata: nel primo caso, infatti, i siti e i musei vengono gestiti da cooperative direttamente impiegate dagli Enti locali e, per la maggior parte, finanziate con la legge regionale 4/2000, mentre quelli di proprietà privata sono gestiti direttamente dai proprietari e aperti solo su appuntamento58. In entrambi i casi comunque la gestione dei beni è del tutto indipendente dagli organi del Consorzio rendendo in questo modo assai difficile
marzo 2007, Affidamento Alla Spa Sa Corona Arrùbia della gestione MUSTER Sa Corona Arrùbia periodo 1.04.2007 al 30.06.2007; <http://www.sacoronaarrubia.it>.
55 Contratto tra Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia e Sa Corona Arrùbia s.p.a cit., sti-pulato in data 5 novembre 2001, art. 9.
56 LR n. 4 del 2000 cit.; DGR n. 36/6 del 2000 cit., n. 36/32 del 2001 cit., n. 39/52 del 2002 cit. e n. 25/19 del 1 giugno 2005, Contributi agli Enti Locali della Sardegna per concorrere agli oneri derivanti dalla gestione dei beni culturali. Art. 12 comma 3 L.R. del 21.4.2005 n. 7. UPB S11.030 Cap. 11212 euro 7.070.000; Delibera Consiglio di Amministrazione del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia n. 17 del 2007 cit.
57 LR n. 4 del 2000 cit., art. 38 comma 1): «L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi, sino al 90 per cento della spesa prevista in progetto e ritenuta ammissibile, per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, bi-blioteche ed archivi. La durata delle convenzioni non può essere inferiore ai tre anni. Nel caso di servizi a rientro tariffario il contributo da erogare a favore degli enti locali deve tenere conto del rientro medesimo».
58 I Comuni consorziati di Barumini, Gonnostramatza, Sardara, Siddi, Villanovafranca e Villanovaforru hanno partecipato singolarmente al bando per i finanziamenti a va-lere sulla legge regionale n. 4 del 2000 e pertanto gestiscono in maniera autonoma i contributi ricevuti, destinati al personale impiegato nei siti di rispettiva competenza. LR n. 4 del 2000 cit.; DGR n. 36/6 del 2000 cit., n. 36/32 del 2001 cit., n. 39/52 del 2002 cit. e n. 25/19 del 1 giugno 2005 Contributi agli Enti Locali della Sardegna per concorrere agli oneri derivanti dalla gestione dei beni culturali. Art. 12 comma 3 L.R. del 21.4.2005 n. 7. UPB S11.030 Cap. 11212 euro 7.070.000; Delibera Consiglio di Amministrazione del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia n. 17 del 2007 cit.
122
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
il raggiungimento degli obiettivi che i soci fondatori si erano prefissati all’atto della sua fondazione, ovvero la piena integrazione territoriale59.
Per quel che concerne l’organizzazione interna del Consorzio, l’attuale Sta-tuto, approvato nel 1999, ne definisce gli organi di rappresentanza, di ammini-strazione e di gestione: l’Assemblea Consortile, il Presidente del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale60. All’Assemblea Consortile spetta il compito di decidere gli indirizzi specifici del Consorzio al fine di conseguirne i compiti statutari e di controllare l’attività dei vari organi, mentre il Presidente, eletto dall’Assemblea Consortile, ha le funzioni di rappresentare e convocare l’Assemblea, nonché di controllare l’attività complessiva dell’Ente, promuovendo indagini e verifiche sulle relative attività61. Il Consiglio di Amministrazione costituisce l’organo di amministrazione dell’Ente e il Presidente del Consiglio di Amministrazione funge da raccordo fra Assemblea e Consiglio, con il compito di coordinare le procedure d’indirizzo con quelle di governo e di amministrazione assicurando così l’unità di tutte le attività62; infine, il Direttore Generale svolge l’attività di gestione per l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi sociali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio63.
Rispetto al primo Statuto (1982), gli organismi gestionali sono aumentati di numero e sono stati maggiormente definiti nelle loro funzioni; in effetti il nuo-vo Statuto risponde alla necessità avvertita dal Consorzio di riorganizzare la propria struttura amministrativa in concomitanza al progressivo incremento delle adesioni dei Comuni64. Al contrario degli organi di gestione, tra lo Sta-tuto del 1982 e quello più recente del 1999, ancora in vigore, non compaiono sostanziali differenze nelle finalità assegnate al Consorzio Turistico; in entrambi i documenti si ribadisce che l’Ente consortile opera allo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale delle comunità e del territorio di riferimento me-diante l’avvio di opere pubbliche e la promozione del patrimonio culturale65.
Il Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia presenta alcune peculiarità che lo differenziano da altre esperienze sistemiche del contesto sardo: è la più antica
59 Statuto del Consorzio Sa Corona Arrùbia registrato a Sanluri il 10 dicembre 1999 Rep. 38, art. 2. Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, Sa Corona Arrùbia e i suoi musei, s.l. 2008
60 Statuto del Consorzio cit. registrato a Sanluri il 10 dicembre 1999 Rep. 38.61 Ivi, artt. 7 -13.62 Statuto del Consorzio cit. registrato a Sanluri il 10 dicembre 1999 Rep. 38, artt. 14-18.63 Ivi, art. 24.64 Statuto cit., Villanovaforru 1982; Statuto di Sa Corona Arrùbia Consorzio Turistico della
Marmilla, Sanluri 1° dicembre 1999, Rep. n. 38.65 Ivi.
123
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
esperienza di associazione tra Enti locali finalizzata al miglioramento delle con-dizioni economiche e sociali delle rispettive comunità attraverso l’integrazione territoriale, lo sviluppo del settore turistico e la promozione del patrimonio culturale. Un altro elemento che contraddistingue l’esperienza consortile è poi il numero dei partecipanti, poiché, con le sue venti adesioni, il Consorzio è oggi il sistema culturale più esteso presente nell’Isola. In realtà, l’ambito di azione del Consorzio si è limitato fino a oggi alla promozione per l’intero territorio inte-ressato; il mancato avvio di una reale messa in rete del patrimonio culturale di pertinenza degli Enti locali consorziati è dovuto ai rapporti spesso difficili fra Amministrazioni pubbliche coinvolte e organi consortili che hanno impedito una effettiva partecipazione dell’Ente negli aspetti più prettamente gestionali dei beni musealizzati.
Il Consorzio si caratterizza anche per la presenza al suo interno di diverse realtà sistemiche che lo coinvolgono in vari modi: la prima di queste esperienze riguarda le strutture culturali di proprietà consortile che, mediante l’affidamen-to a un unico soggetto gestore e l’attivazione di una bigliettazione integrata, si configurano al momento come l’unico esempio di messa a sistema di beni culturali avviata dal Consorzio66. La seconda esperienza è quella costituita dal Sistema museale territoriale denominato MUSTER che, attivo nel triennio 2006-2008, ha visto coinvolto il Consorzio in qualità di ente capofila del progetto67.
A questi due casi si aggiungono altre due realtà gestionali che riguardano solo indirettamente l’Ente consortile perché nate all’interno dei suoi confini: la Fondazione Barumini Sistema Cultura, che gestisce il patrimonio culturale di spettanza del Comune di Barumini, e il Sistema museale denominato LOGUS-Paesaggi del passato, che invece interessa altri quattro Comuni aderenti al Con-sorzio ma estranei alle precedenti esperienze68.
La compresenza all’interno dei confini consortili di diverse esperienze siste-miche del tutto indipendenti dal Consorzio mostra chiaramente come quest’ulti-mo non intervenga in alcun modo nella gestione dei beni culturali dei Comuni consorziati e, di conseguenza, non effettui ancora oggi una gestione unitaria delle strutture musealizzate. Al contempo, queste esperienze testimoniano la volontà da parte degli Enti locali di provvedere a una “messa a sistema” del proprio patrimonio, incoraggiata dagli atti di indirizzo elaborati dalla Regione negli anni Duemila. Sulla base della nostra ricerca, sembra che il Consorzio non
66 Contratto tra Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia e Sa Corona Arrùbia spa cit., stipu-lato in data 5 novembre 2001.
67 Convenzione per la costituzione cit., firmata in data 13 settembre 2006. Si veda la scheda sul sistema MUSTER in questo stesso volume.
68 Si rimanda alla scheda sulla Fondazione Barumini Sistema Cultura in questo volume. Delibera Consiglio Comunale di Sardara n. 32 del 2008 cit.
124
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
sia riuscito a raggiungere l’obbiettivo, prefissato alla sua fondazione nel 1982, della piena integrazione territoriale, tuttavia è indubbio che nel corso degli anni l’Ente abbia raggiunto risultati positivi in termini di sviluppo del territorio, ad esempio grazie alla realizzazione delle strade comunali che tutt’oggi collegano fra loro alcuni centri della Marmilla, con il conseguente miglioramento della viabilità e della comunicazione69. Tra gli effetti positivi raggiunti dal Consorzio ricordiamo poi anche il recupero di edifici storici e il restauro di alcuni monu-menti insistenti sul territorio di riferimento; questi risultati sono stati possibili grazie alla capacità di intercettare i finanziamenti pubblici messi a bando nel corso degli anni70. Le numerose esposizioni temporanee organizzate nei locali del Museo del Territorio hanno permesso a questa struttura di divenire uno dei musei più visitati dell’Isola, richiamando nel territorio un cospicuo numero di turisti71. I successi ottenuti dall’insieme di attività svolte dal Consorzio hanno reso questa realtà un modello gestionale riconosciuto anche a livello nazionale, come dimostrano il Premio Federculture o la citazione tra i Buoni Esempi inclusi nel sito web che raccoglie le migliori esperienze di innovazione elaborate dalle amministrazioni72.
69 Convenzione 109/90 cit., Rep. 7598 del 30 maggio 1991 approvata con delibera dell’A-genzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno n. 2237 del 1991 cit.
70 Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, Progetto di turismo culturale in area rurale cit. Regione Autonoma della Sardegna, Rapporto annuale di esecuzione al 31/12/2000 del Programma Leader II 1994-1999. DGR n. 28/23 del 2007 cit. e n. 36/37 del 2008 cit.
71 Nei suoi dieci anni di attività il Museo del Territorio ha registrato la vendita di ol-tre 600.000 biglietti. Informazione fornita, tramite comunicazione scritta, dal Dott. Alessandro Merici, Presidente del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, in data 23 febbraio 2010.
72 <http://www.federculture.it>, <http://www.buoniesempi.it>.
125
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
2 Percorso Museale Monumentale Sehuiense [Deligia]
Il Percorso Museale Monumentale Sehuiense è un progetto per la messa in rete del patrimonio culturale locale ideato e promosso dall’Amministrazione comu-nale di Seui a partire dall’autunno del 200073. Con questo progetto il Comune ha cercato di intercettare, riuscendoci a partire dal 2001, le risorse economiche messe a diposizione dalla Regione attraverso l’articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000 e dalla relativa delibera di attuazione74. Le disposizioni regionali ex lege 4/2000 prevedevano, infatti, finanziamenti da destinare a quegli Enti locali che avessero presentato alla Regione un piano triennale per la gestione dei beni culturali di loro proprietà o spettanza; tali contributi erano finalizzati a coprire una percentuale (80% al primo anno, 70% e 60% al secondo e al terzo) delle spe-se inerenti il personale direttamente impiegato nei servizi culturali a esclusione di quello relativo ai servizi aggiuntivi75. In questo modo la Regione, da una par-te garantiva il proprio sostegno agli Enti locali nell’esercizio dei servizi basilari per il patrimonio culturale, dall’altra obbligava le singole Amministrazioni a dotarsi di un opportuno piano per la gestione dei beni musealizzati e stimo-lava la diffusione di un modello “imprenditoriale” per l’attivazione di servizi aggiuntivi, in netto contrasto con quanto era stato realizzato in precedenza a seguito della normativa regionale per il contrasto alla disoccupazione76.
Il Comune di Seui già all’inizio dell’anno 2000 aveva avviato una prima ge-stione congiunta per i beni culturali fruibili, ovvero la Palazzina Liberty, sede
73 Progetto Gestione Beni Culturali, Musei e Servizi Aree Archeologiche ed Ambientali-Comune di Seui approvato con DGC di Seui n. 63 del 20 ottobre 2000. Sul sistema museale di Seui si veda anche l’intervento di G. deSoGuS pubblicato in Sistemi museali e musei in Sardegna cit. 2012, pp. 175-178.
74 Ivi. LR n. 4 del 20 aprile 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-nale della Regione (legge finanziario 2000). DGR n. 36/32 del 23 ottobre 2001, L.R. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in ge-stione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali, biblioteche ed archivi. Programma triennale 2001-2003. Annualità 2001. Cap. 1129 UPB S11031 bilancio regionale.
75 LR n. 4 del 2000 cit.; DGR n. 36/6 del 5 settembre 2000, L.R. n. 4/2000 art. 38. Beni Culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a co-operative e società, mediante convenzione dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni mu-seali, beni monumentali e ambientali, biblioteche e archivi. Cap. 11129 del bilancio regionale. Direttive istruttorie e pubblicazione nel BURAS, a norma dell’art. 19 della L.R. 22.8.1990, n. 40. Nello specifico, la percentuale con la quale la Regione distribuiva le risorse a valere sulla legge regionale 4/2000 era così ripartita: l’80% nella prima annualità, il 70% per il secondo anno e il 60% per la terza annualità.
76 Si veda quanto dichiaratamente espresso in proposito nella DGR n. 36/6 del 2001 cit.
126
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
del Museo etnografico, la Galleria Civica e il Carcere Spagnolo77; in particolare, nel febbraio del 2000, l’Amministrazione comunale decise di realizzare una ge-stione integrata delle citate strutture affidandole, tramite appalto, a un unico soggetto. Una volta bandita, la gara fu vinta da una cooperativa locale, deno-minata S’Eremigu, la quale dall’estate del 2000 si occupò di assicurare i servizi di visita guidata, biglietteria, vendita di materiale divulgativo e riordino delle collezioni, per le tre strutture citate78.
L’attività svolta dal personale di S’Eremigu ha coinciso con un immediato incremento della vendita dei biglietti e del numero di visitatori, grazie soprat-tutto all’iniziativa degli stessi operatori, che si sono adoperati per promuovere «a proprie spese» l’offerta culturale sehuiense, quando cioè non erano ancora stati concessi al Comune i finanziamenti regionale ex lege 4/200079.
A seguito dell’avvio dell’esperienza di gestione affidata a un soggetto uni-co, il 20 ottobre del 2000, il Comune elaborò e approvò un progetto triennale di gestione per il proprio patrimonio culturale, da presentare alla Regione per concorrere al bando di finanziamento a valere sulla legge regionale 4/2000, che fu accolto favorevolmente nell’autunno del 200180. Il progetto contemplava in particolare la gestione congiunta delle seguenti strutture museali comunali: la Palazzina Liberty, il Carcere Spagnolo, la Galleria Civica, la Casa Farci, la Casa Are-su-Loy, il Parco Archeologico di Ardasay81. Le strutture musealizzate da inserire all’interno della gestione congiunta risultano incrementate rispetto a quanto già sperimentato con l’affidamento alla cooperativa S’Eremigu a partire dall’estate del 2000: l’offerta dei beni visitabili all’interno del percorso cittadino si sarebbe dovuta arricchire dei palazzi storici delle famiglie Farci e Aresu-Loy e del Parco archeologico di Ardasay ma al momento della presentazione del piano triennale alla Regione, queste strutture non erano ancora fruibili in quanto ancora ogget-to di lavori di restauro e messa in sicurezza, sebbene il Comune avesse previsto
77 Progetto Gestione Beni Culturali cit.78 Si veda Progetto Gestione Beni Culturali cit.79 Ivi.80 Progetto Gestione Beni Culturali cit. DGR n. 36/6 del 2000 cit., n. 36/32 del 2001 cit. e n.
39/52 del 10 dicembre 2002, L.R. 4/2000. Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali. 1° Pro-gramma. Annualità 2002. Cap. 11212.00 UPB S11.050 bilancio regionale 2002.
81 Progetto Gestione Beni Culturali cit. Il Parco archeologico sorge su terreni di proprietà comunale. Comune di Seui, Attestazione Titolarità Museale, allegata alla Richiesta di contributo regionale per il progetto di gestione beni culturali del Comune di Seui, Rep. n. 4093 del 26 ottobre 2000
127
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
la loro apertura entro il 200382. Di fatto, solamente la Casa Farci è stata inaugura-ta in quell’anno, mentre la Casa Aresu-Loy e il Parco archeologico risultano ancora inagibili (2009) perché ancora oggetto di interventi di recupero83.
Una volta ricevuti i finanziamenti regionali, nell’aprile del 2002 il Comune indisse una nuova gara d’appalto per la gestione dell’insieme dei beni culturali inseriti nel progetto triennale; l’appalto si era reso necessario proprio in segui-to alla previsione di implementazione del patrimonio locale con l’inserimen-to delle nuove strutture musealizzate: il Parco Archeologico di Ardasay, la Casa Aresu-Loy e la Casa Farci84.
Il vincitore del bando fu la cooperativa S’Eremigu, che già dal 2000 gestiva la Palazzina Liberty, la Galleria Civica e il Carcere Spagnolo85. La durata della conces-sione del 2002 fu stabilita in nove mesi, ma il Capitolato d’appalto prevedeva che il Comune potesse prorogare il contratto di gestione qualora il progetto avesse continuato a beneficiare dei finanziamenti regionali86. Poiché tuttora S’Eremigu si occupa del Percorso Museale siamo autorizzati a supporre che il Comune di Seui abbia realmente usufruito di tale diritto rinnovando fino a oggi la concessione a questa cooperativa.
Secondo il piano di gestione triennale elaborato dal Comune nell’autunno del 2000 dunque, l’offerta culturale sehuiense da gestire unitariamente avrebbe compreso alcune strutture musealizzate collocate all’interno del paese e nume-rose aree archeologiche incluse in un parco tematico posto a poca distanza dal centro abitato.
Dato che, fatta eccezione per il Parco Archeologico di Ardasay, tutti i beni in-seriti nel progetto insistono nel centro storico cittadino, caratterizzato peraltro dalla presenza di tipiche case in pietra scistosa con balconcini in ferro battuto e porte in legno intagliato, l’offerta culturale del Comune di Seui si configu-ra, per sua natura, come una sorta di itinerario che coinvolge, oltre alle citate
82 Ibidem.83 Seui, si inaugura oggi la Casa Farci, «L’Unione Sarda», 26 luglio 2003; informazione for-
nitaci dalla cooperativa S’Eremigu, tramite comunicazione scritta in data 1 settembre 2009.
84 Determinazione del Responsabile Settore Socio-Culturale del Comune di Seui n. 64 del 19 aprile 2002, Indizione asta pubblica per la gestione dei beni culturali del Comune di Seui; Progetto Gestione Beni Culturali cit.
85 Determinazione del Responsabile Settore Socio-Culturale del Comune di Seui n. 104 del 12 giugno 2002, Approvazione verbale di aggiudicazione asta pubblica per l’affidamento del servizio di gestione dei Beni Culturali del Comune di Seui. Progetto Gestione Beni Cultu-rali cit.
86 Capitolato Speciale per l’affidamento del servizio di gestione integrata Itinerario Turistico Culturale, approvato con Determinazione Comunale del Comune di Seui n. 64 del 2002 cit., art. 2; LR n. 4 del 2000 cit.
128
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
strutture musealizzate, anche il nucleo abitato più antico del paese. Pertanto, nel 2003, in occasione dell’inaugurazione della Casa Farci, il Comune ha deciso di congiungere in un percorso unitario musei e centro storico, denominandolo Percorso Monumentale87.
Il Percorso Monumentale di Seui si articola attorno alla cosiddetta Palazzina Liberty, poiché è da qui che parte la visita all’intero circuito museale, e qui si trovano la biglietteria, il punto di consultazione per disabili e gli uffici ammini-strativi dell’intero Percorso.
La Palazzina è un’abitazione privata dei primi del Novecento, successiva-mente adibita a sede della Società Mineraria Monteponi ossia il gestore, nel pri-mo trentennio del XX secolo, della miniera di antracite presente in territorio di Seui. In seguito, e più precisamente a partire dagli anni Trenta, lo stesso palazzo ha ospitato gli uffici del Comune88. Il principale interesse storico-artistico della Palazzina consiste nella presenza di decorazioni Art Déco che ben testimoniano l’influenza culturale esercitata dagli ingegneri francesi presenti a Seui nei pri-mi anni del Novecento impiegati nella vicina miniera, attualmente in stato di abbandono89.
Oggi la struttura è sede del Museo della civiltà contadina, pastorale, artigianale, della miniera e dell’emigrante, articolato in quattro ambienti tematici − archeo-logico, storico, documentario e civico − nei quali sono allestiti i reperti che ri-percorrono le vicende storiche e culturali della comunità sehuiense. Al piano terra, la prima sala accoglie una piccola sezione archeologica che testimonia la presenza antropica sul territorio di Seui a partire dall’epoca nuragica fino al Medioevo; la seconda e terza sala contengono invece materiali relativi all’atti-vità estrattiva del locale giacimento di antracite, rimasto in attività sino al 1964. La visita al Museo permette, tra l’altro, di ammirare una collezione di oggetti relativi al lavoro minerario, che ne ricostruisce la difficoltà e la pericolosità. Al primo piano dell’edificio è invece ospitata la sezione civica consistente in una collezione di foto che ritraggono personaggi storici e scorci del paese; tale se-zione è completata dalla ricostruzione museale di un autentico studio notarile ottocentesco90.
Il circuito di visita al Percorso monumentale prosegue con il Carcere Spagnolo, in funzione dal 1647 al 1975, edificato nel XVII secolo, durante la dominazione
87 Informazione fornitaci dalla cooperativa S’Eremigu, tramite comunicazione scritta in data 1 settembre 2009.
88 Sito web ufficiale del Percorso Museale Monumentale Sehuiense all’indirizzo <http://www.museiseui.eu>.
89 Ivi.90 Seui, Palazzina Liberty, consultabile sul sito web Sardegna Cultura all’indirizzo
<http://www.sardegnacultura.it>.
129
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
spagnola dell’Isola; la struttura contiene attualmente una collezione etnografi-ca riguardante la storia dell’amministrazione della giustizia in quest’area della Sardegna, denominata Barbagia di Seulo91. All’interno del Carcere sono stati ri-allestiti alcuni ambienti originari, suddivisi in struttura abitativa – composta dalla cucina, dalla camera da letto del carceriere e dallo statu farzu, ossia il sot-totetto, utilizzato come ripostiglio – e in parte detentiva, comprendente l’ufficio del carceriere, la cella femminile, la cella di rigore e la cella maschile.
La visita a questi locali, completata dalla presenza di una sezione documen-taria relativa al trasporto dei prigionieri verso altri centri di reclusione sardi, consente al fruitore di ricostruire le dure condizioni di vita di guardie e dete-nuti.
Un altro bene inserito all’interno del Percorso Museale è la Galleria Civica, articolata in quattro sale nelle quali sono conservate tele, acquarelli e pitture riferibili a un arco cronologico compreso tra il XVII e il XX secolo. La Galleria è inoltre sede del concorso annuale di pittura e di scultura promosso dall’Ammi-nistrazione comunale e rivolto a giovani artisti, non solo sardi92.
La Casa Farci è invece la dimora natale, musealizzata, dello scrittore e politi-co Filiberto Farci, amico intimo di Emilio Lussu e cofondatore del Partito Sardo d’Azione93. Ai piani inferiori della casa-museo – ossia il piano terra, il semin-terrato e la cantina – è stata allestita una sezione prettamente etnografica nella quale vengono esposti gli strumenti rappresentativi delle arti e dei mestieri.
La Casa Aresu-Loy è interessante soprattutto dal punto di vista architettoni-co perché conserva uno degli ormai rari esempi di balconata pensile del XVII secolo94. Attualmente la Casa è chiusa al pubblico perché oggetto di lavori di restauro ma il progetto comunale del 2001 prevede la sua trasformazione in «centro didattico museale»95.
91 Sito web ufficiale del Percorso Museale Monumentale Sehuiense all’indirizzo <http://www.museiseui.eu>. Seui, Carcere Spagnolo, consultabile sul portale culturale della Regione Sardegna all’indirizzo <http://www.sardegnacultura.it>.
92 Sito web ufficiale del Percorso Museale Monumentale Sehuiense all’indirizzo <http://www.museiseui.eu>.
93 La casa-museo è organizzata su quattro livelli: al primo piano si possono visitare lo studio e la biblioteca, dove ancora oggi si conservano i libri appartenuti a Farci e la sua corrispondenza con importanti esponenti della letteratura del Novecento come Grazia Deledda e Sebastiano Satta. Segue la cucina, la camera da letto e una sezione dedicata ai costumi. Si veda il sito web ufficiale del Percorso Museale Monumentale Sehuiense all’indirizzo <http://www.museiseui.eu>.
94 Ivi.95 Progetto Gestione Beni Culturali cit. approvato con DGC di Seui n. 63 del 2000 cit. Informazione
fornitaci dalla cooperativa S’Eremigu, tramite comunicazione scritta in data 1 settembre 2009.
130
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Il Parco Archeologico di Ardasay, esterno al centro storico cittadino ma sito a poca distanza, completa la visita al Percorso Museale ed è composto dall’o-monimo nuraghe monotorre, del quale si conserva parte della torre con scala elicoidale, e da alcuni monumenti di epoca pre-protostorica insistenti nelle sue vicinanze, come tombe dei giganti e pozzi sacri96.
Poiché il centro abitato di Seui, posto nell’entroterra sardo, è estraneo ai normali flussi turistici che interessano, soprattutto in periodo estivo, le località balneari dell’Isola, l’Amministrazione comunale e il personale della coopera-tiva S’Eremigu si sono impegnati ad avviare alcune iniziative per promuovere l’offerta culturale.
La visibilità del Percorso Museale Monumentale Sehuiense è infatti garantita dall’esistenza di un apposito sito internet, dalla diffusione di materiale pubbli-citario cartaceo e dall’organizzazione di eventi culturali di varia natura, tra cui si annovera l’annuale Concorso d’Arte e Pittura del Comune di Seui rivolto ai giovani artisti, non solo isolani97.
A partire dal 2005 inoltre il Percorso ha incrementato la sua potenzialità di attrazione grazie all’inserimento del Comune di Seui tra le diverse tappe dell’itinerario effettuato dal Trenino Verde, un servizio turistico offerto dalle Ferrovie della Sardegna che consente ai visitatori di accedere ad alcune aree dell’entroterra sardo98.
Per realizzare le attività del Percorso, il Comune utilizza dal 2001 due tipi di introiti: i contributi regionali assegnati sulla base della legge regionale 4/2000 e le risorse garantite da bigliettazione, bookshop e organizzazione di eventi99. Per quanto riguarda i proventi inerenti la vendita dei biglietti il Capitolato del 2002 stabilisce che questi siano a totale beneficio del Comune, così come quelli relativi alla vendita di cataloghi e gadget; qualora però questi oggetti siano realizzati a spese del gestore i relativi guadagni risultano essere di pertinen-za di quest’ultimo100. A occuparsi della gestione del Percorso e dei relativi beni
96 Sito web ufficiale del Percorso Museale Monumentale Sehuiense all’indirizzo <http://www.museiseui.eu>.
97 Sito web ufficiale del Percorso Museale Monumentale Sehuiense all’indirizzo <http://www.museiseui.eu>.
98 Sito web ufficiale dell’iniziativa Trenino Verde all’indirizzo <http://www.turismo.ogliastra.it>.
99 LR n. 4 del 2000 cit.; DGR n. 36/6 del 2000 cit., n. 36/32 del 2001 cit. e n. 39/52 del 10 dicembre 2002, L.R. 4/2000. Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali. 1° Programma. Annualità 2002. Cap. 11212.00 UPB S11.050 bilancio regionale 2002. Capitolato Speciale per l’affidamento del servizio di gestione integrata Itinerario Turistico Culturale approvato con Determinazione Comunale del Comune di Seui n. 64 del 19 aprile 2002.
100 Capitolato Speciale cit. approvato con Determinazione Comunale del Comune di Seui
131
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
è, dal 2002, la cooperativa S’Eremigu, vincitrice del bando di gara emesso dal Comune per l’appalto della gestione dell’insieme delle strutture101. La coopera-tiva gestisce le strutture musealizzate fruibili del Percorso Museale Monumentale Sehuiense assicurando l’esercizio dei seguenti servizi102: visite guidate, promo-zione di attività espositive, realizzazione di manifestazioni culturali, gestione biglietteria e bookshop, manutenzione ordinaria e pulizia quotidiana delle strutture afferenti al Percorso e delle aree verdi annesse al Parco archeologico103. Il Comune concede alla cooperativa S’Eremigu anche la possibilità di affittare gli spazi all’aperto antistanti l’area archeologica di Ardasay per lo svolgimento di spettacoli e analoghe attività; in questo caso i profitti sono a totale favore della cooperativa che però ha l’obbligo di presentare opportuna rendicontazione dei costi e dei ricavi104.
Nel Capitolato è prevista anche l’opportunità per la ditta di organizzare manifestazioni culturali di propria iniziativa e a proprie spese, sentito il pa-rere favorevole dell’Amministrazione comunale; i guadagni relativi sono però a favore della ditta105. Il Comune di Seui concedendo al gestore la possibilità di utilizzare le strutture di sua proprietà afferenti al Percorso ha voluto offrire a S’Eremigu la possibilità di creare occasioni di guadagno sperando in questo modo di riuscire a sviluppare il carattere imprenditoriale dello stesso progetto di gestione.
Nella prima fase di attività di quest’esperienza, il Comune aveva provvedu-to ad avviare una bigliettazione congiunta che prevedeva più opzioni di visita a seconda degli interessi del fruitore: all’interno del Percorso era infatti possibile acquistare o un biglietto unico che permetteva l’ingresso a tutti i beni afferenti al progetto o un biglietto cumulativo che consentiva l’accesso a un gruppo for-mato da tre, due o una struttura a scelta106. Nel corso del 2009 però la biglietta-zione relativa al Percorso è stata modificata prevedendo un unico biglietto che include la visita all’intero circuito museale107.
n. 64 del 2002 cit., art. 8 comma C e art. 9 comma 4.101 Determinazione del Responsabile Settore Socio-Culturale del Comune di Seui n. 104
del 12 giugno 2002, Approvazione verbale di aggiudicazione asta pubblica per l’affidamento del servizio di gestione dei Beni Culturali del Comune di Seui. Progetto Gestione Beni Cultu-rali cit.
102 Determinazione Comunale del Comune di Seui n. 104 del 2002 cit. 103 Capitolato Speciale cit. approvato con Determinazione Comunale del Comune di Seui
n. 64 del 2002 cit., artt. 1, 3, 4.104 Ivi, art. 9 comma 5.105 Ivi, art. 9 comma 3.106 DGC di Seui n. 73 del 14 novembre 2003, Adeguamento Tariffe Museo Storico Etnografico.107 Informazione fornitaci dalla cooperativa S’Eremigu, tramite comunicazione scritta in
data 1 settembre 2009.
132
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Al fine di garantire il funzionamento del progetto di gestione unitaria, l’Am-ministrazione comunale ha provveduto a definire nel menzionato Capitolato le figure professionali che debbono operare all’interno del Percorso: un coor-dinatore part-time con funzioni di responsabilità e coordinamento dell’intero servizio, due accompagnatori full-time con mansioni di guida turistica, quat-tro custodi manutentori full-time con compiti di custodi e operai semplici108. L’appalto prevede inoltre che sia un responsabile della cooperativa a occuparsi sia della direzione del servizio di gestione sia del coordinamento delle attività svolte nelle strutture afferenti al progetto109.
La puntuale definizione di tali figure professionali risulta del resto subordi-nata alle direttive espresse dalla Regione nella delibera di attuazione relativa alla legge regionale 4/2000: in questo documento si specificava infatti che, per poter beneficiare delle risorse economiche regionali, gli Enti locali avrebbero dovuto impiegare personale qualificato nei servizi previsti dai rispettivi pro-getti triennali di gestione110.
Il Percorso Museale Monumentale Sehuiense rappresenta un esempio di come gli Enti locali sardi abbiano risposto alle direttive regionali prodotte all’inizio degli anni Duemila con l’emanazione della legge regionale 4/2000, che ha avu-to lo scopo di regolare l’attribuzione di risorse economiche alle Amministra-zioni locali, obbligando queste ultime all’individuazione di prassi gestionali più razionali per il proprio patrimonio culturale. Grazie alle direttive elaborate a seguito della legge del 2000 che gli enti locali hanno dovuto, per esempio, pianificare la gestione dei propri musei e delle aree archeologiche mediante programmi triennali e occuparsi dell’attivazione della bigliettazione111.
Con la legge regionale 4/2000 la Regione si poneva inoltre l’obiettivo di ri-uscire ad avviare una forma gestionale di tipo imprenditoriale del patrimo-nio culturale locale; per questo motivo, nella delibera attuativa alla norma del 2000 si precisava che a partire dal secondo triennio sarebbero stati rifinanziati esclusivamente progetti che avessero dimostrato «capacità imprenditoriali» at-traverso l’incremento delle attività e dei servizi offerti e, di conseguenza, dei rispettivi introiti112. Questa volontà regionale spiega bene la prassi di concedere
108 Capitolato Speciale cit. approvato con Determinazione Comunale del Comune di Seui n. 64 del 2002 cit., art. 8 comma A. Le funzioni attribuite ai manutentori sono quelle di guardiania, pulizia e manutenzione.
109 Ivi, art. 8 comma B.110 DGR n. 36/6 del 2000 cit.; LR n. 4 del 2000 cit.111 LR n. 4 del 2000 cit.; DGR n. 36/6 del 2000 cit.112 LR n. 4 del 2000 cit.; DGR n. 36/6 del 2000 cit.
133
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
alla cooperativa S’Eremigu non solo l’autorizzazione per avviare di sua inizia-tiva alcune attività ma anche la possibilità di usufruire dei relativi guadagni113.
Nello specifico caso di Seui, la volontà di una gestione unitaria del patrimo-nio museale comunale ha preceduto di alcuni mesi l’emanazione della citata legge regionale 4/2000, dato che la progettazione di una gestione congiunta fu elaborata dal Comune nel febbraio 2000 e attuata nell’estate dello stesso anno114; pertanto i finanziamenti ottenuti con la legge regionale 4/2000 e le disposizioni contenute nella relativa delibera di attuazione hanno permesso l’implementa-zione delle strutture da annettere alla gestione congiunta e un miglioramento di quest’ultima, mediante la definizione delle figure professionali da impiegare.
Tra gli elementi di validità riscontrabili nel Percorso Museale Monumentale Sehuiense c’è l’idea di connettere il centro storico al “sistema” dei musei: la cre-azione di un percorso sembra avere un effetto positivo per la valorizzazione dell’abitato storico della cittadina poiché anche le singole costruzioni vengono considerate come parte importante e integrante del patrimonio culturale locale.
Da segnalare infine l’impegno con cui sia gli operatori di S’Eremigu sia l’Am-ministrazione comunale si adoperano per rendere maggiormente attrattivo il Percorso Monumentale, mediante ad esempio il sito internet e la partecipazione a eventi e servizi turistici diffusi anche a livello regionale, come nel caso del men-zionato Trenino Verde115. Il Comune di Seui è posto al centro dell’Isola, nell’area denominata Barbagia di Seulo, e dunque non beneficia della visibilità concessa dalla vicinanza alle località costiere, maggiormente interessate dai flussi turi-stici. Tra gli aspetti positivi prodotti dal progetto si deve annoverare poi il con-tributo che questo ha dato allo sviluppo occupazionale di questo piccolo centro dell’entroterra; l’avvio del Percorso ha coinciso con l’impiego di sette giovani del paese occupati nella cooperativa S’Eremigu che gestisce le strutture muse-alizzate coinvolte nell’itinerario. L’apporto dato dalla gestione del patrimonio locale alla crescita economica e sociale di questa comunità è ulteriormente con-fermato dalle numerose attività connesse al Percorso, come il concorso annuale di scultura e pittura e le diverse manifestazioni culturali, che richiamano in paese i visitatori in diversi periodi dell’anno, contribuendo così allo sviluppo delle attività commerciali e ricettive.
113 Capitolato Speciale cit. approvato con Determinazione Comunale del Comune di Seui n. 64 del 2002 cit.
114 Progetto Gestione Beni Culturali cit. approvato con DGC di Seui n. 63 del 2000 cit.115 Sito web ufficiale del Percorso Museale Monumentale Sehuiense all’indirizzo <http://
www.museiseui>. Sito web ufficiale dell’iniziativa Trenino Verde all’indirizzo <http://www.turismo.ogliastra.it>.
134
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
3 Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna [Deligia]
Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, istituito nel 2001 con decreto del Ministero dell’Ambiente – in concerto con i Ministri delle Attività produttive, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e d’intesa con la Re-gione Sardegna – è un progetto promosso dalla Regione Sardegna, da alcuni enti locali e associazioni al fine di riuscire a conservare e rendere fruibile il patrimonio minerario, geologico, ambientale e storico delle aree della Sardegna caratterizzate da una lunga tradizione di attività estrattiva116.
Sebbene la sua istituzione sia avvenuta nel 2001, la storia del Parco Geomine-rario ha inizio negli anni Settanta, quando si manifestarono le prime avvisaglie di quella crisi del settore estrattivo che nel giro di un ventennio avrebbe portato alla chiusura delle miniere sarde117.
Gli effetti negativi della crisi si ripercossero su tutto il territorio regionale, ma furono molto più drammatici per quelle aree dell’Isola, e per le relative comunità, che su questo tipo di attività basavano la propria economia. Fin da-gli anni Settanta, a livello locale e nazionale, vi fu l’urgenza di affrontare le conseguenze della crisi del settore minerario e di trovare soluzioni appropriate sia per la bonifica e il recupero dei siti minerari che venivano progressivamente dismessi, sia per la rioccupazione degli ex lavoratori118. In quegli anni alcuni esponenti del mondo accademico e delle società minerarie iniziarono a prospet-tare l’eventualità di trovare una risposta alla crisi che permettesse di superare i relativi disagi sociali e di riconvertire un settore ormai improduttivo. Il primo intervento in questo senso risale al 1971, quando l’allora Presidente dell’EGAM (Ente Gestione Attività Minerarie), in occasione di un discorso pubblico a Iglesias, sottolineò l’urgenza di dover iniziare a pensare ad un «dopo miniera» ovvero a forme di recupero e di riuso per gli impianti estrattivi, destinati inesorabilmen-te alla cessazione della loro attività119.
È allora che in Sardegna comincia a svilupparsi l’idea di una riconversione in chiave turistica delle aree minerarie dismesse: tale ipotesi, infatti, dava una risposta concreta sia al problema del ripristino ambientale dei complessi mine-rari abbandonati sia alla necessità di reimpiegare gli ex minatori. Dato che la
116 DM dell’Ambiente del 16 ottobre 2001, Istituzione del Parco Geominerario Storico ed Am-bientale della Sardegna. Sul Parco si veda anche G. pInna, Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in Sistemi museali e musei in Sardegna cit. 2012, pp. 115-120.
117 DM dell’Ambiente del 16 ottobre 2001 cit.118 Intervista a Giampiero Pinna, ex presidente EMSA e commissario del Parco Geomine-
rario, pubblicata sul sito web Miniere di Sardegna, all’indirizzo <http://www.miniere-disardegna.it>.
119 Ivi.
135
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
maggior parte di questi siti si trovava lontana dalla costa e dai maggiori centri balneari, i primi fautori della riconversione pensarono di realizzare un’offerta turistica originale, che integrasse l’ambiente naturale con i siti e i villaggi mi-nerari120.
Contemporaneamente, agli inizi degli anni Settanta, si assiste a una maggio-re attenzione per il patrimonio naturale e per la sua tutela e vengono avanzate le prime proposte per la protezione dell’ambiente in ambito sardo, promos-se soprattutto dal mondo scientifico ed accademico. Nel 1971, ad esempio, la professoressa Franca Valsecchi dell’Università di Sassari pubblicò sul Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali un contributo dal titolo Aree di rispetto bota-nico in Sardegna, nel quale per la prima volta veniva esposto in forma organica il problema della protezione della vegetazione nell’Isola121.
Sempre nel 1971, e successivamente nel 1979, la Società Botanica Italiana, at-traverso il Gruppo di lavoro per la Conservazione della Natura, realizzò il Censimen-to dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale e meritevoli di conservazione in Italia: nel testo furono registrate e descritte sinteticamente ben 57 aree distribuite nel territorio isolano, suggerendo anche una forma di protezione per l’area del Sul-cis-Iglesiente-Guspinese dove erano stati individuati quattro differenti biotopi da tutelare per le loro peculiari caratteristiche122.
Nel 1973 fu pubblicata invece la Proposta per un sistema di Parchi e Riserve Naturali in Sardegna nella quale i due autori, Cassola e Tassi, indicavano alcune aree della Sardegna da tutelare per le particolarità storico-ambientali, come il parco naturale del Monte Arcuentu e Foce del Rio Piscinas, le riserve naturali di Capo Frasca, le Dune di Buggerru, la costa tra Buggerru e Nebida, il Monte Linas, Oridda e Marganai123. Due anni più tardi, nel 1975, anche sulla scorta della proposta di Cassola e Tassi, il Centro Regionale di Programmazione «esaminò la possibilità di istituire un sistema di parchi e riserve naturali in tutta l’Isola» proponendo la realizzazione di sette parchi regionali; lo studio del Centro Regio-nale di Programmazione si concludeva con una bozza di legge quadro regionale e una bozza di legge per l’istituzione di singoli parchi124.
Nello stesso 1975 Fabio Cassola, già autore della Proposta del 1973, presen-
120 Ivi.121 a. caraManda - a. coSSu (a cura di), Società Botanica Sarda, Biotopi di Sardegna, guida a
dodici aree di rilevante interesse botanico, Sassari, Carlo Delfino Editore 1988.122 Ivi. AA.VV., Il Parco geominerario, ambientale e storico dell’Iglesiente-Sulcis-Guspinese, in
La Sardegna nel mondo mediterraneo (IV convegno Sassari - Alghero 1993), Bologna 1995, pp. 370-422.
123 Ivi. F. caSSola, F. taSSI, Proposta per un sistema di parchi e di riserve naturali in Sardegna, in «Bollettino Società Sarda Scientifica Naturale», Cagliari 1973.
124 Società Botanica Sarda cit., p. 171; AA.VV., Il Parco geominerario cit.
136
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
tò al convegno delle Associazioni culturali e naturalistiche tenutosi quell’anno a Iglesias, il progetto di creare un Consorzio di gestione tra enti territoriali, associazioni, università e Azienda forestale, per «la riserva naturale generale di Monte Linas, Oridda e Marganai»; in quella medesima circostanza Cassola espresse la necessità di creare un programma esemplificativo di interventi per la realizzazione e il regolamento dell’uso degli accessi, dei percorsi escursioni-stici e delle attrezzature di supporto alla visita del futuro parco125.
Mentre a livello locale si proponevano progetti per la creazione di parchi naturali, il Governo nazionale cercò invece di trovare soluzioni adatte a salvare l’industria mineraria; a tale scopo lo Stato promosse, alla fine degli anni Settan-ta, un massiccio intervento di modernizzazione del settore nella convinzione che la razionalizzazione dell’attività estrattiva fosse l’unica via possibile per riuscire ad allungare la vita delle miniere126.
Si procedette dunque ad una ristrutturazione generale del settore minera-rio nazionale tesa a rendere più funzionale tale produzione: in primo luogo si provvide a sciogliere l’EGAM (Ente Gestione Attività Minerarie) e a suddividere le sue attività fra le altre società statali, così da riuscire ad organizzare ogni settore singolarmente al fine di renderli sinergici fra loro. Le miniere sarde ven-nero così affidate all’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) e quest’ultima istituì a sua volta la società SAMIM (Società Azionaria Mineraria-Metallurgica) che, dal 1978 al 1987, operò alla modernizzazione del settore, cercando di potenziare l’attivi-tà produttiva sarda, anche approfittando della chiusura di tutte le miniere della Penisola127. Sebbene quelle sarde fossero le uniche miniere di metalli non ferrosi e di carbone rimaste attive sul territorio nazionale, la produzione estrattiva iso-lana non riuscì comunque a superare la crisi e anzi il numero dei licenziamenti aumentò a causa del processo di meccanizzazione del settore128.
Poiché la strategia di riorganizzazione dell’attività mineraria attuata a livel-lo nazionale non dava i risultati sperati, i fautori della necessità di riconverti-re le aree dismesse continuarono a portare avanti il loro progetto e nel 1983, in occasione di un convegno sull’archeologia industriale mineraria tenutosi a Iglesias, fu presentata da Gianlupo Del Bono (Servizio Geologico Nazionale) la proposta di creare un parco minerario e paleoindustriale dell’Iglesiente, sugge-
125 p. M. caStellI, e. pIntuS, Storia della costruzione del Parco Geominerario Storico ed Am-bientale della Sardegna e Ruolo dell’Associazione Onlus per il Parco Geominerario Storico ed Ambientale, s.l., 2005, p. 4; AA.VV. Il Parco Geominerario cit., pp. 370-422.
126 Informazione fornitaci da Giampiero Pinna, ex Presidente dell’EMSA e primo Com-missario Straordinario del Parco, mediante nota scritta in data 3 novembre 2009.
127 Intervista a Sandro Putzolu, ex direttore di diverse miniere, pubblicata sul sito web Miniere di Sardegna, all’indirizzo <http://www.minieredisardegna.it>.
128 Ivi.
137
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
rendo anche l’eventualità d’inserirlo all’interno del programma UNESCO Man and Biosphere (MAB)129.
Qualche anno più tardi, il primo maggio 1987, Legambiente ed alcune orga-nizzazioni sindacali promossero una manifestazione popolare al villaggio mi-nerario abbandonato di Arenas, presso Fluminimaggiore, allo scopo di attrarre l’opinione pubblica sulla necessità di creare un parco minerario, inteso come unica possibilità di sviluppo per i territori e le comunità coinvolte dalla crisi del settore estrattivo130. Gli anni Ottanta si chiudono con un importante inter-vento regionale a favore della realizzazione di parchi naturali: il 7 giugno 1989 la Regione emanò la legge n. 31 recante disposizioni che regolano l’istituzione e la gestione di «parchi, riserve naturali, aree di particolare interesse ambientale e monumenti naturali» al fine di conservare il patrimonio biologico e paesaggi-stico dell’Isola131. Con questa norma la Regione ha provveduto a fornire in pri-mo luogo una definizione di parchi, riserve e monumenti naturali, insistendo sulla necessità di tutelare le aree caratterizzate da valori «naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici»132.
La legge n. 31 del 1989 venne emanata in un momento decisivo della storia del Parco perché proprio in questi anni il susseguirsi di alcuni avvenimenti, primo fra tutti l’esaurimento del giacimento Marx ad Acquaresi, accrebbero la speranza tra i sostenitori del Parco che la sua istituzione fosse ormai prossima. È dunque in questo contesto che si inserisce la nascita, sempre nel 1989, di un Comitato promotore del Parco, dotatosi nel luglio 1991 di un proprio Statuto133.
L’aspettativa per la realizzazione del parco venne in parte confermata anche dalle azioni del Governo nazionale che, nel 1990, legiferò in materia di ricon-versione del settore minerario sardo; la legge nazionale n. 221 del 1990, forte-mente voluta dai parlamentari sardi, introduceva per la prima volta il concetto delle attività sostitutive, e quindi il sostegno economico alle attività, alternative
129 p. M. caStellI, e. pIntuS, Storia della costruzione del Parco cit., pp. 370-422.130 Informazione fornitaci da Giampiero Pinna, ex Presidente dell’EMSA e primo Com-
missario Straordinario del Parco, mediante nota scritta in data 3 novembre 2009.131 LR n. 31 del 7 giugno 1989, Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e
dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambienta-le.
132 Ivi. Dei nove parchi regionali previsti dalla suddetta legge, al 2009 ne sono stati re-alizzati solamente due: il Parco di Porto Conte-Capo Caccia in Provincia di Sassari e il Parco di Molentargius-Saline in Provincia di Cagliari.
133 Intervista a Giampiero Pinna, ex presidente EMSA e commissario del Parco geomine-rario, pubblicata sul sito Miniere di Sardegna all’indirizzo <http://www.minieredisar-degna.it>; p. M. caStellI, e. pIntuS, Storia della costruzione del Parco cit., pp. 370-422.
138
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
a quelle minerarie, avviate nei territori interessati da bacini estrattivi colpiti dalla crisi134.
Nell’autunno del 1991 il coinvolgimento sempre più ampio dell’opinione pubblica determinò l’istituzione ufficiale di un’associazione denominata Comi-tato Permanente per il Parco Geominerario, Ambientale e Storico dell’Iglesiente, con sede legale a Iglesias presso la Società Mineraria Sarda, i cui obiettivi erano la salvaguardia, la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale connesso all’attività mineraria, lo sviluppo economico e sociale delle aree colpite dalla crisi ed, infine, la creazione di proficui rapporti di scambio culturale e scienti-fico fra le comunità di quelle regioni mediterranee che in passato avevano par-tecipato alle attività di studio e coltivazione dei giacimenti minerari di questo territorio dell’Isola135.
La prima iniziativa importante promossa dai membri del Comitato Perma-nente fu la preparazione di un intervento collettivo al convegno La Sardegna nel Mondo Mediterraneo, tenutosi ad Alghero nell’aprile del 1993.136 Il progetto presentato in quest’occasione riguardava la creazione del Parco Geominerario dell’Iglesiente-Sulcis-Guspinese, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione del «patrimonio minerario, geologico, ambientale e storico dell’Iglesiente»; il progetto dunque oltre a individuare alcuni interventi volti alla tutela del patri-monio ambientale, come la definizione di aree di «riserva integrale», ipotizzava la riconversione in chiave turistica degli antichi «percorsi meccanizzati» (de-cauville, ascensori, scivoli, etc.) e dei villaggi minerari in stato di abbandono137. Tra i vari interventi contemplati nel progetto era inserita anche la creazione di un sistema museale formato da «musei satellite» locali articolati attorno ad un «museo guida», individuato in quello dell’Istituto Minerario Sardo a Iglesias138.
134 L n. 221 del 30 luglio 1990, Nuove Norme per l’attuazione della politica mineraria, art. 7 comma 1, «Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell’attività mineraria divenuta antieconomica, […] ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei Comu-ni sui quali insiste l’attività mineraria o nei Comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, […] contributi in conto capitale fino al 25% dell’investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità, da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore».
135 AA.VV. Il Parco Geominerario, cit., pp. 369-422; p. M. caStellI, e. pIntuS, Storia della costruzione del Parco cit. pp. 10-15.
136 AA.VV. Il Parco Geominerario, cit., pp. 369-422.137 Ivi.138 Ivi.
139
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
La visita a queste strutture museali prevedeva una serie di sentieri ove avreb-bero potuto essere collocati alcuni cartelli indicatori, schemi esplicativi e punti di osservazione139.
Sempre nei primi anni Novanta, l’Eni decise di abbandonare la gestione plu-ridecennale delle miniere sarde per dedicarsi esclusivamente all’attività petro-lifera; all’azienda statale dunque succedette la Regione Sardegna che da quel momento si mise a capo dell’attività estrattiva isolana, tramite l’Ente Minerario Sardo (EMSA)140. A seguito dell’ingresso regionale nel settore minerario appar-ve immediatamente evidente l’inutilità di mantenere in attività tali impianti perché economicamente svantaggioso; di conseguenza la Regione fu obbligata a trovare una soluzione concreta al problema della rioccupazione degli ex la-voratori del settore estrattivo141. Per definire un quadro generale ed esausti-vo del problema, l’Ente regionale si adoperò in primo luogo per avviare un censimento del patrimonio minerario da quel momento di sua competenza. In questi anni la Regione promulgò due leggi specifiche. La legge regionale n. 38 del 1993, che istituiva una commissione speciale incaricata di verificare la consistenza e gli aspetti gestionali del «patrimonio minerario della Sardegna e del patrimonio già dismesso da attività mineraria», e la legge regionale n. 29 del 1994, indirizzata alla riqualificazione e alla conservazione del patrimonio di archeologia industriale142. Quest’ultima norma ebbe come obiettivo il censi-mento, la catalogazione e l’«organizzazione in strutture museali del patrimonio archeologico-industriale»143. Le due leggi regionali appaiono strettamente con-nesse perché il censimento del patrimonio minerario disposto e regolato dalla norma del 1993 è stata la naturale premessa agli interventi di riqualificazione previsti dalla legge del 1994144.
Contemporaneamente si ebbe nel 1993 l’emanazione della legge nazionale n. 204 del 23 giugno che finanziava Interventi urgenti a favore del settore minerario
139 Ivi.140 Intervista a Giampiero Pinna, ex presidente EMSA e commissario del Parco geomine-
rario, pubblicata sul sito Miniere di Sardegna all’indirizzo <http://www.minieredisar-degna.it>.
141 Intervista a Sandro Mezzolani, esperto di archeologia mineraria, pubblicata sul sito Miniere di Sardegna all’indirizzo <http://www.minieredisardegna.it>.
142 LR n. 38 del 10 settembre 1993, Istituzione di una Commissione speciale per una indagine conoscitiva sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio minerario della Regione. LR n. 29 del 9 giugno 1994, Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Sardegna.
143 LR n. 29 del 1994 cit., art. 1.144 LR n. 38 del 1993 cit.; LR n. 29 del 1994 cit.
140
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
della Sardegna, finalizzati a favorire la ripresa economica e occupazionale nelle aree interessate dalla cessazione dell’attività estrattiva145.
In forza anche delle opportunità messe a disposizione dalla recente normati-va, nel 1996 il Comitato Permanente per il Parco partecipò al Convegno Internazio-nale per il Centenario dell’Associazione Mineraria Sarda ripresentando la proposta per la creazione del Parco; fu proprio in quest’occasione che l’Ente Minerario Sardo (EMSA) conobbe l’esistenza di questo progetto e iniziò a interessarsene direttamente146. L’appoggio organizzativo e finanziario garantito dalla parteci-pazione dell’EMSA permise ai promotori di diffondere la proposta del Parco an-che al di fuori dei confini regionali. In seguito quindi l’EMSA invitò i funzionari dell’UNESCO a visitare le aree minerarie del territorio del Sulcis-Iglesiente-Guspinese e prese contatto con i rappresentanti delle amministrazioni locali e regionali per discutere dell’idea di istituire il Parco147. Durante queste visite si discusse per la prima volta delle linee guida, dei contenuti e degli obiettivi del progetto per la creazione del futuro Parco Geominerario, arrivando alla decisione di estendere i suoi confini a tutte le aree minerarie dismesse della Sardegna così da superare i limiti geografici, ma anche politici, del comprensorio del Sulicis-Iglesiente-Guspinese148.
Grazie all’interessamento dell’EMSA dunque il progetto del Parco si trasfor-mò da locale a regionale e venne ampliato e migliorato in occasione della sua presentazione all’UNESCO149. Nei cinque volumi che componevano il relativo dossier, venivano definiti specificatamente i valori culturali e ambientali delle miniere, descrivendo singolarmente ognuna delle otto aree che avrebbero do-vuto costituire il Parco150.
La proposta per la realizzazione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna venne dunque ufficialmente presentata in occasione della Confe-renza Generale tenutasi a Parigi dal 24 ottobre al 12 novembre 1997. In risposta l’UNESCO decise di considerare il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della
145 L n. 204 del 23 giungo 1993, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 19 93 n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sarde-gna. Ecologia.
146 p. M. caStellI, e. pIntuS, Storia della costruzione del Parco cit. pp. 25-29.147 Informazione fornita da Giampiero Pinna, ex Presidente dell’EMSA e primo Com-
missario Straordinario del Parco, mediante nota scritta in data 3 novembre 2009.148 Ivi.149 reGIone autonoMa della SardeGna, Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sar-
degna. Sintesi del Dossier presentato all’UNESCO, s.l., 1998; 150 Informazione fornitaci da Giampiero Pinna, ex Presidente dell’EMSA e primo Com-
missario Straordinario del Parco, mediante nota scritta in data 3 novembre 2009; re-GIone autonoMa della SardeGna, Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sarde-gna, cit.
141
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Sardegna il primo “nodo” del Global Geoparks Network, appena istituito151.Il 30 luglio 1998, dopo la conclusione dei lavori di verifica di una Commis-
sione internazionale di esperti appositamente incaricata dall’UNESCO, fu sottoscritta a Parigi la dichiarazione ufficiale di riconoscimento del valore in-ternazionale del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna152. Tale ri-conoscimento venne sancito anche dalla cerimonia ufficiale tenutasi a Cagliari nel settembre dello stesso anno, durante la quale i rappresentanti del Governo Italiano, della Regione Autonoma della Sardegna, della Commissione Nazio-nale Italiana UNESCO, dell’EMSA, delle Università di Cagliari e Sassari fir-marono la cosiddetta Carta di Cagliari, un importante documento che definiva i principi del Parco e le finalità da perseguire per la «salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e paesaggistico-ambientale connesso alle vicende umane che hanno interessato le risorse geologiche e minerarie della Sardegna»153.
A seguito del prestigioso riconoscimento ottenuto a livello internazionale, la Regione Sardegna si adoperò, ancora attraverso l’Ente Minerario Sardo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità. Tale incarico venne affidato alla società regionale di ingegneria Progemisa154. L’elaborazione di detto studio si fondò sui risultati conseguiti nel cosiddetto “dossier UNESCO” e fu portata avanti in due distinte fasi: il primo stadio era finalizzato alla predisposizione della fattibili-tà giuridico-normativa, necessaria per poter disporre di una bozza di propo-sta legislativa che consentisse di definire la struttura e le modalità di gestione tecnica ed economica del Parco e delle sue attività. Il secondo era mirato alla stesura dello studio di fattibilità tecnico-economico155. Il menzionato studio di fattibilità venne presentato ufficialmente durante l’Assemblea generale dell’As-
151 p. M. caStellI, e. pIntuS, Storia della costruzione del Parco cit. pp. 25-26. In realtà la rete Unesco dei Geoparchi fu formalizzata solamente nel 2004 e il Parco Geominerario vi fu inserito solo nel 2007, dunque con netto ritardo rispetto al suo primo riconoscimento. Attualmente il Parco fa parte sia della Rete Europea dei Geoparchi, insieme ad altri 31 membri, che della Rete Mondiale dei Geoparchi, che annovera 55 partner. Parco firmato Unesco, «L’Unione Sarda», 6 novembre 1997; G. Manca, Il Geoparco è nella Rete Unesco. Ma ha rischiato l’esilio, «L’Unione Sarda», 25 ottobre 2007.
152 p. M. caStellI, e. pIntuS, Storia della costruzione del Parco cit., pp. 25-29.153 Carta di Cagliari, Cagliari 30 settembre 1998. p. M. caStellI, e. pIntuS, Storia della co-
struzione del Parco cit., pp. 28-30; G. pInna, Il Parco Geominerario della Sardegna, in Parco Geominerario della Sardegna. Problemi prospettive, Atti del Convegno (Orani 23 maggio 1998), s. l., s. d., pp. 5-15.
154 Parco geominerario, nasce il comitato, «L’Unione Sarda», 19 maggio 1998; Regione Auto-noma della Sardegna, Studio di fattibilità tecnico economico del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. Sintesi, s.l., s.d.
155 Regione Autonoma della Sardegna, Studio di fattibilità cit.
142
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
sociazione per il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, tenutasi a Iglesias il 1° luglio del 2000; sul finire dello stesso mese la proposta di istituire il Parco fu presentata in Parlamento ove però si arenò156. Per sbloccare questa situazione di stallo, il 5 novembre 2000 l’allora Consigliere Regionale Gianpiero Pinna occupò di sua iniziativa la galleria di Pozzo Sella nella vecchia miniera dismessa di Monteponi nel Comune di Iglesias; ebbe così inizio una grande mobilitazione che riportò il progetto del Parco all’attenzione degli organi go-vernativi nazionali157.
L’istituzione del Parco venne allora inclusa nella legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, al comma 10 dell’art. 114 Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale; la suddetta norma statuiva che, entro sessanta giorni dalla sua ema-nazione, il Parco Geominerario dovesse essere formalmente istituito con decreto del Ministero dell’Ambiente158. A causa di un disguido burocratico, dovuto a un vizio di forma riscontrato dalla Corte dei Conti nella prima stesura del decreto istitutivo, la formale istituzione del Parco Geominerario fu però ulteriormente ritardata di circa un anno. La nascita del Parco fu ufficialmente e definitivamen-te sancita con il Decreto Ministeriale del 16 ottobre 2001159.
Così come previsto nel Dossier UNESCO, il Decreto stabiliva che il Parco fos-se suddiviso in otto aree, scelte per le loro caratteristiche naturalistiche, geo-minerarie e per la presenza di un alto numero di testimonianze archeologiche. Attualmente costituiscono il Parco le seguenti aree: 1-Monte Arci, 2-Orani-Guz-zura-Sos Enattos, 3-Funtana Raminosa, 4-Argentiera-Nurra-Gallura, 5-Sarra-bus-Gerrei, 6-Iglesiente, 7-Guspinese-Arburese, 8-Sulcis160.
156 Informazione fornitaci da Giampiero Pinna, ex Presidente dell’EMSA e primo Com-missario Straordinario del Parco, mediante nota scritta in data 3 novembre 2009; L’e-redità nel parco dell’Unesco, «L’Unione Sarda», 31 luglio 2000.
157 Informazione fornitaci da Giampiero Pinna, ex Presidente dell’EMSA e primo Com-missario Straordinario del Parco, con nota scritta in data 3 novembre 2009; d. Maded-du, In miniera per far ripartire il Parco, «L’Unione Sarda», 6 novembre 2000.
158 L n. 388 del 23 dicembre 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-riennale dello Stato (legge finanziaria 2001); p. M. caStellI, e. pIntuS, Storia della costru-zione del Parco cit. , pp. 34-35.
159 DM dell’Ambiente del 16 ottobre 2001. Nello stesso anno, il Ministero dell’Ambiente, con Decreto n. 468 del 18 settembre 2001, Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”, individuò le aree del Sulcis-Iglesiente-Guspinese tra quelle di interesse nazionale ai fini della bonifica dei siti inquinati, assegnando alla Regione Sardegna un contributo economico annuale per una durata ventennale al fine di eseguire gli interventi di ripristino ambientale di tali aree.
160 Regione Autonoma della Sardegna, Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sar-degna. Sintesi del Dossier, cit. DM del 16 ottobre 2001 cit.
143
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Il decreto istitutivo prevede una norma temporanea che vieta all’interno del-le otto aree l’esercizio di tutte quelle attività che possono in qualche modo nuo-cere al territorio apportando trasformazioni o distruzioni, come ad esempio: la costruzione di nuovi edifici o la trasformazione di quelli esistenti, il campeggio al di fuori delle aree autorizzate e appositamente attrezzate, il danneggiamen-to dei beni e delle strutture sotterranee e superficiali161. Allo scopo di creare un percorso logico e cronologico che illustrasse nel migliore dei modi la storia mineraria sarda, queste aree sono state inoltre numerate progressivamente a se-conda delle loro peculiarità e delle vicende storiche; in tal modo si è voluto dare al visitatore la possibilità di ripercorrere cronologicamente la storia dell’attività mineraria sarda ricostruita mediante le relative attestazioni presenti nel territo-rio dall’Età preistorica al Novecento, fruibili grazie alla visita di miniere, siti ar-cheologici, monumenti e musei insistenti sul territorio di riferimento del Parco.
Al fine di facilitare e rendere meno dispersiva la visita a queste otto aree, gli organi di gestione del Parco Geominerario hanno ideato e poi inserito sul sito web ufficiale alcuni itinerari “virtuali”, pensati per i fruitori maggiormen-te interessati a conoscere e comprendere più approfonditamente il territorio162. Questi itinerari, che associano ad ogni “area” un tema diverso, sono accessibili liberamente e non prevedono nessun tipo di servizio per la visita; possono dun-que essere definiti come una forma di “promozione” alla fruizione del Parco163.Attualmente nel Parco sono visitabili i seguenti otto siti minerari (ex miniere o parti di esse): la Grande Miniera di Serbariu a Carbonia, i Pozzi di Ingurtosu ad Arbus, la Galleria Henry a Bugerru, il sito di Funtana Raminosa a Gadoni, i Can-tieri di Montevecchio a Guspini, la Galleria di Villamarina nella Miniera di Monte-poni a Iglesias, la Grotta di Santa Barbara nella miniera di San Giovanni a Iglesias, Porto Flavia a Masua. La Grande Miniera di Serbariu presso Carbonia, rimasta attiva dal 1937 al 1964, è oggi gestita dal Centro Italiano della Cultura del Carbone (CICC), costituito nel febbraio del 2006 dal Comune di Carbonia e dal Parco Geominerario; la presenza di quest’associazione fa sì che tale struttura sia al mo-
161 DM dell’Ambiente del 16 ottobre 2001 cit., art. 3.162 Sito web ufficiale del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della
Sardegna, all’indirizzo <http://www.parcogeominerario.eu>. 163 Gli itinerari proposti nel sito del Parco sono: Itinerario Area Sulcis Terra di Carbone,
Itinerario Area Sarrabus-Gerrei Via dell’Argento, Itinerario Area Orani-Sos Enattos L’oro bianco dei Sardi, Itinerario Area Monte Arci I sentieri dell’ossidiana, Itinerario Area Funtana Raminosa Miniere di Barbagia, Itinerario Area La Maddalena-Sassari Granito e Miniere, Itinerario Area Guspinese-Arburese Miniere e Cervi, Itinerario Area Iglesiente Tra mare, boschi e miniere.
144
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
mento l’unica gestita seppur indirettamente dal Parco164. L’intero complesso è stato recuperato a fini museali nei primi anni Duemila grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal POR 2000-2006, Misura 2.2 Archeologia Industriale165. Il locali della Grande Miniera di Serbariu ospitano attualmente il Museo del Carbo-ne, una struttura polifunzionale per l’alta formazione universitaria, l’Archivio storico della miniera, il Museo Paleoambienti Sulcitani E.A. Martel e il Centro per lo sviluppo delle tecnologie energetiche pulite166. Il Museo del Carbone si sviluppa nel locale della lampisteria della miniera; a questo spazio è collegata da un percor-so museale la galleria sotterranea e la sala argani167. Nella lampisteria ha sede l’esposizione permanente, con pannellistica bilingue e supporti multimediali, che ripercorre la storia del carbone, della miniera e della città di Carbonia. Tale esposizione è costituita da un’interessante collezione di oggetti – lampade da miniera, attrezzi da lavoro, strumenti, oggetti di uso quotidiano, fotografie, do-cumenti, filmati d’epoca e videointerviste ai minatori ancora in vita – utile a ricostruire non solo la storia della miniera e degli uomini che vi lavorarono, ma dell’attività estrattiva isolana in generale. La visita alla galleria sotterranea dà la possibilità al fruitore di poter ammirare dal vivo l’evoluzione delle tecniche di coltivazione del carbone utilizzate a Serbariu dagli anni Trenta alla cessa-zione dell’attività, in ambienti fedelmente riallestiti che testimoniano le diffi-cili condizioni di lavoro dei minatori. La “sala argani” conserva al suo interno ancora intatte le grandi ruote dell’argano con cui si manovrava la discesa e la salita delle gabbie nei pozzi. La struttura polifunzionale è invece ospitata nei locali della torneria, della forge e della falegnameria.
Il Museo Paleontologico è allestito nel padiglione delle ex officine cui si ag-giungono altri ambienti destinati alle esposizioni temporanee e locali per le
164 Atto di Costituzione dell’Associazione denominata “Centro Italiano della Cultura del Carbo-ne”, Rep. n. 16/2006, Carbonia 8 febbraio 2006.
165 reGIone autonoMa della SardeGna, Aggiornamento delle schede di valutazione di misura, consultabile sul sito web istituzionale della Regione Sardegna, all’indirizzo <http://www.regionesardegna.it>. A seguito della revisione di metà percorso la Misura 2.2 Archeologia Industriale è stata assorbita dalla Misura 2.1 Archeologia, Percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici. reGIone autonoMa della SardeGna, Schede di misura del Complemento di Programma aggiornate al 30 giu-gno 2009, consultabile sul sito web istituzionale della Regione Sardegna, all’indirizzo <http://www.regionesardegna.it>. Si veda anche, in questo volume, il saggio di Cri-stina Borgioli sulle politiche regionali.
166 Sito web ufficiale del Centro Italiano della Cultura del Carbona (CICC), all’indirizzo <http://www.museodelcarbone.it>.
167 La lampisteria è il luogo dove i minatori ricevevano le lampade per il lavoro sotterra-neo.
145
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
attività di studio e di ricerca applicata, tutti gestiti dal Dipartimento di Scienza della Terra dell’Università di Cagliari168.
Gli altri impianti attualmente fruibili sono invece gestiti autonomamente dagli enti di rispettiva pertinenza, spesso mediante l’impiego di cooperative locali. La visita a questi impianti permette al fruitore di prendere coscienza di come si svolgeva la vita all’interno dei singoli complessi minerari nel corso degli anni: molte ex miniere infatti sono dotate anche di allestimenti inerenti il tema minerario, che espongono le testimonianze documentarie e gli oggetti d’uso quotidiano, come nel caso degli impianti di Arbus, Bugerru, Guspini, Iglesias e Masua. Oltre alle menzionate strutture estrattive recuperate e ricon-vertite a fini museali, il Parco annette, nel territorio delle otto aree, numerosi siti minerari dismessi e ancora non recuperati, generalmente in stato di abbandono e visitabili liberamente169.
Per completare l’elenco del patrimonio culturale inserito entro i confini del Parco Geominerario, vanno infine menzionati quei beni che, pur non essendo prettamente legati al tema minerario, sono comunque presenti all’interno delle otto aree; tutte queste strutture musealizzate sono state raggruppate a scopi promozionali nel sito web ufficiale del Parco dove vengono presentate suddivi-se per Musei, Chiese, Aree archeologiche, Siti di archeologia industriale, Siti di archeologia militare170. La presenza nel territorio di riferimento di beni di tipo-
168 Per maggiori informazioni sul complesso della Grande Miniera di Serbariu a Carbonia si veda anche la scheda relativa al Sistema Museale Cittadino di Carbonia in questo stes-so volume.
169 Sito web ufficiale del Consorzio del Parco all’indirizzo <http://www.parcogeominera-rio.eu>.
170 Sito web ufficiale del Consorzio del Parco all’indirizzo <http://www.parcogeominera-rio.eu>. Nello specifico, i beni musealizzati indicati nel citato sito web sono i seguen-ti: il Museo Archeologico Comunale Ferruccio Barreca e l’Archivio Storico Comunale di Sant’Antioco, il Museo Mineralogico Sardo a Iglesias; la Cattedrale di Santa Chia-ra a Iglesias, Basilica di Sant’Antioco Martire a Sant’Antioco, Chiesa di Sant’Elia di Tattinu a Nuxis, Chiesa di Santa Maria di Maltadi Guspini, Chiesa di Santa Maria della Neve a Villamassargia; il Pozzo sacro di Funtana Coberta a Ballao, il Villaggio preistorico a Barbusi, il Complesso nuragico Sa Domu e S’Orku a Domusnovas, il Tempio di Antas a Fluminimaggiore, il Villaggio nuragico di Seruci a Gonnesa; l’Area archeologica di Neapolis a Guspini, l’Area archeologica di Montessu a Villaperuccio, la Necropoli punica e Tofet e il Nuraghe Corongiu Murvonis e il Complesso nuragico di Grutti Acqua a Sant’Antioco, la Necropoli di Locci Santus a San Giovanni Suergiu, la Necropoli di Pani Loriga a Santadi, il Tempio fenicio punico e santuario nuragico Matzanni a Vallermosa, il Nuraghe Su Sonadori a Villasor; il centro storico (in quanto città di fondazione) a Carbonia, la Centrale termoelettrica di Santa Caterina a San Giovanni Suergiu, il Lavatoio ottocentesco a Villacidro; la Torre di Cala Domestica a Bugerru, la Torre sabauda e Batteria antinave e antiaerea SR 311 a Calasetta, la Fortezza punica di Monte Sirai a Carbonia, la Forte di S. Vittorio e Batteria antinave
146
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
logia così diversa dà indubbiamente al Parco la possibilità di proporre un’offer-ta turistico-culturale ampia e variegata, sebbene non si registrino al momento azioni di gestione congiunta.
Oltre a istituire il Parco il decreto ministeriale del 16 ottobre 2001 stabiliva anche che la sua gestione fosse affidata ad un Consorzio formato da tutti i sog-getti coinvolti nel progetto: gli Enti locali, la Regione, i Ministeri, le Università di Cagliari e Sassari171. Dato che all’art. 114 della legge finanziaria n. 388 del 2000 detto Consorzio era assimilato agli Enti e istituti di ricerca di cui alla leg-ge n. 168 del 1989, allo stesso fu riconosciuta «personalità giuridica di diritto pubblico» con «potestà statutaria e regolamentare nei limiti di cui alla legge stessa»172.
Nonostante le disposizioni ministeriali, in un primo momento però le veci di tale Consorzio furono assunte da un Comitato Provvisorio avente il compito di provvedere all’avvio delle attività iniziali del Parco173. Fu proprio questo Co-mitato Provvisorio che dovette occuparsi di impiegare nelle attività del Parco i fondi stabiliti dalla citata legge nazionale n. 388 del 2000 e destinati alla gestio-ne del Consorzio174.
L’impiego di questi lavoratori, da occupare inizialmente nella predisposizio-ne dei percorsi e della segnaletica, fu motivo di ritardi nell’avvio delle attività del Parco; tale problema era intimamente connesso all’attribuzione dei lavori di messa in sicurezza e recupero ambientale delle miniere presenti nel territorio di riferimento175. L’affidamento di tali mansioni causò uno scontro tra le due socie-tà a questo preposte, Geoparco Scarl e IGEA; la situazione fu aggravata dal fatto che il Parco non fu in grado di svolgere il suo compito di coordinatore, trovando una soluzione alla vertenza tra le due società, perché non ancora operativo.
e antiaerea ‘Tommaso Zonza’ a Carloforte, la Torre di Portoscuso e Batteria antinave e antiaerea SR 310 ‘Capo Altano’ a Portoscuso, la Fortezza fenicio-punica di Pani Loriga a Santadi, Batteria antinave ‘Ammiraglio Camillo Candiani’, la Punta Menga a Sant’Anna Arresi, la Torre Canai e Forte Sabaudo Su Pisu e Batteria antinave ‘Anto-nio Sogliuzzo’, Capo Sperone e il Semaforo di Capo Sperone a S. Antioco, il Castello di Acquafredda a Siliqua, il Castello Orguglioso a Silius.
171 DM del 16 ottobre 2001 cit., art. 4.172 DM 16 ottobre 2001 cit., art. 4 c. 2. Legge nazionale n. 388 del 2000 cit., art. 114. Legge
nazionale n. 168 del 9 maggio 1989 Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
173 e. arIu, Il sogno del Geominerario diventa realtà. I ministri Mattioli, Letta e Marzano firma-no il decreto istitutivo del parco, «La Nuova Sardegna», 14 ottobre 2001.
174 L n. 388 del 2000 cit.; a. panI, Geoparco, solo rifugio per i disoccupati?, «L’Unione Sarda», 11 novembre 2001.
175 a. MartInellI, Mobilitazione per il parco Geominerario, «L’Unione Sarda», 26 marzo 2002. G. pInna, Il Parco Geominerario cit., in Parco Geominerario cit., pp. 5-15.
147
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Il 23 ottobre 2001 la Regione Sardegna e i Ministeri del lavoro, dell’ambiente, dei beni culturali e delle attività produttive, firmarono una convenzione con la quale l’Associazione Temporanea D’Imprese (ATI), costituita dalle aziende Ifras S.p.A. di Cagliari, Intini S.r.l. e Servizi Globali S.r.l. di Bari, veniva indicata come referente per le attività di bonifica e valorizzazione archeologica e muse-ale all’interno del Parco176. Nella stessa convenzione si stabiliva che la suddetta ATI si sarebbe avvalsa dei menzionati cinquecento lavoratori socialmente utili, impiegandoli a tempo indeterminato, al fine di svolgere le suddette mansio-ni177. Qualche mese più tardi, nel dicembre 2001, la stessa ATI provvide a costi-tuire una società consortile, denominata Geoparco scarl, con il preciso scopo di gestire le attività di bonifica e valorizzazione archeologica e museale delle aree minerarie dismesse178.
La decisione di affidare alla Geoparco scarl gli interventi di bonifica causò però il malcontento dell’IGEA, società a totale partecipazione regionale nata nel 1998 all’indomani della soppressione dell’Ente Minerario Sardo; il disappunto del per-sonale IGEA era motivato dal fatto che la stessa Regione, alla fine degli anni Novanta, aveva assegnato a questa società il compito di occuparsi della messa in sicurezza per tutte le miniere di spettanza regionale presenti in Sardegna179. In altre parole, nonostante l’IGEA avesse precedentemente ricevuto l’incarico di occuparsi della bonifica nelle miniere regionali direttamente dalla Regione con la citata legge regionale n. 33 del 1998, a seguito della nascita del Parco tale fun-zione era stata attribuita dalla Regione alla Geoparco scarl, senza peraltro specifi-care se quest’ultima avesse dovuto operare solo nei siti non regionali o se avesse dovuto bonificare l’insieme delle miniere esistenti nel Parco180.
La questione delle competenze sulla messa in sicurezza delle miniere del Par-co si è in parte risolta nel 2004, quando è stata sottoscritta un’intesa tra la Regione
176 DGR n. 52/15 del 9 novembre 2005, Definizione del programma degli interventi in capo alla Società IGEA S.p.A. per il risanamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis – Iglesien-te – Guspinese inserite nei siti di interesse Nazionale ai termini dell’art. 1 della L. 426/98 e del Decreto ministeriale n. 468 del 18 settembre 2001 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
177 DGR n. 52/15 del 2005 cit.178 Sito web ufficiale dell’Azienda Ifras di Cagliari, all’indirizzo <http://www.ifras-spa.it>.179 LR n. 33 del 4 dicembre 1998, Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppres-
sione dell’Ente Minerario Sardo (EMSA); Intervista a Ilio Salvadori, Presidente dell’I-GEA, pubblicata sul sito Miniere di Sardegna all’indirizzo <http://www.minieredisar-degna.it>.
180 LR n. 33 del 1998 cit.; DGR n. 52/15 del 2005 cit.
148
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Sardegna, i rappresentanti dell’IGEA e della Geoparco scarl181. Tale accordo preve-deva che la Regione provvedesse a suddividere fra i due soggetti le aree minera-rie che necessitavano di interventi di recupero e i relativi finanziamenti. Qualche mese più tardi la stessa Regione ha attribuito un finanziamento di € 12.394.965, 57 all’IGEA per la bonifica e il risanamento delle aree affidate182.
Un altro fattore critico per l’organizzazione del Parco ha riguardato l’etero-geneità della proprietà, e quindi delle competenze, delle diverse aree dove si trovano le miniere: alcune hanno titolarità comunale, altre regionale. Si spiega in questo modo non solo la difficoltà del Parco di inserirsi in maniera concreta all’interno della gestione dei beni musealizzati ma anche la compresenza in uno stesso complesso minerario di diversi soggetti gestori. Queste difficoltà hanno bloccato le attività svolte dal Comitato Provvisorio di Gestione del Par-co, tanto che nel 2003 alcune associazioni, già promotrici del Parco, denunciaro-no a mezzo stampa l’immobilismo di quest’organo che non aveva provveduto a dotare il Parco nemmeno di una sede operativa183.
Nel 2003 subentrò al suddetto Comitato Provvisorio l’organo di gestione definitivo per il Parco ovvero il citato Consorzio del Parco; ma, nonostante ciò, continuò a persistere una situazione di stasi, denunciata nell’agosto 2004 dai consiglieri regionali di minoranza (schieramento di centro-sinistra) in una loro mozione presentata in Regione184. Solo in seguito si registrò un, seppur lento, avvio delle attività del Parco che si concretizzarono parzialmente nel 2006; tra i risultati raggiunti nell’annualità 2004 vi fu la produzione di uno Statuto, col quale sono stati specificati gli organi attraverso i quali il Consorzio è organiz-zato (il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Comunità del Parco, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore del Parco e il Comitato tecnico-scientifico)185.
Il Presidente del Consorzio del Parco, nominato con decreto ministeriale, svolge le funzioni di legale rappresentante e promuove azioni e provvedimenti urgenti per la tutela degli interessi del Parco186; la carica è attualmente (2009) vacante e al suo posto opera un Commissario Straordinario, nominato diretta-mente dal Ministro dell’Ambiente187.
181 DGR n. 52/15 del 2005 cit.; DGR n. 14/45 del 18 marzo 2004.182 DGR n. 25/47 del 3 giugno 2004.183 A. MartInellI, Protesta Pozzo Sella: ‘Sedici mesi inutili’, «L’Unione Sarda», 10 aprile
2003.184 G. GhIrra, Geoparco ancora all’anno zero, «L’Unione Sarda», 10 settembre 2004.185 DM 9 marzo 2004, Emanazione dello Statuto del Consorzio del Parco geominerario storico e
ambientale della Sardegna.186 DM 9 marzo 2004, cit., art. 6.187 DEC/DPN/112 del 2 febbraio 2007; Commissariato il Parco geominerario, «La Nuova
Sardegna», 10 febbraio 2007.
149
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente del Consorzio e da altri se-dici componenti, esercita le funzioni d’indirizzo politico-amministrativo, defi-nendo gli obiettivi e i programmi da attuare, deliberando su atti rientranti in tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministra-tiva e della gestione agli indirizzi impartiti188.
La Comunità del Parco è un organo di programmazione, d’indirizzo e di controllo del Consorzio del Parco, composta da un rappresentante di ogni ente o soggetto giuridico che aderisce al Parco189. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna, esercita un controllo contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento di contabilità adottato dal Consiglio Diret-tivo190. Il Direttore, invece, è la figura responsabile della gestione del Parco e risponde dell’esercizio delle sue attribuzioni al Consiglio Direttivo191.
In ultimo, il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzioni propositive e consulti-ve su ogni questione afferente la gestione del Parco192. In realtà detto Comitato non è mai entrato realmente in funzione e negli ultimi anni il coordinamento scientifico è stato affidato alle Università sarde mediante la stipula di apposite convenzioni.
Lo Statuto regola anche gli aspetti finanziari del Consorzio del Parco. Costi-tuiscono le entrate i finanziamenti disposti con l’art. 114 comma 10 della legge n. 388 del 2000, gli eventuali contributi ordinari e straordinari (della Comu-nità Europea, della Regione Sardegna, delle Province, dei Comuni e di altri enti pubblici statali e locali), gli eventuali lasciti e donazioni, la bigliettazione delle strutture museali e gli introiti dei relativi servizi, i proventi delle sanzio-ni derivanti da inosservanza del Regolamento per la salvaguardia del Parco e le quote di partecipazione dei singoli enti. Queste ultime vengono ripartite in proporzione all’estensione e al valore storico-ambientale del territorio di ogni singolo Comune o Provincia193. In realtà, poiché le attività del Parco sono sta-te finora assai limitate, le uniche fonti di finanziamento sono consistite nelle quote di partecipazione degli enti che compongono il Consorzio e negli introiti della vendita dei biglietti e dei servizi offerti – bookshop, caffetteria, vendita souvenir – all’interno del Museo del Carbone di Carbonia, centrate che vengono
188 DM 9 marzo 2004 cit., art. 7. I sedici membri del Consiglio Direttivo sono così sud-divisi: quattro in rappresentanza dei Ministeri aderenti, quattro in rappresentanza della Regione Sardegna, quattro in rappresentanza dei Comuni ed altri quattro in rappresentanza delle Province facenti parte della comunità del Parco.
189 DM 9 marzo 2004 cit., art. 8.190 Ivi, art. 11.191 Ivi, art. 9.192 DM 9 marzo 2004 cit., art. 12.193 Ivi, art. 6.
150
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
impiegate per coprire le spese riguardanti la gestione del Museo194. Per gli altri beni culturali presenti nelle otto aree del Parco è invece il singolo Ente di appar-tenenza a gestire i relativi introiti.
Nel luglio del 2005 la Regione, nel documento programmatico Sistema re-gionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo, dichiarò di voler contri-buire «ad assecondare il processo di crescita dell’intero Parco Geominerario» al fine di tutelare e valorizzare al meglio tutte le aree minerarie coinvolte nel progetto195. La Regione manifestava la volontà di riorganizzare il settore mu-seale, indicando gli indirizzi programmatici finalizzati alla realizzazione del Sistema Museale Regionale, articolato in diversi sub sistemi a carattere territoriale o tematico196. Mantenendo fede a quanto espresso nel Piano, qualche mese dopo la Regione ha incluso l’azione relativa alla «Valorizzazione museale di Mon-tevecchio-Guspini» tra i 29 interventi previsti nell’Accordo di Programma Qua-dro firmato il 30 settembre 2005 dalla stessa Regione Sardegna, dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; per la realizzazione del suddetto intervento viene stanziato un finanziamento di poco meno di 2 milioni di euro a valere su fondi CIPE197.
L’8 febbraio del 2006 il Parco ha istituito, insieme al Comune di Carbonia, il Centro Italiano della Cultura del Carbone (CICC), finalizzato alla conservazione, alla tutela, al restauro e alla valorizzazione di tutte le strutture e i beni dell’ex miniera di Serbariu e delle altre miniere carbonifere di Carbonia e del Sulcis Iglesiente198. Il CICC gestisce il Museo del carbone presso la Grande Miniera di Serbariu a Carbonia, che avremo modo di illustrare più avanti.
Con il medesimo obiettivo, nel biennio 2007-2008, sono state istituite altre associazioni che, una volta avviate, dovranno garantire un intervento diretto da parte del Consorzio nella gestione dei beni culturali di pertinenza e, in futuro, la creazione di un’offerta culturale integrata199. Il Parco ha istituito altre sette as-
194 Gli introiti relativi alle attività svolte all’interno del Museo del Carbone a Carbonia vanno calcolati al netto di quelli spettanti al Comune di Carbonia come proprietario e co-gestore del Museo.
195 “Sistema regionale dei Musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo”. Documento d’indirizzo politico-amministrativo approvato con DGR n. 36/5 del 26 luglio 2005.
196 Sistema regionale dei Musei cit., approvato con DGR n. 36/5 del 26 luglio 2005.197 Regione Autonoma della Sardegna, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e Attività Culturali, Roma 30 settembre 2005.
198 Ci sarà anche il Parco Geominerario nel Centro italiano del carbone, «L’Unione Sarda», 19 gennaio 2006; Atto Istitutivo dell’Associazione CICC del 2006 cit.
199 Informazione concessa dal dott. Puddu, funzionario del Consorzio del Parco, tramite comunicazione scritta del 22 aprile 2009.
151
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
sociazioni con altrettanti enti locali: il Centro italiano Cultura dell’Ossidiana CICO con i Comuni di Pau e Masullas, l’Associazione Miniere di Rosas con il Comune di Narcao, l’Associazione Monte Linas con il Comune di Gonnosfanadiga, l’Associa-zione SPIEME San Pietro: Isola Ecologica del Mediterraneo con il Comune di Carlo-forte; l’Associazione Valle dei Menhir di Terratzu con il Comune di Villaperuccio, l’Associazione Grotta di Su Benatzu con il Comune di Santadi, l’Associazione Cento Ambientale Minerario Arburese con il Comune di Arbus200. La creazione di queste associazioni è stata fino ad ora il principale strumento con il quale il Parco ha interagito concretamente con gli Enti locali al fine della gestione dei beni cul-turali di spettanza.
Con l’avvio delle prime attività del Parco si manifestò chiaramente l’ina-deguatezza degli organi amministrativi previsti dallo Statuto del 2004, poiché costituiti dai rappresentanti di tutti gli enti coinvolti nelle varie fase della sua realizzazione (Comuni, Province, Regione, Ministeri). Ciò ha comportato una forte instabilità dell’apparato burocratico, che si deve rinnovare ogniqualvolta muta una delle amministrazioni politiche201. Uno dei problemi riguardanti gli aspetti gestionali del Parco può essere perciò individuato nella provvisorietà dei suoi organi amministrativi per assoggettamento alla sfera politica locale, regionale e nazionale.
Per porre rimedio a tale complessa situazione, il Ministero dell’Ambiente nel 2007 decise di affidare la gestione del Parco a un commissario che, una volta delineati chiaramente i problemi insiti nella struttura organizzativa, doveva in-dicare una possibile soluzione202. Il primo Commissario Straordinario del Parco provvide a stipulare, nel marzo 2007, un contratto con l’Università degli Studi di Cagliari affinché quest’ultima incaricasse un gruppo di giuristi per ridefinire il quadro normativo di disciplina del Parco203.
Alla conclusione dei lavori furono proposte alcune modifiche allo Statuto e al decreto ministeriale istitutivo del Parco tese allo snellimento dell’apparato orga-nizzativo con conseguente accelerazione di tutte le attività correnti; il 6 giugno 2007 tali proposte furono approvate all’unanimità dalla Comunità del Parco204.
Le modifiche al decreto istitutivo del 16 ottobre 2001 riguardano innanzi-tutto l’introduzione tra le sue premesse della considerazione secondo la quale
200 Ivi.201 DM 9 marzo 2004 cit.202 Dec/Dpn/112 del 2 febbraio 2007; Commissariato il Parco geominerario, cit.203 G. pInna, Rapporto di fine mandato del Commissario Straordinario, Iglesias, 2 febbraio
2009, p. 3.204 G. pInna, Rapporto di fine mandato del Commissario Straordinario, Iglesias 2 febbraio
2009, pp. 5-6.
152
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
il Parco Geominerario è annesso al sistema della rete dei parchi nazionali e, per-tanto, oltre agli stanziamenti ordinari già previsti, può usufruire anche delle risorse economiche riservate dallo Stato ai citati Parchi nazionali205. La varia-zione più consistente riguarda però la composizione del Consiglio Direttivo del Consorzio del Parco, e prevede una riduzione dei suoi componenti da di-ciassette a nove, introducendo tra questi un rappresentante delle Associazioni e uno delle due Università della Sardegna206. Infine viene proposta l’eliminazione della norma secondo cui i consiglieri decadono ad ogni rinnovo dell’assemblea elettiva dell’istituzione che li ha espressi; questa clausola era infatti proprio la principale causa degli ostacoli sorti in merito alla continuità amministrativa e al regolare funzionamento del Consiglio Direttivo207.
Le modifiche che vengono suggerite per lo Statuto invece sono indirizzate essenzialmente alla sua semplificazione e riguardano: la riduzione degli articoli da trentasei a ventitre; la ridistribuzione delle quote consortili fra tutti i consor-ziati; la semplificazione dell’Organo di Controllo riducendo la sua composizio-ne al solo Ministero dell’Ambiente e non più alla Conferenza dei Servizi, formata dai quattro Ministeri coinvolti nel Parco (Ministeri dell’Ambiente, delle Attivi-tà produttive, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e dalla Regione Sardegna; l’introduzione della pianificazione strategica del Parco e del Piano Territoriale del Parco, quale strumento attuativo del Piano Paesaggistico Regionale al quale resta comunque subordinato208.
A seguito del parere favorevole espresso dalla Comunità del Parco, tale pro-posta di modifica fu trasmessa al Ministero dell’Ambiente e alla Regione, che però non fornì nell’immediato nessuna risposta209. Solamente il 5 novembre 2007 l’allora Presidente della Regione Renato Soru, in occasione dell’incontro col Ministro dell’Ambiente presso la sede del Consorzio del Parco, comunicò di non condividere le proposte di modifica al Decreto Istitutivo del Parco e allo Statuto del Consorzio e presentò direttamente al Commissario Straordinario una propria controproposta210. Poiché le modifiche presentate dal Presidente furono considerate inaccettabili dagli organi di gestione del Parco, essendo totalmente in contrasto con quelle proposte dal gruppo di giuristi e già approvate dalla Co-munità del Parco e dal Ministero dell’Ambiente, il Commissario Straordinario
205 Ivi, p. 8.206 Ivi, p. 9.207 Ivi.208 Ivi, pp. 11-12.209 Ivi, p. 14.210 S. ManteGa, Il Geoparco contro la giunta Soru, «L’Unione Sarda», 10 maggio 2008. G.
pInna, Rapporto di fine mandato, cit., p. 15.
153
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
decise di ritenere comunque concluso il proprio compito, rimanendo in attesa di nuove decisioni prese al riguardo dagli organi superiori211. Dal punto di vista della revisione degli organi di gestione del Parco, a seguito dell’opposizione della Regione, il commissariamento non è potuto giungere all’applicazione di alcuna innovazione sostanziale.
Dall’autunno 2007 sino alla fine del mandato il lavoro del Commissario è stato indirizzato ad assicurare il regolare svolgimento delle attività operative del Consorzio del Parco, quali la promozione e il sostegno ad attività artistiche, culturali e sportive finalizzate alla valorizzazione dei siti del Parco; l’avvio della progettazione finalizzata al recupero e alla valorizzazione delle aree minerarie dismesse; la messa a disposizione del personale necessario ad avviare la gestio-ne delle sue attività operative e la predisposizione degli strumenti di pianifica-zione strategica per la gestione del Consorzio.
Nel novembre 2008 la Comunità del Parco ha approvato il Piano economico-sociale di gestione del Parco, elaborato dall’Università di Cagliari, che prevede la gestione coordinata dei siti minerari e delle strutture musealizzate di archeolo-gia industriale presenti nel territorio del Parco nell’ottica di una loro messa in rete finalizzata alla creazione di un «sistema adeguato alla promozione presso gli operatori turistici nazionali e internazionale»212. In altre parole il Piano eco-nomico-sociale formalizza una pratica già adottata dal Consorzio ovvero la crea-zione di associazioni con gli enti locali che permettano agli organi consortili di inserirsi direttamente nella gestione delle strutture musealizzate insistenti sul territorio di riferimento.
Il Parco Geominerario si distingue in tutto il contesto isolano in primo luogo per le vicissitudini che hanno segnato la sua lunga storia, ma soprattutto per la precocità con cui la necessità della sua realizzazione è stata avvertita a vari livelli istituzionali e sociali come soluzione adatta a recuperare alcune aree e comunità altrimenti destinate al degrado. In effetti la nascita del Parco ha per-messo il riuso a fini museali di alcuni impianti estrattivi inesorabilmente desti-nati all’abbandono e, di conseguenza, ha concesso alle popolazioni interessate una nuova occasione di sviluppo socio-economico mediante la creazione di una proposta turistico-culturale diversa rispetto a quelle esistenti in Sardegna. Tale offerta è poi resa più attrattiva dalla vicinanza alle località balneari di molte delle aree minerarie recuperate.
Tra gli effetti che l’istituzione del Parco ha avuto sul territorio si registra inol-tre l’assunzione a tempo indeterminato di circa cinquecento lavoratori social-mente utili residenti nei Comuni aderenti al Parco, avvenuta grazie alla società
211 S. ManteGa, Il Geoparco contro la giunta Soru, cit.212 G. pInna, Rapporto di fine mandato, cit., p. 31.
154
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Geoparco Scarl incaricata del recupero ambientale di parte dei siti minerari di-smessi. In questo modo la presenza del Parco, seppur indirettamente, è riuscita a garantire un reddito stabile per un consistente numero di famiglie: possiamo dunque asserire che la realizzazione del Parco ha comportato un miglioramento del livello occupazionale del territorio di riferimento213.
È indubbio dunque il forte legame che unisce questo progetto al suo territo-rio, anche in relazione agli aspetti più prettamente politici; non va dimenticato infatti che la nascita del Parco è il risultato di un’importante azione politica, ba-sti pensare che la mobilitazione per la sua istituzione è stata avviata nell’autun-no 2000 da un consigliere regionale e ha coinvolto numerosi esponenti dell’am-biente politico isolano214. Le relazioni con la politica sono anche alla base però dei problemi gestionali che hanno causato forti ritardi nell’avvio delle attività del Parco e che hanno portato, per esempio, alla sovrapposizione di competenze in materia di ripristino ambientale e messa in sicurezza dei complessi estrattivi tra le società IGEA e Geoparco Scarl215.
Proprio questi ritardi e la presenza di un apparato burocratico farraginoso sono i principali motivi per cui, ancora oggi, al Consorzio del Parco non viene riconosciuto, da parte degli enti locali coinvolti, il ruolo di coordinatore delle azioni indirizzate allo sviluppo del territorio mediante la valorizzazione del pa-trimonio minerario. Si spiega in questo modo la presenza all’interno dei confini del Parco di numerosi complessi estrattivi recuperati a fini culturali e turistici gestiti direttamente dagli enti competenti in piena autonomia rispetto agli altri enti coinvolti nel progetto e allo stesso Consorzio del Parco.
Nonostante non si tratti di un sistema museale e non vi sia ancora una gestione coordinata del patrimonio culturale afferente al Parco, abbiamo co-munque ritenuto opportuno includere tale realtà nella nostra indagine perché presenta al suo interno alcuni tratti di originalità: in primo luogo il Parco Geo-minerario è un esempio interessante perché, nonostante le difficoltà riscontrate, dimostra come la riconversione e la musealizzazione di strutture destinate ori-ginariamente a funzioni del tutto diverse possa realmente divenire un efficace strumento per lo sviluppo di una determinata area, trasformandosi anche in un’occasione di riscatto sociale per le popolazioni coinvolte nell’esperienza. L’importanza del Parco Geominerario consiste anche nel fatto che la sua istituzio-ne ha permesso il recupero di un buon numero di impianti estrattivi altrimenti destinati alla distruzione e nel contempo ha reso possibile la conservazione e la
213 a. panI, Geoparco, solo rifugio per i disoccupati?, cit.214 a. MartInellI, Mobilitazione per il parco Geominerario, cit. p. M. caStellI, e. pIntuS, Sto-
ria della costruzione del Parco, cit., pp. 36-40.215 G. pInna, Rapporto di fine mandato del Commissario Straordinario, Iglesias 2 febbraio
2009. DGR n. 52/15 del 2005 cit.
155
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
diffusione della conoscenza di «tutto il bagaglio tecnico e scientifico della tradi-zione mineraria sarda»216. Un altro aspetto singolare di quest’esperienza è dato dal fatto che il Consorzio del Parco, conscio delle potenzialità di sviluppo insite in una gestione congiunta del patrimonio minerario, negli ultimi anni si stia adoperando per realizzare la messa in rete dei beni presenti entro i suoi confini mediante la creazione di associazioni che lo vedono attivo, insieme ai Comuni di riferimento, nella gestione del patrimonio locale. Questo procedimento di messa in rete dei beni di pertinenza degli enti locali aderenti al Parco, avviato a partire dal 2006, è stato formalizzato dal Consorzio del Parco nell’autunno del 2008 con l’approvazione del Piano economico e sociale del Parco.
Sebbene i problemi riscontrati soprattutto a livello gestionale non siano an-cora stati risolti e il Parco continui a essere commissariato, il Parco Geomine-rario costituisce comunque un potenziale esempio di come la valorizzazione congiunta dei peculiari e differenziati aspetti storici e geologici di un territorio possano diventare occasione di riscatto sociale ed economico.
216 G. pInna, Il Parco Geominerario cit. in Parco Geominerario cit., p. 11.
156
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
4 Il Sistema Museale Cittadino di Carbonia [Deligia]
Il Sistema Museale Cittadino di Carbonia è un progetto di messa in rete del patrimonio locale avviato nel 2002, quando l’Amministrazione comunale affida a un unico soggetto l’insieme delle strutture musealizzate di pertinenza con l’obiettivo di migliorare la gestione delle risorse destinate al patrimonio cul-turale217. Dal 2002 al 2009 il Sistema Museale Cittadino di Carbonia si è realizzato mediante l’affidamento della sua gestione a un unico soggetto e l’attivazione di una bigliettazione congiunta.
¬ Precedenti
La prima idea di costituire un forma di gestione congiunta – assimilabile al concetto di “sistema” – a Carbonia risale al 1999, quando l’Amministrazione comunale stabilì di far gestire a un unico soggetto esterno le tre strutture muse-alizzate della città e di programmarne le attività mediante un piano triennale. Tale progetto riguardava due beni di pertinenza comunale – il Museo archeolo-gico Villa Sulcis e il Museo paleontologico e speleologico E. A. Martel – e l’area archeologica del Monte Sirai di competenza statale218. Il servizio di visita all’area archeologica era al tempo già assicurato dal Comune, peraltro proprietario del terreno ove si trovano i resti, poiché negli anni Ottanta la competente Soprin-tendenza Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano aveva concesso al Comune di Carbonia la possibilità di occuparsi dell’accesso all’area arche-ologica mediante l’organizzazione di visite guidate a pagamento, pur senza stipulare un accordo formale219.
Questo tipo di prassi collaborativa tra Comune e Soprintendenza per la ge-stione di aree archeologiche è piuttosto frequente in Sardegna e presenta effetti
217 LR n. 28 del 7 giugno 1984, Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione e LR n. 11 del 9 marzo 1988, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988). DGC di Carbonia n. 543 del 27 ottobre 2000, Approvazione progetto per la gestione unitaria del Museo Villa Sulcis, dell’area archeologica di Monte Sirai e Museo Paleontologico e Speleologico. Determinazione del Responsabile dei Servizi Culturali del Comune di Carbonia n. 198 del 18 ottobre 2002, Fornitura servizi Gestione e valo-rizzazione del patrimonio archeologico e ambientale del territorio comunale-Area archeologica Monte Sirai-Museo Archeologico “Villa Sulcis”-Museo Speleologico e Paleontologico ‘E. A. Martel’-Approvazione Verbali di Gara-Aggiudicazione e approvazione schema di contratto.
218 DGC di Carbonia n. 44 del 9 luglio 1999, Gestione unitaria del Museo Archeologico di Villa Sulcis, dell’Area archeologica di Monte Sirai e del Museo paleontologico e speleologico E. A. Martel.
219 Informazione fornita dal dott. Elio Mei, responsabile ufficio cultura del Comune di Carbonia, tramite comunicazione scritta in data 2 ottobre 2009.
157
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
positivi per entrambi i soggetti: i Comuni possono rendere fruibili i siti archeo-logici presenti nel proprio territorio, ampliando così la propria offerta culturale e creando occupazione, mentre gli Uffici periferici del Ministero sono sollevati dall’onere di occuparsi della gestione delle aree – sovente resa difficile dalla mancanza di personale – e assicurano una maggior vigilanza sui beni, altrimen-ti in stato di abbandono e oggetto di atti vandalici.
Quando nel 1999 il Comune di Carbonia decise di procedere alla gestione congiunta delle tre strutture citate, due di queste risultavano di fatto già af-fidate ad un’unica cooperativa locale: la gestione del Museo Villa Sulcis e del servizio di visite all’area archeologica di Monte Sirai era stata infatti avviata nella seconda metà degli anni Ottanta, in conseguenza alle disposizioni tese a favorire l’occupazione contenute nella legge regionale n. 24 del 1984 e grazie ai relativi finanziamenti, stanziati mediante programmi triennali a partire dall’e-manazione della legge regionale n. 11 del 1988, poi rinnovati fino al 1999.220 Tali norme, con i relativi programmi di attuazione, hanno infatti avuto lo scopo di produrre occupazione anche nel settore dei beni culturali favorendo, da un lato – per circa quindici anni e su tutto il territorio regionale – l’impiego di asso-ciazioni e cooperative formate da giovani e da categorie svantaggiate in musei e aree archeologiche e, dall’altro, stimolando gli Enti locali ad avviare attività relative al settore dei beni culturali221. Gli effetti delle politiche regionali per l’occupazione si esplicitarono dunque a Carbonia con l’affidamento da parte del Comune alla cooperativa V. Pispisa del servizio di visite all’area del Monte Sirai e della gestione del Museo archeologico comunale Villa Sulcis.
Nel 1999, poco prima cioè di deliberare in merito alla creazione di un piano triennale di programmazione per le tre strutture, il Comune decise di assegnare provvisoriamente alla medesima cooperativa anche la gestione del Museo Mar-tel, istituito nel 1972 e gestito fino ad allora da alcuni volontari222.
Alla fine degli anni Novanta il patrimonio culturale di Carbonia dunque si presentava affidato a un unico gestore sebbene non fosse ancora presente una gestione congiunta vera e propria, non essendo praticate attività integrate come la bigliettazione unica o l’elaborazione di un piano unitario. Di conseguenza, il Comune decise nel 1999 di procedere al miglioramento dell’amministrazio-ne dei beni di propria pertinenza, mediante la realizzazione di una gestione congiunta per il Museo Martel, il Museo Villa Sulcis e l’area archeologica del Monte Sirai; questi non solo sarebbero stati affidati a un unico soggetto, ma le loro attività sarebbero anche state pianificate attraverso una programmazione
220 Leggi regionali n. 28 del 1984 cit., n. 11 del 1988 cit., n. 8 dell’8 marzo 1997, Disposizio-ni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997).
221 Si veda in questo volume il saggio di Cristina Borgioli.222 Tre miliardi in tre anni per Parco archeologico, «L’Unione Sarda», 7 maggio 1999.
158
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
di tipo triennale223. Nonostante non si adotti ancora esplicitamente la definizio-ne di «sistema museale», appare chiaro che l’indirizzo verso il quale il Comune si sta muovendo è quello di un’organizzazione sistemica del patrimonio. Le intenzioni del Comune di procedere alla gestione congiunta delle strutture mu-sealizzate e di approntare un piano di programmazione triennale anticipano puntualmente quelle che saranno le direttive relative all’assegnazione dei fi-nanziamenti per i musei di ente locale; queste, infatti, saranno approntate poco tempo dopo dalla Regione, tramite la legge regionale 4/2000, che di lì a poco diverrà la norma di riferimento per la concessione di risorse regionali per il patrimonio culturale224.
Nel 2000, in occasione del bando di finanziamento determinato dalla legge regionale n. 4 del 2000 (art. 38) e relativo a contributi regionali per la gestione del patrimonio culturale di enti locali, il Comune di Carbonia definì un proget-to di messa a sistema dei beni musealizzati di sua pertinenza225. Gli obiettivi che l’Amministrazione comunale voleva raggiungere, mediante la creazione di quello che adesso si definisce «sistema museale» a dimensione cittadina, erano essenzialmente due: l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse economiche e l’implementazione dei servizi e della qualità di quelli già esistenti (visite guida-te e attività didattiche). Oltre a queste finalità, strettamente collegate alla messa in atto del sistema a livello comunale, vi era poi un obiettivo più ambizioso, quello di creare una struttura reticolare, in grado di costruire connessioni con altre realtà del territorio, al fine di realizzare una «rete museale territoriale»226.
Il caso di Carbonia si caratterizza, da un lato, per la precocità con cui si mani-festa l’intenzione di realizzare una gestione sistemica del patrimonio cittadino alla fine degli anni Novanta e, dall’altro, per l’impegno, dimostrato in più occa-sioni, nella creazione di connessioni con altri Enti locali al fine di creare “reti” in grado di migliorare servizi e funzioni per il patrimonio culturale e il turismo.
223 DGC di Carbonia n. 44 del 1999 cit.224 LR n. 4 del 20 aprile 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (legge finanziaria 2000). DGR n. 36/6 del 5 settembre 2000, L.R. n. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in ge-stione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali, biblioteche e archivi. Cap. 11129 del bilancio regionale. Direttive istruttorie e pubblicazione nel BURAS, a norma dell’art. 19 della L.R. 22.8.1990, n. 40.
225 DGC di Carbonia n. 543 del 2000 cit.; LR n. 4 del 2000 cit.; DGR n. 36/6 del 2000 cit.226 DGC di Carbonia n. 543 del 2000 cit.
159
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
¬ Avvio del «sistema»
Il progetto di sistema comunale di Carbonia presentato nel 2000 fu ammes-so, l’anno successivo, ai finanziamenti a valere sulla legge regionale n. 4 del 2000227. Nel 2002 il Comune fu in grado di affidare il Sistema a un unico gestore mediante la pubblicazione di un bando di gara per l’individuazione del sogget-to228. Il concorso fu vinto da un raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) composto dalle cooperative La memoria storica e Mediterranea229. Secondo quanto stipulato con il Comune mediante contratto di appalto, per i due musei e il sito archeologico la RTI, dal 2002, ha gestito la bigliettazione congiunta, la manu-tenzione, la pulizia e la custodia delle strutture, le visite guidate, il servizio di trasporto per i visitatori utilizzato per raggiungere il Monte Sirai, i servizi di bookshop e ristoro, nonché varie attività di promozione culturale230.
Nel 2004 il Comune di Carbonia ricevette anche i finanziamenti relativi agli interventi a valere sulla Misura 2.1 Archeologia, recupero centri storici abbando-nati, a fini culturali e turistici del POR 2000-2006231. L’utilizzo di queste risorse ha reso possibile un ulteriore ampliamento dell’offerta culturale del Sistema carboniense, poiché sono stati realizzati il trasferimento del Museo Martel nei locali della struttura denominata Grande Miniera di Serbariu (già sede del Centro Italiano della Cultura del Carbone), l’ampliamento del Museo Villa Sulcis con re-lativa dotazione di un nuovo deposito e di un centro di restauro; infine è stata avviata la progettazione del Parco urbano archeologico di Cannas di Sotto la cui realizzazione è attualmente in fase di compimento (2009).
Anche a seguito di quanto concretizzato grazie ai contributi POR, nel 2005 il Comune elaborò per il sistema cittadino un secondo progetto triennale, che puntava alla costituzione di due nuove realtà culturali: il Parco di Cannas di Sotto e il programma CIAM (Carbonia: Itinerari di Architettura Moderna) che mirava alla realizzazione di itinerari per la valorizzazione dell’architettura di Carbo-
227 DGR n. 36/32 del 23 ottobre 2001, L. R. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archi-vi. Contributo agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni monumentali e ambientali, biblio-teche ed archivi. Programma triennale 2001-2003. Annualità 2001. Cap. 11129 UPB S11.031 bilancio regionale.
228 DGC di Carbonia n. 198 del 2002 cit.
229 G. dI paSquale, Cambio della guardia anche a Sirai. Gestione dei musei, esce di scena la coop Pispisa, «La Nuova Sardegna», 16 ottobre 2002.
230 Progetto di gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico e ambientale del territorio comunale approvato con DGC di Carbonia n. 543 del 2000 cit.; Determinazione comu-nale del Comune di Carbonia n. 198 del 2002 cit.
231 Determinazioni del Direttore del Servizio Tutela e Valorizzazione Beni Culturali n. 2800 del 22 settembre 2004 e n. 3336 del 23 novembre 2004.
160
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
nia, quale “città di fondazione”232. Il centro attivo di questo nuovo programma è individuato nel Museo del Carbone233. Il Museo, istituito il 5 gennaio 2006, ha sede presso la Grande Miniera di Serbariu, un impianto estrattivo dismesso, bo-nificato e adibito a spazio pubblico grazie ai finanziamenti POR 2000-2006234. Tramite il nuovo programma CIAM, l’Amministrazione comunale intendeva allargare ulteriormente il patrimonio culturale a propria disposizione.
Nel 2006, a seguito della modifica della normativa regionale sui finanzia-menti agli enti pubblici per la gestione del patrimonio culturale (legge re-gionale 7/2005) e in occasione della pubblicazione del relativo bando di co-finanziamento, il Comune ha però dovuto presentare una rimodulazione del precedente programma e pertanto, dato che i finanziamenti a valere sulla legge regionale 7/2005 non sono mai stati erogati, il Sistema di Carbonia è rimasto sostanzialmente invariato per le strutture partecipanti.
Nel 2007, con l’approssimarsi della scadenza del contratto di affidamento per la gestione del Sistema museale, fu indetto dal Comune di Carbonia un nuovo bando di gara235. L’appalto fu vinto da un raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle cooperative Mediterranea, La Miniera e dalla Società
232 DCC Carbonia n. 49 dell’8 giugno 2005, Gestione del Museo Archeologico di Villa Sulcis, dell’Archeologica di monte Sirai e del Museo Paleontologico e Speleologico ‘E.A. Martel’-CIAM-Approvazione Piano di Programmazione Triennale.
233 LR n. 7 del 21 aprile 2005, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-nale della Regione (Legge finanziaria 2005). DGC n. 61/30 del 20 dicembre 2005, Linee di indirizzo relative all’erogazione di contributi agli enti locali pubblici territoriali. DGC di Carbonia n. 202 del 11 settembre 2006, Gestione Musei e aree archeologiche. Approvazione Progetto e richiesta di finanziamento.
234 ISRI, Servizio di valutazione indipendente intermedia del POR della Regione Autonoma della Sardegna 2000-2006, Cagliari 2005, scheda 1.2.b Misura 2.2 Archeologia indu-striale, consultabile nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, all’indi-rizzo <http://www.regionesardegna.it>. Poiché la graduatoria relativa al bando di finanziamento regionale a valere sulla legge regionale n. 7 del 2005 non è mai stata prodotta dalla Regione, quanto programmato nel progetto presentato dal Comune di Carbonia nel 2006 non è ancora (2009) stato compiuto. Bando per la selezione di Progetti triennali di gestione dei servizi relativi ad aree e parchi archeologici, complessi monumentali, musei di ente locale e d’interesse locale. UPB S 11025 Capitolo 11212 (L.R. 21/04/2005 n. 7 art. 12 comma 3-Direttive di attuazione, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/30 del 20/12/2005) pubblicato sul sito web della Regione Autonoma della Sarde-gna in data 6 marzo 2006, all’indirizzo <http://www.regionesardegna.it>. LR n. 7 del 2005 cit.; DGR n. 61/30 del 2005 cit.
235 Determinazione comunale del Comune di Carbonia n. 102 del 15 giugno 2007, Servi-zio di Gestione Unitaria del Sistema Museale Cittadino. Approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e del Bando di gara. Indizione procedura aperta; M. VenturI, Novecentomila euro per gestire i musei, «L’Unione Sarda», 12 dicembre 2007.
161
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Sistema Museo236. Il coinvolgimento nella gestione di Sistema Museo, una socie-tà non locale e ampiamente affermata a livello nazionale, si configura come un elemento di novità nel panorama sardo, dato che, anche sulla scorta della normativa contro la disoccupazione degli anni Ottanta, tali attività sono gene-ralmente affidate a cooperative e associazioni locali. Tra il 2007 ed il 2008, con la gestione affidata al nuovo soggetto, le attività del Comune per il Sistema si concentrano soprattutto su azioni volte al miglioramento dei servizi e del-le strutture afferenti. Gli interventi sono possibili grazie alle citate risorse del POR 2000-2006 e alle richieste di contributi per il restauro a valere sulla legge regionale n. 14 del 2006 che il Comune presentò alla Regione con successo237. Si realizza in questo modo il riallestimento del Museo Martel e l’ampliamento e il restauro del Museo di Villa Sulcis238.
¬ Il «sistema» e le sue strutture
Al momento della nostra ricerca, il Sistema di Carbonia consta di tre strut-ture visitabili con bigliettazione congiunta: il Museo archeologico Villa Sulcis, il Parco archeologico di Monte Sirai e il Museo paleontologico E. A. Martel. Il Parco archeologico di Monte Sirai è sicuramente il bene culturale più conosciuto e visitato nel contesto carboniense, comprende l’omonima area archeologica, il
236 Determinazione del Responsabile dei Servizi Culturali del Comune di Carbonia n. 16 del 24 gennaio 2008, Aggiudicazione servizio di gestione unitaria sistema museale cittadino e affidamento servizi-Periodo febbraio-maggio 2008.
237 LR n. 14 del 20 settembre 2006, Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura. Proposta di deliberazione n. 39 del 19 settembre 2007, Legge regionale 20 set-tembre 2006, n. 14, art. 4, lett. f) e art. 21, lett. C). Assegnazione contributi agli Enti locali per interventi di restauro dei beni culturali. Istanza approvata con DGC di Carbonia n. 204 del 19 settembre 2007.
238 DGC di Carbonia n. 246 del 31 ottobre 2007, n. 12 del 7 febbraio 2008, Gestione del Sistema Museale Cittadino-Supporto completamento nuovo allestimento Museo archeologi-co, n. 19 del 18 febbraio 2008, n. 21 del 18 febbraio 2008, n. 36, POR SARDEGNA-Misura 2.1. Lavori di “Completamento del Museo Archeologico Villa Sulcis e realizzazione del deposito e centro di restauro archeologico. Approvazione del Progetto Definitivo/esecutivo del progetto di completamento dei prospetti e n. 37 del 22 febbraio 2008, POR Sardegna-Misura 2.1. Lavori di Completamento del Museo Archeologico Villa Sulcis e realizzazione del deposito e del Centro di restauro archeologico. Approvazione del progetto definitivo/esecuti-vo del progetto di completamento delle coperture, n. 44 del 29 febbraio 2008, Gestione del Sistema Museale Cittadino, n. 100 del 9 maggio 2008, POR Sardegna-Misura 2.1. Lavori di completamento del Museo Archeologico Villa Sulcis e realizzazione del deposito e centro di restauro archeologico-completamento e sistemazioni esterne-Approvazione progetto defi-nitivo/esecutivo, n. 152 del 27 giugno 2008, Progetto di completamento spazi esterni Forge tornerie, Biblioteca e Museo paleontologico. Approvazione progetto esecutivo.
162
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Nuraghe Sirai e le strutture, realizzate dal Comune e aperte nel 2001, che ospi-tano i servizi di accoglienza, la biglietteria, il bookshop, un ristorante ed una sala convegni239.
L’area archeologica, conosciuta già nella prima metà dell’Ottocento, è sta-ta scavata a partire dagli anni Sessanta (prima campagna 1963-1966; seconda campagna 1980-1985) dalla Soprintendenza archeologica per la Province di Cagliari e Oristano, dall’Università di Roma − sostituita nel 1969 dal CNR − e dall’Università di Sassari240. Il sito presenta importanti testimonianze della cultura nuragica e fenicio-punica. L’insediamento fenicio-punico sorge a pochi chilometri dalla costa, in una posizione strategica per il controllo del bacino mi-nerario dell’Iglesiente e della valle del Cixerri, nel punto di raccordo fra il Sulcis e le pianure del Campidano. Il Parco archeologico di Monte Sirai, caso unico in Sardegna, offre la possibilità di visitare in ogni sua parte un centro di tradi-zione prima fenicia e poi punica, perché privo di sovrapposizioni o modifiche da parte di costruzioni successive. L’abitato è costituito da quattro quartieri di forma allungata e tendenzialmente rettangolare, separati da tre strade parallele e composti da case a schiera. A nord dell’abitato si trovano sia la necropoli feni-cia a incinerazione sia quella punica, in cui sono state rinvenute tredici tombe familiari, a camera, scavate nel sottosuolo. A nord delle necropoli si trova la collina del tofet, articolato in un tempietto prospiciente uno spazio aperto desti-nato alla deposizione delle urne cinerarie dei bambini e a stele figurate241.
L’insediamento nuragico del Monte Sirai è posto all’apice dell’omonima col-lina, a circa un chilometro dall’insediamento fenicio-punico e comprende un castello quadrilobato del XIV secolo a.C. e una successiva fortificazione della fine del VII secolo a.C. che si estende per circa per un ettaro. Quest’ultima, costruita dai fenici e abitata da una comunità mista di nuragici e fenici, rappre-sentava un presidio funzionale allo strategico snodo fra il tronco meridionale e quello settentrionale dell’antica strada sulcitana che collegava Sulcis (l’attuale Sant’Antioco) a Cagliari.242 Il Parco archeologico è strettamente collegato al Mu-seo archeologico Villa Sulcis, in cui vengono esposti i reperti di scavo. Il Museo, inaugurato nel 1988, ha sede nell’antica residenza del direttore delle miniere carbonifere, costruita alla fine degli anni Trenta e circondata da un esteso parco.
La raccolta museale ha avuto origine da due donazioni di reperti archeo-
239 Il Parco Archeologico di Monte Sirai in <http://www.comune.carbonia.ca.it>.240 p. BartolonI, Monte Sirai, Sassari 2004, pp. 18-20.241 Si veda la scheda “Abitato del Monte Sirai” sul sito Sardegna Cultura <http://www.sardegnacul-
tura.it> con bibliografia.
242 Carbonia, fortificazioni fenicie di nuraghe Sirai in <http://www.sardegnacultura.it>; scheda museo in Musei in rete nella Sardegna del sud <http://musei.provincia.cagliari.it>.
163
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
logici dovute a privati, la collezione Pispisa e la collezione Doneddu, e offre un ricco repertorio di testimonianze sulcitane dal Neolitico antico fino all’età bzantina243. La maggior parte dei reperti esposti nelle tre sale del Museo provie-ne dai siti archeologici presenti nell’agro di Carbonia, in particolare dal vicino sito di Monte Sirai, un insediamento fondato dai fenici intorno al 750 a.C. e conquistato nel VI secolo a.C. dai cartaginesi. A questi si aggiungono quelli rinvenuti nel territorio di alcuni Comuni limitrofi. Il nucleo principale dell’e-sposizione è costituito dai corredi funerari provenienti dalla necropoli fenicia e da quella punica di Monte Sirai. A quest’insieme di testimonianze si aggiun-ge una piccola ricostruzione del tofet (cimitero-santuario punico riservato ai bambini) del Monte Sirai, con le originali urne cinerarie e le stele scolpite. Nel Museo si svolgono attività didattiche multimediali che introducono alla visita del sito di Monte Sirai244. Grazie ai finanziamenti POR 2000-2006, nel 2004 sono stati avviati i lavori, conclusi poi nel 2008, che hanno dotato il Museo di un altro edificio atto a ospitare i depositi museali, il laboratorio di restauro e i laboratori didattici245.
La terza struttura inserita nella bigliettazione integrata è il Museo Civico di paleontologia e speleologia E. A. Martel, situato nel centro di Carbonia, che descrive la ricchezza e la particolarità del territorio sulcitano dal punto di vista geologico attraverso un’ampia collezione di reperti del periodo compreso fra il Paleozoico e il Quaternario, rinvenuti nel comprensorio. Il Museo è stato isti-tuito nel 1972 per volontà del Gruppo Ricerche Speleologiche che è proprietario della collezione, concessa in comodato d’uso al Comune nel 1996 allo scopo di ampliare e diversificare l’offerta turistico-culturale246. Grazie all’ampiezza e alla ricchezza della raccolta, il materiale esposto viene ruotato periodicamente: il continuo rinnovarsi dell’allestimento conferisce dinamicità al Museo così da renderne sempre interessante e nuova la visita247. Poiché gli ambienti del Mu-
243 Allegato Progetto di gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico e ambientale del territorio comunale alla DGC n. 543 del 2000 cit. La titolarità della struttura che ospita il Museo è del Comune mentre i beni archeologici conservativi sono dello Stato.
244 Carbonia, Civico Museo Archeologico «Villa Sulcis» in <http://www.sardegnacultura.it>.
245 Determinazioni regionali n. 2800 del 2004 cit. e n. 3336 del 2004 cit. Delibere della Giunta Comunale di Carbonia n. 246 del 2007 cit., n. 12 del 2008 cit., n. 21 del 2008 cit., n. 36 del 2008 cit. e n. 37 del 2008 cit., n. 44 del 2008 cit., n. 100 del 9 maggio 2008 cit.
246 DGC n. 777 del 26 luglio 1996; Allegato «Progetto di gestione e valorizzazione del pa-trimonio archeologico e ambientale del territorio comunale» alla DGC n. 543 del 2000 cit.; M. loccI, Un viaggio nel passato attraverso il Martel di Carbonia, «L’Unione Sarda», 23 luglio 2005.
247 Carbonia, Museo civico di Paleontologia e Speleologia E. A. Martel in <http://www.sarde-gnacultura.it>.
164
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
seo erano in locazione allo IACP, il Comune ha deciso di spostarne la sede in un ambiente proprio e più adatto alla fruizione, perciò, nel 2009, il Museo è stato trasferito all’interno del complesso museale di proprietà comunale denominato Grande Miniera di Serbariu248.
La necropoli ipogeica di Cannas di Sotto (periodo Neolitico ed Eneolitico), situata nell’abitato urbano di Carbonia, è oggetto di scavi dal 2006. Le cavità (domu de janas) individuate sino a questo momento sono circa una ventina. Al-cuni degli ambienti funerari rinvenuti dallo scavo sono stati rimaneggiati an-che in età moderna, mentre altri si sono conservati fino a oggi inviolati. Nell’a-rea della necropoli è ubicato anche un antico nucleo abitativo tradizionale del territorio sulcitano (medau o forriadroxiu) che il Comune intende recuperare per inserirlo nel Parco. I reperti rinvenuti durante gli scavi presso Cannas di Sotto sono stati esposti nel Museo archeologico Villa Sulcis, cui il Parco verrà collega-to. Quest’ultimo, infatti, rientra in un disegno dell’Amministrazione comunale che mira a congiungere, mediante un percorso pedonale sopraelevato, i popo-losi quartieri della Città di fondazione con il Museo archeologico e la Biblioteca comunale249.
Dall’aprile 2009, nella bigliettazione integrata del Sistema è stato inserito anche il Museo del Carbone, che non viene però gestito dallo stesso soggetto che si occupa delle altre strutture afferenti al Sistema250. Il Museo, di proprie-tà comunale, è gestito fin dalla sua istituzione dall’associazione CICC (Centro Italiano della Cultura del Carbone), composta per metà dal Comune di Carbonia e per l’altra metà dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna251. Il Museo del Carbone è stato istituito all’inizio del 2006 presso la Grande Miniera di Serbariu, che ospita anche il Museo speleologico Martel252. Non appena saranno terminati i relativi lavori, entreranno inoltre a far parte del Sistema due altri im-
248 Scheda museo in Musei in rete nella Sardegna del sud <http://www.musei.provincia.cagliari.it>; DGC n. 49 del 2005 cit.; Determinazioni regionali (Sardegna) n. 2800 del 2004 cit. e n. 3336 del 2004 cit.
249 DGC di Carbonia n. 49 del 2005 cit.250 Il Museo era stato inserito nel 2006 nel progetto di «gestione e valorizzazione del
sistema museale», presentato dall’Amministrazione comunale di Carbonia alla Re-gione per concorrere al bando di finanziamenti a valere sulla legge regionale n. 7 del 2005. DGC n. 202 del 2006 cit. LR n. 7 del 2005 cit.; DGC n. 61/30 del 2005 cit., M. VenturI, Biglietto unico per visitare i siti culturali, «L’Unione Sarda», 13 agosto 2008.
251 Atto Istitutivo dell’Associazione CICC fra il Consorzio del Parco e il Comune di Carbonia dell’8 febbraio 2006, Rep. 16/2006.
252 Biglietto unico per visitare i siti culturali, «L’Unione Sarda», 13 agosto 2008; Aperto il museo paleontologico, «L’Unione Sarda», 4 giugno 2009.
165
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
portanti progetti elaborati dal Comune per il patrimonio culturale carboniense: un parco archeologico urbano e un “museo diffuso”253.
Il progetto CIAM (Carbonia: Itinerari di Architettura Moderna) si strutturerà, infatti, come un “museo diffuso” dove il complesso urbano della Città di fon-dazione sarà un unico monumento storico, fruibile grazie alla realizzazione di un itinerario che collegherà i luoghi dell’architettura moderna di Carbonia. La realizzazione del CIAM prevede la creazione di cinque stazioni urbane e di due extraurbane, ubicate nelle frazioni di Cortoghiana e Bacu Abis. Ogni stazione sarà caratterizzata da un tema specifico capace di illustrare, attraverso l’archi-tettura e l’urbanistica, la vicenda storica e costruttiva della Città di fondazio-ne, evidenziandone i caratteri originali e i processi di trasformazione. A questo scopo saranno installati pannelli e “totem” informativi nei punti strategici della città, che avranno anche la funzione di arredo urbano254.
Dal 2007 il Sistema museale carboniense è gestito dal Raggruppamento Tempo-raneo di Imprese (RTI) costituito dalle società cooperative Mediterranea, Sistema Museo e La miniera255. L’appalto per la gestione unitaria del Sistema coinvolge al momento della nostra ricerca le seguenti strutture: il Museo archeologico Villa Sulcis compresa l’annessa area di verde pubblico e con possibilità di apertura di un punto ristoro; il Museo di paleontologia e speleologia E. A. Martel; il Parco archeologico di Monte Sirai, comprese le strutture di accoglienza e il servizio di ristorazione, e il Nuraghe Sirai. Dal momento della loro apertura al pubbli-co saranno oggetto dell’affidamento in gestione anche la Necropoli ipogeica di Cannas di Sotto e la visita guidata su appuntamento al percorso CIAM256. Spettano al Comune, e non sono quindi oggetto di appalto, il coordinamento tecnico-amministrativo e la direzione scientifica di tutte le attività del Sistema museale257.
La struttura gestionale del Sistema assume una conformazione di tipo pira-midale al cui vertice si trova l’Amministrazione comunale che lavora in sinto-nia con la direzione scientifica e con quella tecnico-amministrativa.
La direzione tecnico-amministrativa si occupa del coordinamento delle atti-vità del soggetto gestore del Sistema. A quest’ultimo spettano in particolare: la conservazione delle collezioni museali e dei beni archeologici, mediante la re-
253 DGC di Carbonia n. 49 del 2005 cit.254 Ivi.255 Determinazioni comunali del Comune di Carbonia n. 102 del 2007 cit. e n. 16 del 2008
cit.256 Bando di gara allegato alla Determinazione comunale del Comune di Carbonia n. 102
del 2007 cit.257 Art.7 del Capitolato speciale di appalto approvato con Determinazione comunale del
Comune di Carbonia n. 102 del 2007 cit.
166
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
dazione di inventari sotto la supervisione della direzione scientifica; l’apertura al pubblico dei musei e del Parco archeologico di Monte Sirai le visite guidate, il cui contenuto deve seguire le indicazioni della direzione scientifica; la custo-dia e la vigilanza; la manutenzione ordinaria e conservativa, la cura del verde del Parco di Monte Sirai e del Parco di Villa Sulcis; la promozione delle attività espositive e culturali programmate dalla direzione scientifica; la pulizia gior-naliera; la biglietteria; la vendita presso il bookshop; la gestione del punto di ri-storo presso il Parco archeologico di Monte Sirai, la gestione di laboratori per le scuole in accordo con la direzione scientifica; l’organizzazione di escursioni su itinerari archeologici, paleontologici e ambientali, sempre in accordo con la di-rezione scientifica. La ditta appaltatrice ha inoltre facoltà di realizzare eventi e manifestazioni culturali nelle strutture del Sistema museale a patto che non im-pediscano la visita agli spazi aperti al pubblico gestiti per conto del Comune258.
I servizi realizzati dal RTI per il Sistema museale cittadino consistono in vi-site guidate multilingua, laboratori didattici per le scuole per tutte le strutture musealizzate aderenti, un bar e un bookshop presso il Parco archeologico di Monte Sirai. Il gestore si occupa inoltre del noleggio degli spazi idonei all’inter-no del Museo archeologico per convegni o eventi di vario genere. Il servizio di biglietto cumulativo, che non sostituisce comunque la possibilità di acquistare singoli biglietti di ingresso, comprende tutte le strutture attualmente aperte alla visita259 .
La presenza di una direzione scientifica appositamente istituita e realmente funzionante è forse l’elemento di maggior rilievo dell’esperienza carboniense. In realtà il Comune di Carbonia avrebbe voluto affidare tale compito a due figure professionali distinte, una specializzata nel settore archeologico e l’altra in quello paleontologico260. Per mancanza di risorse finanziarie adeguate, però,
258 Art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con Determinazione comunale del Comune di Carbonia n. 102 del 2007 cit.
259 Il Museo Villa Sulcis in particolare dispone di: percorso tattile, laboratorio di ceramica per le attività didattiche, laboratorio di restauro, sala audiovisivi e due postazioni multimediali che consentono una visita virtuale, con annessa ricostruzione del sito di Monte Sirai. All’interno del Parco archeologico di Monte Sirai è presente una strut-tura che ospita una sala mostre e convegni e un punto ristoro; all’interno del Parco è possibile usufruire di percorsi di «archeo-trekking» lungo l’antica Via Sulcitana che collegava Sulcis (l’attuale Sant’Antioco) a Cagliari, nel tratto fra l’abitato di Monte Sirai e l’omonimo nuraghe. Il Museo paleontologico e speleologico E. A. Martel offre un percorso tattile, la consultazione di una banca dati informatizzata sulla cartografia tecnica tematica delle Grotte della Sardegna e l’accesso alla Biblioteca tematica Otta-vio Corona. Schede musei e sito consultabili sul sito <http://www.sardegnacultura.it>.
260 Progetto di gestione approvato con DCCdi Carbonia n. 49 del 2005 cit.
167
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
il Comune ha dovuto optare per l’affidamento della direzione scientifica del Sistema ad un’unica figura professionale − un archeologo scelto dal Comune mediante selezione per titoli − al quale è stata assegnata anche la direzione del Museo archeologico e di quello paleontologico261.
L’importo dell’appalto per la gestione del Sistema museale comprende le spese di fornitura e quelle per la retribuzione del personale «per quanto altro oc-corra ad assicurare gli interventi ed i servizi affidati alla ditta aggiudicatrice»262. Le spese del Sistema museale sono coperte mediante contributi regionali a vale-re sulla legge regionale 4/2000 per la gestione del personale poi impiegato nei beni culturali di ente locale; a queste risorse vanno aggiunti gli stanziamenti del bilancio comunale a valere sui fondi finalizzati all’occupazione e una quo-ta d’investimento annuale del soggetto gestore del Sistema263. Quest’ultimo si deve impegnare a investire nell’ambito delle attività promozionali per il Siste-ma una somma al primo anno non inferiore al 15% dell’importo a base d’asta e non inferiore al 20% e 30% rispettivamente al secondo e terzo anno.
Il Capitolato d’appalto prevede anche premi economici al soggetto gestore, nel caso in cui si registri un sensibile aumento del numero di visitatori annuali per le strutture del Sistema. Ad esempio, se nel primo anno di gestione il numero di visitatori complessivo sarà superiore alle 12.000 unità, la ditta avrà diritto a un premio di 5.000 euro da detrarre dalla somma di investimento annuale264. Il soggetto gestore ha inoltre diritto ai proventi della bigliettazione e delle vi-site guidate alle strutture di competenza, nonché agli introiti del punto ristoro e del bookshop. Le spese di energia elettrica, consumo idrico, manutenzione ordinaria e servizio telefonico sono a carico del gestore unico, mentre quelle per l’illuminazione del Parco di Villa Sulcis sono a carico del Comune. L’am-mistrazione comunale vuole stimolare in questo modo il gestore del Sistema verso una maggiore imprenditorialità per l’organizzazione dei servizi e delle funzioni dei musei, così come previsto peraltro dalla stessa legge regionale n. 4 del 2000 e soprattutto dalla relativa delibera di attuazione265. A partire dal 2000, infatti, la Regione Sardegna si è fatta promotrice dell’idea che musei e strutture assimilabili di proprietà di Enti locali debbano sviluppare attività finalizzate al
261 Informazione gentilmente concessa dal dott. Elio Mei, referente comunale per il Siste-ma, tramite comunicazione orale in data 12 novembre 2009.
262 Bando di gara allegato alla Determinazione comunale del Comune di Carbonia n. 102 del 2007 cit.
263 Ivi.264 Art. 7 Capitolato Speciale d’Appalto approvato con DCC di Carbonia n. 102 del 2007 cit.265 LR n. 4 del 2000 cit. DGR n. 36/6 del 2000 cit.
168
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
raggiungimento dell’indipendenza economica266. In sintonia con le precedenti leggi regionali n. 28 del 1984 e n. 11 del 1988, la Regione ha sostenuto la crescita dell’occupazione in Sardegna erogando finanziamenti a quegli Enti locali che avessero provveduto ad affidare a cooperative composte per lo più da giovani e donne la gestione dei beni culturali di spettanza267. In questo modo la Regione ha posto il settore dei beni culturali all’interno di dinamiche che si sono rive-late essenzialmente di tipo assistenzialistico. Le direttive della legge regionale 4/2000 si muovono invece in direzione opposta, invitando gli Enti locali a ge-stire i propri musei mirando all’autonomia finanziaria, attraverso l’attivazione di servizi “redditizi”268. Malgrado la volontà dell’Amministrazione comunale dobbiamo però segnalare che il Sistema Museale Cittadino di Carbonia non di-spone attualmente di propri e unitari strumenti di comunicazione; infatti il materiale pubblicitario e le iniziative per la promozione del patrimonio hanno riguardato fino ad adesso le singole strutture del Sistema. Tale carenza può for-se essere motivata dal fatto che solo di recente, nel 2008, la nuova RTI ha preso in gestione il Sistema museale carboniense e quindi non ha ancora avuto il tempo per avviare una concreta attività promozionale unitaria del sistema269.
¬ Conclusione
L’esperienza carboniense presenta quattro elementi che la contraddistinguo-no all’interno del panorama isolano: la precocità dell’ideazione, la volontà di coinvolgere altri soggetti pubblici del territorio, l’innovazione nelle pratiche di gestione adottate e la presenza di un direttore scientifico.
Nel 1999, prima cioè dell’emanazione della legge regionale 4/2000, a Car-bonia circolava già l’idea di gestire i beni in maniera unitaria e con una pro-grammazione prolungata (piano gestionale triennale); questi aspetti sono ov-viamente estremamente positivi, soprattutto dal punto di vista gestionale ed economico, poiché tendono a ottimizzare le risorse e a coordinare le attività in una prospettiva di più ampio respiro, come prova la volontà di creare reti terri-
266 a. hInna, M. MInnutI, a. cadelano, Un nuovo approccio per la gestione dei beni culturali nella Regione Sardegna, in R. GroSSI (a cura di), Cultura tra identità e sviluppo, III Rappor-to Annuale Federculture, Il Sole 24 ORE S.p.a., Milano 2006, p. 190.
267 LR n. 28 del 1984 cit. e n. 11 del 1988 cit.268 LR n. 4 del 2000 cit. e DGR n. 36/6 del 2000 cit.269 Informazioni attinenti le emergenze culturali di Carbonia sono contenute nel sito
ufficiale della Regione dedicato al patrimonio culturale <www.sardegnacultura.it> e nel sito istituzionale del Comune <http://www.comune.carbonia.ca.it> nel quale però non viene fatta menzione dell’esistenza del Sistema Museale Cittadino.
169
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
toriali, in anticipo sulle direttive regionali esplicitate nel 2005 con il documento di indirizzo Sistema Regionale dei musei, Piano di razionalizzazione e sviluppo270. In altri termini, a livello comunale, si comprende che è necessario snellire le strutture di gestione integrandole in un soggetto unico e che è necessario creare una pianificazione delle attività, per evitare sovrapposizioni e per utilizzare al meglio e in maniera più consapevole le risorse disponibili.
La volontà di creare una rete di relazioni con altri Enti locali al fine di mi-gliorare e incrementare l’offerta turistico-culturale del territorio provinciale, manifestata dal Comune di Carbonia nel progetto elaborato nel 2000, era sta-ta peraltro già esplicitata in un’altra occasione. Nella seconda metà degli anni Novanta i Comuni di Carbonia, Arzachena e Guspini avevano promosso la realizzazione di una rete telematica di servizi per il turismo, all’interno della Misura 5b del Programma Operativo Multiregionale (POM) 1995-1999 Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell’obiettivo 1271. Questi altri orientamenti, quindi, dimostrano che si comprende la necessità di integrare i servizi e l’offerta culturale allargando l’interesse a porzioni territoriali di area vasta, varcando ovviamente i confini comunali. Questa linea fu perseguita an-che in seguito ed estesa ad altri settori. Nel 2006, il Comune di Carbonia ha firmato, assieme ad altri dieci Comuni del comprensorio provinciale − Sant’An-tioco (come capofila), Buggerru, Carbonia, Carloforte, Fluminimaggiore, Giba, Narcao, Perdaxius, Santadi, San Giovanni Sergiu, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio − un protocollo d’intesa per la creazione di un Sistema integrato per la gestione dei beni culturali e ambientali del Sulcis-Iglesiente272. Il progetto, cui Carbonia avrebbe preso parte col proprio sistema museale cittadino, doveva incentrarsi sulla promozione culturale e turistica del patrimonio archeologico e ambientale del territorio di riferimento e sull’integrazione gestionale, compren-siva di bigliettazione congiunta, delle realtà musealizzate presenti nei diversi centri coinvolti273.
La volontà di creare tale sistema territoriale risulta presente anche nel docu-mento allegato al Piano regionale triennale preliminare per i musei, i beni culturali ed i luoghi della cultura del 2008, che conteneva le proposte degli Enti locali relative alle esperienze sistemiche da attuare. Tuttavia, nonostante queste dichiarazioni
270 Approvato con DGR n. 36/5 del 26 luglio 2005.271 Centro servizi per lo sviluppo del turismo culturale nella Regione Sardegna costituito da poli
territoriali collegati in rete telematica in <http://www.comune.carbonia.ca.it>. 272 Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Sant’Antioco n. 137 del 29
novembre 2006, Approvazione e adesione accordo di programma per realizzazione di un sistema integrato per la gestione dei beni culturali e ambientali.
273 Protocollo d’intesa approvato con Delibera del Commissario Straordinario del Comu-ne di Sant’Antioco n. 137 del 2006 cit.
170
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
di intenti, dal momento della firma del protocollo d’intesa tra i Comuni le atti-vità per il sistema integrato sono state praticamente nulle274. Nel gennaio 2007 è stato nominato un Comitato di programmazione e coordinamento, cui avrebbe dovuto seguire l’istituzione di un gruppo di lavoro per avviare l’esperienza di sistema275. Di fatto il progetto, malgrado la partecipazione finanziaria dei Comuni aderenti come stabilito dal Protocollo d’intesa, si è bloccato: ancora nel 2009, pur essendo stato bandito un concorso per la selezione di consulenti per l’attuazione del sistema intercomunale, non risulta avviata nessuna attività, tanto che alcuni dei Comuni partecipanti hanno manifestato la volontà di rece-dere dall’accordo276.
Un altro aspetto che connota fortemente il Sistema Museale Cittadino di Car-bonia è l’organizzazione degli organi di gestione e, in particolare, la presenza di una direzione scientifica, realmente operante. Al Direttore scientifico, un ar-cheologo, è stata affidata la gestione di tutti gli aspetti prettamente culturali del progetto, dall’organizzazione delle esposizioni temporanee e dell’attività didattica alla verifica dei contenuti delle visite guidate277. In parallelo, la solu-zione dell’istituzione di premi al gestore per l’implementazione dei visitatori e l’obbligo per questo di reinvestire annualmente quote di denaro importanti per la promozione del Sistema, evidenziano la ricerca di soluzioni nuove a pro-blemi piuttosto diffusi come quello dello scarso flusso di visite278. Tutti questi fattori testimoniano la volontà manifestata dall’Amministrazione comunale di
274 Allegato C alla DGR n. 29/11 del 22 maggio 2008, Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura. Art.7-Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura.
275 In base all’articolo 5 del Protocollo d’intesa è previsto per ogni aderente il versamento all’ente capofila di una quota annua pari a 1,5 euro per abitante. Protocollo d’intesa approvato con Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Sant’Antioco n. 137 del 2006 cit. Avviso di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione, Comune di Sant’Antioco, 24 giugno 2009.
276 Avviso di selezione comparativa cit., Comune di Sant’Antioco, 24 giugno 2009; Gestione dei beni culturali: Comuni in Fuga, flop del progetto, «L’Unione Sarda», 6 novembre 2009.
277 Dalla ricerca condotta dal LARTTE sui sistemi museali in Italia, risulta che la direzio-ne scientifica unitaria per un sistema si realizzi in genere dopo molti anni dall’avvio delle attività sistemiche. Si veda la schedatura nel sito ufficiale del progetto <http://www.sistemimuseali.sns.it>.
278 Come rilevava il rapporto Innovacultura nel 2005, uno degli elementi critici del Si-stema è stata la stasi nel numero di visitatori, ferma a circa seimila presenze l’an-no. Un altro problema fu ravvisato nella scarsa capacità imprenditoriale del Sistema, imputata al fatto che fosse allora lo stesso ente locale a incamerare i proventi della biglietteria. reGIone autonoMa della SardeGna, Federculture, Progetto di monitoraggio e valutazione delle iniziative progettuali avviate in attuazione della normativa di cui all’arti-colo 92 LR 11/1988 e all’art.38 della LR 4/2000. Rapporto Finale, Cagliari 2005 p. 144.
171
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Carbonia di rendere la promozione dei beni culturali un’importante e concreta occasione di sviluppo economico-sociale per la comunità e per l’intero territo-rio provinciale, come ben dimostra anche il continuo impegno nel realizzare connessioni con gli altri Enti locali al fine di sviluppare il turismo in tutta l’area del Sulcis Iglesiente.
L’esperienza del Sistema museale cittadino attesta inoltre come il Comune di Carbonia consideri lo sviluppo del turismo culturale una risorsa necessa-ria per riuscire a superare le ricadute negative della crisi del settore estrattivo, che negli ultimi decenni ha duramente colpito la comunità, legata sin dalla sua origine alla produzione mineraria279. L’importanza che l’Amministrazione co-munale di Carbonia attribuisce all’incremento di un turismo non solo balneare ma anche culturale, e quindi destagionalizzato, è ulteriormente confermata dal fatto che nello stesso territorio insistono anche il Museo del carbone e il Parco Geominerario, sviluppati a seguito della crisi del settore estrattivo per convertire in chiave turistica gli stabilimenti minerari che dagli anni Settanta venivano progressivamente abbandonati in Sardegna280.
279 Si veda, come esperienza analoga e più complessa, quella del Parco Geominerario Sto-rico e Ambientale della Sardegna per il quale si rimanda alla scheda in questo stesso vo-lume, in particolare per la ricostruzione delle vicende della dismissione delle attività estrattive in rapporto con la musealizzazione degli ex impianti.
280 Ivi.
172
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
5 Sistema museale Sa domu de is ainas di Armungia [Borgioli]
Il Sistema museale Sa domu de is ainas nasce come progetto di gestione inte-grata per il patrimonio culturale locale, promosso dal Comune di Armungia, un piccolo centro della provincia di Cagliari. Al momento della nostra indagi-ne il Sistema comprende i beni musealizzati di pertinenza comunale – Museo etnografico Sa domu de is ainas, Bottega del Fabbro e Nuraghe – e si concretizza mediante l’attivazione di un biglietto integrato e l’affidamento della gestione a un unico soggetto, la cooperativa Agorà Sardegna.
¬ I precedenti
Il paese di Armungia, che diede i natali al politico e scrittore Emilio Lussu, all’inizio degli anni Ottanta è stata sede di un importante esempio di “museo-grafia spontanea”: le donne del paese, guidate da un’anziana maestra elemen-tare, iniziarono a raccogliere oggetti d’uso quotidiano allo scopo di traman-dare alle giovani generazioni le tradizioni locali che col passare del tempo si stavano inesorabilmente perdendo281. Infatti Armungia, dagli anni Sessanta, è stato uno dei centri dell’entroterra sardo maggiormente colpito dal fenomeno dello spopolamento, causato dal forte richiamo esercitato dalla concentrazione delle attività economiche in determinate aree industriali o costiere dell’Isola282. Per evitare che l’emigrazione comportasse la perdita delle radici storiche e tra-dizionali della comunità, le donne armungesi dettero avvio al recupero delle attestazioni della cultura contadina e pastorale. Questa vicenda è alla base degli ulteriori sviluppi che condurranno l’Amministrazione comunale a elaborare il progetto di messa a sistema del patrimonio culturale locale nel 2000283. La rac-colta del materiale etnografico ebbe come conseguenza diretta la realizzazione di un primo allestimento museale, inaugurato il 4 dicembre 1982 in occasione dell’anniversario della nascita dell’illustre compaesano Emilio Lussu284. L’al-lestimento del Museo armungese si articolava in una serie di sezioni dedica-te ciascuna a una diversa attività produttiva e alla dimensione domestica, cui si aggiungeva il settore in cui fu esposta la collezione di fotografie legate alla vita di Emilio Lussu, provenienti dall’Istituto sardo per la storia della Resistenza
281 S. FerracutI, Cose di Armungia, «Lares» 1, 2006, pp. 99-131.282 F. tIraGallo, Le migrazioni e il lavoro della memoria ad Armungia, «Lares» 1, 2006, pp.11-
34.283 DGC di Armungia n. 87 del 26 ottobre 2000, Approvazione progetto di gestione “Museo
Storico Etnografico” di Armungia L. R. n. 4/2000 – Art. 38.284 M. G. da re, Il Museo storico ed etnografico “Sa domu de is ainas” di Armungia: riflessioni
dopo un sogno, «Antropologia Museale», 3, 2003.
173
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
e dell’Autonomia285. Qualche anno più tardi, nel 1986, il Comune di Armungia, in occasione dei lavori di ristrutturazione del palazzo denominato ex Municipio e già sede del Museo etnografico, provvide ad affidare all’antropologa Maria Gabriella Da Re, docente presso l’Università di Cagliari, l’incarico di elaborare un nuovo e più puntuale progetto museografico286. Nel 1987 il Comune assegnò la gestione del Museo alla cooperativa Curatoria Bonurzuli che, pur non essendo del luogo, impiegò comunque parte delle donne che erano state attive nella realizzazione del Museo. La parentesi gestionale realizzata da questa coopera-tiva durò però solamente un anno, mentre i lavori per il nuovo allestimento del Museo etnografico si protrassero per oltre un decennio. Dalla metà degli anni Novanta anche l’Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE) partecipò al pro-getto di riallestimento del Museo; il compito dell’ISRE fu analizzare i manufatti suggerendone in alcuni casi il restauro287.
Contemporaneamente ai lavori di riallestimento del Museo Sa domu de is ainas venivano condotti anche altri interventi sul patrimonio museale: in quegli stessi anni si procedeva alla musealizzazione di un’altra antica struttura pre-sente nel centro storico, la Bottega del fabbro che diventerà un altro polo di tipo etnografico del sistema comunale288.
Nel 2000 il Comune inaugurò il nuovo allestimento del Museo etnografico Sa domu de is ainas e, in un secondo momento, la cosiddetta Bottega del Fabbro; le strutture si aggiunsero agli altri beni che costituiscono il patrimonio culturale armungese: il Nuraghe Armungia, la chiesa parrocchiale del XVI secolo e la casa natale di Emilio Lussu289. I beni di spettanza comunale sono esclusivamente il Museo etnografico, la Bottega del Fabbro e il Nuraghe mentre la chiesa e la dimora di Lussu appartengono a privati. Il Nuraghe sorge su un terreno di proprietà co-munale e, sebbene non esista una formale convenzione con la Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano, la gestione dei servizi alla visita è garantita da tempo dallo stesso Comune in accordo con la Soprinten-denza290.
285 S. FerracutI, Cose di Armungia, cit.286 M. G. da re, Il Museo storico, cit.287 L’informazione relativa al ruolo svolto dall’ISRE si deve alla prof.ssa M.G. Da Re,
curatrice del Museo etnografico di Armungia, tramite comunicazione scritta in data 3 novembre 2009.
288 S. FerracutI, Cose di Armungia, cit. 289 Armungia. Il museo. Taglio del nastro per “Sa domu de is ainas”, «La Nuova Sardegna», 13
ottobre 2000.290 Informazione gentilmente fornita dalla dott.ssa Manunza, referente per l’area di Ar-
mungia per la Soprintendenza Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano,
174
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
¬ Il primo progetto di sistema
Agli inizi degli anni Duemila, il Comune si trovò a gestire tre strutture aper-te al pubblico: i due musei etnografici e il Nuraghe. L’Amministrazione comuna-le decise allora, anche per riuscire a intercettare le risorse economiche stanziate dall’articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000, di elaborare un primo pro-getto di gestione congiunta per questi beni291. La norma regionale predispone-va infatti contributi finanziari agli Enti locali per la gestione affidata a terzi di propri beni culturali, a patto che venisse presentato alla Regione un puntuale progetto di gestione triennale292.
Dopo aver presentato con successo nel 2001 un progetto per la «Gestione del Sistema Museale Comunale» al bando regionale di finanziamento relativo alla legge regionale 4/2000293, a partire dal 2002 il Comune di Armungia deli-berò di appaltare a terzi la gestione dell’insieme dei beni di sua competenza, denominando l’operazione Sa domu de is Ainas294. Risultò vincitrice dell’appalto la cooperativa Agorà Sardegna e in tal modo prese concretamente avvio una ge-stione unitaria dei beni tramite l’affidamento della gestione a un soggetto unico e tramite l’attivazione di un apposito biglietto integrato295. Il soggetto gestore
tramite comunicazione orale in data 3 novembre 2009.291 DGC di Armungia n. 87 del 2000, cit. LR n. 4 del 20 aprile 2000, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000). DGR n. 36/6 del 5 settembre 2000, L.R. n. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archivi. Con-tributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante conven-zione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali, biblioteche e archivi. Cap. 11129 del bilancio regionale. Direttive istruttorie e pubblicazione nel BURAS, a norma dell’art. 19 della L.R. 22.8.1990, n. 40.
292 LR n. 4 del 2000 cit. e DGR n. 36/6 del 2000 cit. 293 DGC di Armungia n. 74 del 23 novembre 2001, L.R. 4/2000 art. 38-Progetto gestione
Sistema Museale Comunale. Contribuzione finanziaria a carico del Bilancio Comunale.294 DGR n. 36/32 del 23 ottobre 2001, L. R. 4/2000, art. 38 Beni culturali, biblioteche e archivi.
Contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante con-venzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambien-tali, biblioteche ed archivi. Programma triennale 2001-2003. Annualità 2001. Cap. 1129 UPB S 11031 bilancio regionale. DGR di Armungia n. 74 del 23 novembre 2001, cit.; DGC di Armungia n. 62 del 18 luglio 2002, Affidamento Servizio Gestione Museo-Atto d’indirizzo e Nomina Commissione; Determinazione del Responsabile Settore Amministrativo del Comune di Armungia n. 94 del 2 agosto 2002, Indizione asta pubblica per l’affidamento della Gestione del Sistema Museale Comunale di Armungia-Approvazione dell’Avviso d’Asta e del Capitolato Speciale d’Appalto.
295 Determinazione del Responsabile Settore Amministrativo del Comune di Armungia n. 112 del 30 agosto 2002, Aggiudicazione asta pubblica per l’affidamento annuale in ge-
175
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
aveva in particolare l’incarico di occuparsi dell’apertura, della biglietteria con-giunta, dei servizi di visita guidata alle strutture di pertinenza comunale e del-la loro manutenzione e pulizia296. Il Capitolato Speciale d’Appalto stabilisce nello specifico che il soggetto gestore svolga gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti (idrico, antincendio, antifurto, etc.) e delle strutture del Sistema, occupandosi anche della loro pulizia giornaliera e della cura del verde nelle aree pertinenti297. La cooperativa deve poi garantire i servizi di bigliettazione integrata, comprensiva di visita guidata e apertura del bookshop. Altre attivi-tà che coinvolgono il gestore sono l’organizzazione di mostre tematiche e la vendita di gadget e di pubblicazioni a carattere scientifico e promozionale298. Il Comune assicura la continuità nei servizi e nelle funzioni del soggetto gestore rinnovando annualmente il contratto d’appalto299. Nella prima fase dell’espe-rienza sistemica, che coincise con il biennio 2002-2004, il Comune assegnò alla cooperativa anche il compito di svolgere, previo accordi con i proprietari, visite guidate nelle due strutture non comunali, ovvero la chiesa intitolata alla Beata Vergine Maria e la Casa di Emilio Lussu300.
Tra il 2002 e il 2004, il Sistema museale armungese non si è limitato, così come previsto dal progetto, a operare solamente per i beni di pertinenza co-munale, ma ha esteso parte dei propri servizi, pur se in maniera del tutto infor-male, anche ad altre strutture culturali presenti in paese301. In questo modo il Comune è riuscito a creare, per il periodo indicato, un circuito museale esteso
stione del “Sistema Museale Comunale di Armungia”-Approvazione atti di gara. Contratto d’appalto servizio annuale di gestione del Sistema museale comunale “Sa Domu de is Ainas” Rep. n. 04 del 1 ottobre 2002. Capitolato Speciale d’Appalto approvato con DGC di Ar-mungia n. 94 del 2000 cit.
296 Art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con DGC di Armungia n. 94 del 2000 cit.
297 Ivi. Lo stesso articolo stabilisce l’obbligo per il soggetto gestore di presentare mensil-mente all’Amministrazione comunale il prospetto riepilogativo della bigliettazione giornaliera relativa al Sistema museale.
298 Art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con DGR di Armungia n. 94 del 2000 cit. Progetto triennale di gestione Sistema Museale Comunale “Sa domu de is ainas” 2006-2008, approvato con la DGC di Armungia n. 102 del 2004 cit. Cfr. R. Serreli, I “Diavoli rossi” sbarcano nel Gerrei, «L’Unione Sarda», 3 agosto 2002.
299 Contratto d’appalto servizio annuale di gestione del Sistema museale comunale “Sa Domu de is Ainas” Rep. n. 04 del 1 ottobre 2002.
300 Art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con DGC di Armungia n. 94 del 2000 cit.
301 G. Bulla, Armungia. Le iniziative della giunta comunale. Strade, case e chiese: l’idea del museo-diffuso, «La Nuova Sardegna», 26 ottobre 2002. DGR di Armungia n. 87 del 2000 cit.
176
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
all’intero territorio comunale, sebbene le visite guidate ai beni di proprietà del-la Parrocchia e della famiglia Lussu avessero luogo secondo la disponibilità dei proprietari302.
¬ 2004. Secondo progetto di sistema
Nel 2004 l’Amministrazione comunale di Armungia ha presentato un nuovo progetto di gestione per il Sistema museale allo scopo di usufruire dei finanzia-menti previsti per il triennio 2003-2005 dalla legge regionale 4/2000303. Il pro-getto elaborato in quest’occasione (attivo al momento della nostra indagine) comprende esclusivamente le strutture di spettanza comunale: il Museo etno-grafico Sa domu de is ainas, la Bottega del fabbro ed il Nuraghe Armungia.
Il Sistema museale si configura come un percorso guidato ai principali mu-sei e monumenti cittadini, che ha come proprio centro il Museo Sa somu de is ai-nas, prima struttura in ordine di tempo e per importanza del progetto. Qui sono attivi il servizio di biglietteria integrata (unico tipo di bigliettazione fornita) e bookshop ed è da qui che partono le visite guidate alle altre emergenze cultu-rali cittadine. Attualmente il Museo è organizzato in sei sale tematiche: Sala dei lavori delle donne, Sala dell’agricoltura, Sala dell’artigianato del ferro, Sala del territo-rio, dell’abitato, delle risorse del bosco e della pastorizia, Sala delle immagini e dei suoni e Sala Lussu. Nelle prime quattro sale sono esposti gli oggetti caratteristici delle diverse attività tradizionali locali. La Sala delle immagini e dei suoni si differenzia dalle altre perché è dedicato alla fruizione di materiale multimediale (filmati e registrazioni audio), che permette di ricostruire alcuni momenti della vita quotidiana della comunità locale. La sezione dedicata a Emilio Lussu espone invece fotografie, documenti e altre testimonianze sulla vita del politico e scrit-tore armungese fondatore, nel 1919, del Partito Sardo d’Azione. Nel complesso, i contenuti del Museo e l’allestimento con i suoi apparati connotano la struttura come fortemente didattica e rivolta soprattutto al pubblico delle scolaresche304.
La seconda tappa del circuito del Sistema è il Nuraghe Armungia che sor-ge nelle immediate vicinanze del Museo etnografico, cui è collegato mediante
302 Art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con DGC di Armungia n. 94 del 2002 cit.
303 DGC n. 102 del 29 ottobre 2004, Approvazione progetto di gestione triennale del Sistema Museale di Armungia “Sa Domu de is Ainas” a valere sui fondi della L.R. 4/2000 art. 38-Se-condo Triennio. LR n. 4 del 2000, cit.; DGC n. 36/6 del 2000, cit.
304 Progetto triennale di gestione Sistema Museale Comunale “Sa domu de is ainas” 2006-2008, approvato con la DGC di Armungia n. 102 del 2004 cit. Cfr. sito web ufficiale del Sistema museale, all’indirizzo <http://www.comune.armungia.ca.it/sistemamuse-ale/sistema.html>.
177
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
una passerella per agevolarne la fruizione. Quello armungese è un raro caso di costruzione nuragica conservatasi all’interno di un centro abitato. La torre tronco-conica, edificata tra il XIV e il XV secolo a.C., pur avendo subìto alcune modifiche nel corso di più di tre millenni, conserva ancora intatta la propria struttura interna che viene messa in risalto da un sistema di illuminazione ap-positamente ideato305.
Nella Bottega del fabbro sono invece visitabili gli ambienti musealizzati dell’antica officina del fabbro del paese, attiva dal 1928. Qui vengono ripropo-ste, mantenendo intatta la destinazione d’uso dei vari ambienti, le attività che vi si svolgevano in passato, evidenziando il loro stretto legame con il mondo agropastorale306.
Con il progetto del 2004 sono esclusi dal Sistema museale i beni di proprietà privata, come la Casa Lussu e la chiesa del XVI secolo, inclusi nel percorso di visita del progetto di gestione elaborato nel 2000307.
¬ Gestione finanziaria
Il costo complessivo del progetto di Sistema museale è garantito da finan-ziamenti pubblici regionali e comunali. Come disposto dalla legge regionale 4/2000, i contributi elargiti dalla Regione coprono le spese relative al personale non impiegato nei servizi aggiuntivi, che costituiscono il 90% del costo tota-le308. L’Amministrazione comunale provvede a finanziare con propri fondi di
305 Ivi.306 L’allestimento si articola nei due piani che compongono l’edificio: al piano terra si
trovano la fucina e l’ambiente di lavoro, dove sono esposti gli attrezzi di grosse di-mensioni, come il mantice, autentici e appositamente restaurati; nelle vetrine del se-condo piano, l’abitazione vera e propria, sono conservati invece tutti quegli utensili di piccole dimensioni, come pinze e tenaglie, propri del mestiere del fabbro ferraio (su ferreri). La collezione è arricchita da alcune testimonianze fotografiche che raccon-tano la storia della famiglia Vellini, che dal 1928 fino agli anni Novanta esercitò in paese questa professione.
307 DGC di Armungia n. 87 del 2000 cit. Capitolato Speciale d’Appalto approvato con DGC di Armungia n. 94 del 2002 cit. Cfr. L. pIraS, Porte sprangate nella casa di Lussu, «L’U-nione Sarda», 14 marzo 2006.
308 LR n. 4 del 2000 cit.; DGR n. 36/6 del 2000 cit., DGC n. 36/32 del 2001 cit. e n. 25/19 del 1 giugno 2005, Contributi agli Enti Locali della Sardegna per concorrere agli oneri de-rivanti dalla gestione dei beni culturali Art. 12 comma 3 L.R. del 21 aprile 2005 n. 7 UPB S11.030 Cap. 11212 euro 7.070.000. La legge regionale n. 4 del 2000 e la successiva delibera di attuazione DGC n. 36/6 del 2000 concedono agli Enti locali risorse econo-miche per la gestione del patrimonio culturale di pertinenza nelle seguenti misure: l’80% dei costi al primo anno, il 70% e il 60% rispettivamente al secondo e al terzo
178
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
bilancio sia le spese per il personale non liquidate con i contributi regionali sia le spese di gestione, pari al 10% del costo totale annuale del progetto, mentre le spese relative alla gestione corrente delle strutture (fornitura idrica, elettrica, pulizia e manutenzione delle strutture) sono a carico del soggetto gestore309. I ricavi della bigliettazione integrata sono accreditati al Comune, mentre spetta-no al gestore gli incassi dovuti alla vendita di pubblicazioni e gadget qualora siano realizzati dallo stesso310. Nel caso di eventi espositivi o manifestazioni con ingresso a pagamento organizzati dal gestore, il guadagno della bigliettazione è assegnato al Comune per la quota relativa al biglietto d’ingresso alle strutture del Sistema, e al gestore per l’eventuale quota eccedente311.
Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale di Armungia ha saputo in-tercettare diverse risorse pubbliche allo scopo di implementare l’offerta cultu-rale del Sistema: nel 2004 il Comune ha ricevuto, attraverso la Comunità Mon-tana XXI, i finanziamenti a valere sulla Misura 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici del POR Sardegna 2000-2006, finalizzati al recupero del centro storico e all’ampliamento del Sistema museale312. I suddetti finanziamenti hanno reso possibile il restauro dell’edificio denominato Casa del Segretario, da destinare a sede del costituendo Museo Joyce ed Emilio Lussu, e delle cosiddette Case minime, da adibire a labora-tori didattici per il Sistema museale313. Sempre nel 2004 il Comune di Armungia ha ottenuto i finanziamenti a valere sulla legge regionale n. 26 del 1997 e desti-nati alla creazione di un museo mineralogico314. Dal momento della loro aper-tura queste strutture, tutte di pertinenza comunale, entreranno a far parte del
anno. Per gli anni successivi al terzo la Regione, con delibera n. 25/19 del 2005, ha stabilito di prorogare i finanziamenti ai progetti ex lege 4/2000, destinando loro con-tributi pari al 60% delle spese ammissibili descritte.
309 DGC di Armungia n. 87 del 2000 cit. e n. 74 del 2001 cit. Art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con determinazione comunale n. 94 del 2000 cit.
310 Ivi, artt. 9 e 10.311 Ivi, art. 10.312 Determinazioni del Servizio beni culturali della Regione Sardegna n. 2800 del 22 set-
tembre 2004 e n. 3336 del 23 novembre 2004.313 Determinazioni del Servizio beni culturali della Regione Sardegna n. 2800 del 22 set-
tembre 2004 e n. 3336 del 23 novembre 2004.314 LR n. 26 del 15 ottobre 1997, Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua del-
la Sardegna. DGR n. 54/44 del 30 dicembre 2004, L.R. 15.10.1997, art. 13. Contributi a Università, istituzioni scolastiche, enti locali, soggetti operanti nel settore culturale per l’attuazione di interventi a tutela della cultura e della lingua sarda. Programma d’intervento 2004. UPB S11.020 Cap. 11309-00. Bilancio Regionale 2004.
179
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
circuito di visita del Sistema museale armungese e la bigliettazione integrata verrà adattata alle nuove esigenze315.
L’Amministrazione comunale di Armungia si è attivamente adoperata, nel primo decennio degli anni Duemila, nella realizzazione della messa in rete del proprio patrimonio culturale, creando una sorta di «museo diffuso» finalizzato a recuperare e promuovere la conoscenza delle tradizioni locali e promuove-re il settore turistico per l’economia cittadina316. Per raggiungere l’obiettivo, il Comune ha anche manifestato la volontà di creare un sistema intercomunale con i Comuni limitrofi; nel Progetto triennale di gestione del sistema, approvato nel 2004, è affermata l’intenzione di costituire una rete museale con il vicino Comune di Villasalto, sede di un museo minerario, da realizzarsi mediante l’at-tivazione di un biglietto integrato317. Alla stessa volontà del Comune di Armun-gia di creare una gestione sistemica del patrimonio culturale del territorio del Gerrei va ricondotto il progetto Pranus perdas e isteddus presentato nel 2006 da un gruppo di Comuni del territorio – San Basilio, in qualità di capofila, Armun-gia, Ballao, Goni, Silius, Sant’Andrea Frius, San Nicolò Gerrei e Villasalto – al bando di selezione degli interventi a valere sulla Misura 5.1 Politiche per le aree urbane del POR Sardegna 2000-2006318. Quest’ultimo progetto, al 2009 non anco-ra non avviato, ha l’obiettivo di rafforzare l’offerta dell’accoglienza nel Gerrei, mediante la messa in rete di servizi alla visita319.
¬ Conclusioni
Nel caso di Armungia si registra una sensibilità capillare e diffusa, mani-festata dai primi anni nella volontà popolare di recuperare e tramandare le tradizioni locali mediante l’allestimento di un museo; da questa iniziativa si è sviluppata l’azione del Comune che, nel corso degli anni, ha progressivamen-te costituito piccole ma concrete realtà culturali che, progressivamente, hanno acquisito finanziamenti e si sono rafforzate. Grazie agli indirizzi regionali dei
315 DGR n. 54/44 del 2004 cit.316 DGC di Armungia n. 102 del 2004 cit. Determinazioni del Servizio beni culturali della
Regione Sardegna n. 2800 del 2004 cit. e n. 3336 del 2004 cit. 317 DGC di Armungia n. 102 del 2004 cit. Tale progetto non è ancora stato avviato.318 Determinazione del Direttore del Servizio aree urbane e centri storici della Regione
Autonoma della Sardegna n. 473/CS del 30 giugno 2006.319 DGR n. 29/21 del 22 maggio 2008, Programmazione 2007-2013 Asse V-obiettivo 5.2.1.
Bando CIVIS e n. 26/3 del 3 giugno 2009, POR FESR 2007-2013-Asse V “Sviluppo urbano”-obiettivo operativo 5.2.1. Bando CIVIS. Modifica delib. G. R. n. 29/21 del 22.5.2008.
180
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
primi anni Duemila e ai relativi finanziamenti, ad Armungia si è realizzata una prima esperienza di gestione congiunta e di messa a sistema del patrimonio locale; la tendenza più recente a un’espansione intercomunale delle iniziative “sistemiche” indica che la strada imboccata è promettente, anche se difficile e non semplice, soprattutto alla luce dei tagli sempre più consistenti inferti al finanziamento pubblico alla cultura.
181
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
6 Il Sistema museale Celeberrimi Populi Anglona - Goceano - Monte Acuto [Deligia]
Il Sistema museale Celeberrimi Populi è un progetto intercomunale che coin-volge enti pubblici e soggetti privati nel territorio della Provincia di Sassari. Gli enti si sono uniti nel 2006, mediante la firma di un apposito protocollo d’intesa, allo scopo di supportare i singoli musei di ente locale nel processo di adegua-mento agli standard museali previsti dal Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001320. Ciò è avvenuto a seguito dell’emanazione, da parte della Regione, di una serie di linee d’indirizzo per i musei, inserite nel documento strategico re-gionale intitolato Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo del 2005. Il documento prevedeva l’istituzione di un procedimento di accredi-tamento regionale per musei e luoghi della cultura mediante l’assegnazione di finanziamenti regionali, con selezione dei soggetti meritevoli condizionata dal raggiungimento di alcuni standard ministeriali321.
Il Sistema museale si propone, attraverso la creazione di un’offerta culturale diversificata, di attrarre nel territorio i flussi turistici normalmente indirizzati verso le località balneari della provincia e, in questo senso, la partecipazione al Sistema di soggetti privati è finalizzata all’arricchimento dell’offerta turistico-culturale anche attraverso l’avvio di attività di marketing territoriale322.
¬ Istituzione e sviluppo del Sistema
Il primo progetto del Sistema museale Celeberrimi Populi risale all’aprile 2006, quando il Comune di Ozieri, assieme ad altri soggetti aderenti al Proto-collo firmato agli inizi del luglio di quello stesso anno, presentò alla Provincia
320 Protocollo d’intesa per la costituzione del Sistema museale Celeberrimi Populi allegato e approvato con DCC di Ozieri n. 33 del 5 luglio 2006, Adesione del Comune di Ozieri al Sistema Museale “Celeberrimi Populi” Anglona-Goceano-Monte Acuto, partecipazione al partenariato per progettazione integrata, Bando P.O.R. aprile 2006, approvazione dello Statuto Museale “Celeberrimi Populi” Anglona-Goceano-Monte Acuto e dello schema di pro-tocollo d’intesa. Decreto Ministeriale 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, del D. Lgs. n. 112 del 1998).
321 DGR n. 36/5 del 26 luglio 2005, Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo. Documento d’indirizzo politico-amministrativo.
322 Protocollo d’intesa cit. approvato con DCC n. 33 del 2006 cit. Regione Autonoma della Sardegna, Avviso Pubblico per la Presentazione di Progetti Integrati di sviluppo. Formula-rio n. 8 Operazioni proposte da Enti e altri soggetti pubblici, Aprile 2006, consultabile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo <http://www.regionasardegna.it>.
182
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
di Sassari, in occasione della selezione di Progetti Integrati di Sviluppo relativi al POR 2000-2006, una «manifestazione d’interesse» per la costituzione di un sistema museale. Questo atto dimostra che già a livello provinciale e comunale circolava l’idea di creare un sistema museale intercomunale323.
L’intenzione degli Enti locali era quella di inserire il sistema museale all’in-terno del Progetto Integrato di Sviluppo elaborato dalla Provincia di Sassari e fi-nalizzato a incentivare la promozione turistica del territorio324. Il Sistema Cele-berrimi Populi avrebbe potuto essere inserito fra le attrattive della Provincia di Sassari, con l’obiettivo di sviluppare il settore turistico in tutta l’area provincia-le e non solo nelle località costiere.
Nel 2007 la Provincia di Sassari presentò alla Regione il «Progetto integra-to consolidato» Sistema Turistico integrato della Sardegna Nord Occidentale, che comprendeva anche il Sistema museale Celeberrimi Populi, all’epoca costituito formalmente325. L’istituzione del Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest è avvenuta nel 2008 ma il progetto non ha creato nessun tipo di relazione con-creta con il Sistema museale Celeberrimi Populi, che rimane di fatto una realtà autonoma326.
Il Sistema Celeberrimi Populi è stato ufficialmente istituito il 5 luglio 2006 con la stipula del menzionato Protocollo d’intesa tra i seguenti soggetti pubblici e privati: i Comuni di Ozieri (come ente capofila), Ardara, Bono, Burgos, Ittired-du, Pattada, Perfugas, Viddalba, lo IAL Sardegna (Istituto Addestramento Lavo-ratori), l’Istituto Incremento Ippico della Sardegna, il Museo del Molino della Ditta Galleu di Ozieri, la Società Domus srl, l’Associazione culturale Musicaidea e la Ditta individuale Massimo Canargiu327. In un secondo momento, con la firma di un nuovo Protocollo, in data 28 luglio 2006, al Sistema hanno aderito anche i Comuni di Tergu, Mores e Tula328. In seguito alla firma del Protocollo d’Intesa, il
323 Regione Autonoma della Sardegna, Avviso Pubblico per la Presentazione di Progetti Inte-grati di sviluppo cit..
324 Ivi.325 Regione Autonoma della Sardegna, Avviso Pubblico per la Presentazione di Progetti Inte-
grati di sviluppo-Formulario per la predisposizione dei progetti integrati di sviluppo. Progetto Integrato Consolidato Sistema Turistico Integrato della Sardegna Nord Occidentale, Aprile 2007.
326 Si veda il sito web del progetto Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest, all’indi-rizzo <http://www.stlsardegnanordovest.it>.
327 Protocollo d’intesa cit. approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Ozieri n. 33 del 2006 cit.
328 DGC di Tergu, n. 51 del 5 settembre 2006, Adesione del Comune al Sistema Museale “Ce-leberrimi populi” Anglona-Goceano-Monte Acuto. Partecipazione al partenariato per proget-tazione integrata-Bando P.O.R. Aprile 2006-Approvazione dello Statuto del Sistema Museale “Celeberrimi populi” Anglona-Goceano-Monte Acuto e dello schema di protocollo d’intesa.
183
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Comune di Tula non ha però provveduto a ratificare la sua adesione al Sistema e dunque attualmente non partecipa a Celeberrimi Populi329.
La denominazione del Sistema deriva dall’antica definizione «Celeberrimi populi Sardiniae» data alle popolazioni che vissero nel territorio interessato dal progetto – Balari, Corsi e Iliensi – da Plinio il Vecchio nel terzo libro del Naturalis Historia.
I Comuni aderenti al Sistema dichiararono nel Protocollo d’intesa la loro vo-lontà di adeguare le strutture museali di pertinenza agli indirizzi e alle norme, regionali e nazionali, in materia di beni culturali fino ad allora prodotte: il De-creto Ministeriale del 10 maggio 2001, il Decreto Legislativo n. 42 del 22 genna-io 2004, il documento di indirizzo della Regione dal titolo Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo e, infine, il disegno di legge n. 10/4 del 14 marzo 2006 che sarebbe divenuto di lì a poco legge regionale (la n.14 del 2006) con un articolo specificamente dedicato ai sistemi museali330.
Oltre alla firma del Protocollo d’intesa, nel 2006 il Sistema presentò alla Re-gione un progetto di gestione per il triennio 2007-2009 allo scopo di riuscire a intercettare le risorse economiche stabilite dalla legge regionale n. 7 del 2005331.
Tale progetto indicava come obiettivo primario del Sistema il consegui-mento del riconoscimento regionale attraverso il raggiungimento dei requisiti ministeriali e prevedeva in particolare l’esternalizzazione dei servizi e la loro implementazione; tra le attività prospettate vi erano infatti: la creazione di iti-nerari intercomunali e di programmi didattici, il monitoraggio del numero di visitatori, una capillare azione di promozione (assicurata anche dalla presenza, all’interno del Sistema, di soggetti privati attivi nel settore turistico), l’attivazio-ne di una bigliettazione integrata e l’organizzazione di corsi di qualificazione
329 Informazione fornita tramite comunicazione orale dalla dott.ssa Lucrezia Campus, responsabile scientifico del Sistema Celeberrimi Populi, in data 23 febbraio 2010.
330 Protocollo d’intesa cit. ; DM 10 maggio 2001 cit.; Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; DGR n. 36/5 del 2005 cit.; DGR n. 10/4 del 14 marzo 2006, Disegno di legge concernente “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”. LR n. 14 del 20 settem-bre 2006, Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura, art. 12.
331 DGC di Tergu, n. 46 del 13 settembre 2006, Gestione Museo e siti archeologici-Approva-zione progetto triennale 2007-2009 finalizzato all’ottenimento dei finanziamenti per la gestio-ne da realizzarsi in forma associata con i Comuni afferenti al sistema museale “Celeberrimi Populi” Anglona-Goceano-Monte Acuto; LR n. 7 del 21 aprile 2005, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005); DGR n. 61/30 del 20 dicembre 2005, Linee di indirizzo relative all’erogazione di contributi agli Enti Locali pubblici territoriali della Sardegna per concorrere agli oneri d’esercizio dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito culturale. L.R. 21.4.2005 n. 7 art. 12 comma 3. UPB S 11027 Capitolo 11212, UBP S 11 033 Capitolo 11247.
184
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
per il personale impiegato nelle strutture afferenti a Celeberrimi Populi332. Le azioni previste dal progetto in realtà non risultano avviate al momento
della nostra indagine (2009): la mancata pubblicazione della graduatoria regio-nale relativa al citato bando sui finanziamenti a valere sulla legge regionale n. 7 del 2005 ha infatti interrotto, almeno per il momento, il processo di concretiz-zazione del Sistema museale.
Tra gli obiettivi esposti nel progetto triennale di gestione del 2006, l’unico a essere stato raggiunto è quello dei corsi di formazione rivolti agli operatori impiegati in musei e siti archeologici aderenti al Sistema. La Regione, infatti, così come previsto nel documento regionale Piano di razionalizzazione e sviluppo del 2005, ha promosso nell’ambito del Programma Parnaso una serie di corsi volti alla riqualificazione di tutto il personale coinvolto nella gestione dei beni culturali di pertinenza degli Enti locali333.
Nonostante non abbia ancora avviato concretamente la maggior parte del-le sue attività, il Sistema, attraverso il proprio Comitato tecnico, ha elaborato tra 2007 e 2008 un progetto denominato Restauro dei beni culturali del Sistema Museale “Celeberrimi Populi”, con l’obiettivo di provvedere al recupero del pa-trimonio culturale di cui dispone avvalendosi delle risorse economiche pre-disposte dalla Regione con l’articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2006, finalizzata all’erogazione di fondi per restauri334. In un primo momento ciascun Comune ha individuato i beni o le strutture di propria competenza che neces-sitavano di un intervento di restauro, dichiarando la propria disponibilità a provvedere alla copertura finanziaria del 30% dell’intero costo dell’intervento; successivamente, il Sistema ha raccolto le singole istanze comunali e le ha pre-sentate alla Regione che ha poi provveduto a trasferire le necessarie risorse eco-nomiche a ogni Comune in base all’ammissibilità della domanda presentata335.
332 Istituzione alleate: nasce il sistema integrato dei musei, «L’Unione Sarda», 12 ottobre 2006. DGC di Tergu n. 46 del 2006 cit.
333 DGR n. 36/5 del 2005 cit. Per il Programma Parnaso si veda il sito web ufficiale del progetto, all’indirizzo <http://www.ifold.it>.
334 DGR n. 30 del 24 agosto 2007, Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di “Re-stauro conservativo di beni immobili e beni mobili dell’Abbazia di Nostra Signora di Tergu”-approvazione istanza per l’assegnazione di contributi R.A.S. agli Enti Locali per interventi di restauro dei beni culturali con il sistema museale “Celeberrimi Populi”; DGC di Ozieri n. 118 del 24 aprile 2008; LR n. 14 del 2006 cit., art. 21; DGR n. 28/23 del 26 luglio 2007, Legge Regionale 20 settembre 2006, n,14, art. 4, lettere f) e art. 21, lett. c). Assegnazione con-tributi agli Enti Locali per interventi di restauro dei beni culturali. Approvazione direttive.
335 DGR n. 49/25 del 5 dicembre 2007, Interventi di restauro sul patrimonio culturale. Pro-gramma relativo alla concessione di contributi ai sensi dell’art. 4 lett. f) e dell’art. 21 lett. c) della L.R. 20 settembre 2006, n. 14 e n. 36/37 del 1 luglio 2008, Interventi di restauro sul patrimonio culturale. Programma relativo alla concessione di contributi ai sensi dell’art. 4
185
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Celeberrimi Populi in quest’occasione ha svolto il ruolo di cabina di regia per i diversi Comuni, coordinandone il lavoro in modo da presentare alla Regione un unico progetto. Tale attività dunque risulta essere al momento la prima e unica concreta azione del sistema museale.
Sebbene il Sistema sia stato formalmente istituito, buona parte delle struttu-re museali aderenti non sono state ancora aperte al pubblico, come ad esempio il i Musei dei Comuni di Bono, Pattada e Tergu336.
È evidente che la presenza all’interno del Sistema di musei ancora chiusi limita fortemente le azioni condivise e contribuisce a ritardare l’avvio di tut-te quelle attività gestionali previste dal progetto presentato alla Regione nel 2006337.
Ogni Comune ha messo a disposizione del Sistema musei, monumenti e per-corsi di propria competenza nella prospettiva di creare un progetto ampio ed articolato. Il Comune di Ozieri, capofila del progetto, partecipa al Sistema con il Civico Museo Archeologico, che funge da centro di sistema, il sito archeologico delle Grotte di San Michele, la Basilica di Sant’Antioco di Bisarcio e un itinerario guidato della città e dei dintorni rivolto alle scuole. Il Civico Museo Archeologi-co, inaugurato nel 1985, ha sede dal 2003 nel restaurato convento settecentesco delle Monache Clarisse, nelle sue sale sono esposti reperti archeologici, prove-nienti dalla città e dal territorio circostante, che coprono un arco di tempo in-cluso tra la Preistoria e il periodo medievale. L’elemento che caratterizza questo museo, rispetto alla maggior parte delle altre strutture di analoga tipologia pre-senti nel territorio regionale, è che buona parte della sua collezione, così come l’edificio che lo ospita, appartiene al Comune, essendo frutto di una donazione privata e ciò consente al Museo una certa autonomia gestionale338.
Il Comune di Ardara è inserito in Celeberrimi Populi con il Museo Giudicale, non ancora fruibile, che dovrà ospitare i reperti legati alla vita curtense dei Giudici di Torres. Il Museo sarà connesso ai due monumenti principali della cittadina: la chiesa di Nostra Signora del Regno e le rovine del Castello. La chiesa, risalente all’XI secolo, si è conservata in ottime condizioni e costituisce l’unico esempio di chiesa palatina presente in Sardegna; all’interno dell’edifi-cio sacro sono custodite importanti testimonianze degli arredi antichi, come ad esempio il retablo maggiore, un polittico degli inizi del XVI secolo339. Il castello
lett. f) e dell’art. 21 lett. c) della L.R. 20 settembre 2006, n. 14. 336 Con riferimento al 2009.337 DGC n. 30/2007 cit.338 Si veda la scheda del Civico Museo Archeologico “Convento delle Clarisse” di Ozieri, sul
database regionale dei musei all’indirizzo <http://www.sardegnacultura.it>. 339 Si veda la scheda Ardara, Chiesa di Santa Maria del Regno, sul database regionale ei
musei consultabile all’indirizzo <http://www.sardegnacultura.it>.
186
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
giudicale, coevo e attiguo alla basilica, è invece oggi ridotto allo stato di rudere, anche perché fra il XIX e il XX secolo le sue pietre furono usate per costruire il palazzo comunale di Ardara e alcune abitazioni. Attualmente il Comune di Ardara non ha ancora avviato una gestione concreta dei servizi per la fruizione del patrimonio locale, così le visite alla chiesa, per esempio, sono organizzate da un volontario del luogo e dal parroco.
Il Comune di Bono prende parte al Sistema con il costituendo Museo Stori-co Giovanni Maria Angioy che esporrà le testimonianze del passaggio in paese, durante i moti rivoluzionari sardi del 1794-1796, di Giovanni Maria Angioy, importante personaggio del Settecento sardo nato a Bono340. Il Museo è ubicato sul colle di San Raimondo, sede di un’importante festa popolare durante la quale vengono rievocati i moti angioini.
Il Comune di Burgos aderisce invece al Sistema con il Castello medievale e l’annesso Museo dei Castelli di Sardegna, che ha sede in una casa padronale della fine del XIX secolo. L’esposizione museale si articola in tre ambienti tematici: il primo ospita mostre temporanee, il secondo raccoglie una collezione di carte tematiche in cui sono indicate le torri costiere di età spagnola e i punti strate-gici di difesa dell’isola, l’ultimo invece è dedicato alla ricostruzione della vita contadina. Un altro ambiente del Museo è riservato infine all’esposizione di una raccolta di foto, di diverse epoche, dedicate al tema dei castelli. Completa il percorso una sala multimediale che permette una lettura storica dei quasi cento castelli presenti in Sardegna341.
Il Comune di Ittireddu partecipa a Celeberrimi Populi con il Civico Museo Ar-cheologico ed Etnografico e con due itinerari, uno cittadino ed uno extraurbano. Il Museo si compone di due sezioni: una archeologica, in cui sono conservati alcuni dei reperti rinvenuti nel territorio comunale, e l’altra etnografica, dedi-cata invece alla cultura tradizionale. I manufatti esposti in quest’ultima rac-contano al visitatore, con l’ausilio di pannelli esplicativi e di documentazione fotografica, alcuni aspetti tradizionali della comunità, come le attività agricole e la pastorizia. Gli itinerari di Ittireddu sono invece rivolti in particolar modo alle scolaresche e offrono la possibilità di conoscere più approfonditamente la storia e i beni culturali del piccolo centro abitato e del suo territorio. Nello specifico, l’itinerario urbano comprende l’intero centro storico, con la visita alla piccola chiesa medievale d’impianto bizantino intitolata alla Santa Croce, mentre l’i-tinerario extraurbano offre la possibilità di visitare i numerosi siti preistorici
340 r. Bonu, Scrittori sardi, Cagliari 1972, I, pp. 118-130; di p.p. tIlocca (a cura di), I moti antifeudali in Sardegna: la Sardegna e la casa Savoia, la figura di Giommaria Angioy nel bicentenario della rivoluzione francese, Sassari 1989.
341 Si veda la scheda Burgos, Museo dei Castelli di Sardegna, sul database regionale dei musei consultabile all’indirizzo <http://www.sardegnacultura.it>.
187
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
presenti nell’agro di Ittireddu, nonché alcuni edifici ecclesiastici, testimonianza di un passato più o meno recente e delle manifestazioni religiose, come feste e cerimonie, che qui si organizzavano.
Anche il Comune di Mores prende parte al Sistema con un itinerario nel territorio che comprende tre siti archeologici: il primo, Sa Covaccada, è uno dei maggiori dolmen del Mediterraneo; il secondo, chiamato Su Castru ‘e S. Liseu, è costituito da un ipogeo neolitico trasformato in chiesa funeraria paleocristiana; l’ultimo, il sito di Monte Lachesos, è una necropoli preistoria composta da Do-mus de Janas. Questo itinerario dovrebbe essere arricchito con un nuovo museo, ancora da costituirsi, legato soprattutto alle emergenze archeologiche di epoca romana presenti nel territorio comunale.
Il Comune di Pattada partecipa al progetto con il piccolo Museo del Coltel-lo Sardo e del ferro battuto e con gli itinerari urbano ed extraurbano: il Museo, allestito nel vecchio mercato civico risalente al XIX secolo, illustra la vita e le tradizioni della comunità pattadese attraverso l’esposizione di oggetti che testimoniano la storia della principale produzione artigianale locale, ovvero quella del coltello sardo. Attualmente la struttura museale viene aperta solo in occasione della manifestazione Biennale del Coltello, che ha sede a Pattada, ed ospita gli eventi a questa connessi342. I due itinerari comprendono le emergenze storico-artistiche e archeologiche presenti rispettivamente in paese e nel terri-torio circostante, nonché le due oasi naturalistiche di Monte Lerno e Fiorentini insistenti sul territorio comunale.
Il Comune di Perfugas inserisce nel Sistema il Museo archeologico e paleobo-tanico, un percorso guidato alla città e uno ai suoi dintorni. Il Museo, inaugu-rato nel 1988, si articola in cinque sezioni tematiche: paleobotanica, paleolitica, neolitica ed eneolitica, nuragica, classica e medievale. Ogni sezione espone i reperti, classificati per periodo storico, che illustrano la storia del territorio e testimo-niano come quest’area fosse abitata dall’uomo sin dal Paleolitico Inferiore343. L’itinerario cittadino include la visita alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria degli Angeli dove è esposto l’unico retablo interamente conservato presente in Sardegna: il cinquecentesco Retablo di San Giorgio.
Il Comune di Tergu aderisce a Celeberrimi Populi con un sito archeologico medievale che comprende l’area in cui sorgeva un antico monastero benedet-tino che fu attiguo all’attuale basilica di Santa Maria. Negli ultimi quattro anni quest’area è stata oggetto di un’imponente campagna di scavo, che ha permes-so di recuperare molti materiali destinati ad essere esposti nell’ennesimo mu-
342 Informazione fornita dalla dott. Lucrezia Campus, responsabile scientifico del Siste-ma Celeberrimi Populi, tramite comunicazione orale in data 18 aprile 2009.
343 Si veda la scheda Perfugas, Civico Museo Archeologico e Paleobotanico sul database regio-nale dei musei consultabile all’indirizzo <http://www.sardegnacultura.it>.
188
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
seo di prossima apertura del comprensorio, creato appositamente; tuttavia al momento (2009) l’unico bene fruibile rimane la chiesa di Santa Maria, con gli annessi resti del monastero, visitabili liberamente344.
Il Comune di Viddalba aderisce al Sistema con il Civico Museo Archeologico e con gli itinerari extraurbani correlati. Il Museo ospita i reperti archeologici pro-venienti da scavi effettuati nel territorio comunale e riferibili a un arco di tempo che va dal Neolitico al Medioevo. L’allestimento comprende anche un’impor-tante collezione di stele litiche datate fra la fine del I secolo a.C. e la prima età imperiale; le stele sono state esposte all’interno di un fossato che ricostruisce la collocazione e l’ambientazione in cui sono state rinvenute345. Gli itinerari ex-traurbani comprendono rispettivamente una serie di percorsi escursionistici nel territorio e la visita alla necropoli da cui provengono i reperti esposti al museo.
I singoli Comuni hanno evidentemente tentato di individuare i beni artistici e naturalistici presenti nel loro comprensorio nell’ottica di creare una rete di soggetti culturali tra loro connessi, in cui la territorialità e la tradizione sono l’elemento legante. I piccoli musei, gli sporadici e talvolta eccezionali reperti archeologici, le peculiarità locali, le produzioni tipiche vengono individuati e valorizzati tramite il loro inserimento in strutture appositamente organizzate. La concezione di questo sistema è dunque ad ampio raggio, complessa e molto aperta al territorio, giustamente congegnata in connessione con un concetto di organizzazione reticolare. Importante e significativo è anche il tentativo di inserire in questa progettazione culturale non solo i centri storici, ma anche il territorio rurale, individuando alcuni percorsi: ciò rimanda ad una visione integrata delle problematiche territoriali.
A questi musei di proprietà comunale si aggiungono altre due strutture, site ad Ozieri, appartenenti ad altri soggetti: il Museo del Cavallo, di proprietà dell’E-RA (Istituto Incremento Ippico della Sardegna) e il Museo del Molino della Ditta Galleu; il primo è una piccola esposizione di oggetti riferibili all’allevamento e ai mestieri legati al settore ippico mentre il secondo è la musealizzazione del vecchio mulino della città. Nel Museo del Molino sono conservate una raccolta di palmenti nuragici e romani e una collezione di antiche macchine meccaniche per la molitura ancora funzionanti.
La partecipazione di questi musei mostra la volontà di creare un sistema
344 Si veda la scheda Tergu, Chiesa di Nostra Signora sul database regionale dei musei, con-sultabile all’indirizzo <http://www.sardegnacultura.it>. Nell’area attigua alla Chie-sa l’indagine scientifica ha messo in luce una domus giudicale ovvero un complesso di pertinenze – abitazioni, terre, servi – donato per la fondazione del monastero be-nedettino.
345 Si veda la scheda Viddalba, Civico Museo Archeologico sul database regionale dei musei, consultabile all’indirizzo <http://www.sardegnacultura.it>.
189
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
che coinvolga tutte le realtà del territorio e non solo quelle di proprietà di enti locali.
Tutte le strutture museali sia di proprietà pubblica che privata, si caratteriz-zano per le dimensioni medio-piccole e per la presenza di allestimenti che ma-nifestano numerosi punti di criticità, come le didascalie e i pannelli informativi che, ove presenti, sono esclusivamente in lingua italiana e spesso poco esausti-vi. Anche il servizio di visita guidata, dove esistente, è erogato solo in lingua italiana. Nei musei di proprietà privata inoltre spesso la collezione, formata da un ridotto numero di oggetti di interesse soprattutto demoetnoantropologico, appare priva di un opportuno allestimento, basato su criteri scientifici e volto a far comprendere il significato della raccolta.
I musei archeologici presenti all’interno di Celeberrimi Populi sono una chiara manifestazione della tendenza che da vent’anni a questa parte ha caratterizza-to la realtà isolana: a partire dagli anni Ottanta, infatti, ogni piccolo Comune sardo si è adoperato per realizzare un proprio museo attingendo alle risorse economiche che in quegli anni la Regione metteva a disposizione degli Enti lo-cali che avessero voluto avviare – a fini occupazionali – attività di gestione per il patrimonio culturale346. La presenza di tanti piccoli musei archeologici in un territorio assai limitato o, come in questo caso, all’interno dello stesso sistema museale implica frammentarizzazione e ripetitività dell’offerta poiché ognuna di queste strutture presenta collezioni simili. Nel caso di Celeberrimi Populi la situazione è aggravata dal fatto che, pur in presenza di collezioni interessanti per il loro contenuto, come nel caso di Ozieri e Viddalba, la potenzialità dei rispettivi musei è ulteriormente ridotta a causa della presenza di allestimenti carenti dal punto di vista scientifico e divulgativo: spesso non solo i supporti informativi ma la stessa visita guidata risulta essere troppo sintetica, più adatta al pubblico occasionale che a quello costituito da fruitori esperti e appassionati.
In alcuni casi, ad esempio Ardara e Tergu, l’Amministrazione comunale non ha mai avviato una gestione reale del patrimonio culturale locale e i beni sono fruibili liberamente o grazie al lavoro di alcuni volontari.
Celeberrimi Populi nasce proprio allo scopo di superare tali mancanze per-mettendo alle singole strutture di adeguarsi agli standard ministeriali attraver-so la condivisione delle figure professionali e la razionalizzazione dei costi e dei ricavi347; tuttavia registriamo che, almeno per ora, anziché provvedere a quali-
346 LR n. 28 del 7 giugno 1984, Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione. Legge Regio-nale n. 11 dell’8 marzo 1988 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria del 1988). Su questo aspetto si veda anche il saggio di Cristina Borgioli in questo stesso volume.
347 Protocollo d’intesa cit. approvato con DCC di Ozieri n. 33 del 2006 cit. Decreto Ministe-riale 10 maggio 2001 cit.
190
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
ficare le strutture già funzionanti o ad attivare una gestione reale per quei beni che ne sono attualmente sprovvisti, alcuni Comuni aderenti al Sistema stanno provvedendo per loro conto ad aprire nuove strutture. Tali iniziative, promosse dalle singole Amministrazioni comunali, sono finalizzate ad ampliare l’offerta culturale del Sistema, ma non risolvono, anzi acuiscono, il problema della ri-petitività della proposta culturale; l’apertura di queste nuove strutture museali non solo non coincide con le finalità di razionalizzazione del patrimonio locale promosse dal Sistema Celeberrimi Populi ma, addirittura, aumentando il nume-ro dei beni da gestire ostacola il perseguimento di tale obiettivo.
L’atteggiamento mostrato da alcuni Comuni all’interno di Celeberrimi Populi non coincide inoltre con quanto espresso nel documento strategico regionale Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo e nell’indagine di controllo sui musei e siti archeologici sardi condotta dalla Sezione di Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna della Corte dei Conti. In entrambi i documenti si sottolinea il fatto che l’offerta culturale sarda si caratterizza per la forte frammentarietà dovuta alla “polverizzazione” delle iniziative, con conse-guente limitazione della loro efficacia348. La causa di tale situazione è riscontrata nell’intensa proliferazione di musei che, posti a poca distanza gli uni dagli altri, presentano collezioni simili e ridotte per dimensioni. Sia la Regione che la Corte dei Conti suggeriscono invece alle diverse Amministrazioni locali impegnate a vario titolo nella gestione del patrimonio culturale di unirsi in sistemi così da riuscire, razionalizzando e integrando le risorse di cui dispongono, a elaborare un’offerta turistico-culturale diversificata che riesca ad attrarre il fruitore349.
Oltre agli Enti locali citatati, al Sistema museale aderiscono anche l’Istituto Addestramento Lavoratori - IAL Sardegna e alcuni soggetti privati: la partecipa-zione di queste realtà è finalizzata a sviluppare all’interno di Celeberrimi Populi attività collegabili a quelle relative alla promozione e alla gestione dei musei e dei monumenti comunali e in questo modo il Sistema si pone l’obiettivo di assicurare una diversificazione dell’offerta turistico-culturale, aumentandone nel contempo la visibilità350.
348 Sezione di controllo per la Regione Autonoma della Sardegna della Corte dei Conti, Indagine di controllo successivo avente ad oggetto la ricognizione e l’organizzazione ammini-strativa della realtà museale e dei siti archeologici nel territorio della Sardegna, con approfon-dimento sui musei degli Enti locali, sulla gestione dei finanziamenti concessi dalla Regione, nonché sullo stato di attuazione della normativa statutaria della Regione Autonoma della Sardegna nella materia. Deliberazione n. 13/2002. Esercizi finanziari 2000-2003, 2005. DGR n. 36/5 del 2005 cit.
349 Indagine di controllo successivo cit., 2005 e DGR n. 36/5 del 2005 cit.350 Regione Autonoma della Sardegna, Avviso Pubblico per la Presentazione di Progetti Inte-
grati di sviluppo. Formulario n. 8 Operazioni proposte da Enti e altri soggetti pubblici, aprile 2006.
191
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
A ognuno di questi soggetti è stato assegnato un ruolo specifico all’interno di Celeberrimi Populi e tale compito dovrà essere svolto a partire dal momento dell’avvio a pieno ritmo delle attività sistemiche: una ditta dovrà occuparsi del-la realizzazione di manufatti collegati agli ambiti naturalistici del Sistema (dio-rami), una società di consulenze dovrà predisporre una card (biglietto unico), lo IAL Sardegna dovrebbe promuovere corsi di formazione per tutto il personale addetto alle strutture museali mentre un’associazione culturale avrà invece il compito di organizzare eventi a carattere teatrale e musicale.
Per quanto riguarda la formazione, gli operatori coinvolti nella gestione del patrimonio culturale afferente a Celeberrimi Populi, così come tutti quelli im-piegati all’interno dei beni di spettanza degli Enti locali, hanno avuto modo di frequentare i corsi di riqualificazione promossi dalla Regione nell’ambito del Programma Parnaso; tale programma infatti prevedeva l’organizzazione di alcuni corsi di qualificazione professionale volti al personale già impiegato o da impiegare nelle strutture musealizzate di spettanza degli enti locali351.
¬ Strumenti di gestione
Il Sistema, fin dal momento della sua istituzione, si è dotato di uno Statuto − come raccomandato dagli indirizzi regionali − che ne regolamenta le attività, prescrivendo l’affidamento della sua gestione agli organi appositamente istitu-iti: il Comitato Tecnico, il Responsabile Scientifico e il Comitato Scientifico.352
In realtà gli organi di gestione, pur esistendo, non hanno mai funzionato a regime: l’assenza di attività di tipo sistemico ha fino ad oggi (2009) limitato il loro intervento. Tali organi si sono attivati solo nelle due occasioni in cui il Sistema ha dovuto operare come soggetto unico per poter avere maggiori pos-sibilità di ricevere i contributi finanziari previsti dalla Regione per gli interventi di restauro sui beni culturali353.
Il Comitato Tecnico svolge la funzione di delineare gli indirizzi di sviluppo e i programmi d’intervento del Sistema e a questo compito affianca quello di fornire disposizioni precise sull’utilizzazione dei propri fondi. Tale organo è composto dal Sindaco dei Comuni aderenti (o dai rispettivi delegati), dai rap-presentanti legali degli altri soggetti coinvolti (o dai loro delegati), dal Dirigen-
351 DGR n. 36/5 del 2005 cit. Per il Programma Parnaso si rimanda al sito web ufficiale del progetto, all’indirizzo <http://www.ifold.it>.
352 Statuto del Sistema Museale «Celeberrimi Populi» Anglona-Goceano-Monte Acuto appro-vato con DCC di Ozieri n. 33 del 2006 cit.
353 LR n. 14/2006 cit.; DGR n. 28/23 del 2007 cit., n. 49/25 del 2007 cit. e n. 36/37 del 2008 cit.
192
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
te del Settore Promozione Turistica e Culturale del Comune Capofila (Ozieri) e dal Direttore di uno dei musei fra quelli aderenti354.
Il Responsabile Scientifico si occupa invece del coordinamento del Comitato Scientifico che, a sua volta, gestisce le attività tecnico-scientifiche del Sistema, in merito allo sviluppo e al migliore utilizzo dei suoi servizi. Un altro compito del Comitato Scientifico è quello di sovrintendere all’aggiornamento professionale degli operatori impiegati nelle strutture dello stesso355. Attualmente l’incarico di Responsabile Scientifico è stato conferito al Direttore del Civico Museo Arche-ologico di Ozieri, struttura individuata come centro del Sistema.
Il personale tecnico-amministrativo operativo all’interno del Sistema Cele-berrimi Populi è costituito dal Dirigente del settore promozione turistica e cultu-rale del Comune capofila (Ozieri), dal Capo servizio del museo sede del centro di sistema e dal responsabile del Servizio Museale del Comune di Ozieri356.
Di fatto, malgrado questa puntuale definizione degli organi gestionali del Sistema da Statuto, attualmente ogni Ente coinvolto nel sistema gestisce le strutture museali e i siti archeologici di spettanza in piena autonomia rispetto a tali organi; il personale operante nelle singole strutture musealizzate infatti dipende direttamente dagli Enti locali e non ha nessun rapporto con le altre realtà aderenti a Celeberrimi Populi. In altre parole, i soggetti coinvolti nel Si-stema continuano ad agire come entità amministrative isolate, provvedendo autonomamente alla promozione e all’implementazione delle singole offerte culturali. Il mancato raggiungimento di una gestione integrata del patrimonio musealizzato afferente al Sistema costituisce un grave limite alla realizzazione di un’offerta turistico-culturale diversificata che possa incentivare il settore tu-ristico nelle zone interne della Provincia di Sassari.
Inoltre il fatto che ogni Comune provveda autonomamente alla promozione e alla gestione delle strutture di pertinenza crea inevitabilmente un dislivello nella qualità e quantità dei servizi offerti dalle singole realtà culturali e tale dislivello rende impossibile il raggiungimento del principale obiettivo che Ce-leberrimi Populi si era preposto al momento della sua istituzione, ossia l’adegua-mento di tutte le strutture aderenti agli standard ministeriali, secondo quanto stabilito dal Piano di razionalizzazione e sviluppo regionale del 2005357.
Anche per quanto riguarda gli aspetti finanziari, possiamo definirli solo in via teorica: il Sistema dispone, da Statuto, di un fondo annuale a carico degli
354 Statuto cit., art. 5.355 Ivi.356 Ivi.357 Protocollo d’intesa cit. approvato con DCC di Ozieri n. 33 del 2006 cit. DM 10 maggio
2001 cit.; DGR n. 36/5 del 2005 cit.
193
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
aderenti da utilizzare per le spese di funzionamento, la gestione e il personale di Celeberrimi Populi. Tale fondo è costituito dalle quote che annualmente ogni partner trasferisce al Comune capofila (Ozieri), alle quali si aggiunge il versa-mento che i Comuni devono pagare in base al relativo numero di abitanti358.
Altre fonti di finanziamento per il Sistema sono i contributi regionali, statali e comunitari messi a bando, come ad esempio i contributi regionali relativi agli interventi di restauro su beni culturali di spettanza degli enti locali predispo-sti dall’articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2006 e successive delibere di attuazione359.
Nel progetto triennale di gestione (2007-2009) presentato alla Regione dal Sistema nel 2006, allo scopo di intercettare i contributi finanziari a valere sulla legge regionale n. 7 del 2005, viene dichiarata la volontà da parte del Sistema di raggiungere nel tempo l’autonomia finanziaria o comunque una diminuzio-ne dell’intervento pubblico. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto grazie agli introiti della bigliettazione unica, alla vendita in loco di prodotti dell’arti-gianato locale e di souvenir e ai diritti sulle immagini del patrimonio culturale del Sistema360.
¬ Conclusioni
Celeberrimi Populi si configura virtualmente come un sistema dotato di un proprio Statuto e di una serie di organi di gestione specifici. Tale Sistema però ha soltanto sottoscritto un protocollo d’intesa e ha ottenuto un finanziamento per il restauro di alcuni beni. Per tutti gli altri aspetti, ampiamente descritti nei documenti di programmazione, non sono stati messi in atto interventi di attua-zione, in quanto l’intera procedura dipende dall’esito del bando regionale del 2007 e tale esito, al 2009, non è stato ancora reso pubblico.
Il Sistema si caratterizza, rispetto ad altre realtà analoghe presenti nel pa-norama isolano, per l’estensione intercomunale e per la compresenza di enti pubblici e soggetti privati, accomunati dall’obiettivo di riuscire a sviluppare il settore turistico mediante un’ampia e qualificata offerta museale alla quale collegare eventi teatrali, musicali ed attività di marketing territoriale.
358 Statuto cit. approvato con DCC di Ozieri n. 33 del 2006 cit., art. 6. La quota aggiuntiva che i Comuni aderenti al Sistema devono versare annualmente è pari a 0,20 euro per ogni residente.
359 LR n. 14 del 2006 cit.; DGR n. 28/23 del 2007 cit., n. 49/25 del 2007 cit. e n. 36/37 del 2008 cit.
360 DGR di Tergu, n. 46 del 2006 cit.; LR n. 7 del 2005 cit.; DGR n. 61/30 del 2005 cit.
194
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Nonostante le migliori intenzioni espresse dai partecipanti nel Protocollo d’Intesa al momento della sua istituzione, il Sistema non ha fino a oggi avviato nessuna delle attività previste e dunque non è riuscito a raggiungere un solo obiettivo fra quelli che si era preposto361.
Non si riscontra all’interno di Celeberrimi Populi nessuna attività di tipo “pa-rasistemico”, ma anzi ogni Ente locale che vi aderisce continua, a tre anni dalla sua nascita, a provvedere in maniera del tutto autonoma e isolata alla gestione dei beni musealizzati di pertinenza. Tale situazione limita fortemente le poten-zialità insite nell’offerta turistico-culturale elaborata dal Sistema, caratterizzata dalla presenza di realtà museali diverse inserite in un contesto territoriale di indubbio interesse paesaggistico, archeologico e architettonico: quello dell’An-glona, Goceano e Monte Acuto. La mancanza di una gestione unitaria dei beni culturali inseriti in Celeberrimi Populi contribuisce ad accrescere il dislivello, in termini qualitativi e quantitativi, fra i servizi garantiti in ognuna delle strutture musealizzate afferenti al Sistema. Un ulteriore limite alla proposta culturale del Sistema è dato dal fatto che alcuni dei musei coinvolti non sono ancora aperti al pubblico, come nel caso delle strutture museali di spettanza dei Comuni di Ardara, Bono, Pattada.
Probabilmente i ritardi nell’avvio delle attività sistemiche sono da attribuire alla mancata pubblicazione della graduatoria relativa al bando sui finanzia-menti regionali a valere sulla legge regionale n. 7 del 2005 indetto dalla Regione Sardegna nel 2006; è indubbio però che anche le singole Amministrazioni co-munali siano in parte responsabili della lentezza con la quale vengono superate le criticità che caratterizzano al momento il progetto di messa a sistema del patrimonio culturale locale.
361 Protocollo d’intesa 2006 cit.
195
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
7 Il Sistema Museale Arborense [Borgioli]
Il progetto per la messa in rete del patrimonio culturale locale, denominato Sistema Museale Arborense, è stato promosso dalla Provincia di Oristano a par-tire dalla fine del 2005, quando l’Amministrazione provinciale ha deliberato la volontà di istituire un sistema museale territoriale362. L’obiettivo del progetto era creare occasioni di sviluppo economico e sociale per le comunità interes-sate, mediante l’avvio di azioni tese alla valorizzazione e promozione dei beni culturali locali363. Il Sistema, pur formalmente istituito nell’estate del 2006, non ha (al 2009) avviato alcuna delle attività previste nei documenti istitutivi364.
¬ La progettazione del Sistema
Il progetto Sistema Museale Arborense è stato elaborato dalla Provincia di Oristano a seguito delle disposizioni indicate dalla Regione Sardegna nel suo documento strategico del 2005 dal titolo Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo365. Con questo documento di indirizzo, la Regione dichiarava la volontà di realizzare un sistema museale a dimensione regiona-le da articolare in “reti” organizzate su base territoriale e tematica nelle varie aree dell’Isola: all’interno di tali reti, a dimensione provinciale o intercomunale, avrebbero dovuto essere raggruppati i musei, le raccolte museali e i luoghi del-la cultura insistenti in un determinato territorio.
Uno degli elementi di maggior novità del Piano di razionalizzazione e sviluppo del 2005 fu la volontà di attivare un procedimento regionale di accreditamento indirizzato a tutti quei beni di pertinenza degli Enti locali che avessero voluto beneficiare dei finanziamenti stanziati dalla Regione; in altre parole, il Piano di razionalizzazione e sviluppo stabiliva che tutte le strutture musealizzate intenzio-nate a beneficiare delle risorse economiche regionali avrebbero dovuto essere in possesso dei principali standard definiti dal Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001366. L’adeguamento a questi requisiti aveva lo scopo non solo di migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti nelle strutture culturali isolane, ma
362 DGP (Oristano) n. 306 del 30 dicembre 2005, Istituzione del Sistema Museale Arborense (SMA). Atto istitutivo del Sistema Museale Arborense.
363 Regolamento Sistema Museale Arborense, Oristano, maggio 2006.364 Dichiarazione di Principio per l’istituzione del Sistema Museale Arborense, Oristano 3 apri-
le 2006. Atto Istitutivo cit., Oristano 2006 cit.365 DGR n. 36/5 del 26 luglio 2005, Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e
sviluppo. Documento d’indirizzo politico-amministrativo.366 DM 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di fun-
zionamento e sviluppo dei musei. DGR n. 36/5 del 2005 cit.
196
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
anche di usare la costituzione di reti museali come strumento per ottimizzare la gestione dei musei. La maggior parte delle realtà museali sarde è infatti com-posta da musei medio-piccoli, che dovrebbero necessariamente associarsi per riuscire ad adeguarsi a tali requisiti, condividendo così le risorse economiche e professionali367.
Il Piano individuava inoltre le reti territoriali da attivare nell’ambito del futu-ro sistema museale sardo, coincidenti approssimativamente con i comprensori provinciali, e una serie di musei regionali da istituire per svolgere il ruolo di “nuclei” o centri per le reti territoriali368.
¬ L’istituzione del Museo della Sardegna Giudicale
Per quanto riguarda la Rete Museale della Provincia di Oristano, il Piano regionale del 2005 prevedeva la creazione di un museo dedicato al periodo giu-dicale, il Museo della Sardegna Giudicale. Tale istituto rispondeva alla necessi-tà, manifestata a partire dalla fine degli anni Ottanta, di realizzare strutture adeguate a ospitare le testimonianze di questo particolare periodo della storia sarda, così da favorirne la conoscenza369. Dato il carattere di inamovibilità della maggior parte delle testimonianze artistiche del periodo giudicale, costituite per la maggior parte da edifici ecclesiastici, il Museo avrebbe dovuto configu-rarsi come una sorta di «struttura interattiva in cui s’intrecciano segni, simbo-li, racconti, attività»370. Nello stesso documento strategico si prevedeva inoltre che il Museo fosse istituito proprio a Oristano, antica capitale del giudicato di Arborea. Nell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali firmato dalla Regione nel settembre 2005, fu stanziato un finanziamento di un milio-ne di euro finalizzato alla sua realizzazione e allestimento371. In un secondo momento, però, nel marzo del 2006, la Regione Sardegna stabilì di articolare questo museo in due sedi: una a Oristano e l’altra a Sanluri, cittadina scelta per
367 DM 10 maggio 2001 cit.; DGR n. 36/5 del 2005 cit. 368 Su questo tema si veda il saggio di Cristina Borgioli in questo stesso volume.369 G. SpIGa, Emergenze culturali giudicali nel XVI comprensorio di Oristano, Per una valoriz-
zazione del bene culturale nell’ambito territoriale del XVI comprensorio, Atti del convegno (Arborea 27-28 maggio 1989), Oristano 1991, pp. 99-107. r. dI tuccI, Storia della Sar-degna, Sassari 1964; a. BoScolo, La Sardegna bizantina e alto-giudicale, Sassari 1978; a. BoScolo, La Sardegna dei Giudicati, Cagliari 1979; F.c. caSula, Giudicati e curatorie, in Atlante della Sardegna, Tav. 39, Roma 1980, Fasc. II; F.c. caSula, La storia di Sardegna, Pisa-Sassari 1992.
370 DGR n. 36/5 del 2005 cit. 371 APQ in materia di Beni culturali, Roma 30 settembre 2005; DGR n. 45/20 del 27 set-
tembre 2005, Accordo di Programma Quadro (APQ) “Beni Culturali”. Modifiche ed inte-grazioni alla delibera G.R. 14/1 del 31.3.2005.
197
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
l’importanza rivestita nel XIV e nel XV secolo nella guerra tra il giudicato di Ar-borea e gli Aragonesi372. Nella stessa delibera del 2006 fu prescritto inoltre che il precedente stanziamento regionale di un milione di euro fosse suddiviso in parti uguali tra i due centri, per la realizzazione dell’istituto museale oristanese e di quello sito a Sanluri373.
¬ La Provincia di Oristano
Negli ultimi mesi del 2005 l’Amministrazione provinciale di Oristano aveva iniziato a operare per la realizzazione del sistema museale territoriale, che as-sunse il nome di Sistema Museale Arborense; tale progetto altro non era che la ri-sposta data dalla Provincia oristanese alle istanze espresse dalla Regione con il Documento di indirizzo del 2005374. Nel dicembre dello stesso anno la Provincia approvò l’istituzione del Sistema Museale Arborense, quale sistema provinciale, e invitò tutti gli Enti locali e le diocesi insistenti nel comprensorio di riferimento a partecipare alla sua creazione375. Fu così che, il 3 aprile 2006, i rappresentanti della Provincia di Oristano, dell’Arcidiocesi Arborense, delle Diocesi di Ales-Terralba e Alghero-Bosa e dei Comuni partecipanti firmarono la Dichiarazione di Principio per l’istituzione del Sistema Museale Arborense376. In questo documento i soggetti firmatari, seguendo le disposizioni regionali espresse nel Piano del 2005, stabilirono che il futuro Museo della Sardegna Giudicale sarebbe diventato il fulcro dell’intero sistema provinciale, svolgendo un ruolo di coordinamento delle attività promosse nei musei e nei siti archeologici aderenti al progetto377. Nel frattempo però era cambiata la volontà della Regione che, nel marzo 2006, aveva esplicitamente dichiarato che il Museo della Sardegna Giudicale avrebbe avuto due sedi in due diversi Comuni, con conseguente rimodulazione dei fi-nanziamenti.
Nonostante ciò andò avanti il processo di costituzione giuridica avviato dal-la Provincia di Oristano. A pochi giorni di distanza dalla firma della menziona-ta Dichiarazione di Principio, nel maggio 2006, fu redatto anche il Regolamento del
372 DGR n. 9/19 del 8 marzo 2006, Accordo di Programma Quadro (APQ) “Beni Culturali”. Modifiche alla delibera G.R. n 45/20 del 25 settembre 2005.
373 DGR n. 9/19 del 2006 cit.374 DGR n. 36/5 del 2005 cit.375 DGR n. 306 del 30 dicembre 2005, Istituzione del Sistema Museale Arborense (SMA).376 Aderirono i Comuni di Oristano, Cabras, S. Giusta, Ales, Arborea, Bosa, Busachi, For-
dongianus, Ghilarza, Laconi, Marrubiu, Milis, Nughedu S. Vittoria, Pau, Paulilatino, Samugheo, S. Vero Milis, Sedilo, Santulussurgiu, Suni, Tadasuni, Terralba. Dichiara-zione di Principio per l’istituzione del Sistema Museale Arborense, Oristano 3 aprile 2006.
377 Ivi. DGR n. 36/5 del 2005 cit.
198
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Sistema Museale Arborense che ne definì le finalità, gli organi di gestione e le loro competenze, le attività da svolgere e i compiti da eseguire378. Nello specifico, il Regolamento prevede che il Sistema, una volta avviato, si articoli nei seguenti or-gani gestionali: il Direttore del Sistema Museale, che è anche il Presidente della Commissione di Coordinamento Scientifico; la Commissione tecnico-scientifica e la Commissione di coordinamento. Il coordinamento tecnico del Sistema, da Regolamento, dovrà essere assicurato dall’Assessorato alla cultura della Pro-vincia di Oristano; mentre il coordinamento scientifico dovrà essere svolto da un’apposita Commissione costituita dai direttori dei musei aderenti al progetto e da un rappresentante del Servizio dei Beni Culturali dell’Assessorato Regio-nale competente379. La Commissione di Coordinamento invece avrà il compito di valutare le richieste di accesso così da favorire l’ampliamento del Sistema mediante l’adesione di nuove strutture musealizzate380. Dato che il Sistema Mu-seale Arborense fino a oggi (2009) non ha avviato le proprie attività, tali organi di gestione non sono mai stati concretamente attivati e quindi non hanno mai esercitato le loro funzioni.
L’atto formale con cui è stato istituito il Sistema risale al luglio 2006 e prevede l’adesione, oltre che della Provincia di Oristano come capofila, di una ventina di Comuni con i relativi beni di pertinenza381; tra gli Enti locali che parteci-pano al Sistema Museale Arborense non si annoverano solo quelli insistenti sul territorio del comprensorio di Oristano, ma anche i Comuni ubicati nelle aree limitrofe un tempo incluse entro i confini del giudicato di Arborea. Alla firma della Dichiarazione di Principio fece seguito la sottoscrizione dell’atto istitutivo, che vide partecipare al progetto anche i Comuni di Abbasanta, Asuni, Cuglieri, Masullas, Morgongiori e Norbello, portando a 28 il numero delle adesioni. Per contro le Diocesi di Ales-Terralba e di Alghero-Bosa e l’Arcidiocesi Arborense, pur avendo sottoscritto il documento di dichiarazione, non comparirono fra i firmatari dell’atto istitutivo382.
Tutti i partecipanti, con la firma dell’atto istitutivo, si sono impegnati a ri-spettare alcuni obiettivi tesi al miglioramento della qualità e quantità dei ser-vizi offerti fino a quel momento nei musei e siti archeologici di spettanza; tra i
378 Regolamento del Sistema Museale Arborense, Oristano, maggio 2006.379 Ivi, art. 12. 380 Ivi, artt. 11-13.381 Sono i Comuni di Abbasanta, Ales, Arborea, Asuni, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri,
Fordongianus, Ghilarza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Milis, Morgongiori, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Oristano, Pau, Paulilatino, Samugheo, San Vero Milis, Santa Giusta, Santulussurgiu, Sedilo, Suni, Tadasuni e Terralba. DGP (Oristano) n. 306 del 2005 cit. Atto istitutivo del Sistema Museale Arborense, Oristano 31 luglio 2006
382 Ivi.
199
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
doveri assunti vi erano l’adeguamento agli standard ministeriali, l’assunzione di figure professionali specializzate nel funzionamento delle strutture muse-alizzate, la partecipazione alla futura bigliettazione integrata nell’ambito del Sistema Museale Regionale, la creazione di un coordinamento tecnico e di un Responsabile Scientifico (eletto tra i direttori dei musei aderenti) 383. Il mancato avvio delle attività sistemiche ha comportato però l’impossibilità per i soggetti aderenti di mantener fede agli impegni presi nel documento d’istituzione.
Nell’aprile del 2007 la Provincia di Oristano, in quanto capofila del Sistema, si è resa disponibile a partecipare alla realizzazione del futuro Museo della Sar-degna Giudicale con sede nel capoluogo di Provincia; l’Amministrazione della Provincia di Oristano, infatti, si dichiarò favorevole a partecipare sia alla ge-stione del futuro istituto, sia alla sua realizzazione: a tale scopo concedeva i locali dell’ex Convento del Carmine quale sede oristanese del museo, mettendo a disposizione il personale già impiegato nell’Antiquarium Arborense384. Nell’esta-te di quello stesso anno però l’Amministrazione provinciale mutò opinione e decise di destinare a sede del Museo della Sardegna Giudicale il Palazzo Arcais, la cui riqualificazione è stata oggetto di una gara pubblica nel 2008 e i cui lavori di restauro stanno per essere ultimati (autunno 2009)385.
Le attività volte all’avvio di azioni di tipo sistemico attuate dalla Provincia di Oristano per il proprio territorio possono essere riscontrate in due distinte occasioni. La prima risale al 2006, quando la Provincia, come capofila del Siste-ma Museale Arborense, presentò al bando per i finanziamenti regionali a valere sulla legge regionale n. 7 del 2005 un progetto triennale di gestione denominato Ydra - Progetto di gestione associata dei Beni Culturali in Provincia di Oristano386. Il progetto prevedeva l’attivazione della gestione integrata per i beni culturali insistenti nel territorio provinciale e la creazione di itinerari tematici, definiti «vie», che includessero tutte le emergenze musealizzate, esistenti o da istituire, del comprensorio di riferimento. Anche il progetto Ydra al 2009 non si è ancora
383 Ivi. DGR n. 36/5 del 2005 cit.384 DGP (Oristano) n. 60 del 3 aprile 2007, Compartecipazione della Provincia di Oristano alla
costituzione del Museo Regionale della Sardegna Giudicale.385 Il museo giudicale avrà sede a Palazzo Arcais, «L’Unione Sarda», 11 agosto 2007; V. pInna,
Il Giudicato trova casa in via Dritta, «L’Unione Sarda», 26 settembre 2008; Palazzo Arcais, consegnati i lavori. Diventerà un museo giudicale, «La Nuova Sardegna», 29 settembre 2009.
386 Ydra-Progetto di gestione associata dei Beni Culturali in Provincia di Oristano, allegato n. 21 al documento Avanzamento Intesa Documento Operativo, Oristano Febbraio 2008; LR n. 7 del 21 aprile 2005; DGR n. 61/30 del 20 dicembre 2005; Bando per la Selezione di Progetti triennali di gestione dei servizi relativi ad aree e parchi archeologici, complessi mo-numentali, musei di ente locale e d’interesse locale, pubblicato nel sito web istituzionale della Regione Sardegna, all’indirizzo <http://www.regionesardegna.it>.
200
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
concretizzato a causa della mancata pubblicazione della graduatoria inerente il bando del 2006. Nel 2007 invece la Provincia ha presentato alla Regione, ancora in qualità di capofila del Sistema, un’istanza per accedere ai finanziamenti ne-cessari al restauro di beni culturali previsti dalla legge regionale 14/2006387. Le domande per accedere ai contributi regionali furono elaborate dalla Provincia con i Comuni interessati a interventi di restauro sui propri beni (Paulilatino, Santulussurgiu, Sedilo, Ales, Terralba, Ghilarza, Suni e Bosa): tra questi hanno potuto beneficiare dei suddetti finanziamenti regionali solo i Comuni di Sedilo e Suni388.
Fatta eccezione per queste due esperienze, il Sistema Museale Arborense non sembra aver avviato altre azioni e si presenta quindi al momento inattivo. Tut-tavia il caso del sistema oristanese presenta, pur se in via ancora progettuale e non concreta, alcuni aspetti distintivi. Innanzitutto si tratta, almeno a livello progettuale, dell’unico sistema a dimensione provinciale formalmente istituito fino a questo momento in Sardegna. Il Sistema inoltre è un esempio emblema-tico di come gli enti provinciali intendano organizzarsi per creare realtà gestio-nali di natura aggregativa al fine di riuscire ad adeguarsi agli indirizzi regionali dichiarati nel documento strategico del 2005, e successivamente ratificati con la legge regionale n. 14 del 2006389. La pronta reazione della Provincia è un fattore positivo, che indica la capacità dell’Ente di rispondere alle direttive regionali e di attivarsi per volgere a proprio vantaggio le opportunità regolarmente messe a disposizione. Una reazione altrettanto pronta si registra poi a livello comuna-le, grazie all’adesione di moltissimi Comuni al progetto. Purtroppo il mancato avvio delle attività rende impossibile una sua valutazione effettiva: tale ritardo si lega senza dubbio a quello con cui si procede a livello regionale all’attuazione del Sistema Museale Regionale, all’interno del quale avrebbe dovuto collocarsi il sistema oristanese, e alla realizzazione del Museo della Sardegna Giudicale, de-stinato a essere il centro del Sistema.
387 Istanza della Provincia di Oristano alla Regione Sardegna, Oristano 20 settembre 2007; LR n. 14 del 20 settembre 2006, Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.
388 DGR n. 49/25 del 5 dicembre 2007.389 DGR n. 36/5 del 2005 cit.; LR n. 14 del 20 settembre 2006 cit.
201
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
8 Fondazione Barumini Sistema Cultura [Borgioli]
A Barumini si conserva una delle più note testimonianze della cultura nura-gica, la Reggia denominata Su Nuraxi ed è attorno a questo importante monu-mento archeologico che, nel corso degli anni, si sono sviluppati l’offerta cultu-rale cittadina, i servizi museali e l’elaborazione di nuove forme di gestione per il patrimonio culturale390.
¬ I precedenti
Il sito Su Nuraxi, il primo villaggio nuragico a essere scavato con criteri scientifici negli anni Cinquanta dall’archeologo Giovanni Lilliu, costituisce il complesso megalitico più imponente e meglio conservato della Sardegna, col-locato tra le regioni della Marmilla e del Sarcidano, ai piedi dell’altopiano del-la Giara di Gesturi. La fortezza, oggi interamente visitabile, è costituita da un torrione centrale, racchiuso da un bastione quadrilobato e da un’altra struttura muraria con sette torri. Intorno al nuraghe si trova un ampio villaggio di ca-panne, fra cui la cosiddetta “capanna delle riunioni”, e altri ambienti legati a specifiche attività domestiche o rituali391. Il sito si trova in un’area inizialmente di proprietà privata, divenuta poi demaniale nel 1972, a seguito del ritrova-mento archeologico. Nel 1952 l’intera area è stata, infatti, sottoposta a vinco-lo archeologico e paesaggistico ex legibus 1089/1939 e 1497/1939, mentre sul territorio circostante, dalla fine degli anni Novanta, vige un vincolo di totale inedificabilità, individuato dal Piano Urbanistico Comunale di Barumini (Zona H a tutela preventiva)392. L’estrema importanza del rinvenimento richiamò im-mediatamente sul piccolo centro della Marmilla non solo l’attenzione degli stu-diosi, ma anche quella dell’opinione pubblica e la cittadinanza locale rispose a questo inaspettato interesse con l’avvio di nuove attività commerciali di tipo turistico393.
390 Sull’esperienza di Barumini si veda anche l’intervento del Presidente della Fondazione al convegno Sistemi museali e musei in Sardegna: e. lIllIu, Fondazione Barumini Sistema Cultura in c. BorGIolI, d. la MonIca (a cura di), Sistemi museali e musei in Sardegna, Atti del convegno (Sassari 2010), Felici Editore, Pisa 2012, pp. 137-140.
391 G. lIllIu, r. zucca, Storia della scoperta, degli scavi e degli studi del nuraghe Su Nuraxi in Su Nuraxi di Barumini, Collana «Sardegna Archeologica», Sassari 2005, con riferimen-ti bibliografici; si vedano anche i siti <http://www.sardegnacultura.it>; <http://www.sitiunesco.it>; <http://www.comune.barumini.ca.it>.
392 World Heritage Committee Twenty-first session, Committee Report n. 833, Napoli 1-6 dicembre 1997, consultabile in estratto sul sito <http://www.unesco.beniculturali.it>.
393 G. lIllIu, r. zucca, Storia della scoperta, degli scavi cit., p. 33, cui si rimanda per ulterio-
202
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Negli anni Settanta, a seguito del ritrovamento di un altro villaggio nuragi-co, quello di Genna Maria (1969) presso il vicino centro di Villanovaforru, la co-munità scientifica cominciò a ipotizzare di porre in relazione i due siti creando un unico museo di tipo comprensoriale. Tale museo avrebbe dovuto ospitare i reperti provenienti dal sito Su Nuraxi, dal sito Genna Maria e da altre campagne di scavo condotte in quelle aree. Il progetto del museo comprensoriale tutta-via non si attuò: nel 1984, infatti, fu allestito un museo archeologico comuna-le presso Villanovaforru, che non esponeva reperti provenienti da Barumini. Dunque, a Barumini, ancora negli anni Ottanta non solo non esisteva un museo archeologico ma lo stesso sito veniva reso fruibile solo grazie al lavoro di alcuni volontari, senza l’attuazione di alcun servizio se non quello dell’accompagna-mento alla visita394.
Nei primi anni Novanta (1990-1994) l’area di Su Nuraxi fu soggetta a una se-rie di interventi relativi al consolidamento del complesso archeologico e all’in-stallazione di strutture atte ad agevolarne la fruizione, come illuminazione, scale e passerelle. Tali lavori furono eseguiti grazie alle risorse ordinarie della Soprintendenza alle quali si aggiunsero quelle relative al progetto sugli Itinerari del Mezzogiorno (direttrice Fenicio-cartaginese-nuragica) finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno395.
Contestualmente la Soprintendenza affidò la gestione del sito Su Nuraxi al Comune di Barumini, mediante una convenzione rinnovata da ultimo nel 2007396. Dal 1994 al termine dei suddetti lavori di restauro guidati dalla So-printendenza, la società locale Ichnussa, dopo aver presentato un progetto alla Soprintendenza competente e in accordo col Comune, assunse la gestione dei servizi di Su Nuraxi per conto dell’Ente locale; questi ultimi consistevano essen-zialmente nella visita guidata poiché, data la conformazione dell’area archeolo-gica, per motivi di sicurezza fu necessario rendere obbligatorio l’accompagna-mento dell’utenza397.
ri riferimenti bibliografici.394 u. BadaS, Musei di interesse comprensoriale: esperienze e proposte in Cultura e ambiente,
Atti della prima conferenza regionale sui beni culturali e ambientali, (Cagliari 1986), pp. 275-278.
395 World Heritage Committee Twenty-first session, Committee Report n. 833, Napoli 1-6 dicembre 1997, consultabile in estratto sul sito <http://www.unesco.beniculturali.it>.
396 Informazione fornita dalla dott.ssa Cocco, referente per l’area di Barumini, Soprin-tendenza Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano mediante comunicazio-ne orale in data 2 novembre 2009.
397 G. MarraS, Il caso di Barumini in Giornata sulla gestione dei beni culturali in Sardegna, Atti
203
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Tra il 1994 e il 2002, anche grazie ai nuovi servizi attivati, si è registrato un crescente flusso di visitatori che ha permesso alla società di svilupparsi, au-mentando il numero del personale impiegato e creando un primo centro di accoglienza per i visitatori nell’ex Convento dei Cappuccini di proprietà co-munale398.
Con la crescita dell’interesse da parte degli enti locali, il coinvolgimento di più soggetti nella gestione del sito e le innovazioni normative che consentivano nuovi modelli gestionali per la dotazione di servizi culturali, il Comune si at-tivò anche per altre iniziative. Dal 1999 il Comune di Barumini ha preso parte al Consorzio intercomunale turistico della Marmilla Sa Corona Arrùbia (costi-tuitosi nel 1982) con l’intenzione di condividerne alcune azioni di promozione territoriale399. Quest’ultima è stata attuata principalmente attraverso la pubbli-cazione di itinerari virtuali sul sito web ufficiale del Consorzio400.
¬ L’inserimento nella “lista” Unesco
Il crescente successo, in termini di pubblico e visibilità, consentì al Comune di Barumini di farsi promotore di varie altre iniziative, la più importante delle quali fu la presentazione della candidatura Unesco per il sito archeologico Su Nuraxi: tale candidatura fu accolta e nel 1997 Su Nuraxi è stato inserito nella World Heritage List dell’Unesco con la seguente motivazione:
The Committee decided to inscribe this property on the basis of cultural criteria (i), (iii) and (iv), considering that the nuraghe of Sardinia, of which Su Nuraxi is the pre-eminent example, represent an exceptional response to political and social conditions, making an imaginative and innovative use of the materials and techniques available to a prehistoric island community401.
L’iscrizione nella lista Unesco, se da un lato ha comportato una maggiore vi-sibilità a livello internazionale per il monumento, dall’altro ha anche implicato l’adempimento di un’impegnativa serie di attività per la gestione del sito. Oltre ad assicurare l’impiego di personale professionalmente qualificato e il rispetto di standard qualitativi per i servizi, le prescrizioni Unesco prevedono dal 2002
del Convegno, (Sassari 2002), pp. 25-26.398 Ivi. Si veda anche l’eco che ciò ebbe sulla stampa locale: cfr. ad esempio, Barumini,
prima pagina del «L’Unione Sarda», 10 novembre 1999. Quindi si veda World Herit-age Committee Twenty-first session, Committee Report n. 833 cit.
399 Statuto del Consorzio turistico Sa Corona Arrùbia, registrato a Sanluri in data 10 di-cembre 1999.
400 <http://www.sacoronaspa.it/itinerari%20megalitico.htm>.401 World Heritage Committee Twenty-first session, Committee Report n. 833 cit.
204
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
anche l’elaborazione di uno specifico Piano di Gestione Territoriale402. Nel corso della XXVI sessione, tenutasi a Budapest nel 2002, il Comitato Unesco produsse un documento (Dichiarazione di Budapest) in cui si invitavano tutti i partner a individuare e perseguire una serie di obiettivi strategici per la salvaguardia e la promozione dei beni inseriti nella lista Unesco. Fu quindi deciso che, a partire dal 2002, ogni richiesta d’iscrizione avrebbe dovuto essere accompagnata da un apposito Piano di Gestione contenente i programmi e la metodologia da adottare per la tutela del bene. In Italia lo strumento del piano di gestione è stato succes-sivamente ratificato attraverso la legge n. 77 del 2006403.
Nel marzo 2005 fu stipulato un Protocollo d’intesa per la predisposizione del piano di gestione per Barumini tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali (attraverso la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sar-degna, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Cagliari e Oristano), la Regione Sardegna, la Provincia di Cagliari e i Comuni di Baru-mini, Gesturi, Las Plassas, Tuili e Villanovafranca. Nel 2007 il Protocollo è stato esteso ad altri Comuni del territorio (Genuri, Setzu, Genoni) e alla Provincia del Medio Campidano404. Il Piano di Gestione doveva essere concluso entro il 2009, pena l’esclusione del sito dalla Lista del Patrimonio Universale dell’Unesco; per
402 Informazione ricevuta dalla dott.ssa Daniela Moi, funzionaria del Comune di Baru-mini mediante comunicazione scritta in data 15 giugno 2009.
403 26COM 9-Budapest Declaration on World Heritage, Budapest 28 giugno 2002, con-sultabile sul sito ufficiale UNESCO <http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/14/il-piano-di-gestione>. L n. 77 del 20 febbraio 2006, Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale. Il Piano di gestione viene descritto all’articolo 3: «1) Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione. 2) I piani di gestione de-finiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall’articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con program-mi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette. 3) Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato “Codice”».
404 Si vedano le premesse alla DGR n. 47/19 del 20 ottobre 2009, Redazione del Piano di gestione del sito archeologico UNESCO “Su nuraxi” di Barumini. Finanziamento dei lavori di completamento.
205
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
questo la Regione approvò, in quello stesso anno, un finanziamento speciale di 300 mila euro da destinare al suo completamento405.
Nel corso degli anni, alla alla concessione dei servizi alla società Ichnussa (1994), all’inserimento del sito nella lista Unesco (1997), all’adesione del Comu-ne di Barumini al Consorzio turistico (1999) si sono aggiunte anche altre occa-sioni di approvvigionamento di risorse, specialmente a partire dal 2000. Con il POR Sardegna 2000-2006, per esempio, il Comune di Barumini è stato inserito tra i beneficiari dei finanziamenti relativi al II Asse, Misura 2.1 Itinerari di arche-ologia nuragica e prenuragica negli altipiani della Sardegna Centro-Occidentale, per i seguenti interventi: la realizzazione di un Centro servizi comunale, la creazione di un Museo archeologico e il restauro della Reggia Su Nuraxi406. Nel luglio del 2006 è stato così inaugurato il Polo Espositivo di Casa Zapata, realizzato appunto grazie ai finanziamenti POR, che ha arricchito l’offerta culturale del Comune di Barumini, dotando la cittadina di un museo archeologico fino a allora inesi-stente407.
Il Sistema baruminese si è realizzato gradualmente negli anni in cui la Regio-ne provvedeva ad elaborare puntuali politiche di indirizzo per la creazione di un sistema museale regionale organizzato in sottosistemi a dimensione territo-riale: si ricordano a tale proposito il documento di indirizzo del 2005, Sistema Regionale dei Musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo (approvato con delibera GR 36/5 del 26 luglio 2005), e la legge regionale n. 14 del 20 settembre 2006, Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura. Nella documenta-zione ufficiale relativa alla nascita del sistema di Barumini non si trovano espli-citi riferimenti alla norma regionale né all’Atto di indirizzo del 2005; tuttavia, sebbene non vi siano dirette relazioni, l’esperienza di Barumini prende avvio in un momento in cui le politiche regionali cominciano ad orientarsi verso il so-stegno ai sistemi sollecitando le realtà locali a organizzarsi in forma reticolare.
¬ La Fondazione Barumini Sistema Cultura
Il passaggio cruciale si registra alla fine del 2006, quando il Comune di Baru-mini costituì la Fondazione Barumini Sistema Cultura allo scopo di affidare a tale soggetto la gestione del costituendo sistema museale, al tempo composto dal sito Su Nuraxi e dal nuovo istituto Casa Zapata. Nel mese di dicembre 2006, con
405 Ivi.406 Determinazione del Direttore del Servizio beni culturali della Regione Sardegna n. 93
del 5 febbraio 2003.407 t. Serra, Casa Zapata, un museo che poggia sulla storia, in «Siti», III, 4, ottobre/dicembre
2007, consultabile in <http://www.sitiunesco.it>.
206
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
quattro successive delibere, l’Amministrazione ha provveduto infatti a istituire la Fondazione, ad esternalizzare i servizi dei beni di spettanza e ad affidarli al nuovo soggetto. Nonostante lo Statuto della Fondazione preveda la possibi-lità di partecipazione per soggetti di natura pubblica e privata che ne condi-vidano gli obiettivi, attualmente (2009) l’unico partecipante alla Fondazione risulta essere lo stesso fondatore, ovvero il Comune di Barumini408. L’esistenza della Fondazione ha dato il via a una gestione di tipo sistemico delle strutture musealizzate comunali: Barumini rappresenta il primo esempio in Sardegna di fondazione nata dalla volontà di un Comune per gestire e valorizzare i beni culturali presenti nel proprio territorio, come ha subito rilevato anche la stampa locale409.
La decisione di creare una Fondazione per la gestione del patrimonio locale è stata determinata dalla collaborazione con Federculture, cui il Comune di Ba-rumini è associato. Tale collaborazione è stata avviata allo scopo di individuare il miglior strumento giuridico e gestionale atto a gestire i beni culturali e ad espletare i compiti cui l’Amministrazione comunale è stata chiamata a seguito dell’inserimento nella lista Unesco dell’area archeologica410.
Alla Fondazione sono stati inoltre trasferiti i finanziamenti regionali destina-ti fino a quel momento al Comune per il progetto di gestione dell’area archeolo-gica411. La Fondazione avrebbe permesso di gestire, in maniera congiunta, non solo la reggia nuragica ma anche altre due strutture comunali musealizzate, allora in fase di allestimento in quanto previste dagli interventi a valere sulla misura 2.1 del POR Sardegna 2000-2006: il Museo archeologico presso la co-
408 Sull’istituzione della Fondazione si vedano le DCC di Barumini nn. 45 e 46 del 7 dicembre 2006; DCC di Barumini n. 52 del 27 dicembre 2006; DGC di Barumini n. 105 del 27 dicembre 2006. In particolare poi si vedano gli artt. 9 e 10 dello Statuto della Fondazione Barumini Sistema Cultura approvato con la citata DCC n. 45/2006.
409 c. Fadda Il nuraghe in mano ai manager, «L’Unione Sarda», 31 gennaio 2007; IdeM, Unesco: Barumini è un modello, «L’Unione Sarda», 4 luglio 2008. Il sistema museale realizzato dalla Fondazione è attualmente formato: dal sito archeologico Su Nuraxi, dal Polo Espositivo di Casa Zapata (2006) e dal Centro di promozione e comunicazione cul-turale Giovanni Lilliu (2008). La Fondazione Barumini Sistema Cultura è stata iscritta nel dicembre 2008 nel Registro regionale delle persone giuridiche: estratto dalla De-terminazione del Direttore del Servizio affari generali e istituzionali della Regione Sardegna, n. 1570 del 19 dicembre 2008, BURAS n.1 del 10 gennaio 2009.
410 Si veda in particolare la citata DGC di Barumini 45/2007; si veda anche Progetti gover-nance e modelli di gestione. I progetti realizzati. Comune di Barumini 2006. Definizione del modello giuridico per la valorizzazione e gestione del sistema culturale di Barumini consul-tabile sul sito ufficiale di Federculture all’indirizzo <http://federculture.it>.
411 LR n. 4 del 20 aprile 2000; DGR n. 36/6 del 5 settembre 2000; DGR n. 39/52 del 10 dicembre 2002.
207
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
siddetta Casa Zapata ed il Centro di accoglienza intitolato a Giovanni Lilliu412.Attraverso la Fondazione il Comune di Barumini realizza una forma di ge-
stione sistemica per tre strutture: il sito archeologico Su Nuraxi, che costituisce come ovvio il centro attorno al quale si articola la restante offerta culturale citta-dina, il Polo Espositivo di Casa Zapata che conserva i reperti provenienti dall’area nuragica e il Centro di comunicazione e promozione culturale Giovanni Lilliu (aperto nell’aprile 2008) che funziona da punto di accoglienza e informazione.
Il Polo Espositivo di Casa Zapata è stato inaugurato il 29 luglio 2006 e si svilup-pa all’interno di un complesso architettonico del centro storico, risalente alla seconda metà del XVI secolo: si tratta della dimora della famiglia di Don Azor Zapata, il nobile sardo d’origine iberica che acquistò la Baronia di Las Plassas, Barumini e Villanovafranca. Durante i lavori di recupero della struttura, acqui-stata dal Comune alla fine degli anni Novanta per realizzare il museo archeo-logico cittadino anche grazie ai citati finanziamenti POR, furono rinvenute le rovine del grande nuraghe Su Nuraxi ‘e Cresia, chiamato così per la sua vicinan-za con la chiesa parrocchiale413. L’Amministrazione comunale si trovò pertanto di fronte alla necessità di adattare la struttura museale in fieri alle inaspettate esigenze di conservazione e fruibilità dell’importante ritrovamento archeolo-gico. Per questo l’allestimento museografico rende apprezzabile anche l’intera struttura del nuraghe: il percorso museale si snoda su una passerella metallica con parapetti in cristallo appesa a tiranti in acciaio, che collega i luoghi più significativi del complesso museale e permette di cogliere numerosi dettagli costruttivi del nuraghe da un punto di osservazione inconsueto, accattivante e fortemente didattico. In questo suggestivo ambiente è stata allestita la raccolta archeologica, composta dai reperti emersi durante gli scavi condotti nella reg-gia Su Nuraxi e in altri siti della zona.
Oltre alla sezione archeologica il Museo conserva una raccolta storico-do-cumentaria e una etnografica. Nella prima, allestita all’interno di un grande caseggiato che fu in origine il deposito delle derrate alimentari di Casa Zapata, sono ospitati oggetti e soprattutto documenti che raccontano la storia della fa-miglia, del feudo di proprietà e del rapporto con la comunità locale. L’insieme dei documenti esposti proviene dall’Archivio Zapata, un fondo ricco di oltre trentamila carte, dall’Archivio comunale e da quello del locale Monte di Soc-corso.
La sezione etnografica è dedicata invece agli strumenti della vita quotidia-na della comunità baruminese, legata all’attività agricola e pastorale. In questa piccola sezione è racchiusa la memoria della cultura popolare: gli utensili espo-
412 Determinazione Direttore Servizio BBCC Regione Sardegna n. 93 del 5 febbraio 2003.413 FondazIone BaruMInI SISteMa cultura, Casa Zapata. Il nuraghe museo, s.d, s.l.
208
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
sti sono collocati all’interno di una teoria di lollas, tipiche logge per il ricovero degli animali e degli alimenti, la costruzione delle quali è riconducibile ai gran-di lavori di rifacimento novecenteschi − protrattisi fino agli anni Trenta ma mai ultimati − che hanno interessato Casa Zapata in occasione del matrimonio fra Don Lorenzo e Donna Concetta, ultimi eredi della famiglia.
Appartiene alla raccolta etnografica anche un’importante collezione di lau-neddas − l’antichissimo strumento musicale sardo che ancora oggi è alla base della musica e del ballo popolare − donata al Museo di Barumini e che costitu-isce una sorta di piccolo “museo nel museo”414.
Il Centro di comunicazione e promozione culturale Giovanni Lilliu è stato invece aperto nell’aprile 2008 per accogliere in spazi idonei e con opportuni servizi i visitatori giunti a Barumini e sviluppare al contempo azioni di marketing ter-ritoriale415. Con l’apertura di questo Centro, il Comune di Barumini ha voluto creare un luogo in cui si potessero coniugare servizi museali e di promozione turistica, proponendo approfondimenti e informazioni non solo per quanto concerne il patrimonio culturale ma anche per l’enogastronomia e le produzio-ni artigianali del comprensorio.
Il Centro, strategicamente collocato a metà strada tra l’area archeologica e la città di Barumini, costituisce una grande unità introduttiva sull’archeologia, la storia, il patrimonio naturale e le produzioni locali della cittadina di Barumini e dell’area geografica della Marmilla. Il complesso, infatti, comprende una sezio-ne espositiva divisa per settori, in grado di accogliere più eventi contempora-neamente. Qui vengono ospitate esposizioni temporanee, convegni, spettacoli e laboratori didattici. In uno di questi settori è ospitata ad esempio Artigianar-te, una mostra-mercato a carattere permanente organizzata e patrocinata dalla Provincia del Medio Campidano allo scopo di valorizzare appieno l’artigianato artistico dell’intero territorio provinciale416. All’interno del Centro, oltre agli uf-fici della Fondazione, sono inoltre attivi uno sportello turistico per il territorio provinciale, un bookshop e una caffetteria, tutti gestiti dalla Fondazione Baru-mini Sistema Cultura.
La principale finalità della Fondazione, così come dichiarato nel relativo Statuto, è quella di «tutelare, conservare, valorizzare e gestire» il patrimonio culturale del Comune di Barumini in modo da promuoverne la conoscenza e assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.417 L’a-
414 Ivi. La collezione di strumenti musicali costituirà il nucleo fondante del futuro Museo Regionale delle launeddas.
415 <http://www.comune.barumini.ca.it>.416 DCP del Medio Campidano n. 48 del 26 giugno 2008.417 Art. 2 dello Statuto della Fondazione approvato con DGC di Barumini n. 45 del 7
dicembre 2006.
209
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
dozione del soggetto giuridico della Fondazione è stata individuata dal Comu-ne, in collaborazione con Federculture, come la soluzione più idonea per rispon-dere ai problemi di gestione per Su Nuraxi e i musei comunali, specialmente per quanto concerne l’adeguamento ai criteri imposti dall’iscrizione del sito nel patrimonio mondiale Unesco.
Nella realizzazione di una gestione sistemica tra il sito e i musei l’Ammini-strazione locale intende anche implementare e sviluppare il turismo, non solo migliorando i servizi per la fruizione dei beni ma anche promuovendo luoghi meno noti del territorio e valorizzando la produzione artigianale e enogastro-nomica418.
L’esperienza sistemica realizzata dal Comune tramite la Fondazione Baru-mini Sistema Cultura si concretizza nel 2006 mediante tre azioni: la costituzione di un unico soggetto gestore (la Fondazione), l’attivazione di un biglietto uni-co per le tre strutture coinvolte (sito archeologico, Museo Casa Zapata e Centro Giovanni Lilliu) e l’attività di promozione culturale effettuata presso il Centro Giovanni Lilliu419.
La Fondazione gestisce tutti i servizi del “sistema”: la bigliettazione, le vi-site guidate, le attività didattiche, il bookshop, la caffetteria, le informazioni turistiche e la promozione, affidata al materiale pubblicitario cartaceo (cartine, cartoline, brochures), reperibile presso le strutture museali e nei siti coinvolti, alla pubblicazione di opuscoli illustrati nonché all’organizzazione di mostre, convegni, giornate di studio, manifestazioni ed altri eventi culturali420.
La Fondazione si configura come un soggetto di diritto privato senza sco-po di lucro, che dispone di autonomia statutaria e gestionale421. Gli organi di amministrazione e di gestione della Fondazione sono: il Presidente e il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale d’Indirizzo, l’Assemblea Generale, il Segretario Generale, il Collegio dei Revisori dei Con-ti422. Il Presidente è «di diritto» il Sindaco di Barumini o un suo delegato, ha la rappresentanza legale della Fondazione, presiede il Consiglio di Amministra-zione, il Consiglio Generale di Indirizzo e l’Assemblea Generale423.
418 d. MoI, Fondazione Barumini Sistema cultura, «Siti», V, n. 1, gennaio-marzo 2009, con-sultabile in <http://www.sitiunesco.it>.
419 DGC di Barumini n. 46 del 7 dicembre 2006; DGC di Barumini n. 105 del 27 dicembre 2006.
420 Le informazioni relative alle attività della Fondazione sono state gentilmente fornite dalla dott.ssa Daniela Moi, funzionaria del Comune di Barumini tramite comunica-zione scritta in data 15 giugno 2009.
421 Art. 1 dello Statuto approvato con DCC di Barumini n. 45 del 7 dicembre 2006.422 Ivi, art. 16.423 Ivi, art. 17.
210
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Il Consiglio di Amministrazione (formato dal Presidente e da due membri nominati dall’Assemblea generale) delibera in merito agli obiettivi e ai pro-grammi della Fondazione, predispone i bilanci, dispone l’impiego dei fondi patrimoniali, indica i criteri per l’assunzione del personale, assume le decisioni per la stipula di contratti e convenzioni; ha inoltre facoltà di nominare i Comi-tati Scientifici per la consulenza e l’approfondimento di particolari tematiche rientranti negli interessi della Fondazione424.
Il Consiglio Generale d’Indirizzo è l’organo preposto a fornire pareri e pre-sentare proposte circa le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, verificandone i risultati. Compongono tale organo i rappresentanti dei diversi soggetti partecipanti alla Fondazione: in realtà, dato che l’unico partecipante alla Fondazione è attualmente il Comune di Barumini, il Consiglio generale è diretta espressione dell’Ente locale425.
L’Assemblea Generale, composta dal Presidente e dai rappresentanti di tutti i partecipanti, formula pareri consultivi e proposte su attività, programmi e obiettivi della Fondazione426. Il Segretario Generale coordina le attività della Fondazione, mentre il Revisore dei Conti ha il compito di provvedere al riscon-tro della gestione finanziaria (art. 23 dello Statuto).
Dal punto di vista delle risorse umane, la Fondazione impiega cinquanta operatori con diverse mansioni nel settore museale. Tra questi sono compresi anche gli ex dipendenti della società Ichnussa cui, dal 1994 fino alla nascita della Fondazione, è stata affidata la gestione del patrimonio culturale di spettanza comunale427. Al suo interno sono pertanto confluite quattordici figure profes-sionali già appartenenti alla società, un tempo concessionaria della gestione comunale di Su Nuraxi, mentre gli altri impiegati sono stati assunti direttamen-te dalla Fondazione al momento della sua costituzione. Questo ampliamento di personale − che comprende manutentori, archeologi, guide turistiche, sto-rici dell’arte, guardiani, addetti alla ristorazione e alle pulizie − è motivato dall’accrescimento negli ultimi anni dell’offerta museale cittadina e dei relativi servizi. Nello specifico, la gestione esercitata dalla Fondazione prevede, attra-verso il personale sopra indicato, le attività di accoglienza, accompagnamento e servizio guida ai monumenti e al museo (anche in occasione di mostre), la manutenzione (compresa la pulizia delle strutture e delle aree archeologiche), la sorveglianza, la gestione dei servizi aggiuntivi (punti di ristoro, bookshop,
424 Ivi, artt. 18, 19, 26.425 Ivi, artt. 20 e 21.426 Ivi, art. 22.427 Questa informazione è stata dedotta dalla comunicazione scritta ricevuta dalla dott.
ssa Daniela Moi, funzionaria del Comune di Barumini, in data 15 giugno 2009.
211
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
info-point) e, infine, l’organizzazione di eventi culturali come manifestazioni e convegni.
La Fondazione gode di autonomia statutaria e gestionale, disponendo di un Fondo di dotazione indisponibile e di un Fondo di gestione disponibile per la gestione di esercizio428. Il Fondo di dotazione indisponibile è costituito dai beni immobili di proprietà della Fondazione, o conferiti a questa ad uso permanente, e dalle donazioni effettuate da privati. Il Fondo di gestione disponibile è dato dagli introiti delle attività svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione, dai beni mobili e immobili concessi a questa non in uso permanente, dai frutti dell’inve-stimento patrimoniale, dall’iniziale conferimento di 25 mila euro effettuato dal Comune di Barumini come partecipante fondatore, dai contributi e dalle do-nazioni pubbliche e private espressamente destinate alle attività dell’esercizio.
Il Comune di Barumini trasferisce inoltre alla Fondazione le risorse derivan-ti dagli interventi economici regionali per gli enti locali finalizzati alla gestione del personale impiegato nei beni culturali ex art. 38 LR 4/2000429. Fino all’i-stituzione della Fondazione, infatti, il personale impiegato nella gestione del sito archeologico Su Nuraxi, gestito dalla società Ichnussa in convenzione con il Comune, era pagato unicamente grazie ai cofinanziamenti regionali attribuiti all’Amministrazione comunale sulla base di quanto stabilito dalla LR 4/2000430.
Dal 2006, ovvero dalla nascita della Fondazione, questi contributi regionali sono andati a coprire le spese relative alle figure professionali già appartenenti alla società e poi assunte dalla Fondazione, mentre per il rimanente personale impiegato la Fondazione provvede attraverso gli incassi derivanti dalle attività gestionali e dai servizi aggiuntivi. Tra questi si possono annoverare gli introiti della bigliettazione, della vendita di souvenir e di prodotti locali presso il Cen-tro Giovanni Lilliu, i proventi derivati dall’attività convegnistica o dall’affitto delle sale, le entrate dei punti ristoro431. Per quanto concerne i proventi deri-vanti dalla bigliettazione (ingresso museo Casa Zapata, esposizioni temporanee del Centro Lilliu e sito Su Nuraxi) questi vengono incamerati direttamente dalla Fondazione che provvede però a versarne il 10% all’Amministrazione comu-nale432.
Il Comune di Barumini ha quindi saputo creare nel corso degli anni un’of-ferta culturale di qualità, articolandola intorno alla presenza di uno dei più im-
428 Artt. 1 e 5 dello Statuto della Fondazione Barumini approvato con DCC di Barumini n. 45 del 7 dicembre 2006.
429 DCC di Barumini n. 52 del 27 dicembre 2006.430 DGR n. 36/32 del 23 ottobre 2001.431 Informazione ricevuta dalla dott.ssa Daniela Moi, funzionaria del Comune di Baru-
mini mediante comunicazione scritta in data 15 giugno 2009.432 DCC di Barumini 52/2006 cit. e DGC di Barumini 105/2006.
212
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
portanti monumenti dell’Isola. Il richiamo turistico esercitato dalla Reggia nu-ragica è stato lo strumento che ha permesso di organizzare un piccolo sistema che cerca oggi di sviluppare però anche altre tematiche, supplementari rispetto a quella dell’archeologia nuragica, ma comunque intimamente connesse alla storia locale, come avviene per esempio con il Museo di Casa Zapata. La lun-gimiranza del Comune è stata quella di non basare l’intera offerta culturale e turistica cittadina sul solo sito Su Nuraxi, pur essendo pienamente consapevole che il grande flusso di visitatori di Barumini è diretta conseguenza della pre-senza del monumento. L’attenzione riposta negli allestimenti museali, l’attività convegnistica e quelle di supporto alla visita rendono il caso di Barumini come uno tra i più vivaci del contesto sardo. La stessa costituzione di una Fondazio-ne, la prima nata per volontà comunale nell’Isola, conferma il forte interesse del Comune allo sviluppo del comparto turistico-culturale come perno dell’econo-mia locale. Il fatto che, a tre anni di distanza dalla sua istituzione, la Fondazione continui a essere costituita unicamente dal Comune di Barumini – malgrado il relativo Statuto preveda anche l’adesione di altri soggetti433 – risponde a una precisa strategia adottata dall’Amministrazione locale e finalizzata a non ap-portare nessun cambiamento al tipo di gestione sinora applicato al patrimonio culturale di proprietà e spettanza comunale. La partecipazione di nuovi sogget-ti, pubblici e privati, comporterebbe infatti inevitabilmente delle modifiche alla gestione effettuata con riscontri positivi dal 2006.
¬ Conclusioni
Questo caso di studio dimostra in maniera molto chiara alcune interessanti dinamiche. In primo luogo l’affidamento della gestione di aree archeologiche demaniali da parte della Soprintendenza competente a un’amministrazione co-munale, una prassi piuttosto diffusa nella Sardegna degli anni Ottanta, quan-do gli uffici periferici del Ministero non disponevano di sufficiente organico mentre i Comuni beneficiavano dei contributi regionali a valere sulla norma contro la disoccupazione (legge regionale 28/1984)434. In secondo luogo la con-cessione da parte del Comune della gestione dei servizi a una società locale e la successiva presa di coscienza dell’importanza del settore culturale nell’ambito dell’economia locale. Ciò ha spinto il Comune ad attivarsi su più fronti per l’intercettazione di risorse da destinare a tale comparto: la candidatura Unesco, la domanda all’ente regionale per i fondi da utilizzare per il personale impiega-to nel settore culturale, l’orientamento verso il comparto della valorizzazione
433 Statuto della Fondazione approvato con DCC di Barumini n. 45 del 2006 cit.434 LR n. 28 del 7 giugno 1984, Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione.
213
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
delle risorse locali tramite il POR, l’adesione a Federculture e il dialogo per l’in-dividuazione della miglior forma di gestione. Questi passi sono stati compiuti per iniziativa esclusiva dell’Ente comunale, che ha compreso l’importanza dei resti archeologici e che ha voluto ampliare l’offerta introducendo anche altri beni presenti nel tessuto urbano.
Si possono registrare anche alcuni successi: l’aumento di pubblico, l’aper-tura di nuovi spazi museali, l’aumento dell’occupazione, l’incremento degli introiti finanziari destinati al personale. Negativamente invece va giudicata la mancata elaborazione del Piano di gestione, inadempienza che rischia di far usci-re il sito dalla lista Unesco.
214
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
9 Il Sistema museale MUSTER-Sa Corona Arrùbia [Deligia]
Il Sistema museale denominato MUSTER, acronimo di MUSei del TERritorio, è un progetto interprovinciale per la messa in rete del patrimonio culturale locale. Il progetto si sviluppa nel territorio del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia ed è finalizzato al potenziamento dell’offerta museale e dei servizi con-nessi, così da riuscire a creare per le comunità interessate proficue occasioni di sviluppo economico, legate principalmente alle attività turistiche435. Il Consor-zio Turistico ha avuto la funzione di capofila mentre i sei Comuni consorziati di Collinas, Gonnostramatza, Lunamatrona, Mogoro, Pauli Arbarei e Segariu hanno avuto il ruolo di partners; ognuno di questi soggetti ha aderito al MU-STER con i beni culturali di spettanza436. Il Sistema è stato attivo solo nel corso del triennio 2007-2009.
¬ Precedenti
Il progetto relativo alla creazione del Sistema museale MUSTER è stato ela-borato nel settembre 2006 in occasione della partecipazione al bando di finan-ziamento regionale a valere sulla legge regionale n. 7 del 2005 per l’erogazione di contributi per la gestione del patrimonio culturale degli Enti locali437. Le di-rettive di attuazione della legge prevedevano in particolare contributi fino al 70% da destinare agli Enti locali che avessero presentato alla Regione uno spe-cifico piano triennale per la gestione dei beni culturali di pertinenza, riservando
435 Convenzione per la costituzione e la gestione associata del sistema museale territoriale MU-STER-Sa Corona Arrùbia, Villanovaforru 13 settembre 2006.
436 Ivi.437 Progetto Triennale Muster-Sa Corona Arrùbia approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia n. 33 del 6 settembre 2006, Approvazione Progetto Triennale di gestione dei servizi relativi ad aree e parchi arche-ologici, complessi monumentali, musei di ente locale. L.R. 21/04/2005 n° 7 art. 12 comma 3 Deliberazione G.R. 61/60 del 20.12.2005. LR n. 7 del 21 aprile 2005, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005); DGR n. 61/30 del 20 dicembre 2005, Linee di indirizzo relative all’erogazione di contributi agli Enti Locali pubblici territoriali della Sardegna per concorrere agli oneri d’esercizio dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito culturale. L.R. 21.4.2005 n. 7 art. 12 comma 3. UPBS 11027 Capitolo 11212, UBPS 11 033 Capitolo 11247. Regione Autonoma della Sardegna, Bando per la Selezione di Progetti triennali di gestione dei servizi relativi ad aree e parchi archeologici, complessi monumentali, musei di ente locale e d’interesse locale, consultabile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, all’in-dirizzo <http://www.regionesardegna.it>.
215
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
inoltre un premio del 5% a quelli con popolazione inferiore alle tremila unità che avessero partecipato al bando in forma associata438 .
Il progetto MUSTER preveda che l’istituzione del Sistema coincidesse con l’attivazione di una gestione congiunta di tutti i beni musealizzati coinvolti; tale proposta era piuttosto ambiziosa in quanto alcuni musei comunali (Colli-nas, Lunamatrona, Mogoro, Pauli Arbarei e Segariu) erano al tempo ancora ine-sistenti e avrebbero quindi dovuto aprire in occasione dell’avvio del sistema439. Diversa era poi la condizione di altre strutture culturali aderenti al progetto: il museo comunale Turcus ‘e Morus di Gonnostramatza e i beni di proprietà del Consorzio Sa Corona Arrùbia – Museo del Territorio, Parco Geobotanico, Parco dei Monumenti Nuragici e Prenuragici, seggiovia e Centro di Ristoro – erano già attivi e, proprio per questo motivo, beneficiavano da tempo dei finanziamenti regio-nali erogati in base alla legge regionale n. 4 del 2000, che stanziava contributi destinati agli Enti locali per la gestione del patrimonio culturale440. Le risorse a valere sulla questa norma avevano permesso al Consorzio e al Comune di Gonnostramatza di attivare, a partire dai primi anni Duemila, i rispettivi pro-getti di gestione: il Consorzio aveva avviato la gestione integrata dei beni di sua proprietà, mentre il Comune di Gonnostramatza aveva dato inizio alla gestione del Museo comunale Turcus ‘e Morus441.
438 DGR n. 61/30 del 2005, cit. Regione Autonoma della Sardegna, Bando per la Selezione di Progetti triennali, cit.
439 Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia n. 33 del 2006, cit.
440 LR n. 4 del 20 aprile 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000); DGR n. 36/6 del 5 settembre 2000, L.R. n. 4/2000 art. 38. Beni Culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli Enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione dei servizi relativi ad aree archeologi-che, beni museali, beni monumentali e ambientali, biblioteche e archivi. Cap. 11129 del bilan-cio regionale. Direttive istruttorie e pubblicazione nel BURAS, a norma dell’art. 19 della L.R. 22.8.1990, n. 40. La legge finanziaria regionale n. 7 del 2005 cit. e la relativa Delibera di attuazione n. 61/30 del 2005 cit. hanno sostituito la normativa precedentemente in vigore in materia di contributi agli Enti locali (Legge finanziaria regionale 4/2000 cit. e Delibera Regionale n. 36/6 del 2000 cit.). La nuova legge seguì cronologicamen-te la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2004 che sanciva l’illegittimità dell’articolo 113bis del TUEL e toglieva in questo modo a Regioni ed Enti locali un riferimento generale per le modalità di affidamento a terzi dei servizi privi di rilevan-za economica, toccando quindi una questione che riguardava anche la concessione dei servizi per musei e istituti della cultura. Con la citata legge regionale del 2005 la Regione Sardegna si è adeguata al mutato contesto normativo nazionale. I commi 7 e 8 dell’articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005, infatti, consentono nuovamente il ricorso all’affidamento a terzi della gestione dei beni culturali.
441 DGR n. 36/32 del 23 ottobre 2001, L.R. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archi-vi. Contributi agli Enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, median-
216
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Pertanto il progetto MUSTER si trovava a dover gestire e riallineare situa-zioni assai differenziate: da un lato musei già esistenti e funzionanti, dotati anche di servizi al pubblico e di propri apporti finanziari; dall’altro strutture ancora non esistenti o non aperte al pubblico, che dovevano essere interamente organizzate sul versante della fruizione e dotate di risorse finanziarie. La coe-sistenza all’interno dello stesso progetto di sedi museali funzionanti e di altre strutture di recente apertura è uno dei tratti distintivi dell’esperienza MUSTER.
Il 13 settembre del 2006, a pochi giorni dal termine stabilito per la parteci-pazione al menzionato bando regionale, i diversi Enti coinvolti sottoscrisse-ro la Convenzione che istituì il Sistema museale MUSTER. Come previsto nel progetto, alla firma del documento seguì l’apertura dei cinque nuovi musei442. L’inaugurazione di queste nuove strutture aveva lo scopo di arricchire l’offerta turistico-culturale non solo del Sistema, ma di tutto il Consorzio Turistico443.
Nel triennio 2007-2009 il patrimonio culturale afferente al MUSTER com-prendeva dunque i beni dei diversi Enti aderenti al progetto: il Consorzio Turi-stico, ad esempio, prendeva parte al MUSTER con le strutture di sua proprietà ovvero il Museo del Territorio con gli annessi servizi di seggiovia e centro di ristoro, il Parco Geobotanico e il Parco dei Monumenti Nuragici e Prenuragici.
Il Museo del Territorio a Lunamatrona, che si articola in tre padiglioni dedicati rispettivamente alla fauna, alla botanica e all’antropologia del territorio della Marmilla, fu individuato come centro del Sistema444. Questo museo, grazie alla numerose mostre temporanee organizzate, ai laboratori scientifici di archeolo-gia del DNA per lo studio del genoma umano dei popoli preistorici e all’atelier Giogus antigas comprensivo di una collezione di oltre 200 antichi giocattoli sar-di, si configura come una delle esperienze museali più attive e didatticamente
te convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali, biblioteche e archivi. Programma triennale 2001-2003. Annualità 2001. Cap. 1129 UPB S11031 bilancio regionale; DGR n. 39/52 del 10 dicembre 2002, L.R. 4/2000. Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli Enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni mu-seali, beni monumentali e ambientali. 1° Programma. Annualità 2002. Cap. 11212.00 UPB S11.050 bilancio regionale 2002; DGR n. 44/37 del 30 dicembre 2002, L.R. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli Enti locali per l’affidamento in gestio-ne a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali. 3° programma. Annualità 2002. Cap. 11212.00 UPB S11.050 bilancio regionale 2002.
442 Convenzione cit., Villanovaforru 13 settembre 2006; a. pIntorI, In Marmilla la santa al-leanza dei musei, «L’Unione Sarda», 23 maggio 2006; t. SeBIS, Sei musei per la filiera della cultura, «La Nuova Sardegna», 23 maggio 2006.
443 Convenzione cit., Villanovaforru 13 settembre 2006.444 Ivi.
217
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
vivaci dell’Isola445. Un aspetto molto importante del Museo del territorio è poi la valorizzazione del contesto naturale mediante il cosiddetto Parco Geobotanico, una struttura d’interesse scientifico-didattico e turistico, realizzata allo scopo di salvaguardare le biodiversità della Sardegna446. Infine, nei pressi del Museo del Territorio, si trova la seggiovia che lo collega con l’altipiano della Giara del Siddi, dove ha sede un centro di ristoro e alcuni dei siti compresi del Parco ar-cheologico dei Monumenti nuragici e prenuragici. La nascita del Parco archeologico si deve al Consorzio che ha rilevato i terreni su cui sorgono i monumenti e ha messo questi ultimi in sicurezza rendendoli fruibili alla visita.447 Nel 2001 il Consorzio ha poi fondato la Sa Corona Arrùbia Spa, una società per azioni, cui ha demandato la gestione dei beni448.
Il Comune di Mogoro si inserì nel sistema MUSTER con il Complesso Nura-gico di Cuccurada e il relativo Museo del Carmine, creato al fine di conservare i reperti provenienti dal sito archeologico. Nel triennio 2007-2009 entrambi i beni musealizzati non sono stati totalmente visitabili: l’area archeologica infatti è stata oggetto di alcune campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano, mentre il Museo, allocato in un ex convento di carmelitani, ospita al primo piano uno spazio destinato
445 Tra le mostre organizzate all’interno del Museo del Territorio di Lunamatrona ricor-diamo: I Dinosauri; I Grandi di Spagna. Goya, Dalì, Picasso; Leonardo da Vinci. Genio Curioso; L’uomo egizio. L’antica civiltà faraonica nel racconto dei suoi protagonisti; La doppia elica del DNA; Arte Precolombiana; Gli Etruschi, un’antica civiltà rivelata. La realizzazio-ne del laboratorio del DNA presso il Museo del Territorio è stata possibile grazie ai finanziamenti regionali a valere sulla Misura 2.1 del POR Sardegna 2000-2006. De-terminazione regionale (Sardegna) n. 93 del 5 febbraio 2003; Delibera Consiglio di Amministrazione del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia n. 17 del 27 aprile 2005, POR Sardegna 200/2006-Misura 2.1-Progetto “Itinerari di archeologia nuragica e prenura-gica negli altipiani della Sardegna centro occidentale”-Approvazione proposta presentazione Sezione antropica. Si veda la scheda dedicata al Consorzio Sa Corona Arrùbia in questo volume.
446 Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, Sa Corona Arrùbia e i suoi musei, s.l. 2008, pp. 11-13.
447 Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, cit., p. 15. Convenzione fra il Consorzio Turi-stico Sa Corona Arrùbia e l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogior-no n. 109/90 del 30 maggio 1991, Convenzione per il regolamento del finanziamento per assicurare la realizzazione di itinerari turistici per la valorizzazione delle risorse del territorio consorziale.
448 Deliberazione dell’Assemblea Consortile (Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia) n. 2 del 9 febbraio 2000, Approvazione costituzione società Mista Consorzio Turistico “Sa Corona Arrùbia” e INSAR, per la gestione delle strutture Museo, Seggiovia e Centro Ristoro; Contratto tra Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia e Sa Corona Arrùbia S.p.a per l’af-fidamento a quest’ultima della gestione dei beni di proprietà del Consorzio, stipulato in data 5 novembre 2001.
218
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
alle mostre temporanee e al secondo una sala che in futuro dovrà esporre il ma-teriale proveniente dagli scavi in corso449. Pertanto i beni messi a disposizione dal Comune di Mogoro sono aperti e funzionanti, ma in maniera parziale e con alcune difficoltà450.
Il Comune di Paùli Arbarèi aderì al Sistema con il Museo Etnografico della Donna, struttura che espone una collezione eterogenea di oggetti, come tessuti e ricami, che testimoniano la cultura materiale del territorio legata alle attività tradizionali femminili; la raccolta costituisce anche l’occasione di una narrazio-ne dedicata a donne sarde “speciali”, realmente esistite o protagoniste di miti e leggende, come levatrici, accabadoras (coloro che praticano l’eutanasia), donne condannate al rogo, pittrici e poetesse451.
Il Comune di Lunamatrona ha partecipato al MUSTER con il Museo demo-antropologico DEA-LUNA, dove è esposta una collezione di oggetti e docu-menti d’epoca che testimoniano i cambiamenti sociali avvenuti a partire dagli anni sessanta del Novecento nella Sardegna meridionale che hanno comportato il passaggio dalla tradizionale società basata sull’agro-pastorizia all’industria-lizzazione e al turismo452.
Il Comune di Gonnostramatza prese parte all’esperienza sistemica con il Museo Turcus ‘e Morus, dedicato al tema delle incursioni dei Turchi e dei Mori in Sardegna; l’istituzione di questa struttura museale si collega alla presenza di una lapide, datata 1515 e conservata in una chiesa campestre, nella quale si fa riferimento alla distruzione del centro di Uras «de manu de turcus e morus» capitanati dal Barbarossa. Il Museo raccoglie testimonianze legate alle incursio-ni moresche mediante 35 pannelli informativi, plastici di battaglie e un gruppo di statue iperrealistiche realizzate da artisti del luogo; l’allestimento museale, essenzialmente formato dai pannelli informativi e dalle riproduzioni di armi e oggetti d’epoca, non prevede una collezione di reperti originali risalenti al periodo storico cui è dedicato il Museo453.
Il Comune di Segarìu aderì al Sistema con il Museo delle Argille, luogo dove sono raccolte le testimonianze storiche e antropologiche che documentano l’u-so delle argille dalla Preistoria ai giorni nostri; in questo edificio è ospitato an-che il Centro di documentazione ed esposizione delle tecniche di utilizzazione di argille e impasti nelle culture prenuragiche e nuragiche (CE.D.E.U.A.)454.
449 Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, cit. , p. 21.450 Si fa riferimento alla situazione al momento della ricerca, nel 2009.451 Ivi, p. 29.452 Ivi, p. 25.453 Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, Sa Corona Arrùbia, cit., p. 17.454 Ivi, p. 27.
219
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Il Comune di Collinas invece entrò nel MUSTER con il Museo Civico Giovan Battista Tuveri, nel quale sono esposte le testimonianze e i documenti che riper-corrono le vicende storiche del piccolo centro di Collinas fino alla fine dell’Ot-tocento; al Museo è annesso il Centro Studi e Documentazione Giovan Battista Tuveri455.
I musei inseriti nel MUSTER presentavano temi molto diversi e in questa differenziazione tematica fu ravvisato il punto di forza del Sistema, che offriva ai visitatori un ventaglio variegato di offerte culturali: naturalistica con il Parco Geobotanico e il Museo del Territorio, archeologica con il Parco Archeologico dei Monumenti Nuragici e Prenuragici, il Complesso Nuragico Cuccurada e il Museo del Carmine a Mogoro, etnografica col Museo Etnografico della Donna di Paùli Arbarèi e il D.E.A.-Luna Museo Demoantropologico di Lunamatrona, storica con il Museo Turcus ‘e Morus di Gonnostramatza, il Museo delle Argille di Segarìu e il Museo Giovanni Battista Tuveri di Collinas456.
La maggior parte delle strutture museali descritte, eccezion fatta per il Mu-seo del Territorio, si caratterizza per le dimensioni medio-piccole e proprio tale particolarità ha reso auspicabile l’organizzazione in forma sistemica, al fine di garantire un’offerta turistico-culturale diversificata e un miglioramento dei ser-vizi mediante la condivisione delle risorse economiche e professionali457. Non va dimenticato inoltre che il MUSTER è stato istituito dopo la pubblicazione delle disposizioni in materia di musei espresse dalla Regione nel documen-to strategico Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo del 2005: in tale provvedimento, infatti, la Regione prevedeva un procedimento di accreditamento per quei musei di ente locale che avessero voluto accedere ai finanziamenti regionali458. In altri termini, secondo il Piano, le strutture museali intenzionate a beneficiare delle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione avrebbero dovuto adeguarsi ad almeno alcuni dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001459. Nei propositi regionali l’attivazione
455 Ivi, p. 23. Giovanni Battista Tuveri, nato nel 1815 a Collinas dove morì nel 1887, è il personaggio più illustre del paese: esponente del cattolicesimo federalista, eletto per due volte come deputato nel Parlamento Subalpino, autore di numerose opere di carattere politico, filosofico e giuridico. Nel 1867 si fece promotore della cosiddetta “questione sarda”, promuovendo un riscatto dell’Isola e del popolo sardo contro uno Stato centralista e oppressivo. a. accardo, G. B. Tuveri e i suoi tempi, Cagliari 1989; a. deloGu, Filosofia e società in Sardegna: Giovanni Battista Tuveri (1815-1887), Milano 1992; G. GanGeMI (a cura di), La linea sarda del federalismo, Roma 2002.
456 Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia cit., p. 9.457 Convenzione cit., Villanovaforru 13 settembre 2006.458 “Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo”. Documento d’indirizzo
politico-amministrativo approvato con la DGR n. 36/5 del 26 luglio 2005.459 “Sistema regionale dei musei” cit.; DM 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-
220
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
del procedimento di riconoscimento avrebbe comportato la nascita di realtà sistemiche qualificate nel territorio isolano, dato che i piccoli musei si sarebbero dovuti associare per riuscire a raggiungere i requisiti necessari all’accesso ai contributi regionali. Nel progetto triennale MUSTER presentato alla Regione nel 2006, è espressa la volontà di tutti i partecipanti di aderire al sistema al fine di apportare un miglioramento della gestione e dei servizi nei musei comunali già esistenti, dato che, in qualche caso, tali strutture presentavano serie carenze negli aspetti funzionali e gestionali460.
La nascita del MUSTER, così come quella di altri sistemi museali sardi, si motiva quindi con la volontà, espressa dal 2005, di creare un sistema museale regionale organizzato in sub sistemi a carattere territoriale e tematico461.
Le dimensioni medio-piccole delle strutture afferenti al MUSTER spiega-no anche l’attenzione dimostrata dagli organi di gestione del Sistema all’or-ganizzazione di esposizioni temporanee tese a conferire visibilità al progetto, richiamando in questo modo l’attenzione del pubblico residente e dei turisti sul patrimonio museale locale. Le mostre sono state in genere organizzate nelle sin-gole strutture museali e hanno avuto tematiche diverse: Moleskine; Vetri, Ricami e Tessuti; Angela Tremonti, 25 Aprile; Ceramiche Archeologiche, Madri di Sardegna462; la più grande di queste esposizioni è stata Sulle tracce di Guttuso, allestita nel 2007, l’unica mostra ad aver coinvolto tutte le sedi museali comunali afferenti al MUSTER e che ha dato quindi la possibilità di mettere in campo un’attività promozionale congiunta e reciproca per i musei del Sistema463. In occasione di questa mostra fu avviata una bigliettazione integrata di tipo sperimentale che riguardava unicamente i musei comunali; tale biglietto congiunto è rima-sto attivo fino alla scadenza del progetto, nel 2008, senza peraltro essere mai integrato con quello, di tipologia analoga, esistente per i musei del Consorzio Turistico464.
A partire dal 2001 l’affidamento delle strutture musealizzate di proprietà del Consorzio a un unico soggetto gestore ha permesso anche l’avvio di una forma di bigliettazione congiunta, tuttora (2009) attiva465. La coesistenza all’interno
scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei.460 Progetto triennale cit.461 “Sistema regionale dei musei” cit., 462 Informazione fornita dal dott. Paolo Sirena, Direttore Scientifico del Sistema MU-
STER, tramite comunicazione scritta in data 11 giugno 2009. 463 t. SeBIS, Tutti in fila per Renato Guttuso. È l’arte il nuovo business in Marmilla, «La Nuova
Sardegna», 6 gennaio 2008.464 Informazione fornita dal dott. Paolo Sirena, Direttore Scientifico del Sistema MU-
STER, tramite comunicazione scritta in data 11 giugno 2009. 465 Contratto tra Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia e Sa Corona Arrùbia S.p.a per l’affida-
221
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
del MUSTER di due forme di bigliettazione integrata si motiva con la necessità per i suoi organizzatori di sperimentare un biglietto unico per i musei di nuova apertura pur non perdendo gli introiti garantiti da quello inerente le strutture musealizzate del Consorzio, avviato da tempo con esiti più che soddisfacenti; la visibilità del MUSTER è stata incrementata anche attraverso l’avvio di alcune esperienze di diversa tipologia, come la didattica museale, la presentazioni di libri, l’organizzazione di convegni e di eventi concertistici466.
Nel triennio di attività (2007-2009) il progetto MUSTER ha manifestato alcu-ni elementi di valore che lo hanno reso un’esperienza positiva per il territorio di riferimento con un’offerta turistico-culturale interessante e diversificata, ca-pace di attrarre i visitatori in zone interne della Sardegna, notoriamente meno frequentate dai turisti. L’avvio del MUSTER ha permesso l’apertura di cinque nuove strutture museali, che hanno contribuito ad ampliare la proposta cultu-rale di quest’area, e, grazie all’utilizzo della notorietà del Museo del Territorio di Lunamatrona, si è conferita visibilità a realtà museali piccole ma significative per la conoscenza della Marmilla.
Se però, da una parte, la diversificazione delle tipologie museali apporta-ta dal Sistema ha contribuito a rendere interessante il MUSTER, dall’altra la compresenza all’interno dello stesso Sistema di strutture musealizzate aperte al pubblico in diversi momenti ha influito non sempre positivamente sull’atti-vità gestionale dell’intero progetto, soprattutto per quel che riguarda gli aspetti economici. Infatti, i musei di nuova apertura non potevano godere dei finan-ziamenti pubblici di cui invece beneficiavano le strutture già aperte; questo fattore ha comportato una diversificazione nelle dotazioni finanziarie di cia-scun museo che nei tre anni di esistenza del MUSTER ha avuto ripercussioni sugli sviluppi del progetto sistemico. La stessa coesistenza di due bigliettazioni integrate dimostra come le diverse possibilità economiche a disposizione dei partners non abbiano permesso sul lungo periodo la creazione di una gestione realmente unitaria per l’intero Sistema.
Nel 2007 il Consorzio Turistico, in qualità di capofila, ha affidato la gestione congiunta di tutte le strutture del MUSTER alla società per azioni Sa Corona Arrùbia spa, nata nel 2000 al fine di gestire i beni di proprietà consortile e costi-tuita per il 51% delle azioni dal Consorzio turistico Sa Corona Arrùbia e per il restante 49% dall’INSAR-Iniziative Sardegna spa di Cagliari467. Applicando una
mento a quest’ultima della gestione dei beni di proprietà del Consorzio, stipulato in data 5 novembre 2001.
466 Informazione fornita dal dott. Paolo Sirena, Direttore Scientifico del Sistema MU-STER, tramite comunicazione orale in data 15 giugno 2009.
467 Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia n. 17 del 21 marzo 2007, Affidamento alla Spa Sa Corona Arrùbia della gestione MUSTER
222
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
prassi già adottata in precedenza per i beni di proprietà consortile, la Società per azioni ha poi assegnato la gestione dei servizi per il Sistema MUSTER a diverse altre cooperative468.
Dal 2007 fino alla scadenza del progetto triennale nel 2008, la gestione delle strutture musealizzate afferenti al MUSTER è stata dunque effettuata da alcu-ne cooperative locali: nello specifico, le strutture che risultavano attive prima dell’avvio del Sistema sono rimaste affidate alle stesse cooperative che vi erano già impiegate (il Lichene rosso per il Museo del Territorio e il Centro di Ristoro, La seggiovia per l’omonima struttura, la cooperativa Serzèla per il Museo di Gon-nostramatza), i musei di nuova apertura invece sono stati dati in gestione alla cooperativa La Musa469. Questi soggetti locali hanno garantito, per conto della Spa Sa Corona Arrùbia, l’esercizio di tutti i servizi nelle strutture di rispettiva pertinenza, comprese le visite guidate, gli infopoint, il bookshop, l’attività didat-tica e l’organizzazione delle esposizioni temporanee470. L’affidamento alla Spa non ha dunque coinciso con l’avvio di una gestione realmente unitaria dei beni afferenti al Sistema, piuttosto, con la pratica di delegare a cooperative locali le strutture musealizzate del MUSTER, si è sviluppato il livello occupazionale del territorio di riferimento.
La presenza di diverse cooperative e di strutture con differenti dotazioni economiche ha però contribuito a creare un dislivello nella qualità e nella quan-tità dei servizi offerti dal MUSTER: nonostante infatti esistesse un organo di gestione centrale, il Direttore del Sistema, col compito di coordinare il lavoro degli operatori impiegati nelle strutture inserite nel progetto, la possibilità di disporre di risorse finanziarie e professionali e di spazi differenti ha determi-nato una diversa offerta di servizi per i musei. Di conseguenza le strutture con maggiori fondi, come quelle di proprietà del Consorzio Turistico, hanno potuto garantire un numero più ampio di servizi rispetto ai beni con dotazioni ridotte, ovvero la maggior parte dei musei comunali.
Sa Corona Arrùbia periodo 01.04.2007 al 30.06.2007; Delibera del Consiglio di Ammini-strazione del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia n. 2 del 9 febbraio 2000, Appro-vazione costituzione società mista Società Mista Consorzio Turistico “Sa Corona Arrùbia” e INSAR, per la gestione delle strutture Museo, Seggiovia e Centro Ristoro.
468 Questa eventualità era prevista anche dalla stessa Delibera del 2007 che approvava l’affidamento della gestione del Sistema alla suddetta Spa. Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia n. 17 del 2007, cit.
469 Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia n. 17 del 2007 cit. Informazioni fornite dal dott. Paolo Sirena, Direttore Scientifico del Sistema museale MUSTER, mediante comunicazione orale in data 30 maggio 2009.
470 Informazione fornita dal dott. Paolo Sirena, Direttore Scientifico del Sistema MU-STER, tramite comunicazione orale in data 15 giugno 2009.
223
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Durante il triennio 2007-2009, la gestione dell’intero Sistema è stata affidata agli organi individuati nella Convenzione stipulata il 13 settembre 2006, in par-ticolare il Direttore, il Comitato e l’Ufficio centrale di Coordinamento471.
Nel triennio la figura del Direttore del Sistema ha coinciso con quella del Direttore del Museo del Territorio, cosicché quest’ultimo ha svolto il compito di coordinare tutto il personale impiegato e l’intera gestione delle strutture coin-volte472. Il Comitato di Sistema – composto dai sindaci dei Comuni aderenti, dal Presidente del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia e dal Presidente della Sa Corona Arrùbia Spa − è stato l’organo di controllo generale e di verifica dei ri-sultati delle attività svolte dal Sistema; l’Ufficio Centrale di Coordinamento ha avuto invece funzioni strumentali alla gestione ed è stato preposto alla realizza-zione del Sistema473. La Convenzione firmata nel 2006 prevedeva che fosse isti-tuita un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra le cooperative al tempo impiegate nella gestione dei vari musei coinvolti ma ciò non si è mai verificato.
L’organizzazione del MUSTER, definita nella Convenzione del 2006, preve-deva infine la partecipazione diretta alla gestione del Sistema di tutti i partners afferenti al progetto, in modo da garantire un’assoluta condivisione sia degli intenti che delle iniziative intraprese all’interno del Sistema per migliorarne le funzioni e la visibilità.
Il Sistema ha anche tentato di agire in maniera propositiva e autonoma, com-portandosi come un soggetto unitario. Nel biennio 2007-2008 il Consorzio Tu-ristico ha partecipato come capofila del MUSTER al bando per l’assegnazione delle risorse regionali previste dalla legge regionale n. 14 del 2006, destinate al restauro dei beni culturali di ente locale; l’aver preso parte a questa gara ha per-messo ad alcuni Comuni afferenti al Sistema di beneficiare dei finanziamenti regionali per il recupero di beni culturali locali474.
471 Convenzione cit., Villanovaforru 13 settembre 2006, artt. 5-9.472 Ivi, art. 8.473 Ivi, artt. 6, 7 e 9.474 LR n. 14 del 20 settembre 2006, Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della
cultura; DGR n. 28/23 del 27 luglio 2007, Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 4, lettere f) e art. 21, lett. c). Assegnazione contributi agli Enti Locali per interventi di restauro dei beni culturali. Approvazione direttive; DGR n. 49/25 del 5 dicembre 2007, Interventi di restauro sul patrimonio culturale. Programma relativo alla concessione di contributi ai sensi dell’art. 4 lett. f) e dell’art. 21 lett. c) della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, Bilancio regionale 2007. € 5.000.000; DGR n. 36/37 del 1 luglio 2008, Interventi di restauro sul patrimonio culturale. Programma relativo alla concessione di contributi ai sensi dell’art. 4 lett. f) e dell’art. 21 lett. c) della L.R. 20 settembre 2006, n. 14. Per l’annualità 2007 sono stati approvati i finanziamenti regionali per i progetti presentati dai Comuni di: Col-linas per il restauro degli oggetti appartenenti alla collezione del Museo G.B. Tuveri; Gonnostramatza per il restauro del campanile della Chiesa Parrocchiale di San Mi-
224
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Gli aspetti finanziari sono stati uno dei principali aspetti critici del MUSTER, tanto che ne hanno determinato nel 2008 la conclusione. Il Sistema è nato per permettere ai diversi soggetti partecipanti, e in particolar modo ai Comuni pro-prietari dei musei di nuova apertura o di esigue dimensioni, di intercettare i finanziamenti regionali previsti dalla legge n. 7 del 2005475. La mancata pubbli-cazione della graduatoria relativa al bando del 2006, e dunque i conseguenti ri-tardi nell’assegnazione dei relativi finanziamenti regionali, ha però costretto gli Enti locali proprietari delle nuove strutture a non confermare la convenzione al momento della sua scadenza, nel 2009, perché impossibilitati a continuare a sostenere con i propri fondi gli istituti museali di rispettiva spettanza, come in-vece avevano fatto per tutto il triennio di attività del Sistema. Questa difficoltà è stata determinata dal fatto che i Comuni hanno provveduto ad aprire i musei, secondo gli accordi presi, e sostentarne il funzionamento, in attesa delle entrate regionali. Nel triennio le entrate più consistenti sono state quelle derivanti dalla bigliettazione integrata, ma esse non costituivano un’entrata atta a coprire tali costi di funzionamento476.
Nell’esperienza sistemica attuata dal MUSTER ha avuto un ruolo fondamen-tale l’aspetto finanziario; l’incertezza e la differenza nelle risorse economiche a disposizione dei diversi partners hanno contribuito ad accentuare la discrasia tra le strutture aderenti. Si è verificato un sensibile dislivello qualitativo e quan-titativo fra i servizi offerti dalle strutture museali comunali rispetto a quelli
chele Arcangelo e dei reperti rinvenuti negli scavi del paese scomparso di Serzela, da destinare in un secondo momento alla fruizione pubblica presso il museo locale; Lunamatrona per gli interventi di restauro dei dipinti murari della cupola della Par-rocchiale di San Giovanni Battista; Paùli Arbarèi per il restauro dell’immobile sede del Museo della donna e di sei sculture lignee policrome seicentesche in estofado de oro conservate nella Chiesa Parrocchiale di San Vincenzo Diacono. Quello stesso anno non sono stati finanziati, invece, i progetti presentati nella medesima occasione dai Comuni di Mogoro, Segariu e dal Consorzio stesso. Nel 2008 hanno beneficiato del sostegno economico della Regione gli interventi richiesti dai Comuni di: Collinas per il fonte battesimale settecentesco conservato nella Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo; Gonnostramatza per la Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo e della Chiesa di Sant’Antonio; Lunamatrona per i dipinti murali della navata della Parrocchiale di San Giovanni Battista; Mogoro per il completamento del restauro dell’ex Convento del Carmine, da destinare a usi museali, e per l’area archeologica di Cuccurada. Sempre nel 2008 non hanno ricevuto i contributi gli interventi proposti dal Comune di Paùli Arbarèi e relativi al restauro della Chiesa Parrocchiale e dell’an-nesso campanile.
475 LR n. 7 del 2005 cit.; DGR n. 61/30 del 2005 cit.; Delibera del Consiglio di Ammini-strazione del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia n. 33 del 2006 cit.; Convenzione cit., Villanovaforru 13 settembre 2006.
476 Informazione fornita dal dott. Paolo Sirena, Direttore Scientifico del Sistema MU-STER, tramite comunicazione orale in data 15 giugno 2009.
225
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
garantiti nei beni di proprietà consortile; inoltre tali difficoltà sono state acuite dal mancato intervento regionale. In tal modo il progetto MUSTER è stato in-terrotto; il mancato finanziamento delle attività legate al MUSTER oltre ad aver comportato, con la chiusura dei cinque musei comunali, il ridimensionamento dell’offerta turistico-culturale del territorio della Marmilla, ha provocato anche la perdita del lavoro per il personale della cooperativa.
In conclusione l’esperienza MUSTER testimonia la difficoltà che talvolta gli Enti locali incontrano nel creare aggregazioni sistemiche sul territorio in as-senza di concreti sostegni finanziari di natura pubblica. Forse in questo caso un altro elemento critico è stato quello di aver voluto realizzare un Sistema all’interno di una realtà preesistente più ampia e che perseguiva una finalità analoga: il Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia. Quest’ultimo è stato istituito nel 1982 per elaborare un’offerta competitiva sul mercato turistico e attrarre in questo modo nell’entroterra della Marmilla i flussi di turisti presenti nelle località balneari della zona477. MUSTER si è configurato dunque come un inter-vento attuato dallo stesso Consorzio nel tentativo di riuscire a raggiungere il suo obiettivo prioritario, ovvero lo sviluppo turistico se non di tutto il territorio consortile almeno di quella parte coinvolta nel Sistema. La compresenza di due realtà analoghe però (MUSTER e Consorzio) e la mancata realizzazione di una gestione realmente congiunta, ad esempio la presenza di due biglietti integrati, ha probabilmente contribuito a non far decollare il progetto come previsto.
477 Decreto del Presidente della Giunta Regionale (Sardegna) n. 98 del 24 dicembre 1982, Costituzione Consorzio Turistico tra i Comuni di Collinas, Lunamatrona, Siddi e Villanova-forru.
226
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
10 Gli Itinerari del Territorio Museo [Borgioli]
Il Comune di Alghero ha avviato una politica mirata a una gestione di tipo sistemico del proprio patrimonio culturale attraverso il progetto Itinerari del Territorio Museo, che consiste nell’affidamento di una serie di itinerari tema-tici a un soggetto unico, l’Associazione Temporanea d’Imprese denominata SMUOVI. Di pari passo la disponibilità dei percorsi di visita è resa più compat-ta dall’attivazione di una bigliettazione congiunta che permette al fruitore più opzioni di visita478. Le due leve per la configurazione sistemica dell’insieme dei beni culturali sono quindi gli Itinerari e la bigliettazione integrata.
Itinerari del Territorio Museo è una serie di percorsi nel centro storico di Al-ghero che include anche le strutture musealizzate cittadine e i siti archeologici presenti nel territorio; l’Amministrazione comunale ha voluto così creare una sorta di “museo diffuso”, percorribile attraverso circuiti di visita suddivisi per tematiche che approfondiscono alcuni aspetti della storia algherese. Questa ini-ziativa è l’evoluzione diretta di un altro, precedente progetto, elaborato a parti-re dal 2003 e finalizzato alla realizzazione di un Sistema Museale Integrato ossia la messa in rete di tutto il patrimonio cittadino e l’apertura di nuove strutture museali479.
¬ Terra e Territorio Museo
Il Comune manifestò interesse alla creazione di un sistema museale cittadi-no già nella seconda metà degli anni Novanta, quando partecipò a un program-ma europeo di cooperazione denominato Terra480. Nell’aprile del 1996, infatti, la Comunità europea indisse un concorso per la realizzazione di consorzi tra Enti regionali o locali che avrebbero dovuto occuparsi dell’elaborazione e della rea-lizzazione di progetti pilota in «materia di assetto del territorio»481. L’obiettivo
478 Su questa esperienza si veda anche S. MaSIa, Gli Itinerari del Territorio Museo in c. Bor-GIolI, d. la MonIca (a cura di), Sistemi museali e musei in Sardegna. Politiche ed esperien-ze. Atti del convegno (Sassari 2010), Felici Editore, Pisa 2012, pp. 129-136. Convenzione tra il Comune di Alghero e la Associazione Temporanea d’Impresa formata dalle società Itine-ra, Mosaico e SILT per la gestione triennale dei servizi di accompagnamento e informazione turistico culturale progetto: Itinerari del Territorio Museo, Alghero 22 gennaio 2007.
479 Comune di Alghero, Dal Territorio Museo al Sistema Museale Integrato: il patrimonio cul-turale nelle strategie di pianificazione del territorio di Alghero, a cura di S. Masia dirigente del Comune di Alghero, 4 febbraio 2005.
480 DCG di Alghero n. 83 del 18 febbraio 1998, Progetto Europeo “Terra Incognita: un proget-to pilota di inserimento del patrimonio nelle strategie di assetto del Territorio”. Approvazione e ratifica del protocollo d’intesa di costituzione della rete europea.
481 Programma Terra, Invito a presentare le proposte, Gazzetta Ufficiale delle comunità Euro-
227
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
del programma comunitario era quello di creare reti di cooperazione tra enti di diversi Paesi dell’Unione Europea, accomunati da omogenee caratteristiche geografiche e morfologiche, al fine di attuare azioni di sviluppo sostenibile482.
Il Comune di Alghero prese parte al programma Terra proponendo, in qua-lità di responsabile, il progetto denominato Terra Incognita: un progetto pilota di inserimento del patrimonio nelle strategie di assetto del territorio; quest’ultimo venne presentato dall’Amministrazione algherese insieme ad altri quattro part-ners spagnoli: tutti gli enti erano accomunati dall’appartenenza all’ambito d’in-fluenza storico-culturale della Corona d’Aragona483. Il progetto risultò vincitore e conseguì il finanziamento comunitario per il triennio 1997-1999, cosicché i cinque Enti ufficializzarono la loro partecipazione al progetto nel novembre 1997 con la firma di un protocollo che fu poi ratificato dal Comune di Alghero il 18 febbraio 1998484.
Il progetto Terra Incognita prevedeva che tutti gli aderenti attuassero una strategia di sviluppo locale fondata sulla promozione del patrimonio culturale, inteso come attrattore per implementare il turismo. Tra le azioni previste da Terra Incognita vi era anche la creazione di un marchio o logo unico per tut-te le città aderenti, riconosciuto e inserito nel registro comunitario nel 2001.485 In particolare, il Comune di Alghero partecipò a Terra Incognita con l’obiettivo di valorizzare il centro storico, anche attraverso l’apertura di nuovi musei e centri culturali, così da riuscire a prolungare la stagione turistica oltre i mesi estivi. A tale scopo l’Amministrazione locale destinò i fondi comunitari alla realizzazione di una sorta di “museo diffuso”, denominato Territorio Museo, che coinvolgeva tutte le presenze culturali in loco: sia quelle già esistenti, come i siti archeologici, sia quelle di nuova apertura, come il Museo di Arte Sacra e i due Centri di accoglienza e interpretazione486.
Al momento dell’avvio del progetto Terra Incognita, nel 1997, il patrimonio culturale di cui disponeva il Comune di Alghero era costituito esclusivamente
pee, C119 del 24/4/1996, pp. 9-11.482 Ivi.483 Mancomunidad de las altas Cinco Villas (Aragona), Mancomunidad del Somontano
(Aragona), Consell Comarcal del Garraf (Catalogna), Comune di Peralada (Catalo-gna). Su questa esperienza si veda S. MaSIa, M. MIrò alaIx, Terra incognita. La gestione creativa del patrimonio culturale, Alghero 2002.
484 DGC di Alghero n. 83 del 1998 cit.485 Certificado de Registro, Registro Ajuntament de Peralda 22 marzo 2001, Alghero 27
marzo 2001.486 Formez, Sviluppo locale. Archivio delle Esperienze, Scheda “Terra Incognita” consultabile
all’indirizzo <http://db.formez.it>, <http://ec.europa.eu/regional_policy/innova-tion/innovating/terra/projects/incognita.html>.
228
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
dalle aree archeologiche in gestione per conto della Soprintendenza. Già dal 1995, infatti, il Comune aveva firmato una convenzione con la Soprintendenza Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro per regolamentare la gestio-ne dei siti archeologici insistenti sul territorio comunale: la Necropoli di Anghe-lu Ruju, i villaggi nuragici di Palmavera e di Sant’Imbenia. L’accordo, resosi necessario perché i suddetti siti da tempo incustoditi erano spesso oggetto di atti vandalici, prevedeva sostanzialmente che il Comune si facesse carico della gestione delle aree archeologiche demaniali, site nel territorio di spettanza, al fine di provvedere alla loro guardiania e manutenzione ordinaria, ai servizi di accoglienza, accompagnamento e informazione turistico-culturale487. A seguito quindi di questa convenzione, il Comune ha assunto dal 1995 la gestione del-le aree archeologiche presenti nel territorio algherese, provvedendo successi-vamente ad affidarle a cooperative locali tramite l’indizione di apposite gare d’appalto488.
Dalla metà degli anni Novanta, le azioni dell’Amministrazione algherese si sono pure rivolte all’implementazione del patrimonio culturale cittadino. Il primo risultato raggiunto in tal senso è stata la firma, nell’ottobre del 1999, della convenzione con la Diocesi di Alghero-Bosa che ha permesso l’inserimen-to del Museo Diocesano di Arte Sacra nel progetto Terra Incognita. Nell’accordo venivano definiti gli obblighi di ognuna delle due parti: il Comune si doveva occupare dell’inserimento del Museo all’interno dell’itinerario denominato La via Sacra, della contribuzione alle spese per l’allestimento museale, della re-alizzazione di uno spazio multimediale all’interno dell’istituto; la Diocesi, a sua volta, si impegnava a garantire per tutta la durata della convenzione, os-sia per un periodo di nove anni, la fruibilità del Museo, la sua gestione e le relative spese, l’adeguamento strutturale dell’edificio e la sua collaborazione
487 DGC di Alghero n. 1013 del 19 luglio 1995, Convenzione provvisoria per i servizi di manutenzione ordinaria di accompagnamento ed informazione turistico culturale delle aree archeologiche del territorio comunale; Regolamento per la gestione delle aree archeologiche approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Alghero n. 39 del 25 giugno 1996.
488 DCG di Alghero n. 64 del 26 marzo 2001, Appalto per la gestione dei servizi di accompa-gnamento, informazione turistico-culturale, salvaguardia, tutela e manutenzione ordinaria delle aree archeologiche nel territorio comunale di Alghero. Approvazione capitolato. Proroga temporanea appalto in corso. Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Econo-mico del Comune di Alghero n. 242 del 22 novembre 2001, Appalto per l’affidamento della gestione dei servizi di accompagnamento, informazione turistico-culturale, salvaguar-dia, tutela e manutenzione ordinaria delle aree archeologiche. Aggiudicazione alla Associazio-ne Temporanea d’Imprese costituita tra la Coop. SILT e la Coop. Itinera di Alghero. Contratto di appalto per l’affidamento servizi di accompagnamento, informazione turistico-culturale, salvaguardia, tutela e manutenzione ordinaria delle aree archeologiche, Rep. 464 del 19 giu-gno 2002.
229
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
alla realizzazione dell’itinerario tematico489. Nel 2000, inoltre, nella medesima prospettiva di allargamento e costituzione di rapporti stabili con altri sogget-ti pubblici, il Comune ha deliberato, ancora nell’ambito del progetto Territorio Museo, un partenariato con l’Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT) allo scopo di dare avvio ad attività volte alla formazione e all’aggiornamento dell’imprenditoria agricola locale, nell’ottica dello sviluppo di azioni di marketing territoriale da applicare alle produzioni tipiche del ter-ritorio algherese490.
Il Comune di Alghero grazie ai contributi della Comunità europea, nell’e-state del 2000, una volta terminati i necessari lavori di ristrutturazione dell’edi-ficio, inaugurò il Museo Diocesano di Arte Sacra, con sede nell’antica chiesa del Rosario491. Nell’aprile 2001 riuscì a realizzare due nuove strutture: il Centro di Accoglienza presso la Torre di Porta Terra e il Centro di interpretazione ubicato nella Torre di San Giovanni. Queste due strutture avevano il compito di accogliere il visitatore e fornirgli tutte le informazioni necessarie alla visita della città492. A queste tre strutture musealizzate si aggiungevano altrettanti itinerari tematici, organizzati all’interno del centro storico, che offrivano al visitatore la possibili-tà di approfondire alcuni aspetti della storia cittadina attraverso la conoscenza dell’architettura civile (La via Catalana), religiosa (La via Sacra) e militare (La via delle Torri). Si registra quindi, effettivamente, un allargamento del patrimonio disponibile, in coerenza con le intenzioni dichiarate nel progetto.
Una volta ricevuti i finanziamenti comunitari, il Comune si è attivato nella ricerca del soggetto al quale affidare la gestione delle strutture musealizzate af-ferenti al Territorio Museo. Nel febbraio del 2000, l’Amministrazione locale ban-dì un «concorso di idee», in collaborazione con la Società per l’Imprenditorialità Giovanile spa, finalizzato all’individuazione di imprese giovanili capaci di ela-borare e attuare progetti di gestione per i musei, i centri culturali e gli itinerari tematici realizzati grazie al programma europeo Terra493.
489 Accordo di collaborazione tra il Comune di Alghero e la Diocesi di Alghero-Bosa per lo svilup-po del progetto europeo Terra Incognita, Alghero 5 ottobre 1999.
490 DGC di Alghero n. 134 del 8 giugno 2000, Progetto Europeo Terra Incognita. Approvazio-ne atto di partenariato con l’ERSAT.
491 c. FIorI, Ecco i tesori della Chiesa, «L’Unione Sarda», 3 luglio 2000.492 c. FIorI, Turismo culturale, rivoluzione d’aprile, «L’Unione Sarda», 1 marzo 2001; Id., I
nuovi baluardi del turismo, «L’Unione Sarda», 8 aprile 2001.493 DGC di Alghero n. 11 del 18 febbraio 2000, Concorso di idee per la gestione del territorio
museo: siti, circuiti museali ed itinerari. Approvazione schema di convenzione con la I.G. La Società per l’Imprenditorialità Giovanile, controllata dal Ministero del Tesoro, è stata istituita nel 1999 allo scopo di sviluppare e sostenere le imprese giovanili. DGC di Alghero n. 99 del 4 maggio 2000, Concorso di idee per la gestione del territorio museo: siti, circuiti museali ed itinerari. Approvazione del capitolato d’oneri, dell’avviso di gara, dell’av-
230
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Nel 2001 il Comune affidò la gestione di questi beni a soggetti privati: i due citati Centri e gli itinerari tematici furono assegnati alla cooperativa locale Iti-nera mentre le aree archeologiche furono date in concessione, tramite apposita gara d’appalto, all’Associazione Temporanea di Imprese formata dalle coope-rative Silt, come capogruppo, e da Itinera494. La cooperativa Silt era nota nel ter-ritorio perché impegnata nella gestione dell’area archeologica di Palmavera già prima della firma della menzionata convenzione del 1995 fra Comune e Soprin-tendenza495. Inoltre la gestione del Museo diocesano fu assegnata nel 2000 dalla Diocesi alla cooperativa Mosaico mediante la firma di un’apposita convenzione con procedura ad affidamento diretto496. I beni controllati dal Comune furono così gestiti da tre soggetti diversi: Itinera, Silt e Mosaico.
¬ PIT e POR
Una volta avviato il Territorio Museo, il Comune di Alghero ha costantemen-te cercato, nel corso dell’ultimo decennio, di intercettare diversi finanziamenti pubblici allo scopo di riuscire a completare le azioni iniziate grazie ai contributi europei, così da continuare nelle attività di recupero del centro storico e im-plementazione del patrimonio culturale. L’obiettivo principale dell’Ammini-strazione algherese è stato istituire un Sistema Museale Integrato per l’avvio di una concreta gestione congiunta dei beni cittadini, anche allo scopo di rendere la valorizzazione del patrimonio locale una valida occasione per lo sviluppo socio-economico della comunità.
Nel 2001, ad esempio, l’Amministrazione comunale ha partecipato come ca-pofila al Progetto Integrato Territoriale (PIT) denominato SS2-Dalla Costa del Corallo al Logudoro Mejlogu che vide coinvolti 18 Comuni dell’area costiera e dell’entroterra del Logudoro-Mejlogu, la V Comunità Montana e l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte. Il progetto, che nella fase di “ottimizzazione” pre-vedeva 46 operazioni, mirava allo sviluppo turistico dell’intera area facendo leva sul già avviato turismo balneare per promuovere anche le zone più interne caratterizzate da un ricco patrimonio culturale e dalla presenza di produzioni
viso per estratto. 494 DGC di Alghero n. 64 del 2001 cit.; Determina comunale di Alghero n. 242 del 2001
cit.495 DGC n. 1013 del 1995 cit.496 DGC di Alghero n. 270 del 30 novembre 2001, Delibera del Comune di Alghero- Gestio-
ne del Territorio Museo. Siti, circuiti museali, itinerari. Approvazione schema contratto e rinegoziazione; Convenzione tra la Diocesi di Alghero-Bosa e la “Mosaico” Piccola Società Cooperativa A.R.L., 29 giugno 2000.
231
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
agroalimentari tipiche. Nella città di Alghero le azioni del PIT, avviate concre-tamente a partire dal 2003, hanno permesso il restauro delle antiche mura e dei bastioni, quello dell’ex carcere di San Michele destinato successivamente a sede del Museo della Città (museo civico) e il completamento dell’allestimento del Museo del Corallo497. Parte delle strutture recuperate grazie a questi finan-ziamenti sono state destinate a essere inserite all’interno del Sistema Museale Integrato, una volta che le attività di quest’ultimo verranno avviate498.
Successivamente, nel 2002, il Comune fu ammesso anche ai finanziamenti a valere sulle Misure 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di cen-tri storici abbandonati a fini culturali e turistici e 4.5 Potenziamento e qualificazio-ne dell’industria turistica in Sardegna del POR Sardegna 2000-2006, presentando, nell’ambito dell’intervento denominato Città Regie, un progetto che prevedeva il restauro delle Torri di Sulis e di San Giacomo e del Palazzo Serra499. Il progetto Città Regie stabiliva contributi finalizzati al recupero di edifici storici e alla crea-zione di servizi per il turismo nelle città di Alghero, Bosa, Castelsardo, Cagliari, Oristano e Sassari500.
¬ Itinerari del Territorio Museo
Nel 2003 l’Amministrazione comunale elaborò anche tre progetti per il servi-zio civile nazionale che riguardavano la valorizzazione del patrimonio cultura-le locale; a partire da quel momento il Comune ha creato annualmente progetti simili, permettendo in questo modo l’impiego di volontari del servizio civile nelle strutture culturali cittadine realizzate grazie al progetto Territorio Museo501. Ancora nel 2003 il Comune ha ricevuto i finanziamenti regionali a valere sulla
497 Pagina dedicata ai fondi strutturali consultabile nel sito web del Comune di Alghero, all’indirizzo <http://comune.alghero.ss.it>.
498 Comune di Alghero, Dal Territorio Museo al Sistema Museale Integrato, cit.499 Determinazione del Direttore del Servizio beni Culturali della Regione Autonoma
della Sardegna n. 1801 del 15 luglio 2002.500 Le informazioni sul progetto Città Regie e sul POR Sardegna 2000-2006 sono desun-
te dal sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo <http://www.regionesardegna.it>.
501 DGC di Alghero n. 82 del 26 marzo 2003, Circolare Ministeriale 29 novembre 2002 n° 31550/III/2.16. Progetti di Servizio Civile Nazionale. Approvazione n. 4 progetti per assun-zione volontari per servizio civile nazionale. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prot. N. 53890/I.9 del 4 novembre 2003; Determinazione del Direttore Generale dell’Uffi-cio Nazionale per il Servizio Civile del 3 ottobre 2003; Circolare della Presidenza Re-gionale n.11564 del 9 giugno 2008, Progetti di servizio civile nazionale-Legge 64/2001-pre-sentati nel periodo 1-31 ottobre 2007 ai sensi del D.M. 3 agosto 2006.
232
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
legge regionale n. 4 del 2000 per il progetto degli Itinerari del Territorio Museo; tali contributi, stando all’articolo 38 della norma, dovevano essere destinati a coprire i costi del personale direttamente impiegato nella gestione degli itine-rari cittadini502.
Quando, nel 2004, il Comune bandì la gara per l’affidamento della gestione degli Itinerari del Territorio Museo, i percorsi cittadini presentati per l’occasione erano aumentati di numero rispetto a quelli elaborati nel 2001: La via catalana, La via delle Torri (coincidenti con i precedenti omonimi percorsi), Tra arte e storia (centro storico e musei), Tramonto dai tetti (percorso panoramico dal campani-le della cattedrale ad altre torri), Circuito generale di visita della città, Itinerario nel Parco archeologico (necropoli e fortezze nuragiche), Itinerario didattico (visi-ta didattica a tutte le strutture del progetto Territorio Museo)503. Poiché la gara pubblica del 2004 andò deserta, l’Amministrazione algherese decise di affidare il progetto mediante trattativa privata. In quell’occasione, in accordo col Comu-ne, le tre cooperative già impegnate nella gestione dei beni culturali afferenti al progetto Territorio Museo – Itinera, Mosaico e Silt – costituirono un’associazione temporanea di impresa, denominata SMUOVI, si è occupata dal 2007, ovvero dalla firma della relativa convenzione, degli Itinerari del Territorio Museo504.
Grazie alla sua capacità di intercettare varie forme di finanziamento pubbli-co, il Comune di Alghero si ritrovò a gestire, alla metà degli anni Duemila, un patrimonio culturale più corposo rispetto a quello esistente alla fine del decen-nio precedente; in quegli anni infatti erano stati avviati i lavori nelle strutture recuperate grazie ai citati finanziamenti a valere sul POR Sardegna 2000-2006, sul PIT denominato SS2-Dalla Costa del Corallo al Logudoro Mejlogu e sulla legge regionale n. 4 del 2000505.
502 LR n. 4 del 20 aprile 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000). DGR n. 24/36 del 29 luglio 2003, L.R. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologhe, beni museali, beni monumentali e ambientali. 2° programma. Annualità 2003. Cap. 11212.00 UPB S11.050 bilancio regionale 2003.
503 Determinazione comunale di Alghero n. 702 del 15 dicembre 2004, Legge Regionale 4/2000 “Itinerari del Territorio Museo”; prenotazione di spesa; indizione di gara.
504 Determinazione comunale di Alghero n. 265 del 29 maggio 2006, Legge regionale 4/2000. Itinerari 2000 “Itinerari del Territorio Museo”; prenotazione di spesa; indizione di gara del Territorio Museo. Approvazione del progetto esecutivo e dello schema di convenzione per affidamento gestione all’ATI costituita dalle cooperative Itinera, Mosaico e SILT. Conven-zione cit., Alghero 2007 cit.
505 LR n. 4 del 2000 cit. DGR n. 36/6 del 2000 cit. e n. 24/36 del 2003 cit. Pagina dedicata ai fondi strutturali consultabile nel sito web del Comune di Alghero, all’indirizzo <http://comune.alghero.ss.it>.
233
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
L’opportunità di disporre delle suddette risorse economiche e, di conse-guenza, la possibilità di recuperare il centro storico e alcuni importanti edifici della città hanno orientato l’Amministrazione comunale verso la creazione di una forma sistemica all’interno della quale organizzare il patrimonio: il men-zionato Sistema Museale Integrato, un progetto di messa in rete per i beni cultu-rali cittadini che si sviluppa dalla precedente esperienza del Territorio Museo. Alla fine del 2004, il progetto elaborato dal Comune di Alghero e denominato Dal “Territorio Museo” al “Sistema museale integrato”: il patrimonio culturale nelle strategie di Pianificazione del territorio di Alghero fu incluso tra i Progetti esemplari del Rapporto annuale di Esecuzione del POR Sardegna 2000-2006506.
¬ Sistema Museale Integrato
Nel 2005 il Comune elaborò il progetto formale relativo alla realizzazione del Sistema Museale Integrato di Alghero, che si configurava in sostanza come l’ampliamento di quanto precedentemente realizzato nell’ambito del progetto Territorio Museo. Il nuovo Sistema museale doveva comprendere tutti i beni e gli itinerari già contemplati nel Territorio Museo e le strutture recuperate grazie ai POR e PIT (Palazzo Serra, Torre Sulis, Torre San Giacomo, Museo Civico Archeolo-gico, Museo della città, Museo del corallo)507.
Il progetto vinse nel 2005 il Premio Cultura di Gestione di Federculture e ciò permise di avviare una collaborazione tra il Comune e l’associazione finalizzata all’individuazione della forma gestionale migliore da attribuire al costituendo sistema museale508. In particolare l’Amministrazione locale affidò a Federcultu-re l’elaborazione di uno studio di fattibilità relativo al progetto Alghero Sistema Cultura-Progetto d’Integrazione dell’offerta culturale del Comune di Alghero; lo studio effettuato suggeriva non solo l’affidamento della gestione del patrimonio cul-turale algherese a un unico soggetto, ma configurava anche i possibili aspetti giuridico-amministrativi, gestionali ed economici del futuro sistema museale509.
506 POR Sardegna 2000-2006, Rapporto Annuale di Esecuzione al 31 dicembre 2004.507 Comune di Alghero, Dal Territorio Museo al Sistema Museale Integrato, cit.508 Il progetto vinse il premio con la seguente motivazione: «il progetto ha il merito di ave-
re inserito il patrimonio culturale al centro delle strategie di sviluppo socio-economico del territorio. La fruizione dei beni culturali in un’ottica di integrazione e complemen-tarietà risponde all’esigenza di rafforzare il prodotto turistico locale rendendo la città un unico polo espositivo. L’obiettivo è stato quello di attuare un programma orientato non solo alla conservazione del proprio patrimonio culturale ma anche di sviluppare attività culturali ed istituzionali attraverso un piano di interventi multisettoriale». Si veda il sito ufficiale Federculture, all’indirizzo <http://www.federculture.it>.
509 Informazione fornita dal dott. P. Alfonso funzionario Settore Cultura del Comune di
234
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
Anche in ragione di questa indicazione, nel 2007 il Comune ha provveduto ad assegnare, mediante trattativa privata, la gestione degli itinerari tematici cit-tadini all’Associazione Temporanea d’Imprese SMUOVI. L’affidamento ad un unico soggetto gestore ha avuto come prima e principale benefica conseguenza l’attivazione di una bigliettazione integrata510.
Le attività svolte dalla SMUOVI nella gestione degli Itinerari rappresentano l’unica forma ‘parasistemica’ attualmente (2009) attiva nella città di Alghero, mentre i musei coinvolti nel progetto di sistema museale integrato non sono an-cora aperti al pubblico. Di conseguenza il Sistema Museale Integrato non risulta ancora effettivamente avviato.
Al momento della nostra indagine il progetto Itinerari del Territorio Museo si articola in otto percorsi di visita alla città che coinvolgono anche alcune strut-ture musealizzate cittadine511.
Ai fini della promozione turistica, ovvero allo scopo di dare al visitatore l’immagine di un “museo a cielo aperto”, gli otto percorsi sono stati uniti in tre gruppi tematici denominati Sale: la Sala del centro storico è dedicata alla storia di Alghero; la Sala dell’arte sacra è invece rivolta ad approfondire le testimonianze del culto cattolico attraverso la collezione del Museo di Arte Sacra e la visita alle chiese cittadine; la Sala del Parco Archeologico è incentrata sulla storia delle antiche popolazioni sarde che viene narrata grazie alla visita alle aree arche-ologiche nuragiche, prenuragiche e fenicie (Villaggio Palmavera, Necropoli di Anghelu Ruju, Villaggio di Sant’Imbenia).
L’affidamento della gestione degli Itinerari a un unico soggetto apposita-mente costituitosi ha permesso l’attivazione di un biglietto congiunto che offre la possibilità al visitatore di scegliere fra una serie di opzioni: la visita a uno o più itinerari, l’ingresso a una struttura musealizzata o l’acquisto di una card che
Alghero con comunicazione scritta in data 25 novembre 2009.510 Convenzione cit., Alghero 2007 cit.511 La Via Catalana comprende i palazzi e i monumenti più rappresentativi del centro
storico: La via delle torri si sviluppa lungo il perimetro dell’antica cinta muraria; Tra arte e storia include la visita al centro storico, al Museo Diocesano di Arte Sacra, al Centro di accoglienza e di informazione turistica e al Centro d’interpretazione della città siti nella Torre di Porta Terra; Tramonto dai tetti consiste in un percorso panoramico sulle ter-razze delle torri e dal campanile della Cattedrale. Inoltre il Circuito generale di visita alla città è l’itinerario completo al centro storico con accesso alle strutture museali e ai monumenti, l’Itinerario archeologico naturalistico consiste nella visita ai siti archeo-logici inseriti nel progetto Territorio Museo; a questi si aggiungono infine l’Itinerario didattico ovvero un percorso di visita pensato per le scuole ai monumenti, musei, torri, campanile e siti archeologici del progetto Territorio Museo e l’Itinerario generale che comprende i monumenti e i musei del centro storico e le aree archeologiche del progetto Territorio Museo. Cfr. Determinazione comunale di Alghero n. 702/2004 cit.
235
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
comprende l’accesso a 2 o a 4 strutture e la scelta tra la visita con guida o con audio guida512. Oltre a garantire i servizi di accoglienza e accompagnamento guidato, la SMUOVI, stando alla convenzione firmata nel 2007 con il Comune di Alghero, deve occuparsi anche del servizio di promozione e accoglienza in occasione delle inaugurazioni di eventi espositivi organizzati dall’Amministra-zione locale513. Il personale della ATI SMUOVI, direttamente impiegato nei ser-vizi culturali relativi al progetto degli Itinerari del Territorio Museo, è finanziato con le risorse economiche messe a disposizione dall’articolo 38 della legge re-gionale n. 4 del 2000 e relativa delibera di attuazione514.
La gestione da parte di un unico soggetto si limita però ai soli Itinerari men-tre le singole strutture museali e i siti archeologici afferenti al Territorio Museo sono gestiti da soggetti diversi. La cooperativa Itinera si occupa del Centro di accoglienza e di informazione turistica e del Centro d’interpretazione del Territo-rio Museo-Museo Multimediale515. Itinera si occupa anche della manutenzione, dell’accompagnamento guidato, dei servizi di pulizia, segreteria, biglietteria e bookshop attivati all’interno dei due Centri di accoglienza e interpretazione516. La cooperativa SILT si occupa delle aree archeologiche presenti nel territorio comunale ovvero il complesso nuragico di Palmavera, un villaggio nuragico edificato in varie fasi a partire dal XV secolo a.C., la Necropoli di Anghelu Ruju, risalente al Neolitico finale e il villaggio di Sant’Imbenia, un complesso costitu-ito da un nuraghe riconducibile al periodo del Bronzo Medio e da un villaggio di capanne, datato all’Età del Ferro517. Per regolarizzare la gestione delle sud-
512 Convenzione cit., Alghero 2007 cit.513 Ivi, art. 2.514 LR n. 4 del 2000 cit.; DGR n. 36/6 del 2000 cit. e n. 24/36 del 2003 cit.515 Il Centro di accoglienza e informazione del Territorio Museo ha lo scopo di introdurre il
visitatore nel patrimonio culturale, storico e naturale della città e del suo territorio, mediante postazioni multimediali; è da questo Centro, sito nella Torre di Porta Terra, che partono i percorsi tematici degli Itinerari Territorio Museo, gestiti dalla ATI SMUO-VI. Il Centro d’interpretazione del Territorio Museo-Museo Multimediale è invece il luogo in cui il visitatore può chiedere informazioni approfondite e ottenere indicazioni ne-cessarie a sviluppare ricerche personali, acquisendo in questo modo la possibilità di compiere un itinerario della città secondo gli ambiti cronologici e tematici di maggior interesse. I due Centri in origine (primi anni del 2000) si trovavano in due diverse costruzioni: il primo a Torre di Porta Terra e il secondo a Torre di San Giovanni; dato il carattere complementare di questi due Centri però, è stato deciso di riunirli in uno stesso luogo, e precisamente nei due piani in cui si suddivide la Torre di Porta Terra, entrata principale dell’antica città-fortezza.
516 Capitolato speciale d’oneri approvato con DGC di Alghero n. 99 del 2000 cit.; Contratto cit. Rep. 464 del 2002 cit.
517 Attualmente (2009) i siti visitabili sono quelli di Palamavera e Anghelu Ruju, mentre
236
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
dette aree archeologiche l’Amministrazione comunale aveva firmato nel 1995 un’apposita convenzione con la Soprintendenza competente518. In realtà le aree archeologiche sono ufficialmente affidate dal 2001 a un’Associazione Tempo-ranea d’Imprese appositamente costituitasi fra le cooperative Itinera e SILT; ma nello stesso atto istitutivo della ATI la cooperativa Itinera ha dato pieno mandato alla Silt affinché quest’ultima possa compiere tutte le attività previ-ste dal contratto ovvero la gestione dei servizi di accompagnamento guidato, manutenzione e salvaguardia519. Un caso diverso è invece quello del Museo di Arte Sacra, ubicato nell’ex chiesa del Rosario, che conserva il tesoro liturgico della Cattedrale e delle altre chiese cittadine. L’accordo stipulato nel 1999 dalla Diocesi di Alghero-Bosa, proprietaria della struttura museale, e dal Comune di Alghero stabilisce che sia la prima ad occuparsi direttamente della gestione del Museo; a tal scopo la stessa Diocesi ha firmato nel 2000 una convenzione con la cooperativa Mosaico affidando a quest’ultima il Museo520. Il documento del 2000 prevede nello specifico che al soggetto gestore competano vigilanza, custodia, pulizia e manutenzione della struttura; la Mosaico deve inoltre garantire i servi-zi aggiuntivi e le spese per il personale e per la gestione del Museo521.
Le singole strutture afferenti al Territorio Museo non godono di nessuna for-ma di finanziamento pubblico, eccetto quella comunitaria risalente al triennio 1997-1999 che ha dato avvio al progetto.522. I rispettivi contratti di gestione fir-mati con il Comune stabiliscono che le due cooperative Itinera e SILT debbano
l’area di Sant’Imbenia − nei cui pressi sono sorti una struttura alberghiera e un cam-ping − è visitabile solo su appuntamento con la Soprintendenza. Campeggi di Porto Conte, associazioni ambientaliste contro la Regione, «La Nuova Sardegna», 26 ottobre 2006.
518 DGC di Alghero n. 1013 del 1995 cit.; Regolamento per la gestione delle aree archeologiche approvato con DGC di Alghero n. 39 del 1996 cit. Poiché questi beni musealizzati, anche a seguito della suddetta convenzione, sono di spettanza comunale, l’Ente loca-le ha provveduto ad assegnare la loro gestione alle due citate cooperative mediante indizione di apposita gara d’appalto. DGC di Alghero n. 99 del 2000 cit., n. 64 del 2001 cit. Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Alghero n. 242 del 2001 cit.; Contratto cit. Rep. 455 del 2002 cit. e Contratto cit. Rep. 464 del 2002 cit.
519 Capitolato speciale d’appalto approvato con DGC di Alghero n. 64 del 2001 cit.; Deter-mina Comunale del Comune di Alghero n. 242 del 2001 cit.; Contratto Rep. n. 455 del 2002 cit.
520 Accordo di collaborazione cit., Alghero 1999 cit.; Convenzione tra la Diocesi di Alghero-Bosa e la “Mosaico” 2000 cit.
521 Convenzione tra la Diocesi di Alghero-Bosa e la “Mosaico” 2000 cit.522 Programma Terra, Invito a presentare le proposte, Gazzetta Ufficiale delle comunità Euro-
pee, C119 del 24/4/1996, pp. 9-11. DGC di Alghero n. 83 del 1998 cit.
237
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
provvedere autonomamente al loro sostentamento mediante gli introiti relativi alla bigliettazione e ai servizi accessori offerti. Gli stessi contratti prevedono inoltre che le due menzionate cooperative debbano anche versare al Comune una quota annuale: la cooperativa Itinera, soggetto gestore dei Centri di Tor-re Porta Terra, versa ogni anno nelle casse comunali la somma di € 2.582,28; mentre la ATI Silt-Itinera, alla quale sono affidate le aree archeologiche, paga al Comune annualmente € 4.648,11; tale somma viene trasferita dal Comune alla Soprintendenza secondo quanto stabilito dal relativo accordo523. Le clau-sole contrattuali che prevedono l’autofinanziamento e il pagamento dei rispet-tivi canoni annuali, ideati dal Comune di Alghero, possono essere considerate come una sorta di incentivo per le cooperative a migliorare la qualità e la quan-tità dei servizi offerti, evitando in questo modo una loro sopravvivenza solo in funzione dell’assistenza data dallo stesso Ente locale.
L’esperienza gestionale sperimentata dal Comune di Alghero presenta al-cune peculiarità che la rendono unica in Sardegna; fra queste caratteristiche va sicuramente annoverata la capacità dell’Amministrazione algherese di inter-cettare diverse forme di finanziamento finalizzate al recupero e alla valorizza-zione dei beni cittadini. A questa abilità si affianca la volontà manifestata dal Comune di indirizzare tutte le citate risorse alla realizzazione di un unico pro-getto, ossia la creazione del Sistema Museale Integrato. Il Comune di Alghero sin dall’avvio, nel 1997, del progetto Territorio Museo, ha considerato la promozione del patrimonio culturale come un’occasione concreta per incentivare lo svilup-po economico e sociale della comunità; lo stesso versamento che le cooperative coinvolte nella gestione dei beni musealizzati devono effettuare al Comune a scadenza annuale è motivato dalla volontà dell’Ente locale di riuscire ad av-viare una gestione di tipo imprenditoriale del patrimonio di sua competenza.
È in quest’ottica che deve essere letta anche l’intenzione manifestata dall’Am-ministrazione comunale di creare il Sistema Museale Integrato; la realizzazione di questo progetto, che coinvolgerà non solo le strutture musealizzate afferenti al Territorio Museo ma anche quelle di nuova apertura, dovrebbe consentire la rea-le messa in rete del patrimonio culturale algherese e darà avvio ad una gestione di tipo sistemico estesa a tutti i beni presenti nel territorio comunale.
Sostanzialmente, questa serie di operazioni promosse dall’Amministrazione del Comune di Alghero ha determinato una serie di risultati positivi. In pri-mo luogo la manutenzione e il risanamento di alcuni spazi cittadini, quindi la fruibilità attraverso visite guidate. In seconda istanza, l’apertura di nuove strutture museali e il conseguente allargamento dei servizi culturali sono un altro positivo contributo apportato dall’attivazione della messa a sistema del
523 Contratto cit., Rep. 455 del 2002 cit. Contratto cit., Rep. 464 del 2002 cit.; DCC n. 39 del 1996 cit.
238
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
patrimonio. In terzo luogo l’afflusso di finanziamenti straordinari di origine comunitaria è un ulteriore elemento positivo che ha avuto come ricaduta la creazione di opportunità di lavoro nel territorio. La costituzione e lo svilup-po di alcuni soggetti privati operanti nel campo della promozione e gestione del patrimonio culturale risponde alla necessità delle amministrazioni locali di garantire un livello minimo di occupabilità nei territori. Infine, le casse comu-nali ricevono anche un introito, non molto cospicuo, ma costante, da parte dei soggetti affidatari della gestione del patrimonio: anche questo è un fattore di virtuosismo che corrisponde ad una politica di gestione sana e improntata al merito e alla produttività.
239
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
11 Camù e Karalis Card [Borgioli]
Al momento della nostra indagine nella Città di Cagliari si registrano due diverse esperienze di messa in rete del patrimonio culturale, entrambe pro-mosse dall’Amministrazione comunale: la Karalis Card, un biglietto che integra l’accesso alle emergenze culturali cittadine con l’uso dei trasporti pubblici, e il Consorzio Camù - Centri d’Arte e Musei, che realizza la gestione integrata per cinque strutture di pertinenza comunale524. I due progetti sono strettamente connessi fra loro non solo perché coinvolgono in parte gli stessi beni musea-lizzati, ma soprattutto perché la bigliettazione integrata mediante card viene gestita, per volontà del Comune, dallo stesso Consorzio Camù che realizza l’omonimo progetto di gestione integrata. Per questo motivo abbiamo ritenu-to opportuno analizzare queste due esperienze unitamente per evidenziare il forte legame che le caratterizza. Entrambi i progetti, inoltre, sono frutto di un unico indirizzo della politica culturale adottata dal Comune negli ultimi anni, finalizzato alla realizzazione di una gestione unitaria del patrimonio cittadino allo scopo di elaborare un’offerta culturale alternativa a quella balneare, così da riuscire a destagionalizzare il turismo in città.
¬ Precedenti
Già nel 1998 il Comune di Cagliari aveva firmato un accordo con altri sei Comuni – Alghero, Bosa, Castelsardo, Iglesias, Oristano e Sassari – per l’at-tuazione di un circuito turistico intercomunale denominato Città Regie. Tale intervento si è poi concretizzato grazie agli interventi previsti dalle misure 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici e 4.5 Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sar-degna del POR Sardegna 2000-2006. Nello specifico, il Comune di Cagliari ha realizzato, nell’ambito del progetto Città Regie, la sistemazione dell’ex Palazzo Civico e l’avvio di attività di promozione turistica intercomunale525.
524 Si veda anche F. FronGIa, Consorzio Camù e Karalis Card in c. BorGIolI, d. la MonIca (a cura di), Sistemi museali e musei in Sardegna. Politiche ed esperienze, atti del convegno (Sassari 2010), Felici Editore, Pisa 2012, pp. 142-148.
525 Le sette Città aderenti al progetto sono quelle che furono insignite del titolo di «città» − non subordinati dunque a vincoli feudali ma direttamente sottoposti alle giurisdi-zioni regie − durante l’età aragonese per particolari meriti mercantili o per le proprie posizioni strategiche. Venti miliardi al centro storico grazie all’accordo tra le sette città regie dell’Isola, «Unione Sarda», 11 gennaio 2001; Determinazione dell’Assessorato al turismo della Regione Autonoma della Sardegna n. 398 del 24 marzo 2005.
240
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
È però dal 2002 che l’Amministrazione comunale di Cagliari si è adoperata attivamente per attuare una forma di gestione associata per il patrimonio cit-tadino.526 Risale a quell’anno il primo progetto di gestione integrata approvato dal Comune e proposto alla Regione al fine di intercettare i contributi a valere sull’articolo 38 della legge regionale n. 4 del 20 aprile 2000527. La norma, con i ri-velativi indirizzi di attuazione, prevedeva infatti un cofinanziamento regionale agli Enti locali per il personale impiegato in musei, aree archeologiche, monu-menti, biblioteche ed archivi di Enti locali, mentre rimanevano a totale carico dell’ente proprietario o del soggetto affidatario le spese per la realizzazione dei servizi aggiuntivi528. Per accedere ai bandi di finanziamento regionali, gli Enti interessati dovevano produrre appositi progetti di gestione di durata triennale. Per la selezione di questi progetti la Regione individuava tra i criteri preferen-ziali l’attuazione di gestioni integrate o relative ad ambiti sovracomunali529.
Nel 2002 il Comune di Cagliari partecipò al bando regionale con un progetto denominato Il sistema monumentale del Comune di Cagliari. Progetto per la gestione integrata e la promozione dei Centri d’arte e cultura e degli spazi per la cultura e la comunicazione, che coinvolgeva cinque strutture di proprietà comunale: il Cen-tro della Cultura contadina Villa Muscas e i cosiddetti «Centri d’Arte e Cultura» Il Ghetto, il Lazzaretto, l’Exmà e il Castello di San Michele530. Tali strutture, fin dal momento della loro apertura, erano state affidate dall’Amministrazione comu-nale cagliaritana a soggetti diversi, come cooperative, associazioni o società: l’Associazione Villa Muscas e la cooperativa Il Ghetto si occupavano degli omo-nimi centri, la cooperativa Sant’Elia 2003 del Lazzaretto, la società Penty Service dell’Exmà, la società Sirai del Castello di San Michele531.
526 Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali della Regione Autonoma della Sardegna n. 1801 del 15 luglio 2002.
527 DGC di Cagliari n. 764 del 25 ottobre 2002, Approvazione progetto, con relativo piano di finanziamento, per la gestione di Centri Comunali d’Arte e Cultura, per l’ottenimento dei finanziamenti RAS di cui alla L. R. 4/2000 art. 38. LR n. 4 del 20 aprile 2000, Dispo-sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000). DGC n. 36/6 del 5 settembre 2000, L.R. n. 4/2000, Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, me-diante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali, biblioteche e archivi. Cap. 11129 del bilancio regionale. Direttive istruttorie e pubblicazione nel BURAS, a norma dell’art. 19 della L.R. 22.8.1990, n. 40.
528 LR 4/2000 cit. e DGR n. 36/6 del 2000 cit. 529 LR 4/2000 cit. e DGR n. 36/6 del 2000 cit. 530 DGC di Cagliari n. 764 del 2002 cit. I cosiddetti «Centri d’Arte e Cultura» si configura-
no come centri polivalenti, con sede in edifici storici della città, recuperati dal Comune tra il 1993 ed il 2000 per destinarli ad ospitare mostre temporanee ed eventi culturali. Cfr. sito web ufficiale del Consorzio Camù, all’indirizzo <http://camuweb.it>.
531 DGC di Cagliari n. 764 del 2002 cit.
241
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
L’affidamento di tali strutture ai rispettivi gestori era avvenuto mediante diverse modalità: gara d’appalto per il Castello di San Michele e l’Exmà, affida-mento diretto per Ghetto e Lazzaretto532. Nel 2000 il Lazzaretto era stato affidato al soggetto gestore, la cooperativa Sant’Elia 2003, mediante la stipula da parte del Comune di Cagliari di un “Patto di Quartiere” ovvero un accordo che preve-deva l’impiego all’interno della nuova struttura culturale di persone residenti nel medesimo quartiere ove era ubicato il Centro533. La cooperativa Il Ghetto, invece, nel maggio 2003 ha iniziato a occuparsi della gestione dell’omonimo Centro grazie alle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 37 del 24 di-cembre 1998 e destinate all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale534.
Il progetto elaborato dall’Amministrazione comunale nel 2002 prevedeva la realizzazione di una gestione integrata dei beni coinvolti; tale gestione si doveva attuare mediante l’adozione di comuni standard nell’ambito della pro-mozione, della manutenzione, della didattica museale e dell’organizzazione di eventi535.
Il Comune auspicava che a tale progetto aderissero tutte le strutture cul-turali di propria pertinenza, così da avviare una gestione congiunta se non di tutto, almeno della maggior parte del patrimonio cittadino; i soggetti coinvolti nella gestione dei beni non riuscirono però ad accordarsi sulla costituzione di una società o cooperativa atta alla gestione integrata e per questo l’idea iniziale dell’Amministrazione si ridimensionò includendo soltanto le strutture che era-no riuscite a trovare un accordo536.
Tale vicenda costituisce un passaggio fondamentale della storia sia del Con-sorzio Camù che del progetto Karalis Card, perché contribuisce a chiarire gli avvenimenti successivi che hanno condotto alla nascita delle due esperienze di gestione integrata oggi attive in città.
La necessità di creare una cooperativa o una società cui affidare la gestione del sistema cittadino è motivata dal fatto che la legge n. 4 del 2000 stabiliva che
532 Informazione fornita tramite comunicazione orale dal dott. Fabrizio Frongia, Presi-dente del Consorzio Camù-Centri d’Arte e Musei, in data 30 ottobre 2009.
533 Informazione fornita tramite comunicazione orale dalla dott.ssa Francesca Spissu, del Consorzio Camù-Centri d’Arte e Musei, in data 19 febbraio 2010.
534 LR e n. 37 del 24 dicembre 1998, Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio. Informazione fornita tramite comunicazione orale dalla dott.ssa Francesca Spissu, del Consorzio Camù-Centri d’Arte e Musei, in data 19 febbraio 2010.
535 DGC di Cagliari n. 764 del 2002 cit.536 Informazione fornita dal dott. Frongia, Presidente del Consorzio Camù, tramite co-
municazione orale in data 30 ottobre 2009.
242
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
le risorse economiche regionali venissero assegnate agli Enti locali solo se que-sti avessero provveduto ad affidare i beni culturali di spettanza a un soggetto di tipo imprenditoriale, in particolare cooperative o società; erano quindi escluse dai finanziamenti le gestioni concesse ad associazioni di qualunque tipo537.
Nel 2003 il Comune di Cagliari decise di rimodulare il progetto dell’anno precedente, piuttosto dispendioso, dividendolo in due distinti programmi per avere maggiori possibilità di accedere ai finanziamenti regionali. Furono perciò formulate due nuove proposte di gestione triennale: la prima, dal titolo Gestione beni culturali cittadini e Castello di San Michele era a cura dell’Assessorato all’Am-biente e Urbanistica e riguardava esclusivamente il Castello di San Michele e il Parco urbano adiacente; la seconda fu denominato Gestione Servizio Beni Monu-mentali Camù - Il Sistema Museale Cagliaritano - Progetto per la gestione integrata e la promozione dei Centri d’Arte e Cultura del Comune di Cagliari, riguardava i Centri culturali Exmà, Lazzaretto, Il Ghetto e fu predisposto dall’Assessorato alla cultura538.
Da entrambi i progetti rimase escluso il Centro della Cultura contadina Villa Muscas a causa della forma giuridica del gestore, l’Associazione Villa Muscas, non contemplata tra i requisiti del bando regionale a valere sulla legge regio-nale 4/2000539.
Entrambi i progetti riuscirono a ottenere i finanziamenti regionali, permetten-do così alla pubblica amministrazione cagliaritana di avviare una prima espe-rienza di gestione integrata del patrimonio culturale di pertinenza540.
537 LR 4/2000 cit. articolo 38, comma 1: «L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi, sino al 90 per cento della spesa prevista in pro-getto e ritenuta ammissibile, per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, bi-blioteche ed archivi. La durata delle convenzioni non può essere inferiore ai tre anni. Nel caso di servizi a rientro tariffario il contributo da erogare a favore degli enti locali deve tenere conto del rientro medesimo».
538 Informazione fornita tramite comunicazione orale dalla dott.ssa Francesca Spissu, del Consorzio Camù-Centri d’Arte e Musei, in data 19 febbraio 2010.
539 Informazione fornita tramite comunicazione orale dal dott. Fabrizio Frongia, Presi-dente del Consorzio Camù-Centri d’Arte e Musei, in data 30 ottobre 2009.
540 DGR n. 44/37 del 30 dicembre 2002, L.R. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e ar-chivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e am-bientali. 3° programma. Annualità 2002. DGR n. 24/36 del 29 luglio 2003, L. R. 4/2000 art. 38. Beni culturali, biblioteche e archivi. Contributi agli enti locali per l’affidamento in ge-stione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali e ambientali. 2° programma. Informazione fornita tramite comunicazione orale dalla dott.ssa Francesca Spissu, del Consorzio Camù-Centri d’Arte e Musei, in data 19 febbraio 2010.
243
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
¬ Camù-Centri d’Arte e Musei
L’Amministrazione comunale era consapevole che una concreta integrazio-ne delle strutture inserite nei due progetti non sarebbe stata possibile finché queste fossero state gestite da soggetti diversi.541 Al fine di avviare un processo di maggior integrazione nella gestione dei quattro «Centri Comunali d’Arte e Cultura», le cooperative e le società che fino a quel momento avevano operato in maniera separata decisero, con il beneplacito dell’Amministrazione comu-nale, di istituire un soggetto unico che si occupasse delle strutture comunali542.
Il 28 gennaio 2004 fu dunque firmato l’Atto costitutivo del Consorzio Camù-Centri d’Arte e Musei composto dai soggetti che fino a quel momento si erano occupati della gestione dei centri comunali: la cooperativa Il Ghetto per l’omo-nima struttura, la società Penty Service per l’Exmà, la società Sirai per il Castello di San Michele, la cooperativa Sant’Elia 2003 per il Lazzaretto543.
La nascita del Consorzio non ha però comportato l’unione dei due progetti presentati alla Regione nel 2003, questi infatti, oltre a rimanere ben distinti l’u-no dall’altro, hanno continuato fino al 2008 a fare riferimento ognuno al rispet-tivo Assessorato di pertinenza544.
Nel 2005 ha iniziato a collaborare con il Consorzio Camù anche la società Iti-nerarte, che gestisce all’interno dell’ente consortile le due Torri pisane: quella detta di San Pancrazio e quella denominata dell’Elefante545.
Attraverso il Consorzio quindi si realizza attualmente una gestione congiun-ta per i seguenti beni di proprietà del Comune di Cagliari:
- Centro Comunale d’arte e cultura Il Ghetto: inaugurato nel 2003, con sede in uno storico palazzo che ha avuto diverse destinazioni d’uso (già Quartiere dei Dragoni e Caserma San Carlo) e si trova all’interno
541 Cfr. Rapporto Innovacultura, Progetto di monitoraggio e valutazione delle iniziative pro-gettuali avviate in attuazione della normativa di cui all’art. 92 LR 11/1988 e all’art. 38 della LR 4/2000, giugno 2005 consultabile online sul sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo <http://www.regione.sardegna.it>.
542 Informazione fornita dal dott. Fabrizio Frongia, Presidente del Consorzio Camù, at-traverso comunicazione orale in data 30 ottobre 2009.
543 Atto costitutivo del Consorzio Camù del 28 gennaio 2004 Repertorio n. 101217.544 Nel 2008 i due progetti sono stati affidati all’Assessorato Cultura del Comune di
Cagliari. Informazione fornita tramite comunicazione orale dalla dott.ssa Francesca Spissu del Consorzio Camù in data 19 febbraio 2010.
545 Scheda esperienza Camù il sistema museale Cagliaritano, «Database Sviluppo Locale-Formez», consultabile on line all’indirizzo <http://db.formez.it>. L’ingresso formale della società Itinerarte all’interno del Consorzio Camù risale al 2009. Informazione fornitaci tramite comunicazione orale dalla dott.ssa Francesca Spissu del Consorzio Camù in data 16 febbraio 2010.
244
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
dell’antico ghetto ebraico della città546. L’intera struttura, da anni in stato di abbandono, è stata oggetto di un importante intervento di restauro – conclusosi nel 2000 – che ne ha permesso il recupero a fini museali. Oggi il complesso, che si sviluppa su quattro piani, ospita mostre temporanee, convegni e manifestazioni culturali di vario genere. Il Centro è inoltre sede del comitato tecnico che coordina la manifestazione culturale Cagliari Monumenti Aperti547.
- Centro Comunale d’arte e cultura Lazzaretto: il Centro, sito nel quartiere Sant’Elia, ha sede nell’antica struttura ospedaliera d’impianto quattrocentesco che fu destinata ai malati di peste. Anche quest’edificio è stato recuperato dal Comune di Cagliari nel 2000 e da allora è diventato sede di importanti eventi, convegni e spettacoli. Il Centro organizza inoltre escursioni a fini didattici sul colle di Sant’Elia e laboratori artistici e scientifici548.
- Centro Comunale d’arte e cultura Exmà (Ex mattatoio comunale): il Centro è stato uno dei primi spazi urbani a essere restaurato e riconsegnato alla cittadinanza dal Comune di Cagliari. Conclusosi il ripristino nel 1993, l’edificio è diventato sede di un centro polivalente e da quel momento ospita esposizioni temporanee d’arte, spettacoli, rassegne cinematografiche, concerti, sfilate di moda, laboratori didattici e creativi, convegni. L’Exmà è l’unico centro a esporre una collezione permanente: la raccolta Nicola Valle, composta da oltre seicentocinquanta stampe, tra le quali si segnala la presenza di opere di importanti incisori non
546 DGC di Cagliari n. 764 del 2002 cit.; sito web ufficiale del Consorzio, all’indirizzo <http://camuweb.it>.
547 La manifestazione Cagliari Monumenti Aperti s’inserisce all’interno dell’evento cultu-rale a carattere regionale Monumenti Aperti, che coinvolge 59 Comuni sardi e i loro monumenti al fine di incentivare la fruizione del patrimonio locale da parte dei resi-denti. La manifestazione consiste essenzialmente nella realizzazione di un calendario di eventi che nell’arco dell’anno interessano tutti i beni culturali aderenti. Cfr. sito web ufficiale del progetto, all’indirizzo <http://www.monumentiaperti.com>.
548 DGC di Cagliari n. 764 del 2002, cit.; sito web ufficiale del Consorzio, all’indirizzo <http://camuweb.it>. Durante i lavori all’ex Palazzo Civico di Cagliari, la collezione etnografica Manconi-Passino, ivi esposta, è stata ospitata nei locali del Lazzaretto. Il recupero dell’ex Palazzo Civico è stato realizzato dal Comune di Cagliari nell’ambito del progetto Città Regie, inserito fra gli interventi previsti dalle misure 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici e 4.5 Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sardegna del POR Sardegna 2000-2006. Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali della Regione Autonoma della Sardegna n. 1801 del 2002 cit.
245
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
solo sardi ma anche stranieri, donate nel 1997 al Comune dalla famiglia dell’intellettuale cagliaritano549.
- Centro Comunale d’arte e cultura Castello di San Michele: il Centro ha sede nell’omonima struttura costruita dai pisani nel XIII secolo a difesa della città da attacchi esterni. Il Castello è, dal 2001, centro d’arte polivalente, sede di alcune delle manifestazioni culturali più importanti anche a livello regionale550. Dal 2004 inoltre è la sede ufficiale del progetto Cagliari Città dei Bambini, iniziativa promossa dall’Assessorato alle politiche sociali e finanziata dalla legge n. 285 del 1997551.
- Torri pisane di San Pancrazio e dell’Elefante: costruite sotto il dominio pisano, rispettivamente nel 1305 e nel 1307, le due torri rappresentano una testimonianza della primitiva cinta muraria della città di Cagliari. Oltre alla possibilità di ammirare dall’interno le strutture di questi due importanti monumenti medievali, la visita alle due Torri permette al fruitore di godere del panorama del golfo cagliaritano. Le due architetture sono inoltre il punto di partenza di alcuni itinerari finalizzati a far conoscere al fruitore il centro storico cittadino; questi percorsi guidati non rientrano però nei servizi inclusi nella normale bigliettazione né in quella integrata della Karalis Card: il visitatore deve pagare un biglietto a parte per poterne usufruire552.
La realizzazione di Camù ha permesso l’integrazione dei servizi e delle funzioni relativi a spazi museali e beni monumentali differenti per tipologia e missione culturale. Ogni Centro aderente al Consorzio si è progressivamen-te specializzato nell’organizzazione di mostre temporanee su una determinata produzione artistica: vi sono cioè spazi espositivi deputati alla pittura, all’arte contemporanea, alla fotografia e alla cultura materiale553. Dal momento della
549 DGC di Cagliari n. 764 del 2002 cit.; sito web ufficiale del Consorzio, all’indirizzo <http://camuweb.it>.
550 DGC di Cagliari n. 764 del 2002 cit.; sito web ufficiale del Consorzio, all’indirizzo <http://camuweb.it>.
551 L n. 285 del 28 agosto 1997, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza. Questa norma istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realiz-zazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale volti a favorire, fra le altre cose, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza.
552 DGC di Cagliari n. 764 del 2002 cit.; sito web ufficiale del Consorzio, all’indirizzo <http://camuweb.it>.
553 Scheda esperienza Camù il sistema museale Cagliaritano, in «Database Sviluppo Locale-
246
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
sua istituzione a oggi il Consorzio ha realizzato una gestione di tipo congiunto delle strutture di pertinenza che si concretizza essenzialmente nell’adozione di comuni standard espositivi, didattici, scientifici, documentativi e promozionali e nell’attivazione, a partire dal 2005, di una bigliettazione integrata554.
Le spese relative al personale impiegato per il funzionamento delle struttu-re gestite dal Consorzio Camù, esclusi i servizi aggiuntivi, così come disposto dall’articolo 38 della legge regionale 4/2000, sono state coperte da finanzia-menti pubblici ovvero da risorse regionali e comunali555. I rimanenti costi di gestione sono invece liquidati per mezzo degli introiti realizzati con i servizi aggiuntivi e con attività di fundraising condotti da Camù556.
Ciascun aderente al Consorzio gestisce la propria struttura di riferimento oc-cupandosi della manutenzione, della pulizia, della sorveglianza e della bigliet-teria ma anche dei relativi servizi aggiuntivi, organizzando mostre temporanee ed eventi culturali eterogenei, svolgendo attività didattiche e visite guidate557. L’organizzazione di esposizioni temporanee è un’attività molto importante nel-la gestione delle strutture svolta da Camù, soprattutto perché la maggior parte dei centri afferenti al Consorzio non dispone di una propria collezione per-manente: le mostre temporanee dunque costituiscono l’elemento di maggior visibilità per il Consorzio. Oltre ad occuparsi dell’organizzazione e della realiz-zazione di eventi espositivi propri, il Consorzio ospita nei Centri gestiti anche alcune mostre itineranti progettate o già allestite in altri contesti558.
I Centri ospitano infine nei loro spazi anche diverse associazioni cagliaritane e in questo modo il Consorzio ha cercato di trasformare tali strutture in punti di aggregazione per la comunità. L’obiettivo di Camù è infatti quello di accrescere nei residenti la conoscenza e il senso d’appartenenza per il proprio patrimonio culturale, anche attraverso la realizzazione di appositi laboratori didattici ed eventi culturali559.
Formez», consultabile on line all’indirizzo <http://db.formez.it>.554 Ivi. L’informazione relativa alla bigliettazione integrata avviata nel 2005 è stata con-
fermata dal dott. Fabrizio Frongia, Presidente del Consorzio Camù, tramite comuni-cazione orale in data 30 ottobre 2009.
555 DGR n. 44/37 del 2002 cit. e n. 24/36 del 2003 cit. LR n. 4/2000 cit. e DGR n. 36/6 del 2000 cit. Si veda anche il saggio di Cristina Borgioli in questo volume.
556 Cfr. sito web ufficiale del Consorzio Camù, all’indirizzo <http://www.camuweb.it>. 557 Scheda esperienza Camù cit., consultabile on line all’indirizzo <http://db.formez.it>;
informazione fornita dal dott. Frongia, Presidente del Consorzio Camù, tramite co-municazione orale in data 5 settembre 2009.
558 Cfr. sito web ufficiale del Consorzio Camù, all’indirizzo <http://www.camuweb.it>.559 Informazione fornita dal dott. Frongia, Presidente del Consorzio Camù, tramite co-
municazione orale in data 24 settembre 2009.
247
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
¬ Il Progetto Sistema Museale della Città di Cagliari
Forte dell’esperienza maturata con l’attivazione del Consorzio Camù, il Co-mune di Cagliari ha presentato un nuovo progetto di gestione congiunta per il patrimonio culturale, in occasione dei bandi di finanziamento regionali emessi in data 6 marzo 2006 a valere sulla nuova normativa regionale, la legge finan-ziaria n. 7 del 2005 che sostituiva la precedente normativa560.
Il nuovo progetto di gestione integrata presentato dal Comune di Caglia-ri, diversamente da quello elaborato nel 2002 e successivamente rimodulato l’anno seguente, include anche beni culturali con titolarità non comunale561. Si ipotizzava infatti la creazione di un sistema museale cittadino che comprendes-se, oltre alla presenza delle strutture già gestite da Camù, altre otto strutture di pertinenza comunale: la Galleria Comunale d’Arte, il Museo d’arte siamese Stefano Cardu, il Centro culturale comunale Ex vetreria, il Centro di Villa Muscas, l’Anfiteatro romano, la Villa di Tigellio, il Carcere di Sant’Efisio, la Cripta di Santa Restituta, cui si sarebbe aggiunta la Grotta della Vipera di spettanza statale562. Con l’elaborazione di questo progetto dunque il Comune proponeva la nascita di un sistema che avrebbe aggregato il complesso dei beni e degli istituti museali cagliaritani, e non esclusivamente quelli di sua pertinenza. Per la gestione di tale sistema si optava per l’affidamento diretto ad una fondazione, da istituire appositamente, partecipata in misura prevalente dal Comune563.
A pochi mesi di distanza dalla presentazione di questo primo progetto di messa in rete, il Comune di Cagliari, con delibera della giunta n. 349 del set-
560 LR n. 7 del 21 aprile 2005, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione e la relativa delibera di attuazione (DGR n. 61/30 del 20 dicembre 2005, Linee di indirizzo relative all’erogazione di contributi agli enti locali pubblici territoriali) so-stituivano la normativa precedentemente in vigore in materia di contributi agli Enti locali (legge finanziaria regionale 4/2000 cit.). La nuova produzione normativa av-venne a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2004 che sanciva l’illegittimità dell’articolo 113bis del Tuel e sottraeva a Regioni ed Enti locali un rife-rimento generale per le modalità di affidamento a terzi dei servizi privi di rilevanza economica, toccando quindi una questione che riguardava anche la concessione dei servizi per musei e istituti della cultura. Con la legge regionale finanziaria del 2005 la Regione Sardegna si è dunque adeguata al mutato contesto normativo nazionale. I commi 7 ed 8 dell’articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005 infatti consentono nuovamente il ricorso all’affidamento a terzi della gestione dei beni culturali. Su que-sto argomento si rimanda al contributo di Cristina Borgioli in questo volume.
561 DGC di Cagliari n. 231 del 2006 cit. e n. 272 del 7 giugno 2006, Approvazione del Proget-to Sistema Museale della Città di Cagliari-Integrazione.
562 DGC di Cagliari n. 231 del 2006 cit. e n. 272 del 2006 cit. Nel progetto di gestione integrata approvato con questi documenti si afferma che il sistema avrebbe dovuto comprendere anche altri siti ipogei cittadini non meglio specificati.
563 DGC di Cagliari n. 231 del 2006 cit. e n. 272 del 2006 cit.
248
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
tembre 2006, ne approvò uno nuovo che in parte rimodulava il precedente564. Nel nuovo documento non si menziona più la creazione di una fondazione ma si stabilisce che per il sistema museale, composto dalle medesime strutture del precedente progetto, si sarebbe dovuto procedere alla gestione indiretta dei servizi tramite concessione a terzi565. Poiché la graduatoria relativa ai progetti sul bando di finanziamento sulla legge regionale 7/2005 non è mai stata pubbli-cata, il progetto di creare il sistema museale cagliaritano non è ancora avviato al momento della nostra indagine (2009).
¬ Karalis Card
Malgrado il mancato avvio del progetto di sistema del 2006, l’Amministra-zione comunale non ha comunque rinunciato all’idea di realizzare una più estesa messa in rete del patrimonio culturale cittadino: nell’estate del 2008 il Comune ha attivato una bigliettazione integrata che coinvolge musei, siti ar-cheologici, monumenti, teatri e beni ambientali, della città e di parte del terri-torio566. Aderiscono a questo progetto, tramite protocollo d’intesa, l’azienda dei trasporti pubblici locali (CTM), l’Università di Cagliari, la Diocesi, il Consorzio Camù, la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, l’Arciconfraternita dei Genove-si, associazioni e cooperative locali (Anamnesys, Arteficio, Inmediarte, Orientare, Specus, Villa Muscas, Itinerarte srl, Sirai snc), il Parco Naturale Regionale Molen-
564 DGC di Cagliari n. 349 del 14 settembre 2006, Approvazione del nuovo progetto ‘Sistema Museale della Città di Cagliari’ con relativo piano di finanziamento, per l’ottenimento del contributo per i progetti triennali di fruizione dei beni e di promozione dei servizi relativi ad aree e parchi archeologici, complessi monumentali, musei di ente locale e d’interesse locale di cui alla L.R. 7/2005 art. 12 comma 3.
565 DGC di Cagliari n. 349 del 2006 cit. Nel documento non si fa riferimento alla motiva-zione precisa che ha condotto l’Amministrazione comunale a mutare, in pochi mesi, il parere sulla tipologia di soggetto al quale affidare la gestione del sistema museale cittadino. L’unico riferimento che potrebbe spiegare questo cambiamento è quello alla mutata situazione normativa regionale, intervenuta proprio in quel periodo con l’emanazione delle leggi regionali n. 4 del 11 maggio 2006, Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo e n. 9 del 12 giugno 2006, Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Le due leggi apportavano nuove disposizioni in materia di erogazione di contributi agli enti pubblici; la legge n. 9, ad esempio, conferiva alle province i compiti di «programmazione ed erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale», nonché la promozione della gestio-ne associata dei musei e dei luoghi della cultura (art. 77, comma 1 lett. b) e c) della legge regionale n. 9 del 2006 cit.).
566 DGC n. 195 del 17 luglio 2008, Istituzione Karalis Card.
249
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
targius Saline, Sardegna Concerti, Sardinia Jazz, CeDac (Centro diffusione attività culturali)567.
All’iniziativa, denominata Karalis Card, aderisce anche un soggetto non ca-gliaritano: il Comune di Settimo San Pietro con il Museo multimediale Arca del Tempo568. La partecipazione di questo Comune è motivata dal fatto che la strut-tura museale di spettanza è gestita dallo stesso Consorzio Camù, che ha parte attiva nell’organizzazione della card569.
La card realizza un’integrazione tra la bigliettazione d’ingresso ai beni mu-sealizzati coinvolti e la possibilità di usufruire del trasporto pubblico locale e in questo modo l’Amministrazione comunale ha inteso raggiungere un du-plice obiettivo: offrire un servizio aggiuntivo ai turisti rendendo più agevoli gli spostamenti in città e, al contempo, avvicinare il pubblico dei residenti al patrimonio culturale cagliaritano570. In sostanza, con l’attivazione della Karalis Card il Comune di Cagliari ha realizzato una sorta di itinerario cittadino molto ampio, che tocca le principali emergenze culturali cagliaritane, che risultano più facilmente raggiungibili grazie alla partecipazione al progetto dell’azienda di trasporto locale. L’intenzione del Comune di rivolgere l’iniziativa anche ai residenti si manifesta in particolare nella presenza di carte integrate di diversa durata – 1, 3, 7, o 365 giorni – che consentono al cittadino di usufruire anche per un intero anno dei vantaggi connessi al possesso della card. Il biglietto integrato consente al suo possessore di usufruire di tutta una serie di vantaggi e agevo-lazioni come l’ingresso scontato agli spettacoli allestiti nei teatri comunali571.
La Karalis Card consente nello specifico:
567 Comune di Cagliari, Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari, il CTM Spa, la Rete di Partenariato dei Luoghi della Cultura e il Consorzio Camù-Centri D’Arte e Musei, Cagliari 25 luglio 2008.
568 DGC di Settimo San Pietro n. 85 del 23 luglio 2008, Approvazione protocollo d’intesa della Karalis Card.
569 Cfr. in <http//www.camuweb.it>.570 Comunicazione Ufficio Stampa del Comune di Cagliari del 22 luglio 2008, consulta-
bile online all’indirizzo <http:\\www.ufficiostampacagliari.it>. La Karalis Card non è l’unico caso di bigliettazione integrata che coinvolge beni culturali e sistema di trasporto pubblico locale; altri esempi di tourist card presenti nel panorama italiano sono: la Trento Card, la T For You di Trieste, la Verona Card, la Carta Orvieto Unica, la Roma Pass. Tutte queste iniziative hanno in comune anche il fatto che sono promosse dall’Amministrazione locale e valgono esclusivamente per il territorio comunale. La Campania artecard, invece, è un’iniziativa promossa dalla Regione Campania che per-mette di accedere al patrimonio culturale, ai trasporti e ai servizi culturali e turistici di tutto il territorio regionale. Cfr. S. pellIzzerI, Le card integrate cultura-trasporti. Uno strumento di valorizzazione e promozione turistica del patrimonio artistico e culturale. Espe-rienze a confronto, Milano s.d.
571 Cfr. sito web ufficiale dell’iniziativa, all’indirizzo <http://www.karaliscard.it>.
250
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
- l’accesso scontato ai seguenti beni: la Collezione Piloni, la Galleria Comunale d’Arte, il Museo Arciconfraternita dei genovesi, il Museo Cere anatomiche Clemente Susini, il Museo di arte siamese Stefano Cardu, il Museo della Cultura Contadina Villa Muscas, l’Anfiteatro Romano con gli annessi siti (Cavità e Galleria rifugio, l’Orto dei Cappuccini), il Museo diocesano (privato), il Centro Exmà, il Centro Il lazzaretto, il Castello di San Michele, il Centro Ex vetreria, la Passeggiata Coperta-percorsi archeologici, la Torre dell’Elefante, la Torre di San Pancrazio, la Grotta della Vipera (statale), la Villa di Tigellio, l’Orto botanico (Università), la Cripta di Santa Restituta, L’Arca del tempo di Cuccuru Nuraxi (Museo multimediale di supporto alla visita del parco archeologico adiacente) nel comune di Settimo San Pietro, il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline572;
- agevolazioni per gli eventi del Teatro Lirico di Cagliari e degli altri teatri comunali della città;
- sconti presso i bookshop aderenti all’iniziativa;
- accesso gratuito all’intera rete di trasporto pubblico afferente al CTM per il periodo di validità del biglietto integrato573.
L’Amministrazione comunale al momento dell’istituzione della card ne ha af-fidato l’organizzazione gestionale e finanziaria al Consorzio Camù, che quindi svolge un ruolo di coordinamento per l’intera iniziativa574. La decisione presa dal Comune si motiva col fatto che Camù ha rappresentato negli ultimi anni la realtà con maggiore esperienza nel settore culturale, essendo impegnato dal 2004 a realizzare una gestione integrata dei Centri culturali di spettanza comunale.
Tra i compiti di Camù vi è anche quello di provvedere alla ripartizione dei proventi della bigliettazione integrata realizzata dalla Karalis Card, che vengo-no così distribuiti tra gli aderenti: il 45% alle strutture visitabili, il 35% al prose-guimento del progetto e il 20% al Comune575.
La creazione del “circuito” cittadino mediante l’istituzione della card non ha però comportato l’avvio di una gestione congiunta delle emergenze culturali
572 Ciascuna di queste strutture rimane comunque anche visitabile singolarmente con l’acquisto del relativo biglietto.
573 Cfr. sito web ufficiale della Karalis Card, all’indirizzo <http://www.karaliscard.it>. 574 DGC di Cagliari n. 195 del 2008 cit. Nella stessa delibera si legge che il Comune ha
concesso a Camù un finanziamento di sessantamila euro destinato alla realizzazione del progetto.
575 DGC di Cagliari n. 195 del 2008 cit.
251
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
coinvolte nella bigliettazione integrata. Tali strutture risultano gestite ognuna da un proprio soggetto che opera in piena autonomia, rispondendo esclusiva-mente all’Ente che ha la titolarità del bene. Si può dunque a ragione affermare che le attività condivise per il patrimonio aderente alla card sono essenzialmen-te di tipo promozionale.
Nel 2008 l’unica forma di gestione integrata e concreta, che riguarda più aspetti, dal funzionamento delle strutture all’attivazione dei relativi servizi, è quella realizzata dal Consorzio Camù. L’importanza del ruolo svolto da Camù nel panorama culturale cagliaritano è riconosciuta dalla stessa Amministrazio-ne comunale che, nel 2008, ha voluto affidare al Consorzio, in virtù della sua esperienza nel settore della gestione dei musei, il coordinamento della Karalis Card576. È indubbio dunque il profondo legame che esiste fra le due esperienze di messa in rete del patrimonio culturale cittadino promosse dall’Amministra-zione, un legame che non si limita alla presenza del Consorzio fra i partner aderenti alla card, ma che si esplica principalmente nel ruolo svolto da Camù nell’organizzazione, economica e finanziaria, del progetto di bigliettazione in-tegrata.
Questa sinergia fra i due interventi ideati e promossi dalla pubblica ammini-strazione manifesta appieno la volontà del Comune di riuscire a realizzare una gestione sistemica del patrimonio culturale, intesa come strumento efficace per lo sviluppo, in chiave socio-economica, della comunità. Anche l’esperienza di messa in rete del patrimonio a livello sovra comunale attuata con il progetto Città regie mostra chiaramente l’intenzione dell’Amministrazione cagliaritana di gestire in chiave sistemica le emergenze culturali presenti in città; in tal senso il Comune di Cagliari si pone, fra quelli presi in considerazione dalla nostra indagine, come uno dei più attivi nella realizzazione di una gestione congiunta del patrimonio cittadino.
Tra gli aspetti positivi di questa iniziativa si annoverano in primo luogo la ristrutturazione e la messa a disposizione del pubblico di una parte consistente del patrimonio culturale locale; in secondo luogo il coinvolgimento e dunque l’occupazione di molte società nella gestione dei servizi; in terzo luogo la di-mostrazione dell’interesse ad interagire anche con altri Comuni o soggetti, in ambito extra comunale e nell’ambito dei privati.
576 Ivi.
252
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
12 Rete museale dei Fenici [Deligia]
La Rete museale dei Fenici è stata istituita nel 2008 mediante la firma di un apposito protocollo d’intesa. Si tratta di un progetto che si sviluppa dalla vo-lontà della Regione di istituire un museo dedicato alla cultura fenicia in Sar-degna − volontà già espressa nel documento regionale di indirizzo del 2005 Sistema Regionale dei Musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo − e finalizzato alla messa in rete delle testimonianze della civiltà fenicia presenti nei musei e nei siti archeologici dell’Isola577. La Rete, di fatto non esistente al momento della nostra indagine (2009), dovrebbe configurarsi in futuro come un circuito virtuale avente il proprio “centro” nel Museo multimediale di Torre Grande presso Oristano, anch’esso da realizzare. Il compito del Museo sarà illustrare e colle-gare tra loro tutte le testimonianze materiali della cultura fenicia conservatesi in Sardegna578.
¬ 1. Precedenti
La volontà di valorizzare le testimonianze materiali della cultura fenicia conservate nell’Isola esplicitata dalla Regione alla metà degli anni Duemila, risale agli inizi degli anni Ottanta quando, a livello nazionale, furono progettati e finanziati i cosiddetti Itinerari Turistico-Culturali per il Mezzogiorno. Nel 1982 il CIPE deliberò a favore dello stanziamento di risorse economiche finalizzate alla realizzazione di diversi itinerari nel Sud Italia, tra i quali era prevista anche una direttrice denominata Fenicio-Cartaginese-Nuragica che interessava le Re-gioni Sicilia e Sardegna579. Le disposizioni espresse dal CIPE prevedevano che questa direttrice fosse articolata in un tratto Fenicio-Cartaginese, da attuare nel territorio siciliano, e in un tratto Fenicio-Cartaginese-Nuragico, da sviluppare in Sardegna580. Si deve sottolineare però che, se nella zona della Marmilla risul-tano evidenti alcune positive ricadute dei finanziamenti CIPE relativi agli iti-nerari per il Mezzogiorno in Sardegna, specialmente per la valorizzazione dei
577 Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Oristano, Comune di Oristano, Pro-tocollo d’Intesa per la Realizzazione della Rete museale dei Fenici, Cagliari 2 aprile 2008. Sistema Regionale dei Musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo. Documento d’indirizzo politico-amministrativo approvato con DGR n. 36/5 del 26 luglio 2005.
578 DGR n. 64/6 del 18 novembre 2008, Piano Regionale per i Beni Culturali, Istituti e Luoghi della Cultura.
579 Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 1982, Approvazione del programma stralcio progetto per gli itinerari turistico culturali nel Mezzogiorno.
580 Delibera CIPE n. 99 del 1982, cit.
253
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
complessi nuragici, più difficile appare valutare quali siano stati i concreti effet-ti sul territorio per quanto riguarda il patrimonio culturale di ambito fenicio581.
¬ 2. La promozione della civiltà fenicia tra istanze locali e regionali
In tempi più recenti la Regione ha espresso il proposito di promuovere la conoscenza del patrimonio fenicio in occasione degli stanziamenti CIPE pre-visti dalla delibera n. 20 del 2004 e destinati ai futuri Accordi di Programma Quadro (APQ) Stato-Regioni582. Nella delibera n. 14/1 del 31 marzo 2005 la stessa Amministrazione regionale inseriva tra gli interventi da proporre all’in-terno dell’APQ in materia di beni culturali anche la realizzazione di un museo regionale della cultura nuragica, fenicia e contemporanea del Mediterraneo, da istituire a Cagliari583.
A distanza di pochi mesi però il progetto di fondare questo museo mutò, dato che la Regione decise di realizzare due distinte strutture museali: il Museo della civiltà fenicia della Sardegna nel Golfo di Oristano e il Museo dell’arte nu-ragica e dell’arte contemporanea mediterranea a Cagliari584. La Regione manifestò tale proposito nel documento di indirizzo Sistema Regionale dei Musei. Piano di Razionalizzazione e sviluppo del 2005, nel quale dichiarava il suo impegno a cre-are un sistema museale regionale articolato in diversi sub sistemi a carattere territoriale o tematico con estensione per lo più provinciale585.
Tra questi sub sistemi si annoverava anche la Rete museale della provincia di Oristano, all’interno della quale si ipotizzava l’istituzione di un nuovo museo regionale denominato Museo della civiltà fenicia della Sardegna; quest’ultimo avrebbe dovuto presentare un «quadro della civiltà fenicia dell’intera isola […] unendo in un percorso virtuale i musei e i siti archeologici fenici della Sarde-gna, del Mediterraneo e dell’Atlantico»586. Per quanto riguarda la collocazione geografica del museo, il documento suggeriva il centro del Golfo di Orista-no, considerate le numerose testimonianze della civiltà fenicia ivi presenti, ma
581 Per le notizie su quanto realizzato nel territorio della Marmilla nei primi anni Novan-ta grazie ai finanziamenti CIPE, si rimanda alla scheda relativa al Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, in questo stesso volume.
582 Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate-Rifinanziamento L. 208/1998 Periodo 2004-2007 (L. F. 2004).
583 DGR n. 14/1 del 31 marzo 2005, Delibera CIPE n. 20/2004-Punto 6.1.3. Adempimenti al 31.3.2005. Approvazione definitiva.
584 Sistema Regionale dei Musei 2005 cit.585 Ivi pp. 40-41.586 Ivi.
254
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
non individuava tuttavia chiaramente il comune nel quale la struttura sarebbe dovuta sorgere né il rapporto che avrebbe dovuto avere con la rete museale provinciale587. Nelle intenzioni della Regione il futuro museo dei fenici avrebbe dovuto svolgere una duplice azione: da una parte costituire il polo museale principale per l’archeologia nel territorio della provincia di Oristano e, dall’al-tra, fungere da “centro” per una ipotetica rete a dimensione regionale dedicata al tema della cultura fenicia588.
Nei mesi estivi del 2005 fece seguito alla pubblicazione del Piano di raziona-lizzazione e sviluppo un acceso dibattito, che trovò ampia eco sulla stampa locale, tra le Amministrazioni comunali di Cabras, Santa Giusta e Oristano in merito al luogo ove dovesse essere istituito il museo; ognuno di questi Comuni infatti si reputava idoneo a ospitare la nuova struttura in quanto conservava nel proprio territorio importanti testimonianze della colonizzazione fenicia589. Mentre i tre Comuni del Golfo di Oristano erano impegnati a contendersi la futura sede del Museo, nel settembre 2005 la Regione Sardegna, il Ministero dell’Economia e della Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali stipularono l’Accor-do di Programma quadro in materia di beni e attività culturali (APQ) nel quale non si faceva alcun riferimento né al museo dedicato alla civiltà fenicia né alla Rete museale dei Fenici590.
Il 9 marzo 2006 la Regione, la Provincia di Oristano e i citati Comuni di Oristano, Cabras e Santa Giusta sottoscrissero un Documento di condivisione, nel quale veniva presentato un articolato programma per la valorizzazione del patrimonio culturale inerente la cultura fenicia, in particolare per quanto riguardava la creazione del museo regionale e la realizzazione di una rete mu-seale591. In tale Documento si dichiara in primo luogo che il Museo della civiltà
587 Ivi.588 Lo stesso Piano regionale del 2005 predisponeva la creazione di un altro museo re-
gionale, da istituire sempre ad Oristano, e dedicato al tema della Sardegna Giudicale. Cfr. Sistema Regionale dei Musei 2005 cit.
589 M. oBInu, Oristano vuole il museo fenicio. Barberio: «È la sede naturale», «Il Giornale di Sardegna», 4 settembre 2005; V. pInna, Oristano, Cabras e Santa Giusta salutano il Museo dei Fenici, «L’Unione Sarda», 3 ottobre 2005; r. petretto, Il pessimismo di Cherchi: dicia-mo addio al Museo dei Fenici, «La Nuova Sardegna», 5 ottobre 2005; Nessun taglio per il museo. L’assessore Pilia: i fondi non erano stati stanziati, «La Nuova Sardegna», 6 ottobre 2005.
590 Regione Autonoma della Sardegna, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Mini-stero per i Beni e le Attività Culturali, APQ in materia di beni e attività culturali, Roma 30 settembre 2005.
591 Documento di condivisione tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Oristano e i Comuni di Oristano, Cabras, Santa Giusta per la realizzazione del Progetto sovracomunale strategico, integrato e complessivo sulla “Via dei fenici”, denominato PHOINIX, Oristano 9
255
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
fenicia della Sardegna «deve intendersi come rete museale del Golfo di Oristano in riferimento al Museo archeologico di Santa Giusta, al Museo Archeologico di Cabras, all’Antiquarium Arborense di Oristano e ai siti archeologici di Tharros (Cabras) e di Othoca (Santa Giusta)»592. Secondo quanto stabilito, dunque, il museo regionale si sarebbe dovuto configurare come un «Polo Museale Metro-politano a stella comprendente i musei e il patrimonio culturale di Oristano, Cabras e Santa Giusta», per l’istituzione del quale viene prevista la stipula di un apposito protocollo d’intesa593. L’idea iniziale di museo regionale viene quindi trasformata in quella di una “rete” di dimensioni più ridotte.
Nello stesso Documento di Condivisione veniva poi illustrato un ulteriore e importante progetto per il territorio oristanese: i Comuni di Oristano, Santa Giusta e Cabras dichiaravano la loro intenzione a promuovere un progetto so-vra comunale «strategico, integrato e complessivo» sulla cosiddetta “Via dei Fenici”, dal titolo Phoinix-Parco Fluviale Fenicio che prevedeva, oltre alla rea-lizzazione di due parchi archeologici (rispettivamente presso i siti di Othoca e Tharros), anche la creazione di un itinerario ciclabile e pedonale – denominato appunto Via dei Fenici – finalizzato a collegare i tre Comuni mediante percorsi lungo le aree lagunari594. Questo itinerario si sarebbe congiunto con il cosiddet-to Parco Fluviale Fenicio, un altro progetto stavolta del Comune di Oristano, che prevedeva la realizzazione di un ulteriore percorso, consistente essenzialmen-te nel prolungamento della Via Fenicia, verso le pinete di Torre Grande, dove avrebbe dovuto avere sede il “polo” principale del Museo della civiltà fenicia595.
Pertanto i firmatari del Documento di Condivisione del 2006 si impegnavano in diverse azioni: innanzitutto a dare luogo ad un partenariato per la realizza-zione del progetto Phoinix, ma anche alla firma di un protocollo per la realizza-zione di un sistema territoriale definito «Polo Museale Metropolitano a stella» e infine alla gestione comune del patrimonio culturale-museale con l’adozione di un logo e di una card di servizi596. Il Documento di Condivisione prefigurava quindi un complesso sistema territoriale integrato di musei e aree archeologi-che, dedicato alla cultura fenicia, inserito a sua volta in un parco a valenza am-
marzo 2006. Su questi progetti si veda anche r. zucca, Conclusioni in c. BorGIolI, d. la MonIca (a cura di), Sistemi museali e musei in Sardegna. Politiche ed esperienze, atti del convegno (Sassari 2010), Felici Editore, Pisa 2012, pp. 152-160.
592 Documento di condivisione cit.593 Ivi.594 Ivi.595 Documento di condivisione cit.596 Piace a tutti il parco fluviale fenicio. Il progetto incassa il si unanime anche in Consiglio Co-
munale, «La Nuova Sardegna», 11 marzo 2006; La Regione sposa il Parco fluviale, «L’U-nione Sarda», 10 marzo 2006.
256
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
bientale, caratterizzato da percorsi capaci di collegare musei e siti di interesse archeologico e naturale597.
Il partenariato tra le Amministrazioni locali previsto nel menzionato Docu-mento di condivisione era finalizzato a intercettare ogni forma di finanziamento pubblico per la concretizzazione del progetto Phoinix e in effetti tale partena-riato partecipò, alla fine del marzo 2006, al bando Progetti di qualità 2005-2006 Polis a valere sull’Asse V Misura 5.1 Politiche per le aree Urbane del POR Sarde-gna 2000-2006, senza però essere ammesso ai finanziamenti598. Riepilogando, a partire dal 2006 si registrano nel territorio oristanese due distinti progetti per la promozione del patrimonio culturale locale di ambito fenicio: il primo, de-nominato Phoinix, era dedicato alla creazione di un parco con itinerari volti alla fruizione del patrimonio archeologico mentre il secondo, la Rete museale dei Fe-nici, si sarebbe dovuto articolare attorno alla costruzione di una serie di musei relativi alla civiltà fenicia.
Nell’ottobre del 2006 fu pubblicato il primo Atto integrativo dell’APQ Sar-degna per i beni culturali del 2005 e tra le modifiche apportate da questo docu-mento si annovera anche l’introduzione dell’intervento denominato Rete Mu-seale dei Fenici599. Con la delibera n. 13/1 del 30 marzo 2006 la Regione aveva individuato e determinato alcune azioni da integrare al precedente APQ e tra queste aveva inserito anche la realizzazione della Rete museale dei Fenici. Nel menzionato primo Atto integrativo, firmato a Roma il 2 ottobre 2006, venivano inoltre stanziati 500 mila euro a valere su fondi CIPE destinati alla creazione della Rete600. Proprio il contributo di 500 mila euro risulta essere al momento (2009) l’unica dotazione economica di cui il progetto dispone ed è indirizzato specificatamente alla realizzazione e all’allestimento del Museo della Civiltà Fe-nicia in Sardegna601.
597 Documento di condivisione cit.598 DCC di Santa Giusta n. 16 del 21 marzo 2006, Adesione Polo Museale metropolitano e pro-
getto Phoinix Parco Fluviale Fenicio; Determinazione regionale n. 477/CS del 3 luglio 2006, POR Sardegna 2000-2006-Misura 5.1 “Politiche per le aree urbane”-Delibera CIPE 35/05 “Riserva Aree Urbane”-bando “Progetti di qualità 2005-2006”-approvazione dei la-vori della commissione di valutazione ai sensi dell’art. 8 del bando-approvazione graduatoria definitiva dei Progetti di Qualità. Phoinix solo sedicesimo, «La Nuova Sardegna», 5 luglio 2006; a. MaSala, Il Parco Fluviale resta a secco, «L’Unione Sarda», 6 luglio 2006.
599 Regione Autonoma della Sardegna, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Mini-stero per i Beni e le Attività Culturali, APQ in materia di beni e attività culturali Atto Integrativo, Roma 2 ottobre 2006.
600 DGR n. 13/1 del 30 marzo 2006, Deliberazione CIPE n. 35 del 27.5.2005-punto 7.1.3: adempimenti al 31.3.2006. Regione Autonoma della Sardegna, Ministero dell’Econo-mia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, APQ in materia di beni e attività culturali Atto Integrativo, Roma 2 ottobre 2006.
601 Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Oristano, Comune di Oristano, Pro-
257
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Nella descrizione della Rete museale, contenuta nell’allegato alla delibera 31/1 del 2006, veniva enunciata la sua presenza tra i progetti del documento strategico regionale del 2005 Sistema Regionale dei Musei. Piano di Razionalizza-zione e sviluppo; in realtà nel documento si faceva piuttosto riferimento al mu-seo regionale dedicato alla cultura fenicia, il quale, solo successivamente con il Documento di Condivisione del 9 marzo 2006, si configurerà e andrà a coincidere con la «rete museale del Golfo di Oristano», che dovrebbe raccogliere i musei e le aree archeologiche di Cabras, Santa Giusta e Oristano602. Pertanto è proprio il primo Atto integrativo all’APQ il documento nel quale viene menzionata, per la prima volta, la Rete museale dei Fenici.
Nell’autunno 2007, sebbene il progetto Rete museale dei Fenici non venga di fatto modificato dagli ulteriori atti integrativi all’APQ in materia di beni culturali della Sardegna, le Amministrazioni comunali coinvolte cominciano a lamentare – come ha modo di registrare anche la stampa locale – il ritardo nell’avvio della Rete e a temere che il progetto non venga attuato603.
Il 2 aprile 2008 la Regione Sardegna, la Provincia di Oristano e il Comune di Oristano stipulano un Protocollo d’Intesa per la realizzazione della Rete museale dei Fenici avente come centro il museo da allestire presso il torrione costiero di Torre Grande, un sobborgo marino nel territorio del Comune di Oristano604. È in quest’occasione che vengono destinati alla realizzazione di questa nuova struttura museale i 500 mila euro stanziati nel primo Atto integrativo al men-zionato APQ per i beni culturali605.
Stando al documento sottoscritto nella primavera del 2008, la Rete dei Fe-nici consiste ora nella creazione di un museo regionale multimediale presso Torre Grande, concepito come una «struttura di sintesi […] con la finalità di presentare un quadro della civiltà fenicia della Sardegna»; in altri termini il nuovo museo dovrà diventare il centro multimediale di un sistema regionale che virtualmente riunisce tutti i musei e gli scavi sardi che presentano attesta-zioni della civiltà fenicia606. Alla firma di tale Protocollo non parteciparono i Comuni di Cabras e Santa Giusta, coinvolti invece nel precedente Documento di Condivisione del marzo 2006 che prospettava un’organizzazione sistemica a
tocollo d’Intesa per la Realizzazione della Rete museale dei Fenici, cit.602 Sistema regionale dei Musei 2005 cit., Documento di Condivisione cit.603 V. pInna, Phoenix: «Dove sono finiti i soldi?», Al progetto la Regione aveva destinato 500
mila euro, «L’Unione Sarda», 30 settembre 2007.604 Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Oristano, Comune di Oristano, Pro-
tocollo d’Intesa per la Realizzazione della Rete museale dei Fenici, cit.605 Ivi.606 Ivi.
258
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
dimensione locale. I due Comuni decisero in un primo momento di proseguire comunque l’iter di attuazione della rete “locale” progettata con il Documento di condivisione del 2006, parallelamente e indipendentemente da quanto era stato elaborato nel 2008 con il Protocollo d’intesa tra Regione, Comune e Provincia di Oristano per la Rete dei Fenici.607 In realtà, però, già nell’estate del 2008 le stesse Amministrazioni comunali deliberarono la creazione di un’Associazione Tem-poranea di Scopo (ATS) con il Comune di Oristano e con l’Amministrazione provinciale608. Tale ATS era finalizzata all’elaborazione di un nuovo progetto Phoinix comprendente adesso tre realtà di fatto non ancora esistenti: il Parco Archeologico del Golfo dei Fenici, la Via dei Fenici e la Rete museale dei Fenici609. Il suddetto progetto, con la Provincia di Oristano come capofila, è stato redatto per essere presentato ad ARCUS «in relazione alle Iniziative prioritarie da pro-grammi ministeriali del Ministero per i Beni e le attività culturali»610.
Nello specifico il programma elaborato dalla ATS prevede la realizzazione di un Parco archeologico suddiviso in tre zone e comprendente siti insistenti sia sul territorio della Provincia di Oristano che di quella del Medio Campidano; il Centro del Parco è stato individuato nel Museo della Civiltà Fenicia, destinato a ospitare anche il corso di archeologia subacquea dell’Università di Sassari611. Il progetto della Via dei Fenici invece rimane sostanzialmente invariato rispetto al 2006612.
Nell’estate del 2008 la Regione ha provveduto a indire il bando regionale per l’appalto relativo all’allestimento e alla rifunzionalizzazione della struttura architettonica della Torre di Torre Grande, come sede del futuro Museo della Civiltà Fenicia in Sardegna e strumento ideale per attrarre il turismo balneare verso i siti archeologici e i musei del territorio interno613. Al momento della pubblicazione di tale gara la Torre apparteneva ancora al Demanio, tanto che la
607 Nota stampa sui lavori del Consiglio Provinciale di Oristano del 4 aprile 2008; Comu-nicato Stampa del Consiglio Provinciale di Oristano del 4 aprile 2008, consultabili sul sito della Provincia <http://www.provincia.or.it>.
608 DGC di Santa Giusta n. 116 del 6 agosto 2008, Partecipazione del Comune di Santa Giu-sta alla associazione temporanea di scopo (ATS) con la Provincia di Oristano, il Comune di Oristano e il Comune di Cabras per il progetto “Phoinix” concernente il Parco Archeologico del Golfo dei Fenici, la via dei fenici e la Rete museale dei fenici.
609 Ivi.610 Ivi.611 Ivi.612 Ivi.613 Bando di Gara per la “Procedura aperta avente a oggetto l’appalto concorso per la progettazio-
ne e la realizzazione della Rete museale dei Fenici”, consultabile sul sito web istituzionale della Regione Sardegna, all’indirizzo <http://www.regionesardegna.it>.
259
Schede dei sistemi sardi - C. Borgioli, G. Deligia
Regione nel bando specificava che, in caso di mancata acquisizione del bene, la procedura di gara sarebbe stata annullata614.
La Rete museale dei Fenici compare ancora alla fine del 2008 nel Piano regionale per i Beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura tra quelle realtà che andran-no a comporre il futuro Sistema Museale Regionale615. Nell’autunno del 2009 è stata comunicata la mancata aggiudicazione della gara per il concorso relativo alla progettazione del museo regionale616.
¬ 3. Conclusioni
Il progetto Rete museale dei Fenici, pur non essendo stato concretamente av-viato, presenta alcuni importanti spunti di riflessione per il contesto sardo. In primo luogo si tratta di un progetto elaborato dalla Regione che dovrebbe co-stituire, una volta realizzato, una rete di tipo tematico a estensione regionale e uno dei capisaldi del Sistema Museale Regionale, così come contemplato nel documento di indirizzo per il patrimonio museale elaborato dalla Regione nel 2005617.
Altro elemento di interesse si riscontra nel fatto che la Rete sarà formata dall’insieme delle principali testimonianze ascrivibili alla civiltà fenicia conser-vate su tutto il territorio regionale e troverà il suo centro in un museo “virtua-le”, il Museo della civiltà fenicia in Sardegna, cui spetterà il compito di illustrare e collegare, in maniera virtuale appunto, tali attestazioni. Il Museo dunque dovrà configurarsi come un “polo” regionale per la promozione della fruizione di tut-ti quei siti archeologici e quei musei ove si conservino reperti fenici e non solo, quindi, come una tradizionale raccolta di materiali tematicamente omogenei.
Il caso della Rete museale dei Fenici mostra altresì alcuni aspetti di criticità: se da un lato infatti emerge la vivacità degli Enti locali nell’elaborazione di speci-fici progetti di valorizzazione per il patrimonio culturale – nella fattispecie per le attestazioni fenice nel Golfo di Oristano – dall’altro si nota talvolta una certa difficoltà a far convergere istanze locali e volontà regionali, sebbene mirate ad un medesimo obiettivo.
Infine possiamo ipotizzare che un freno alla concretizzazione della Rete mu-seale – che necessiterebbe di cospicue risorse finanziarie per essere realizzata
614 Ivi.615 DGR n. 64/6 del 2008 cit.616 Avviso dell’Assessorato della Pubblica Istruzione pubblicato nel BURAS 33, parte
Terza, 10 novembre 2009.617 Sistema regionale dei Musei 2005 cit., Documento di Condivisione cit.
260
Prima parteSistemi museali in Sicilia e in Sardegna
– sia probabilmente imputabile alla mancata attuazione, nelle forme stabilite dalla legge regionale n. 14 del 20 settembre 2006, del Piano Regionale dei Beni Culturali, che ha sostanzialmente generato una situazione di stasi618.
618 LR n. 14 del 20 settembre 2006, Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura. L’art. 7 di questa norma stabilisce che il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, elaborato dalla Regione, debba essere approvato «dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, previo il pare-re obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare e nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione- Enti locali».