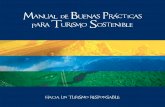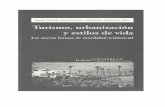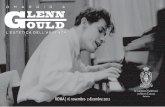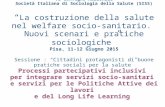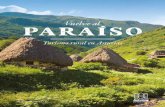La città del turismo. Processi e forme del turismo sulle coste della Sardegna
Transcript of La città del turismo. Processi e forme del turismo sulle coste della Sardegna
1
La città del turismo. Processi e forme del turi-smo sulle coste della Sardegna di Giuseppe Onni 1. La trasformazione del paesaggio attraverso il turismo: l’ideologia turistica
Lo spazio turistico contemporaneo si dimostra di difficile esplora-
zione e molto sfaccettato, si può anche affermare che esistano tanti “turismi” quanti turisti si indirizzano nelle varie destinazioni (Ber-nardi e Filippi, 2004): dal turismo di massa, legato allo spazio turisti-co moderno, che corrisponde alla visione delle forme turistiche dagli anni ’50 del secolo scorso in poi alle quali i sociologi del turismo (Boorstin, 1964; MacCannell, 2005[1976]) fanno corrispondere il tu-rismo moderno all’epoca dell’industrializzazione diffusa, da ciò di-scende una concezione del turismo come “industria”, al turismo po-stmoderno, tendente a configurarsi come mondo esaustivo, ambito ideale all’interno del quale vivere un concentrato di immagini e di icone turistiche e per questa ragione separato dal contesto, anche fisi-camente.
Il turismo in sostanza “strappa” elementi di territorio e li pone in condivisione nella rete dei flussi turistici, distaccando la città simula-cro dalla città reale; emerge quindi la necessità di riferirsi a modelli che possano descrivere in qualche modo la complessità del fenomeno turistico e i processi connessi.
Lo stato dell’arte mostra da un lato una sorta di esplosione dello spazio turistico, con l’acquisizione di territori sempre nuovi (van der
2
Duim e Caalders, 2002; Minca, 1996a; Minca, 1996b; La Rocca, 2005) e sempre più vasti, dall’altro una vera e propria implosione dello spazio turistico, con la concentrazione all’interno di ambiti chiusi o semichiusi di una serie di immagini e di paesaggi turistici puri, stilizzati, figli delle mappe mentali che muovono i mercati della vacanza internazionale (Augè, 1993; Minca, 1996b; Kellner, 1991; Harvey, 1993; Nuryanti, 1996).
La Sardegna, in merito, è un campo di studio privilegiato: le sue coste nel corso degli ultimi cinquanta anni hanno visto la realizza-zione di tutta una serie di insediamenti legati in vario modo alle for-me turistiche. Gli spazi turisti sardi sono quasi esclusivamente costie-ri; nonostante il fatto che negli ultimi anni molto sia stato fatto per spostare il baricentro dell’offerta verso le aree più interne, la doman-da turistica si rivolge quasi solo alla linea di costa.
Questa attenzione ha avuto origine negli anni ’60 dello scorso se-colo ed ha modificato in modo sostanziale la struttura dell’insediamento in Sardegna e il peso relativo delle diverse parti nella rete urbana, con un enorme incremento dell’insediamento lungo la costa piuttosto che nell’interno. L’evoluzione degli insediamenti ha realizzato quella che possiamo chiamare una “città del turismo”, discontinua nelle forme tradizionali, talvolta villaggi non pianificati, talvolta enclaves turistiche.
Il paesaggio della città turistica cede alla ragion estetica, si nutre di immagini stereotipate create sia dalle società locali che dai tour operators operanti nell’organizzazione, o riorganizzazione, degli spa-zi turistici e dei relativi flussi.
La separazione fisica e funzionale tra turista e società locale non rende possibile l’integrazione della città turistica con i contesti locali, dei turisti con le popolazioni e i territori che le ospitano. Gregotti (1990) definisce “a-topici” quegli insediamenti chiusi in sé, privi di relazione col contesto e facenti parte di sistemi a rete con altri simili. Sono, per esempio, la caratteristica dei villaggi turistici, enclaves a-stratte dai territori che le ospitano, isole di perfetta efficienza che creano pesanti divaricazioni con le realtà locali e inducono l’indifferenza al contesto da parte degli ospiti (dei veri ospiti distratti da tutto quello che li circonda). Quello che prevale non è tanto il pia-cere dell’esplorare, quanto quello di ritrovarsi in un ambiente noto e privo di ogni sorpresa.
3
L’isolamento artificiale dal contesto reale e le immagini predispo-ste per i turisti può condurre a spazi turistici “puri”, che generano da un lato segregazione rispetto ai caratteri della società locale, e, d’altro lato, assicurano la maggior distanza possibile, non solo fisica, tra i luoghi ospitanti e i desideri che possono essere soddisfatti da un’esperienza turistica. Gli spazi turistici hanno così l’apparenza di città in miniatura, alla moda, e conferiscono uno status sociale a chi li utilizza. È possibile notare che anche in queste città turistiche si re-alizzano processi di gentrificazione simili a quelli che avvengono nelle città compatte.
Può sembrare paradossale, ma si tratta piuttosto delle due facce della stessa medaglia: la ricerca del nuovo, o dell’esotico se si vuole usare un termine in voga presso i tour operator, offre esperienze turi-stiche preconcette e prevedibili, mentre la ricerca dell’autenticità dei luoghi rischia di far vivere al turista, e talvolta anche alle popolazioni ospitanti, solo delle rappresentazioni artificiose del passato, sia nel campo della vita sociale che in quello architettonico.
Il processo di evoluzione del fenomeno turistico nel corso degli anni ha inoltre posto sempre, in modo esclusivo, l’accento sulle ca-ratteristiche delle risorsa ricettiva piuttosto che sui luoghi e sui terri-tori. Quando il discorso si è spostato, col trascorrere del tempo, an-che sui territori, si è cercato di dare risalto all’etnocentricità degli stessi reiterando forme e modelli.
Per questo motivo il turista si rapporta con immagini dei luoghi più che con i luoghi stessi, e le immagini dei luoghi sono, general-mente, sempre le medesime, infatti il quadro complessivo degli spazi turistici è fittile, ovvero le strutture legate all’accoglienza, la stessa città turistica nel senso esteso del termine, si realizza con un’ottica temporalmente molto ridotta, quanto interessa ha un orizzonte tem-porale molto ravvicinato. Le politiche, quindi, rispondono appieno ai caratteri di quella che potrebbe essere considerata un’ideologia che propone il territorio in forma simbolica, ripescando degli archetipi e proponendoli ai flussi turistici, spesso con pochissime elaborazioni1.
1 Avviene un fenomeno molto noto: elementi di identità, tradizioni spesso amate e difese
dalla popolazione, diventano “folclorismo”, cioè oggetti ed eventi sottoposti alle leggi di mercato (quando, dove, come, durata, ecc.).
4
Da quanto esaminato pare si possa desumere una comune e perse-verante visione del territorio come oggetto di politiche turistiche po-co lungimiranti, ma soprattutto indirizzate alla creazione di spazi straordinari, arelazionali e temporalmente circoscritti.
Spazi straordinari e arelazionali in quanto realizzano immagini a-territoriali evocative, attraverso le quali il turista giunge a conoscere solo superficialmente le società locali ospitanti, formando e disfa-cendo relazioni aleatorie costruite su istanti di confronto generalmen-te eterodiretti, confrontandosi con dei simulacri del territorio e non con il territorio stesso.
Il fattore temporale merita tuttavia un ulteriore attenzione. Il tem-po è una delle variabili che meno sono tenute in considerazione dai “professionisti del turismo”, i luoghi sono visti come immobili nel tempo, come se fossero immuni dagli effetti che i flussi turistici pro-ducono sul territorio.
Le politiche turistiche sono sempre state rivolte prettamente alla ricettività e non, piuttosto come avrebbe dovuto essere, ad una com-pleta pianificazione del sistema. Il fatto che lo scopo delle politiche turistiche fosse migliorare la qualità della ricettività e che l’ottica temporale dei soggetti addetti alla guida delle forme turistiche fosse ridotta, ha condotto a politiche rivolte essenzialmente agli oggetti se-de di turismo, quali alberghi, resort, B&B eccetera, senza considerare in alcun modo le ricadute sul territorio.
È allora utile tentare di rappresentare il percorso turistico della Sardegna attraverso una modellizzazione.
5
Figura 1: il percorso dell'ideologia turistica La figura rappresenta in modo semplice le divergenze temporali
dei caratteri della città turistica attraverso l’ideologia turistica. Dal grafo emerge la continua generazione di nuove forme, anche
attraverso la reinterpretazione di quelle già esistenti, ma non emerge
6
in alcun modo quali effetti questo continuo e sfaccettato sviluppo del percorso abbia avuto sul territorio.
Si manifesta però un importante fattore: il concomitante sviluppo della Costa Smeralda, dei villaggi turistici e delle borgate costiere. La nascita del Consorzio Costa Smeralda ha influenzato, e molto, lo sviluppo delle politiche turistiche tanto da ispirare nuove forme an-che in villaggi turistici preesistenti, così come ha influenzato lo svi-luppo degli insediamenti costieri, anch’essi in parte preesistenti (Ser-reli, 2004). Tutti e tre i casi, in parallelo, hanno condotto a un robusto intervento di costruzione, quasi esclusivamente lungo le coste; con effetti non troppo differenti tra loro.
Nei villaggi turistici e, soprattutto, nella Costa Smeralda, però, si è realizzata la costruzione di una Sardegna esotica ed immaginaria, metonimica, destinata ad un turismo nazionale ed internazionale, ma comunque contenuta entro dei limiti spaziali e con un occhio di ri-guardo al contesto territoriale; viceversa nelle borgate marine, cre-sciute senza una pianificazione urbana coerente, simulacri esse stesse del simulacro Costa Smeralda, la qualità del contesto non è stata os-servata ed è stata delegata alla sensibilità dei singoli.
Secondo Aristotele l’uomo ha la tendenza a costituirsi in comunità (Zucca, 2006), tuttavia i villaggi turistici e le borgate marine rara-mente possono dirsi tali, in quanto sottoposti a flussi stagionali. Così il paesaggio costiero della Sardegna, nel tempo, ha visto lo sviluppo di due processi quasi antitetici, e talvolta non privi di antagonismo, tra loro: da un lato si ha una forma ricettiva offerta ad utenti esterni all’isola ed esclusiva nei costi e nelle modalità di accoglienza; dall’altro si è avuto un accrescimento di località destinate quasi e-sclusivamente agli abitanti locali provenienti dai centri abitati, grandi e piccoli, limitrofi. Residenze esclusive contro seconde case, per cir-ca trent’anni, dagli anni sessanta agli anni novanta del secolo scorso, questa è stata la politica turistica prevalente, anche con episodi di gentrificazione.
Esempio di questo è il caso del villaggio turistico I Grandi Viaggi Santa Giusta, situato sulla costa sud orientale della Sardegna, nel ter-ritorio del Comune di Castiadas.
Il villaggio Santa Giusta rientra perfettamente nei canoni della proposta turistica indirizzata a far assaporare al turista le peculiarità
7
locali. La campagna pubblicitaria sul sito web2 dell’azienda proprie-taria del villaggio descrive l’area con “cottage dai caldi colori medi-terranei, perfettamente inseriti nello scenario naturale” e, come dice il sito “L’architettura del club è tipicamente mediterranea, con forme e colori che si accordano magnificamente con l’ambiente che lo cir-conda”. Il club è situato in “un’ampia zona protetta con ginepri se-colari e gigli selvatici” che “fa da cornice alla splendida baia che si affaccia su un mare dall’acqua limpida e cristallina”. Il villaggio si è inoltre dotato di una propria politica ambientale che intende: “rispet-tare scrupolosamente le leggi e la normativa ambientale applicabile … integrare il villaggio e le sue attività nella natura circostante, con particolare attenzione agli aspetti paesaggistici, arrecando il minimo disturbo alla flora e alla fauna locali, e privilegiando la crescita di es-senze arboree autoctone; sensibilizzare i propri clienti sulle tematiche ambientali e orientarli a mettere in atto comportamenti corretti dal punto di vista ambientale; mantenere rapporti corretti e collaborativi con la comunità e le istituzioni locali; definire obiettivi e programmi ambientali in attuazione degli impegni assunti con questa politica; …comunicare la presente politica a tutte le persone che lavorano per il club o per conto di esso; mettere a disposizione del pubblico e di chiunque ne faccia richiesta la presente politica”.
La strategia di marketing è prettamente indirizzata alle peculiarità del sito ed alla bellezza dell’ambiente nel quale il resort è inserito, in realtà lo stesso villaggio, realizzato tra la fine del secolo scorso e i primi anni di questo secolo, si configura come un corpo chiuso ri-spetto al territorio e l’unica apertura è rivolta alle spiagge che risulta-no essere l’unico oggetto dell’interesse del turista.
Si realizza la costruzione di un mondo idilliaco, quale stereotipo di piccolo mondo perfetto e pacificato all’interno di una cinta murata. I cottage perfettamente inseriti nello scenario naturale tali non sono, del resto l’architettura degli stessi si richiama non a forme tradiziona-li ma riproduce un impianto simile a quello dei Club Mediterranée, di stampo urbano, connotato in modo essenziale dal tema del “recinto”.
L’attenzione per l’ecologia – sia essa reale o presunta – è conside-rata dall’azienda un punto di forza per l’immagine della località turi-stica, mentre invece, e soprattutto in ragione del carico antropico che
2 http://www.igrandiviaggi.it/scheda.php?id=22
8
concentra migliaia di ospiti in poco più di poche centinaia di metri quadrati di spiaggia, si presentano forti interferenze con i processi ambientali, con allontanamento delle sabbie dal litorale e diradamen-to del ginepreto come conseguenza del calpestio o della voglia del “souvenir” della località di vacanza, che richiameranno alla mente del turista, al ritorno del periodo del riposo, i paesaggi visitati dentro una bottiglia colma di sabbia oppure in un ramo contorto.
Figura 2_il processo di espansione del Resort Santa Giusta Le immagini di fig. 2 riproducono il processo di espansione del
resort sui luoghi e, contemporaneamente, i processi di erosione in at-to lungo la linea del litorale. Dal 1977 al 2008 si assiste ad una co-piosa riduzione della prateria di posidonia e ad una equivalente ridu-zione del ginepreto prospiciente la spiaggia. In più si nota il processo di appropriazione dei luoghi, sempre crescente. E di particolare inte-resse, inoltre, è anche il rapporto che intercorre tra chi fruisce i luo-
9
ghi prossimi al villaggio e chi invece quei luoghi li conosce o li vive da molto più tempo.
Dal momento della sua realizzazione il rapporto tra il villaggio e il territorio mostra molte criticità, un vero e proprio conflitto con chi usualmente fruiva i luoghi. Si è impostato, nel corso degli anni un vero processo di gentrificazione nei confronti della società locale a dispetto di chi risiede nel resort, in quanto le aree di litorale, pur es-sendo ovviamente liberamente fruibili, sono gestite come se fossero oggetto di concessione per cui non sono ammessi fruitori che non siamo gli ospiti del resort. Si svela un senso di appropriazione dei luoghi da parte di pochi fruitori temporanei – i tempi di permanenza nel villaggio raramente superano la settimana – che genera seri pro-blemi di relazione. Il paesaggio diviene privato e la forma turistica esclusiva in quanto tende effettivamente a privare spazi ad altri.
Se si volessero analizzare gli effetti di questo processo si rende-rebbe necessario ragionare ponendosi alla giusta distanza, e esplorare gli effetti delle forme turistiche, astraendosi dall’ideologia turistica per comprendere meglio le conseguenze di quelle politiche sul terri-torio.
Questa astrazione si rivela con una lettura a distanza degli effetti stessi, in modo da non concentrarsi esclusivamente sui dettagli e sul-le forme degli oggetti turistici, ma capire meglio i rapporti, i modelli generati, le forme generate sul territorio.
I principi di generazione delle forme turistiche indotti dall’ideologia turistica hanno condotto, come esplorato in preceden-za, a ragionare esclusivamente sulle forme puntuali, sugli oggetti tu-ristici piuttosto che sul complesso delle stesse. La distanza critica corretta da quale osservare i processi del turismo sul territorio (Mo-retti, 2005), deve essere, prima di tutto spaziale, proprio per non in-correre nell’errore di porre attenzione esclusivamente agli oggetti del turismo, siano essi legati alla ricezione o alle risorse delle quali il tu-rismo si nutre. Ma, come già affermato, la distanza deve essere anche temporale. Il tempo è una variabile rilevante, contrariamente a come lo si pensi nella gestione delle politiche turistiche, e come tale deve essere trattato, curando di ragionare sui contesti nei quali i processi turistici avvengono, nel tempo, anche con velocità diverse tra loro.
Osservare l’evoluzione del turismo in Sardegna dalla “giusta di-stanza” permette di mettere in evidenza alcune questioni sui quali ci
10
si è già soffermati, come la realizzazione di spazi straordinari e spe-cializzati, destinati solo a dei flussi periodici di uso, una reiterazione non contestuale di forme architettoniche e di modelli di organizza-zione del territorio, sia nelle gated communities costiere destinate ai flussi internazionali che, in modo ancor più banale, nelle borgate co-stiere; vissute da chi il territorio lo abita durante tutto l’anno, in ri-chiamo alle forme invalse nel turismo d’élite e, infine, la ricerca del folclorico ad ogni costo, trascurando la storia dei territori ospitanti ma mettendo in scena solo un’icona (mercantile) degli stessi.
Lozato-Giotart (2008) definisce gli spazi turistici regionali quelli nei quali si presenta una forma di presenza turistica forte. Il concetto di regione turistica verte sul tasso di funzione alberghiera, cioè il numero dei posti letto in albergo diviso la popolazione totale per 100, che consente di comprendere quando in un’area particolare riceve un dato numero significativo di turisti.
Ma lo stesso autore riflette sul fatto che la dominanza di un’attività non manifesta sempre la variabilità dell’intensità turistica all’interno di uno spazio regionale, in quanto una regione turistica sembrerebbe definirsi a partire dal momento in cui l’organizzazione della struttura generale del territorio e dei beni e dei servizi disponi-bili sul territorio, è totalmente, o in parte, destinata all’uso turistico. Tra regioni turistiche definite sono facilmente individuabili tipologie di regioni o spazi turistici regionali con delimitazioni sfumate. La re-gione turistica, afferma infine l’autore, è dunque uno spazio funzio-nale la cui immagine deriva da un insieme naturale e umano più o meno omogeneo e continuo.
L’evoluzione delle forme turistiche in Sardegna, secondo i prece-denti criteri, offre la visione di scenari urbani diffusi in quanto spazi regionali poco polarizzati, infatti nonostante si abbiano grandi flussi di turisti ogni anno il numero di stazioni o di centri turistici risulta re-lativamente basso.
Si è già osservato che il turismo in Sardegna ha interessato in mo-do quasi selettivo le coste, ma in tempi più recenti, tuttavia, sembra maturare un interesse anche per l’interno. Il bacino di accoglienza è in fase di mutamento, il centro dell’attenzione non è più solo l’area specializzata costiera, luogo straordinario, bisogna dirlo, dove spen-dere il proprio tempo ha una forte attrattiva, ma sempre più ci si ri-
11
volge verso aree “periferiche” più interne, meno specializzate all’accoglienza, luoghi della vita ordinaria.
Si può intendere allora una metafora per rappresentare il processo in atto, attraverso la definizione di territori turistici diffusi, ognuno con le proprie caratteristiche, certo, non paragonabili alla “megalopo-li” turistica della costa catalana, ma si avverte comunque la tensione alla litoralizzazione degli spazi turistici. Non una città lineare, di cer-to, ma comunque si tende ad occupare gli spazi residui con nuovi in-sediamenti. Il tutto è ovviamente il frutto della monocultura (o ideo-logia) turistica che vede in vincolo stretto il turismo e l’attività im-mobiliare, senza considerare la necessità di spazi maggiormente compiuti in senso urbano, non più dei vuoti da occupare stagional-mente ma spazi pubblici, non necessariamente edificati.
L’attitudine postmoderna del risiedere in più luoghi, sia nella città dove si svolge la propria quotidianità, sia nei luoghi destinati al ripo-so e allo svago, conduce ad una “respirazione” degli spazi turistici, con periodi di inspirazione, nei mesi estivi quando il carico turistico è più elevato, e di espirazione nei mesi invernali. Quanto ne conse-gue è uno spazio dicotomico, fragile, che non ha realmente una di-mensione urbana se non per pochi giorni all’anno. La città turistica, quindi, esiste solo alcuni mesi l’anno.
In sintesi conclusiva è possibile affermare che i principi fondativi dell’ideologia turistica hanno sempre indirizzato le politiche turisti-che verso la ricettività e non, piuttosto, come avrebbe dovuto essere, ad una completa pianificazione del sistema di accoglienza per poter-ne utilizzare le diverse valenze che un determinato territorio offriva (natura, storia, cultura, ecc.). Il fatto che, in contemporanea, lo scopo delle politiche turistiche fosse migliorare la qualità della ricettività e che l’ottica temporale dei soggetti addetti alla guida delle forme turi-stiche fosse ridotta, ha condotto a politiche rivolte essenzialmente a-gli oggetti sede di turismo, quali alberghi, resort, B&B, campeggi, eccetera, senza considerare in alcun modo le ricadute sul territorio. Si potrebbe tradurre tale filosofia con una specie di motto “senza letto non c’è turismo”, che è vero, ma che si sarebbe dovuto accompagna-re ad un’altra affermazione “la realtà locale, in tutti i suoi aspetti de-ve essere l’oggetto del desiderio del turista”.
2. Evoluzione della “città turistica” in Sardegna
12
Il processo di evoluzione del turismo, in Sardegna, è stato diffe-rente per modi e luoghi, ma anche per scelte politiche. Modi e luoghi in funzione delle tipologie di insediamento, scelte politiche per la lo-calizzazione delle strutture turistiche.
L’insediamento turistico ha avuto tempi, forme e modelli diversi (Boggio 1978, Brandis e Scanu 2001, Mazzette 2002, Usai e Cao 2002, Usai e Paci 2002, Serreli 2004, Bandinu 2006, Sistu 2008) a seconda del periodo storico. I luoghi del turismo non possiedono confini definiti, appaiono permeabili o impermeabili a seconda dell’uso specifico, sia esso destinato ai residenti o ai “forestieri” (Price, 1983), non si individuano dei centri riconosciuti come storici e la loro trama urbana si presenta frammentata piuttosto che concen-trata, questo in ragione della funzione specifica di ciascuno.
I modelli urbani richiamano quindi due diversi modi di fruire le ri-sorse turistiche, di utilizzo dei servizi, in sostanza due modelli urbani profondamente differenti. I centri destinati ai residenti locali, si ha una prevalenza di seconde case o piccoli alberghi; nelle strutture de-stinate ai turisti non locali si hanno sistemi direttamente riconducibili a enclaves turistiche, recinti per turisti, prevalentemente villaggi va-canze o grandi alberghi, fisicamente separati dal contesto.
In effetti un vero e proprio insediamento turistico non si è avuto se non dal 1962 in poi, data di realizzazione della Costa Smeralda. Ed è un turismo realizzato da un imprenditore privato, l’Aga Khan Karim, mentre in precedenza l’esperienza turistica fu diretta dalla Regione Sardegna, negli anni precedenti al Piano di Rinascita, come un’industria e attraverso la legge regionale n. 62 del 22 novembre 1950 si costituì l'Ente Sardo Industrie Turistiche, in seguito noto sempre come ESIT.
Prima degli anni ’50, in effetti, non è corretto parlare di turismo in Sardegna nel senso pieno del termine, ma di villeggiatura; difatti, co-erentemente con le mode dei primi anni del secolo, inaugurati dall’aristocrazia inglese, ci si spostava per i “bagni al mare”, autoco-struendo ombreggi e ripari stagionali oppure ci si recava in alta colli-na o montagna, anche in case d’amici, alla ricerca di maggiore salu-brità, assente in certe parti dell’isola particolarmente malariche.
È il caso, per esempio del Poetto, località balneare di Cagliari, e-stesa quasi otto chilometri e sorta agli inizi del ‘900. Dai primi stabi-limenti balneari nel secondo dopoguerra, ad imitazione delle cabine
13
per bagnanti, sorsero i cosiddetti casotti, veri e propri edifici utilizza-bili come seconda residenza oltre che come spogliatoio, costruiti proprio lungo la spiaggia (fig. 3). Il 1986 segna la fine dei casotti, in-fatti quando scadde la concessione di 99 anni del Demanio Marittimo le strutture furono abbattute, per motivi sanitari, dalla Capitaneria di Porto su ordine del Ministero della Marina Mercantile.
Figura 3_I casotti del Poetto Le forme turistiche proposte dall’ESIT fanno quindi riferimento
alle abitudini invalse nella popolazione sarda a recarsi in villeggiatu-ra in località con caratteristiche simili a quanto detto, ovvero come definite in un’espressione invalsa dal dopoguerra ad oggi e partico-larmente apprezzata nel linguaggio di chi costruisce, genera e propo-ne le politiche turistiche, “vocate al turismo”.
È, in sostanza, la genesi di un turismo alberghiero, mirato a valo-rizzare località di particolare pregio ambientale o storico, sia sul ma-re che in montagna3. L’obiettivo specifico dell’ESIT è distribuire le
3 Dall’art. 2 L.R. 62/1950: L' Ente Sardo Industrie Turistiche ha il compito promuovere
ed attuare iniziative dirette allo sviluppo delle attività turistiche in Sardegna; diffondere la
14
strutture alberghiere all’interno del territorio, soprattutto nel settore settentrionale4.
Il contesto turistico ha avuto un processo di formazione del pro-prio paesaggio in modo diverso a seconda, innanzitutto, della tipolo-gia di turista a cui la forma turistica era indirizzata (Price, 1983). La distinzione tra la tipologia di vacanza del turista proveniente dal “continente” e quella della popolazione residente, nella reciproca dif-ferenza, ha influito pesantemente sugli insediamenti litoranei, in quanto quelli destinati al turista appaiono generalmente ben pianifi-cati, con tutti i servizi necessari e ben localizzati rispetto ai principali porti d’arrivo in Sardegna, mentre gli insediamenti destinati alla so-cietà locale sono stati, in genere, soggetti ad agglomerazioni non pia-nificate di abitazioni, prive addirittura all’inizio dei servizi più ele-mentari quali impianti idrici ed elettrici.
Quindi la prima e fondamentale dicotomia è stata proprio la diffe-renziazione delle scelte che, conseguentemente, ha influito in modo sostanziale anche sui paesaggi turistici: i turisti non provenienti della Sardegna hanno scelto, sin dall’inizio complessi alberghieri e villaggi turistici mentre i turisti provenienti dalla Sardegna hanno indirizzato le loro vacanze verso i centri costieri o in luoghi di soggiorno tempo-raneo (abitazioni anche provvisorie e poi nel tempo stabilizzatesi). La città turistica, essenzialmente costiera, risulta avere così due a-spetti peculiari nei quali le proprietà definibili di centralità sono sono rappresentate, da una parte, dai resort e dalle strutture alberghiere in genere, definite spesso “di qualità” ed “esclusive” e, proprio in ra-gione di questa terminologia, operano la separazione fisica del turista
conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche dell'Isola; incoraggiare le iniziative private, favorendone il consorzio e la mutualità; istituire premi per stimolare iniziative di carattere igienico - sanitario, artistico e di altra specie; promuovere la istituzione di corsi o scuole e la costituzione e lo sviluppo di organizzazioni professionali nell'interesse del turismo; racco-gliere notizie ed informazioni relative al turismo regionale, nazionale ed internazionale; stu-diare e proporre al Governo Regionale provvedimenti diretti ad incrementare le attività turi-stiche nell'Isola con particolare riguardo al movimento dei forestieri.
4 Già nei primi anni ’60 fu costruita la rete dei cosiddetti Alberghi Esit (11 nel comples-so) in alcune località riconosciute di rilievo dal punto di vista turistico, tra le quali: San Leo-nardo (Santu Lussurgiu), Grande Hotel (Alghero), La Spendula (Villacidro), Il Gabbiano (La Maddalena), Miramonti (Tempio), Miramare (Santa Teresa di Gallura), “Albergo Esit” a Nuoro (sul Monte Ortobene). Fonte: L’Italia in automobile, Sardegna , Touring Club Italia-no, 1963
15
dal contesto sociale; dall’altra parte, vere e proprie enclaves a-territoriali; le caratteristiche di perifericità sono invece attribuibili a-gli insediamenti costieri, spesso soprattutto di seconde case (Cappai et al. 2012), poco attente alla qualità del paesaggio.
In sostanza è possibile attribuire alla “città turistica”, due modalità diverse di usare il paesaggio e di confrontarsi e relazionarsi con le società locali.
Il paesaggio costiero sardo possedeva nel 1951 sessanta insedia-menti, di questi solo ventidue erano esclusivamente dedicati all’ospitalità dei villeggianti durante i mesi estivi. Dal 1951 al 1961, conseguentemente alla crescita economica nazionale, sorsero venti nuovi insediamenti destinati soprattutto a seconde case, ma nessuno di questi offriva in realtà ospitalità in termini di turismo alberghiero. La realtà turistica degli anni cinquanta è quindi orientata soprattutto a dare alloggio in seconde case ai residenti nell’isola piuttosto che ad una vera e propria offerta turistica extra-regionale, l’unica città che dia un’offerta turistica precisa è Alghero con i suoi alberghi (tra i quali il Miramare, albergo realizzato dall’ESIT); è pur vero che in Sardegna non esisteva una vera e propria domanda turistica, essa si è sviluppata solo in seguito, all’inizio degli anni ‘60.
Si può stabilire, quindi, che l’origine del turismo in Sardegna, no-nostante esistessero già dalla fine della seconda guerra mondiale i complessi alberghieri dell’ESIT, si ha con la realizzazione del Con-sorzio Costa Smeralda, avvenuta nel 1962. Le forme turistiche pre-cedenti, legate al più alla “villeggiatura” nei paesi dell’interno presso case private o casotti lungo la costa, divengono superate con la crea-zione della Costa Smeralda e il concetto di vacanza e di turismo as-sume un nuovo significato.
L’importanza della realizzazione della Costa Smeralda travalica il contesto locale in senso stretto: infatti l’impostazione completamente differente ha fatto si che nuovi modelli si ingenerassero sul territorio, soprattutto su quello costiero. Spinti dall’esempio, per così dire, della Costa Smeralda, dal 1962 al 1971, sorgono ventidue nuovi centri di soggiorno estivo e diciassette località destinate ai “forestieri”, le pre-esistenti si accrescono, costituite essenzialmente da seconde case lun-go alcune aree quali la costa della provincia di Oristano, soprattutto di Cuglieri e San Vero Milis, con la realizzazione delle borgate di Santa Caterina di Pittinuri, S’Archittu, Torre del Pozzo, Putzu Idu,
16
Mandriola, Sa Rocca Tunda, Sa Marigosa, Su Pallosu, S’Anea Scoa-da; lungo la costa sud orientale della Sardegna, con l’espansione di Villasimius, la creazione di villaggi quali Marina di Capitana, Mari Pintau, Kala'e Moru, Geremeas, Baccumandara, Torre delle Stelle, Solanas e, sulla costa orientale, Costa Rei. Tutti insediamenti caratte-rizzati da un diffuso degrado urbanistico ed edilizio dovuto ad uno sviluppo, fino alla metà degli anni ‘70, sostanzialmente spontaneo a causa dell’assenza di strumenti urbanistici approvati. La fig. 4 mo-stra, in sintesi, tutti gli insediamenti litoranei sorti in Sardegna dopo il 1962, permettendo di avere un’idea di quale sia stato il processo di litoralizzazione del turismo. Nessuno di questi insediamenti preesi-steva prima della nascita della Costa Smeralda.
18
Sulla costruzione nella costa molto ha influito la normativa nazio-nale attraverso la cosiddetta "legge ponte” (n. 765 del 6 agosto 1967), definita da Barp (1977) il “secondo ciclo edilizio”, che ha riguardato l’Italia meridionale e insulare negli anni ’70. Le norme di tale legge, infatti, mentre sfavorirono l’espansione urbana nell’area agricola, hanno avuto un’influenza espansiva nelle aree costiere (fossero esse già urbanizzate o meno), dove si sviluppò una forte attività edilizia (Madau, 2009). Proprio in conseguenza di questa legislazione, nell’isola, dal 1972 al 1977 si realizzarono altri trentatré villaggi, co-struiti essenzialmente da imprenditori non locali, ricalcando i modelli realizzati nel decennio precedente.
Il processo di realizzazione di villaggi definiti “turistici” è prose-guito durante gli anni ’80 lungo la costa di Arbus e la costa sud occi-dentale; durante gli anni ’90 l’espansione ha interessato il nord, ad esempio il Bagaglino a Stintino, e la costa orientale, come Porto Co-rallo a Villaputzu.
Il periodo storico tra gli anni ’80 e ’90 è molto importante, due leggi, una nazionale e una regionale, mutano in parte l’approccio al contesto. La legge nazionale, detta Galasso (n. 435 del 08.08.1985)5, che introduce per la prima vola la tutela dei beni naturalistici ed am-bientali in Italia; la legge regionale è la n. 45 del 22.12.19896, ovvero la prima legge urbanistica della Sardegna. Con la prima, attraverso l’introduzione di nuovi vincoli, si ingenera una novità sostanziale nell’uso degli spazi, soprattutto litoranei, col divieto di edificare en-tro i 300 m dalla battigia, con la seconda vengono definite in modo più preciso le zone urbanistiche nelle quali si può “fare turismo”, le cosiddette zone F. Iniziano così a mutare gli usi degli spazi ma, ed in modo ancora più importante, i gusti dei turisti, che si frammentano in modo sempre maggiore e, conseguentemente, crescono anche le de-stinazioni. Accade, come già rilevato, che il turismo si sposta anche verso l’interno dell’isola, in misura diseguale ma importante.
Così, negli ultimi dieci-quindici anni del secolo scorso, nasce l’agri-turismo che riveste particolare importanza anche in ragione dei
5 Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso). Conversione in legge con modificazioni del
decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zo-ne di particolare interesse ambientale.
6 Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 Norme per l'uso e la tutela del territorio re-gionale
19
suoi mutamenti di scopo. Difatti in origine, soprattutto alla metà de-gli anni ’90, era riposta molta aspettativa in questa nuova forma di ricezione, si riteneva che potesse condurre ad una conoscenza più approfondita della realtà agricola locale e dei contesti territoriali del-le aree più interne ma, nel tempo, vi è stato un progressivo abbando-no dell’attività di turismo recettivo ed una crescente trasformazione, fatte salve alcune eccezioni, delle strutture in ristoranti nell’agro al “servizio” dell’escursionismo più che del turismo.
A partire dal 2000 i bed and breakfast (B&B) e gli alberghi diffusi hanno rappresentato l’ultima frontiera nell’immaginario turistico lo-cale. I primi nascono da una modificazione di due differenti tipolo-gie, le pensioni (luogo della villeggiatura negli anni ’50) e le seconde case date in affitto per brevi periodi. Lo sviluppo dei B&B è tuttora in corso, con valori in crescita soprattutto nelle città costiere, Alghe-ro in testa a tutte (Cannaos e Onni 2012), e con valori significativi nei centri dell’interno. Nei comuni interni all’isola, in particolare nei loro centri storici, in ragione della presenza di molti edifici dismessi, vengono realizzati diversi alberghi diffusi (Onni 2009), cioè alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ri-cevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante ed an-nessa cucina e dalla dislocazione delle stanze in uno o più stabili se-parati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e di-stanti non oltre 200 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali.
E’ dunque evidente come le politiche turistiche della Sardegna negli ultimi anni siano rivolte essenzialmente al settore ricettivo, av-vallando modelli ripetibili quali bed and breakfast, alberghi tout court, residenze turistiche, alberghi diffusi, eccetera.
In Sardegna si possono osservare diversi di questi spazi, che con-siderati come sistemi generano città turistiche, ognuno con una pro-pria forma, densità, architetture, distribuzione delle funzioni e dota-zione di servizi.
3. La città turistica. Casi di studio
La città turistica si presenta dunque con aspetti differenti, partico-lari, che possono variare in relazione alla posizione geografica oppu-re, ed in modo più importante, a seconda delle popolazioni che la abitano, siano esse popolazioni residenti o popolazioni turistiche. Il
20
contesto attuale della città turistica necessita, quindi, di essere analiz-zato ragionando su alcuni casi di studio, ritenuti utili per far emerge-re le principali differenze e peculiarità.
I tre casi di studio scelti indagano tre aspetti della città turistica: quella destinata in modo quasi esclusivo ai turisti non sardi, quella nella quale convivono turisti locali e non e quella destinata in modo quasi esclusivo alla società locale sarda.
I tre casi scelti sono: Porto Cervo per il fatto di essere stato il pri-mo luogo turistico in senso stretto; Stintino in quanto nella penisola di cui fa parte vi sono insediamenti di natura differente e relativi a differenti popolazioni; Sa Rocca Tunda nella marina di San Vero Mi-lis un insediamento realizzato solo con lo scopo di dare una seconda residenza alla popolazione locale.
21
3.1 Porto Cervo
Figura 5_il contesto territoriale di Porto Cervo Porto Cervo è l’insediamento turistico per antonomasia della Co-
sta Smeralda. Situato nella regione storica della Gallura, nel setten-trione della Sardegna, è frazione del Comune di Arzachena. L’insediamento, come città di fondazione, nasce dopo l’istituzione del Consorzio Costa Smeralda, nel 1962, ed è oggi sede di diverse attività turistico-alberghiere, residenziali e commerciali.
È interessante visionare quale fosse il territorio ove è situato l’insediamento negli anni ’50, come bene lo rappresenta l’immagine del 1954. Il territorio, noto alla popolazione locale come Monti di mola, era totalmente inedificato sino agli anni ’60 allorquando il principe ismailita Karim Aga Khan, con altri imprenditori, acquistò e realizzò la prima vera località turistica in Sardegna.
Figura 6_Porto Cervo 1954
22
Nell’immaginario locale ed internazionale la Costa Smeralda, con Porto Cervo in testa, assume il ruolo di località privilegiata del jet set internazionale. Tutti i luoghi del turismo in Sardegna, da quel mo-mento, ne furono potentemente influenzati. Una influenza che spinge tutta la città turistica della costa sarda a nascere ad imitazione della Costa Smeralda, se ne perseguono le fogge, in modi più o meno coe-renti, sia in prossimità alla Costa Smeralda Stessa sia in altri siti. Il Consorzio Costa Smeralda, proprio per questa “smeraldizzazione” del territorio, è addirittura costretto a tutelarsi, infatti, per il principio della sineddoche, quasi tutta la costa della Gallura settentrionale, pur non facendo parte del Consorzio stesso, suole essere individuata co-me Costa Smeralda. Nel sito del Consorzio Costa Smeralda7 si legge: “chi usa l'espressione Costa Smeralda per indicare suoli non com-presi nel territorio gestito dal Consorzio viola il nome civile di que-sto; ne sfrutta indebitamente la notorietà; ricava ingiustificato pro-fitto dalla rinomanza che il territorio gestito dal Consorzio ha acqui-stato nel corso degli anni per effetto delle attività di valorizzazione e di protezione che, con ingenti investimenti, il Consorzio vi ha svolto; trae in inganno il pubblico, inducendolo a ritenere che i suoli falsa-mente indicati come situati in Costa Smeralda posseggano i pregi ambientali e fruiscano delle infrastrutture e delle misure di protezio-ne di cui il Consorzio ha dotato il proprio territorio. Il Consorzio Costa Smeralda agisce, ai sensi della legge e del proprio Statuto, nei confronti di chiunque leda i suoi diritti e quelli dei proprietari asso-ciati, ne usurpi il nome, ne sfrutti la notorietà o tenti di attribuire ad altri suoli i pregi che sono propri del territorio attrezzato e gestito dal Consorzio Costa Smeralda”.
Nel 1977 l’insediamento turistico si è ampliato e si è stabilizzato, nel complesso è quello della immagine della Fig. n. 7.
7 http://www.consorziocostasmeralda.com/pages/it/limiti.html
23
Figura 7_Porto Cervo 1977 L’insediamento è realizzato in modo che il turista si riconosca nel
luogo, sia pure esso un luogo di citazioni, un simulacro. È il simula-cro stesso della Costa Smeralda ad assurgere a unica rappresentazio-ne di un luogo (Ritzer e Liska, 1997; Lash e Urry, 1994), è la realiz-zazione della forma turistica come forma di distacco dal territorio. Il turismo diventa la proiezione di un’immagine globale, corrisponden-te ad archetipi che vanno aldilà del comportamento turistico, si ri-conduce alle performances pubblicitarie e al grado di evocazione che alcuni nomi, foto, icone provocano sul turista.
L’esempio mostra proprio uno degli aspetti espressi in precedenza dall’ideologia turistica: la costruzione di luoghi idilliaci, indirizzati alle esigenze del mercato turistico, veri e propri spazi effimeri (Min-ca, 1996b), luoghi “straordinari”. Lo spazio turistico è allora soprat-tutto legato alle immagini, immagini che si creano i turisti e immagi-ni prodotte da chi gestisce i flussi turistici (Miossec, 1977).
Il turismo della Costa Smeralda si nutre della extra-ordinarietà dei luoghi, si è spinti a visitare un luogo proprio in ragione della diversi-tà che esso offre e della sua esclusività, ma appare in modo evidente la volontà, in chi guida o indirizza il turismo e ne condiziona successi ed insuccessi (ovvero amministrazioni pubbliche, catene alberghiere, tour operators, ecc.), di negare interesse per il confronto tra turista e luogo ospitante e ancora di più tra turista e residente.
24
L’immagine del luogo “creata” diviene spesso più potente rispetto alla realtà del luogo stesso e incide in modo rilevante sul destino del-la località turistica. Non esiste viaggio senza un corredo di rappresen-tazioni del luogo da visitare. Si avverte allora un processo di banaliz-zazione dei paesaggi turistici e del contesto ambientale, che portano a forme di fruizione insostenibili. E la banalizzazione si mostra anche nella struttura urbana, occupando gli spazi in modo diffuso, sovrac-caricando l’ambiente e gravando sulla linea di costa con un costruito sfrangiato e, soprattutto, a-relazionale col contesto territoriale.
Figura 8_Porto Cervo 2008 Nel 2008 l’insediamento si è ampliato come risulta dalla Fig. n. 8.
Il territorio risulta fortemente antropizzato, la diffusione del costrui-to, rispetto agli anni ’70 è molto cresciuta e il mosaico si presenta a tessere di dimensione e forma molto diverse tra loro. Il turismo con-quista lo spazio, la città turistica cresce ma in modo incontrollato. È la vittoria della gated communities; nella Costa Smeralda il turismo è esclusivo, ma lo è tale anche in quanto esclude popolazioni altre, in qualche modo gentrifica lo spazio. Il contesto mostra un territorio tu-ristico che procede per chiusura degli spazi, riducendo l’ambiente na-turale, auto-segregandosi in ambienti sempre più chiusi. Diretta ed inevitabile conseguenza di questo è un rapporto di disaffezione che si crea tra la società locale e le forme turistiche, dovuto all’assenza di relazione. Questa disaffezione non nasce solo da come i luoghi ven-
25
gono presentati e proposti dai tour operator, ma anche da come sono gestiti.
3.2. Stintino
Figura 9_il contesto territoriale di Stintino Stintino è la “città turistica” che presenta le maggiori caratteristi-
che di complessità della costa nord-occidentale della Sardegna in quanto vi si possono ritrovare tutte le caratteristiche-tipo degli inse-diamenti sia per turisti che per residenti. Stintino si caratterizza per-ché organizzato in molte località, a partire dal comune originario, di-verse nelle forme e, soprattutto, nei contenuti turistici.
Il paese originario nasce, intorno al 1885, dal forzato abbandono dell’isola dell’Asinara della popolazione che vi risiedeva, a causa della fondazione sull’isola di una colonia penale, e resta frazione del comune di Sassari sino agli anni ‘80. Da un isola la popolazione pas-sa su una penisola. Il paese, nato come paese di pescatori, dopo gli anni ’60 muta per la concomitanza di una serie di cause; l’evoluzione è perfettamente leggibile dalle foto aeree. Nel 1954, infatti, la struttu-ra urbana di Stintino è quella rappresentata nell’immagine della Fig. n. 10. È un centro urbano di ridotta
26
Figura 10_Stintino 1954 dimensione, che si allunga nella piccola penisola. È molto interes-
sante notare come siano ancora leggibili gli usi agricoli di prossimità all’urbano, nella frammentazione di piccoli appezzamenti di terreno posizionati lungo una delle vie di accesso alla città. Il contesto terri-toriale perturbano non presenta alcun segnale di particolare urbaniz-zazione.
Diverso è invece il contesto sociale e culturale a partire dagli anni ’60. Nel 1962 a Porto Torres si insedia l’industria petrolchimica vo-luta dal Piano di Rinascita8, che erogava cospicui finanziamenti stata-li per lo sviluppo economico, un evento che muta completamente il volto al territorio. Non più un territorio legato all’agricoltura e alla pesca, peraltro in un contesto sociale complessivamente povero, ma estremamente orientato ad un modello di innovazione eterodiretta. Nello stesso periodo “nasce” il turismo nella Costa Smeralda e Stin-tino si trova nella posizione ideale per accogliere il modello turistico tipico dell’epoca, quello di massa, o “fordista”, cioè concentrato nel-lo spazio e nel tempo. Il centro urbano, spinto dalla forza trasforma-tiva imposta dalla presenza di questi processi, inizia ad espandersi e ad uscire al di fuori dal centro matrice.
Nel 1977 Stintino non è già più il piccolo borgo di pescatori ma sono già sorte, sia nei pressi dell’abitato che in altre parti della peni-sola, alcune attività legate al turismo come alberghi e piccoli villaggi (Fig. n. 11).
8 Legge 11 giugno 1962, n. 588
27
Figura 11_Stintino 1977 Abbandona quindi il suo sito primigenio per aprirsi verso il terri-
torio, soprattutto appena a settentrione dell’abitato sorgono già degli edifici in quello che era il campo agricolo, seppur si mantengono gli usi agricoli di prossimità. Ma è l’inizio di una trasformazione, nuove e numerose attività sopraggiungono e conquistano lo spazio. In un lasso di tempo di trent’anni la dimensione del centro urbano è più che raddoppiata, abbandonando la struttura compatta per una costi-tuita da annucleamenti, condizionati anche dalla presenza dei vari re-sort o centri alberghieri.
Oggi lo spazio urbano (si veda la fig. n. 12) è caratterizzato, come conseguenza, della privatizzazione degli spazi destinati al turismo che, ovviamente, gli stessi sono sottratti allo spazio pubblico. Il pro-cesso di espansione si rivela soprattutto verso la parte più interna del territorio, gli effetti della nuova realtà urbana sono messi in evidenza dalla scomparsa quasi totale degli spazi in origine destinati all’agricoltura, sostituiti da altre funzioni di tipo urbano (stazioni di servizio, ecc.), residenze singole o terreni incolti. Sintomatico è che nella via di accesso alla città da occidente, denominata via degli Orti, non sia presente più neanche un orto.
28
Figura 12_Stintino 2008 Discorso a parte merita la Pelosa, forse la parte più rinomata della
città turistica di Stintino, che è divenuta essa stessa l’immagine di Stintino. Il turista riconosce, oggi, Stintino nella Pelosa. Come af-ferma MacCannell, (2005 [1976]), il primo contatto che un turista ha non è con il luogo ma con la rappresentazione del luogo; la spiaggia della Pelosa è la più conclamata rappresentazione di Stintino, dive-nendone marker simbolico. Spiaggia dagli inequivocabili pregi am-bientali, nel 1954 si presentava priva di qualunque elemento costruito (vedi Fig. n. 13).
Figura 13_La Pelosa 1954
29
È dagli anni ’60 che inizia la crescita urbana della Pelosa, con la
realizzazione di seconde case che, negli anni a seguire, hanno dato avvio ad un vero e proprio settore ricettivo sommerso. In seguito sorgono anche alberghi realizzati da importanti imprenditori (per e-sempio la famiglia Moratti, proprietari della Saras9). Nel 1966 sulla scia tracciata dalla Costa Smeralda gli stessi Moratti realizzano l’Hotel Roccaruja e la località diviene un importantissimo elemento dell’economia locale, avviando così il processo di smeraldizzazione del litorale. Di seguito, negli anni ’70 anche la SNAM, gestita dall’ENI, dopo l’acquisto del Roccaruja, realizza più di sessanta ap-partamenti in villette, che vengono gestite dall’ISAR (ex proprietà Moratti) ora costola dell’ENI. È la presenza della zona industriale di Porto Torres che quindi modifica la struttura urbana della città turi-stica, ovviamente non solo di Stintino ma di tutto il litorale sassarese.
Nel 1977 la situazione dell’insediamento della Pelosa è come ap-pare nella Fig. n. 14.
9 La Saras Raffinerie Sarde S.p.A. è una società per azioni italiana, di proprietà della
famiglia Moratti, costituita nel 1962 dal capostipite della famiglia Angelo Moratti, operativa nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica. Nel maggio del 1962, lo stesso anno di costituzione del Consorzio Costa Smeralda, il Piano per la Rina-scita della Sardegna diviene legge dello Stato italiano. E’ l’anno dell’inizio della costruzione della raffineria della Saras a Sarroch e del complesso chimico della Sir a Porto Torres (terzo gruppo chimico italiano dopo Eni e Montedison).
30
Figura 14_La Pelosa 1977 La crescita dell’insediamento è notevole, molta parte del territorio
risulta costruita e destinata a funzioni legate al turismo, soprattutto d’elite. In questo particolare momento, come conseguenza, il conte-sto urbano appare realizzato per parti, in funzione dei diversi inter-venti dei differenti imprenditori. Diversa la situazione come risulta oggi (Fig. n. 15): la conquista del territorio da parte dell’insediamento appare molto più compiuta, il numero degli inter-venti si è incrementato e l’insediamento appare composto di parti dif-ferenti, in funzione dei diversi alberghi o resort che ne hanno dise-gnato la sagoma. La Pelosa è un insediamento soprattutto di resorts o simile, e questo è essenzialmente il suo limite, che porta al suo totale abbandono durante i mesi invernali.
È la realizzazione di spazi straordinari, nella loro elitarietà, desti-nati solo a dei flussi periodici, con una reiterazione acontestuale delle gated communities destinate ai flussi internazionali; il territorio si è fatto turistico (Minca, 1996a), ripensandosi in funzione della propria immagine, diventando un mercato di “cose belle” ovvero un teatro di cliché e preconcetti.
Figura 15_La Pelosa 2008 3.3 Sa Rocca Tunda
31
Figura 16_il contesto territoriale de Sa Rocca Tunda Sa Rocca Tunda rappresenta la periferia della città del turismo, sul
litorale del Comune di San Vero Milis; l’insediamento è sorto duran-te la metà degli anni sessanta sulla spinta del processo turistico na-scente con l’intento di soddisfare la voglia di seconda casa sul mare degli abitanti dell’oristanese, ma nasce senza alcuno strumento urba-nistico. Il principio edificatorio è per accumulazioni successive, gli edifici si addossano gli uni agli altri senza un chiaro intento. La rin-corsa alla smeraldizzazione si interrompe in breve tempo, allorquan-do ci si accorge che l’insediamento, ancora alla fine degli anni ’80, è privo di qualunque fondamentale opera di urbanizzazione.
Il percorso storico dell’insediamento può essere fatto iniziare, co-me per gli altri casi precedentemente esposti, dagli anni ’50. La fig. 17 mostra un territorio completamente libero da qualunque edifica-zione, al contempo si riesce a comprendere la natura profondamente rurale dello stesso territorio, usato a fini pascolativi o foraggieri dagli abitanti di San Vero Milis o di eventuali pastori transumanti dalle a-ree più interne, la maglia agricola arriva sin quasi a ridosso delle spiagge e la salina sulla sinistra dell’immagine è ancora produttiva.
32
Figura 17_Sa Rocca Tunda 1954 Gli anni sessanta segnano l’inizio dell’edificazione incontrollata,
quasi sempre autorizzata nell’insediamento principale, quasi mai a ridosso della salina. È un momento di conquista degli spazi, a mac-chia di leopardo, gli edifici sorgono persino a ridosso della spiaggia e si vanno ad occupare, per passi successivi, gli spazi liberi. Il processo prosegue sino ai primi anni ’80, difatti la fig. 18 mostra l’insediamento alla fine degli anni ’70.
Figura 18_Sa Rocca Tunda 1977 Il processo di edificazione cerca in questo momento altri spazi ol-
tre quelli disponibili, difatti, a poca distanza dall’insediamento prin-cipale, ne sorge un altro a ridosso della salina, con case di pregio leg-germente più elevato rispetto al precedente, che prende il nome de Sa Marigosa. Però chi non dispone di un’area di proprietà vuole uno spazio per alloggiare, ed ecco sorgere, abusive, delle capanne di fala-sco o mattoni lungo l’area demaniale, ovvero la spiaggia sottostante la salina e prospiciente l’altra borgata marina presente su questo ter-ritorio nota come Su Pallosu. La storia di questi edifici merita un pic-colo inciso. La presenza delle capanne di falasco a Sa Marigosa e, in prossimità dell’altra borgata marina, come in molte altre spiagge e località del Sinis (come per esempio San Giovanni di Sinis, Is Arut-tas, Putzu Idu), ha un notevole sviluppo negli anni ‘50. Alle barrac-cas per i pescatori, utilizzabili anche come ricovero di attrezzi, si ag-giungono nel corso degli anni numerose capanne, casotti in legno e piccole abitazioni in muratura con lo scopo di trascorrere al mare le
33
ferie estive. La concentrazione maggiore di casotti si raggiunge negli anni ’70, superando il centinaio di unità. È interessante rilevare che questa forma di edificato, totalmente abusivo, fosse generalmente apprezzato e, anzi, quasi invidiato dai residenti degli insediamenti “ufficiali”, merito della vitalità della comunità che stagionalmente vi si insediava, generando le condizioni di prossimità e vicinato dei co-muni originari. Le demolizioni degli edifici abusivi si compirono a cavallo tra gli anni ’70 ed ’80, e pur riconoscendo la valenza cultura-le dei manufatti di falasco e il loro inserimento nel paesaggio, venne emanata l’ordinanza di demolizione dal Comune di San Vero Milis, eseguita con grandi difficoltà per l’opposizione dei proprietari.
Figura 19_i casotti o barraccas presso Sa Rocca Tunda Conseguentemente alla demolizione, il tratto di litorale compreso
tra il borgo de Sa Marigosa e quello de Su Pallosu, anche in relazione al fatto che le demolizioni stesse lasciarono segni inequivocabili d’inquinamento, fu lasciato in parziale abbandono. Restarono i tre
34
centri, ma solo Sa Rocca Tunda continuò ad incrementare la propria dimensione. Conseguentemente all’applicazione della Legge Galasso si ebbe l’inizio delle lottizzazioni oltre i 300 metri dalla linea di co-sta, tuttavia, nonostante le stesse fossero maggiormente “pianificate”, si inserirono in modo totalmente disorganico. Quale sia la situazione tra gli anni ’80 e ‘90 è dimostrato dalla figura 19, che permette di comprendere il proseguo dell’espansione dell’insediamento, difatti ad est dello stesso sorge un’altra piccola borgata, denominata Su Crastu Biancu. I due insediamenti nell’arco di un decennio si uniran-no senza soluzione di continuità, in ragione di concessioni edilizie concesse antecedentemente al 1985 o in ragione della nascita delle zone F (turistiche) disciplinate dalla Legge Urbanistica Regionale. Sul versante occidentale, invece, si nota ha una maggiore difficoltà nell’unire Sa Marigosa a Sa Rocca Tunda, nonostante vi si costrui-scano edifici aldilà dei 300 metri.
Figura 20_Sa Rocca Tunda 2000 La situazione odierna (fig. 20) vede occupati tutti gli spazi edifi-
cabili entro i 300 metri dalla linea di costa, per questo motivo, come è anche visibile nella fig. 19, è iniziata l’edificazione nell’agro, nuo-vamente in assenza di autorizzazione, anche in ragione del fatto che il Piano Paesaggistico Regionale vigente della Regione Sardegna im-pedisce l’istituzione di nuove zone F turistiche. Lo sfogo naturale al-lora diviene l’agro, che va lentamente saturandosi, soprattutto paral-lelamente alla via di accesso principale che proviene dalla strada sta-tale più a monte.
35
Figura 21_Sa Rocca Tunda 2008 La struttura urbana quindi, oggi, dopo essersi quasi compattata
negli anni ’90 rinizia a diffondersi, a scomporsi, continua insomma a perdere caratteri di qualità urbana a discapito dell’imperante ideolo-gia turistica: costruire nuove case per offrire forme di ospitalità “sommersa”.
4. Nuove forme turistiche: alcune proposte
Da quanto descritto si rende necessario individuare nuove forme che oltrepassino i percorsi tracciati dall’ideologia turistica con lo scopo di rigenerare il contesto della città turistica. Quanto si deve rintracciare è allora una nuova forma turistica possibile, da calibrare sul principio della relazione tra società locale e turista, per scardinare la continua ricerca di forme ridondanti, di spazi segregati, di luoghi in abbandono. Per questo motivo si rende necessario esplorare forme turistiche più orientate al dialogo sociale tra turista e residente, che favoriscano non solo la percezione di un nuovo senso del luogo ma che siano utili a generare nuova urbanità, localizzate all’interno della città del turismo ma al contempo aperte alla società locale. La città del turismo deve superare le forme generate dall’ideologia turistica mirando a forme di turismo “inclusivo” da contrapporre all’”esclusivo”, e la sua parola chiave deve essere servizio, inteso sia a favore del turista in quanto nuovi servizi possono rendere più par-tecipata la loro esperienza nei luoghi visitati e più piacevole la per-manenza in luoghi in genere poco noti o poco serviti sia della società locale in quanto consentono di usufruire di prestazioni di qualità sen-za doverle cercare altrove.
36
Ragionando in astratto, una forma turistica che offra servizi nella città del turismo deve rispettare questi requisiti:
• presentarsi come una discontinuità rispetto le consuete forme turistiche;
• configurarsi come una forma turistica non preordinata ed eterodiretta, rigenerandosi grazie alla costante possibilità di creare condizioni ottimali alla vulnerabilità reciproca tra ospite ed ospitante;
• consentire un superamento dell’individualizzazione tipica dei villaggi turistici e dei resort in genere;
• fornire funzioni e servizi connessi all’abitare per miglio-rare la qualità della vita dei territori ospitanti e l’equità territoriale.
Un primo caso che può essere utilizzato come esempio di questo modo di concepire il turismo è rappresentato dal compendio costiero di Is Mortorius, un piccolo promontorio lungo la costa del Golfo di Cagliari, in territorio di Quartu Sant’Elena tra gli insediamenti di Ca-pitana e Terra Mala, di proprietà dell’Agenzia regionale Conservato-ria delle Coste della Sardegna.
Figura 22_il contesto territoriale di Is Mortorius
37
Questo piccolo luogo, denso di storia in quanto presenta tracce di insediamento dall’epoca nuragica, testimoniata dalla presenza del nu-raghe Diana trasformato in fortino durante il secondo conflitto mon-diale, durante il quale si stabilì nella parte prospiciente il mare la bat-teria “Carlo Faldi” di difesa costiera e, inoltre, permangono anche i resti di una tonnara. La batteria fu adibita a colonia marina una volta dismessa nel dopoguerra. Oltre il nuraghe, verso l’interno, sorgono numerose abitazioni, molte seconde case per le vacanze e molte resi-denze stabili. Un vero insediamento costiero.
Alle spalle del compendio e tutto attorno ad esso si distribuisce li-nearmente, da Cagliari a Villasimius, la città del turismo del meri-dione sardo, che presenta le medesime caratteristice viste in prece-denza in tutti e tre i casi analizzati.
Il compendio è oggi un luogo abbandonato e inospitale e questa condizione di decadenza dei luoghi ha fatto si che si sviluppasse nel-la società locale un piccolo processo partecipativo, accompagnato anche da un blog10, in modo tale da raccogliere il maggior numero di proposte possibili circa la riqualificazione dei luoghi. Ancor di più è stato fatto dall’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna che nel 2010 ha bandito un concorso di idee per la sua ri-qualificazione.
In merito a questo concorso è utile citare la proposta dal titolo “Passavamo sulla terra leggeri”11 che rappresenta al meglio quanto si intenda per nuova forma turistica. Attraverso interventi reversibili si insediano funzioni leggere di supporto alla zona turistica circostante (servizi alla balneazione), all'ambito urbano di Quartu e di Cagliari (attività culturali), all'ambito territoriale costiero (Centri documentali sull'insediamento nuragico, sul sistema delle Torri costiere, sul si-stema della Linea di difesa a Mare), di educazione ambientale e ap-prendimento e conoscenza delle dinamiche naturali costiere.
Il progetto consente la generazione di alcuni servizi assenti nel territorio, quali spazi d’ombra, un’area di ristoro e semplici servizi alla balneazione sotto forma di spazi riparati che permettono a singo-
10 http://ismortorius.wordpress.com/ 11 Capogruppo Vector17 (Francesco Spanedda, Narciso Revenoldi), Collaboratori: Mas-
similiano Campus, Paola Addis, Roberto Senes, Consulenti: Mariolina Marras (paesaggio), Francesca Bua (Archeologia), Alessandro Muscas (Geologia), Giuseppe Onni (programma-zione), Favaro & Milan (Strutture)
38
li, famiglie o a gruppi di trascorrere una giornata al mare. In questo modo si migliora la qualità d'uso della spiaggia e si innesca un gene-rale processo di riappropriazione da parte della società locale. Lo scopo finale è quello di favorire la presa di coscienza del luogo da parte di uno strato più ampio di popolazione e in un ambito geografi-co più vasto, anche usando funzioni culturali, implementate desti-nando uno degli spazi reversibili ad una piccola sala conferenze. Il principio è quindi la generazione di servizi, qualitativamente elevati ed utili al territorio e non solo al turista.
Altra discontinuità è la gestione complessiva del compendio, né pubblica, né privata, ma collettiva, e questo è stato fatto con lo scopo di ribaltare la situazione di degrado e abbandono dei luoghi, ormai considerati terra di nessuno, nonostante siano pubbliche e quindi di tutti. La gestione dell’area è quindi affidata ad un comitato, soggetto collettivo composto dalla società locale12, che si occupa di rendere fruibili gli spazi e di gestire le attività e le varie funzioni, garantendo la pulizia dei luoghi, regolando e controllando l’uso corretto degli spazi a terra e a mare e si occupa di reinvestire tutti guadagni. La proprietà rimane pubblica, ma l’insieme dei beni ambientali e stori-co-archeologici del compendio sono affidati al collettivo in comoda-to oneroso, cui corrisponde non un pagamento in denaro ma uno o più servizi: in questo caso la tutela e la conservazione dell’insieme dei beni.
12 Un rappresentante della Conservatoria (membri permanenti), più due membri elettivi:
un rappresentante del Comune di Quartu Sant’Elena e un rappresentante delle imprese ope-ranti sul sito. In caso di decisioni importanti riguardanti la gestione delle strutture come ad esempio i cambi di fase il comitato potrebbe ampliarsi e esprimersi in forma allargata, inse-rendo altre due figure: un docente universitario con competenze in materia di paesaggio o di ricerca archeologica e un rappresentante della Provincia di Cagliari, con lo scopo di rag-giungere obiettivi di eccellenza in materia di ricerca e di qualità nella capacità di rintracciare fonti di finanziamento europee e non solo.
40
Figura 24_Schemi funzionali La vita delle persone si svolge attraverso sequenze di azioni, cir-
costanze, spazi in cui hanno luogo funzioni che, per varie ragioni, accadono quotidianamente. L'insieme di questi contesti e delle fun-zioni che a essi si riferiscono è dunque il teatro della quotidianità. D'altra parte queste pratiche sono assai spesso azioni routinarie, av-vengono per abitudine a partire da motivazioni che appaiono come quasi inconsapevoli per chi risiede in un luogo, mentre d’altro canto possono apparire straordinari, nuovi, autentici, per chi lo visita.
Una delle pratiche quotidiane consuete è la cura di sé, la cura della persona e il mercato turistico offre anche l’eventualità di poter curare sé stessi durante il periodo di una vacanza, basti pensare al turismo termale o a quello dei centri benessere. Chiunque abbia avuto l’esperienza di una visita medica sa che nella sala d’attesa si svilup-pano due atteggiamenti: timore nei confronti degli altri presenti e scelta personale di chiudersi in letture o pensieri, oppure curiosità nei confronti dell’altro, volontà di conoscenza e condivisione.
Non si tratta di cercare il dolore nelle forme turistiche, ma la scel-ta di utilizzare la cura della salute come strumento per scardinare i principi dell’ideologia turistica nasce proprio dall’assunto che i rap-porti, le relazioni, che si creano durante la condivisione di un’esperienza medica sono spesso molto duraturi, in quanto nati in momenti di particolare necessità.
41
È quindi un caso in cui, per motivi particolari, si raggiunge il pun-to di vulnerabilità tra due persone che non conoscendosi condividono però un esperienza, positiva o negativa che sia.
Un esempio di un simile tipo di turismo è individuato nella propo-sta di progetto che ha vinto il Premio del Paesaggio bandito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 2008, nella categoria H: in-terventi per la pianificazione del paesaggio di vaste aree urbane o e-xtra urbane13.
Il territorio di Osilo (Sassari) è un esempio interessante e unico di architettura industriale, rappresentato dal sistema di 36 mulini ad ac-qua situati nella valle del fiume San Lorenzo. All'interno della valle, in aggiunta al sistema di mulini, vi è un piccolo insediamento (circa 187 abitanti) il villaggio di San Lorenzo a Monte, nucleo compatto dove vivono la maggior parte degli abitanti, con case sparse lungo il fiume, alcuni dei quali sono rappresentati dai mulini e, infine, a valle dai villaggi di San Lorenzo a Valle e Pirastreddu. Il territorio della Valle di San Lorenzo dista pochi chilometri dal litorale settentriona-le, nei pressi della Marina di Sorso e dal litorale di Platamona.
Figura 25_Inquadramento territoriale della Valle di San Lorenzo La proposta di progetto intende dimostrare che il paesaggio è una
componente importante dell'identità locale e questo rimane tale no-nostante si trovi all'interno di una componente turistica. La proposta è orientata verso un turismo relazionale, non con il solo scopo di re-
13 Project Team: Francesco Spanedda, Paola Pittaluga, Martino Marini, Giuseppe Onni,
Vlatka Colic, Gianluca Melis, Antonio Serra, Paolo Vargiu, Roberto Serra
42
cuperare parte del patrimonio edilizio, la maggior parte è già stato trasformato in case per seconda residenza o per usi irregolari nel fine settimana o in estate, ma anche con l’obiettivo di riqualificare il pae-saggio fluviale e la rigenerazione del paesaggio rurale storico, crean-do le condizioni per nuove forme di turismo in un contesto di più ampio uso. Il riconoscimento della valle come "spazio di decelera-zione" dirige lo studio di funzioni relative al benessere e alla salute fisica e mentale attraverso l'uso dell’acqua, ovvero attraverso la rea-lizzazione di partenariati pubblico-privati per l’attivazione delle fun-zioni relative al turismo della salute.
L'elemento che può innescare il processo può essere rappresentato da una spa realizzata in un mulino abbandonato in mezzo della valle. Un altro mulino, più isolato e posizionato nella parte più stretta della valle, lo si individua come in grado di ospitare un residence e un cen-tro di trattamento dedicato alle persone con disabilità, per i quali le qualità terapeutiche delle acque e delle attività connesse possono es-sere molto utili. La spa e il centro sono serviti da una struttura ricet-tiva, organizzata secondo la tipologia dell’albergo diffuso con la rea-lizzazione di 16 residenze dove i turisti possono soggiornare, con una disponibilità fino a 50 posti, privilegiando l'accoglienza dei disabili che utilizzano i servizi e le loro famiglie in modo da fornire un servi-zio raro.
È necessario quindi pensare in modo diverso, passando da spazi turistici privati a spazi semi-pubblici, con iniziative su piccola scala che producano effetti su larga scala, fornendo funzioni di servizio e servizi di qualità a prezzi accessibili a coloro che non sono turisti, quindi godibili non solo dai turisti, ma anche da chi vive quotidiana-mente lo spazio turistico.
44
5. Conclusioni
Occorre allora partire da questi semplici concetti: le forme turisti-che proposte sono leggere, conducono ad esperienze di relazione tra turisti e società locale, sono poco invasive (in quanto non ha senso saturare ulteriormente gli spazi del territorio) e correttamente inserite nel contesto e, infine, cercano di rappresentare un bene comune tra turista e società locale.
La struttura turistica si configura allora come una forma turistica non preordinata, non eterodiretta, ma si rigenera grazie alla costante possibilità di creare condizioni ottimali alla vulnerabilità reciproca tra ospite ed ospitante, permettendo la generazione di un tessuto so-ciale coeso, che consenta il superamento dell’individualizzazione ti-pica dei villaggi turistici e dei resort in genere attraverso l’opportunità di effettuare un esperienza di socialità in un contesto diverso da quello quotidiano, aprendo scenari molto interessanti.
Innanzitutto la generazione di nuove relazioni che consente l’instaurarsi di un nuovo tessuto sociale. Una forte discontinuità con quanto propone parte del mercato turistico.
La relazione tra turista e società locale può diventare un momento importante del processo turistico. È per questo che una forma turisti-ca alternativa deve cercare di favorire il contatto sociale. Il territorio, gli spazi turistici, sono direttamente interessati da questo confronto, che deve essere diretto, senza interposizioni e non eterodiretto, per re-innescare processi di urbanità.
La forma turistica riveste quindi un’importanza reale sui contesti a bassa densità quali la città del turismo, generalmente marginali e ca-renti di servizi. I pochi presenti non garantiscono le stesse condizioni di urbanità di territori più densamente popolati. Si innesca così un circolo vizioso che porta a fenomeni di spopolamento, che a loro vol-ta influiscono sulla qualità e quantità dei servizi offerti. Ragionare solo sul turismo come forma di economia in questo tipo di territori, come lo sono spesso quelli sardi richiede sempre e solo nuovi alber-ghi o resort, mentre pensare al turismo come occasione per fornire servizi rivolti al turista e alla società locale significa non solo inter-venire sul turista ma anche generare ricadute positive sul territorio ospitante e migliorarne la qualità delle vita. Avere un servizio in ter-ritori a bassa densità significa consentire a chi vive in quei luoghi la
45
garanzia di un più facile accesso a beni di cui si può disporre solo a distanze ragguardevoli. Significa, quindi, costruire urbanità, aumen-tare le opportunità e la qualità della vita, raggiungere forme di equità territoriale.
Significa produrre anche un nuovo senso del luogo: da un lato, grazie alla possibilità di avere un servizio di qualità, la società locale non è costretta a cercare altrove il proprio benessere e si riappropria dei propri luoghi, dall’altro il turista trova quell’autenticità esisten-ziale, fondamento nelle motivazioni di viaggio. Si ottiene in contem-poranea un’appropriazione e una ri-appropriazione dei luoghi da par-te dei due soggetti, su uno spazio condiviso. Si produce quindi un nuovo luogo, e lo spazio turistico cessa di essere considerato come a-topico.
Bibliografia
Augè M. (1993), Non luoghi: introduzione ad una antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera.
Bandinu B., 2006, Pastoralismo in Sardegna: cultura e identità di un popolo, Zonza, Sestu.
Barp A. (1977), Il secondo ciclo edilizio, Angeli, Milano. Bernardi U., Filippi V. (2004), “Dal Turismo ai turismi: trasfor-
mazioni sociali e sfide culturali”, in A. Savelli (a cura di) Turismo, territorio, identità. Ricerche ed esperienze nell’area mediterranea, Angeli, Milano.
Best S., Kellner D. (1991), Postmodern Theory, Guiford, New York
Boggio F., 1978, Il turismo in Sardegna. Considerazioni geogra-fiche, Studi di economia, Università di Cagliari, vol. IX, n. 1/2/3. Cagliari.
Boorstin, D. (1964), The Image: A Guide & Pseudo Events in America, New York: Harper and Row; Turner, L., and J. Ash (1975), The Golden Hordes, London: Constable.
Brandis P., Scanu G., 2001, La Sardegna nel Mediterraneo. L’importanza economica del turismo oggi, Patron Editore, Bologna.
Cappai A., Alvarez I., Minchilli M., 2012, “Identification and georeferencing of second homes: a planning support in the Sardinian coastal municipalities”, in (a cura di) Campagna M., De Montis A., Isola F., Lai S., Pira C., Zoppi C., Planning Support Tools: Policy
46
Analysis, Implementation and Evaluation. Proceedings of the Sev-enth International Conference on Informatics and Urban and Re-gional Planning INPUT2012, Franco Angeli, Milano.
Cannaos C., Onni G, 2012, The tip of the iceberg. Tests of indirect measures of tourism in Alghero, in (a cura di) Campagna M., De Montis A., Isola F., Lai S., Pira C., Zoppi C., Planning Support Tools: Policy Analysis, Implementation and Evaluation. Proceedings of the Seventh International Conference on Informatics and Urban and Regional Planning INPUT2012, Franco Angeli, Milano.
Gregotti V. (1990), “Tipologie atopiche”, in Casabella, n 568. Harvey D.(1993), La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano. La Rocca R.A. (2005); “Mass Tourism and Urban System: Some
Suggestions to Manage the Impacts on the City”; E-Review of Tour-ism Research (eRTR), Vol. 3, n. 1; pagg. 8-17
Lash S., Urry J. (1994), Economies of Signs and Space (Theory, Culture & Society), Sage Publications
Lozato-Giotart J.P. (2008), Geografia del turismo. Dallo spazio visitato allo spazio consumato, Hoepli, Milano.
MacCannell D. (2005[1976]), Il Turista, ed. it. a cura di L.Guiotto, Utet Libreria, Torino.
Madau C. (2009), Paesaggio e turismo in Sardegna, tra politiche e prassi. In: Paesaggi e sviluppo turistico: Sardegna e altre realtà geo-grafiche a confronto: atti del Convegno di studi, 15-17 ottobre 2008, Olbia, Italia. Roma, Carocci editore. p. 499-519. (Collana del Dipar-timento di teorie e ricerche dei sistemi culturali, Università degli stu-di di Sassari, 4. Sezione geografica, 1).
Minca C. (1996a), “Lo spazio turistico postmoderno”, in (A-A.VV.) Il viaggio – dal grand tour al turismo post-industriale, Atti del Convegno Internazionale – Roma 5-6 dicembre 1996. Edizioni Magma – FLM Napoli.
Minca C. (1996b), Spazi effimeri, Cedam, Padova. Miossec J.M. (1977), “Un Model de l’Espace Touristique”,
L’Espace Gèographique n. 6, pagg. 41–80. Moretti A. (2005), La letteratura vista da lontano, Einaudi Nuryanti W. (1996), “Heritage and Postmodern Tourism”, Annals
of Tourism Research, n. 23, pagg. 249-260.
47
Onni G., 2009, “L’albergo diffuso del Montiferru”, in (a cura di) A. Calcagno Maniglio Paesaggio costiero, sviluppo turistico sosteni-bile, Gangemi, Roma
Piazza A. (2005) in Moretti A. La letteratura vista da lontano, Ei-naudi.
Price R. L. (1983), Una geografia del turismo: paesaggio e inse-diamenti umani in Sardegna, Formez, Cagliari.
Ritzer, G., A. Liska. (1997), “''McDonaldization'' and ''Post-Tourism'': Complementary Perspectives on Contemporary Tourism”, in Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory. C. Ro-jek and J. Urry, eds., Routledge: London.
Serreli S. (2004), Dimensioni plurali della città ambientale. Pro-spettive d'integrazione ambientale nel progetto del territorio, Franco Angeli, Milano.
Sistu G., 2008, Immaginario collettivo e identità locale. La valo-rizzazione turistica del patrimonio culturale fra Tunisia e Sardegna, Franco Angeli.
Usai S., Cao D., 2002, “L'impatto economico del turismo in Sar-degna”, in (a cura di Paci R. e Usai S.) L'ultima Spiaggia, Turismo, sostenibilità ambientale e crescita in Sardegna, CUEC, Cagliari.
van der Duim R., Caalders J. (2002), “Biodiversity and tourism, Impacts and Interventions”, Annals of Tourism Research, Vol. 29, n. 3, pagg. 743-761.
Zucca D. (2006), Essere linguaggio discorso-Aristotele filosofo dell’ordinario, Mimesis Edizioni.