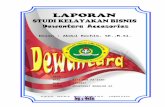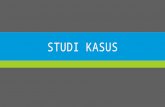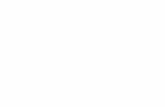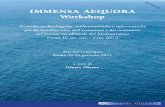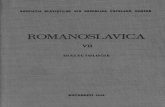Studi di tradizioni popolari
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Studi di tradizioni popolari
a cura di
Giancarlo Baronti e Daniele Parbuono
Studi di tradizioni popolari: passato e presente
Morlacchi Editore
Giancarlo Baronti
Serpi in seno: figure e fantasmi di donne viricide nella letteratura di piazza.
Quando l’è maritataDiventa una serpe velenosaSuperba arrabbiata e fastidiosa,Vol sapere il tutto, il come, il quando...1
Premessa
Se i contrasti costituiscono probabilmente i componimen-ti più tradizionali e con maggior frequenza rinvenibili
nei repertori dei cantastorie, una delle caratteristiche più evidenti dei testi tipici di quella che si potrebbe definire in termini generali “letteratura di piazza”, è sicuramente la co-stanza con cui, a livello narrativo, si utilizzano le inesauribili risorse derivanti dal porre ripetutamente in opposizione il mondo maschile e quello femminile. Le storie di maggior successo sono quelle che in qualsiasi modo riescono a porre al centro dell’attenzione l’inesauribile conflitto tra il mondo dell’ordine e quello del disordine, tra il mondo del dovere e quello del piacere, tra il mondo del necessario e quello del superfluo, tra il mondo dell’onore e della franchezza e quello del sotterfugio e della menzogna, tra il mondo della spada e quello del veleno e così via. Si potrebbe continuare pratica-mente all’infinito a dipanare coppie di opposizioni incentra-
1. Avvertimento a’ chi desidera di pigliar Moglie al tempo da desso. Opera Ridicolosa, e Bella, In Bologna, Presso Domenico Barbieri. Sotto le Scuole. Con licenza de’ Superiori. 8 pp., versi.
7Serpi in senoGiancarlo Baronti 6
te su questo tema perché tale dualismo manicheo consente appunto di trovare risorse espressive inesauribili.
Tale opposizione attraversa tutti i generi da quelli più leg-geri e scherzosi (i contrasti tra suocera e nuora rappresenta-no solo apparentemente un conflitto all’interno del mondo femminile) passando attraverso l’ampio filone delle storie sulle cortigiane, sino ad arrivare alla letteratura del patibolo incentrata in Italia, almeno fino alla prima metà del Seicento, sulla continua e costante proposizione e riproposizione di figure di uxoricide, parricide, liberticide, di donne cioè che uccidono spietatamente mariti, padri e figli che impediscono loro di liberamente godere il mondo2. Mi riferisco in questa esposizione quasi esclusivamente alla situazione italiana, ma credo che considerazioni molto simili potrebbero essere fat-te anche per altri Paesi, in primo luogo per l’Inghilterra3, ove sono state compiute diverse ricerche sull’argomento.
2. Nuovo, e distinto ragguaglio dell’enorme, e spaventevole caso segui-to nella Città di Seza Stato di Roma, dove s’intende come una rea femina per godere il Mondo ha avvelenato il Marito, e come per voler di Dio partorì due Mostri diabolici, e come fu presa dalla Giustizia, tormentata, e condannata al fuoco ad esempio universale li dodici Ottobre 1737. In Cremona, ed in Modena. Per Francesco Torri, Con Licenza de’ Supe-riori. 4 pp., prosa.
3. Cfr. sharPe J. a. 1981, lieBlein l. 1983, hill a. n. 1987, amussen s. D. 1994, Dolan F. e. 1994, KermoDe J. - WalKer G. (a cura di) 1994, stavreva K. 1997, clarK s. 2001, clarK s. 2003, KilDay a. m. 2007, ranDall m. 2008.
Le storie che vedono come tragiche protagoniste Pruden-zia Anconitana4, Apollonia5, Giovanna Vicentina6, Giustina Parigina7, Marzia Basile8, Margherita Catalana9, la perfida
4. Il lamento di Prudenza anconitana la cui prima edizione conosciu-ta e quella fiorentina del 1557- Il Piatoso Lamento Che fece M. Prudentia prima che fusse condotta alla Giustitia.Con la nuova giunta di tutto il caso successo di quanto disse & scrisse di man propria, In Fiorenza presso al Vescovado, MDLVII. del mese di Giugno- ha avuto in oltre tre secoli numerosissime edizioni fino all’ultima di Contrucci, Prato, del 1866 (cfr. Baronti G. 1992).
5. Historia bellissima D’un caso maraviglioso e compassionevole di un vecchio ucciso da Pollonia sua moglie Innamorata di un Giovenetto seguita nel Tirolo, e come per Giustitia di Dio furno scoperti e castigati. Composta ad utile d’ogni fedel Christiano, In Ronciglione per Giacomo Menichelli.
6. Il lacrimoso lamento qual fece la Signora Giovanna Vicentina, la quale fu decapitata & di poi squartata, per aver ammazzato il suo Marito. Aggiuntivo anche di nuovo il lamento dell’Amante, qual fece avendo la sua testa in braccio. Ad istantia di Pantalon Braghetta, Stampata in Par-ma, Con licenza de’ Superiori. 4 pp., prosa.
7. Nuovi eccessi di crudeltà non più intesi di Giustina Parigina la qua-le innamoratasi di Alessandro della Città di Trino (credendosi che non havesse moglie) per adempiere i suoi amori, uccise il proprio fratello, e se ne fuggì con esso, e poi dal medesimo fu abbandonata; mà pervenuta in Trino in casa dell’istesso fù alloggiata, e per vendicarsi uccise Lui, la Mo-glie, e Trè Figli, & ella fu inghiottita dalla terra. Caso esemplare per chi non stima la Divina Giustizia, 8 pp., 49 ottave.
8. La morte di Martia Basile Napolitana. Che fù condannata dalla Giu-stitia per haver fatto ammazzare il marito. Con la morte di quattro altre per-sone per tal causa. Composta da Giovanni della Carrettola Napoletano. In Terni, per il Guerrieri. Con licenza de’ Superiori. 1627.12 pp., 50 ottave.
9. La Catalana punita, crudelissimo e meraviglioso caso seguito nella Città di Barcellona capo della Catalogna. Tradotto dallo Spagnolo in Italia-no dal P. Maestro Fulgenzio Bozzolini Osservante, che serve da specchio a chi non osserva il quarto comandamento di Dio, 12 pp., 49 ottave.
9Serpi in senoGiancarlo Baronti 8
donna di Ragusa10, la scellerata Livia di Alicante11, la sven-turata Isabella12, la bella Callamita13, la crudel Violante14, e tante altre ancora di cui parleremo in seguito, dominano prepotentemente la letteratura del patibolo, non eguagliate neppure dall’ampio e continuo risalto dato alle vicende dei grandi banditi. Tali storie di donne scellerate in larga parte vengono riproposte, sostanzialmente immutate, sino alla fine dell’Ottocento non senza però un’interessante e significativa soluzione di continuità: al periodo aureo che va dalla fine del Cinquecento ai primi anni del Settecento segue più di un secolo in cui i temi che dominano la letteratura del patibolo si mostrano più sensibili ai problemi dell’aggressione com-piuta dall’esterno per fini di lucro -vengono ossessivamente deplorate le ripetitive gesta di anonimi rapinatori e grassa-
10. Caso maraviglioso e compassionevole, nuovamente occorso nella Città di Ragusa. D’una perfida donna, la quale ha fatto morire il marito, & uccisi i proprij figliuoli, e lei s’è impiccata. Caso compassionevole, e degno da essere inteso da ogn’uno. In Venetia, & in Viterbo. 1620. Con licenza de’ Superiori. 8 pp., prosa.
11. Nuovo racconto del crudele, e compassionevol Caso occorso in Ali-cante d’una Madre, che hà ucciso il proprio Figliuolo, e dato a mangiare gl’interiori ad una Cagna, e li membri al Marito; Ove s’intende, che per suo castigo fù portata viva all’inferno da i Demonij. In Bologna per gl’Eredi d’Antonio Pisarri Con licenza de’ Superiori. 10 pp., 23 ottave.
12. Nuova, e distinta relatione d’una Diabolica risolutione seguita nella Città di Marsiglia di una Figliuola di diecinove anni, quale dominata dal Diavolo, hà dato la morte al proprio Padre e Madre. Con il severo e giusto castigo, che ne hà fatto la Giustitia, & un’avvertimento, che fece al Popolo avanti la sua morte. In Roma, Brescia, Verona, Reggio, Milano, Parma, Genova, Ancona, & in Bologna per gli Eredi del Pisarri 1680. Con licenza de’ Superiori. 4 pp., prosa.
13. Caso funestissimo occorso nella Città di Parigi. In Todi con permes-so. 12 pp. 44 ottave.
14. Nuova e bellissima istoria della crudel Violante che per l’amore che portava al proprio figlio, fece uccidere il suo sposo, e, perciò ella dalla Giu-stizia fu fatta ignominosamente morire. Composta in ottava rima da Andrea de’ Santi Romano. In Colle, per Angiolo M. Martini e Comp. Con Licenza de’ Superiori, 12 pp., 53 ottave.
tori- pur senza abbandonare mai del tutto il ricco filone del-le donne assassine. Ma già nei primi anni dell’Ottocento si ricominciano a ristampare ed a rimettere in circolazione, ad esempio, le antiche storie di Prudenzia Anconitana e Marzia Basile e si continuerà a riproporle costantemente sino ai pri-mi anni del nostro secolo.
l’attenzione sulle Donne
Lo scopo di questa relazione non è certo quello di analizza-re puntualmente i testi delle storie di piazza che riguardano le donne ed i loro crimini efferati, quanto di compiere un tentativo per evidenziare i motivi di ordine storico-culturale che hanno condotto ed in parte in qualche modo costretto i cantastorie a dare un largo e rilevante spazio alle figure cri-minali femminili all’interno della letteratura del patibolo, in un periodo di tempo in cui i fasti e gli splendori della esecu-zione capitale raggiungono il loro culmine.
Le storie di cui ci occupiamo sono composte, date alle stampe e vendute in occasioni ben determinate – feste, fie-re, esecuzioni capitali – da figure professionali quali i canta-storie che vivono di tale attività e conseguentemente hanno tutto l’interesse a far sì che il prodotto del loro lavoro otten-ga il maggior successo possibile: le storie devono, come si dice, incontrare, ricevere cioè la positiva sanzione popolare, essere quindi ascoltate, acquistate, memorizzate e ripetute ed entrare stabilmente nel circuito della trasmissione ora-le, divenire patrimonio tradizionale della cultura popolare. Perché tutto questo avvenga è necessario che gli argomenti narrati, le sequenze e le modalità della narrazione risponda-no ai bisogni, agli interessi ed ai modelli culturali delle classi popolari e quindi il cantastorie prima di comporre una sto-ria deve necessariamente operare delle scelte ed individuare la vicenda che meglio interpreti tali caratteristiche. Molto
11Serpi in senoGiancarlo Baronti 10
spesso il cantastorie, ieri come oggi, non prende spunto da avvenimenti reali ma inventa di sana pianta una storia in cui può a suo piacimento introdurre e miscelare accuratamente gli ingredienti che ritiene più rispondenti allo scopo15, op-pure riprende una vecchia storia di successo e la ripresenta come assolutamente nuova dopo aver modificato la data, la località ed i nomi dei protagonisti.
Dal punto di vista dell’impatto sul pubblico tutto ciò non ha molta importanza: storie basate su episodi realmente ac-caduti hanno avuto scarso successo, mentre altre, frutto di invenzioni o di riplasmazioni hanno incontrato i favori del pubblico.
Tipico è il caso della sventurata Isabella, una giovane che per amore uccide il padre e la madre, la cui tragica vicenda viene continuamente riproposta dai cantastorie, modifican-do ovviamente le coordinate spazio-temporali, in un arco di tempo che va dalla metà del Seicento alla seconda metà del Settecento16 e riesce a tal punto ad entrare all’interno
15. Lorenzio de Antiquis, uno degli ultimi cantastorie italiani ha rive-lato che una delle sue composizioni di maggior successo Tragedia d’amore: tragedia di una ragazza ingannata e tradita dal suo fidanzato (1955), non prende spunto da un fatto realmente accaduto ma è di pura invenzione, anche se ovviamente pesca trama situazioni e sequenze in un repertorio assolutamente tradizionale.
16. Nuova, e distinta relatione di una diabolica rissolutione, seguita nella Città di Malta di una Figliuola di età di 19. Anni, quale dominata dal Diavolo, hà dato morte al proprio Padre, e Madre, e due Figliuoli, uno di trè Mesi, e l’altro di 15. Con il severo, e giusto castigo, che ne hà fattola Giustitia, & un’avvertimento che fece al Popolo avanti la sua morte. Seguito alli 10. Agosto del 1672. In Bologna, per Giacomo Monti. 1672. Con lic. de Superiori. 4 pp., prosa. Nuova, e distinta relatione d’una Diabolica risolutione seguita nella Città di Marsiglia di una Figliuola di diecinove anni, quale dominata dal Diavolo, hà dato la morte al proprio Padre e Madre. Con il severo e giusto castigo, che ne hà fatto la Giustitia, & un’avvertimento, che fece al Popolo avanti la sua morte. In Roma, Brescia, Verona, Reggio, Milano, Parma,Genova, Ancona, & in Bologna per gli Eredi del Pisarri 1680. Con licenza de’ Su-
periori. 4 pp., prosa. Nova, e distinta relazione d’una Diabolica rissolutione seguita nella Città di Marsiglia di una Figliuola d’età di diecinove anni, quale dominata dal Diavolo, hà dato morte al proprio Padre, e Madre. Con il severo, e giusto castigo, che ne ha fatto la Giustitia, & un’avvertimento, che fece al Popolo avanti la sua morte. In Roma, Bologna, Padova, et in Trevigi, Per Pasqua-lin da Ponte. Con Licenza de’ Superiori. 1685. 4 pp., prosa. Nuova, e Distinta Relatione d’una diabolica risolutione seguita nella Città di Marsiglia L’Anno 1689. ad 15. Gennaro. D’una Figliuola d’età di dieci-nove anni, quale dominata dal Diavolo, hà dato morte al proprio Padre, e Madre. Con il severo, e giusto castigo, che ne ha fatto la Giustitia & un’av-vertimento che fece al Popolo avanti la sua morte. In Padova, Trevigio, Verona, Cremona, & in Reggio, per Prospero Vedrotti. Con licenza de’ Superiori. 1690, 4 pp., prosa. Nuova, vera, e distinta relatione d’una Diabolica rissolutione Seguita nella Città di Nissa di Provenza Li 4. Maggio 1710. D’una figliuola d’un Gen-tilhuomo d’età d’Anni 19. in circa, essendo innamorata d’un bellissimo gio-vane figliuolo di un Mercante; il Padre, ne la Madre non volendo consentire alle Nozze, di notte tempo dominata dal Demonio con un Stilo ha dato la morte al Padre, et alla Madre mentre dormivano, et dipoi se n’è fuggita con il suo Amante. Et essendo presa dalla Giustizia con il suo Amante li diede ad ambidoi crudelissima morte. Et dipoi sentirete la morte di sette Marinari, che menavano via la Figliuola, et l’Amante, con grandissimi esempij, che hanno lasciato a figliuoli, acciò si allevino col Santo timor di Dio. In Nizza, Torino, Milano, Padova, & in Venetia 1710. Con Licenza de’ Superiori. 4 pp., prosa. Nuova, vera, e distinta relazione d’una diabolica rissoluzione, seguita nella città di Nizza di Provenza alli 3. aprile dell’anno corrente 1711. D’una figliu-ola d’un gentilhuomo, In Nizza, et in Forlì, nella stamp. nova di Giuseppe Merendi.Nuova, vera, e distinta relazione d’una diabolica risoluzione seguita nella Città di Nizza di Provenza nel Mese di Maggio 1722. D’una Figliola d’un gentiluomo d’età danni 19. in circa, essendo innamorata d’un bellissimo Giovine Figluolo di un Mercante; il Padre nè la Madre non volendo con-sentire alle Nozze, di notte tempo dominnata dal Demonio con uno Stilo ha dato la morte al Padre, ed alla Madre mentre dormivano, e di poi se n’è fuggita con il suo Amante; Ed essendo presa dalla Giustitia con il suo Amato, diede ad ambedue crudelissima morte. In oltre sentirete la morte di sette Marinari, che menavano via la Figliola, e l’Amante, con grandissimi essempi, che hanno lasciato a’ Figliuoli, acciò si allevino col Santo timor di Dio. In Vercelli, Milano, & in Parma. Con licenza de’ Superiori. 4 pp.,
13Serpi in senoGiancarlo Baronti 12
prosa.Nuova istoria d’una Diabolica Risolutione seguita nella Città di Nizza di Provenza d’una Figliola d’un Gentiluomo d’età d’anni 19. in circa, essendo innamorata d’un bellissimo Giovine Figliuolo di un Mercante: Il Padre nè la Madre non volendo consentire alle Nozze, di notte tempo dominata dal Demonio con uno Stilo hà dato la morte al Padre, ed alla Madre mentre dormivano, e dipoi se nè fugita con il suo Amante. Et essendo presa dalla Giustizia con il suo Amato diede ad ambedue crudelissima morte. Inoltre sentirete la Morte di sette Marinari, che minavano via la Figliola, e l’Aman-te, con grandissimi essempi, che hanno lasciato a’ Figliuoli, acciò si allevino col santo timor di Dio. In Palermo, Nella Stamperia di Gio: Battista Molo, 1723. Con licenza de’ Superiori, 4 pp., prosa.Nuova, e distinta relazione d’una diabolica risoluzione seguita nella città di Marsiglia d’una figliuola d’età di diecinoue anni, quale dominata dal diavo-lo, hà dato morte al proprio padre, e madre. Con il seuero, e giusto castigo, che ne hà fatto la giustizia, & un avvertimento, che fece al popolo avanti la sua morte, In Padova, Treviso, Verona, & in Rimino, per l’Albertini, 1723Nuova e vera relazione di una diabolica risoluzione seguita nella Città di Nizza di Provenza alli dodici del mese di Febraro 1726 di una figliuola d’un gentiluomo d’età d’anni 19. in circa, essendo innamorata d’un bellissimo Giovine figliuolo di un mercatante; il Padre, ne la Madre, non volendo ac-consentire alle nozze, di notte tempo dominata dal Demonio con un Stilo ha dato la morte al Padre, et alla Madre mentre dormivano e di poi se n’e fuggita con il suo amante, Et essendo presa dalla Giustizia con il suo Aman-te diede ad ambedue crudelissima morte. E poi sentirete la morte di sette Uomini, che menavano via la Figliuola, e l’Amante, con grandissimi esempj, che hanno lasciato a’ figliuoli, acciò si allevino col Santo timore di Dio, Tori-no, Piacenza, Parma ed in Ferrara, per Bernardino Pomatelli Stampatore Vescovale. Con licenza de’ Superiori 1726, 4 pp., prosa. Nuova vera, e distinta relazione d’una diabolica risoluzione seguita nella Città di Nizza di Provenza Ad 11. Aprile 1739. D’una Figliuola d’un Gen-tiluomo, d’età d’anni decinove in circa; la quale, essendo innamorata di un bellissimo Giovine Figliuolo di un Mercante, il Padre, e la Madre non vol-sero acconsentire alle Nozze; perciò di nottetempo, dominata dal Demonio, con uno Stillo ha dato Morte a’ propri Genitori, mentre dormivano, e dippoi se n’è fuggita con il suo Amante. Ed essendo presa dalla Giustizia con il medesimo, diede ad amdibue crudelissima Morte, E poisentirete la Morte di sette Uomini, che menavano via la Figliuola, e l’Amante con grandissimi Esempj, che hanno lasciato a’ Figliuoli, acciò si allevino col Santo Timor di Dio. In Nizza, Venezia, ed in Bologna; Nella Stampa di Carlo Alessio, e Clemente Maria Fratelli Sassi. Con licenza de’ Superiori, e Privilegio, 4
del circuito dei processi di trasmissione orale che Salomo-ne-Marino la raccoglierà dalla viva voce di una popolana di Castellammare del Golfo verso la metà dell’Ottocento17. A testimonianza del continuo lavorìo cui viene sottoposto un testo di questo tipo sia dagli operatori professionali del settore sia all’interno dei processi di trasmissione orale, la lezione raccolta oralmente differisce notevolmente da quelle a stampa che sono giunte sino a noi consevate dall’interesse dei bibliofili, anche se la vicenda narrata è sostanzialmente la stessa. Sono ovviamente entrati in azione processi loca-li di contestualizzazione, di cristallizzazione, di tempora-lizzazione e di individualizzazione: la versione raccolta da Salomone-Marino è in dialetto siciliano e non in lingua, è in versi mentre quelle a stampa sono in prosa, le coordinate spazio-temporali sono diverse da quelle – pur estremamente variegate – presenti nelle stampe – il fatto è ambientato a Trapani nei primi anni del Cinquecento – ed infine anche il nome della protagonista appare modificato, non più Isabella ma Lisabetta.
L’opera del cantastorie non è però soggetta solamente alla sanzione popolare dal basso ma anche, in modo particolare
pp., prosa. Sentenza di morte seguita in Napoli Li 15. Aprile 1780. Di una Figliuola di un Gentiluomo d’età d’anni 19. in circa, la quale essendo innamorata di un bellissimo Giovine Figliuolo di un Mercante, il Padre, e la Madre non vollero acconsentire alle Nozze, perciò di notte tempo con un Stilo ha dato la morte ai proprj genitori mentre dormivano, e dippoi se n’è fugita con il suo Amante. Ed essendo presa dalla Giustizia con il medesimo, diede ad ambe-due come anche alla Balia la Morte. E poi sentirete la Morte di sette Ma-rinari, che menavano via la Figliuola, e l’Amante con grandissimi Esempj, che ànno lasciato a’ Figliuoli, acciò si allevino col santo timor di Dio. I nomi delli suddetti Marinari sono questi. Michele Squadrello, di anni 41. France-sco Fileso di anni 26. Fabrizio Bianchi di anni 40. Orazio Franchi di anni 25. Vincenzo Valetti di anni 28. Biagio Rotoni di anni 37. Marco Segato di anni 20. In Napoli, Roma, ed in Pesaro. Con licenza de’ Superiori. 4 pp., prosa.
17. Cfr. salomone-marino s. 1880: 50-57.
15Serpi in senoGiancarlo Baronti 14
nel periodo di tempo preso in considerazione, a quella che potremmo definire la censura dall’alto: il potere religioso e quello laico ovviamente, ma non è da trascurare neppure quello potenzialmente espresso da fazioni e da famiglie po-tenti che potrebbero risentirsi di qualche pubblicità di troppo fatta a vicende che le riguardano sgradevolmente da vicino.
Di fatto, nell’ambito della cosiddetta letteratura del pa-tibolo, si verifica che di fronte ad un notevolissimo numero di possibili casi da narrare offerti dalle numerose esecuzioni capitali che movimentano quasi settimanalmente la vita delle grandi città, le storie siano relativamente poche e soprattutto insistano costantemente su alcune tipologie criminali.
Anche ammettendo che molte stampe non siano state conservate, che molte storie non siano state date alle stampe né si ritrovino conservate nella tradizione orale, rimane co-munque la certezza che solo un numero esiguo di eventi, veri o fittizi, sono stati elaborati dai cantastorie e che un numero rilevante di questi concerne protagoniste femminili, mentre in effetti, le donne, sia pur nell’ambito dei ‘delitti familiari’, forniscono un contingente assolutamente esiguo alle con-danne ed alle esecuzioni capitali.
Come la mancanza, nella letteratura di piazza riguardan-te il patibolo, di alcune fattispecie di reato (ad esempio la sodomia), malgrado i registri e le cronache delle compagnie di conforto riportino un numero rilevante di giustiziati, può essere spiegata dal timore della censura dall’alto, così, credo, la dominanza di protagoniste femminili coinvolte in ben de-terminati tipi di reato debba essere essenzialmente spiegata in termini di sanzione dal basso. Si tratta come abbiamo già indicato di delitti familiari: uxoricidi, parricidi e liberticidi, mancano significativamente storie relative a casi di infantici-dio, anche se, in modo particolare negli anni a cavallo tra il XVI ed il XVII secolo è con questa imputazione che molte donne vengono mandate a morte.
Tale dominanza di azioni femminili nelle narrazioni ri-spetto ad un mondo agito e dominato dai maschi, non credo possa essere spiegata facendo ricorso alla struttura del fait diverse, del fatto di cronaca, che orienta le scelte del gior-nalismo moderno secondo i criteri dell’eccezionale e del paradossale, per cui si tende a privilegiare l’evento che si di-stingue per alcune caratteristiche da quelli più usuali e ricor-renti. Nel caso delle storie in questione ci troviamo di fronte, se mai, ad un meccanismo opposto: esse raccontano sempre la stessa cosa, ripetono sempre la medesima vicenda, descri-vono sempre il medesimo conflitto tra i due dispositivi che Michel Foucault ha individuato all’interno delle strategie di scelta matrimoniale, il dispositivo di alleanza e il dispositivo di sessualità18.
Sia che si tratti di mogli che uccidono i mariti o di figlie che uccidono il padre o entrambi i genitori, alla base del conflitto esiste sempre una scelta matrimoniale imposta alla donna sulla base di esigenze familiari di carattere economi-co-sociale che prescindono totalmente dalle sue possibili in-clinazioni sentimentali e sessuali. Ovviamente nel caso delle figlie che uccidono i genitori si tratta di una imposizione matrimoniale ventilata e incombente mentre nel caso delle mogli che uccidono i mariti si tratta di una scelta subìta il cui rimorso, quotidianamente esperito e lentamente deliba-to, produce alla fine una tragica risoluzione.
Crediamo quindi che i motivi che hanno portato a questa predominanza della devianza femminile nelle storie di piaz-za incentrate sulla criminalità e sulla giustizia, siano da in-quadrare essenzialmente nel rilevante interesse che per tutti riveste il discorso sul matrimonio, sulla parentela, sul fami-lismo, sui vantaggi e sui rischi di scelte che sono allo stesso tempo ineludibili e irreversibili: in una società strutturata secondo rigidi modelli patrilineari e patrilocali i delitti delle
18. Cfr. Foucault m. 1978 [1976]: 104.
17Serpi in senoGiancarlo Baronti 16
donne, in particolare questi delitti delle donne assurgono, solo loro e proprio loro, al rango di crimini universali.
mariti vecchi
Nelle storie di piazza il conflitto tra il dominante dispositivo di alleanza che privilegia denaro e status sociale e le istanze femminili che tendono invece a privilegiare i sentimenti e l’attrazione fisica, si esprime attraverso quella che potrem-mo definire la metafora del “marito vecchio” nella quale si compendiano simbolicamente i risultati pratici a cui porta il dispositivo di alleanza: donne giovani maritate ad uomini vecchi che non le soddisfano sessualmente e le opprimono con i loro sospetti e la loro avarizia.
Per la loro funzione di mediatori tra cultura egemone e cultura subalterna, i cantastorie non possono ovviamente schierarsi apertamente a favore di istanze che tendono a di-struggere le basi dell’istituto e del sacramento matrimoniale, ma l’insistenza con cui in quasi tutti i casi di uxoricidio si descrive la situazione secondo lo stereotipo del marito vec-chio, fa comprendere come il punto dolente fondamentale delle diverse situazioni narrate non consista solamente nella irrequieta, minacciosa e caotica vitalità del femminile, quan-to nel fatto che si continuino a stringere unioni squilibrate pensando solo all’utile immediato e non alle possibili e pro-babili future conseguenze. Se in quasi tutte le storie la figura del “mal’accorto vecchio”19 è continuamente adombrata, e di una, dove si da essempio a quelle Donne, quali sogliono
19.Caso maraviglioso e compassionevole, nuovamente occorso nella Cit-tà di Ragusa. D’una perfida donna, la quale ha fatto morire il marito, & uccisi i proprij figliuoli, e lei s’è impiccata. Caso compassionevole, e degno da essere inteso da ogn’uno. In Venetia, & in Viterbo. 1620. Con licenza de’ Superiori. 8 pp., prosa, cfr p. 5.
per volontà della robba dare marito vecchio alle loro figliuo-le, & poi le figliuole li danno morte, per pigliarsi piacere con un’altro marito più giovane20, abbiamo già parlato nel saggio precedente, in quella di Apollonia, costituisce sicuramente il motivo centrale. La storia di Apollonia di cui si conosce un’edizione della seconda metà del Seicento, è sicuramente cinquecentesca in quanto è citata da Giovanni della Car-rettola nella sua storia di Marzia Basile del 1603 assieme a quella di Prudenza anconitana (non pensi di Prudentia Anco-nitana, / e d’Impellonia ancor la morte strana21). Anche l’au-tore, che si desume dal testo (Perché in tal pensier spinto è il Brunetto), Gio. Gratio (oppure Oratio o Graziadio anche in testi d’epoca) Brunetto ben conosciuto22, sembra essere vissuto in tale epoca23.
20. Historia bellissima dove si da essempio a quelle Donne, quali soglio-no per volontà della robba dare marito vecchio alle loro figliuole, & poi le fi-gliuole li danno morte, per pigliarsi piacere con un’altro marito più giovane. Novamente posta in luce. In Viterbo. Con licenza. 1623. 8 pp., 30 ottave.
21. La morte di Martia Basile Napolitana. Composta per me Giovanni della Carrettola. In Napoli, / Con licenza de’ Superiori , cfr. Str. 10.
22. Cfr. croce B. 1940.23. L’opera più importante del Brunetto, su cui molto è stato scritto
(cfr. taBet raicich P. 1969; Bronzini G. B. 1990) è sicuramente la storia di Stellante Costantina detta anche canzone di Bellafronte la cui prima edizione conosciuta è quella di Macerata: Historia bellissima di Stellante Costantina figliuola del Gran Turco. La quale fù da certi Christiani, che teneva in Corte suo Padre rubbata, e fù venduta à un Mercante di Vicen-za appresso Salerno. Con molti intervalli, e successi. / Opera bellissima, composta per me Gio. Gratiadio Brunetto, In Macerata, per Pietro Sal-vioni, Con licenza de’ Superiori, 1617.La storia in 48 ottave è stata ristampata innumerevoli volte ed è passata anche con esiti molto interessanti nella tradizione orale di molte regioni italiane. Anche all’inizio di queat storia Il Brunetto si manifesta quale au-tore: Poiché da bel pensier spinto il Brunetto/ Questa bell’opra a tutti far palese. A Gio Gratio Brunetto sono attribuite anche altri componimenti da cantastorie:Opera nuova d’una madre la qual marita una figliuola, contra sua voglia e come se ne fugge e va a ritrovare il suo innamorato, cosa bellissima posta
19Serpi in senoGiancarlo Baronti 18
La storia inizia narrando l’amore della giovane tirolese Apollonia per un suo coetaneo:
Haveva lei Pollonia sempre amatoda quando piccola era un giovanetto,e lui di lei ancor, tutt’infiammatoche amor li struggeva il cor nel petto.
A questo amore si oppongono i progetti del padre che la voleva far sposare a un ricco vecchio:
il Padre che di lei fu ostinatodarli marito un Vecchio per dispettoqual fece per amor della ricchezzadar sua figlia in mano à tal vecchiezza.
Si prosegue con il tradizionale motivo dei lamenti della gio-vane che non vuole accondiscendere al matrimonio “squili-brato” combinato dal padre:
Pollonia che pregava la sua Madreche a tal fatto al Padre lo sconsiglia
in luce per Gio. Gratio Brunetto à beneficio universale, stampata l’anno 1591Opera noua di dui amanti. Contrasto bellissimo. posta in luce da Gio. Gratio Brunetto, Napoli, Ad instanza di Giouanni Napolitano, 1595. Il lamento e morte di Benedetto Mangone. Capo di banditi nel regno di Napoli. con li crudelissimi assassinamenti, che lui faceva in campagna. Come fu pigliato in Alessandria della Paglia vestito da Pellegrino, e con-dotto a Napoli, dove fu attanagliato & arrotato. Stampata in Firenze ap-presso Giovanni Baleni l’anno 1599. Opera noua molto bella dimandata la crudel impresa, che fa la pouertà con la ricchezza, cosa molto piaceuole da intendere / nouamente compo-sta per Giouan Gratio Brunetto, In Venetia, presso Gio. Battista Bonfa-dino, 1604.Tradimento d’amore, cosa molto dilettevole da intendere. Novamente po-sto in luce per Gio: Gratio Brunetto, In Venetia, presso G[io]. B[attista] Bonf[adino]. 1607.
La consolazione canonica della madre che non può opporsi alla volontà del capo famiglia, rientra pienamente all’interno dei luoghi comuni della letteratura di piazza in cui le figure delle donne anziane e “vissute”, madri e fantesche, appaiono generalmente provviste di un senso pratico che spesso incli-na su di un versante decisamente immorale e candidamente cinico:
La consolava con parole leggiadredicendo che non si foccia [sic] maravigliahoggi ò domani questo vecchio è spentopadrona restarai d’oro e d’argento
La giovane però non si lascia consolare dalle ovvie e accorte, anche se non del tutto disinteressate parole della madre e, pur obbedendo, medita di abbreviare la vita a quel coniuge che una tradizionale prassi matrimoniale24 basata sul dispo-sitivo di alleanza tra le famiglie e non sulla libera scelta ses-suale degli individui le aveva dato suo malgrado:
Pollonia, che per il gran dolor piangeva,quando si vide il Vecchio per marito,fra lei pensava e poi così dicevamisera me son gionta amal partito…Pollonia si sentia il cor mancaretanto del gran dolore, e gran dispettosegretamente si mandò a chiamareil suo caro amor tanto perfettodicendogli cor mio, che s’hà da fare?
Il primo pensiero corre naturalmente a quell’arma che da sempre appare sposata all’elemento femminile e che certa-mente in una storia di piazza, luogo di cristallizzazione e
24. Cfr. casanova c. 1987: 69.
21Serpi in senoGiancarlo Baronti 20
riproduzione del senso comune, non poteva mancare; la fre-sca sposa si procura, tramite l’innamorato, del veleno ma le cose non prendono la giusta piega:
Il giovinetto con sua diligenzapensa e ripensa fare un caso rioli andò a portare un perfido veleno,con le sue man un bon bicchiero pieno.Lei prese prese quel becchiero allegramenteanfdava in camera dove il suo maritodormiva il Vecchiarello innocenteper darcelo a bere così polito, e così caminando prestamenterestò il suo pensier molto fallito,al piè una pianella urtò in pianocosì il bicchiero li cascò di mano
La storia prosegue descrivendo la furia di Apollonia che spinge l’innamorato ad uccidere il marito e di fronte alle sue esitazioni provvede di persona alla bisogna:
prese un cortello acuto a suo disegnodandolo in mano a lui non fu bastanteche anomo tale non havea di farloal povero vecchiarello di ammazzarlo.Prese il cortello e li cascò in terraperse la forza e gli mancò il colore,e lei di crudeltà di cor si serrado dar morte al vecchio con dolore,s’inchina giù e quel coltello afferra,il Vecchio dorme e lei senza timore,mentre dormia il pover Vecchiarellogli ficcò nella gola quel coltello.
Il resto si snoda secondo l’abituale copione che caratterizza simili storie esemplari, frutto di un’attenta mediazione cul-turale: la giustizia divina non può permettere che l’enorme delitto rimanga impunito e fa in modo che la giustizia terre-
na ne venga a conoscenza: il fedele cane del vecchio assassi-nato ne scopre le spoglie che gli amanti avevano sotterrato. I due sono prontamente, interrogati, confessano e sono con-dannati a morte. Pur pentendosi del delitto commesso, fin sul patibolo non cessano di rivolgersi sguardi, parole e gesti d’amore:
all’hor l’amante con sua lingua spiegae dichiarando sue parole acortedolcissimo cor mio se mi vuoi beneprima morir voglio che mi conviene.….si cavò dalle mano un’anello….e lo dà in mano alla giovinettaquest’è la fè cor mio, gioia mia diletta
La morale finale non pare scaturire naturalmente dalle se-quenze del racconto, che insistono molto sull’amore che lega i due condannati ma sembra veramente posticcia, aggiunta in fondo solo per rispetto della morale corrente:
Horsù Signori, che havete ascoltatidi questa Historia le norle e gli erroriprima avvertisco voi innamorati,che sete pazzi per seguire amori,al fine vi trovate assai ingannati,pieni di travagli e di dolori,chi non mi crede proverà l’effetto;che si ricorderà ben di brunetto.
L’interesse popolare per simili storie non consiste quindi so-lamente nel perenne fascino che l’accoppiata amore-morte ha da sempre esercitato in quanto materia in grado di far esperire gli elementi fondamentali della cultura, i cardini che sorreggono il comune orizzonte del mondo: la vita, la morte, la sorte dell’anima e del corpo, la giustizia, il crimine,
23Serpi in senoGiancarlo Baronti 22
il bene ed il male, il destino e la sorte. Il mondo popolare, come mostrano chiaramente i rituali dello charivari ha sem-pre espresso una particolare e costante attenzione, ha ma-nifestato uno straordinario interesse al controllo simbolico-rituale dei possibili effetti negativi delle unioni matrimoniali squilibrate25.
In tali rituali organizzati dai giovani della comunità, oltre alla disapprovazione delle seconde nozze dei vedovi (in cui concretamente molto spesso un vecchio vedovo sposava una giovane nubile), si manifesta in modo più generale un’osti-lità nei confronti di quelle unioni che vedano una marcata differenza di età tra gli sposi.
La reazione rituale della comunità giovanile ad alcune unioni matrimoniali contrassegnate da una qualche forma di squilibrio tra i coniugi, sembra riflettere in modo abbastanza evidente l’affermazione simbolica di una sorta di monopolio o di diritto di prelazione da parte delle associazioni giovani-li sulle scelte matrimoniali dei coetanei che idealmente do-vrebbero attuarsi all’interno della comunità di appartenenza e della medesima generazione.
In effetti nelle storie delle donne che uccidono i mariti, il rimorso e l’“ossessione” per la prima non-scelta, appare ge-neralmente acuito e portato a precipitazione dalla concreta opportunità riparatrice del presentarsi di una possibile scel-ta basata sul sentimento, sul desiderio sessuale e soprattutto sul rispetto dei limiti generazionali: la donna non agisce mai da sola; un giovane amante viene pazientemente condotto, spronato, costretto ad aiutarla a liberarsi definitivamente del vecchio marito.
I ritmi frenetici e convulsi della narrazione degli atroci delitti, l’abbassamento cui sono inevitabilmente sottoposti i corpi delle vittime (scorticati, sminuzzati, gettati nella latri-na) richiamano alla mente tradizionali rituali di inversione e
25. Cfr. rey-FlauD h. 1985.
degradazione: i delitti delle donne hanno i ritmi ed i conte-nuti di uno charivari casalingo portato all’estremo:
La donna tramortita, non sapendo che fare, vedendo l’Amante a fuggire, e il Marito morto, pensò la maniera di sotterrarlo, pen-sando mille forme e mille maniere, alla fine con nuova barbarie lo tagliò in mille pezzi, e lo portò da basso in cantina, e gli inte-riori li gettò nel necessario...26
...essa Catarina, vinta dal Diavolo prese una corda con un capo a una colonna della lettiera & l’altro capo tirandolo a lei con le mani havendolo ella intortiata attorno al collo di suo marito, lo strangolò, doppo prese un Cortello e lo scorticò...27
Adormetato questo meschino, conforme l’accordo fatto con l’a-mante... gli legarono i piedi e le mani e poi presa una corda lo strangolarono; di poi lo posero sopra d’un asse e lo portarono sopra del granaio e poi conforme l’uso di bottega d’ammazzar un porco; la Scelerata non contenta della morte del Marito, di più gli tagliò la testa... tagliò la carne del Marito e ne fece salcizze...28
26. Relazione della gran Giustizia seguita nella gran Città di Turrino contro Margherita Stati per aver strangolato con le sue mani il Marito, e poi tagliato in pezzi. In Venezia, MDCCXLIV. Per Gio: Battista Occhi. Con licenza de’ Superiori, 4 pp. prosa, cfr. pag. 3.
27. Caso occorso nuovamente à Salò in Riviera del Lago di Garda. Di Catarina Pistora, La quale avendo strangolato, e scorticato Pietro Rondini suo Marito per la qual causa è stata giustiziata. Con il suo lamento fatto ad esempio delle Mogli, le quali devono amar con ogni affetto il suo marito, obedendo alli precetti Divini. In Ferrara, per Bernardino Barbierij [circa 1690-1700]. Con licenza de’ Superiori. 8 pp., prosa + lamento in versi, cfr. pag. 3.
28. Crudelissimo caso Occorso nella Terra di S. Giovanni di Duin, Patria del Friuli dove s’intende, che Catarina Bianchi habbi strangolato il proprio Marito, e poi della Carne habbi fatto Salcizze, e le habbi vendute, e poi per volontà di Dio si è scoperta, & hanno sententiato alla morte lei, un Giovine e la Serva. In Venetia, Padova, Verona, Bassano, Viterbo, et in Bologna, per l’Erede del Benacci 1707. Con licenza de’ Superiori. 4 pp., prosa + lamento in versi, cfr. pag. 3.
25Serpi in senoGiancarlo Baronti 24
...la scelerata non contenta della morte del Marito, di più gli ta-gliò la testa, sminuzzò la carne del Marito e poi pistò tutto insie-me, ne fece Salami...29
Per quasi tutto il secolo XVIII circola praticamente una sola storia variamente riplasmata e riformulata30 che racconta ap-
29. Distinta relazione di un Caso orrendo successo nella Patria del Friu-li Territorio della Serenissima Repubblica di Venezia, e della memoranda Giustizia seguita alli 23. Luglio 1732. Nelle persone di Battista Rossi, Cate-rina Bianchi, e Francesca Bindetti; Condannati a Morte. Ascoli, Fermo, ed in Foligno; per Feliciano, e Filippo Campitelli, Stampatori. Con Lic. de’ Sup. f. v., prosa, verso.
30. Caso occorso nuovamente à Salò in Riviera del Lago di Garda. Di Catarina Pistora, La quale avendo strangolato, e scorticato Pietro Rondini suo Marito per la qual causa è stata giustiziata. Con il suo lamento fatto ad esempio delle Mogli, le quali devono amar con ogni affetto il suo marito, obedendo alli precetti Divini. In Ferrara, per Bernardino Barbierij [circa 1690-1700]. Con licenza de’ Superiori. 8 pp., prosa + lamento in versi. Crudelissimo caso Occorso nella Terra di S. Giovanni di Duin, Patria del Friuli dove s’intende, che Catarina Bianchi habbi strangolato il proprio Ma-rito, e poi della Carne habbi fatto Salcizze, e le habbi vendute, e poi per volontà di Dio si è scoperta, & hanno sententiato alla morte lei, un Giovine e la Serva. In Venetia, Padova, Verona, Bassano, Viterbo, et in Bologna, per l’Erede del Benacci 1707. Con licenza de’ Superiori. 4 pp., prosa + lamento in versi. Crudelissimo caso Occorso nella Terra di San Giovanni di Duin, Patria del Friuli alli 4. Ottobre 1721. Dove s’intende, che Gelida Branci abbi stran-golato il proprio Marito, e poi della Carne abbi fatto salsicce, e le habbia vendute; E poi per volontà di Dio si sia scoperta, ed hanno sententiato alla Morte Lei un Giovine, e la Serva. In Venezia, Padova, Verona, Bassano, Ed in Lucca per Domenico Ciuffetti. Con licenza de’ Superiori. 4 pp., prosa + versi.Distinta relazione di un Caso orrendo successo nella Patria del Friuli Terri-torio della Serenissima Repubblica di Venezia, e della memoranda Giustizia seguita alli 23. Luglio 1732. Nelle persone di Battista Rossi, Caterina Bian-chi, e Francesca Bindetti; Condannati a Morte. Ascoli, Fermo, ed in Foli-gno; per Feliciano, e Filippo Campitelli, Stampatori. Con Lic. de’ Sup. f. v., prosa.Relazione della gran Giustizia seguita nella gran Città di Turrino contro Margherita Stati per aver strangolato con le sue mani il Marito, e poi tagliato
punto la vicenda di una donna sposata contro la sua volontà che assieme all’amante uccide il marito, ma naturalmente e non poteva essere altrimenti in tutti i casi il postino suonerà sempre due volte.
La vicenda di Catarina Pistora la prima, cronologicamen-te, che siamo riusciti a rintracciare presenta un prologo nel quale si dà corso a tutte le invettive contro la empia crudeltà & la inhumana sceleratezza di una donna dispettosa, arrabia-ta & vendicatrice che ha osato, mossa da troppo sfrenato e dishonesto amore con infamia dell’onore, uccidere il suo più caro e sviscerato amico.
Il più caro e sviscerato amico si rivela essere nel corso della narrazione l’anziano marito (forse l’autore usando la paro-la amico vuol sottolineare l’impossibilità per il coniuge di essere qualcosa d’altro?) che le era stato dato contra sua vo-glia e che Catarina assieme al giovine Andriano elimina con modalità estremamente truculente. Ovviamente i due aman-ti non riescono a farla liscia: vengono condannati a morte e giustiziati. Secondo le buone consuetudini l’autore della storia fa dire a Catarina prima di essere decapitata e squar-tata alcune parole di circostanza che dovrebbero costituire la morale della vicenda: a Padri di famiglia a non voler dar marito contro la volontà loro ad alcuna figliola, ma contem-poraneamente alle moglie di mettersi con ogni affetto ad ama-
in pezzi. In Venezia, MDCCXLIV. Per Gio: Battista Occhi. Con licenza de’ Superiori, 4 pp. prosa.Nuova, e distinta relazione della terribil Giustizia seguita in Milano il giorno di Giovedì 17. Giugno 1762. nelle persone di Margherita Rotelli di Cordevado d’anni 18. Domenico Davanzi Bresciano d’anni 22. Catterina Rossoni Udinese d’anni 51. In Venezia, MDCCLXII. Per Gio: Battista Occhi. Con licenza de’ Superiori. 4 pp., prosa.Nuova, e distinta relazione della Giustizia seguita in Ferrara il dì 19. Mag-gio 1770. Nella Persona di Antonio Galliarini, ed Annunziata Barbieri, nativi della Terra di Renazzo. Rei convinti; e confessi di barbaro Omicidio seguito in persona del Marito di detta Donna. In Ferrara, ed in Mantova. Con Licenza de’ Superiori. 4 pp., prosa.
27Serpi in senoGiancarlo Baronti 26
re il suo Marito. Insomma sarebbe meglio che le giovani non fossero costrette a matrimoni decisi secondo il dispositivo di alleanza, ma una volta che il matrimonio è fatto bisogna tenersi il marito quale che sia a meno che non si voglia fare la fine della povera Catarina.
Alla storia è allegato un lungo lamento di Catarina Pistora in terzine nel quale invano si cercherebbe qualche maggior particolare sulle vicende e sulla morale della storia: infatti è perfettamente identico al lamento che i cantastorie avevano messo in bocca a Prudenzia Anconitana circa un secolo e mezzo prima.
Se la storia di Catarina Pistora, scritta alla fine del Seicen-to, insiste molto sul motivo dell’unione squilibrata a fonda-mento del delitto, anche le altre si muovono praticamente sullo stesso binario. In una storia del 1762 Margherita Rotelli d’anni 18 coniugata con Girolamo Rotelli già in età di anni 48, giudicandolo, qual Marito, d’età avanzata (anche in que-sto caso, come nella precedente storia di Catarina Pistora l’allusione alla sessualità é evidente e sottolineata: Girolamo è vecchio non in assoluto ma in relazione alle funzioni che si richiedono al marito di una diciottenne e non è quindi in grado di soddisfare sessualmente la moglie) decide di sosti-tuirlo con Domenico Davanzi d’anni 23. I due amanti una sera che appunto il marito dormiva saporitamente (anche questa sottolineatura del dormire saporitamente ammicca ad altre cose che si possono fare a letto), gli tagliano la gola e lo fanno a pezzi che poi gettano in una latrina. Il seguito è prevedibile: scoperti finiscono la loro vita sul patibolo.
Attraverso il medium della letteratura di piazza, attra-verso la narrazione di truci delitti e di atroci giustizie, viene chiaramente e ripetutamente presentata, esplicitata, sottoli-neata una situazione estremamente importante per la vita di tutti alla quale bisogna prestare estrema attenzione. Tutte le madri, tutti i padri, tutte le figlie ed in modo particolare tut-ti gli anziani celibi o vedovi devono riflettere attentamente
prima di compiere scelte che potrebbero condurre ad esiti tragici e dolorosi. Prima di aderire acriticamente agli imme-diati e spesso reciproci vantaggi che offre il dispositivo di alleanza, un modello di scambio delle donne che non tiene conto delle propensioni personali, bisogna meditare tutti sui possibili futuri svantaggi. Come abbiamo visto la vasta pro-duzione di exempla da parte dei cantastorie non riguarda so-lamente casi di mogli che uccidono i mariti, ma anche di fi-glie che per non sottostare a matrimoni, combinati contro la loro volontà, sterminano la propria famiglia oppure fuggono con l’amante31: al di là degli stereotipi moralismi sui quali nelle storie si “deve” necessariamente insistere, il profondo e intesivo messaggio che trasmettono è quello di mettere in primo piano una contraddizione intrinseca al modello ma-trimoniale dominante su cui è interesse di tutti riflettere ed operare con buon senso.
serPi in seno
Esiste, come abbiamo detto, un altro motivo per cui il filo-ne delle tragedie familiari imperniate sulle figure di mogli e figlie assassine, risulta dominante all’interno della letteratura del patibolo: anch’esso appare strettamente dipendente dal-le dinamiche inerenti la dialettica fra proposta individuale e sanzione collettiva che regola strettamente una produzione culturale finalizzata esclusivamente alla vendita del prodotto.
Abbiamo accennato al fatto che i delitti familiari com-messi dalle donne sono gli unici o quasi, in grado di assur-gere al rango di crimini universali, in grado cioè di colpire
31. Opera nuova d’una madre la qual marita una figliuola, contra sua voglia e come se ne fugge e va a ritrovare il suo innamorato, cosa bellissi-ma posta in luce per Gio. Gratio Brunetto à beneficio universale, stampata l’anno 1591.
29Serpi in senoGiancarlo Baronti 28
tutti e provocare reazioni repressive ed emotive all’interno di tutta la collettività.
Per chiarire meglio il senso di questa universalità è ne-cessaria una breve digressione che delinei il quadro socio-culturale nel quale si articolano i processi di comunicazione e ricezione dei componimenti dei cantastorie.
Dal punto di vista delle modalità concrete, dei compor-tamenti che di fatto si rappresentano per coloro che li com-piono come dotati di una forte ed indiscutibile rilevanza giuridica, si può affermare che nelle società d’antico regime coesistono, interagiscono e spesso confliggono tra di loro, due modalità di “pensare” e di “fare” giustizia.
Una è quella istituzionale e statuale che ha lasciato ar-chivi che ha prodotto codici e procedure scritte e che ha sempre orgogliosamente sostenuto di essere l’unica giustizia terrena abilitata, la Giustizia. L’altra modalità è costituita invece da quello che potremmo definire l’aspetto operativo di una sorta di diritto vivente, cioè dal tradizionale istituto della vendetta che ancora diffusamente regola i rapporti tra le diverse fazioni, parentele, agglomerati familiari, nei quali si struttura la vita comunitaria, secondo le modalità di aggre-gazione tipiche del patronage32.
Il modello di funzionamento della giustizia comunitaria basato sulla vendetta è fondato sulla reciprocità e sulla sim-metria, per cui calibrati scambi di violenza servono a mante-nere un equilibrio, se pur instabile e precario, tra le fazioni in lotta, mentre il funzionamento della giustizia statuale, basato sulla pena come deterrente esemplare e come retribuzione, è fondato sulla netta separazione e sullo squilibrio delle parti in causa. L’istituzione pubblica si pone come neutrale, come terza istanza rispetto ai contendenti, presentandosi autono-ma dal particolarismo dei singoli contesti di senso e cercando inoltre di neutralizzare, con la teatralizzazione collettiva del
32. Cfr. WicKham c. 1985: 846.
momento punitivo, l’universo delle alternative, la più cor-posamente consistente delle quali è appunto la possibilità del ricorso al tradizionale e radicato istituto della vendetta33.
La presenza dell’orientamento giuridico basato sulla reciprocità della vendetta che esclude il ricorso ad istanze esterne alle dinamiche in atto, non appare, nel periodo di cui stiamo parlando, solo un elemento residuale in via di ra-pido assorbimento ma costituisce una struttura ordinatrice e regolatrice che informa di sé consistenti settori della vita so-ciale, in contrasto con una visione della società che vede nel-la presenza e nel radicamento delle istanze promosse dalla giustizia statuale le uniche possibilità della convivenza civile.
In una situazione di questo tipo non è facile parlare di cri-minalità, non è semplice intendersi su quali siano i compor-tamenti da tutti sentiti e avvertiti come profondamente lesivi.
Di criminalità si può parlare solo in un contesto in cui il produttore di senso preponderante sia lo stato come eserci-zio impersonale della coercizione e dell’attività giudiziaria che individua astrattamente il crimine e poi in maniera selet-tiva concretamente lo persegue, nelle violazioni che si rivol-gono o direttamente contro l’assetto considerato legittimo delle relazioni sociali e dei rapporti economici o indiretta-mente nella trasgressione della legge emanata da coloro che tale assetto sociale garantiscono e custodiscono sia sul piano mondano sia su quello ultramondano. In concreto, in epoca moderna, la legge emana o dal sovrano o dalla divinità, per cui avremo crimini di lesa maestà umana, come ad esempio il porto di armi proibite e la falsa monetazione e crimini di lesa maestà divina come la bestemmia e la sodomia. In ef-fetti lo stato eleva, almeno dal punto di vista della “validità ideale”, al rango di “obbligazione universale” la tutela dei cardini dell’intelaiatura di interessi materiali e di significati simbolici sulla quale struttura e legittima la propria autorità.
33. Cfr. mosconi G. A. 1986: 240.
31Serpi in senoGiancarlo Baronti 30
Nell’orientamento giuridico basato sulla vendetta ha invece senso il concetto operativo di misfatto, inteso come atto volontariamente ostile, rivolto non ad un referente col-lettivo, generico ed astratto, ma concepito come “offesa”, come un oltraggio, nel suo significato di rottura di un giusto equilibrio tra le parti. Un atto diretto esplicitamente contro un gruppo, o contro un individuo in quanto esponente di un gruppo avverso, nel tentativo di lederlo materialmente o moralmente.
In questa prospettiva quindi il misfatto oltraggioso non è un comportamento “significativo” per l’intera collettività che debba essere gestito da un’istituzione che coaguli for-malmente la reazione generale. Esso riguarda esclusivamen-te il bersaglio più o meno ampio contro cui è volutamente indirizzato, il quale, appunto per ripristinare il capitale ma-teriale o simbolico intaccato, si adopererà per “vendicarsi”, nel senso appunto di mettere in atto comportamenti efficaci ed atti a mostrare significativamente alla collettività che è perfettamente in grado di tutelare il proprio capitale sim-bolico e di ricostituire o di ricompensare simbolicamente la perdita del suo capitale materiale.
Tornando al nostro tema appare chiaro come l’enorme numero di delitti individuati e perseguiti dalla giustizia dello stato ed il corrispondente enorme numero di giustiziati, in realtà non offrano poi “materiale” significativo dal punto di vista di coloro, come i cantastorie, che devono elaborare un prodotto che potenzialmente interessi tutti.
Certamente le cronache patibolari sono ricchissime di omicidi efferati, di violenze atroci, di ratti sanguinosi che però, all’interno dell’ottica familistica largamente diffusa, non solo non riguardano coloro che non vi sono implicati, ma sono fondamentalmente considerati, e spesso lo sono, azioni e reazioni giuridiche all’interno dell’ideologia della vendetta di cui la giustizia dello stato farebbe meglio a non impicciarsi e di cui spesso non s’impiccia. I mariti uxoricidi,
i padri o i fratelli che uccidono le rispettive figlie o sorelle in fin dei conti rientrano pienamente nella logica della tutela familistica del prezioso capitale simbolico dell’onore: com-portamenti non solo considerati legittimi ma dovuti, obbli-gati.
Significativa a tale proposito appare una storia34 nella quale si racconta come una giovane donna innamorata, per vendicarsi del fratello che le aveva ucciso l’amante per tute-lare l’onore della famiglia e che in seguito aveva meditato di uccidere anche lei per cancellare definitivamente l’oltraggio subìto, lo uccida a sua volta mentre fuor di ogni sospetto dor-miva. In questo caso esemplare il comportamento del fratel-lo è presentato come del tutto normale e doveroso (ripieno di giusto sdegno) anche quando meditava di sopprimere la sorella (se ne va per ammazzare parimente la sorella, ma du-bitando della Giustizia, & anco forse non volendo bruttarsi le mani nel suo sangue); la riprovazione e la condanna sono invece indirizzate esclusivamente sulla giovane donna (una sera con scelerata mente scannò con un coltello nel letto il fratello): i delitti maschili rientrano comunque all’interno del modello culturale dominante, quelli femminili invece lo minano alle fondamenta.
Per questo fondamentale motivo i delitti delle donne ri-guardano tutti, essi non solo non rientrano all’interno della ideologia della vendetta ma confliggono apertamente con essa: i delitti familiari delle donne sono atroci crimini per la legge dello stato, ma lo sono ancor di più per una comunità
34. Nuovo, et horrendo caso occorso in Roma, colpa del dishonesto Amore di una giovane, che ha scannato il proprio fratello, il quale havea ucciso il suo Amante; Et affogato nel Tevere il Facchino, che portava nel fiu-me il detto suo fratello morto, ove s’intende l’aspra morte di questa Donna. Con alcune Rime composte sopra Lorenzo, & Lucretia giustitiati in Roma, cosa degna da essere intesa, per essempio d’ogniuno. Stampato in Roma, in Bologna, in Vicenza, & ristampato in Mantova, per Giacomo Russinel-lo.1587. Con licenza de’ Superiori. 8 pp., prosa + versi.
33Serpi in senoGiancarlo Baronti 32
organizzata su basi segmentarie in cui la sicurezza all’inter-no della propria famiglia-fazione costituisce il prerequisito essenziale per la vita sociale.
La donna che uccide il marito o il padre scardina e di-strugge le basi stesse della possibile convivenza, mette in pe-ricolo la continuità stessa di una società che sulle strutture familiari e parentali allargate si regge.
Le donne che pur di ottenere i propri scopi, di solito estremamente materiali, non esitano a tradire il vincolo co-niugale o quello di sangue e la solidarietà familistica, “inte-ressano” veramente tutti.
Queste subdole serpi che nascostamente ingannano la fi-ducia colpendo proditoriamente gli uomini dove si sentono e dove necessariamente si devono sentire più al sicuro, più protetti, più al riparo dai nemici e dalle insidie, spesso som-ministrando la pozione venefica addirittura in quel cibo che invece tanto amorevolmente e servizievolmente35 avrebbero dovuto preparare36, fanno veramente paura a tutti.
Per questo le storie insistono tanto su questi delitti, si ostinano a descrivere le doppiezze, i sotterfugi, le astuzie, gli infingimenti delle donne, perché appunto esse costituiscono un pericolo maggiore del nemico, del rivale esterno che si teme ma si conosce; le donne invece tramano nell’ombra, sorridono amorevolmente mentre apparecchiano la morte:
Ecco la sera il povero maritoLa moglie abbraccia e bacia con amore,Disse: mi sento; oimè, tutto smarrito,Con sospettoso e tremolante core,Vorrei mangiare e non sento appetito,Mi sento male e non sento dolore;Disse la donna, ma finge, umilmente,
35. Cfr. Daenens F. 1983: 33.36. Cfr. rath K. D. 1987: 634.
Mangia marito mio che non è niente....37
Le storie insistono ossessivamente anche sull’aspetto subdo-lo e proditorio del crimine femminile: la vittima è colpita quando meno se l’aspetta generalmente nel sonno dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro:
...doppo cenato il marito stanco del viaggio andò al riposo nel letto. O tristo sonno per questo poverino, non pensa quella trista ed ultima notte che li aveva da succedere. Addormentato il me-schino andò la scellerata al letto...38
La finzione non finisce con la morte del marito ma continua per ingannare i parenti, i vicini e la giustizia:
...La scelerata moglie con finte lagrime dava a credere il dolore che aveva avuto per la morte del marito, solito inganno delle donne, senzaché la Giustizia si accorgesse di tal misfatto....39
I delitti familiari delle donne costituiscono quindi il crimi-ne per eccellenza, quello su cui tutti sono sicuramente d’ac-cordo, quello che consente ai cantastorie, diciamo così, di andare sul sicuro, di essere certi di non trovare disinteresse ed indifferenza. I delitti delle donne sono profondamente inesivi, il loro racconto mostra chiaramente, mette a nudo i fragili cardini su cui si reggono i destini degli uomini, le loro
37. La morte di Martia Basile Napolitana. Che fù condannata dalla Giu-stitia per haver fatto ammazzare il marito. Con la morte di quattro altre persone per tal causa. Composta da Giovanni della Carrettola Napoletano. In Terni, per il Guerrieri. Con licenza de’ Superiori. 1627. 12 pp., 50 ot-tave, XI ottava.
38. Relazione della gran Giustizia seguita nella gran Città di Turrino contro Margherita Stati per aver strangolato con le sue mani il Marito, e poi tagliato in pezzi, op. cit. cfr p. 3.
39.Nuovo, e distinto ragguaglio dell’enorme, e spaventevole caso segui-to nella Città di Seza Stato di Roma, dove s’intende come una rea femina per godere il Mondo ha avvelenato il Marito, op. cit., cfr. p. 3.
Giancarlo Baronti 34
storie fanno attingere al fondo del sociale e del culturale, rendono trasparenti le opzioni, le scelte su cui si fonda la convivenza umana.
Giancarlo Baronti
Donne e veleni.Conflitti di genere nella letteratura di piazza
una strana ePiDemia
Si sentì con stupore dell’istesso pontefice morire alcune persone d’una infermità che ben osservata da medici, non veniva giudicata naturalmente, ma più tosto d’ar-tificioso veleno dolcificato con ingrediente tale, che si rendeva impossibile il poterne dare alcun ragguaglio, perché quelli che mo-rivano di questo antidoto erano così belli e coloriti in volto, che non davano alcun indizio, anzi minimo contrassegno di veleno1
Così l’anonimo cronista inizia a raccontare la lunga e tormentata storia di quello che prima di essere un caso
giudiziario fu uno straordinario ed inquietante evento che almeno pubblicamente si concluse, durante un caldo pome-riggio estivo del 1659, in Campo de’ Fiori a Roma, con la rituale, purificatrice e soprattutto rassicurante esecuzione capitale per impiccagione di cinque donne.
La vicenda è abbastanza nota ed è stata anche accurata-mente analizzata nei suoi aspetti politici e sociali dall’Ade-mollo e nelle sue implicazioni di carattere tecnico giuridico
1. Cit. aDemollo a. 1881: 14.
37Donne e veleniGiancarlo Baronti 36
dal Mirogli2, che nella prima metà del secolo successivo ot-tenne una speciale autorizzazione papale per consultare gli atti processuali, tenuti accuratamente chiusi a chiave perché in essi erano descritti gli ingredienti e le modalità di prepa-razione del temibile veleno:
Processo che si conserva sigillato nell’Offizio del Governo e con il non aperiatur nisi de speciali ordine Illustrissimi Guber-natoris, a motivo che non possa da esso ricavarsi il pernicioso modo di comporre questo temporaneo veleno, ed avessimo il permesso dalla Santissima Memoria di Benedetto XIV di po-terlo aprire3.
Non abbiamo quindi intenzione di rivisitarla, se non a brevi linee, in quelli che potremmo definire i suoi apetti documentari ufficiali, ma solo di metterne in luce al-cuni aspetti sui quali ci pare interessante e importante approfondire la riflessione, ad esempio sulle modalità con le quali essa è stata costruita, interpretata, delimi-tata e definita dal meccanismo giudiziario e sul modo in cui è stata rappresentata, narrata ed amplificata nei componimenti dei cantastorie. La vicenda infatti, oltre ai misteriosi ma terrificanti veleni, contiene altri temi-bili e inquietanti ingredienti, se pur meno palesi, che la connotano in modo altrettanto decisivo e peculiare.
Il primo ed il più rilevante è che essa si qualifica im-mediatamente come uno sconvolgente complotto tut-to al femminile, come un terribile «sordo macello di mariti»4, compiuto da infide mogli in combutta tra di loro:
2. Cfr. miroGli F. 1764.3. Cit. miroGli F. 1764: 136.4. Cit. aDemollo a. 1881: 23.
Sabbato saranno impiccate in Campo di Fiore cinque donne artefici di veleno che uccideva senza darne verun segno, col quale avavano fatta la carità di liberare quietamente da mariti spiacevoli gram nimero di mogli scontente. E benché si speri che la ricetta muoia insieme con le maestre, non di meno si promulgherà un antidoto di poca spesa e sperimentato per ef-ficace, affinché chi temesse di aver preso questo tossico possa a tempo ripararvi5.
Se dai verbali del processo ogni tanto sembrano far capolino anche figure maschili di un certo rilievo, nella fase conclusi-va vengono accuratamente scremate e si perdono via via per strada, cosicchè alla fine, saranno solo donne (sei in tutto) a salire sul patibolo:
Rinnovossi per mezzo di tale invenzione la scelleratezza di quelle donne rammentate da Livio che attossicavano i loro mariti, perocché non ebbe notizia il fisco che altro genere di omicidio si commettesse con quel liquore, e come il peccato ha si brutta faccia che i suoi seguaci si argomentano di ricoprirla eziandio a se stessi, spacciarono queste malefiche l’arte loro per carità onde le sfortunate mogli si liberassero della tirannia degli insoffribili mariti6.
La repressione, oltre agli aspetti pubblici che si dipanarono con eccezionale solennità in tutta la città per poi concludersi in Campo de’ Fiori, sembrò averne anche di terribilmente segreti cosicché non è possibile conoscere il numero esatto delle donne che furono coinvolte e punite per cancellare le inquietudini e le apprensioni che tale episodio aveva susci-tato:
Sabbato 5 luglio 1659 doppo pranzo furono fatte morire im-piccate cinque donne in Campo di Fiore, le quali nelli Anni
5. Cit. sForza Pallavicino P. 1848: 89.6. Cit. aDemollo a. 1881: 23.
39Donne e veleniGiancarlo Baronti 38
passati nel tempo del Contaggio avevano dispensato Carafe di acqua distillata con veleni di arsenico e solimato per far morire la gente, con la quale acqua molte donne avevano ucciso li loro mariti et altri loro parenti, delle quali donne ne furono molte murate nelle carceri della Inquisitione7.
Tutto questo non doveva e non deve certamente stupire perché l’accoppiata donna-veleno, non solo tutte le volte che si adombra fa emergere con connotati fortemente ne-gativi e parossistici il problema della irriducibile e radicale “diversità” della donna, ma è anche una delle più ricorrenti fattispecie nella lotteria giudiziaria penale, oramai da seco-li assunta a vero e proprio luogo comune stereotipo, tanto che in ogni buon trattato di tossicologia, l’autore non poteva esimersi dal richiamarne l’indiscutibile validità e la provata verità:
Le donne sono state le prime inventrici d’un così barbaro modo di nuocere all’uman genere perché quel sesso imbelle riconoscendosi impotente ad eseguire le sue vendette a faccia scoperta contro il sesso virile, procurò di ritrovare il modo di farlo in occulto con sì orrido tradimento…8
Così, lapidariamente, si esprime Filippo Mirogli che badava al sodo e poco si curava di impreziosire la sua prosa tecnica con le quasi obbligate citazioni dei classici, ma in altri l’as-serto viene largamente documentato da impressionanti moli di citazioni bibliche e classiche9. Il fatto nuovo che emerge non riguarda quindi tanto e solo il sesso dei protagonisti e la diabolica e tradizionalmente scontata affinità tra le donne e i veleni, quanto il profilarsi e l’emergere in parallelo, nelle carte processuali e nell’immaginazione collettiva di un senso
7. Cit. GiGli G. 1953: 486.8. Cit. miroGli F. 1764: 3.9. Cfr. cosPi a. M. 1681: 405. In effetti il capitolo XXII del volume si
intitola: Che le donne sono più facili a dare il veleno.
di inquietudine e di turbamento nei confronti di quella che veniva interpretata come una sorta di associazione segreta, di una sotterranea collusione, una insidiosa trama di donne che aveva lo scopo esplicito sia di liberare le affiliate dai ma-riti scomodi, sia di propagandare e di diffondere a scopo di lucro gli strabilianti effetti ed i minimi rischi che presenta-va il nuovo ritrovato venefico. La cronaca giudiziaria, come abbiamo già detto, è molto ricca di figure di donne avvele-natrici, si pensi ad esempio a Prudenzia Anconitana, giusti-ziata a Firenze nel 1549 per aver avvelenato, sotto «diabolica istigazione»10 il proprio marito e la cui storia in versi è stata stampata e cantata nelle piazze per più di quattro secoli11, ma è la prima volta che dietro gli avvelenamenti si intravede un livello organizzativo collettivo, trapela una volontà espli-cita di generalizzare un modello drastico di risoluzione della conflittualità che spesso oppone la donna all’uomo all’inter-no delle mura domestiche, emerge la patente intenzione di fornire un servizio a disposizione delle donne che vogliono liberarsi dei mariti scomodi.
Altro elemento di estremo interesse è costituito dal fat-to che l’esecuzione capitale romana segna il momento più alto, il culmine di una sorta di panico collettivo, di inquie-tudine ed insicurezza di massa, di palpabile apprensione nei confronti del veleno, proprio alla metà di quello che non a torto è stato definito il secolo delle avvelenatrici12, a causa della straordinaria frequenza con cui si attivano nel corso del Seicento procedimenti giudiziari per avvelena-mento che vedono coinvolte un gran numero di donne. Ci sembrano ovviamente da scartare, sia l’ipotesi etiologica che
10. Cit. ronDoni G. 1901: 230.11. La prima edizione conosciuta è la seguente: Il Piatoso Lamen-
to Che fece M. Prudentia prima che fusse condotta alla Giustitia.Con la nuova giunta di tutto il caso successo di quanto disse & scrisse di man propria, In Fiorenza presso al Vescovado, MDLVII. del mese di Giugno.
12. Cfr. leBriGe a. 1981.
41Donne e veleniGiancarlo Baronti 40
postula un rapporto meccanico e “naturale” tra la frequenza dei reati e quella dei procedimenti giudiziari, che se appa-re improponibile adesso lo è a maggior ragione nel secolo diciassettesimo, sia l’altra ipotesi che vede nell’aumento dei procedimenti giudiziari per avvelenamento il riflesso di una migliore organizzazione e di un effettivo processo della scienza medica e della tossicologia che, almeno a considera-re i trattati sull’argomento del periodo in questione, paio-no difficilmente dimostrabili. In prima approssimazione si può notare che l’aumento dei processi per avvelenamento è immediatamente successivo a quello che si può definire lo sgretolamento del paradigma giudiziario ed inquisitorio della stregoneria al quale, nel periodo precedente era sta-to affidato il compito di gestire e reprimere la «malvagità femminile»13. In modo particolare negli stati della Chiesa la “Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum” emanata negli anni venti del secolo, aveva, in modo particolare a Roma, quasi totalmente eliminato i procedimenti per stregoneria, richiedendo per la loro istruzione la presenza di prove indubitabili e di indi-zi oggettivi e verificabili e svalutando nettamente quindi, le pure e semplici denunce, le dicerie e le confessioni non ac-certabili e non controllabili estorte attraverso la tortura. Ma il veleno, con tutte le connessioni simboliche che si trascina dietro e con tutta l’insicurezza e l’inquietudine che suscita, pare ricondurre ancora una volta l’ambito del contendere all’interno di una dimensione tanto poco tecnico-giuridica e tanto più pervasa di fantasmi oscuri ed inafferrabili che riproducono una sorta di complesso ossidionale. Il veleno sembra sempre provenire da quella zona oscura, margina-le, liminare ed inafferrabile all’interno della quale agiscono e si perpetuano tramite i saperi femminili le forze caotiche che assediano e tentano continuamente di distruggere e di
13. Cit. Muraro L. 1976: 100-101.
corrompere la cittadella della luce e della fede14. Anche se non si parla più di streghe, non è un caso che la principale imputata del processo romano, Girolama Spana, venga de-scritta come «detta Indovina, la quale, o sia vero, o falso, fu pubblicata per Fattucchiera, e che avesse commercio con il Demonio, con la scorta del quale possedeva l’arte d’indovi-nare le cose perdute, ed anche che predicasse le cose future, e che già avesse scoperte molte cose occulte a persone di riguardo»15 e che quindi il veleno si collegasse naturalmente a tale dimensione di dominio delle forze oscure della natu-ra alle quali si ricorreva abitualmente per modificare destini negativi che sul piano delle dinamiche relazionali esplicite e consapevoli non sembravano suscettibili di miglioramento.
Altro elemento importante è dato dal comprensibile cla-more suscitato dal caso e dall’ampia risonanza che ebbe in tutta la penisola, accresciuta indubbiamente dalla diffusio-ne di “storie” in versi composte da cantastorie e stampate in moltissime copie, che venivano cantate e contempora-neamente vendute nei principali centri. In questo modo le vicende ed il mito delle sventurate donne entravano pre-potentemente a costituire un nuovo capitolo, un ulteriore episodio di un costante e ricorrente filone della “letteratura di piazza”: quello dell’ostinato conflitto tra i sessi16 che vede una costante svalutazione della donna, considerata fonte di perturbazione dei legami sociali per la sua incontrollabile ed indomabile sessualità ed elemento di disgregazione e ro-
14. Cfr. corsi D. 1990.15. Relazione della morte di Gerolama Spana, e Graziosa Farina Fa-
bricatrici, e Dispensatrici dell’Acquetta, con la quale morivano le genti & con la morte Di tre altre Donne che servendosi della sudetta Acquetta, diedero la morte ai loro Mariti, Biblioteca Apostolica Vaticana, Mano-scritto Vaticano Latino 7439, ff. 214r -217v., cfr. f. 214v.
16. Cfr. Pasqualino a. - viBaeK J. 1987.
43Donne e veleniGiancarlo Baronti 42
vina delle famiglie per il suo costante desiderio di lusso e di sfarzo17.
il comPlotto Delle Donne
Le ricerche compiute negli archivi fra atti processuali e cro-nache locali hanno mostrato18 come l’episodio romano non costituisca assolutamente un fatto isolato, ma mostri eviden-ti collegamenti con eventi simili verificatisi prima a Palermo e poi a Napoli, fino a mostrare un filo sotterraneo che sem-bra unire le protagoniste ed ampliare a dismisura i confini e la rilevanza del caso che assume l’aspetto paradigmatico ed apocalittico di un complotto generalizzato delle donne con-tro gli uomini per realizzare praticamente, per concretare nei fatti una delle condizioni che secondo la tradizione, pre-annunciano l’imminenza della fine del mondo e del giudizio universale: quando tutte le donne saranno vedove...19
Il bandolo iniziale della matassa pare essere a Palermo dove nella prima metà del secolo XVII si contano numerose esecuzioni capitali per veneficio. La prima è del 9 maggio 1612 quando «nel piano della marina fu impiccata Seba-stiana di Arizzi, per aver avvelenato il marito Alessandro Arizzi»20. Non possediamo ulteriori notizie sul caso e quindi non si può escludere che sia stato un episodio isolato, men-tre invece negli anni seguenti la frequenza delle esecuzioni capitali pare configurare una forte e preoccupata risposta re-pressiva nei confronti di un complotto di vaste proporzioni:
17. Cfr. FarGe a. 1989.18. Cfr. martini m. 1915-16.19. Cfr. cocchiara G. 1963: 185.20. Cit. cutrera a. 1917: 176.
Il 17 febbraio 1633 fu giustiziata Francesca la Sarda (Ra-pisardi), come fabricatrice d’un veleno diabolico in acqua, della quale solo dandone una stilla in qualsivoglia cosa, facea perdere il calore naturale, e fra tre giorni al più ne morivano le persone che la bevevano, così in Palermo come nel re-gno... e vi andarono 60 mila persone onde ne caddero due con danno e però non si poté fare la giostra nel canevale
21 giugno, fu giustiziato Placito di Marco per aver composta acqua velenosa per ammazzare diverse persone
12 luglio fu giustiziata Thofania d’Adamo per aver fatto morire al quandam Francesco d’Adamo suo marito et altri personi con acqua venenosa…21
Si fece l’orrenda ma giustissima giustizia... per aver dato il vele-no a diverse persone con certa acqua maledetta...22
Il succedersi delle esecuzioni, la presenza dell’acqua veleno-sa ed il nome dell’ultima condannata che ha dato il nome al composto velenoso, da allora in poi denominato acqua Tofa-na, ci fanno comprendere che forse è in questi anni che co-mincia ad emergere l’ossessione e l’inquietudine del veleno che poi si diffonderà per giungere sino a Roma. Anche se le esecuzioni del 1633 segnano il momento culminante dell’af-faire dei veleni palermitani, l’attenzione nei confronti di un pericolo sentito come sempre incombente e proveniente da un mondo temibile, sconosciuto e sotterraneo non cessa de-finitivamente:
18 marzo 1634, fu impiccato Vincenzo Tuzzolino, per aver uc-ciso due mogli ed altre persone con acqua velenosa… 10 ottobre 1634 fu impiccata Catarina lo Duca per aver avvele-nato suo marito Blasi lo Duca…
21. Cit. cutrera a. 1917: 192-193.22. Cit. salomone-marino s. 1882: 10.
45Donne e veleniGiancarlo Baronti 44
27 gennaro 1648, fu impiccata Catarina Boni, per aver com-posto e fabricato polvere di veleno, qual vendeva a molti e ne seguirono molti avvelenati… 20 maggio 1665 fu impiccata Angela Sileci e Gattino come di-spensatrice di acqua avvelenata, per aver con l’acqua medesi-ma, ucciso una giovinetta23.
Ma mentre seguivano questi ultimi episodi anche a Napoli si incominciava a parlare dell’acqua velenosa:
Giovedì primo agosto 1645 fu carcerata una donna raccoglitri-ce alla quale fu trovato nella propria casa un fiasco pieno d’ac-qua stimata della medesima qualità che dispensavano mediante pecunia, gli anni addietro due altre raccoglitrici, che furono impiccate, che fa morire le persone a tempo, senza che se ne accorgano…24
Ma il fenomeno sembra raggiungere la sua massima intensità a Napoli solo in un periodo successivo alla vicenda romana e cioè nei primi anni del secolo seguente allorché incomin-ciò a circolare per la città voce che «l’acqua Tufania... era sparsa non solo nel Regno, ma anche in Roma e in altre parti, in modo tale che non v’era persona sicura della vita ed era penetrata anche nei monasteri... tanto che causò timore tale che non si condiscendeva a prendere rinfreschi in casa d’al-tri, anzi si soffriva la sete, sospettandosi di molti esser morti dell’acqua»25.
Gli effetti della diffusa inquietudine che sembra trasfor-marsi in vero e proprio panico e della mobilitazione popo-lare il popolo era in grande aspettativa di veder castigata l’enorme rea26. non si fecero aspettare molto e anche se la principale imputata, Caterina de Martino detta la Scartel-
23. Cit. cutrera a. 1917: 194-216.24. Cit. aDemollo a. 1881: 4.25. Cit. martini m. 1915: 375.26. Cfr. martini m. 1916: 378.
lata, riesce a sottrarsi alla giustizia a causa di un prolungato conflitto tra la curia arcivescovile ed il tribunale laico che l’aveva fatta arrestare in luogo immune, altre complici salgo-no sul patibolo:
Nel giugno del 1716 furono fatte impiccare al Mercato tre don-ne: una era Bizzocca, un’altra di Chiaia e l’altra di Fuorigrotta, e, un anno dopo Orsola Antonucci, già famosa a S. Giovanni a Mare per facinora egregia torturata tamquam cadaver rendeva sulle forche l’infame bell’anima insieme con Laura Melluso e Grazia Trinchella27.
Anche Napoli quindi, dopo Palermo e dopo Roma, si pu-rifica dei veleni e tenta di rassicurare l’inquietudine e il ti-more serpeggianti tra la popolazione innalzando patiboli e indirizzando la repressione nei confronti di donne elevate a simboli rappresentativi dei poteri malefici, oscuri e subdoli del veleno. Appare infatti stranamente singolare che con la sola e scarsamente significativa eccezione di Palermo28, tutti i condannati a morte siano donne anche se dai documenti processuali emergono con evidenza chiare responsabilità di personaggi maschili che hanno acquistato ed utilizzato il ve-leno, ma che restano assolutamente impuniti, perché in loro si sarebbe potuto scoprire l’altra faccia del veleno quella che interessa soprattutto le lotte interne ai ceti dominanti29.
27. Cit. martini m. 1916: 379.28. Ad onor del vero è da rilevare che anche a Napoli il 20 luglio
1713 viene giustiziato un uomo accusato di aver avvelenato la moglie e un degente dell’ospedale degli Incurabili, ma è da notare che innanzitutto non fu giustiziato pubblicamente ma strozzato all’interno del carcere della Vicaria e che poi egli appare essere niente di più di uno strumento nelle mani della sua amante, la moglie dell’avvelenato, certa Antonia Piscopo che aveva preparato l’acqua velenosa ed era stata l’istigatrice dei due delit-ti. La Piscopo verrà pubblicamente impiccata a Baia il 22 agosto (Martini M. 1916: 565).
29. Cfr. tricoli G. 1980: 76
47Donne e veleniGiancarlo Baronti 46
E anche a Napoli come a Roma la figura di quella che viene ripetutamente indicata come la principale responsa-bile, pare emergere dalle zone oscure di un humus culturale impastato di pratiche di bassa magia, di un mondo rovescia-to e misterioso nel quale non riescono a entrare e dominare i valori della legge e della morale convenzionale. Si tratta, al pari di Gerolama Spana, di una donna largamente cono-sciuta per la sua fama di operatrice in grado di dominare e controllare le forze occulte che regolano la vita degli uomini e ad essa si ricorre abitualmente per avere filtri d’amore oltre che per acquistare l’acqua velenosa atta anch’essa a risolvere per il meglio situazioni di vita familiare e sociale che i clien-ti si autorappresentavano come bloccate indefinitivamente in modo assolutamente negativo: il movimento di clienti descritto da Caterina De Martino nella sua confessione ai giudici si indirizza, pare indifferentemente, verso il veleno o verso il filtro d’amore, ambedue considerati come “scorcia-toie” che la clandestina “medicina delle donne” metteva a disposizione per risolvere il “problema” particolare dal qua-le ognuno di loro si considerava afflitto30. Anche durante la grande stagioni dei veleni quindi, il bersaglio più facilmen-te individuabile, più comodamente isolabile dalla giustizia punitiva e più adatto ad essere offerto ai grandiosi rituali patibolari di morte e di espiazione, è costituito da quelle donne che partecipano di una cultura sotterraneamente e tradizionalmente tramandata che riesce a utilizzare e a do-minare le forze e le entità che sono tenute a distanza e conti-nuamente esorcizzate dalla società cristiana: le donne come «Circi sempre intente a preparar veleni»31 ove la subdola costanza nell’attività di distruzione del mondo si sposa alla dimensione pagana. Il paradigma giudiziario della stregone-ria e dietro di esso il fantasma inquietante di una sessualità
30. Cfr. martini m. 1915: 349-351.31. Cit. FarGe a. 1989: 146.
femminile non domesticabile e inculturabile, ufficialmente abolito, manifestamente assente nelle modalità esplicite con cui si dipana l’iter giudiziario, continua a connotare come modello culturale latente non solo l’operato dei giudici ma anche ad indirizzare i risentimenti e le aspettative popolari.
Il caso romano mostra chiaramente il modo in cui non solo è stata completamente riscritta al femminile la vicenda sia in sede giudiziaria sia a livello di opinione pubblica, ma anche come immediatamente sia emersa in tutta la sua per-turbante evidenza la realtà di un vasto complotto femminile teso a minare le basi della convivenza civile e della morale cristiana, architettato da donne «di mal nome ed assuefatte alle scandalose ed indecenti conversazioni e spassi, ai piaceri vituperosi del mondo»32.
Donne che mal sopportavano l’autorità ed il controllo di mariti severi, violenti e stretti di borsa e che quindi escogi-tano accordandosi tra di loro un mezzo discreto, sicuro e soprattutto poco appariscente per liberarsene. Donne che rifiutano gli effetti spiacevoli del dispositivo di alleanza che regolava i matrimoni e che costringeva parecchie giovani a maritarsi con uomini molto più anziani di loro o con vecchi vedovi33 e che invece manifestano apertamente di preferire un dispositivo di sessualità che privilegi i sentimenti e la reci-proca attrazione fisica e che quindi vogliono “rovesciare” il mondo capovolgendone i valori e mettendo quindi in primo piano le istanze corporee del piacere fisico e della sessualità. Donne che pur di ottenere il proprio scopo non esitano a tradire il vincolo coniugale e ad assassinare il coniuge sot-to il tetto domestico ingannandone la fiducia e colpendolo, serpi in seno, proditoriamente proprio là dove si sentiva più
32. Relazione della morte di Gerolama Spana, op. cit. cfr. f. 215v.33. È nota la riprovazione popolare per tali tipi di unione troppo
squilibrati che si esprime nella rituale e tradizionale forma dello charivari. Cfr. le GoFF J. - schmitt J. c. 1981, rey-FlauD h. 1985.
49Donne e veleniGiancarlo Baronti 48
sicuro, più protetto, più al riparo dai nemici e dalle insidie, somministrandogli la pozione venefica addirittura in quel cibo che invece tanto amorevolmente e servizievolmente34 dovrebbe preparare35. Donne infine che si ostinano nell’om-bra a tramare ed operare con l’aiuto delle forze del male per distruggere ciò che faticosamente l’uomo riesce a costruire alla luce del sole.
L’elenco che emerge dal procedimento predisposto dai giudici romani, anche se parziale è notevole: come dice l’A-demollo36 si tratta di una vera e propria strage di mariti, circa diciassette in tre anni ai quali si deve aggiungere un genero, troppo geloso della moglie, e forse un altro marito, un per-sonaggio importante, il duca di Ceri. Di lui, anziano e di debole complessione e della sua bella e giovane moglie il processo, tutto indirizzato a colpire le donne dei ceti popo-lari, tace, ma la voce popolare non faceva mistero delle cause della morte dell’anziano patrizio ed anche dalle confessioni di alcune imputate emerge il nome, dai giudici palesemente ignorato forse per ordine superiore, di Maria Caterina Al-dobrandini duchessa di Ceri, che si diceva innamorata e si voleva levare di torno il marito37.
Sembra proprio che a tradire le donne e a farle cadere nelle mani dei giudici sia stata la fretta mostrata da alcune di esse di risposarsi dopo la morte del precedente marito:
Fra i morti di questo male furono il cavamacchie a S. Salvator delle Cuppelle, il marito della bella macellara e il marito del-la linarola a ponte Sisto: Monsignor Baranzoni, Governatore di Roma, che ne era stato avvisato, andò personalmente a S. Salvatore alle Cuppelle, per fare qualche osservazione, et egli stesso si confermò nel sospetto, e credette fermamente che non
34. Cfr. Daenens F.1983: 33.35. Cfr. rath K. D. 1987: 634.36. Cfr. aDemollo a. 1881: 24-27.37. Cfr. aDemollo a. 1881: 30
fossero morti naturalmente ma violentemente. Si accrebbe il sospetto che li descritti passati all’altra vita erano maritati a tre bellissime giovani con precedenti disgusti, e con finte la-crime, apparenze strepitose e novi sponsali con gran fretta conchiusi...38.
Ma i sospetti restavano sospetti e tutte le indagini sembrava-no infrangersi contro quello che appariva il robusto steccato dell’omertà femminile, allorché una donna, in confessione, rivela di essersi liberata del marito grazie all’acqua velenosa datale da una sua compiacente amica e dal quel momento in poi l’inchiesta comincia ad ingranare ed a macinare sul serio. Per incastrare colei che veniva considerata la mente di tutto il complotto, gli inquirenti ricorrono però ad un sotterfugio che la dice lunga sul loro modo di rappresentar-si la situazione: fanno giungere in gran segreto da Fermo a Roma la moglie del Bargello che fingendosi una nobildon-na disperata per le malvagità del coniuge riesce ad ottenere dalla Girolama Spana il tanto sospirato corpo del delitto, una bottiglietta di acqua tofana. Le precauzioni prese, se mostrano come coloro che conducevano le indagini pensas-sero effettivamente di trovarsi dinnanzi un fronte compatto di donne impossibile da infrangere, manifestano per di più come gli inquisitori non si fidassero neppure di alcuna don-na di Roma, quasi che l’ipotizzato complotto assumesse ai loro occhi l’aspetto di un conflitto talmente generalizzato e diffuso, da costringerli per maggior sicurezza a ricorrere ad una persona fidata fatta giungere appositamente da fuori: il mondo delle donne è visto come un universo a parte, chiuso ed incomprensibile per gli uomini che possono penetrarvi con mille difficoltà e solo mediante l’aiuto di altre donne.
38. Cit. aDemollo a. 1881: 15.
51Donne e veleniGiancarlo Baronti 50
il monDo Delle Donne
Per coloro che seguivano con attenzione i componimenti che i numerosi cantastorie diffondevano e recitavano nel-le più diverse situazioni ed occasioni, ove trovassero un buon numero di gente raccolta, il grande macello romano dei mariti non poteva certo costituire un evento inaspettato e suscitare una grande sorpresa. Non solo da lungo tempo erano abituati a sentirsi ripetutamente enumerare in piazza le infinite malizie delle donne39 e ad essere messi in guardia sui pericoli del matrimonio40, ma erano stati già da tempo minuziosamente avvertiti sui pericoli connessi alle unioni matrimoniali basate esclusivamente sul dispositivo di alle-anza, attraverso una storia veramente opportuna «dove si da essempio a quelle Donne, quali sogliono per volontà della
39. Nove mila nove cento novanta nove Malitie delle Donne. Nelle quale si narra tutti gl’inganni, astutie, falsità, tradimenti, robbarie, assassi-namenti, belletti, solimati argento vivo, unguenti, impiastri, & pelamenti. Cioè che usano le false, & scelerate Cortegiane per gabbare i semplicetti giovani, che di loro s’innamorano, si come la signora Lesina gli discopre, sopra il corpo d’una femina volendo operare il suo ingegno, non basta-rebbe, ch’el Ciel fosse carta, i mar fosse inchiostro, e gli arbori fossero penne, volendo compitamente narrare le sue gran falsità. Composte per Antonio de’ Santi Fiorentino. In Venetia, Appresso il Bonfadino. 1614 Con Licenza de’ Superiori, Et Ristampata, Appresso Alessandro Vecchi. 8 pp., 25 ottave.
40. Le malizie delle donne con la superbia, e pompa, che usano, e in-segna alla gioventù a trovare buona Moglie, con un’esempio a’ Maritati di attendere a Casa sua. Opera nuova, onesta, piacevole, e da ridere. Milano, per Francesco Bolzani. Con licenza de’ Superiori. 8 pp., versi.Il Marito disperato il quale si lamenta della trascurata vita della Moglie. Con una canzone sopra la instabilità della Fortuna. Opera nuova di Gio: Briccio Romano. Data in luce da Lorenzo Barbereti, da Pistoia. In Mace-rata, & in Terni. Per il Guerrieri. Con licenza de’ Superiori. 1619. 8 pp., versiAvvertimento a’ chi desidera di pigliar Moglie al tempo da desso. Opera Ridicolosa, e Bella. In Bologna, Presso Domenico Barbieri. Sotto le Scuo-le. Con licenza de’ Superiori. 8 pp., versi.
robba dare marito vecchio alle loro figliuole, & poi le figliu-ole li danno morte, per pigliarsi piacerecon un’altro marito più giovane»41. La storia in questione, del cui profetico auto-re purtroppo non conosciamo il nome, inizia con i lamenti di una giovane che non vuole accondiscendere al matrimonio “squilibrato” combinato dal padre:
Che non lo brama, nè vuol tal marito,Che ad altra parte sta suo cuor ferito
La consolazione canonica della madre che non può opporsi alla volontà del capo famiglia rientra pienamente all’interno dei luoghi comuni della letteratura di piazza in cui le figu-re delle donne anziane e “vissute” appaiono generalmente provviste di un senso pratico che spesso inclina su di un ver-sante decisamente immorale e candidamente cinico:
Non ti turbar figlia se pur è vecchioQuel che ti dà tuo padre per consorte,Questo partito te piacia più che altri,Che in breve tempo se’ l toglie la morte...Con l’acuto falcion, tagliente e forte;Tu resterai patrona d’oro, e argento,Et haverai marito al tuo talento.
La giovane però non si lascia consolare dalle sagge anche se forse non del tutto disinteressate parole della madre e pur obbedendo, medita di abbreviare la vita a quel marito, che una tradizionale prassi matrimoniale42 basata sul dispositivo
41. Historia bellissima dove si da essempio a quelle Donne, quali so-gliono per volontà della robba dare marito vecchio alle loro figliuole, & poi le figliuole li danno morte, per pigliarsi piacere con un’altro marito più giovane. Novamente postain luce. In Viterbo. Con licenza. 1623. 8 pp., 30 ottave.
42. Cfr. casanova c. 1987: 69.
53Donne e veleniGiancarlo Baronti 52
di alleanza tra le famiglie e non sulla libera scelta degli indi-vidui, le aveva dato suo malgrado :
Ottantacinque anni havea il vecchiarello,Venti ne havea la bella giovinetta,Sempre pensava al giovinetto bello,Quello che la tenea d’amore costretta,Per sodisfare l’horribil martelloDi dar la morte al vecchio si dilettaLa donna per sodisfar il suo appetitoPensa dar la morte allo marito.
E ovviamente il suo primo pensiero corre a quell’arma che oramai appariva pienamente sposata all’elemento femminile e che certamente in una storia di piazza, luogo di cristalliz-zazione e riproduzione del senso comune, non poteva man-care: la fresca sposa si procura, tramite l’amante, del veleno, ma le cose non prendono la giusta piega:
Havea la bella donna inordinatoDare al marito suo crudel veleno Dal suo caro Signor li fu portatoUn bicchier di tossico pien pieno,E per destin di man li fu cascato,La bella donna si stracciò il seno,Non lasciarò per questo ogn’altro modoScioglier dal petto l’intricato nodo.
La storia prosegue descrivendo l’uccisione del marito con-certata con l’amante che però all’ultimo momento esita e manda avanti la donna:
Il giovin poi con gran paura e scornoTremando cadde lo pugnale in terra, La infuriata donna prese lo pugnale,Dando al marito ferita mortale.
Il resto si snoda secondo l’abituale copione che caratterizza simili storie: la giustizia divina non può permettere che l’e-norme delitto rimanga impunito e fa in modo che la giustizia terrena ne venga a conoscenza, i due amanti sono condanna-ti a morte e la donna, pur pentendosi del delitto commesso, fin sul patibolo non cessa di rivolgersi all’amato:
Salendo per la scala la giovinetta,Disse ò Signor della celeste corteTi prego che l’alma nostra al ciel sia eletta,Perdona a noi l’error fallace e forte;Poi si voltò all’amante, e disse, aspettaAnima mia, ch’adesso vengo a morte...
Ai piedi del patibolo i genitori della sventurata riflettono amaramente sui loro errori:
Lo padre e la sua madre meschinellasono pentiti assai di simil sorte43, dicendo, ò sventurata figlia bella,che per amor ti veggo giunta a morte,Scurata s’è per me ogn’altra stella, Ohimè, che a tue preghiere non fui accorte,Quanto fu grande il mio vano appetito,per robba le diedi un vecchio per marito.
La morale finale, messa in bocca, secondo il tradizionale topo letterario delle “ultime parole del condannato”, alla povera fanciulla in procinto di essere giustiziata, non pare però scaturire naturalmente dalle sequenze del racconto, ma sembra veramente posticcia, aggiunta in fondo solo per ri-spetto della morale corrente:
43. Nelle ottave precedenti le lettere iniziali di ogni verso sono maiu-scole, mentre in questa e nelle ottave successive cominciano a comparire delle minuscole: probabilmente il compositore aveva esaurito alcune let-tere maiuscole.
55Donne e veleniGiancarlo Baronti 54
Signori vogliate essempio portareA l’altre donne di mia crudel sorte,Che non si lassino d’amore ingannare,Che portino rispetto al lor consorte,Vogliano honor e fedeltà portareMentre che han vita, ancor dopo la morte,Dite che pensi a me chi segue amore,che non serve il celar fatto l’errore.
Indipendentemente dalla morale esplicita che l’autore pare quasi costretto ad introdurre per attenuare le conseguenze della “logica” del racconto, emerge una morale implicita di straordinario interesse. Prima di tutto trapela l’imma-gine di una malvagità della donna che non è strutturale ma contingente, legata cioè al fatto che le dinamiche dei rapporti sociali gestiti dagli uomini costringono le donne, in determinate occasioni, a reagire, a ribellarsi. In secondo luogo emerge che tale reazione non è irrazionale, anarchica e distruttiva, ma espressa in funzione di un rifiuto della su-bordinazione della sessualità alla riproduzione dei rapporti di parentela. La donna quindi non accetta di sottomettere la sua sessualità ed il suo desiderio alla regola delle allean-ze, al gioco degli scambi matrimoniali, che non tengono in considerazione le propensioni individuali e gli aspetti cor-porei ed emozionali ritenuti naturali e fondamentali per la scelta del coniuge e quindi, non potendo agire altrimenti, cerca di minare internamente e nascostamente il patto al quale suo malgrado è stata costretta, da meccanismi sociali che non controlla e nella quale si trova costantemente in posizione subordinata.
L’opzione di compromesso della società tradizionale, che accetta le unioni squilibrate ma parallelamente ne canalizza la disapprovazione a livello simbolico nelle manifestazioni rituali del charivari, con lo scopo anche di esorcizzarne le possibili conseguenze negative, non riesce certamente a tam-
ponare in modo generalizzato i livelli di insofferenza che in modo particolare nelle situazioni urbane si manifestano e che l’accorto cantastorie aveva colto lanciando un monito rimasto inascoltato: non date marito vecchio alle figliole...
L’alternativa pratica a tale situazione che troverà una certa, ma sicuramente socialmente limitata, applicazione nel secolo successivo, sarà quella di svincolare l’unione ma-trimoniale dall’esercizio dell’attività sessuale, di separare la regola sociale del dispositivo di alleanza dalla propensione individuale al dispositivo di sessualità e quindi di permet-tere nella prassi una libera scelta dei partners sessuali indi-pendentemente dal vincolo matrimoniale. All’epoca della grande stagione dei veleni però non solo era più largamente diffusa l’abitudine ai cosiddetti matrimoni d’interesse, ma i mariti esercitavano una strettissima vigilanza sulle mogli, fil-trandone le frequentazioni e controllandone l’abbigliamento e l’ornamento come si può verificare nei consigli impartiti a “quelli che devono prender moglie”:
Essendo a tavola vi tirerete davanti il miglior boccone, perché ella veda la Padronanza assoluta, che avete in casa. Le negarete talvolta qualche cosa, che dimanda, per non mostrarvi obli-gato a sodisfarla del tutto. Non le farete carezze ch’una, o due volte la Settimana, acciocchè il troppo domesticarsi non renda noja. Non le conferirete segreto alcuno, per non iscoprirvi sì sciocco d’aver bisogno de’ suoi consigli. Non le permettere-te d’uscir di casa, acciocchè conosca l’ubbidienza, che a voi si deve. Non le concederete gran libertade sù la Famiglia per non scemare l’autorità della vostra. Sopra ogni cosa guardate bene a non darle ne pure un minimo segno, che siate innamorato de fatti suoi, che s’ella se ne accorge, siete spedito44.
44. Sopra quelli, che devono prender moglie. In Piacenza, Parma, Ferrara, ed in Bologna, per Clemente Maria Sassi Successore del Benacci. 1740. Con licenza de’ Superiori, 4 pp.
57Donne e veleniGiancarlo Baronti 56
La sequela ininterrotta di negazioni mostra chiaramente come il compito essenziale dell’uomo all’interno della vita di coppia deve consistere in una tenace, paziente e diuturna opera di contenimento, di addomesticamento, quasi di civi-lizzazione di una sorta di naturalità indomita e inquieta che spesso necessità di mezzi di controllo anche violenti45.
Abbiamo comunque mostrato come attraverso la lette-ratura di piazza fosse già emersa e fosse stata chiaramente esplicitata una situazione di sorda inquietudine, di profonda e vasta insofferenza femminile nei confronti di un modello di scambio delle donne che non tiene conto delle propen-sioni personali: la vasta produzione di exempla che non ri-guarda solamente i casi di mogli che uccidono i mariti46, ma
45. Canzonetta nuova sopra la pazzia di una sposa guarita dal bastone sul nuovo intercalare di Nicodemo Lermil, 2 pp., 10 strofe di sette sette-nari.Novella di Madonna Isotta da Pisa, di nuovo posta in luce, non meno honesta che ridiculosa, e piacevole. Dove si comprende la sapienza d’un Giovane nel corregger la superba moglie. Composta per il famoso Andrea Volpino da Soverzoch. Stampata in Siena. 1581. 16 pp., 60 ottave.
46. La produzione è molto amplia ed in questa sede offriamo sola-mente alcuni esempi:Caso crudelissimo, successo nuovamente nella città di Parigi, dove s’in-tende come una Donna avvelenò il suo Marito ed uccise il proprio Figlio. Con due prodigiosi Miracoli, uno della Beata Vergine Maria del Rosario, e l’altro di S.Antonio da Padova, con molti accidenti occorsi, In Lucca, per Domenico Ciuffetti, Con lic. de’ Sup., 46 ottave.Crudelissimo assassinamento occorso nella Città di Reggio di Lombardia, nel quale s’intende la Morte d’un Nobile Cittadino, datale da duoi Villa-ni con consentimento della Moglie, e della sua Serva. Opera degna d’es-ser intesa per esempio d’ogni fedel Christiano. ad istanza de Domenico Barbi[e]ri. In Bologna per il Moscatelli 1626. Con licenza de’ Superiori. Caso maraviglioso e compassionevole, nuovamente occorso nella Città di Ragusa. D’una perfida donna, la quale ha fatto morire il marito, & uccisi i proprij figliuoli, e lei s’è impiccata. caso compassionevole, e degno da essere inteso da ogn’uno. In Venetia, & in Viterbo. 1620. Con licenza de’ Superiori, 8 pp., prosaIl lacrimoso lamento qual fece la Signora Giovanna Vicentina, la quale fu
anche di figlie che per non sottostare a matrimoni combi-nati contro la loro volontà sterminano la propria famiglia47, anche se spesso insiste sulla necessità di meglio controllare, all’interno della famiglia, le componenti femminili, con la sua insistenza su tali temi continua a mettere in primo piano gli effetti devastanti di un conflitto perenne ed irrisolto.
Ovviamente del tutto diverso e meno accomodante il tono che i componimenti di letteratura di piazza assumono nel raccontare i fatti di Roma, insistendo dettagliatamente sulla malvagità quasi allo stato puro delle donne giustiziate. Abbiamo rintracciato due storie notevolmente diverse fra
decapitata & di poi squartata, per aver ammazzato il suo Marito. Aggiun-tivo anche di nuovo il lamento dell’Amante, qual fece avendo la sua testa in braccio. Ad istantia di Pantalon Braghetta, Stampata in Parma, Con licenza de’ Superiori, 8 pp. 22 + 23 terzine.
47. Nuova, e distinta relatione di una diabolica rissolutione, seguita nella Città di Malta di una Figliuola di età di 19. Anni, quale dominata dal Diavolo, hà dato morte al proprio Padre, e Madre, e due Figliuoli, uno di trè Mesi, e l’altro di 15. Con il severo, e giusto castigo, che ne hà fatto la Giustitia, & un’avvertimento che fece al Popolo avanti la sua morte. Seguito alli 10. Agosto del 1672, In Bologna, per Giacomo Monti. 1672. Con lic. de Superiori. 4 pp., prosaSentenza di morte seguita in Napoli Li 15. Aprile 1780. Di una Figliuola di un Gentiluomo d’età d’anni 19. in circa, la quale essendo innamoratadi un bellissimo Giovine Figliuolo di un Mercante, il Padre, e la Madre non vollero acconsentire alle Nozze, perciò di notte tempo con un Stilo ha dato la morte ai proprj genitori mentre dormivano, e dippoi se n’è fugita con il suo Amante. Ed essendo presa dalla Giustizia con il medesimo, die-de ad ambedue come anche alla Balia la Morte. E poi sentirete la Morte di sette Marinari, che menavano via la Figliuola, e l’Amante con grandissimi Esempj, che ànno lasciato a’ Figliuoli, acciò si allevino col santo timor di Dio. I nomi delli suddetti Marinari sono questi. Michele Squadrello, di anni 41. Francesco Fileso di anni 26. Fabrizio Bianchi di anni 40. Orazio Franchi di anni 25. Vincenzo Valetti di anni 28. Biagio Rotoni di anni 37. Marco Segato di anni 20. In Napoli, Roma, ed in Pesaro. Con licenza de’ Superiori. 4 pp., prosa.Opera nuova d’una madre la qual marita una figliuola, contra sua voglia e come se ne fugge e va a ritrovare il suo innamorato, cosa bellissima posta in luce per Gio. Gratio Brunetto à beneficio universale, stampata l’anno 1591.
59Donne e veleniGiancarlo Baronti 58
loro quanto al contenuto ma sostanzialmente simili quanto all’impostazione generale.
La prima48 stampata in epoca immediatamente successiva ai fatti, sulla base di altra stampa folignate non rintracciata, rivela una scarsa conoscenza dei particolari ma dispone in maniera molto accorta gli eventi all’interno di una rappre-sentazione dominata dal fantasma perturbante della fem-minilità come “irresponsabile” e della sessualità femminile come incontinente e sfrenata:
Se dell’horribil caso haveteEl più crudele, che mai successoHoggi nel Mondo sentiretePunto per punto vi narrarò appressoTanta crudeltà quanta vedeteDi queste ingiuste donne sì perversePer cavarsi suoi falsi appetitiFe morir molta gente e lor mariti.
Dopo questo inizio che entra immediatamente in argomen-to, contrariamente alle abitudini tradizionali dei cantasto-rie che usualmente si dilungano in invocazioni alla divinità o alle muse, vengono accuratamente dispiegate le iniquità commesse dalle donne:
Se suo marito a casa ritornavaCredea pigliarsi piacere e dilettoE della sua mogliera si fidavaStava sicuro senz’alcun sospettoE lei la medicina preparava
48. Relatione del lamento e morte di alcune scelerate Donne, le quali hanno fatto morire i loro Mariti, con moltissime altre persone, in Roma, & altri luoghi con darli Acque Velenose, dove sentirete tutto il successo come proprio è seguito. In Foligno, & in Bologna, per Domenico Barbie-ri, In S. Mammolo, Alle due Rose. 1659. Con licenza de’ Superiori. 8 pp., 24 ottave.
Poi gliela dava avanti che andasse a lettoE piangere il suo male poi fingeva,E tra di loro gran festa faceva.
La contrapposizione all’interno della famiglia tra la figura maschile, fiduciosa, serena, sicura ed ignara delle insidiose trame muliebri e quella femminile infida, ingannatrice e si-mulatrice, non potrebbe essere più netta; alla fine dell’ottava emerge anche la contrapposizione tra la solidarietà tradita del vincolo familiare ed una solidarietà “estranea” alla fami-glia, ricercata all’interno del mondo femminile. È il prologo del complotto:
Se una mettea sotterra il suo maritoDa ste donne tornava in affettoMi ho cavato il mio appetito,E mi son levata la doglia del petto,Hora trovaremo altri partiti,E ci pigliaremo piacere, e diletto,E se per sorte siamo maltrattateFaremo come ho fatto per il passato.
La donna vive di appetiti, è ossessionata dal piacere e im-mersa totalmente in un’aura di sensualità, la sua sessualità è incostante ed incontinente, si è appena liberata di un uomo e già progetta di liberarsi del prossimo se non sarà di suo completo gusto e non le concederà abbastanza libertà. Per-chè appunto le sue aspirazioni non vanno oltre la sensualità corporea e la storia insiste ripetutamente su tale inclinazione che caratterizza in modo decisivo la natura femminile:
Pensando sempre al mondo gioireDarensi spasso, piacere e contento. (VI ottava)...Care sorelle mie non dite niente Che ci possiamo pigliare piacere. (VII ottava)...
61Donne e veleniGiancarlo Baronti 60
Quando credeva star allegramenteSi perse ogni piacere ogni contento. (VIII ottava)
La storia poi, seguendo i tradizionali canoni, si dipana attra-verso le immancabili sequenze della scoperta del complotto, della carcerazione delle donne, della tortura e della confes-sione per poi indugiare nella parte finale sugli aspetti più coinvolgenti della cerimonia patibolare, il pentimento, le preghiere, i rimpianti.
A tale proposito, ed appare anch’esso un elemento tra-dizionale e stereotipo della vena di misoginia che percorre larga parte della letteratura di piazza sottolineando in ne-gativo la diversità femminile anche nei momenti estremi, è importante notare come, negli attimi finali che precedono la morte e pur dopo essersi pentite delle loro malefatte, le cin-que donne sembrino ancora anelare verso quelle aspirazioni di vita che le avevano condotte al patibolo:
E tra di loro cominciorno a direS’è perso ogni piacere, ogni contentoE li miei gusti ritornan sospiriA l’hor da tutti eram visitate, Et hor morimo alla forca appiccate...
E perso ha il color nostra figuraOgni bellezza mette sotto terraNostro giardin sarà la sepoltura,Le feste, spassi, e giuochi homai si serra...
Hora non serve più di farci bella,Tutto lo giorno attorno per lavareNon serve più ne busti nè gonnellaE manco le gioie potremo portareE perso il parlar, e la favellaTornarò in gran pianto il mio cantare...Hora non serve a noi dar medicinaCento bon giorni, e una mala mattina
Nella contrapposizione retorica tra il destino che incombe (una mala mattina) e la vita trascorsa(cento bon giorni) le donne continuano a rievocare i piaceri e gli appetiti caratte-ristici della loro visione del mondo.
Nella chiusa finale non può mancare insieme al riepilogo dell’argomento una minacciosa esortazione:
A migliara, e migliara morte ha dato Come nell’Historie hora si senteQueste donne inique, e dispietateFecer morir tanta povera gente.E voi donne essempio ne pigliateVedove, e maritate similmenteQui s’insegna a viver con timoreE pigli essempio chi commette errore.
Abbiamo detto che questa storia praticamente coeva agli eventi non mostra un gran rispetto per i particolari, anche se riporta fedelmente ed anzi si dilunga sugli aspetti peculiari dell’esecuzione capitale che avvenne con maggior pompa e ritualità di altre. Per ciascuna donna era stato approntato un carro ed il corteo, che percorse le principali vie della città, era preceduto da un banditore che richiamava l’attenzione del pubblico:
Il Sabbato passato mezzo giornoSopra i carri le fece montarePoi le fece girare in ogni contorno La giustitia largo facea fare.Quando fu arrivata a fin del giornoIn campo di fiore le fece guidare.Ciascuna il cartello sopra have[v]aDi quel che havea fatto ogn’un diceva.
Avanti poi la Tromba sonavaDicendo per cavarsi li suoi appetitiQueste son le donne, che l’acqua adopravan.
63Donne e veleniGiancarlo Baronti 62
Ciascuna fè morire il suo maritoAltra gente ancor che la compravanIn breve tempo si vedea spedito.Per ogni strada sonava si forteChe per i falli loro vanno a la morte.
La promessa che la storia porta sul frontespizio («sentirete tutto il successo come proprio è seguito») non viene però mantenuta sino in fondo perché l’autore dimostra di non conoscere né il numero né i nomi delle donne giustiziate – Gerolama Spana o Spara, Giovanna de Grandis, Maria Spinola, Graziosa Farina e Laura Crispolti49 – e parla di una non meglio identificata Paola condotta per prima sul pati-bolo (mentre invece fu la Farina) quale principale istigatrice dei delitti:
Prima la bella Paola andò alla morteCome che lei fu a capo d’ogni male.
Poi vengono nominate solamente la “Gironima”, ovviamen-te Gerolama, e Giovanna, la de Grandis, e delle altre, con un escamotage tipico dei saltimabanchi e degli imbonitori di piazza che cercano di avvolgere nel mistero le cose che non sanno, il nostro anonimo cantastorie dichiara di non fare i nomi, dando ad intendere però di conoscerli:
Giovanna, e l’altre donne andaro a morteIl bello nome suo lasso da parteIn questo loco non si puole direÈ degno, & è stampato nelle carte.
Molto più dettagliata ed anche di maggior mole (quaranta-nove ottave contro le ventiquattro della precedente) appa-re la seconda storia stampata a Napoli50 e sicuramente più
49. Cfr. aDemollo a. 1881: 27.50. La nuova, e curiosa Historia del giusto castigo dato a cinque Don-
informato il suo autore, Francesco Ascioni, anche se nel corso della storia non viene mai nominata l’epoca esatta dell’esecuzione penale e poichè la data di stampa è l’anno 1699, l’incauto acquirente poteva pensare che i fatti si fosse-ro svolti da poco, mentre invece erano trascorsi esattamen-te quarant’anni. Il trucco non è certamente nuovo, molto spesso i cantastorie, ripescavano storie vecchie e credute dimenticate, le facevano ristampare modificando date, nomi e luoghi e le rivendevano e le cantavano come nuove. Ma forse l’Ascioni, data la perfetta conoscenza delle circostanze e delle sequenze degli eventi che dimostra di possedere ha veramente assistito all’esecuzione capitale e ne ha paziente-mente confezionato la storia in ottava rima che sicuramente avrà avuto altre edizioni prime delle due conosciute51.
ne in Roma, quali facevano, e dispensavano acque avvelenate con le quali le Donne davano Morte a i loro Mariti. Composta in ottava rima da Fran-cesco Ascioni Napolitano. In Napoli per il Pittante, 1699, Con lic. de’ Sup. E si vendono al Largo del Castello sotto la Posta. 8 pp., 49 ottave. Di poco precedente a questa è un’altra edizione: Historia del giusto casti-go dato à cinque Donne in Roma, quali facevano, e dispensavano acque avvelenate con le quale le donne davano morte a i loro mariti. Giustiziate nella piazza di Campo di Fiore. Composta da Francesco Ascione Napoli-tano. E dato in luce da francesco Petrini, In Ronciglione per il Menichelli 1696, Con licenza de’ Superiori. Si vendono in Piazza Navona al Morrion d’Oro da Mutio Mauritio e Gio: Battista Bona. Tra le due edizioni non esistono varianti significative.
51. Francesco Ascioni è soprattutto noto per aver trasposta in ottava rima (95 ottave) la tragica storia di Gio. Fiore e Filomena che ha avuto nu-merose edizioni dalla metà del Seicento alla metà dell’Ottocento mentre il testo in prosa era stato stampato molte volte nel corso del Cinquecento:Bellissima historia di gran compassione dell’infelice successo per cagione di amore tra Gio. Fiore, e Filomena occorso nel Monte di Fiesole ... tra-dotta di prosa in rima da Francesco Ascioni napolitano. Le prime due edizioni risalgono alla metà del Seicento: In Ronciglione, per Giacomo Menichelli, e In Fiorenza all’insegna della Stella. Risulta autore anche di altre opere in versi stampate intorno alla metà del Seicento e quindi in teoria avrebbe potuto essere a Roma nell’estate del 1659:
65Donne e veleniGiancarlo Baronti 64
Lo sfondo, l’orizzonte in cui la storia colloca la vicenda mostra immediatamente il conflitto tra la pace e la tranquil-lità della città retta dalle leggi di Dio e degli uomini e la per-versa volontà delle donne di distruggere l’assetto del mondo facendo da tramite alle forze oscure e sotterranee del male; la donna come punto debole della civitas dei, la donna come ianua diaboli:
Nella città che i sette colli inonda...dove pietà, dove Giustizia abbondadove sol carità si può trovare,sotto un governo tal, dove in letitiasempre abbracciata sta pace e Giustitia.
Sotto tante bontà queste superbe,stavano dico, e non so dirvi como,che con toschi maligni, e suchi d’erbeterminavano poi i giorni all’Huomo... più tosto furie le chiam’io, che uscitefussero qua dalla città di Dite.
Rispetto alla storia precedente, nella quale si nota una scarsa conoscenza delle persone coinvolte e una non esatta collo-cazione degli eventi, in questa sono ampliamente descritte le protagoniste a cominciare da quella Gerolama Spana che
Partenope restaurata da serenissimo ed invittissmo D. Giovanni d’Au-stria, Composta da Francesco Ascione napolitano, In Napoli per France-sco di Tommaso, 1648. Le lodi e grandezze della Aguglia e fontana di piazza Navona: Memoria di N. S. papa Innocenzo X: opera del signor Cavalier Bernino, Con le descrittione de’ frutti, fiumi, & animali che sono in detta fontana: E il lamento di tutte l’arti, che stavano in detta Piazza Navona in 39 sestine di ottonari, Roma, Francesco Cavalli, 1651.La Opera nuova Spirituale, dove s’intende la Vita, Virtù, Miracoli, e Mor-te del Glorioso S. Paolino Vescovo di Nola, Composta in ottava rima da Francesco Ascione Napolitano, In Napoli, per Nicolò Monaco.
costituisce il collegamento tra la grande stagione dei veleni romana ed i precedenti fatti palermitani:
Vennero dico dai Siccanii lidiuna chiamata Geronima Spagna, e l’altra Maria Spinola, che ai fidisia mal tal nome haver femina vana.Hor queste fuora dai paterni nidisparsero tra noi fama profana,Ch’una Astrologa fusse, & i secreti,delle Stelle sapesse, e de i Planeti
Nella Longara ad habitar sen venneGeronima l’astrologa cattivache con le ciarle sue credito ottenne,dalle credole sue chiamossi diva,l’altra alli Monti la sua casa tennedelle Carrette al vicolo si scriva,e ritrovorno al praticar di horroremalvaggie Donne compagnia peggiore.
Dopo aver introdotto le figure di quelle che sono conside-rate le principali protagoniste del caso e che portarono in Roma il “veleno ignoto” dalla Sicilia, l’autore tratteggia il ritratto delle altre che si associarono nel complotto:
Vicino a S. Lorenzo in Palispernastava una tal Giovanna de Granni,ed era cava macchie arte sua internacome suol fare chi ha imbrattati i pannicostei con queste una amicitia esternapresero dico in breve corso di anni,e tutte tre poi fabricar quest’acquecon che più d’un estinto in terra giacque.
Giunsero a queste tre due altre poiLaura Crispolti e stava alla Torrettae Gratiosa Farina a danni suoi,
67Donne e veleniGiancarlo Baronti 66
che soleva abitar spesso a Ripettaqueste fur venditrici infra di noidi quell’acqua cattiva maledetta,che l’huomo al viver suo vea terminatomen di quel, che li dava il Cielo, el Fato.
La sorie prosegue, descrivendo gli effetti del veleno porta-to a Roma dalle due donne siciliane. È interessante notare come non solo nella letteratura di piazza ma anche negli atti processuali il famoso veleno fosse costantemente ritenuto una invenzione di fresca data, avvenuta a Palermo e poi dif-fusa in altre città da alcune perfide donne. Le cose in effetti non stanno proprio così, perché il veleno utilizzato a Roma, un composto inorganico dell’arsenico inodore ed insapore, era già conosciuto da tempo ed aveva già arricchito le crona-che criminali e riempito la fantasia popolare, ricevendo di-verse denominazioni52. La novità più che nel veleno consiste invece proprio nel fatto che il suo segreto era uscito da una ristretta cerchia sociale che lo aveva da tempo immemorabi-le nascostamente utilizzato per perseguire i suoi scopi di ca-rattere politico, economico e dinastico e stava divenendo di uso e di accesso comune, mettendo tragicamente a nudo la fragile consistenza di quelli che tra i legami sociali venivano considerati i più sacri e duraturi:
Preser pensiero, e fu riparo e schernoTal’acqua di Perugia53, far chiamarema il vero nome, è l’acqua di Palermoche [la] infame Tofania usò di fare,quanti in quella Città più di un inferno
52. Cfr. calDerara a. 1989: 27.53. L’autore suppone che le prave donne per sviare le attenzioni ab-
biano denominato l’acqua venefica da loro prodotta, acqua di Perugia, ma in effetti l’acquetta di Perugia era largamente conosciuta e si diceva prodotta già nel quindicesimo secolo da monache perugine (cfr. Passarini l. 1968 [1875]: 174).
sette otto giorni non potea campare,Acqua fatta così, che terminataè in tanti giorni, a quante gocce è data.
Entra nella storia l’eco dell’inquietudine e dell’apprensione generalizzata che le notizie sul veleno avevano rapidamen-te diffuso. Non era sufficiente la indubitabile efficacia del composto arsenicale, esso appariva anche circondato da un alone magico che ne faceva un perfetto veleno a termine, che, contrariamente a quanto un minimo di pratica potreb-be far supporre, conduceva i malcapitati alla morte dopo tanti giorni quante erano le gocce versate nelle vivande.
La pratica del veleno nasce e si diffonde all’interno di un mondo femminile incomprensibile e nascosto, all’appa-renza fatuo leggero e ciarliero, ma sostanzialmente infido e malvagio:
Ma perché delle donne è il solito usoraccontar sempre ciarle, e far partitinel maneggiar che fanno l’ago el fusolodano i drudi, e tacciano i mariti...
Nell’andarsi costor l’acque a pigliareper bellettarsi, o accomodarsi il viso,...veniano i lor fatti a raccontare, e quelle il pianto tramutarlo in risoli prometteano a chi vedeano il lacciodir del Marito mal, levar l’impaccio.
Il complotto delle donne comincia a precisarsi in tutti i suoi più tragici e orribili connotati:
Tal opra fu che tante donne furoche non solo al marito dieder morte,ma istigavano le altre all’atto impurodi mutar come loro vita e consorte,che se il Ciel per pietà modo sicuro
69Donne e veleniGiancarlo Baronti 68
di castigar costor non dava in sortein Roma ben potea con tal partiti,ogni donna pigliar cento mariti.
Solo l’intervento divino riesce a frenare e sconfiggere que-ste “nemiche dell’humana natura”, che anteponevano il loro piacere e la loro sfrenata ed incontenibile sessualità a qualsi-asi valore di convivenza familiare e di vita sociale, suscitando allarme sociale e diffusa inquietudine in tutta la città:
Sparsa per Roma poi la fama ciarladell’acque triste e dei veleni infetti,in ogni loco, et in ogni strada parladi tanti attorto invedovati letti,chi dalla mente alli huomini levarlapuò questa opinione, onde so’ astrettiche incontrando hoggi a vedove partiti,dicono queste so’ ammazza mariti.
Et han ragion un tal pensiero havere,mentre non si vedeano altro per Roma,sol vedove assai, ma con piacerede volti allegri, e inanellata chiomae gl’huomini nessun vestito haveredi moglie estinta, onde se stesso domaperché costor con dispietate vogliefacean morir mariti, e mai le moglie.
Le “dispietate voglie” femminili sembrano davvero voler trasformare la città in un cimitero di uomini, dove esse si possono aggirare felici ed imbellettate; nella sua radicale am-biguità il volto della donna abbandona la maschera cultura-le e lascia finalmente e pienamente trasparire quello della
morte, della distruzione assoluta, alla quale la donna se non è contrastata controllata e repressa, fatalmente conduce54.
Nel corso della storia viene anche indicato l’antidoto che l’autore ha probabilmente ricavato da una “Notificazione a pubblica utilità”55 pubblicata in Roma proprio il giorno suc-cessivo all’esecuzione capitale delle cinque donne:
acqua che un sol rimedio vi si trovase, gustandola mai, pronto haveretesucco di limoncello, ò pur di aceto,questo guarisce il mal, guasta il secreto.
Il seguito della storia è totalmente incentrato sui riti patibo-lari di espiazione e purificazione, la cui descrizione compia-ciuta raggiunge spesso dei livelli di “gallows humour” che esprimono pienamente ed espressivamente la soddisfazione per la definitiva ed esemplare sconfitta del complotto delle donne ed il ritorno ad un’ordinata e tranquilla restaurazione dei “naturali” rapporti di dominio maschile allinterno delle famiglie:
Ella esortando il popolo a pregare, Dio per li falli suoi, salì la scala,non sò se allor potesse astrologarese havea sorte benigna, o Stella malaarte o modo non ha d’indovinarecome può far se per la corda cala...
Fù legata, e battuta hai che tormentifu estinta ogn’arte ogni virtude ogn’opra& un pezzo buttò dei calci ai venti
54. Cfr. FarGe a. 1989: 147.55. Antidoto: succo di limoncello o aceto preso nella quantità di tre
oncie in circa reiterandolo in caso di continuazione degli accidenti sud-detti con render Grazie a Sua Divina Maestà… Roma lì 6. Luglio 1659, In Roma, Nella stamperia della reverenda Camera Apostolica, 1659.
71Donne e veleniGiancarlo Baronti 70
& un pezzo il boia ancor vi ballò sopra.
Anche questa storia come l’altra giunge ad una medesima conclusione con un invito rivolto alle donne a non lasciarsi trascinare dai cattivi consigli ed in modo particolare a non lasciarsi trasportare dal profondo impulso di uccidere i pro-pri mariti:
Finisco, e prego il Ciel se alcuna mai,di tal cattivo pensier l’ingombri il petto,si estingua a fatto come nebbia ai raidi Febo in dar morte al suo diletto;fama tu, che per tutto scorri e vaipregoti a nota fa questo soggettoacciò ogni Donna vero esempio piglidi tal Donne fuggir l’empii consigli.
Anche se i veleni non cesseranno di apparire nelle cronache giudiziarie56 e nelle storie di piazza57, la loro grande stagione può dirsi conclusa. Essi continuerranno sempre a rimanere sullo sfondo delle opzioni possibili ed a condizionare sotter-raneamente le scelte individuali, ma non saranno più inter-pretati come indizi rivelatori di un conflitto tra i sessi e come
56. Cfr. scutellari G. 1700, ratti n. 1914, manaresi a. 1981, Fiume G. 1987.
57. Distinto ragguaglio di quel, che è seguito in Messina a’ 17. del Mese passato dell’Anno presente. Di una Donna, la quale fece morire di veleno 60. persone, con l’attroce morte meritatamente datali dalla Giusti-zia. In Messina, e in Venezia, Appresso Gio: Battista Occhi. Con licenza de’ Superiori, 4 pp., prosa.Nuovo, e distinto ragguaglio dell’enorme, e spaventevole caso seguito nella Città di Seza Stato di Roma, dove s’intende come una rea femina per godere il Mondo ha avvelenato il Marito, e come per voler di Dio partor due Mostri diabolici, e come fu presa dalla Giustizia, tormentata, e condannata al fuoco ad esempio universale li dodici Ottobre 1737, In Cremona, ed in Modena. Per Francesco Torri, Con Licenza de’ Superiori, 4 pp., prosa.
ipotizzabili strumenti di una sorda guerra collettiva che le donne potrebbere muovere alle regole sociali stabilite dagli uomini. L’esplosione del caso violento, il terrore del crimi-ne più inquietante sono riusciti per un “attimo” a mettere a nudo i rapporti sociali immediati non più mascherati dal-la finzione della rappresentazione quotidiana, dalla “mon-tre”; hanno rivelato l’intelaiatura di una rappresentazione fantasmatica della realtà, nascosta e soggiacente dalla quale emerge in tutta la sua devastante immediatezza, l’immagine profonda di una minacciosa e caotica sessualità femminile che nel segreto di un mondo oscuro, inafferrabile ed indo-mabile, complotta sin dalla notte dei tempi per erodere ciò che di umano l’uomo cerca di ordinare e costruire su di un universo naturale infido e misterioso
Cogliendo l’occasione offerta da un caso giudiziario, at-traverso la retorica sociale che sempre circonda i grandi delitti e cercando di ripercorrere il vissuto collettivo e l’am-plificazione leggendaria che i testi di letteratura di piazza hanno fatto del “sordo macello dei mariti”, abbiamo tentato di risalire dagli eventi ai modelli mediante i quali essi sono stati gestiti, interpretati e vissuti. Come ha spesso ricordato Geoges Bataille «solo gli aspetti leggendari del crimine rie-scono a metterne in piena luce la verità»58.
58. Cit. Bataille G. 1982: 7.
Giancarlo Baronti
Alberi di maggio in Umbria
Quando è maggio è maggio per tutti1
La storia dell’antropologia e le modalità della scrittura an-tropologica ci hanno mostrato con chiarezza che proce-
dure di eccessivo comparativismo fanno smarrire la tensione e l’impegno che la ricerca etnografica deve mantenere con il singolo avvenimento indagato, ma, proprio per individuare quegli elementi di affinità o di scarto che consentono di col-locare ciascun evento, sia pur nella sua specificità, all’interno di una morfologia rituale di più ampio respiro, ogni mani-festazione festiva studiata deve essere accostata almeno alle altre feste che si svolgono in aree contermini nello stesso pe-riodo stagionale. Tanto per fare un esempio locale, uno dei più grandi errori compiuti dai ricercatori del passato è stato quello di considerare i ceri di Gubbio come un fenomeno unico e incomparabile che si potesse indagare solo all’inter-no delle dinamiche urbane della città di Gubbio, una sorta di straordinario fiore sbocciato in un insignificante deserto. Solo di recente si è diffusa la nuova consapevolezza che la festa dei ceri sostituisce una splendida realizzazione urbana di arcaici modelli festivi rurali largamente diffusi nei territori circostanti e che non sia possibile comprendere a fondo la elaborata specificità dei ceri senza considerare i contesti fe-stivi rurali che li attorniano.
Poiché uno degli elementi che caratterizzano il ciclo di maggio in Umbria è la traslazione processionale di frasche e cimature di alberi variamente ornate, elaborate e allestite,
1. Cit. mannocchi l. 1920: 82.
75Alberi di maggio in UmbriaGiancarlo Baronti 74
in questo breve excursus concentreremo la nostra attenzio-ne proprio su quegli eventi festivi che presentano caratteri-stiche che potremmo definire affini, cioè azioni rituali che posseggono come elemento centrale la traduzione di essenze arboree e/o vegetali (dendroforie) in un arco di tempo che va dalla fine di aprile alla metà di giugno.
alBeri in Piazza
Un primo gruppo di dendroforie è costituito da quei rituali che tendono a concentrarsi nel momento di passaggio tra aprile e maggio e che prevedono, schematicamente2, il ta-glio, in un’area boschiva più o meno contigua al centro abi-tato, di un alto albero, generalmente un pioppo, eseguito, secondo regole stabilite, da gruppi maschili; il suo trasporto, mediante mezzi ritenuti localmente appropriati, nel luogo simbolicamente centrale della comunità; il suo innalzamento dopo operazioni, diverse da luogo a luogo, di decorticazio-ne, rifinitura e allestimento.
Il rituale brevemente descritto, nei suoi aspetti essenziali è largamente diffuso non solo in Italia ma in quasi tutta l’Eu-ropa, pur presentando ampi spettri di variabili localmente connotate:
Dans toute la Provence, on plante encore de nos jours à la date du premier mai des arbres qu’on entoure des fleurs et des rubans…. On plante des Mais devant les églises, sur les places publiques devant les maisons des autorités locales3
Tanto diffuso e tanto conosciuto che Rousseau, proprio dell’albero piantato in piazza, aveva fatto il simbolo fonda-mentale della festa popolare:
2. Cfr. van GenneP a. 1949: 1534.3. Cit. seiGnolle c. 1963: 187.
Piantate nel mezzo di una piazza un palo coronato di fiori, riuni-tevi il popolo e avrete una festa4.
In effetti la semplice operazione di piantare, per un tempo determinato, il tempo della festa, un albero adeguatamen-te allestito, al centro di una dimensione urbana, opera una trasformazione degli spazi in funzione dell’evento festivo: l’albero di maggio diviene il polo di attrazione dei tempi del-la festa e il punto di riferimento principale delle sequenze rituali che la caratterizzano.
Rituali simili sono tutt’ora diffusi nella nostra regione e in aree ad essa limitrofe delle Marche e del Lazio. La docu-mentazione disponibile lascia intravedere come nel passato la loro diffusione fosse sicuramente più ampia e non limitata alle sole aree periferiche o montane.
In effetti tali rituali sembrano oggi addensarsi lungo la dorsale appenninica, in modo particolare in Valnerina:
Nella notte del trenta aprile i giovani di Preci si recano lungo il fiume per prendere il pioppo più alto, tolgono la corteccia e lo sfrondano ad eccezione della parte superiore ove collocano una bandiera ed un ramo fiorito, quindi lo trasportano nella parte più elevata del paese e lo piantano in una buca prece-dentemente allestita. Dopo aver piantato l’albero i giovani si recano sotto le finestre delle giovani del paese cantando delle serenate. Alla fine del mese di maggio il pioppo viene venduto e con il ricavato viene organizzata una cena a cui partecipano i giovani maschi che hanno tagliato e innalzato l’albero5.
Come si può notare tutte le operazioni sono gestite dai gio-vani maschi della comunità che alla fine consumano col-
4. Cit. rousseau J. J. 1970b [1758]: 613.5. Rilevazione delle feste popolari nella regione umbra a cura del Con-
siglio Regionale dell’Umbria e dell’Istituto di Etnologia e antropologia cul-turale dell’Università degli Studi di Perugia, 1985, Schede non pubblicate, rilevatori: Maria Pia Bianchi, Mauro Bianchi; informatori: Maria Pia M..
77Alberi di maggio in UmbriaGiancarlo Baronti 76
lettivamente i proventi derivati dalla vendita del legname. Al “piantamaggio” sono associate anche pratiche rituali di corteggiamento e preliminari di fidanzamento come appare evidente anche in altre situazioni:
A Campi i giovani del paese, durante la notte, vanno a rubare il maggio (un pioppo alto e sottile) ci mettono un ramo fiorito in cima e lo piantano al centro del paese. Quest’anno [1965] ha dato origine a liti, perché l’hanno piantato gli ammogliati ei ra-gazzi, allora, per dispetto, l’hanno tagliato; però hanno dovuto pagare i danni e piantare un altro maggio. Il 2 sera, di solito, i giovani vanno a cantare maggio e fanno le serenate sotto le finestre delle case in cui abitano ragazze. Il 3 le giovani che hanno accettato la serenata si cambiano per andare a messa, mentre quelle che non l’anno accettata non ci vanno e, allora, 1’uomo che non trova in chiesa la ragazza si mette la giacca alla rovescia e un cappellaccio in testa. La domenica seguente i ragazzi vanno a riscuotere le uova, 12 ciascuno, dalle ragazze che si sono mutate d’abito: con il ricavato fanno una cena e poi mettono festino (fanno una festa da ballo). Il maggio rimane nel posto in cui è stato piantato, fino alla fine del mese6.
Dal complesso rituale documentato a Campi (comune di Norcia) emerge anche un altro aspetto non secondario nel-le dinamiche festive del ciclo di maggio: il conflitto interno al mondo maschile che oppone i giovani/celibi agli adul-ti/coniugati. In effetti il ciclo festivo di maggio utilizza in modo marcatamente espressivo i rapporti di correlazione/opposizione sia interni alla comunità (tra mondo maschile e mondo femminile, tra maschi giovani/celibi e maschi adulti/coniugati, tra ceti e ambiti sociali distinti) sia esterni (tra la comunità di appartenenza ed altre comunità limitrofe).
Anche nelle Marche è documentato un modello simile, ma più ritualmente definito:
6. Cit. lanzi m. 1965-1966: I, 99.
Ad Agolla [comune di Sefro, provincia di Macerata] i pali del maggio sono due: quello dei giovani e quello dei vecchi. I due gruppi in gara si fanno una concorrenza aperta e spietata per la maggior riuscita del “Piantamaggio”, il cui albero viene scelto tra i più alti della zona e viene piantato nei luoghi maggiormen-te in vista per essere meglio ammirato ed elogiato. I due alberi sono rimossi solo la sera del 31 maggio7.
Altra documentazione proveniente dalla vicina regione ci mostra come i riti di maggio siano anche occasione di com-petizione campanilistica tra località limitrofe:
Piace ricordare una vecchia lite sorta tra Colmurano e Ripe San Ginesio per via del “pianda Mmagghju”, tra il 1873 e ‘77. Questa volta i Ripani non ne piantarono uno, com’era costu-manza, ma tre e ciò pare, per far dispetto ai Colmuranesi che, in ossequio alla tradizione, ne avevano piantato uno solo.Nella notte seguente all’avere eretti i tre maggi, nove ardimen-tosi colmuranesi si recarono a Ripe e riuscirono a portar via quello più alto su cui sventolava la bandiera italiana e lo pianta-rono a Colmurano. I Ripani tentarono di riprenderlo, ma non vi riuscirono, allora lo stesso sindaco del centro intervenne, dando alla questione impronta politica, affermando di avere i colmuranesi recato offesa al tricolore. Il prefetto di Macerata, volendo rimettere i due centri in pace, obbligò al sindaco di Colmurano a restituire la bandiera. Altro fatto del genere si ebbe nel 1962 e di poi nel 1963, tra i giovani di Domo, frazione di Serrasanquirico e quelli dei centri vicini, e ancora nel 1968, tra i giovani della frazione di San Lorenzo e quelli del comune di Apiro8.
In alcune località il “maggio” innalzato in piazza può anche essere utilizzato come palo della cuccagna:
7. Cit. GinoBili G. 1971: 61.8. Cit. GinoBili G. 1971: 61.
79Alberi di maggio in UmbriaGiancarlo Baronti 78
I ragazzi di Civitella [comune di Sellano, provincia di Peru-gia], fino a circa quindici anni fa, nel primo giorno di maggio piantavano un tronco d’albero nel punto più alto del paese e ponevano all’estremità dello stesso “le ciambelle“ (dolci prepa-rati in casa dalle ragazze di Civitella). I giovani, di fronte ad un folto pubblico, cercavano di risalire il tronco per conquistare il premio. La serata si concludeva con le serenate dedicate dai ragazzi alle proprie innamorate9.
Non sempre il momento agonistico coincide con la cesura calendariale; la presenza della cuccagna in molte altre fe-ste appartenenti a diversi momenti del ciclo calendariale è probabilmete dovuta al fatto che l’aspetto agonistico in fun-zione premiale può facilmente mantenere una sua propria autonomia svincolata dalle connotazioni simboliche che possiede il “maggio”:
A Norcia in occasione del 3 maggio nel rione Capolaterra si faceva l’albero della cuccagna. Veniva infisso al suolo un alto albero in cima al quale erano appesi piccioni, salami, fichi e una borsetta con denaro: prendeva tutto chi riusciva a scalare sino alla cima il tronco spalmato di grasso aiutandosi con cenere e segatura10.
All’interno del rituale del “maggio” ci troviamo quindi di fronte ad un’altra variante in cui l’albero, il fulcro della festa, diviene il campo di gara per una competizione agonistica in cui i giovani maschi gareggiano, manifestamente per procac-ciarsi risorse alimentari, ma simbolicamente per acquisire una sorta di “priorità” nella scelta sessuale. Una delle prime testimonianze, in Umbria, di pali di maggio utilizzati come alberi della cuccagna proviene dal sinodo di Amelia del 1595 che ne proibisce l’erezione:
9. Rilevazione delle feste popolari nella regione umbra, 1985, cit., rile-vatori: Maria Pia Bianchi, Mauro Bianchi; informatori: Quinta D..
10. Cit. lanzi m. 1965-1966: I, 99.
De festis diebus cap. 754: De calendis Maij... ut mos ille qui maxime agrestibus usurpatur, cal. Maij, caesam praelongam, ac proceram arborem in plateis, triviisque erigendi, statuendique; decisisque ramis ac detracto cortice, qui lenior, atque ascensio dif-ficilior sit, lacertorum atque crurum amplexu; nixuque scandere conantur, ad summamque altitudinem pertingere...11.
Tali sporadici interventi dell’autorità ecclesiastica non pa-iono però aver inciso in profondità sulle usanze locali, in modo particolare nelle zone più isolate e conservative. Se mai, a decretare la fine degli alberi di maggio, sono stati i recenti processi di spopolamento delle aree montane:
Nel cerretano (Cerreto di Spoleto) nel passato i giovani pianta-vano al centro del paese il maggio, il tronco di un pioppo alto e sottile, decorticato e sfrondato, ornato in cima da rami fioriti e da un cerchio da cui pendevano cibarie. I giovani a turno garreggiavano per raggiungerne la sommità12.
Anche in una novella dell’abate Casti troviamo la descrizione dell’albero di maggio utilizzato come albero della cuccagna:
Tra il basso volgo universal costanteCostume egli è nel primo dì di maggioDrizzare in piazza spaziosa o innanteAd un rustico tempio di villaggioFra gli evviva del popol festeggiante,Qualche altissimo pino, o abete o faggio,E un uso tal, nella comun favella,Piantare il maggio da ciascun s’appella.Di salami e prosciutti ai rami pendeGran copia in premio a chi vi monta prima;II contadin robusto, erpica ascendePel mondo tronco alla frondosa cima.
11. Cit. corrain c. - zamPini P. 1970: 126.12. Rilevazione delle feste popolari nella regione umbra, 1985, cit., rile-
vatori: Maria Pia Bianchi, Mauro Bianchi; informatori: Maria B., Luigi B..
81Alberi di maggio in UmbriaGiancarlo Baronti 80
Giuntovi lo saccheggia e poi discendeCarco e superbo della preda opima.La folta turba al vincitor villanoCon grida applaude e batte mano a mano13.
Da quanto fin qui esposto sembrerebbe che i riti dell’albero di maggio non abbiano niente a che fare con il calendario religioso e si qualifichino sostanzialmente come dei riti di passaggio di carattere stagionale, con espliciti momenti di competizione maschile a carattere sessuale, assolutamen-te estranei alle scansioni liturgiche. Del resto l’espressione “piantare maggio” allude metaforicamente e furbescamente, sia in Umbria sia nelle Marche14 sia nell’alto Lazio15, sia in Toscana all’atto sessuale:
Ma non sapea ch’espressione taleIn equivoco senso si volgeaper dinotare l’atto coniugale16.
Ciò molgrado, oppure forse più propriamente proprio per questo, alcune delle manifestazioni più interessanti e com-plesse appaiono invece strettamente collegate a ricorrenze religiose, come la festa del Maggio a San Pellegrino (comune di Gualdo Tadino), la festa di San Pancrazio a Castelgiorgio e la festa di Sant’Antonio da Padova a Isola Fossara (comu-ne di di Scheggia e Pascelupo).
Affrontare specificatamente i peculiari aspetti delle tre feste richiederebbe spazi impensabili all’interno di un con-tributo che vuol essere generale e quindi risulta forzatamen-
13. Cit. casti G. B. 1829: 550. 14. Cfr. mannocchi l. 1920: 8315. Cfr. GruPPo interDisciPlinare, vita, cultura, storia Delle classi
suBalterne Dell’alto lazio (a cura di) 1983: 96.16. Cit. casti G. B. 1829: 550.
te generico, ci limiteremo a mettere in evidenza alcuni ele-menti di riflessione.
L’abbinamento dei riti dell’albero in piazza con ricorren-ze liturgiche ben definite ha necessariamente imposto che i “maggi” vengano eretti in date diverse da quella di passaggio tra la fine di aprile e il primo giorno di maggio. Solo a San Pellegrino la “coincidenza” tra la festa del santo (30 aprile) e la tradizionale cesura stagionale consente di piantare l’al-bero nella notte canonica17, mentre a Castelgiorgio il maggio viene innalzato la sera della vigilia (11 maggio) della festa di San Pancrazio e a Isola Fossara, l’albero, abbattuto nella prima domenica di giugno, viene eretto all’alba del giorno della festa di Sant’Antonio da Padova , 13 giugno18.
In questi casi ci troviamo probabilmente di fronte a pro-cessi di sincretismo che hanno “costretto” i tradizionali ri-tuali di passaggio da aprile a maggio a dislocarsi all’interno di diversi momenti del ciclo stagionale.
Uno degli elementi di differenza tra le tre feste menziona-te riguarda l’essenza arborea di riferimento ed il suo taglio; mentre nelle due feste del versante appenninico si tratta di pioppi che sono scelti e tagliati ogni anno, nel caso del co-mune dell’orvietano si tratta di un castagno che viene rin-novato ogni quattro o cinque anni: individuato in autunno e tagliato nei mesi invernali. In quest’ultimo caso nella festa manca completamente quell’aspetto notturno tumultuoso, furtivo, esoterico ed iniziatico che contraddistingue tutte le operazioni di taglio e di trasporto dell’albero:
Verso la fine di maggio uomini mascherati corrono di notte per la campagna in cerca del pioppo più alto. Scagliano sassi contro le finestre aperte e sparano per impedire alla gente di spiarli. Trovato il pioppo lo abbattono, lo portano in cima ad
17. Cfr. Bossi s. 1993-1994.18. Cfr. alimenti a. 1973-1974.
83Alberi di maggio in UmbriaGiancarlo Baronti 82
una collina, ve lo piantano e lì si realizza un rumoroso ban-chetto di porchetta e di vino. Alle donne è severamente vietato partecipare alla cerimonia: durante la notte, riunite intorno al focolare, devono rimanere tappate nelle case. II mattino se-guente esse potranno recarsi in cima al colle e baciare il tronco del pioppo19.
Situazioni simili si ritrovano anche nell’alto Lazio ove in al-cuni luoghi (Sant’Angelo di Roccalvecce, comune di Viter-bo) ogni anno si sceglie l’albero da tagliare, mentre in altri (Bassano in Teverina) si rinnova solo la cimatura:
L’albero di maggio o palo di maggio era spogliato dei rami e delle foglie, ad eccezione della cima che, verdeggiante, doveva testimoniare trattarsi di un albero vivo; per questo, era impor-tante che si tagliasse un albero nuovo ogni anno. Tuttavia, poi-ché con il tempo il significato originario del rito andò perduto e la tradizione mantenne semplicemente il valore di una festivita comunitaria ricorrente, si affermò l’uso di conservare sempre lo stesso albero, che nel giorno della festa, prima di essere in-nalzato e piantato in terra, veniva completato con una cima fronzuta e rivestito di fiori ed erbe…20.
La ricca varietà di manifestazioni incentrate sull’albero di maggio, i diversi stili festivi riscontrabili non consentono sicuramente di ricondurli ad un’unica linea genealogica, di sprofondarli in un passato indefinito e serotino in cui tutti i “maggi” appaiono grigi. La ricerca etnografica ha proprio lo scopo di sottrarre la specificità dei singoli eventi festivi all’ammasso generalizzante che ne appiattisce i rilievi e ne elimina le sfumature. Proprio per questo non vorremmo più ritrovare, anche se inserito in un testo elaborato a puro sco-po divulgativo, affermazioni di questo tipo:
19. Cit. sePPilli t. 1964: 105.20. Cit. GruPPo interDisciPlinare, vita, cultura, storia Delle classi
suBalterne Dell’alto lazio (a cura di) 1983: 96
La tradizione dell’albero del maggio si riallaccia agli originari riti pagani anche a San Giovenale (Nocera Umbra): la sera del 30 aprile viene piantato in mezzo al paese un albero maestoso, denominato “calenne” (in quanto scelto e tagliato nei boschi del vicino monte Galenne) ed adornato con fiori gialli profu-matissimi (cosiddetti “maggiociondoli”) a forma vagamente fallica. I rami dell’albero ed i fiori sono portati da gruppi di giovani sotto le finestre delle ragazze, a cui vengono dedicate serenate e scherzi amorosi21.
L’ovvio richiamo agli “originali riti pagani” e l’immancabile presenza della simbologia fallica fanno trascurare l’unico ele-mento che veramente potrebbe riallacciare il rito del “pian-tamaggio” ad una tradizione arcaica: il nome dato all’albero, “calenne”, non è, infatti, da riferirsi alla denominazione del monte da cui è tratto, se mai potrebbe essere il contrario, ma al fatto che viene innalzato ai primi di maggio, alle calende di maggio, appunto. Del resto l’albero di maggio è denominato similmente “lu calenne” a Monterivoso, comune di Ferentil-lo22, “calende” in alcune zone della lucchesia e “calendi” è definito in area piemontese23.
Frasche Di onore
Altro complesso di rituali presente nel ciclo di maggio è co-stituito dalla traslazione individuale o collettiva, da parte di giovani maschi celibi, di frasche che possono essere sempli-cemente fiorite, oppure più elaborate, cioè adorne di fettuc-ce colorate e cariche di primizie stagionali, preparazioni ali-mentari, oggetti di vestiario e di abbigliamento, e dalla loro collocazione di fronte alle abitazioni di giovani donne nubili.
21. Cit. limiti m. 1986: 127.22. Cfr. Petronio m. (a cura di) 1999: 126.23. Cfr. naselli c. 1953b: 50
85Alberi di maggio in UmbriaGiancarlo Baronti 84
Anche tali rituali sono largamente diffusi in area europea e documentati in Francia dagli inizi del XIII secolo24 ai gior-ni nostri:
Il costume di piantare un albero verde, più o meno ornato di-nanzi alla porta della ragazza che si ama o si desidera sposare, è segnalato in Francia dai testi del XIII secolo e verso la stessa epoca appare nella valle del Reno… Il costume è altrettanto antico in Italia ove l’albero piantato viene chiamato maggio o majella. Ai nostri giorni il medesimo costume è stato identifica-to in un gran numero di province francesi25.
Come riferisce van Gennep anche in Italia l’uso di quelli che egli definisce, in opposizione ai “maggi collettivi” pre-cedentemente illustrati, “maggi individuali”26 è ampiamente documentato, sia pur in epoche più recenti:
Attaccare il Maio a ogni uscio: Solent enim amasii praecipue in pagis, oppidisque Kalendis Maii virideis arbusculas floribus ornatas… rusticas canendos cantilenas amasiarum domibus in amoris signum affigere27.
Come abbiamo fatto per gli alberi di maggio innalzati sul-le piazze anche per questo rituale riportiamo dei versi della fine del Cinquecento in cui la frasca e la sua composizione sono dettagliatamente illustrate:
E voglio ancora e costi ogni denajo Dinanzi all’uscio un dì ficcarti il Majo, Il qual di beriquocoli [albicocche] e ciambelle, Di melarancie dolci, e confortini Farò gremito e d’altre cose belle, Che monteranno un pozzo di quatrini.
24. Cfr. van GenneP a. 1949: 153725. Cit. van GenneP a. 1977 [1925]: 159.26. Cfr. van GenneP a. 1949: 153627. Cit. monosini a. 1604: 407.
V’appiccherò le scarpe e le pianelleIntagliuzzate e’ cintol pe’ calziniE, che stia bene in su la tua gamurra [sopraveste],V’attaccherò un grembial di tela azzurra28.
Anche Carmeli nella sua ricerca di genealogia antiquaria do-cumenta la presenza in ambito rurale di simili rituali29:
Tale appunto è l’uso dei contadini di piantare il majo, cioè un ramo verde dinanzi alla porta della innamorata, o pure di ap-penderlo all’uscio medesimo… Questo stesso uso che anche oggidì nella gente villereccia rimane, si pratica per onorare la persona, per segno di onore…30
Generalmente non si tratta di un semplice e nudo ramo ma di una frasca abbellita ed arricchita di doni:
Il Majo era leggiadro dono con adornamento di nastri a vari colori e appiccatevi tra le frasche ciambelle e zuccherini…31.
La notte antecedente la prima domenica di maggio si usava una volta piantare el maio, cioè offrire alle fidanzate bottiglie, ciambelle, confetti appesi a dei rami di albero ornati di fiori32.
Anche in Umbria rimane memoria di simili rituali nell’usan-za dell’Alta valle del Tevere di «mettere un ramo di acacia detto maggio sul davanzale delle finestre delle ragazze»33 e nella pratica documentata nelle campagne di Todi di «met-tere fiori sulle finestre delle fidanzate»34.
28. Cit. alleGri a. 1608: 201.29. In particolare Tomo II, capo VII: Dell’uso di piantare il majo,
pp. 140-153. 30. Cit. carmeli m. 1750: 152. 31. Cit. Passarini l. 1968 [1875]: 35.32. Cit. olivieri D. 1925: 51-52.33. Cit. Puletti m. 1968-1969: I, 104.34. Cit. rossi l. 1988-1989: II, 103.
87Alberi di maggio in UmbriaGiancarlo Baronti 86
L’usanza di accompagnare simili presenti con canti rituali collega il rito della frasca di onore ad un altro rituale più diffuso nella nostra regione:
Troviamo a Bologna, come altrove, divulgatissimo l’uso di of-frire alla donna amata un alberello fronzuto (Majo), abbellito con nastri di seta di vario colore, piantandolo innanzi alla fi-nestra o presso la porta di casa di lei, mentre cantavansi liete canzoni dette maggiolate…35.
Si tratta, in Umbria del cosiddetto “cantamaggio”, eseguito nella notte tra il trenta aprile e il primo maggio da comiti-ve ambulanti, generalmente maschili, che compiono giri di questua, fermandosi di casa in casa per “cantare il maggio”, una sequenza di stornelli a saltarello in cui, dopo aver richie-sto la tradizionale licenza di cantare, si annuncia l’arrivo del nuovo mese, si fanno complimenti alle giovani donne della famiglia, al padrone e alla padrona di casa e infine si richie-dono cibarie, in genere uova. Spesso nei canti sono presenti anche delle “maledizioni subordinate”36 nel caso la famiglia non offra niente ai questuanti.
Elemento caratteristico e identificativo delle comitive di questua è il “maggio”, un piccolo alberello fiorito trasporta-to da uno dei maggerini:
A la mitate de testa notte, in puntu, Maggiu facea l’entrata a Campitillu tra soni, canti e un arbiru fiuritu. Era un arbiru finu e ardu tantu ma liggeru de legnu e de fronna ch’era tanta tra le scarpette bianche e ghijalle de la Madonna [fiori di robinia]. Eppò a ogni ponta de ramu steno attaccate a pinnuluni catenel-le de carta a culuri e li lampiuni37.
35. Cit. Falletti P. - villaFalletto G. c. 1939-1942: III, 403.36. Cfr. van GenneP a. 1949: 1427.37. Cit. Farinacci m. 1985: 61.
Anche nelle aree contermini del viterbese il “maggio” della questua era preparato con molta cura. Particolare attenzione era rivolta alla illuminazione ed alla “sonorità”, in quanto ritenute in grado di preannunciare con largo anticipo agli ospiti l’arrivo della squadra dei questuamti:
Le compagnie recavano con se un albero di maggio, variamen-te adornato:...un albero de ‘na pianta che ha ffiorito, coi fiori. Poi si accomoda, se fa un arboretto a uso vaso, poi s’infiocca co’ delle rose, col maggio, ‘l maggio fiorito no, dei cerchi al centro, vene come un vaso. dopo ce se mette dei campanelli, dei bunzinecchi... poi col filo, co’ la luce, co’ ‘na batteria, e ddentro c’era le lampadine...38.
In alcune zone dell’Abruzzo le cibarie ricevute non erano riposte, come in Umbria, in un apposito canestro ma veniva-no appese direttamente al “maggio”, quasi a stimolare, nelle tappe successive, la generosità delle famiglie visitate:
A un ramo d’albero chiamato il “Maggio” appendono fiori e frutta e preceduti da quello, vanno in giro per paese. Quanto di meglio raccolgono dalla generosità di chi ha l’omaggio dei loro canti, appendono al ramo istesso39.
Testimonianze più recenti mettono in luce come la presenza del “maggio” possa ridursi sino a divenire un semplice sim-bolo (un bastone) e il rituale della questua si possa arricchi-re di significati politico-sociali che prima non possedeva, a testimonianza che i rituali pur mantenendosi formalmente simili possano mutare il loro senso in rapporto alle intenzio-ni e alle aspettative di coloro che li organizzano e di coloro che ne fruiscono:
38. Cit. GruPPo interDisciPlinare, vita, cultura, storia Delle classi suBalterne Dell’alto lazio (a cura di) 1983: 82.
39. Cit. Finamore G.1890: 137.
89Alberi di maggio in UmbriaGiancarlo Baronti 88
…ce venìano sempre lì da noialtri… se metteano de fori nco-minciavano a cantà. Me pare cinque, sei perché c’era quello co la fisarmonica quello che portava l canestro quello col basto-ne e doppo c’erano quelli che cantavano, facevano a coppie cantavano due e poi quell’altri due cantavano la strofa dopo…c’aveano un fazzoletto rosso ntorno l collo…40.
La costante presenza del “maggio” consente di accostare i cantamaggi umbri alle simili maggiolate toscane, ai bruscelli parimenti toscani, in cui è costante la presenza dell’albero41, e anche a rituali europei che presentano analoghi aspetti:
Ciclo di maggioRussin. I questuanti portavano in giro dei rami di pino o un alberello decorato di nastri e di fiori.Dardagny. I bambini poveri e specialmente i pastori vanno di casa in casa, portando un alberello decorato di nastri e di fiori; ricevono uova e, talvolta del vino42.
Un’altra forma di traslazione cerimoniale di frasche fiorite, in occasione della cesura calendariale tra aprile e maggio, che presenta aspetti diversi da quelli sinora illustrati, è carat-terizzata dall’azione congiunta ddei giovani di ambo i sessi. Anche su tale rituale esistono testimonianze cinquecente-sche:
Est item consuetudinis, ut juventus promiscui sexus laetabunda Calend. Maji exeat in agros, et cantitans inde virides reportet arborum ramos, eosque ante domorum fores ponat…43.
Anche a Roma è documentata una simile usanza:
40. Cit. menichetti s.1999-2000: I, 68.41. Cfr. Fresta m. 1983: 30.42. Cit. van GenneP a. 1977 [1925]: 154.43. Cit. verGilio P. 1644 [1499]: 334.
A Roma, al primo maggio i giovani dei due sessi andavano per la campagna a cogliere rami che portavano per la città danzando44.
Nell’Alta valle del Tevere il rituale sembra rivestire significa-ti più complessi di non facile decifrazione:
La sera del trenta aprile quando i contadini ritornano dai cam-pi si riuniscono in corteo e ciascuno reggendo in mano un ramo di acacia [robinia] fiorito detto maggio, vanno in giro per la campagna danzando e cantanto e radunando altri contadini per aumentare la schiera. Le coppie di sposi si scambiano il coniuge45.
Nella festa di Sant’Isidoro ad Allerona troviamo materiale rituale relativo alle frasche d’onore utilizzato all’interno di una festa religiosa. In effetti, al di là delle evidenti peculiarità di carattere materiale che presentano i pugnaloni di Allero-na, nella nostra regione è documentata la presenza di fra-sche d’onore, generalmente utilizzate all’interno del ciclo di maggio in funzione erotico-affettiva, in relazione ad ambiti sacrali. In un areale abbastanza vasto che va da Trevi fino a tutto il comune di Spoleto troviamo presente, in occasione delle feste per Sant’Antonio abate, una frasca costituita da un bastone alla cui sommità è assicurata una gabbia metal-lica ricoperta di foglie verdi cui sono assicurati fiocchi e na-stri colorati oltre ad agrumi, cioccolatini e altri confezioni di commestibili di piccole dimensioni46. A convalida del fatto che la frasca d’onore può essere utilizzata come elemento rituale in molteplici ambiti la troviamo anche presente in al-cuni riti di termine dei grandi lavori agricoli stagionali47.
44. Cit. Falletti P. - villaFalletto G. c. 1939-1942: IV, 590.45. Cit. Puletti m. 1968-1969: I 104.46. Cfr. cesarini o. 2001-2002.47. Anche la cosiddetta “carità della croce” realizzata alla fine della mie-
titura agghindando le croci messe a protezione dei campi il 3 maggio con spighe di grano raccolte, potrebbe costituire una sorta di frasca d’onore.
91Alberi di maggio in UmbriaGiancarlo Baronti 90
In un areale ancora più vasto ma centrato su quello pre-cedentemente indicato, alla fine della raccolta delle olive i braccianti preparavano per il “caposcala”, per ringraziar-lo di averli ingaggiati, una frasca costituita da un palo con rami di abete assicurati da un nastro, cui erano appesi pic-coli “presenti” (sciarpe, calze, una camicia, mandarini e altri commestibili). Prima di consegnare la frasca al “caposcala” i braccianti sfilavano in corteo per il paese mostrandola a tutti. La sera stessa il caposcala offriva una cena detta “benfi-nita” a tutti coloro che avevano lavorato alle sue dipendenze nel corso della raccolta delle olive48.
torce in Processione
Resta da esaminare un’ultima tipologia di dendroforie pre-senti nella nostra regione all’interno del ciclo di maggio; in questo caso si tratta di macchine processionali effimere co-stituite da tronchi d’albero opportunamente lavorati e farciti di materiale infiammabile in modo da costituire delle grandi torce, incendiate nel corso di feste appartenenti al calendario liturgico. Non ci soffermiamo in modo dettagliato sull’argo-mento al quale abbiamo dedicato uno specifico saggio49.
A seconda delle località presentani modalità di prepara-zione diverse e diverse denominazioni. A Vasciano (comune di Todi):
…il secondo sabato di maggio, festa delle forche, grandi fiac-cole costituite da tronchi di albero opportunamente aperti e riempiti di trucioli e schegge di legno e altro materiale infiam-mabile: la sera vengono portate processionalmente dalla chiesa di San Biagio al cimitero distante circa 400 metri50.
48. Cfr. GasParri e. 1998-1999: II, 447.49. Cfr. Baronti G. 2006.50. Rilevazione delle feste popolari nella regione umbra, 1985, cit., rile-
A Canalicchio (comune di Collazzone, provincia di Perugia) la processione di fiaccole si svolge il primo e il due maggio in occasione della festa dei Santi Filippo e Giacomo e della festa di Sant’Anastasio. Le fiaccole sono costituite da tronchi di pino sapientemente aperti e accuratamente acconciati a torcia51.
A San Vito in Monte (comune San Venanzo, provincia di Terni) sempre in occasione della festa dei Santi Filippo e Giacomo la sera del trenta aprile si svolge una processione con grandi fiaccole composte da tronchi di ginepro spaccati e riempiti di pezzi di legno, così come a Migliano (comune di Marsciano per il Corpus Domini.
Una vasta area nella parte meridionale della provincia di Terni nel corso del mese di maggio è interessata da nume-rose manifestazioni festive caratterizzate dalla presenza di particolari fiaccole dette intusse che richiedono tecniche di fabbricazione particolarmente accurate.
A Schifanoia (comune di Narni) la festa con processio-ne si volge l’otto maggio per il patrono San Michele Arcan-gelo così come avviene a Sant’Urbano (comune di Narni) sempre per San Michele Arcangelo l’ultimo sabato di mag-gio (data liturgica 8 maggio). Anche ad Aguzzo (comune di Stroncone) il 14 maggio per la festa di San Vittore (il siriano), a Itieli (comune Narni) per la festa di San Nicolò (San Nicola di Mira) la seconda o terza domenica di mag-gio (data liturgica 9 maggio) a San Faustino (comune di Narni) l’ultima domenica di maggio per la festa dei santi Santi Faustino, Giovita (data liturgica 12 febbraio) e Euro-sia (data liturgica 25 maggio).
Queste feste sono state fatte oggetto in tempi relativa-mente recenti di una intensa campagna di ricerche con par-ticolare riguardo verso la documentazione delle tecniche,
vatori: Bruno Preterossi; informatori: Paola G..51. Cfr. Baronti G. 2006: 14-15.
93Alberi di maggio in UmbriaGiancarlo Baronti 92
spesso molto complesse, di elaborazione delle torce proces-sionali, e dei saperi e delle credenze che vi sono connesse: a Stroncone52, a Migliano53 a Canalicchio54, a San Venanzo55 fino ad arrivare all’ultimo lavoro, risultato di una capillare e pluriennale inchiesta etnografica nelle aree meridionali del comune di Narni56.
Sicuramente i modelli a cui si possono ricondurre le varie tipologie di dendroforie documentate in Umbria vengono da lontano e sono anche andati molto lontano, integrandosi in momenti rituali molto diversi tra di loro e molto distanti nel tempo e nello spazio. Per esemplificare l’ampiezza del fenomeno possiamo citare due importanti momenti festivi caratterizzati dalla presenza di imponenti fiaccole. A Fara Filiorum Petri (provincia di Chieti), per la festa di Sant’An-tonio abate del 17 gennaio vengono costruite, trasportate nella piazza antistante la chiesa dedicata al santo e poi incen-diate immani torce dette “farchie” costituite da lunghi fasci di canne riempiti di paglia, fascine ed erba secca57. A San Marco in Lamis (provincia di Foggia) nel corso delle ceri-monie della settimana pasquale, a seguito della processione del venerdì santo sono portate in processione su carretti e incendiate, grandi torce di canne a forma di cono chiamate “fracchie”, tenute insieme da grossi cerchi di ferro, che con-tengono rami, sterpi, schegge di legno e frasche58.
Lo scopo che si deve porre la ricerca antropologica sor-retta da un’etnografia rispettosa delle peculiarità e delle sfumature locali non è sicuramente quello di tentare una impossibile ricostruzione genealogica che raccordi forzata-
52. Cfr. Di marco A. 2001-2002.53. Cfr. PoPolizio F. 2001-2002.54. Cfr. manuali D. 2000-2001.55. Cfr. riBiGini m. 2000-2001.56. Cfr. Giuliani m. l. 2006.57. Cfr. GanDolFi a. - Di virGilio D. 1999.58. Cfr. triPPuti A. M. 2003.
mente l’estrema variabilità del presente ad un monolitico, compatto quanto ipotetico passato, ma di comprendere in che modo, in ogni piccola parte di mondo l’utilizzo del ma-teriale rituale tradizionalmente disponibile, spesso sussunto all’interno di specifici momenti liturgici probabilmente ca-lati dall’alto, abbia permesso di costituire situazioni uniche e irripetibili e consentito a ciascuna comunità di esprimere simbolicamente e di comunicare esteticamente in un evento festivo controllato i cardini portanti del proprio mondo.
Giancarlo Baronti
Il paese della fame e la città di Cuccagna.Penuria ed abbondanza alimentare
nel mondo popolare rurale in Umbria
moDernizzazione
Lo magnà pocu fa male all’omu, lo magnà troppu fa male al corpu1
Parlare di tradizioni alimentari locali, di “prodotti tipici”, in un momento in cui sono divenute largamente palesi
la consapevolezza collettiva e l’inquietudine che non esiste più alcuna possibilità di controllo individuale o di gruppo sulla origine, la preparazione e la conservazione degli ali-menti che quotidianamente si commerciano e si consumano, potrebbe sembrare totalmente anacronistico: il vino al me-tanolo, la “mucca pazza”, i polli alla diossina, hanno fatto chiaramente emergere quali siano le reali procedure di quel “mercato globale” che vediamo generalmente mascherate sotto accattivanti messaggi pubblicitari: l’oca arrosto “della trebbiatura” che troviamo disponibile tra le vivande “tipica-mente locali” offerte dalle numerose sagre paesane di luglio non è sicuramente il tradizionale “oco” allevato nella nostra regione; non sappiamo né da dove viene, né come è stato nutrito, possiamo al massimo conoscere come è stato cuci-nato, ma è sufficiente per definirlo un prodotto tipico o un alimento tradizionale2?
1. Cit. GriFoni o. 1943: 82. 2. Cfr. Giacchè l.1999.
97Il paese della fame e la città di CuccagnaGiancarlo Baronti 96
Ci sembra quindi necessario fare qualche preliminare ri-flessione sul concetto di tradizione ed in modo particolare su quello di tradizione alimentare se non si vuole correre il rischio di sposare ciclicamente una ideologica quanto inap-pagabile nostalgia nei confronti di un passato “genuino” che viene ampiamente idealizzato allo scopo di sfuggire le ango-sce, non solo alimentari, del presente o, d’altro canto, se non ci vuole limitare a constatare che il revivalismo rural-folclo-rico che vediamo dilagare in tutti i suoi contraddittori aspet-ti, costituisce l’effetto di un diffuso bisogno di radicazione che ricerca tenacemente nell’elemento basilare dell’identità, il cibo, un ancoraggio alle insicurezze sociali e culturali del mondo contemporaneo.
traDizione e innovazione
I repertori regionali di ricette culinarie che costituiscono oramai una importante fetta dell’editoria nazionale e locale, tendono a presentare una cultura alimentare astratta, riferi-scono generalmente una grammatica ed una sintassi dei pasti senza connotazioni di tempo e di occasione; in sostanza ap-paiono quasi totalmente deprivati di quelle leggi e di quelle regole di selezione, combinazione, trasformazione e opposi-zione3 che da sempre hanno concretamente denotato le pos-sibilità e le disponibilità alimentari dei singoli contesti socia-li e culturali: la langue della cucina popolare troppo spesso viene confusa con la parole della cucina urbana, nella quale le maggiori disponibilità di risorse, di ingredienti e di tempo può lasciare spazio al gusto, all’abilità ed alla scelta indivi-duale; nel mondo popolare rurale le scelte culinarie restano largamente dominate dalla necessità. La cottura della carne, fondamentalmente la sola consumata, quella degli animali
3. Cfr. sePPilli t. 1994: 13.
da cortile, non avviene sulla base dei gusti; la carne arrosto, indubbiamente preferita, viene preparata solo in pochissi-me occasioni; generalmente la carne viene cotta in umido perché “rende” di più, nel senso che dalla stessa quantità è possibile ricavare più razioni individuali.
Senza andare ad affrontare temi ampiamente dibattuti nella letteratura antropologica quali le costrizioni profonde fondanti le identità culturali – la totalità del mondo naturale disponibile è diviso in ciò che si può mangiare ed in ciò che non si può mangiare4 – dobbiamo comunque sottolineare che la tradizione alimentare popolare, in un ambiente natu-rale definito, appare innanzi tutto dominata da una forte de-terminazione di ordine economico generale (la distribuzione ineguale tra le classi sociali delle risorse disponibili) che la individua come un regime alimentare caratterizzato da una perenne scarsità.
La penuria alimentare che denota i regimi alimentari del-le classi subalterne nella nostra regione, non può essere né dimenticata, né trascurata in quanto quella che definiamo come “cucina tradizionale” o come “cucina contadina” è il frutto diretto delle selezioni, delle articolazioni, delle inno-vazioni che si sono strutturate e prodotte in funzione del regime alimentare della scarsità.
Qualora si dimentichi tale assunto di fondo, si può cor-rere il rischio di imputare al gusto o alla libera scelta ciò che è invece il frutto della cruda e della dura necessità. Ne sono un convincente esempio quei panegirici dei “cibi sani e genuini” del mondo contadino da parte di chi può facilmen-te permettersi ben altro. Riportiamo, ad esempio e monito, un “elogio della polenta” che dovrebbe far attentamente ri-flettere, non solo perché pronunciato da uno studioso che avrebbe dovuto ben conoscere le condizioni materiali di esi-stenza del popolo italiano, ma anche perché dimostra che
4. Cfr. sePPilli t. 1981, sePPilli t. 1990.
99Il paese della fame e la città di CuccagnaGiancarlo Baronti 98
il paternalismo rivestito di suggestioni tardo-romantiche nei confronti delle classi popolari è sempre duro a morire:
Polenta, quanta retorica hanno fatto sul tuo nome i vecchi co-mizianti demagoghi di casa nostra e i sempre nuovi calunniato-ri stranieri! O cibo della nostra umile gente, cibo disprezzato e preso a simbolo della nostra povertà, della nostra fame, cibo italiano, tu mi piaci più di tutti i pastrocchi e i manicaretti dai nomi difficili che ci ammannisce la cucina internazionale. Io ti mangio con gioia perché il tuo nome e il tuo sapore mi ricorda la campagna, la casa, l’ospitalità…5
In questo caso il clima folcloristico di maniera del fascismo, unito ad un malinteso “amor patrio”, sembra aver completa-mente fatto dimenticare che l’alimentazione esclusiva a base di polenta (la cosiddetta dieta monomaidica) era stata all’o-rigine di una delle più gravi ed estese patologie del mondo popolare rurale: la pellagra.
Regime di scarsità non significa peraltro una distribuzio-ne omogenea nel tempo delle risorse disponibili all’interno del nucleo familiare; sottende invece una organizzazione complessa finalizzata ad articolare, in rapporto al ciclo ca-lendariale, a quello della vita umana e a quello delle grandi opere nei campi, un rigido sistema di parsimonia intercalato da brevi intervalli di relativa abbondanza sostenuti dalla te-saurizzazione di riserve alimentari in funzione cerimoniale e festiva:
La cucina era operazione eminentemente rituale, scandita sul doppio binario dei cicli stagionali e del calendario liturgico orchestrato dalle lune e dai soli, dai santi e dai patroni, dalle vigilie e dalle feste legate al ciclo agrario, dal carnevale e dalla quaresima, dalle nascite, dalle morti e dai matrimoni6.
5. Cit. toschi P. 1939: 21.6. Cit. camPoresi P. 1989: 63.
Se da un punto di vista puramente economicistico e nutri-zionale tale prassi può apparire totalmente irrazionale (sem-brerebbe forse più corretto distribuire in modo omogeneo le risorse –non solo in rapporto ai carichi stagionali, come in effetti avviene -invece di alternare a lunghi periodi di pe-nuria brevi momenti di eccessiva abbondanza), essa però ha un senso all’interno della dimensione culturale complessiva, in quanto risponde ad ineludibili esigenze di ordine sociale e simbolico.
In effetti nel mondo rurale tradizionale coesistono, arti-colati secondo precise regole, due regimi di elaborazione e consumo del cibo: un regime che potremmo definire nutri-zionale che organizza la parsimonia del quotidiano in rap-porto alla necessità biologica del nutrimento ed un regime alimentare che entra in gioco nei momenti festivi e che rive-ste un’importanza fondamentale per i rapporti sociali e per l’universo culturale.
Mentre il cibo quotidiano serve essenzialmente al biso-gno primario di nutrire il corpo per la sopravvivenza e per permettere l’espletamento delle attività lavorative, l’alimen-tazione festiva serve a “nutrire la cultura”: mentre i pasti quotidiani vengono rapidamente consumati o all’interno del nucleo familiare o sui campi, il cibo della festa costituisce un’occasione d’incontro molto più allargata, è il fulcro di un’atmosfera di effervescenza sociale che permette di instau-rare rapporti sociali, che consente di esperire le sensazioni connesse all’identità sociale e all’appartenenza culturale. Il cibo della festa, contrariamente al cibo del quotidiano, non ha lo scopo di rafforzare il corpo ma di rafforzare invece la complessa trama dei rapporti culturali e sociali, attraverso il meccanismo della reciprocità dei doni e degli scambi nella cerchia parentale, amicale e comunitaria. La festa, per il tem-po che le è concesso, nasconde e riesce a “far dimenticare” l’orizzonte quotidiano dominato dalla tragicità e dalla pre-carietà delle condizioni materiali e psicologiche di esistenza.
101Il paese della fame e la città di CuccagnaGiancarlo Baronti 100
L’elemento fondamentale che caratterizza l’alternanza tra la nutrizione del quotidiano e l’alimentazione del festi-vo è quindi il rapporto-contrasto tra l’accorta penuria della prima e l’abbondanza della seconda (si pensi ai matrimoni contadini in cui nel corso del giorno delle nozze si imban-discono colazioni, pranzo e cena in cui ogni invitato ha a disposizione una quantità di cibo sufficiente a nutrirlo per un mese).
In questo prospettiva ci troviamo di fronte ad una tra-dizione alimentare fortemente strutturata secondo due di-stinti regimi che fanno riferimento a situazioni e ad esigenze materiali, sociali e culturali completamente diverse: oggi, tramontato il tempo della penuria, ma tramontato anche il tempo della festa, non riusciamo neppure a cogliere il senso profondo del piacere del cibo festivo, ad esempio di quello festivo per eccellenza, la carne, che da un lato costituiva la realizzazione di un desiderio alimentare quasi perennemente frustrato e dall’altro risultava indubbiamente e fortemente “insaporito” dal contesto sociale e culturale nel quale veniva assunto.
Solo in questa prospettiva articolata risulta comprensibi-le l’atteggiamento largamente diffuso tra le persone anzia-ne di origine rurale, (atteggiamento per altro non dovuto solamente all’inevitabile e comprensibile rimpianto per il mondo passato della loro giovinezza, in quanto hanno for-temente presente e viva nel ricordo le condizioni di penuria alimentare) che continuano comunque a considerare, nel complesso, la situazione del passato migliore della attuale:
Era mejo ‘na volta. Perché almeno era tutta roba genuina e adesso invece è tutta roba medicata, tutto… La gente ‘ncò chi è superbo… il mondo è tutto pe’ l’interesse. Adesso, visto, ognuno a casa sua. ‘Na volta là pei campi eri dieci, undici per-sone e se tajava co’ la falce e se cantava tutti insieme. Si andava
a ballà per le famije e chi portava la torta col formaggio cotta sotto la brace, chi gli strufoli. C’era più allegria ‘nsomma…7
Sembra quasi che non sia possibile separare il gusto dalla necessità, il piacere del cibo dalle regole di distribuzione dif-ferenziata cui appare soggetto nel mondo popolare tradizio-nale: il cibo dalla festa ha un sapore particolare perché non si differenzia solo qualitativamente e quantitativamente dal cibo quotidiano, ma sostanzialmente perché è “condito” di socialità e di pregnanza simbolica.
Non appare neppure corretto opporre semplicemente alla parsimonia nutrizionale del quotidiano, la relativa ab-bondanza alimentare della festa, in quanto mentre si può genericamente parlare di cibo quotidiano caratterizzato da una ripetitiva e stagionale monotonia, non è possibile fare altrettanto per i cibi della festa.
Ogni festa, in modo particolare le feste più significative del ciclo calendariale, hanno i propri particolari e caratte-ristici cibi che tradizionalmente sono elaborati e preparati esclusivamente in occasione delle specifiche ricorrenze; si pensi alle torte dolci e salate preparate nel corso della setti-mana santa, il cui consumo è rigorosamente interdetto pri-ma della mattina di Pasqua, alle fave lesse nel giorno del-la commemorazione dei defunti (2 novembre), alla rituale commistione tra dolce e salato nel corso delle vigilie più sim-bolicamente rilevanti (Natale, Pasqua, Morti), alla “imbrec-ciata” (zuppa mista di tutti i cereali e legumi che richiama la panspermìa del mondo classico) in occasione dei passaggi fondamentali del ciclo calendariale (primo giorno dell’anno; primo maggio), al “farricello” per Sant’Antonio Abate (17 gennaio), alla “giuncata” dell’Ascensione, al cappone per Natale, l’agnello per Pasqua, il gallo per Ferragosto, ecce-tera, eccetera.
7. Cit. scassellati P. 1997-1998: inf. 1-2.
103Il paese della fame e la città di CuccagnaGiancarlo Baronti 102
l’iDeoloGia Della traDizione
Ancora riflettendo sul concetto di tradizione alimentare, non si può pensare ad essa come ad un complesso monoli-tico, a qualcosa che viene solamente e puramente trasmesso nel corso delle generazioni senza modificazioni e trasforma-zioni di sorta.
Se andiamo, anzi, ad analizzare in dettaglio i contenuti della tradizione alimentare, ci accorgiamo che sono costituiti da continui e progressivi riaggiustamenti, da manipolazio-ni, da suggestioni ed assimilazioni esterne, riplasmate però all’interno di un ambito familiarmente noto e costituito, che consente quella sorta di “inganno culturale” per cui si mangiano cose diverse continuando fortemente a credere di mangiare sempre la stessa cosa.
Senza andare troppo indietro nel tempo, a rimarcare come gran parte degli ingredienti, che sembrano stabilmente far parte delle preparazioni tradizionali, in realtà siano stati introdotti in Europa in epoca moderna, si può, ad esempio, notare come gli ingredienti impiegati nella preparazione fa-miliare della tradizionale “torta” o “pizza” di Pasqua salata, non solo differiscano da zona a zona, ma vedano, adesso, in alcune aree, l’impiego di burro e di qualità di formaggi provenienti dall’Italia settentrionale, solo da pochi decenni entrati nell’uso o accessibili al consumo popolare locale:
Le torte de Pasqua se facevano col formaggio pecorino, perché il parmigiano una volta non si conosceva… ci sarà pure stato ma noi non lo compravamo…8
Ciò che può e deve essere considerato maggiormente tradi-zionale, a rigore, non è il contenuto materiale dell’alimento, i singoli ingredienti, ma sono i modelli culturali nel quale
8. Idem: inf. 3.
è stabilmente incluso, la trama simbolica nella quale è in-serito. Se facciamo un breve confronto con un passato an-che recente riscontriamo che vi sono cibi che ancora oggi vengono abitualmente preparati in occasioni di particolari ricorrenze e altri che, invece, non vengono più preparati. La diversa sorte non è sostanzialmente da imputarsi a motivi le-gati alla sfera alimentare, ma è da ricercarsi in un progressivo sfilacciamento del contesto rituale e festivo che sorreggeva lo specifico alimento: le particolari vivande, tipiche di una ricorrenza o di una festa, decadono perché sono le ricorren-ze a non “ricorrere” più e sono le feste tradizionali che non sono più “rispettate”.
La scelta e la disponibilità degli ingredienti è soggetta, nel corso del tempo, a sollecitazioni di vario ordine, che oscillano da regimi di penuria, come in passato, a esigenze derivanti dalla modificazione del gusto, come al presente, che impongono continue rivisitazioni, ricalibrazioni ed ag-giustamenti delle formule tradizionali.
Da ciò ne consegue, paradossalmente, che la continui-tà e la persistenza di preparati di antica tradizione non sia dovuta, come abitualmente si crede, alla loro capacità di mantenersi sempre identici e immuni dai processi di innova-zione, ma consiste proprio nella loro flessibilità, nella idonei-tà all’adattamento, nella capacità di mutare materialmente rimanendo culturalmente sempre se stessi.
Ciò che si sta oggi verificando, come effetto dei rapidi processi di modernizzazione, non è più solo un processo di adattamento a mutate condizioni, ma un fenomeno di traumatica lacerazione del tessuto culturale tradizionale, es-senzialmente rurale, all’interno del quale ricevevano conso-lidata articolazione e ritualizzazione le tappe fondamentali della vita dell’uomo e i momenti più significativi del ciclo calendariale, in cui trovavano la propria idonea collocazione le specifiche preparazioni alimentari.
105Il paese della fame e la città di CuccagnaGiancarlo Baronti 104
Il rapido decadere degli stili e dei modelli di vita tradizio-nalmente orientati, ha avuto quindi, tra le altre innumerevoli conseguenze, anche quella di far “dimenticare”, assieme alle cadenze festive o rituali che costellavano la vita comunitaria tradizionale, anche i cibi che vi erano intimamente connessi.
il Paese Della Fame
Disse Cristu all’Apostoli soi:non magnate l’erba ch’è roba de boi9.
il Pane quotiDiano
Il consiglio di Cristo agli apostoli espresso nella forma del wellerismo popolare non potrebbe essere più chiaro, così come appare molto eloquente anche lo stesso concetto espresso in forma proverbiale: Più erba se magna, più bestia se diventa10; malauguratamente la necessità imponeva nei pasti quotidiani un regime contraddistinto oltre che dalla controllata frugalità per la sua povertà e dalla monotonia dell’accoppiata cereali-verdure che poteva essere riscattato completamente solo nei rari eventi festivi:
Argivi e dicevi: “Mamma che c’è da magnà oggi?” “L’erba”… Non c’era altro, c’erano i facioli, i ceci o l’erba…. La cucina era sempre quilla; mica come adesso che ogni tanto ne inventano una! Se magnava sempre quilla: erba, pasta, minestra facioli, patate… la storia era sempre quilla…11
Le testimonianze della memoria sono concordi nel sottoli-neare la ripetitività della dieta quotidiana che solo piccoli
9. Cit. GriFoni o. 1943: 85.10. Ibidem.11. Cit. scassellati P. 1997-1998: inf. 1.
accorgimenti nella elaborazione culinaria potevano masche-rare:
La domenica o pe’ le feste po’ darse che ‘n pollastrino s’am-mazzava, se mangiava ‘n pezzo de carne ma ne la settimana no, tutte faciole, ceci, tutto vegetale12
Pizza de granturco, poi la polenta, ma soprattutto le fave, tutte le mattine. La mattina un pezzetto de pane e basta. La pasta-sciutta la mangiavamo du’ volte l’anno pe’ Natale e pe’ Pasqua, el resto basta. La carne nun la mangiava nessuno, quella che c’era se vennea...13
Anche i risultati delle grandi inchieste nazionali svolte tra la fine del secolo scorso e gli inizi del Novecento testimoniano, per l’Umbria, che la memoria dei protagonisti non è soggetta ad errori nel descrivere le grandi coordinate dell’alimenta-zione, che comunque tendono a mantenersi relativamente costanti14:
I cibi dei coloni sono generalmente, se non di scarso volume, di poca sostanza nutritiva. Il pane viene fatto senza sale, con poco frumento, molto granturco, fava ed altre leguminose: e talvolta vi si aggiungono perfino le ghiande. Non sempre la farina è sufficiente a far pane e vi suppliscono le focacce mal cotte sulla tegghia o panaro, ovvero su apposita pietra, la polenta e le erbe mal condite perfino mal salate. Le carni per lo più di capra o di pecora sono riservate pei dì solenni o dedicati ad intensivi lavori… Erbe, frutti, patate, fagioletti, fave fresche, pomidoro, zucche, peperoni, cocomeri, aglio, cipolla ed altri prodotti dei campi e degli orti, immaturi e di poco valore, sono il comple-mento dei cibi del contadino15.
12. Cit. Baronti G. 1999: 35.13. Cit. marGheriti D. - Pernazza c. 1983: 59.14. Cfr. metelli G. 1997.15. Cit. noBili-vitelleschi F. 1884: 354.
107Il paese della fame e la città di CuccagnaGiancarlo Baronti 106
Le diverse farine che concorrono a preparare il pane o i pre-parati azimi oltre che ricorrere occasionalmente in periodi di carestia – Tempo de carestia, pan de janna è bono16 – seguono una regola distributiva che tende a far prevalere la farina di frumento nel periodo estivo successivo al raccolto e nei periodi di lavoro più pesante e poi passare a successive sem-pre maggiori integrazioni di altre farine (tendenzialmente di mais) negli altri periodi, fino ad arrivare all’inizio dell’inver-no all’assenza totale della farina di frumento:
Nell’Umbria il pane si fa col frumento e colla farina di grano-turco, più in uso sono la polenta e le focacce…L’uso di fare il pane con farina di ghiande, sempre però me-scolata ad altra farina è piuttosto comune in molte parti delle Marche e dell’Umbria… A Perugia la più comunemente usata è la mescolanza delle ghiande con il grano turco… Nell’Umbria intorno a Gubbio si fa il pane con puro orzo o con mescolanza di granturco ed orzo…Nell’Umbria si fa il pane [anche] con sola farina di castagne o si mescola questa con la segala o il grano turco. Nelle Mar-che e nell’Umbria è [anche] la farina di fave che si mescola al grano, ma viene adoperata anche la veccia e qualche volta la cicerchia…17
Il protrarsi di una alimentazione povera e poco variata pro-duce l’insorgere di specifiche patologie:
16. Cit. Falcinelli v. 1972: I 66.17. Cit. Panizza m. 1890: 53ss. A proposito della cicerchia, divenu-
to un legume oramai rarissimo, totalmente scomparso dall’alimentazione popolare, ma ultimamente “resuscitato” riportiamo il ricordo di chi non le ha mangiate per scelta ma le ha dovute mangiare per necessità: «Le cicerchie… le cicerchie quanto erano cattive. Non le ho mai potute digerì. Le cicerchie so’ na bestiaccia ma so’ sparite dalla faccia della terra! Non piacevano a nessuno ma… purtroppo venivano. Le facevano e speravamo sempre che non venissero, però vengono e toccava magnassele…» (cit. scassellati P. 1997-1998: inf. 4).
In generale il vitto che usano tanti nostri mezzadri è quasi to-talmente vegetale: assai di rado mangiano carne. I più poveri si nutrono continuamente di pane e focaccia di granturco, di erbe cotte, di minestre di pasta, di grano, di riso, di legumi con-citi coll’olio o col lardo o col sol pepe. Fanno pure molto uso di patate e rape lessate, di cetrioli e di frutta. Se poi sono agiati, allora il desco familiare è qualche volta imbandito di pane di grano, talvolta frammisto a granturco ed anche alla farina di fava o di veccione… Generalmente parlando il più dei coloni vivono di solo granturco… lo che rende i consumatori privi di forze, sofferenti nella persona, perché colpiti dalla pellagra, e terminano i loro giorni tra continue sofferenze…18.
Anche all’inizio del nostro secolo non si notano grandi cam-biamenti nel vitto quotidiano :
L’alimento principale è rappresentato dal pane il quale, a secon-da delle stagioni è composto di farina di grano (pane puro) o di farina di grano mista a farina di granturco (pane misto).Così nell’estate e nella primavera, dall’aprile al settembre, quando i lavori sono più duri e richiedono maggior energia, mangiano pane tutto di grano. Negli altri mesi dell’anno consumano pane fatto con 1/3 di farina di grano e 2/3 di farina di granturco. Questo è un ripiego al quale i nostri contadini si rassegnano mal volentieri: essi mangerebbero pane esclusivamente di gra-no, ma debbono rinunziarvi per ragioni di economia… Per dare un’idea di quanto sacrificio sia pel contadino il mangiare questa seconda qualità di pane, dirò che la nostra massaia, che è donna illuminata e che rifugge da ogni ribellione, fa questo passaggio gradualmente; nei primi giorni mischia colla farina di grano una piccola quantità di farina di granturco, in seguito aumenta a mano a mano la dose… 19
18. Cit. amicizia G. 1893: 15.19. Cit. Priore G. o. 1931 [1905]: 112-113. Priore riporta anche
l’articolazione stagionale e quotidiana e la composizione dei pasti di una famiglia di mezzadri di Casalina (comune di Deruta): «L’inverno mangia-no due volte al giorno: alle 9 e alle 17; l’estate tre volte: alle 7, alle 13 e alle 20. Inverno. Mattina: fave o fagiuoli, pane misto, vino; Sera: cavoli o
109Il paese della fame e la città di CuccagnaGiancarlo Baronti 108
Negli anni trenta l’unico miglioramento apprezzabile è co-stituito dalla quasi totale eliminazione della farina di gran-turco nella preparazione del pane:
Gli alimenti principali… il pane o per meglio dire la fa-rina di grano utilizzata principalmente sotto forma di pane, ma anche, ed in quantità notevole, sotto forma di pasta ali-mentare. Fino a circa venti anni fa, in sostituzione del grano si usava molto granturco.. ma oggi il consumo di granturco è enormemente diminuito. Dopo il grano vengono per impor-tanza i fagioli… poi le patate, erbaggi diversi…( Una fami-glia colonica del colle-piano del Trasimeno 1933)20
rape, pane misto, vino. Estate. Mattina: patate o legumi, pane puro, vino; Giorno: pasta (tagliatelle) o pomodori cotti, pane, vino; Sera: insalata, pane puro, vino». A risultati del tutto simili pervengono altri tre lavori di analisi delle condizioni dei contadini e dei mezzadri umbri condotti nel periodo (cfr. Preziotti a. 1906, Brizi a. 1909, GramiGnani e. 1914). Uniche differenze riscontrate riguardano le articolazioni dei pasti che in alcune aree (Cannara) sono tre anche nel corso dell’inverno. In tal caso esso consiste quasi esclusivamente in pizza di granturco cotta al testo. Si-tuazioni e ritmi alimentari simili ricorda Antonio Scassellati Sforzolini per la zona di Gualdo Tadino: «Il colono capo di casa è solito alzarsi all’alba svegliando i dormienti. I bifolchi che sono i primi a coricarsi si alzano un paio d’ore avanti giorno per governare il bestiame. Appena giorno ciascu-no pon mano ai lavori a cui è adibito. Circa le nove l’inverno la massaia allestisce la colazione che per i più poveri consiste in poca torta mal cotta, per i più agiati pane con grano e granturco o fagioli o erba. Con questo solo pasto vanno fino alla sera che ciascuno ha una porzione di polenta, o erba o legumi. … Nell’estate poi la porzione di torta per le famiglie povere è più grossa per le famiglie più agiate evvi colazione verso le 6 del mattino consistente in pane. A mezzo giorno una minestra ed a cena insalata o erba cotta…», cit. scassellati sForzolini a. 1900: ????.
20. Per quanto riguarda questa famiglia di mezzadri del comune di Tuoro l’inchiesta riporta anche l’articolazione stagionale e quotidiana e la composizione dei pasti:
Inverno. Colazione ore 11: verdura, pane, vino (non sempre); Cena: minestra fatta in casa o minestrone o zuppa di pane e fagioli, pane. Estate. Colazione ore 8: fagiolini o patate, vino, pane; Pranzo ore 14: minestra fat-
Leggermente diversa e ancora dipendente dalla farina di granturco appare la situazione nelle zone più collinari:
Insieme al grano che sta a rappresentare sempre la materia pri-ma con cui l’accorta massaia fabbrica i due principali alimenti, pane e pasta fatta in casa, troviamo… il granoturco. Durante i tre mesi invernali il pane di grano scompare dalla mensa e viene sostituito con quello di granoturco. È questo il perio-do in cui, in questa zona, si constata una relativa insufficienza alimentare…( Una famiglia colonica dell’altipiano eugubino 1933)21.
il saPore Della Festa
Carne fa carne, vinu fa sangue e pane mantene22.
Come abbiamo già notato la maggior parte delle persone anziane di estrazione rurale con cui capita di intrattenersi in colloquio nel corso delle ricerche demologiche, sembra mostrare nei confronti delle condizioni materiali e sociali nelle quali hanno trascorso l’infanzia e la giovinezza, un at-teggiamento contrassegnato da un rimpianto per l’ambiente
ta in casa con sugo di maiale, pane, vino; Cena ore 20: insalata, pane, vino. 21. Anche per questa famiglia del territorio di Gubbio si fornisce l’ar-
ticolazione stagionale e quotidiana e la composizione dei pasti da cui si nota che le condizioni della famiglia consentono qualche volta il consumo di carne anche nei giorni feriali:
Inverno. Colazione ore 9: fagioli o cavoli o rape, qualche volta carne di maiale o pesce secco e pane di granturco; Cena ore 18: minestra di pasta fatta in casa o minestra di fagioli o polentone, pane di granturco. Estate. Colazione ore 8: fagioli o patate o carne di maiale, pane di grano; Pranzo ore 12: minestra fatta in casa e pane di grano; Cena ore 20: insalata e pane di grano, vino.
22. Cit. GriFoni o. 1943:86.
111Il paese della fame e la città di CuccagnaGiancarlo Baronti 110
di vita comunitario oramai definitivamente tramontato e l’a-cerbo ricordo delle ristrettezze economiche che si traduce-vano in una alimentazione quotidiana contraddistinta dalla parsimonia, dalla monotonia degli ingredienti e dalla totale assenza di alcuni alimenti, concordemente considerati come estremamente appetibili.
Tale diversità di giudizio (opposizione tra una vita cul-turale positivamente valutata ed una vita materiale con-traddistinta dalla penuria alimentare) pare completamente annullarsi nelle occasioni di rammemorazione degli eventi festivi legati ai cicli calendariale, della vita umana e dei gran-di lavori stagionali, allorché al senso di pienezza culturale dato dall’effervescenza dell’atmosfera festiva si unisce un al-tro senso di pienezza dato dalla possibilità, in tali occasioni non solo di mangiare di più ma di consumare in abbondanza quegli alimenti non altrimenti disponibili:
Pe’ San Martino sì. Si invitavano gli amici e ce se spremeva a fa una cena come se deve. Ma sapessi che gusto c’era a magnà de quei tempi la carne a sfamo, che ce n’è fin che ti va! A san Martino s’ammazzava l’oca vecchia, l’oca giovane, il billo…23.
Tale alternanza tra “frugalità” e “sperpero” fa sì che i beni alimentari prodotti stagionalmente dalle attività familiari, in modo particolare quelli concernenti gli animali da cortile e le preparazioni derivanti dal maiale, non sono né totalmente, né immediatamente disponibili per il consumo interno.
Le famiglie mezzadrili, infatti, erano obbligate periodica-mente, nel corso dell’anno, a fornire ai proprietari del fondo una certa quantità di derrate alimentari che dovevano quindi risultare disponibili al momento prefissato; altrimenti dove-vano essere acquistate:
23. Cit. scassellati P. 1997-1998: inf. 5.
...c’erano gli obblighi del padrone: pe’ Natale je toccavano sei capponi, pe’ Carnevale quattro galline, pe’ Pasqua toccava daje cento ovi24
Inoltre alcuni prodotti dovevano essere venduti per procu-rarsi altri beni assolutamente necessari sia per motivi pratici sia per esigenze di ordine sociale o culturale(ad esempio le aringhe ed il baccalà per le vigilie più importanti e per il periodo di Quaresima):
S’arlevavano i polli e i coniji, ma si vendevano pe’ comprà, il sa-pone, lo zucchero, il sale. E anche un po’ di formaggio si com-prava perché, benché avevamo le pecore ce lo divideva tutto il padrone e… quando eravamo giù nei campi, che mangiavamo la pasta senza formaggio25?
I santi le vigilie si rispettavano molto, guai!! Nessuno mangiava carne si faceva il baccalà26.
Le donne vendevano gli ovi o i piccioni e compravano il bac-calà…27.
Era anche necessario accumulare le provviste in previsione dei pasti da fornire a coloro che venivano ad aiutare in occa-sione delle grandi opere della primavera-estate:
Bè quello, quanno era d’estate, uno c’ea da farcià, se affettava il prociutto, ‘l capocollo, no? Quanno se carrava, quanno se mieteva, toccava lasciallo pe’ quanno uno ciaveva le faccenne da fà, toccava chiamà la gente...
24. Idem: inf. 625. Ibidem.26. Cit. sPeDicato s. 1997-1998: inf. 1.27. Cit. scassellati P. 1997-1998: inf. 1.
113Il paese della fame e la città di CuccagnaGiancarlo Baronti 112
Il sanguinaccio se facea asciugà vicino al camino. Dopo se coceva sulla graticola... così se sarvavano i salami pe’ la farciatura...28.
C’era una regola che per esempio il capocollo fino a Pasqua non si poteva mangiare, questa era una cosa che la sapeva an-che un bambino di cinque anni; prima si consumava la roba che andava più a male, per dire i sanguinacci, le salcicce, la do-menica, poi il capocollo la mattina di Pasqua, po’ darsi che era pronto anche prima, non lo metto in dubbio, ma si mangiava per Pasqua, poi venivano i salami, in primavera, poi la spalla verso maggio e il prosciutto dopo; dopo la battitura era tutto finito rimaneva solo il lardo e delle volte il barbozzo...29.
Anche le feste, sia relative al ciclo calendariale, sia quelle legate al ciclo della vita umana (matrimoni, battesimi, cre-sime, comunioni), previste nel corso dell’anno, avevano bi-sogno di una accorta accumulazione di beni alimentari che permettessero di allestire “senza economia” le indispensabili “orge” alimentari.
In effetti le occasioni nelle quali si poteva mangiare fino a saziarsi (“a sfamo”) in modo particolare di alimenti altamen-te appetiti quali la carne, erano relativamente scarse:
La carne per lo più si mangiava quando facevamo i lavori in campagna: mietitura, battitura, vendemmia. E per le feste ri-cordatevoli cioè Natale, Pasqua…30
Anche se per la domenica e in altre feste compariva sulla ta-vola la carne, i suo consumo appariva estremamente limitato e controllato:
28. Cit. Baronti G. 1999a: 5629. Cit. sPeDicato S. 1997-1998: inf. 2. 30. Cit. scassellati P. 1997-1998: inf. 3.
Beh… il coscio del pollo bisognava dividerlo; mica se magnava sano! Con il coscio se facevano due parti… prima de mettersi a tavola la carne bisognava dividerla bene. Chi cucinava spartiva; perché un conijo per sedici persone bisogna saperlo spartire bene! C’è da farci un culo così31!
Uno spezzatino fatto con il coniglio e il sughetto uno ci intin-geva il pane, un po’ d’erba; a volte era il pollo o la gallina, la domenica la carne c’era sempre. Certo era pochino un coniglio per quindici persone ne veniva un pezzettino per uno, ma uno ci mangiava il pane, poteva darsi che ti davano mezza testa con un po’ di sughino…32
Di fronte ad una sorta di rigida contingentamento della carne è evidente che si attendano e si ricordino i momenti nei quali era possibile, anzi codificata la possibilità di assumerne delle quantità maggiori33:
Finito de seminà se faceva la “cena de li sementi”. S’ammaz-zava un pollastro, due, tre secondo quanti erino e ne faceano mezzo a testa, perché allora lu pollastro non se magnava mai... se magnava una vorda due lo mese, sennò la carne ne vedevi poca eh... se facea una cena, co’ i vicini, co’ i parenti e usava mezzo pollastro a testa…34.
31. Ibidem.32. Cit. sPeDicato s. 1997-1998: inf. 3.33. Anche modi di dire riferiti ad occasioni del ciclo della vita o del
ciclo calendariale mostrano come tali eventi festivi siano inscindibilmente legati al consumo della carne. In occasione di matrimoni: Viva la cuoca / viva la ciccia / viva la sposa / e chi la stropiccia. In occasione dell’ulti-mo giorno dell’anno: Per San Silvestro / el cavolo per devozione / e la ciccia un bel boccone. L’usanza di mangiare il cavolo bollito per l’ultimo dell’anno è legato ad un episodio dell’agiografia del Santo papa nel quale si racconta che Silvestro mangiasse alla sera un cavolo che aveva seminato solamente la mattina (cit. Puletti m. 1968-1969: inf. 1 e 2).
34. cit. Baronti G. 1999a: 49.
115Il paese della fame e la città di CuccagnaGiancarlo Baronti 114
Le grandi opere dell’estate (per tradizione si incominciava a mietere il giorno dopo la ricorrenza di San Giovanni Batti-sta – 24 giugno – e si doveva aver terminato la battitura e la carratura del grano il giorno di Sant’Anna – 26 luglio –), in modo particolare la battitura, sono quelle che vedono impe-gnati per circa un mese notevoli quantità di persone che, po-dere per podere, si aiutano vicendevolmente in uno scambio reciproco di “opere” cioè di lavoro che non prevede alcuna ricompensa ma esclusivamente la fornitura dei pasti per il periodo di tempo in cui i lavoranti operano sul podere:
La trebbiatura durava due o tre giorni… secondo me era la festa più bella, se mangiava bene… la carne, c’erano l’oche ar-rosto, la pasta fatta in casa.. se portava il bocconcello tutto su l’aja35.
Ciascuna famiglia deve pertanto organizzarsi per soddi-sfare adeguatamente e senza sospetto di risparmio (per “non farsi compatire” dagli altri) gli appetiti di tutti coloro che aiutano a mietere e trebbiare perché ne sarà adeguatamente ricambiate quando toccherà il suo turno di aiutare nei pode-ri vicini. Soprattutto per le donne di casa era un periodo di frenetica attività.
In tali periodi la frequenza quotidiana dei pasti aumenta notevolmente fino ad arrivare in alcune zone anche a otto36, mantenendosi comunque mediamente intorno a cinque:
35. Cit. rossini F. 1990-1991: inf. 1.36. Almeno a quanto documenta Preziotti (cfr. Preziotti a. 1906),
per la zona di Cannara nel corso della mietitura (durata media 8-9 giorni):Alimentazione pro capite:Ore 5 Pizza di grano e formaggio (bocconcello) , 100 grammmi, vino,
un bicchiere.Ore 8 Minestra di fave, a volontà; pane di grano, a volontà, vino, due
bicchieri.Ore 9, 30 come alle ore 5Ore 11 Panzanella (pane inzuppato nell’acqua e condito con olio e
La mietitura è una delle fattighe più pesanti per il contadino, perché dalle tre del mattino fino alla sera è costretto sudare alla sferza del sole canicolare del Luglio, a riparare simile laborio-so lavoro supplisce con una spessa alimentazione innaffiata da molto vino. Alle 4 1\2 la Massaia porta nel campo canestre di pane, aglio o cipolla, minestra di legumi e quant’occorre per l’appuntacore o prima colazione.Alle ore 9 si mangia fritto in padella d’interiori di pecora pro-sciutto o formaggio.Alle 12 minestra all’ovo e carne di pecora bollita unita ad essa ossi di maiale affumicati.Alle 3 pom. Panzanella consistente in pan di fiore bagnato con acqua condito con olio pepe aceto cipolle e mentuccia e sale.Alle 6 pom. Frittata con cipolla e pomodoro, torta di fiore cot-ta al testo con anici impastati.Alle 8 1\2 Insalata o faggioletti al tegame.Ogni distribuzione di cibo ha con sé varie distribuzioni di vino puro, di vino innaffiato con acqua. L’acetello è dato solamente quando i mietitori hanno sete da un pasto all’altro37.
Penuria e consumo controllato di carne non vuol per altro significare che la dieta quotidiana consistesse in un vero e proprio regime vegetariano, infatti le verdure, i cereali ed i legumi erano comunque conditi con il lardo e lo strutto derivanti dalla lavorazione del maiale. Il periodo veramente di magro era la Quaresima, che seguiva il Carnevale, caratte-rizzato da una relativa abbondanza di carne:
aceto) a volontà, vino, due bicchieri.Ore 12 Minestra con brodo di pollo o maccheroni, a volontà; carne di
pollo, 100 grammi, pane di grano, a volontà, vino tre bicchieri.Ore 16 come alle ore 5Ore 18 Frittata di uova in ragione di due uova a testa, pane di grano,
a volontà, vino, due bicchieri.Ore 20 Insalata, a volontà, pane di grano, a volontà, vino, due bic-
chieri.37. Cit. scassellati sForzolini a. 1900: ???????????
117Il paese della fame e la città di CuccagnaGiancarlo Baronti 116
Giovedi grasso tre ultimi giorni di carnevale: Il giovedi grasso a colazione si mangia la ventresca arrostita allo spiedo, e chi non l’avesse ammazzato il maiale o se la procura col denaro o va per la questua del cicolo38 per il contado. A pranzo si fa un poco di minestra col battibene o lardo. La cena la minestra con carne e castagnole. Il Sabato del Carnevale si ammazzano uno due o più billi secondo le persone in famiglia, così uno o più paia di galline ed anco qualche castratello sfuggito agli occhi del padrone e tutta questa carne si ripartisce per la cena e pranzo della Domenica, Lunedi e Martedi del Carnevale in modo che la domenica e lunedi si cena, solo il martedi si pranza e si cena. Il venerdi casciaiolo e Martedi di Carnevale la sera vi devono essere i maccheroni il venerdi col solo formaggio, il martedi con rigagli di pollo39.
Per la Quaresima erano invece proscritti tutti i condimenti di origine animale40:
Il primo giorno e il Venerdì di Quaresima si faceva astinen-za, se mangiava cioè di magro, non si mangiavano neanche le ova che si portavano a vendere e in cambio se prendevano le sardine. Se dicea: Ecco inizia la Quaresima / So’ quarantasei giornate / Non si mangian più frittate / né frittate né piccion / che faranno ‘sti ghiottoni41?
38. A proposito della “questua del cicolo” o cigolo, bastone appuntito utilizzato per infilarvi i pezzi di ventresca o di lardo di maiale ottenuti, i giovani questuanti cantavano: Cigolo, cigoletto / chi ce dà ‘n pezzo de porchetto. Anche le questue alimentari, organizzate dai gruppi di giovani in moltissime occasioni del ciclo calendariale, ccostituivano un elemento molto importanze per la possibilità che offrivano di allestire pranzi a base di carne.
39. Cit. scassellati sForzolini a. 1900: ???????????40. In alcune zone della regione l’ultimo giorno di Carnevale, il mar-
tedì grasso, si usava cantare: Ecco Carneval che se la coglie/ oggi a carne domani a foglie. (GuBBini m. P. 1969-1970: I 120).
41. Cit. rossi l. 1988-1989: inf. 1.
Durante i digiuni della Quaresima ci si consolava nell’at-tesa del giorno di Pasqua allorché, si iniziavano a mangiare le torte dolci o salate preparate in precedenza e si “avviava” il capocollo.
Come abbiamo già precedentemente ribadito il regime alimentare tradizionale rurale appare soggetto ad un insieme estremamente articolato di regole derivanti da un lato dalla penuria che costringe a distribuire in modo estremamente accurato le risorse disponibili e dall’altro dalla festa, cioè dalla necessità culturale e sociale di sottolineare adeguata-mente anche da un punto di vista alimentare i momenti fon-damentali del ciclo calendariale, le tappe basilari del ciclo della vita umana ed i momenti terminali dei cicli agricoli nei quali si raccolgono le derrate necessarie al sostentamento dell’anno a venire.
Tali regole obbligano non solo ad una distribuzione ac-curata delle risorse disponibili nell’arco annuale, ma anche ad un controllo capillare dei consumi quotidiani all’interno della famiglie:
Me ricordo che se la mamma coceva un ovo ne dava un pez-zetto al poro babbo uno al mi’ fratello più grande e noi piccoli magnavamo l’insalata sola… non come ora che ce se mette a tavola e ognuno ne prende quanto vuole. Per i più grandi la parte un po’ più grande e per i più piccoli la parte un po’ più piccola.. Magari loro una salciccia e noi potti mezza…42
la città Di cuccaGna
Aò, aò, aò so’ pollastri e maccaro’43
42. Cit. scassellati P. 1997-1998: inf. 7.43. Cit. GriFoni O. 1943: 88.
119Il paese della fame e la città di CuccagnaGiancarlo Baronti 118
Chi avrebbe mai potuto pensare al tempo di Bertoldo che morì, abituato ai cibi rustici, per aver mangiato da “signo-re” – «incominciò a gustar di quelle vivande gentili e delica-te s’infermò gravemente a morte»44 –, o al tempo – non c’è bisogno di andare molto indietro – dell’ossessivo mito del Paese di Cuccagna45, negazione del lavoro e della disloca-zione differenziata delle risorse, il cui paesaggio è costellato, nei sogni di coloro che non riescono mai a saziarsi, di cibi già cotti e pronti per essere divorati da tutti, che l’utopia dell’abbondanza alimentare si sarebbe davvero realizzata nel nostro piccolo angolo di mondo e che finalmente l’ossessio-ne del cibo, il conflitto tra gusto e necessità, i rigidi confini tra alimentazione quotidiana e festiva sarebbero divenuti solo degli sbiaditi ricordi del passato.
Nei vecchi carnevali di campagna la maschera del “dot-tore”, tinta di farina bianca, si aggirava visitando falsi malati e prescrivendo ironicamente a tutti la medesima, impossibi-le e inarrivabile cura: due fiaschi di vino e tre bistecche di maiale al giorno46. Oggi una simile prescrizione non fareb-be più ridere, sia pur amaramente, perché non esiste più lo scarto tangibile e fortemente sentito tra ciò che si vorrebbe mangiare e ciò che invece si deve mangiare, ma la penuria e le obbligate rinunce del passato continuano comunque a condizionare i comportamenti di coloro che non hanno di-menticato la fame e le privazioni alimentari, proiettando nel presente modelli culturali, non solo di consumo alimentare, che testimoniano una sorta di “rivalsa” sociale attuata me-diante un nuovo rapporto con il cibo47, in modo particolare con la carne, che non è più necessario centellinare, distribu-ire minuziosamente, organizzare nel corso dell’anno, ma si
44. Cit. croce G. c. 1993 [1606]: 14845. Cfr. cocchiara G. 1952, camPoresi P. 1978, camPoresi P. 1991.46. Cfr. GraGnoli F. 1968-1969: I, 217.47. Cfr. clemente P.1985.
può invece consumare “a sfamo” in una serie di occasioni che si tende sempre di più a moltiplicare.
Tali tendenze culturali profonde, che andrebbero co-munque più analiticamente indagate e documentate e che affondano le radici in una sorta di “desiderio” rimasto co-stantemente inappagato nella lunga filiera delle passate ge-nerazioni, si possono chiaramente individuare in alcuni fe-nomeni attuali.
Uno di questi può essere considerato il fortissimo attac-camento presente nelle classi subalterne rurali nei confronti dell’esercizio della caccia, anche nei suoi aspetti ritenuti più deteriori del bracconaggio e della cattura di specie protette. Tale totale adesione alla pratica venatoria, a livello popolare rurale, non possiede nessuna caratteristica riferibile l’impie-go del tempo libero o ad una sorta di pratica sportiva, la molla che la trascina costantemente e forse ciecamente avan-ti riguarda la possibilità che la caccia offriva, al tempo della fame, di procurarsi della carne al di fuori del rigido contin-gentamento dettato dalla necessità:
Chi poteva prende la cacciagione praticamente era proprio per l’alimentazione; perché mancava la carne… s’andava de con-trabbando: starne, lepri, tordi, merli. Se cercava de pijalli più che se poteva. Se prendevi un merlo o due se metteva sul sugo della pastasciutta…48
La caccia consente quindi di procurarsi una sorta di alimen-to prezioso e desiderato, la carne, non solo non prevista o prevedibile, ma in un certo senso anche proibita ed in fin dei conti “gratuita”, non prodotta dal lavoro allevante dell’uo-mo, ma “colta” direttamente dal mondo naturale, come in una sorta di domestico, familiare e accessibile Paese di Cuc-cagna.
48. Cit. scassellati P. 1997-1998: inf. 8.
121Il paese della fame e la città di CuccagnaGiancarlo Baronti 120
Altro elemento interessante all’interno del modello cul-turale di perseguimento di un “riscatto” storico dal “paese della fame”, è costituito dai “pranzi” che vengono allestiti in occasione di cerimonie relative a passaggi del ciclo della vita umana, nel passato non fatti oggetto di particolari attenzio-ni e “marche” di carattere alimentare. Cresime e comunioni sembrano sempre di più ad assomigliare, dal punto di vista alimentare, ai matrimoni: la cerchia degli invitati al ristoran-te non si limita più ai familiari ed ai parenti stretti, ma tende ad allargarsi agli amici ed ai conoscenti, quasi a testimoniare ed a certificare pubblicamente che la famiglia è in grado di offrire alimenti a volontà e soprattutto a sottolineare l’ora-mai raggiunto e acquisito rapporto monetario con il cibo: non si allestisce più il pranzo a casa, con le derrate accurata-mente tesaurizzate nel corso dell’anno, ma si va al ristorante e si “paga” il conto.
Ultimo elemento da sottolineare, in questa prospettiva, è il pullulante successo, nella nostra regione, delle sagre estive che si denotano esplicitamente per il loro carattere alimen-tare (della tagliatella, dell’oca, della salciccia, eccetera, ecce-tera, eccetera).
Se molte feste del ciclo calendariale sono finite, nel sen-so che non sono più “festeggiate”, non sembra sicuramente esaurito, culturalmente e socialmente, il desiderio di festa, nel senso che le istanze un tempo soddisfatte dalle cerimonie e dalle feste tradizionali, sembrano oggi dislocarsi in dire-zioni diverse e sorgere spontaneamente, nella più assoluta mancanza, è da sottolineare, di qualsiasi progetto o inter-vento di politica culturale, che indirizzi le iniziative in alvei rispondenti alle identità culturali e alle specificità materiali, dei singoli ambiti territoriali.
Nessuna occasione di aggregazione comunitaria può es-sere trascurata e tanto meno disprezzata: la macchina antro-pologica della festa continua a voler funzionare e le centinaia
di sagre allestite ed organizzate ogni anno ne sono una signi-ficativa, anche se spesso traumatica conseguenza.
In esse l’elemento fondamentale, spesso anzi l’unico elemento corposamente evidente, è il cibo (nella società dell’abbondanza si riscattano le obbligate frugalità del pas-sato) riproposto oramai svincolato dal contesto festivo o rituale che lo sorreggeva, unico appiglio certo e materiale ad un pericolante senso di identità che riflette il crollo della cultura tradizionale ed il deserto che ne è conseguito.
Il pubblico che frequenta tali sagre paesane è composto in gran parte da famiglie del luogo o dei paesi vicini; fami-glie, in specie nelle componenti più anziane, che non sono solite frequentare i ristoranti, se non nelle occasioni cerimo-niali (nascite, cresime, comunioni, matrimoni). Le sagre con la loro quotidiana e accessibile offerta dei piatti che un tem-po erano solo della festa, in modo particolare di carni arro-sto, l’oggetto “storico” del desiderio alimentare subalterno, riempiono e riscattano il ricordo di un vuoto alimentare, ma soprattutto confusamente riempiono un vuoto culturale.
Ma… stranamente c’è sempre un ma, l’utopia del Paese di Cuccagna fattasi finalmente realtà, il paradiso alimentare disceso sulla terra, la facile abbondanza a portata di mano e di tasca, presenta un aspetto che nessuno avrebbe potuto mai immaginare. Le carni allestite ed imbandite sono certo carni, ma non sono le carni di una volta: il pollo non sa più di pollo, il maiale non è più il maiale di una volta, le carni bo-vine poi, sogno proibito, non sembrano essere così appetibi-li come lo erano nel passato. In questo Paese di Cuccagna c’è qualcosa di falso, di artefatto, ogni tanto assomiglia ad una colossale fregatura: come i polli finti di cartone colorato che vengono posti sugli alberi della cuccagna, solo per “bellez-za”, per far figura, perché, oggi, nessuno si arrampicherebbe più su di un palo per prendere solo un pollo.
Daniele ParBuono
La penuria alimentare nell’Umbria dei proverbi1
La penuria alimentare che denota i regimi alimentari delle classi su-balterne nella nostra regione, non può essere né dimenticata, né trascurata in quanto quella che definiamo come “cucina tradizio-nale” o come “cucina contadina” è il frutto diretto delle selezioni, delle articolazioni, delle inno-vazioni che si sono strutturate e prodotte in funzione del regime alimentare della scarsità2.
Dalle parole di Giancarlo Baronti emerge per intero la dimensione di una “questione alimentare” relativa alla
classe mezzadrile della nostra regione, in un periodo storico antecedente alla modernizzazione delle campagne e ai muta-menti socio-economici che hanno trasformato una classe di “frugali produttori” in una classe di “voraci consumatori”3.
1. Questo saggio è già stato pubblicato in «Percorsi Umbri. Rivista antropologica della provincia di Perugia», numero 2/3, giugno 2008, pp. 66-71 (cfr. ParBuono D. 2008).
2. Cit. Baronti G. 1999b: 12.3. Le espressioni “frugali produttori” e “voraci consumatori” sono
estrapolate da un intervento di Luciano Giacchè tenuto alla presentazio-ne dei libri Cantar l’Umbria. Musica, canto e danza nelle tradizioni umbre (cfr. PalomBini G. 2005) e Il ballo del Saltarello nel Centro Italia (cfr. Par-Buono D. 2006), svoltasi nell’ambito di “Corciano Festival” il 17 agosto 2007.
125La penuria alimentare nell’Umbria dei proverbiDaniele Parbuono 124
Al contempo emerge la complessità dell’evoluzione ali-mentare che, strettamente connessa al mutamento sociale di cui essa è frutto, rende il dato della situazione attuale: la penuria alimentare è tornata di moda, non nei suoi con-tenuti ma nelle sue forme esteriori ora edulcorate, non nei suoi aspetti quantitativi ma solo nei suoi aspetti qualitativi. I significanti del regime di penuria vengono acquisiti oggi dalla cultura alimentare dominante – disgiunti dai significati a cui fino a poco più di mezzo secolo fa erano connessi – che li presenta sulle tavole imbandite di ristoranti e di feste pae-sane o nelle abbondanti cene festive familiari.
Le ricette elaborate in un regime di scarsità da un lato, riprese e vendute per “autentiche”4, costituiscono il nucleo di un movimento economico determinante per una regione come l’Umbria che lega il proprio nome alla ricostruzione e alla ri-proposizione della propria tradizione, dall’altro hanno rappresentato un punto di partenza per successive elabora-zioni e modificazioni rese possibili dalla nuova abbondanza dei prodotti. Tanto per intenderci da una parte si propone la “Torta di Pasqua” come “piatto tipico”, dall’altra si sono operate sulla sua ricetta modificazioni significative, possibili solo grazie alle nuove condizioni economiche; per essere an-cora più chiari e per portare un esempio tangibile si può far presente che lo strutto, ingrediente basilare di questa torta, è stato ormai da tutti sostituito con l’olio d’oliva (che in un re-gime di scarsità alimentare era considerato ingrediente raro come l’oro, proprio perché assai costoso).
In realtà, pur potendo presentare al grande pubblico l’a-spetto esteriore della penuria, pur potendo vendere il “fol-clorismo alimentare” come estetizzato ingrediente di una tipicità dai sapori globalizzati e dozzinali, risulta complesso
4. Per una riflessione sul concetto di “autenticità” connesso a feno-meni di carattere demo-etno-antropologico si vedano aime m. 2005 e ParBuono D. 2007a.
rendere la dimensione ontologica della penuria stessa, così come risulta complesso proporre la commercializzazione della “scarsità” come “tipicità” rimanendo fedeli alla realtà di cui essa un tempo era testimonianza concreta. Il regime di scarsità alimentare e le classi sociali subalterne a cui esso era connesso sono de facto inscindibili. La penuria alimentare è stata per secoli conseguenza e testimonianza di un determi-nato “sistema strutturale”, partecipando di una dimensione esistenziale in cui alimentazione, lavoro, organizzazione fa-miliare, rapporti di genere, rapporti sociali, rapporti amicali, sentimenti, comunicazione interpersonale, sistema valoriale costituivano un tutto difficilmente riproponibile se non in alcuni dei sui aspetti marginali.
Molte delle testimonianze che giungono oggi a parlarci dell’Umbria mezzadrile – come del resto di altre regioni ita-liane – ci ricordano una realtà in cui la maggiore o minore disponibilità alimentare, la maggiore o minore abbondanza di un alimento rispetto a un altro, risultavano determinanti per la riuscita del lavoro, per la buona salute, per la salva-guardia della forza fisica indispensabile al buon esito delle attività agricole, per la buona pace tra i membri della fami-glia. «Quanno sta bene lu córpu, l’annima trionfa»5 – e non solo l’anima – ricorda un proverbio attestato nella zona di Spello e riportato nella pubblicazione di Venanzo Peppo-loni.
Proprio lo studio paremiologico può essere considerato uno dei mezzi migliori per comprendere a pieno le impli-cazioni sociali e culturali della penuria alimentare. Poco si è lavorato, in realtà, sull’approfondimento scientifico e sul-la ricerca etno-linguistica connessa ai proverbi nei dialet-
5. Cit. PePPoloni v. 1981: 204. Tutti i proverbi inseriti in questo contributo sono stati estratti da opere già pubblicate; si è scelto, dunque, di non operare alcuna normalizzazione sulla trascrizione fonetica e di ris-pettare i criteri di trascrizione adoperati da ciascun autore.
127La penuria alimentare nell’Umbria dei proverbiDaniele Parbuono 126
ti dell’Umbria. Se ne trova testimonianza in alcune tesi di laurea conservate presso la biblioteca di Antropologia o co-munque negli archivi dell’Università degli Studi di Perugia6, in alcune pubblicazioni (un esempio è appunto PePPoloni v. 1981) che di fatto riportano una serie di proverbi inse-riti come cornice ad altre questioni legate alla “civiltà con-tadina”, nei vocabolari o nei lessici scritti per le numerose varianti dialettali presenti in Umbria (dove questi vengono riportati soltanto come fraseologia esplicativa dei lemmi) e nella sistematica raccolta curata nel 1943 da Oreste Grifoni.
Probabilmente l’argomento meriterebbe un’attenzione maggiore rispetto a quella che fino a ora gli è stata conces-sa, proprio perché attraverso lo studio del proverbio, inter-pretabile come esteriorizzazione comunicativa di quello che con Gramsci può essere definito «senso comune»7, potreb-bero essere comprese, ancora più in profondità, sensazioni collettivamente condivise che il dialettofono difficilmente avrebbe potuto esprimere a parole8, sia per la mancanza dei mezzi linguistici necessari – mi riferisco, per esempio, a quei proverbi che parlano di una certa filosofia di vita, di concetti che solo attraverso il proverbio il dialettofono riusciva a co-municare e, contemporaneamente, a comprendere accettan-doli come propria forma mentis – sia perché «chi parla solo il dialetto o comprende la lingua nazionale in gradi diversi, partecipa necessariamente di una intuizione del mondo più o meno ristretta e provinciale, fossilizzata, anacronistica in
6. Si vedano per esempio cianGaretti B. m. 1981-1982 e mencacci c. 1990-1991.
7. Cfr. Gramsci a. 1992.8. «Ho domandato mille volte alla gente idiota cosa significasse un
tal proverbio, e così staccato, non me l’hanno saputo dire; ma appena ho chiesto a che proposito lo dicessero, me n’hanno resa subito per-fetta ragione; per la qual cosa si può dire che versano dalle labbra una sapienza che non sanno di possedere […]», cit. Giusti G. - caPPoni G. 1994: XIV.
confronto delle grandi correnti di pensiero che dominano la storia mondiale. I suoi interessi saranno ristretti, più o meno corporativi o economistici, non universali»9.
Il proverbio dialettale dunque parla la lingua del mezza-dro ne condensa i saperi, ne esplica le pratiche professiona-li, familiari, sociali, religiose, taumaturgiche, apotropaiche, guidandolo nella vita quotidiana, nelle difficoltà costanti, nelle pratiche festive, nell’educazione dei figli. Una “filosofia dei poveri” che è funzionale alla realtà circostante, legata a una dimensione del dire non estetizzata e anestetizzata nell’inefficacia del luogo comune, ma performativa, concre-ta, tangibile. Il proverbio era guida esistenziale e maestro di vita; inserire un proverbio nel discorso significava compie-re un’azione, sì verbale, ma anche perlocutoria10, significa-va ammantare la frase di una credibilità, spesso imperativa, resa tale da un indiscutibile ipse dixit, di cui l’“ipse” non poteva essere soggettivato se non in una secolare coscienza collettiva e, proprio per questo, il “dixit” risultava indiscuti-bilmente attendibile.
«ll’anno è llungo e r pòrco è ccórto»11; «chi magna pocu magna sempre»12; «se la bocca rîe la borsa piagne»13; «Joânni se magnò la roba e je avanzorno l’anni»14, dicono alcuni dei proverbi tratti dalle fonti poco sopra riportate. Pronuncia-re nella quotidianità una frase di questo genere significava adoperarne la semantica per far passare un concetto chiaro e insindacabile: «la fèm(e) fa nì l bui néro»15; «ventre digiunu
9. Cit. Gramsci a. 1992: 20.10. Per un approfondimento sulla teoria degli atti linguistici perlocu-
tori si veda austin J. l. 1987 [1962].11. Cit. mattesini e. - uGoccioni n. 1992: 379.12. Cit. GriFoni o. 1943: 33.13. Idem: 34.14. Idem: 88.15. Cit. moretti G. 1973: 238.
129La penuria alimentare nell’Umbria dei proverbiDaniele Parbuono 128
non sente niciunu»16; «la fame fa scappà’ lu lupu dalla tana»17. L’attenzione alla gestione delle risorse alimentari, al metico-loso e oculato razionamento - «lo magnà’ pocu fa male all’o-mu, lo magnà’ troppu fa male al corpu»18 – era una preroga-tiva imprescindibile in un regime di scarsità continuativo; il rischio della fame era costantemente al cospetto di una clas-se subalterna che con le soluzioni ad essa aveva per necessità e non per “tipicità” imparato a convivere. «Si la trippa nun - z arimpe, la gréñña nun ze stréññe»19, la pancia vuota non arrecava solamente problemi di carattere fisico e psicologico ma, conseguentemente, impediva di lavorare a pieno regime, impediva la corretta e doverosa gestione dei campi, procu-rando, potenzialmente, ulteriore futura penuria alimentare.
In un “sistema vita” in cui nulla, per necessità, si può spre-care, tutto funziona meccanicamente senza margini di appros-simazione. Non razionare le risorse alimentari, non calcolare al dettaglio il loro uso, la loro conservazione, la loro equa ri-partizione – «chi mmagna da sólo se stròzza»20 ricorda un pro-verbio attestato nell’Orvietano da Mattesini e Ugoccioni, ma anche nello Spoletino da Peppoloni, similmente al «chi tuttu se magna, se strozza»21 raccolto da Grifoni –, portava gravi conseguenze sull’intera catena, rischiava di ledere il meccani-smo produttivo, quindi l’equilibrio del gruppo, la salute e la sopravvivenza dei singoli che, in un sistema di questo tipo, era la salute e la sopravvivenza del gruppo stesso.
È vero che «dove sono molte braccia è molto pane»22, ma è anche vero che «quanno ‘n c’è-ppiù-qquèlle, fanfanitti
16. Cit. GriFoni o. 1943: 88.17. Ibidem.18. Idem: 82.19. Cit. moretti G. 1973: 238.20. Cit. mattesini e. - uGoccioni n. 1992: 282.21. Cit. GriFoni o. 1943: 87.22. Cit. PaPa c. 1985: titolo.
e-ccaccaèlle»23, cioè ‘quando non hai più nulla da mangiare dovrai arrangiarti con quello che trovi’, perché avere molte braccia significava avere molte bocche e avere molte bocche significava dover gestire le risorse in maniera ineccepibile, magari arrangiandosi con sostanze alimentari sostitutive di bassa qualità, ma di facile accesso: «n témpu de caristìa pane de jjanna»24; «n tèmp(e) d(e) karestìa pèn d(e) vécce»25.
«Minestra che basti, pane c’avanzi»26; infatti, com’è noto, «l’alimento fondamentale è il pane»27, che nel quotidia-no non poteva assolutamente mancare: “quést’è lu pane, e quést’è lu càciu” diceva la nonna di un folignate28 attualmen-te residente a Castiglione del Lago, porgendogli una fetta di pane spessa e una sottile che doveva fungere appunto da formaggio. La costante presenza del pane nei pasti, spesso come unico alimento insieme all’acqua o al vino, lo rendeva elemento cardine dell’alimentazione contadina, immancabi-le sostentamento, tanto da rendere palese una comune con-statazione economico-alimentare: «mulinari e fornari ‘nse moru’ mai de fame»29; «quaranta mulinari, quaranta fornari, quarant’osti so’ centoventi ladri justi justi»30.
Le necessità inequivocabili che emergevano dall’esigenza biologica di nutrirsi rendevano l’alimento pane – accessibile, economico, facilmente cucinabile o reperibile – indispensa-bile e, al tempo stesso, il lemma pane carico di significati che trascendevano dalla mera sostanza alimentare. La polisemia
23. Cit. PePPoloni v. 1981: 51.24. Cit. Pasquini D. 1993: 8625. Cit. moretti G. 1973: 437.26. Cit. GriFoni o. 1943: 85.27. Cit. clemente P. 1985: 217.28. Intervista effettuata a Castiglione del Lago, il 15 gennaio 2008, a
Pietro A. nato a Foligno nel 1948, attualmente residente a Castiglione del Lago (Pg).
29. Cit. GriFoni o. 1943: 52.30. Idem: 53.
131La penuria alimentare nell’Umbria dei proverbiDaniele Parbuono 130
del significante “pane” collegava, in traslato, questa sostanza a una serie di significati differenti: nel proverbio e in genera-le nella fraseologia adoperata nel quotidiano, “pane” poteva significare, appunto, sostanza alimentare (es. «pane, formag-giu e pere, pasto da cavaliere»31) ma anche ricchezza, autosuf-ficienza (es. «lo pane dell’antri cià sette croste e la più-ddura è la mullica»32 che può essere interpretato come ‘quando si ha bisogno degli altri si vive male’) o possibilità, buona sorte mal sfruttata (es. «chi cc’ha r pane n c’ha le dènte, chi cc’ha le dènte nun c’ha r pane»33).
A differenza del pane che, pur se reso obbligatorio dal regime di penuria, conservava un alto grado di rispetto tra le classi subalterne, alcune sostanze facilmente reperibili in campagna attiravano un comprovato sdegno non solo ali-mentare: «più erba se magna, più-bbestia se dovènta»34. L’erba è sostanza alimentare destinata all’allevamento delle bestie e, pur tenendo presente che in periodi di assoluta ristrettezza ogni sostanza commestibile poteva aiutare a superare la gior-nata – «chi spiccica non digghjiuna»35 cioè ‘talvolta anche il poco è sufficiente’ –, nel sentire comune appariva davvero eccessivo, disumano, doversi nutrire allo stesso modo dei buoi. In questo caso la dimensione alimentare trascendeva il materiale per farsi ideologica e, in un proverbio specifi-co, spirituale, religiosa: «desse Cristu all’Apostoli sôi: Non magnate l’erba ch’è roba de bôi»36. Il tirare in ballo il divie-to, reale o presunto, della divinità significava giustificare un moto di ribellione intrinseco al gruppo reso palese di fronte alla difficoltà oggettiva, significava giungere ad un limite di tolleranza oltre il quale non ci si poteva spingere e giustifica-
31. Idem: 86.32. Cit. PePPoloni v. 1981: 224.33. Cit. mattesini e. - uGoccioni n. 1992: 161.34. Cit. PePPoloni v. 1981: 162.35. Idem: 47.36. Cit. GriFoni o. 1943: 85.
re, quasi con timore, il proprio rifiuto, mettendolo in bocca alla divinità. ‘Disse Cristo’ è ancora più forte di quel gene-rico, inconscio e inconsapevole “ipse dixit” non soggettiva-bile, che potremo definire “senso comune”; oltre Cristo non esiste nulla e se il Creatore ha detto che «l’erba […] è roba de bôi», non deve e non può esistere nessuna situazione im-manente in grado di cambiare questo dictat: quando si tira in ballo la divinità, la sua parola non è performativa ma è la “performazione inaggettivabile”. Nella fattispecie «desse Cristu» si traduce in ‘la misura è colma’, oltre ciò è vietato andare qualunque sia la ragione.
La sostanza alimentare maggiormente desiderata era la carne, il cui valore si caricava di elementi simbolici e rituali. La carne era l’alimento delle feste calendariali, dei principali passaggi legati al ciclo della vita, ma anche alle grandi fatiche agricole37.
Si mangiava carne nei pranzi di matrimonio, di battesi-mo, di comunione, di cresima o delle feste religiose annuali e nei pasti organizzati durante i lavori agricoli che implica-vano un notevole dispendio di energia (mietitura, battitu-ra, vendemmia). «In effetti nel mondo rurale tradizionale coesistono, articolati secondo precise regole, due regimi di elaborazione e consumo del cibo: un regime che potremmo definire nutrizionale che organizza la parsimonia del quoti-diano in rapporto alla necessità biologica del nutrimento ed un regime alimentare che entra in gioco nei momenti festi-vi e che riveste un’importanza fondamentale per i rapporti sociali e per l’universo culturale. Mentre il cibo quotidiano serve essenzialmente al bisogno primario di nutrire il corpo per la sopravvivenza e per permettere l’espletamento delle
37. Per un approfondimento sulla teoria dei riti di passaggio si veda van GenneP a. 1981 [1909].
133La penuria alimentare nell’Umbria dei proverbiDaniele Parbuono 132
attività lavorative, l’alimentazione festiva serve a “nutrire la cultura”»38.
In questo ambito però, oltre al rassegnato ma realistico «chi spera su la carne, oggi ride, dimane piagne»39 pare inte-ressante, riportare due proverbi che, attraverso un processo di semantica inversa vicina all’uso retorico del paradosso, rendono l’idea del grado di desiderabilità dell’oggetto in questione: «carne de porcu nè poca, nè troppa»40 e «la carne de vaccina fa vergogna a chi la cucina»41. Al vertice della sca-la gerarchica del desiderio alimentare stava la carne vaccina che, insieme al latte, «sono per lo più assenti dalla dimensio-ne alimentare contadina»42 (anche perché, principalmente, le bestie vaccine e bovine venivano utilizzate per la loro for-za trattrice e non per la loro capacità alimentare); un gradino sotto stava la carne di maiale che «oltre la produzione del campo […] la produzione dell’orto e della bassa corte (gal-line, conigli, anatre, oche, tacchini) […] è necessaria, per l’alimentazione»43.
La dovuta parsimonia nel razionamento della carne suina era direttamente proporzionale al desiderio di consumarne quantità superiori a quelle consentite e, proprio per questo, attraverso il proverbio, passava l’insegnamento di fare atten-zione a evitarne il consumo smodato.
Per quanto riguarda la carne vaccina aumentavano pro-porzionalmente sia il desiderio di consumo che la necessità della parsimonia. Quindi, nell’interpretare oggi i due pro-verbi in questione, non va commesso l’errore di frainten-derne il senso paradossale con la reale applicazione. L’alto desiderio di consumare carne, in primo luogo vaccina/bo-
38. Cit. Baronti G. 1999b: 12-13.39. Idem: 64.40. Idem: 83.41. Idem: 86.42. Cit. clemente P. 1985: 216.43. Ibidem.
vina, in secondo luogo suina, emerge per opposizione dai due proverbi che, in proporzione al livello del desiderio, ne palesano la mancanza attraverso l’espressione limitativa44. È chiaro comunque che la privazione non poteva assolutamen-te essere totale; se è vero che, come ricorda un proverbio to-scano, «l’erba non fa collottola»45, se è vero che il pane è l’ali-mento quotidiano che serviva essenzialmente al nutrimento biologico e al sostentamento, almeno una minima quantità di carne era necessaria a garantire salute e forza fisica: «carne fa carne, vinu fa sangue e pane mantêne»46.
Il grado di disperazione al quale poteva portare una si-tuazione di continuata penuria bene si legge nelle amare parole di un proverbio attestato nell’Orvietano: «è mmèjjo fàccia róscia che ttrippa móscia»47, cioè ‘meglio vivere di ele-mosina che morire di fame’, proprio per questo nei periodi di abbondanza o comunque non di scarsità è «mejo che la trippa crepa, che la robba se spreca»48. Proprio lo spauracchio dell’elemosina, possibile destino di ogni persona che dove-va la sua sopravvivenza all’andamento dei raccolti mediato dallo sfruttamento della classe sociale dominante – «trippa piena ‘n pénza pe’-qquella vuta»49; «saccu pienu non com-patisce quillu digiunu»50 –, creava nel “senso comune” un sentimento di mutuo soccorso racchiuso in un significativo
44. La stessa interpretazione, può essere data, probabilmente, di altri due proverbi riportati da Grifoni: «Pocu cibu e niente affannu, sanità al corpu dànno» (Cit. GriFoni o. 1943: 83); «Chi vô vive sanu e lestu magni pocu e ceni prestu» (ibidem).
45. Cit. GriFoni o. 1943: 86. Lo stesso valeva per altre sostanze ali-mentari reputate poco nutrienti: «‘na magnata de pulenta e ‘na biuta d’ac-qua arza ‘na còssa e la pulenta scappa» (Cit. PePPoloni v. 1981: 101).
46. Ibidem.47. Cit. mattesini e. - uGoccioni n. 1992: 311.48. Cit. PePPoloni v. 1981: 49.49. Idem: 232.50. Cit. GriFoni o. 1943: 88.
135La penuria alimentare nell’Umbria dei proverbiDaniele Parbuono 134
proverbio riportato da Grifoni: «Meju boccon donatu, che boccon magnatu»51.
In generale il rapporto con il cibo, con il buon cibo, ap-pariva come il risultato di un palese ossimoro concettuale che accostava all’oggetto del desiderio, l’alimento prelibato o scelto, il rischio consapevole della rovina che poteva scatu-rire dall’abitudine al lusso non possibile e non accessibile. La classe subalterna sentiva il peso della sua condizione vivendo nella rassegnazione verso un futuro che non avrebbe potu-to portare a nessun sensibile cambiamento; la realtà segnata dalla penuria rendeva l’umiltà unico sentimento razionale e condannava l’ingordigia, il desiderio, come fonti di sicura disgrazia: «la bona cucina vôta saccoccia e saccuccina»; «bona cucina, miseria vicina»; «la bocca è ‘mmucu (buco) strittu, se magna la casa co’ tuttu lu tittu»; «lu gargalizzu ‘ngnotte la casa co’ tuttu ‘l fienile»52; «n’ammazza più la gola che la spada»53.
La riflessione paremiologica sui proverbi alimentari dell’Umbria dovrebbe continuare nell’analisi delle differen-ze fonetiche, morfologiche e sintattiche, attestabili nelle sue diverse zone dialettali54 per poi spingersi a investigare com-parativamente sui possibili piani di intersezione tra i livelli linguistico, semantico ed etnologico; così come si potrebbe aprire un’ampia parentesi sulle possibili strade da percor-rere per tutelare e conservare questo importante “bene im-materiale”. Compito di questo contributo è, però, soltanto quello di riportare l’attenzione su una questione primaria – appunto lo studio dei proverbi – per l’analisi della penuria alimentare nell’Umbria mezzadrile.
51. Idem: 101.52. Idem: 87.53. Idem: 88.54. La suddivisione dell’Umbria in zone dialettali è stata proposta da
F.A. Ugolini nel 1970 e pubblicata in uGolini F.a. 1970. Il lavoro è pro-seguito con le ricerche e gli studi di E. Mattesini, pubblicati in mattesini e. 2004.
La complessità linguistica e comunicativa del proverbio restituisce alla dimensione della penuria una collocazione spazio-temporale precisa, non facilmente commerciabile. La “tradizione selezionata”55 e presentata al pubblico della con-temporaneità non riesce a rendere conto della multiforme realtà in cui l’alienazione che viene venduta come “prodotto tipico” aspira ad “affondare le proprie radici”. Il prodotto che si vende come “tipico” è, in realtà, un “nonprodotto”56 non più connesso al regime di penuria che in passato ne ave-va ispirato la genesi, quanto alle vigenti leggi del mercato, del commercio e dell’economia. Sarebbe forse utile affianca-re a questa diffusa tendenza la promozione di una coscienza critica finalizzata a una “defolclorizzazione57 alimentare” in grado di svincolare la “tipicità” dagli eccessi del gusto di maniera romantica per ricollocarla nel suo spazio concreto: la contemporaneità.
Il proverbio nella contemporaneità ha perso, probabil-mente, la sua funzione vitale e rimane un’espressione lin-guistica che, non più materialmente ma soltanto metafori-camente, accompagna la quotidianità comunicativa di tutti noi. Alcuni proverbi appaiono oggi desueti, disgiunti dalla realtà, testimoni di un’epoca che ormai si è chiusa.
Certo a guardarsi intorno, nel «paese di cuccagna»58 del-le grandi abbuffate, delle sagre e delle feste paesane, delle iniziative politiche, religiose, commerciali, pubblicitarie, nel regime dell’abbondanza sette giorni su sette, torna alla men-
55. Pietro Clemente, a proposito dei balli tradizionali in Sardegna, esprimeva un concetto che può essere ben utilizzato anche in questo caso: «le tradizioni si scelgono» (Cit. clemen te P. 1998: 17.)
56. Il termine “nonprodotto” calca volutamente parte della sua semantica dal concetto di “nonluogo” elaborato da Marc Augé. Per un approfondimento sulla questione si veda auGé m. 1993.
57. Per un approfondimento sul concetto di “defolclorizzazione” si veda Gri G.P. - zolDan c. 2007.
58. Cit. cocchiara G. 1952: titolo.
Daniele Parbuono 136
te un proverbio largamente diffuso in Umbria, che qualche decennio fa avrebbe avuto un profumo di speranza augu-rale, di preghiera provvidenziale, oggi pare essere assunto soltanto come un dovere inderogabile, come una missione da compiere: «du k(e) s(e) maññucca dì c kondukka»59.
59. Cit. moretti G. 1973: 326.
Giancarlo Baronti e alessanDra seGhetta1
Alberi e santi ad Allerona
il Bello Delle Feste
La festa di Sant’Isidoro ad Allerona, come altre che si svolgono periodicamente nella nostra regione, possiede
una caratteristica che la rende estremamente appetibile per una ricerca di tipo etnografico: una assoluta e totale assenza di qualsiasi tipo di documentazione sul suo passato. Tutti gli spogli e i sondaggi eseguiti negli archivi civili ed ecclesiastici della zona hanno dato, finora, esiti negativi.
Ciononostante non sono mancati tentativi di tipo anti-quario e tardo evoluzionista di considerare la presenza del-le macchine processionali dette “pugnaloni” (caratteristica specifica della festa alleronese) come un puro e semplice re-litto di materiali rituali del mondo classico2.
Diverso, ovviamente, è il discorso allorché si intrapren-de una doverosa analisi di tipo critico-filologico su eventi
1. Ad Alessandra Seghetta si deve la realizzazione della campagna di interviste per la realizzazione della sua tesi di laurea (seGhetta a. 1999-2000) che costituisce, assieme a una ripetuta osservazione e frequentazio-ne dell’evento festivo la base etnografica di questo lavoro. Per maggior comprensione il materiale di intervista, raccolto nei mesi di febbraio e marzo 2000 è restituito in una trascrizione fonetica estremamente sem-plificata che non nasconde però uno dei tratti fondamentali e salienti del dialetto di Allerona e in genere di tutto l’orvietano: l’apertura in [-e] della [-i] finale, [le contadine] “i contadini”. Per maggiori e più corrette infor-mazioni si può consultare il lavoro di Giovanni Moretti (cfr. moretti G. 1987: 129-134).
2. Cfr. Perali P. 1939: XXX-XXXI, satolli D. 1964.
139Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 138
festivi che posseggono, invece, una complessa e articolata documentazione che ne accompagna le plurisecolari vicende (sePPilli a. 1972).
Se la questione fosse ristretta solo all’interno del dibattito antropologico, non varrebbe forse la pena di soffermarsi più a lungo sull’argomento, ma tali approcci riduzionisti, largamen-te utilizzati nelle guide turistiche e nelle pubblicazioni locali, hanno diffuso una sorta di vulgata che si manifesta anche nel corso dei colloqui di intervista: molte delle persone interpella-te hanno orgogliosamente affermato che la festa del loro pae-se, magari la festa del patrono, era una festa pagana.
Pur ammettendo la possibilità che moduli e materiali rituali precristiani o anche preclassici, possano essere stati filtrati, rielaborati e riplasmati fino a ritrovarsi nelle odierne manifestazioni festive, non è possibile accettare un modello interpretativo che si prefigge come unico scopo quello di ri-salire la filiera diacronica, si limita ad ascrivere totalmente il presente a lontani e insondabili passati e si preclude la possi-bilità di indagare il senso che ogni singola festa possiede per la determinata comunità che la allestisce, la realizza e la vive.
Simili approcci, esemplare quello di Perali che, per sua stessa ammissione, non ha neppure mai assistito alle feste di cui parla, non sono interessati alle dinamiche del presen-te, ma solamente a individuare, facendo ampio sfoggio di erudizione antiquaria, quali siano stati gli antichi rituali che stanno all’origine delle odierne feste.
Così facendo manifestazioni come i Pugnaloni di Acqua-pendente e di Allerona e la Barabbata di Marta che oggi, pur presentando alcuni elementi di affinità tra di loro, posseggo-no autonome e ben distinte fisionomie, sono ricondotte alla medesima, identica origine:
…accenneremo anche a qualche altro tratto dei “Pugnaloni” e della “Barabata”, che ci sembrano connessi ad episodi di quel-le antiche “simulazioni” ed “imitazioni” compiute dai ragazzi
di una delle numerose “corporazioni di mestiere” esistenti ad Ostia, nel porto fluviale-marittimo di Roma3.
Il rischio incombente in ogni approccio generalizzante e condotto con taglio esclusivamente diacronico, è quello di immettersi in un vortice sempre più esteso di raffronti e di comparazioni perdendo di vista la specificità di ciascun evento festivo. Elementi isolati di complessi rituali festivi, separati dal contesto storico e geografico che li ha prodotti, scardinati dal singolo e specifico discorso festivo che forni-sce loro intelligibilità e senso, sono collocati fianco a fianco, come materia morta su di un tavolo anatomico, e astratta-mente messi a confronto tra di loro per individuare affinità e somiglianze.
La singolarità di ogni situazione viene così persa di vista e diluita in una sorta di magma originario e indistinto; in questo caso, trattandosi di dendroforie, cioè di rituali che attuano traslazioni di essenze vegetali, si può proprio parlare di quel “brodo vegetale” cui accennava van Gennep4, nella sua critica alle interpretazioni antiquarie ed evoluzioniste ti-piche dell’evoluzionismo di Frazer5.
Ogni festa certamente vive di elementi ereditati dalla tradizione, ma trasmessi secondo una linea genealogica che non riconduce mai ad un passato indistinto ma può risalire ad uno specifico passato localmente connotato. Se mancano documenti sul passato per la festa di Allerona non mancano, come vedremo, per quelle di Acquapendente e di Marta: ciò che emerge, oltre al fatto che le feste subiscono continue tra-sformazioni e costanti aggiustamenti, è che ognuna di esse presenta caratteristiche peculiari e inconfondibili.
3. Cit. Perali P. 1939: XXX.4. Cfr. van GenneP a. 1947: 993-995.5. Cfr. Frazer J. G. 1911.
141Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 140
Non mi pare che ci sia bisogno di sottolineare come sia quasi naturale che tutte le feste che in areali contigui si svolgono all’interno dello stesso ciclo calendariale, possano presentare alcuni elementi di affinità: non può meravigliare, anche se si possono sempre trovare delle eccezioni, che le feste del ciclo primaverile, alle nostre latitudini, presentino addobbi, macchine processionali e decorazioni elaborate con fiori freschi, con foglie verdi, fronde rigogliose e frutti di stagione.
Ciò che conta è che le singole feste, pur rivelando alcuni tratti simili, sono diverse non solo perché fanno riferimento a occasioni calendariali o liturgiche differenti (passaggio da aprile a maggio, molteplici figure del sacro quali la Vergi-ne e diversi santi a culto prevalentemente locale) ma perché ogni festa è il frutto di una sorta di operazione di bricolage che, sulla base del “materiale festivo” disponibile, compie delle scelte e realizza un prodotto, un discorso festivo, una concatenazione di sequenze rituali, di gesti, di oggetti, nel suo complesso assolutamente unico. Il gioco della pignatta, l’albero della cuccagna sono presenti in molte occasioni fe-stive ma, oltre a non essere mai realizzate con le medesime modalità, in ogni specifica festa si inseriscono in sequenze temporali diverse e possiedono un senso diverso. L’albero della cuccagna di maggio non ha lo stesso significato di un albero della cuccagna inserito in altro momento del ciclo ca-lendariale. Tale meccanismo di produzione della differenza costituisce un elemento di coagulo delle peculiari identità locali e si attiva anche nei processi di “invenzione della tradi-zione”, cioè in occasione della istituzione di nuovi momenti festivi, realizzati da comitati locali o da pro-loco allo scopo di incrementare il turismo ma anche per riannodare sim-bolicamente interrotti legami con un passato locale, spesso improbabile ma avvertito come distintivo e qualificante. Le innumerevoli giostre della Quintana o del Saracino o dell’A-nello che sono germogliate negli ultimi decenni in molti cen-
tri dell’Italia centrale, pur mettendo in scena le medesime situazioni agonistiche, tendono puntigliosamente a mante-nere una loro specifica identità e una patente riconoscibilità attraverso meditate alchimie di un materiale festivo sostan-zialmente identico. Per altro, il radicamento sociale e cultu-rale ottenuto da simili eventi festivi non può essere imputato al riferimento privilegiato che cercano di mantenere con il passato, ma piuttosto al fatto che, mettendo in scena una ad-domestica finzione del passato riescono a convogliare e ca-talizzare istanze culturali e relazionali espresse dal presente.
Il bello delle feste consiste proprio nel fatto che non ne esistono di uguali, anche quelle che per motivi liturgici o calendariali sono elaborate con “materiale festivo” identico alla fine riescono diverse e continuano a mantenere la pro-pria identità anche se sottoposte a continui processi di ripla-smazione.
Altro elemento negativo connesso agli approcci che pur partendo dal presente, lo abbandonano lestamente per rifu-giarsi in un più domesticabile passato, riguarda l’impossibi-lità di prendere in considerazione gli aspetti più concreti e materiali degli eventi festivi: se le feste continuano tutti gli anni a ritornare è perché vi sono delle associazioni e delle co-munità che lavorano, spesso duramente, per farle ritornare e che nella festa investono non solo risorse economiche ma soprattutto risorse simboliche e comunicative.
Se le feste procedessero da sole senza rispondere alle esi-genze culturali e sociali di coloro che le preparano, le allesti-scono e le vivono, non si comprenderebbe perché alcune di esse ad un certo punto smettono di ritornare e finiscono nel più completo oblio.
Solo il metodo etnografico può tentare di rispondere a tutte le questioni sollevate, in quanto promuove modalità di ricerca rivolte al presente, tese cioè a esperire gli eventi nel momento in cui si realizzano.
143Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 142
Ovviamente il presente non è solo ciò che si svolge sotto gli occhi del ricercatore ma comprende anche quello che si coglie attraverso una etnografia della memoria nelle testimo-nianze soggettive dei singoli e quindi le impressioni dell’oggi e i ricordi del recente passato, fissati nella memoria di coloro che appartengono alla comunità e che hanno vissuto e con-tinuano a vivere la festa. Solo sulla base della osservazione diretta e delle informazioni raccolte mediante colloqui di intervista è possibile individuare le istanze culturali e rela-zionali che la comunità esprime e realizza nell’ambito di una specifica occasione festiva.
Premessa
Per poter meglio comprendere il significato che ha possedu-to fino ad un recente passato e quello che, invece, esprime oggi la festa di Sant’Isidoro ad Allerona, soprattutto per co-loro che la organizzano e vi partecipano ma anche per coloro che vi assistono da spettatori o turisti, è necessario delineare brevemente la direzione e gli effetti delle grandi e repenti-ne trasformazioni economiche, sociali e culturali che hanno investito, assieme a tante altre aree della nostra regione e del nostro Paese, anche questo piccolo mondo di cui stiamo parlando.
Il modello insediativo di Allerona è simile a quello di molti altri piccoli e medi centri dell’Italia centrale: il bor-go antico, arroccato sopra un’altura, domina fisicamente la campagna sottostante contrassegnata dal tipico paesaggio a case sparse dell’appoderamento mezzadrile. La forte di-versità tra borgo e podere, almeno sino alla fine degli anni sessanta dello scorso secolo, corrispondeva ad una netta e sentita divisione di ordine sociale e culturale. Prima della completa dissoluzione della mezzadria nella compatta strut-tura del borgo risiedevano i piccoli e medi proprietari ter-
rieri, gli artigiani, i commercianti e i pochi addetti al settore terziario, nella campagna frammentata in centinaia di poderi abitavano esclusivamente le famiglie coloniche i cui compo-nenti salivano raramente in paese: in occasione delle feste di precetto, per ottemperare agli obblighi stagionali imposti dal contratto di mezzadria o per l’acquisto dei generi di consu-mo indispensabili che l’economia poderale non produceva:
S’annava avanti così, perché la bottega, le così dette vecchie botteghe, ce s’annava pochissimo, due o tre volte all’anno a fa spesa... pe la trebbiatura, pe la mietitura, Pasqua, Natale e stoppe. Perché la moneta girava pochina. Anche, voglio dì, pe vestisse eh... le donne pe tutto l’inverno filavano la canapa, no? Pe fasse le lenzola, ce facevano n po’ tutto... A primavera, finita la canapa, cominciavano co la lana pe fa le maglie, li majoni e ce facevano n po’ le giaccone, le mutande, tutto ce facevano co la lana. Le scarpe eh, c’erono le calzolae perché nun se trovavano ne le botteghe. Questo me lo ricordo bene, io; da ragazzette s’annava dal calzolaio a prende la misura e te faceva la scarpa6.
Il borgo costituiva non solo il centro del potere economico e, almeno fino al secondo dopoguerra, del potere politico ma esercitava una forte egemonia culturale sulle classi rurali subalterne:
Era vero e ha esistito fino alla guerra. Fino alla guerra c’era sta rivalità fra contadini e paesani, na specie de campanilismo, ecco... ma mica solo lì, dapertutto. Basta che erano paesani, se davano n po’ più di... arie, pure se stavano peggio di noi come soldi. sta discriminazione ha nsistito per così dire, non solo ad Allerona, ma n po’ tutta la campagna e l paese. Per-ché, allora, le contadini vivevamo tanti in campagna, nsomma. Quando s’arrivava al paese, specialmente a le feste da ballo, mettemo no? Difficile che la ragazza del paese ballava co uno della campagna... toccava sempre fa due e due... È vero, nsom-
6. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 14.
145Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 144
ma; a quelli che domanda, de settant’anni, del tempo nostro, chi se lo ricorda, je dice che è così…7
Con il passare del tempo e soprattutto con la cessazione del rapporto di mezzadria ed il conseguente spopolamento delle campagne, il netto dualismo tra città e campagna si è in par-te attenuato, ma non è scomparso del tutto. Solo una piccola parte dei componenti delle famiglie coloniche che hanno ab-bandonato i poderi e trovato occupazione nell’artigianato, nell’industria e nei servizi si è trasferita nel borgo: la parte più consistente risiede infatti nella grossa frazione di Alle-rona Scalo e in un quartiere di nuova costruzione edificato sulle pendici meridionali del borgo proprio per soddisfare, almeno in parte, le esigenze abitative delle famiglie che ave-vano lasciato i poderi.
Le case coloniche disseminate nella campagna in piccola parte sono rimaste abbandonate e disabitate, in parte sono state acquistate da forestieri, in parte utilizzate come secon-de case:
…na volta eravamo tutte contadine... Lei guarda, come vede co l’occhio tutte le case abbandonate, erono tutte piene, co tutte contadine... 8
La meccanizzazione e le nuove tecniche di conduzione agri-cola hanno progressivamente ma radicalmente trasformato il paesaggio agrario circostante che non presenta più, se non in modo marginale e residuale, le culture promiscue tipiche dell’appoderamento e della conduzione mezzadrile: ad ampi seminativi si alternano attualmente aree dedicate alle colture specializzate della vite e dell’olivo.
Tali trasformazioni hanno gradualmente, nel corso degli ultimi trenta anni, trasferito il fulcro delle attività economi-
7. Idem: inf. 15.8. Idem: inf. 16.
che e culturali dall’antico borgo collinare alla frazione di Allerona Scalo, situata in pianura e contigua alle principali vie di comunicazione, che ha visto, in pochi anni, un con-sistente insediamento di attività artigianali, industriali e di trasformazione dei prodotti dell’agricoltura e un parallelo costante aumento della popolazione che attualmente supera largamente quella residente nel borgo. La sede municipa-le è ovviamente rimasta nel borgo antico ma da vent’anni i sindaci di Allerona sono tutti “espressi” dalla frazione più popolata.
L’antica opposizione città-campagna, che oggi non può certamente ripresentarsi secondo le modalità tradizionali di conflitto tra borgo e insediamenti rurali, trova ancora sottil-mente il modo di esprimersi in un conflitto latente, spesso accuratamente dissimulato e negato, tra l’antico borgo e la nuova frazione “usurpatrice”:
…però, nsomma, l’alleronesi ce potevano vede poco co li con-tadini e come adesso co Allerona la stazione… [Allerona Sca-lo] eppure nu jemo mai fatto niente... ma è così9.
Il peso, tuttora dolorosamente sentito, di un “cattivo passa-to” impastato di miseria, di fame e di umiliazioni, si avverte ancora non tanto nella vivezza dei ricordi ma soprattutto in una sorta di sordo risentimento che non permette di ripia-nare completamente quel profondo solco che, fino a ieri, ha marcatamente diviso questa piccola comunità:
... li padroni erono gnorante... na volta era così… La polen-ta, mattina, a colazione, poi la sera, a cena... le contadine eh... carina, li faceono soffrì, li padrone! Eh sì... a queli tempe, era difficile... noe ce toccava lavorà e n se poteva dì niente, nun
9. Ibidem.
147Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 146
potevi fiatà; e toccava lavorà l doppio: pe noe e pe loro e tanto nu je bastava... c’era sacrificio… 10.
Perché na volta, l contadino al padrone che abitava lì, je disse: “Sor padrò, ma io su sto libretto nun ce capisco niente!”. “E nun ce devi capì. Si c’arrive a capì, è finito!”. Si arrivava a capì dov’era lo sbaglio, allora - dice - era finita. Perché, na volta li padroni erano li padroni e facevano li signori veramente... li contadine erono n po’ stiave… ’l contadino lo maltrattavono... nun potevono reagì, perché nun erano all’altezza da trovà le parole giuste pe digliele e... nun erano all’altezza…11
Per tener conto delle passate disparità sociali e insediative e delle differenze di ordine ideologico e culturale che storica-mente hanno espresso, la rilevazione etnografica sulla festa di Sant’Isidoro ha previsto colloqui d’intervista sia con i resi-denti del borgo, sia con gli ex mezzadri che un tempo popo-lavano la campagna sottostante, al fine di garantire adeguato spazio a quella pluralità di prospettive che sola permette di definire il senso complessivo di un evento, nodale all’interno del ciclo calendariale di Allerona, come la festa di Sant’Isi-doro. Proprio partendo dai significati parziali che gli attori sociali, dai loro punti di vista, attribuiscono agli eventi, rie-sce possibile comprendere la vitalità di una festa, la “neces-sarietà” delle riplasmazioni e degli aggiustamenti introdotti in tempi recenti e, non ultima, la palese infondatezza di tutte quelle interpretazioni che hanno teso a individuare il senso della festa in lontani e improbabili passati, senza compren-dere che una festa può continuare ad esistere solo se realizza costantemente il bisogno di una collettività di esprimere e di manifestare, mediante simboli condivisi, i propri assetti culturali e sociali, le dinamiche dell’appartenenza, le coor-dinate dell’identità.
10. Idem: inf. 27.11. Idem: inf. 23.
sant’isiDoro aGricoltore. la traDizione aGioGraFica
Le ragioni della larga diffusione del culto di Sant’Isidoro agricoltore in tutta l’Europa moderna sono strettamente connesse alle vicende della sua vita e a quelle della sua ca-nonizzazione.
Secondo le fonti agiografiche ufficiali12 nacque a Madrid da una famiglia di poveri contadini i quali vivevano colle fa-tiche delle lor mani coltivando i campi altrui13 e, rimasto ben presto orfano, iniziò la sua vicenda terrena di contadino alle dipendenze di un proprietario terriero di Madrid presso cui rimase fin quando la città non venne conquistata dagli Almo-ravidi (nei primi anni del XII secolo). Fuggì, allora, a Torre Laguna dove si sposò con Maria Toribia e iniziò a lavorare alle dipendenze di un altro possidente terriero. Ritornato in seguito a Madrid si impiegò presso Giovanni di Vergas (o Vargas). In tutte queste diverse situazioni lavorative Isidoro si mostrò sempre estremamente umile e rispettoso nei con-fronti dei suoi datori di lavoro anche quando fu ripetuta-mente accusato di trascurare i suoi doveri per dedicarsi alla preghiera. Già da queste prime e succinte notizie biografi-che si delinea la figura di un uomo profondamente legato al mondo rurale non solo per le sue origini familiari e per le necessità economiche, ma anche per un’autentica vocazione a una vita semplice, riservata e sottomessa. Tale dedizione all’umile lavoro dei campi e la costante pratica religiosa sono i valori che più di tutti emergono dalla figura del santo, an-che i miracoli che tradizionalmente gli si attribuiscono ap-paiono in linea con tale caratterizzazione. Il primo, che ri-troviamo come motivo costantemente riprodotto nella festa di Allerona, concerne proprio la risoluzione metastorica del
12. Cfr. Il grande libro dei Santi. 1998: II, 1136-1138; Isidoro (1080-1130).
13. Cfr. scattiGno A. 1984: 498.
149Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 148
conflitto tra lavoro e pratica religiosa. Giovanni de Vergas, stupito dei buoni risultati del lavoro di Isidoro, un giorno lo spiò e lo scoprì in preghiera mentre un gruppo di angeli guidava l’aratro al suo posto. Secondo un’altra tradizione il miracolo presenterebbe modalità diverse:
I vicini accusarono Isidoro presso il cavaliere di trascurare l’agricoltura e di andare piuttosto peregrinando per le chiese di Madrid… Il cavaliere, irato, affronta Isidoro che reagisce con pazienza e modestia, promettendo di risarcire… il danno eventualmente arrecato al padrone. Dubbioso, il cavaliere volle allora attendere nascosto il ritorno del contadino dalle sue pie devozioni, e di nuovo fu colto dall‘ira nel constatare con quale negligenza Isidoro si ponesse al lavoro. Movendo dunque ver-so di lui, lo trovò nel campo intento a tracciare solchi, ma un duplice giogo di buoi bianchi arava con lui al suo fianco14.
L’altro miracolo riguarda invece il rapporto di assoluta de-ferenza e di dedizione di Sant’Isidoro nei confronti del suo padrone:
Leggesi negli atti dei santiche Isidoro abitava in una campa-gna presso Madrid a servizio dell’illustre Giovanni de Vargas: Un giornonell’estivo tempo, in cui il cocente sole vibrando più fervidi raggi inaridisce la terra, costiu venuto a visitare il suo podere ardendo di sete domandò ove fosse dell’acqua, onde rinfrescare le arse fauci. Isidoro allora additando da lungi un luogo, risposegli, che lì ne troverebbe. Avviossi il de Vargas colà, dove non iscorgendo che un’arida pietra si tenne derisoe fecene aspre querele. Allora il santo impugnato il pungolo per-cosse quel duro macigno e subito sgorgò d’acqua dolcissima e fresca una fonte perenne15.
La canonizzazione giunge, abbastanza tardiva, a distanza di circa cinque secoli dalla morte (12 maggio 1622) e sembra
14. Idem: 483.15. Cit. N. N. 1838: 189-190.
rispondere, piuttosto che a motivi di carattere prettamente religioso e devozionale, a esigenze politiche (assieme a lui sono canonizzati altri tre santi spagnoli) e di tipo sociale: l’umile, pio e ossequioso santo spagnolo sembrava costituire un ottimo modello da offrire alla devozione delle inquiete plebi rustiche europee. Ben presto, infatti, addirittura prima della canonizzazione, il suo culto si andò rapidamente dif-fondendo in tutta la Spagna, la Francia la Baviera e l’Italia, radicandosi particolarmente nelle zone rurali.
La prima attestazione di un culto nei confronti di Sant’I-sidoro ad Allerona si ritrova nella seconda metà del Seicen-to, perfettamente in linea con le più ampie dinamiche euro-pee di diffusione del culto:
Nello statuto del Comune di Allerona del 1583 nel libro IV: “De li extraordinari” al capitolo X: “De le feste da riguardarsi” non viene citata la festa di Sant’Isidoro. La prima menzione di un altare dedicato a Sant’Isidoro, nella Chiesa alleronese tito-lata a San Michele Arcangelo, è fatta nella visita pastorale vo-luta dal vescovo di Orvieto mons. Giuseppe della Corgna (25 aprile 1673). La stessa notizia, dell’esistenza cioè di un altare dedicato al santo, la troviamo nel 1678. Nel 1722 il vescovo mons. Onofrio Elisei fa notare, negli atti della cronaca della sua visita, che l’altare di Sant’Isidoro è mantenuto dagli agri-coltori. Più particolareggiata è la notizia fornitaci dal vescovo mons. Giuseppe dei Conti di Marsciano che, nel resoconto del 2 maggio 1735, fa scrivere che essendo l’altare di Sant’Isidoro per tradizione affidato alla manutenzione degli agricoltori, essi si obbligavano a portare ogni anno una “coppa” di frumento, per ogni pezzo di terra arato nell’arco di un giorno. Esortò che questo obbligo fosse rispettato, e per soddisfare le spese di cul-to e per rendere più solenne la festa del santo16.
Notizie, tutto sommato, molto scarne ma che indicano chia-ramente come la manutenzione dell’altare e l’organizzazio-
16. Cit. Farnesi l. 1978.
151Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 150
ne della festa annuale fossero di esclusiva competenza dei lavoratori della terra, probabilmente riuniti in una sorta di associazione sul modello di quelle “società dei bifolchi” che ad Acquapendente organizzavano e gestivano la festa dei Pugnaloni e a Castelgiorgio la festa di San Pancrazio.
DiFFusione e asPetti Del culto Di un santo contaDino
Come abbiamo già rilevato la diffusione del culto di Sant’I-sidoro fu ampia e capillare; per la regione umbra non si di-spone di adeguata documentazione mentre per la Toscana sono stati raccolti elementi che confermano l’interesse e l’attenzione dei grandi proprietari terrieri nei confronti di un modello di santità totalmente funzionale alle esigenze di controllo sociale delle campagne a conduzione mezzadrile:
Un Santo tutto dedito alla fede, in particolare devoto al culto mariano, alla famiglia e al lavoro dei campi; era il simbolo e l’espressione insieme della cultura e della religiosità contadina ma anche dello spirito conservatore dei ceti dominanti. Le vir-tù che testimoniavano la sua “santità” in terra, erano la pietà, la carità, l’umiltà, l’astinenza e soprattutto la pazienza. Isidoro, tutto Chiesa, campo e famiglia, era l’immagine di una perfe-zione morale, era un modello che si prestava ad entrare con la sua specificità contadina nel già popolato universo devozio-nale delle compagne toscane. Era, così fu presentato ai fedeli toscani, un modello di identificazione positiva per i lavorato-ri delle campagne, specie per quell’universo atomizzato della mezzadria, dove il contadino viveva e lavorava insieme alla sua famiglia nell’isolamento del podere e sotto l’occhio vigile del fattore e del padrone17.
Naturalmente la figura del santo dell’agiografia ufficiale subisce, nella sua recezione popolare, processi di riplasma-
17. Cit. ciuFFoletti z. 1985: 30.
zione tendenti a renderla più vicina e più familiare. Così la tradizione orale raccolta ad Allerona colloca le vicende della vita terrena del santo non nella lontana Madrid, ma nella più familiare Maremma toscana e, non recependo totalmente il messaggio di umiltà e di subordinazione presente nella tra-dizione ufficiale, finalizza il miracolo dell’acqua non all’ap-pagamento della sete del padrone, ma all’abbeveramento dei buoi aratori:
... l mi poro babbo mi riccontava che sto san Sidoro era n bifol-co a Maremma. Allora a Maremma lavoravano co tutte bestie, mica c’erano li trattori. E vedevano sto san Sidoro che teneva le bestie sempre mejo dell’artre… sempre li mejo bovi e allora dice: “Ma come mai, come mai?” e l padrone lì, n so chi era, l conte, lo pigliava n po’ sott’occhio. E la mattina va là, l pa-drone pe rimproverallo, lue, ha visto? Co la paletta, quella lì che adesso portano n processione... col pungolo, col pungolo se sterrava, se puliva l’aratro, davante le bove, prese quello e scappò su l’acqua e bevero le bove. Allora l padrone rimase male; disse: “Te see più de me”, je disse... Per questo, dopo, lo fecero santo18.
In molte località, tutt’ora, il quindici di maggio, si assiste alla celebrazione liturgica della festa del santo contadino generalmente associata all’ostentazione dei frutti del la-voro agricolo, come, ad esempio, nell’area extraurbana di Foligno, attorno alla chiesa di San Manno, dove la statua del santo viene trasportata in processione assieme a grossi “ceri”, strutture in legno a forma di piramide a gradoni, trai-nati da trattori e ricoperti di “primizie”, oggi riproduzioni in plastica, ma un tempo sicuramente frutti e ortaggi naturali. Simile, anche se realizzato diversamente da un punto di vista materiale, è il modello di riferimento per la festa del santo contadino a Fossola, una frazione di Carrara:
18. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 16.
153Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 152
Il quindici maggio, giorno della ricorrenza del Santo, la solen-ne celebrazione religiosa è accompagnata a Fossola da varie iniziative popolari; tra queste la più antica è quella del “Maz-zolino di Sant’Isidoro”. Si tratta di un disco di compensato del diametro di circa un metro, sul quale vengono fissati, con l’aiuto di fili di ferro, tutti i prodotti dei campi: frutta, verdu-ra, prodotti dell’orto, spighe di grano, olio, uva, uova, pane, ecc…. Il “mazzolino” viene esposto sulla facciata della chiesa, appoggiato alla balaustra della vetrata che sovrasta il portale d’ingresso e benedetto dopo la celebrazione religiosa.19
i PuGnaloni Di allerona
La peculiarità dell’evento festivo alleronese non consiste, quindi, nei festeggiamenti tributati al santo contadino, lar-gamente diffusi in molte aree rurali, ma nella presenza do-minante che possiedono all’interno della festa i carri e le fra-sche processionali denominati pugnaloni.
Con il termine pugnalone oggi si intende una sorta di car-ro di piccole dimensioni, tant’è che un intervistato ha preci-sato: «beh, quelli di Allerona so carretti»20, non motorizzato, che si regge su ruote e solitamente trainato, nel corso della festa, dai rispettivi costruttori. Sul pianale del carro sono al-lestite in buon ordine riproduzioni in miniatura di scene di vita rurale (animali, attrezzi agricoli, cicli lavorativi, squar-ci d’interno di case di campagna…). Il tutto realizzato con grande verosimiglianza ed esclusivamente con materiali na-turali o tradizionali, legno, argilla, cartapesta, metallo, così com’è sancito dal regolamento della festa elaborato dalla pro-loco. Interessante, da un punto di vista comparativo è anche la pratica di allestire sui pianali quelli che con termine tecnico si chiamano “giardini di Adone”, cioè coltivazioni di
19. Cit. http://www.massacarrara.net/lsgmarconi/trare5it.htm.20. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 14.
cereali attuate con particolari modalità che, il giorno della festa, possano simulare, nel contesto miniaturizzato, i campi a seminativo. Ricordiamo che simili tecniche sono diffusa-mente utilizzate per allestire nella settimana di Pasqua i co-siddetti “sepolcri”.
I soggetti e le scene, riprodotti con grande attenzione, maestria e cura dei particolari, oggi non sono scelti arbitra-riamente dai costruttori. Ogni anno, infatti, la pro-loco e il municipio di Allerona assegnano un tema che dovrà essere reso in forma plastica sui pugnaloni: vendemmia e vinifica-zione, la raccolta e la spremitura delle olive, il ciclo lavorativo del grano. In passato ciascun costruttore decideva autono-mamente l’allestimento tematico del pianale del pugnalone:
Poe, ce ne mettono de le... quello che se faceva n orticino, ma li carri... quanno è la sera avanti de la festa del Santo, ce se pre-para tutto: la barbaricia, quella del bosco che cresce su le sasse [muschio] ...poe ce famo n po’ come le campe, na vigna, du se fa l fieno, du se fa l’oliveto, li pascoli, ce pascolano le pecore, do essimo fatto n porchettino, na scrofetta, dele pecorelle21.
Al centro del pianale del carro è conficcato un frondoso ramo d’albero, la cosiddetta “frasca”, ornato con fettucce e nastri colorati, fiori, come il maggiociondolo ed il papavero tipici di questo mese, grano, carciofi, aglio, cipolle, frutta di stagione, pane ed altri prodotti della tradizione alimentare contadina come vino e formaggio. Nel passato venivano in-seriti nei pugnaloni anche altri oggetti, le piccole ricchezze che poteva possedere una famiglia colonica:
… io me ricordo che da quanno ero fija, insomma… fanno st’albere e poi l’infioccono e doppe ce mettono pane, vino, l formaggio, tutto aglio, cipolla, tutto quello che… de i campi, carciofe, ce mettono tutto questo, piano piano e lo nfioccono
21. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 24.
155Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 154
co tutte le fiore… tutte anche co le fiore fatte de carta, che ce l’ho fatte anch’io. Attaccavano li scialli, le sciarpe colorate… le collane de corallo delle nonne... chi c’aveva più cose da metter-ci, ce l’appendeva, ha capito? Quelli nastri de li fiji; se facevono la cresima col nastro, le mettevono lì, le lasciavono tutte pe fa nfioccà ste... albere22.
La frasca è solitamente di quercia, chiamata nel locale dia-letto “cerqua”, oppure di pioppo, denominato alla maniera toscana “oppio”, di ornello o di acero detto “stucchio”:
Sì, n albero qualsiasi: cerqua, diciamo, lo stucchio; nu lo so si ha capito qual è. Piante così, fatte conto, piante grosse tutte infioccate, nastre, le colore. Era bello nco da vèdise, sa! Io, me rimanevano impresso, n vedeve l’ora da vedelle. Le vedevamo n processione. Io, me ricordo che ce s’annava co le mi sorelle, li mi fratelli 23.
La preferenza ricade su queste tre essenze perché sono le più diffuse nei boschi alleronesi; in particolar modo si predi-lige la cimatura del pioppo perché con le sue fronde, meglio delle altre, fa risaltare i nastri variopinti e i prodotti con cui viene addobbato:
La frasca noe ce l’emo messa sempre; soprattutto de pioppo perché de pioppo se vedono le nastre24.
Sulla tavola di ogni pugnalone immancabile scena è quella che riproduce uno dei miracoli di Sant’Isidoro: il santo ingi-nocchiato in disparte in atto di preghiera ed un angelo che ara in sua vece i campi con un aratro trainato da una coppia di buoi:
22. Cit. Seghetta A.1999-2000: inf. 3.23. Idem: inf. 28.24. Idem: inf. 24.
Il miracolo di Sant’Isidoro, sul carro ci deve essere sempre, è fondamentale; comunque sia realizzato il carro, in un angolo, il miracolo del Santo che prega mentre gli angeli per lui tirano l’aratro in modo tale che il lavoro vada avanti ugualmente, è fondamentale. Proprio per legare, diciamo così, la tradizione del pugnalone alla solennità religiosa, alla festa di Sant’Isidoro. Non c’è pugnalone senza Sant’Isidoro e non c’è Sant’Isidoro senza pugnalone. Io ripeto, l’ho già detto anche prima, ma da quando so nato non ho mai visto disgiunte la festa di Sant’Isi-doro dalla manifestazione dei pugnaloni25.
Assieme ai carri vengono allestite e portati in processione a braccio delle “frasche d’onore” che gli Alleronesi chiamano pungoli o pugnaloni a rocca, costituite da un bastone che nella sommità presenta una sorta di gabbia ovoidale costru-ita con asticelle di legno flessibile, solitamente di pioppo:
… quattro bastoni piegati, legati a questo palo, alla testa, poi allargati un po’, fatti na specie di uovo, diciamo... Quattro a croce così... e quello lì, l’imbottivano di fiori... di fiori e roba dei campi26.
… l’ultimo metro, c’era una gabbia ovoidale; lì ce mettevono li fiori de campagna, le caciotte, le fotografie dei proprietari dei pugnaloni, dei contadini...27
Bisogna precisare che la presenza nella festa dei “pugnalo-ni a rocca” è piuttosto recente, frutto, assieme ad altri che tratteremo in seguito in modo più dettagliato, di un ripensa-mento complessivo dei tempi e dei modi della festa che ha preso corpo nel corso degli ultimi venti anni:
… si è cominciato a ricreare il pungolo che prima era stato po-sto nel dimenticatoio. Poi si è creata anche con il pungolo, eh,
25. Idem: inf. 1.26. Idem: inf. 4.27. Idem: inf. 25.
157Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 156
la rocca, no? La raffigurazione del pungolo che nella sommità ha, diciamo così... la gabbia, quella struttura ad asticelle ricur-ve con dentro nastrini, santini, oppure proverbi che richiama-no l’attività della natura, oppure pezzetti attaccati di prodotti agricoli, oppure anche arnesi…28
La recente introduzione dei “pugnaloni a rocca” è in effetti una reintroduzione in quanto simili sorte di pugnaloni sono documentati in una descrizione della festa probabilmente risalente agli anni Trenta dello scorso secolo:
… i “Pugnaloni” di Allerona consistono in un’asta alta circa tre metri, il cui ultimo metro in alto è avvolto da una grossa gabbia ovoidale, formata di fruste o verghette flessibili di legno e somi-gliante ad una grande “rocca”, da filare. La gabbia è tutta orna-ta di nastri a colori vivaci e di fiori freschi di campagna fissati sulle fruste, e, dalla sommità della gabbia esce, in alto, isolato, un mazzo compatto di fiori, a forma di pomo o di testa. Dentro la gabbia dondolano, sospesi a cordicelle ed a nastri, formaggi freschi (le squisite “caciotte” alleronesi), fiaschetti di vino, nidi di uccelli, arnesi da bifolco, piccoli aratri di legno, piccoli bovi di terracotta... lesine, martelli, ecc. Dal di sotto della gabbia pendono cartigli con motti e proverbi in lode dell’agricoltura e della vita campestre, e pendono anche fotografie con ritratti del portatore del “Pugnalone” e della sua famiglia. In questi ultimi anni si videro appesi ai “Pugnaloni” anche fotografie di S. M. il Re Imperatore e del Duce29.
Nelle due fotografie pervenuteci dei pugnaloni, anch’esse risalenti agli anni Trenta dello scorso secolo30 non troviamo traccia del “pugnalone a rocca”, ma, accanto ai pugnaloni costituiti da grandi frasche fissate su pianali di legno portati a spalla da quattro uomini (gli antenati degli attuali pugna-
28. Idem: inf. 1.29. Cit. Perali P. 1939: XXX-XXXI.30. Gentilmente segnalateci e forniteci dal signor Alessio Torrini di
Allerona e appartenenti al suo archivio di famiglia.
loni a carro), compaiono singoli rami d’albero di più conte-nute dimensioni, retti a mo’ di stendardo processionale da un solo uomo:
Poi se tajava n albero, diciamo, no tanto grosso che se poteva portà a spalla. Poi st’albero se nfioccava e ce se attaccava qual-che piccolo attrezzo, diciamo robbetta piccola31.
L’incongruenza non è rilevante, ma mostra come i pugnalo-ni di Allerona, pur continuando a mantenere la medesima denominazione, abbiano subito, non solo in tempi recenti, notevoli trasformazioni.
Schematicamente potremmo individuare due diverse ti-pologie di pugnaloni.
Una è costituita da una vera e propria macchina proces-sionale che prevede l’allestimento di un ampio pianale di legno con al centro una grande frasca e che ha subito nel corso del tempo modificazioni solo in rapporto alle tecniche di traslazione. Inizialmente, come mostrano le fotografie de-gli anni Trenta, portato a spalla, in seguito posto su ruote e trainato, dopo una breve parentesi motoristica32, a braccia.
L’altra tipologia è quella di una “frasca d’onore”, portata da una sola persona, che può essere costituita da un sem-plice ramo frondoso oppure da un palo alla cui sommità è stato applicata una struttura globulare di verghe flessibili poi adornata di foglie e fiori. Quest’ultima tipologia, per la so-miglianza che possiede con lo strumento utilizzato un tempo per la filatura domestica, viene definita “pugnalone a rocca”.
31. Cit. seGhetta a.1999-2000: inf. 6.32. Intorno alla metà degli anni ’90, si decise di far sfilare i pugnaloni,
durante la processione della domenica, appoggiandoli sui trattori bene-detti nel giorno precedente. Ma l’innovazione durò solo per pochi anni perché la rumorosa presenza delle macchine stonava con la composta at-mosfera della processione.
159Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 158
Il problema che si pone è quello del rapporto che lega le diverse soluzioni più o meno elaborate al termine pugnalone.
Pugnalone è termine desueto ma attestato33 per pungolo, attrezzo agricolo, utilizzato soprattutto nel lavoro di aratura, a forma di sottile bastone che presenta a una estremità un raschietto e all’altra un punteruolo:
In detto giorno di sabbato verso sera trovai che il detto Ago-stino passava sopra il mio trifoglio col carro tirato dai bovi e perticaro… e mi si fece addosso col bastone che aveva in mano chiamato pugnalone con cui si tocca i buoi nell’aratro.
Il raschietto, detto anche vanghetta, serve a ripulire le ruote dei carri e il vomere dell’aratro dalle incrostazioni di terra e dal fango, la parte acuminata è utilizzata dai bifolchi per pungolare i buoi34:
… questo pungolo che serviva per punzecchiare i buoi quando aravano i campi, i contadini che aravano, i buoi, se i buoi si fermavano… è n bastone di legno con da capo un punteruolo e in fondo come un raschietto perché dalla parte a punta, ci punzecchiavano i buoi per farli camminare ed arare, e invece dall’altra parte ci pulivano… l’aratro35.
Il pungolo è un attrezzo largamente utilizzato nelle cam-pagne soprattutto dai conduttori di buoi e potrebbe natural-mente essere assurto a simbolo di quella particolare catego-
33. Archivio di Stato di Perugia, Giudiziario penale secolo XVIII: 1782, 11: Perusinae seu Castri Formarum, Vulnerum cum periculo contra Augustinum filium Feliziani alias Tancione.
34. Come tutti gli strumenti che vengono da lontano, accuratamente elaborati e pensati nel corso di generazioni, anche il pungolo non presenta niente di casuale: la sua lunghezza, circa due metri, non è opzionale e non dipende neppure dalla funzione ergonomica relativa all’azione del pungo-lare: costituiva una unità di misura che consentiva al bifolco di calcolare il giusto numero di solchi da praticare sul terreno da arare.
35. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 4.
ria di lavoratori agricoli, i bifolchi appunto, che compaiono sempre come organizzatori e responsabili di molte delle fe-ste primaverili. Probabilmente i pugnaloni di Acquapenden-te, oggi grandi pannelli portanti disegni composti di petali e foglie accuratamente incollati, e quindi più associabili alle infiorate che alla festa di Sant’Isidoro, derivano il loro nome da antiche frasche processionali simili a quelle di Allerona, descritte in documenti cinquecenteschi:
… i bifolci li quali vanno innanti le croci, et dopo il confalone in ordinanza a tre o quattro per fila, con bastoni ornati di fiori et biscotti et cose rusticali meglio che ciascuno puote, et li fan-no a gara a chi le pol fare piu belli36.
Anche nella festa della Madonna del Monte di Marta (Viter-bo) che si svolge il 14 maggio, il gruppo dei bifolchi porta in corteo simili attrezzi denominati localmente “cerrate” e, da documenti dei primi anni del Settecento, risulta che sulla sommità dei pungoli venivano fissati alcuni oggetti:
Vi erano pure i bifolchi, i quali portavano le verghe con palette di ferro, istrumento da aratro, in cima dei quali, chi ci portava attaccate ciambelle e chi altre cose…37
Anche la miniaturizzazione del lavoro contadino, elemento costante dei pianali dei grandi pugnaloni di Allerona, risul-ta documentata, sempre nei primi anni del Settecento, nella processione di Marta, assieme a frasche processionali simili anch’esse a quelle presenti ad Allerona:
Venivano poi per ordine li bifolchi; questi anche portavano i loro segni, cioè cerase, aggiostate con nastri, fiori, rami d’olivo
36. Cit. straPPaFelci E. 1988: 65.37. Cit. De sanctis ricciarDone P. 1982: 111.
161Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 160
con ciambelle pendenti, …altri con un pezzo di tavola portava-no alcuni bovi di creta in atto di arare…38.
Per quanto riguarda la festa di Sant’Isodoro ad Allerona i pugnaloni-pungoli non costituiscono solo un generico simbolo di una élite di lavoratori agricoli come i bifolchi: la loro presenza si collega direttamente alla figura del san-to contadino. L’attrezzo con cui il santo compie il miracolo dell’acqua è un pungolo sia nella tradizione agiografica uf-ficiale – «leggermente toccando col pungolo de Giovenchi superficialmente la terra… e l’acqua scaturì appunto dalla terra»39 – sia nelle narrazioni di tradizione orale:
… quanno co la vanghettina era ora d’abbeverà, ah... puntava la vanghettina e scappava fora la sorgente dell’acqua... vera-mente era na frusta e poi ce mettevano na vanghettina piccola, piccola; perché... se l voltorecchie è carico de terra, n po’ lo tire, ma… allora se faceva così, co quella vanghettina40.
Il pungolo compare come attributo fondamentale nell’ico-nografia più antica del santo, mentre in quella più recente viene spesso sostituito da un generico bastone o da una van-ga. In particolar il pungolo appare in due opere ottocente-sche collocate nella chiesa di San Domenico a Foligno. Si tratta di un dipinto ad olio e di una scultura processionale a grandezza naturale entrambi raffiguranti Sant’Isidoro con abiti da contadino che tiene in mano il pungolo con cui col-pisce la terra da cui scaturisce miracolosamente l’acqua.
In questo contesto, considerate anche le evidenze di tipo comparativo, dovremmo supporre, ma si tratta solo di un’i-potesi, che la tipologia di pugnalone cosiddetto “a rocca”, possa essere quella più arcaica, in quanto mantiene un rap-
38. Idem: 11339. Cit. scattiGno a. 1984: 525n.40. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 24.
porto diretto con il pungolo che per l’occasione festiva viene addobbato nella parte superiore di fiori e foglie. Anzi si po-trebbe affermare che il pugnalone a rocca potrebbe essere il risultato dell’associazione dei due attrezzi immancabilmente presenti su ogni carro agricolo, il pungolo appunto e il “cri-no”, una sorta di cesto a maglie larghe, di forma general-mente cilindrica, composto da rami di salice intrecciati, pre-valentemente utilizzato per il trasporto dell’erba e del fieno:
… fatto così, de vinco, serviva pe fa l’erba. Adesso lo nfiorono tutto, je mettono tutte fiore ntorno e lo porteno n processio-ne… È fatto de vinco, no? E c’ha le costole, nun è tutt’attacca-to, e poi quello lo nvestono co tutte le fiore… questo è tonno, è alto così, col tonno e… co li fiori”41.
la Festa Di sant’isiDoro oGGi
Secondo le fonti ecclesiastiche Sant’Isidoro era tradizional-mente festeggiato nella domenica in Albis (la prima dopo Pasqua), poi Paolo V ne segnò la festa il 15 maggio, tuttora giorno della sua memoria, in particolare a Madrid. Pochi anni prima, Cesare Baronio nel Martirologio Romano ne aveva indicata la festa il 10 maggio, ma non si conoscono i motivi della discordanza con il calendario canonico42.
Ad Allerona la festa di Sant’Isidoro e dei Pugnaloni si celebra oggi nella terza domenica di maggio. Fino a non molto tempo fa la festa si celebrava il lunedì successivo alla seconda domenica di maggio: in seguito torneremo in modo più analitico ad esaminare i motivi che hanno prodotto lo spostamento di data.
Nei mesi precedenti iniziano i preparativi da parte de-gli organizzatori. Della festa si occupano due comitati: uno
41. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 18.42. Cfr. Il grande libro dei Santi. 1998: 1137
163Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 162
chiamato “Comitato dei Festaroli”, l’altro detto “Comitato permanente dei Pugnaloni”. Il primo è composto da cinque squadre che si alternano annualmente; si occupano della questua e, insieme al parroco del paese, stilano il program-ma che comprende sia le celebrazioni religiose sia le cosid-dette manifestazioni civili:
Loro preparano proprio la festa, diciamo, religiosa... Loro pas-sano alla raccolta così tra noi, in casa passano... e gli diamo un’offerta pe fa la festa perché altrimenti non si farebbe. Loro pensano a portare, magari non so, magari uno spettacolino la sera precedente, cioè preparano questo tipo di festa… Ogni anno un gruppo diverso. Sono … cinque squadre, si alternano anno per anno, perciò ogni cinque anni è come un circolo, pra-ticamente ripetono43.
Il secondo comitato è composto da quattro o cinque membri stabili, ciascuno dei quali rappresenta un ente o un’associa-zione informale interessati al buon svolgimento della festa: il comune, la scuola elementare e quella media, il corteo storico che sfila in questa giornata di festa, i costruttori dei Pugnaloni. Le mansioni di questo gruppo permanente sono fondamentalmente legate al coordinamento generale di tut-te le attività che ruotano attorno alla festa ed in particolare all’individuazione dei costruttori dei pugnaloni, alla prepa-razione dei costumi e al reperimento dei figuranti del corteo storico:
…praticamente riguardano principalmente il rapporto coi co-struttori dei carri, il corteo storico… e quelle attività artigianali che si fanno il pomeriggio. Cioè quelli so tutti diciamo coor-dinati dal comitato permanente dei pugnaloni e chiaramen-te fatti anche con l’aiuto dei festaroli insomma perché sennò altrimenti...44
43. Idem: inf. 4.44. Idem: inf. 1.
la viGilia Della Festa
I festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro cominciano già dal sabato pomeriggio, quando (intorno alle 17.00) avviene la benedizione delle macchine agricole nella piazza antistan-te il palazzo comunale. Qui giungono gli agricoltori che di-spongono in ordine i propri trattori l’uno accanto all’altro rivolti verso la facciata del palazzo. Il sacerdote, nel corso della messa, illustra una lettera di San Paolo in cui si afferma che Dio ha dato all’uomo il compito di dominare la natura, e, al termine, si avvicina alle macchine agricole e le benedice una a una. La benedizione ha una funzione beneaugurante in un periodo in cui stanno per iniziare i grandi cicli lavorativi dell’estate: garantire il buon funzionamento degli strumenti con cui l’uomo trae dalla terra il suo sostentamento e proteg-gere gli uomini che talvolta, per un cattivo uso di questi stru-menti, per poca accortezza, o per sventura, possono subire infortuni durante il lavoro. Terminata la messa si scioglie l’atmosfera misurata e contegnosa che ha contraddistinto il rituale religioso e si crea progressivamente il contesto tipico delle feste di paese. La piazza si popola di bambini che co-minciano a correre e di persone che si avvicinano al furgone dove si distribuiscono gli immancabili panini con porchetta; oppure ci si accalca attorno al tavolino imbandito con vino, bibite analcoliche e biscotti all’anice offerti a profusione. In-torno alle 18.00, dopo la pausa gastronomica, giovani e adul-ti, si organizzano per partecipare ai giochi popolari. Quello che più entusiasma e che viene riproposto tutti gli anni è il gioco delle pignatte: su di un filo, precedentemente assicura-to con un capo al balcone del palazzo comunale e con l’altro ad un palo della luce di fronte al palazzo, sono state appese delle brocche dette appunto pignatte, ognuna riempita con diversi ingredienti: cioccolatini, caramelle, farina, acqua, zucchero, un pacco di caffè, oppure una somma di denaro così irrisoria da avere più che altro un valore simbolico. Lo
165Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 164
scopo del gioco consiste nel riuscire a rompere una delle pi-gnatte con l’ausilio di una lunga canna. I partecipanti non gareggiano tutti insieme: uno dopo l’altro vengono bendati e fatti girare su se stessi, nel tentativo di far loro perdere l’o-rientamento. Nella ricerca dell’obiettivo i concorrenti sono aiutati dalle rumorose indicazioni degli astanti che sugge-riscono gli spostamenti necessari per giungere sotto il filo e colpire le pignatte. Anche se il giocatore, fra tutta quella confusione e fra tutte quelle grida, riesce a comprendere i suggerimenti, spesso artatamente contraddittori o svian-ti per aumentare il divertimento, la difficoltà maggiore sta nel riuscire a colpire la pignatta con la forza necessaria a provocarne la rottura. Le fatiche del concorrente saranno ri-compensate positivamente se dalla pignatta usciranno cioc-colatini, caramelle o ancor meglio soldi; mentre avranno un esito negativo se sarà bagnato dall’acqua o impolverato dalla farina. Il vincitore sarà eletto fra quelli che, rotta la pignatta, avranno avuto la sorte di trovare il premio maggiore.
Anche nel passato il gioco della pignatta costituiva una delle attrattive indispensabili della vigilia della festa:
… preparavano na corda... allora c’erano le pignatte de coccio e l’attaccavano a na corda, mettevano na corda traverso sempre su a le fontane, e poi lì dentro do ce mettevano la cenere, do ce mettevano l’acqua, do ce mettevano un capocollo, na formetta de formaggio... se annava bene, sennò pijavano cenere ed ac-qua! Ecco tutto45.
Se ci siamo soffermati tanto sul gioco delle pignatte, non è solo per scrupolo etnografico, ma perché si tratta di un gio-co che, collocato in un periodo fondamentale di passaggio del ciclo calendariale, in un momento di margine in cui i frutti del lavoro dei campi sono quasi giunti a maturazione ma ancora non sono resi disponibili, presenta dei significati
45. Idem: inf. 8.
simbolici di grande rilevanza. Come è stato autorevolmente sottolineato46 in questo periodo dell’anno sono documenta-ti, in areali molto vasti e anche molto distanti tra di loro, giochi cerimoniali che hanno lo scopo di distribuire all’in-terno della collettività sorti positive e sorti negative. Pur te-nendo conto delle dovute differenze con i giochi cerimoniali analizzati da Cirese, anche nel gioco delle pignatte ciascun partecipante per ottenere il bene (denaro, cioccolatini cara-melle) rischia di assumere il male (acqua o farina e, un tem-po, cenere) e se ottiene il bene condanna altri al male: alla fine del gioco il gruppo dei partecipanti resta diviso in due parti, quella dei fortunati e quella degli sfortunati. Alla base del gioco sussiste una concezione, simile a quella che articola l’ideologia del malocchio, secondo cui il gruppo dispone di una quantità limitata di valori positivi e negativi (il numero comunque limitato di pignatte poste sul filo) che devono es-sere distribuite solidalmente e contemporaneamente47.
Al termine dei giochi, la banda riprende a suonare e si conclude così il pomeriggio in piazza. La sera, verso le ore 21.00, la festa riprende con l’innalzamento del globo aero-statico, che avviene nella piazza della Chiesa di Santa Maria. Si termina poi con musica e balli.
il Dì Di Festa
La domenica è interamente dedicata alla festa di Sant’Isi-doro e dei pugnaloni. L’inizio ufficiale dei festeggiamenti è fissato nella tarda mattinata (intorno alle 11:00) e giungendo in paese si colgono immediatamente le trasformazioni indot-te dal tempo e dallo spazio della festa: la banda che suona, i pugnaloni già allineati nella piazza del Comune brulicante
46. Cfr. cirese a. m. 1960.47. Cfr. cirese a. m. 1963: 188-189.
167Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 166
di persone, le case addobbate con stendardi rosso-azzurri, i colori comunali ma anche i colori associati ai due santi più importanti per gli alleronesi: il rosso a Sant’Isidoro, l’azzur-ro a Sant’Ansano. Molti alleronesi sono già in fermento da diverse ore: la giornata comincia presto per i realizzatori dei pugnaloni impegnati negli ultimi preparativi. I fiori che abbelliscono i carri, ad esempio, vengono colti la mattina stessa, perché possano mantenersi freschi il più a lungo pos-sibile. Altri alleronesi mattinieri sono i figuranti del corteo storico composto da circa ottanta persone fra adulti e bam-bini. Sfilano con costumi che, secondo le intenzioni di chi li ha ideati, dovrebbero ricordare il cosiddetto “vestito della festa” che gli appartenenti alle classi coloniche dell’Ottocen-to tenevano da conto per indossarlo esclusivamente nei gior-ni festivi. Alcuni costumi riproducono anche gli abiti tipici delle classi più abbienti di quel secolo:
Noi per ricordare questo allora abbiamo cercato delle vecchie foto di nonni o dei bisnonni, di chi chiaramente era nato da generazioni ad Allerona, abbiamo trovato quello e poi da qui è nato questo corteo che comunque ha circa venti anni. Ecco questo, i costumi abbiamo iniziato venti anni fa, ecco… Sì, poi dopo le gente, anche qui le gente del paese che c’hanno detto: “Ah ma anch’io c’ho na vecchia foto della nonna, sai...”, allora gli altri anni abbiamo aggiunto un altro costume o altri due a secondo del materiale che abbiamo trovato48.
Il corteo, la banda e tutti i convenuti si ritrovano nella piaz-zetta contigua alla chiesa di San Michele Arcangelo dove si celebra la messa su di un altare allestito per l’occasione; i pugnaloni rimangono nella piazza del Comune e solo più tardi verranno guidati in processione fra le vie del paese. La funzione religiosa avviene all’aperto perché la piccola chie-sa di San Michele non sarebbe in grado di contenere tutti i
48. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 4.
presenti. Oltre all’abituale addobbo con i paramenti sacri ed i fiori, dietro l’altare c’è anche un’immagine di Sant’Isidoro. Il corteo storico si dispone alla sinistra del sacerdote e la stessa cosa fanno i ragazzi della “Schola Cantorum” anche loro in costume: due ragazze della “Schola”, al momento dell’offertorio consegnano al sacerdote il pane, il vino ed al-tri prodotti della campagna. Questa particolare offerta, così come l’addobbo dell’altare, rendono la messa un rituale di ringraziamento e di omaggio a Sant’Isidoro, che continua con la processione lungo le vie del paese.
Intorno alle ore 12.15 circa, terminata la prima parte della messa, il parroco comunica l’ordine con cui il corteo storico e tutti gli altri partecipanti dovranno abbandonare la piazza per iniziare la processione49. Il rispetto della corretta sequenza è garantito da alcuni uomini che, con bandierine rosse e verdi, regolano l’immissione dei diversi gruppi nella processione e suggeriscono loro anche i momenti di pausa durante il percorso.
Preceduti da tre uomini vestiti di tunica bianca e mantel-lina rossa – quello al centro porta una nuda croce di legno e i due ai lati lanterne processionali - iniziano a muoversi i tamburini, vestiti comunque come figuranti del corteo stori-co: sono tre o quattro giovani, che indossano un pantalone nero piuttosto corto, cosiddetto “a zompa fosso”, una ca-micia bianca, un gilet nero e un paio di scarponcini. Gli altri figuranti si dispongono in base all’età, dai più piccoli ai più grandi: subito dopo i tamburini vengono dei bambini vestiti pressappoco come i primi e delle bambine che indossano abiti colorati arricchiti da fazzoletti, legati a mo’ di fiocco in-torno al collo oppure dai grandi colletti ricamati e recano in mano mazzolini o piccoli cesti di fiori di campagna. Dietro di loro sfilano ragazzi e ragazze vestiti in modo molto simile agli altri figuranti di età inferiore. Alcune ragazze si distin-
49. La descrizione si riferisce all’edizione della festa del 1999.
169Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 168
guono dalle altre perché indossano in testa un fazzoletto e due di loro sfilano l’una accanto all’altra, recando in testa rispettivamente un cesto di fiori e una brocca.
Il corteo storico prosegue con figuranti che impersona-no uomini e donne appartenenti a diverse classi sociali. Per primi quelli di estrazione contadina, riconoscibili dai vestiti più essenziali e meno eleganti che indossano: gli uomini con il solito “completo bianco e nero” e le donne con un vesti-to colorato e un grembiulino e con gonne piuttosto ampie. Quelli che seguono impersonano, invece, donne e uomini di classi sociali più elevate: le prime indossano gonne strette e lunghe, di tinta unita e scura la loro camicetta è elegante, ri-finita con bottoni e colletti, alcune indossano anche cappelli o si riparano dal sole con eleganti ombrellini. Gli uomini si distinguono dai contadini per le scarpe di vernice, il vestito di una stoffa più pregiata e completo di giacca a maniche lunghe e per la presenza di cappelli e bastoni. Il corteo stori-co termina con due uomini che portano rispettivamente un pungolo nudo e un altro infiocchettato.
La processione continua con i “civili” cioè coloro che non indossano costumi del passato ma solo un abito attuale ritenuto consono all’occasione festiva: alcuni, disposti in fila indiana, portano dei pugnaloni “a rocca”. Seguono i costrut-tori dei pugnaloni che trainano i propri “carretti” aiutati da amici e parenti e la banda musicale che suona in determinati tratti del percorso.
A questo punto inizia la parte della processione di conte-nuto più prettamente religioso.
Alcune donne, appartenenti alla “Pia unione delle sorelle di Maria Santissima Addolorata”, sfilano con il loro stendar-do, accompagnate da alcune suore e dalla quasi totalità delle donne cha partecipano alla processione. Seguono tre uomini della “Compagnia di Sant’Ansano” vestiti di tunica bianca e mantellina azzurra che alzano lo stendardo raffigurante il santo, simbolo della loro associazione, accompagnati dal
parroco che porta la reliquia di Sant’Isidoro e che, in alcuni momenti del tragitto, prosegue le celebrazioni liturgiche al-ternando preghiere a letture di testi sacri.
Quattro giovani, vestiti di tunica bianca e mantellina ros-sa portano a spalla un pianale che supporta una composi-zione plastica, probabilmente ottocentesca, raffigurante il miracolo di Sant’Isidoro che, nel tempo, almeno secondo la tradizione locale, avrebbe fatto da prototipo esemplare per tutti i pianali dei pugnaloni a carro: il proprietario terriero sceso da cavallo, nascosto dietro un albero frondoso50, osser-va Sant’Isidoro che prega mentre un angelo conduce l’aratro trainato da una coppia di bianchi buoi:
Mo la storia dei pugnaloni nostra è nata, così dicono, uno, un uomo, se vede che annava a la festa, vedeva ste bovette, vedeva sto cavallo, vedeva st’ometto sotto la quercia che pregava, ha nventato, dice: “Chissà se anche io fo un ripiano e lì ce metto li bovette... lui era n contadino, allora ha portato in processione ste bovette, su un ripiano co l’albero. Poi, doppo, j’è venuto in mente a altre persone, dice: “Ma chissà se lo famo n po’ più grande”. Allora hanno cominciato a fa la casetta, poi l cavalli-no, poi l’aratro... nsomma l carro da piccolo è diventato gran-de. Poi, doppo, c’è stato anche l premio; davano de le premi a chi le faceva meglio. Allora, comincia n po’ de ripicca; allora hanno cominciato a fa n carro, du carre poi tre carre... anche na famiglia mia, no zio, anche loro facevano sto pugnalone e lo portavono ne le spalle; n quattro portavano sta barella, sopra che stavano le bovette l carro, la trebbia, tutte ste cose agricole le mettevano lì sopra. Poi, passava na commissione e dava dei premi, poi ce nascevono anche de le discussioni, perché quello era fatto mejo, quello che j’evono dato di più, quello de meno, ce so state n po’ de discusione e so ite avante anne, anne e anne…51
50. L’albero non fa parte della composizione plastica in legno e stucco colorato, ma ogni anno viene rinnovato con un rametto frondoso.
51. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 11.
171Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 170
La tenuta (tunica bianca con mantellina rossa) distingue co-loro che potremmo chiamare i “volontari di Sant’Isidoro” poiché non esiste una associazione stabile titolata al santo. Seguono, vestiti allo stesso modo, quatto uomini che tra-sportano il dipinto raffigurante Sant’Isidoro in preghiera dinnanzi al crocefisso e poi il sindaco circondato dalle auto-rità civili e militari e accompagnato dalle insegne comunali (uno stendardo di color rosso e azzurro).
Chiude la processione il corteo dei fedeli di sesso ma-schile che potremmo dire “non strutturati”, all’interno del disegno organizzativo predisposto.
La processione segue un percorso predefinito: lascia-ta la piazzetta di San Michele Arcangelo si sposta verso la piazza del Comune, ove sosta il tempo necessario per con-sentire l’inserimento nel corteo dei pugnaloni a carro. Ri-preso il percorso entra, passando sotto la cosiddetta “porta del Sole”, un arco in pietra sormontato da un orologio, nel borgo storico dove si snoda nelle strette viuzze per riuscire dalla cosiddetta “porta della Luna” che si apre, in direzione opposta, fra le mura di cinta. Abbandonato il borgo la pro-cessione continua lungo un viale che la riporta di nuovo alla piazza del comune. La supera proseguendo in discesa verso il quartiere nuovo detto “Case Nuove” per poi tornare in-dietro, risalendo ancora una volta fino alla piazza del Comu-ne. I tamburini, giunti per primi, procedono pochi metri più avanti fino a fermarsi sotto l’arco sormontato dall’orologio e gli altri figuranti del corteo storico, man mano che arrivano, si dispongono alle loro spalle. Giunti i pugnaloni, vengono allineati di nuovo nella piazza del Comune, così come si tro-vavano ad inizio mattinata. Il sacerdote sale sugli scalini del Municipio, recita l’Ave Maria, annuncia la squadra che avrà l’incarico di allestire la festa di Sant’Isidoro per l’anno suc-cessivo, elencandone ad uno ad uno i componenti, ringrazia la squadra che per l’anno in corso si è occupata della festa
e, infine, impartisce a tutti i convenuti la benedizione con la teca che contiene una reliquia del Santo. La banda riprende a suonare per circa un quarto d’ora e i pugnaloni a carro, sono spostati dalla piazza e dislocati nei vicoli e negli slarghi più caratteristici dell’abitato per essere ammirati dai turisti e valutati dalla commissione preposta ad eleggere il migliore, ovvero quello che più si attiene al tema stabilito per quell’an-no. Nell’opinione corrente sembra che l’idea di premiare il pugnalone migliore con una somma di denaro sia nata in tempi recenti come incentivo per non far morire la festa ma, come vedremo in seguito era già presente negli anni Trenta:
Sì, mh la gara, io direi è, diciamo un incentivo. Io guardo alla gara non perché veramente il comitato che premia i carri voglia selezionare un carro dall’altro dicendo che c’è una diversità artistica, oppure le forme dell’artigianato si sono espresse, di-ciamo, in un modo più preciso che in un altro. Intanto l’aspet-to fondamentale è che le figure, le scene vengono riprodotte con quell’approssimazione, diciamo così che è tipica dell’arte popolare. Quindi quello che si cerca attraverso questo premio è di premiare l’impegno. È un premio simbolico per incorag-giare la gente a farli ancora ed è relativo alla scena che la giuria dà come tema52.
Per tutto il pomeriggio, nei vicoli e nelle piazzette del borgo, alcuni fra gli alleronesi più anziani, vestiti con abiti simili a quelli utilizzati per il corteo storico, allestiscono una sorta di mostra degli antichi mestieri. C’è il fabbro, il calzolaio, il falegname, il battilana, la filatrice, il cestaio, chi realizza sco-pe di saggina, chi mostra come un tempo si faceva il bucato con il ranno:
…abbiamo aggiunto l pomeriggio eh... mh i vecchi mestieri e quello che facevano una volta in campagna. Ed allora trova la persona che fa i cesti di... di vinco, oppure l’uomo che... batte
52. Idem: inf. 1
173Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 172
le falci, quello che fa le scope, quelle di saggina di una volta ecco, tutte… quella che lavava li panni… si filava e si batteva la lana cioè quelle cose che ci facevano una volta così…53
Per i turisti ed i visitatori il pomeriggio può scorrere piace-volmente fra gli assaggi dei prodotti tipici locali: crostini, biscotti fatti in casa, fave, formaggi, panzanella… in attesa della cerimonia di premiazione dei pugnaloni che avviene nel tardo pomeriggio.
il Passato Della Festa
Non si posseggono documenti sulla festa di Sant’Isidoro se non alcune fotografie risalenti agli anni Trenta dello scorso secolo e quella breve descrizione, probabilmente coeva, che ne fa Giuseppe Petricelli, di cui abbiamo già riferito la parte che riguarda i cosiddetti pugnaloni a rocca:
Debbo alla cortesia dell’amico G. Petricelli di Allerona alcune notizie sui “Pugnaloni”, che il secondo lunedì di Maggio ven-gono portati in processione nel suo paese, in onore di Sant’I-sidoro agricoltore, nel giorno successivo alla festa di Sant’An-sano, patrono del luogo. Promossi annualmente da una com-missione di contadini e finanziati con offerte private, che i “bifolchi” chiedono e riscuotono durante il raccolto del grano nell’anno precedente, i “Pugnaloni”… dopo la processione si radunano nella piazza pubblica e i portatori offrono ai “festa-roli” le primizie della campagna, contenute nei “Pugnaloni”, cioè formaggi freschi, vino depurato, ecc. II miglior “Pugnalo-ne” riceve un premio in denaro54.
Dalla breve descrizione emergono alcuni elementi interes-santi: la festa non si svolgeva la terza domenica di maggio,
53. Idem: inf. 4.54. Cit. Perali P. 1939: XXX-XXXI.
bensì il lunedì seguente la seconda domenica di maggio, cioè il giorno successivo allo svolgimento della festa del patrono di Allerona Sant’Ansano. La festa era totalmente organizzata dagli appartenenti al mondo mezzadrile che mediante un co-mitato, probabilmente denominato secondo modelli arcaici come in altre località vicine, di “bifolchi”, provvedeva al re-perimento delle risorse necessarie mediante le tradizionali questue stagionali. Tale situazione, oltre che da numerosi intervistati è confermata anche dal parroco di Allerona:
La festa di Sant’Isidoro era fatta dai contadini, solo dai conta-dini. I festaroli erano i contadini e la gestivono loro e la festa si faceva l giorno dopo il Santo [Ansano], di maggio, la domenica di maggio e perciò si faceva di lunedì…55
Le primizie contenute nei pugnaloni non sono offerte a tutti gli astanti ma solo ai “festaroli”, cioè a coloro che hanno materialmente organizzato della festa: non si tratta quindi di beni che possano circolare liberamente ed essere offerti a chiunque, ma di beni soggetti ad una circolazione control-lata. L’offerta del bene alimentare serve a ricambiare una prestazione secondo il modello maussiano del dare-ricevere-ricambiare: la comunità mezzadrile nel suo complesso forni-sce, tramite la questua, le risorse necessarie, il fondo cerimo-niale indispensabile per lo svolgimento della festa, in cambio “riceve”, come prestazione differita, la festa, non tanto e non solo come divertimento e diversivo, ma come momento ri-tuale di affidamento alla potenza del sacro a tutela e pro-tezione dei rischi che possono incombere sul raccolto ora-mai prossimo. Poiché le risorse alimentari raccolte per lo “spreco” festivo, in una comunità dominata dalla scarsità di beni, non potrebbero essere mai sufficienti per tutti ne sono “delegati” al consumo, preferibilmente collettivo, coloro
55. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 29.
175Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 174
che hanno dedicato un surplus di lavoro all’organizzazione materiale della festa56.
L’offerta di un premio in denaro per il miglior pugnalone non è solo un’introduzione recente ma risulta presente anche in anni precedenti al 1939; sarebbe interessante appurare se sia stato il frutto di una iniziativa “dal basso”, cioè dei “fe-staroli”, oppure stimolata dalle autorità locali in un periodo in cui il regime fascista stimolava e diffondeva un’ambigua valorizzazione dell’arte popolare:
Quanno era brutto tempo; dico:... “O bah, ma che fate sempre co ste lavore” dice: “Eh, qualche cosa farò” lue sì. Invece face-va come un barile, faceva, e c’ha fatto l’areoplano, c’ha fatto. Quanno che è stato pe eh, ha nfioccato n’albero e ha portato st’areoplano in cima, se girava e girava, così e ha preso il primo premio. Questo era del 1930. Sì ha vinto il primo premio. L’an-no doppo l’ha rifatto, ha rifatto st’albero tutto nfioccato co tut-te le fiore, tutto quello che ce vole, allora era tempo del fascio; c’ha messo tutto... le quatre de Musolini. Anche quell’anno ha preso il primo premio e po’ dice: “Basta io non voglio sapé più gnente” perché doppo je dispiaceva a quell’altre che c’evono lavorato di più e nun prendevono gnente57.
Il tentativo di analizzare, in modo più dettagliato, quali fos-sero gli aspetti della festa nel passato può quindi fondarsi esclusivamente sul serbatoio della memoria di coloro che, nel corso della loro vita, hanno partecipato, assistito o co-munque sentito parlare delle attività e delle dinamiche so-ciali connesse all’evento festivo.
I pugnaloni, sia quelli a rocca sia quelli su pianale, erano costruiti nelle case coloniche nei momenti di sosta dal lavoro che la stagione invernale consentiva più facilmente:
56. Cit. clemente P. 1983: 151-154.57. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 4.
...Quelli più riusciti bene, magari li lasciavano. Poi pe l’anno successivo, sempre, ogni anno, facevano qualcosa in più. Ma-gari facevano na carriola in più, oppure facevano un recinto per le pecore su questo piano, no? Su questo intavolato... e tuttora... ma questo avveniva tutto durante l’inverno, quando magari in campagna, in modo particolare, non si faceva niente ed allora se dedicava nella stalla: stavano caldi, facevano il su lavoro perché dovevano governà le bestie e in più se dilettava-no a fa questi affarini58.
Era soprattutto il capo famiglia che si preoccupava di allesti-re il Pugnalone per la festa di Sant’Isidoro, ma era comun-que aiutato da tutta la famiglia:
Tutte... il babbo co li fiji, il capo famija diciamo, però... era compresa... tutta la famija59.
Era un lavoro, dunque, che impegnava, poco alla volta, per diversi mesi all’anno, fino a quando a maggio i pugnaloni venivano portati in processione. Celebrata di lunedì, la fe-sta di Sant’Isidoro sembrava dilatare i tempi della festa di Sant’Ansano: «...veramente era quasi tutta na festa...»60.
A memoria d’uomo la festa è stata sempre celebrata nel paese. i coloni, il lunedì mattina, lasciavano la campagna per raggiungere Allerona. In alcuni casi erano necessarie due, tre ore di cammino, perciò bisognava abbandonare il caso-lare di buon’ora. In realtà, però, il casolare non veniva mai lasciato completamente disabitato non tanto per evitare che restasse incustodito, quanto per la necessità che rimanesse qualcuno della famiglia a badare alle persone più anziane, ma soprattutto ad occuparsi degli animali. Il lavoro non po-teva arrestarsi e quindi non tutti potevano far festa in quella giornata:
58. Idem: inf. 7.59. Idem: inf. 9.60. Idem: inf. 6.
177Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 176
Si eravamo quattro in famija, due ce se annava e due se rimane-va perché c’era l bestiame e dà da mangià alle bestie, nsomma61.
Concorrevano anche altri motivi a impedire che tutti i com-ponenti delle numerose famiglie mezzadrili potessero inter-venire alla festa di Sant’Isidoro; le condizioni economiche, infatti, non consentivano che ogni componente della fami-glia possedesse un proprio vestito, oppure le scarpe da in-dossare per quell’occasione:
In processione, in processione ci andavano, ma non era come adesso che vanno tutte le donne, li fiji, tutte come il corteo, ha visto, allora poche ce le portavano... Chi je mancava l vestitino, chi je mancavono le scarpe, eh eh, allora c’erono le miserie ed allora tutte n ce se potevono annà62.
Poi li vestitini non ce l’avevamo, eravamo scalze, alla mejo ce s’annava; però no tutte... dispiaceva perché se vedeva passà le famije che stavano mejo de noe, ch’annavono alla festa… e noe se piagneva perché non avevamo le panni63.
Per accontentare tutti i componenti della famiglia, desi-derosi di vivere questi momenti di festa, ci si organizzava così: qualcuno andava in paese la domenica per la festa di Sant’Ansano altri, invece, il lunedì per la festa di Sant’Isi-doro.
I componenti di queste numerose famiglie estese che il lunedì si recavano ad Allerona per la festa di Sant’Isidoro, portando con sé i pugnaloni preparati nel corso dell’inver-no, erano accolti al limitare del borgo dai “festaroli”, coloro che materialmente avevano organizzato la festa.
61. Cit. Idem: inf. 12.62. Idem: inf. 3.63. Idem: inf. 12.
Come abbiamo notato il loro compito era quello di com-piere i giri di questua per radunare le risorse necessarie con-sistenti, prevalentemente, in prodotti naturali:
Pe sta festa passavano a raccattà e je se dava l grano nvece che le solde… Allora le solde non c’erano… l grano lo vendevono e ce facevono le solde64.
Attualmente i “festaroli” sono divisi in squadre che si alter-nano ciclicamente, in passato i “festaroli vecchi”, alla fine del giorno festivo, indicavano coloro che li avrebbero sosti-tuiti nell’anno seguente:
Prima anno pe anno se faceva che i festaroli vecchi, che fanno la festa quest’anno, alla fine, il giorno stesso, ricavavono le fe-starole pe l’anno prossimo65.
Le risorse provenienti dalla questua erano impegnate per ga-rantire una buona riuscita a tutti gli aspetti della festa, quelli religiosi, quelli connessi al divertimento e quelli alimentari:
...poi facevano l conto, allora: la processione, l vino, n po’ de divertimente... allora facevano la corsa delle pignatte, la corsa delle somare, facevano le gioche...66.
Il cibo della festa cioè l’alimento caratteristico preparato per l’occasione era costituito, come è riscontrabile per molte al-tre occasioni festive della regione umbra67, da biscotti all’a-nice:
… li facevano co poca roba, co n po’ d’anice... Anche se era poco bono, ha visto, era desiderato perché come se dice, c’era poco e
64. Idem: inf. 11.65. Idem: inf. 6.66. Idem: inf. 11.67. Cfr. Baronti G. 1999a: 61
179Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 178
niente. Chi non ha conosciuto la vita de cinquant’anni fa, nun ce crede; però, voglio dì, oggi tutti c’avemo un po’ del tutto68.
Il biscotto, oltre a “marcare” simbolicamente il giorno di fe-sta, serviva, al mattino, per rifocillare coloro che giungevano dalle campagne per partecipare alla festa, e, alla sera, come una sorta di viatico per il ritorno:
...poi i biscotti, perché la gente veniva da fuori e facevano un cammino anche abbastanza lungo ed allora i contadini, ecco, magari prima de dové ritornà, partivano alle dieci pe esse qua a mezzogiorno e ripartendo all’una erano a casa alle tre, alle quattro. Sa, partire digiuni non era tanto simpatico, perché poi, allora, a piedi eh69!
La messa in onore di Sant’Isidoro era celebrata nella chiesa, titolata a San Michele Arcangelo e situata fuori del borgo, dove c’è un altare dedicato al santo contadino; oggi, invece, come abbiamo già detto, è celebrata nella piazzetta adiacen-te, perché le persone che assistono sono più numerose di un tempo e la chiesa non riuscirebbe a contenerle tutte. Dopo la messa si formava il corteo processionale che, entrando nel borgo, si recava direttamente alla chiesa di Santa Maria, dove tutti quanti entravano portando anche i pugnaloni a rocca:
Eh... tutte le Pugnalone, la gente se fermava fora e l pugnalone, l quadro che portavono l Santo, entrava n chiesa; facevono na preghierina de qualche secondo, poi usciva e ripartiva70.
Il nuovo parroco, giunto ad Allerona all’inizio degli anni settanta (1971), assistendo per la prima volta alla cerimonia rimase molto perplesso:
68. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 14.69. Idem: inf. 7 70. Idem: inf. 23
… s’entrava dentro la chiesa co tutte le frasche... eh... diven-tava na cosa da ride proprio… io vedendo n affare del gene-re caddi dalle nuvole… me misi le mani sui capelli a vedé ste scene. Dico: “Ma questi che fanno”, mh... ora n po’ de cultura classica ce l’avevo, perché avevo studiato. Ma dico: “Qui siamo in un mondo pagano proprio, la fraschetta, poi co i vini addos-so, insomma no, ecco”71.
Terminata la breve cerimonia che consisteva praticamente in un omaggio alla statua di Sant’Ansano – «Allora Sant’Isido-ro doveva fare omaggio, secondo l’antica loro tradizione, al patrono Sant’Ansano...»72 –, la processione ritornava per via delle Fonti Coperte al punto di partenza dove si scioglieva e la maggior parte dei convenuti riprendeva la via di casa:
Dopo se sfacevano le pugnalone, ognuno a casa sua, ognuno pe le campe, allora se campava co le campe, tanto tempo nun c’era da sta... Appena la messa, dopo c’era la benedizione della messa e doppo la messa, ognuno a casa sua... Sant’Isidoro era de lunedì e la gente era attaccata alla campagna perché allora se viveva davero con la campagna; nsomma, … ce se veniva però se riannava subito via. Non è che durava la festa come adesso, fino a sera...73.
Prima di riprendere la discesa verso i poderi, comunque, nel momento di passaggio che segna il termine della festa e l’inizio del ritorno al tempo della normalità quotidiana, avveniva una sorta di rito profano di aggregazione della co-munità rurale, sicuramente circoscritta ai soli maschi adulti, consistente nel consumo collettivo, in un clima di socialità effervescente, di cibo e bevande:
71. Idem: inf. 2972. Idem: inf. 2973. Idem: inf. 9.
181Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 180
Sì e... doppo, ha visto? … era la smimbocciata tra amici, la chiacchierata... tutto questo....e la gente beveva, l’anziane se mbriacavano n po’, poi cantavono e tutto e... na volta eravamo tutte contadine... Beh, nsomma... insomma era così... comun-que, è stata sempre na bella festa... Allora era n’altra cosa... via, la sbimbocciata e... sì, la processione, poi panini, biscotti e dammiggiane de vino... era n quel modo… era na tradizione... se passava na giornata tutte le contadine... eravamo a migliaia allora... purtroppo l mondo è cambiato e la campagna... che voi fa74!
Mentre il cibo quotidiano, in un modo colonico contrad-distinto dalla sottoalimentazione e da una scarsa e precaria disponibilità di beni, va incontro essenzialmente al bisogno primario di nutrire il corpo per la sopravvivenza e per per-mettere l’espletamento delle attività lavorative, l’alimenta-zione festiva serve a “nutrire la cultura”. Mentre i frugali pa-sti quotidiani vengono rapidamente consumati o all’interno del nucleo familiare o sui campi, il cibo della festa costitu-isce un’occasione d’incontro molto più allargata, è il fulcro di un’atmosfera di effervescenza che permette di instaurare rapporti sociali, che consente di esperire le sensazioni con-nesse all’identità sociale e all’appartenenza culturale, attra-verso il dispendio, il consumo non parsimonioso e control-lato delle risorse75. Il cibo della festa non ha lo scopo, come il cibo quotidiano, di rafforzare il corpo ma ha la funzione di rafforzare la complessa trama dei rapporti culturali e sociali, attraverso il meccanismo della reciprocità dei doni e degli scambi nella cerchia parentale, amicale e comunitaria. La fe-sta, per il tempo che le è concesso, nasconde e riesce a “far dimenticare” l’orizzonte quotidiano dominato dalla durezza e dalla precarietà delle condizioni materiali e psicologiche di esistenza.
74. Idem: inf. 16.75. Cfr. sePPilli t. 1984-1985: 11.
Proprio dalla descrizione, precedentemente riportata, dei momenti di socialità caratteristici delle fasi finali della festa di Sant’Isidoro, sembra trapelare una sorta di rimpian-to per alcuni aspetti di un mondo oramai definitivamente perduto. Si tratta di una sorta di consapevolezza, che affiora spesso nelle parole di coloro che hanno vissuto una parte della loro esistenza all’interno del mondo contadino, del prezzo pagato nel miglioramento delle condizioni materiali di esistenza in termini di socialità, di identità culturale e di espropriazione dal controllo della produzione.
Il momento nodale di trasformazione della festa di Sant’I-sidoro, l’epoca (1971-72) in cui all’interno della comunità i tempi ed i modi della tradizione iniziano ad essere messi in discussione, coincide con l’arrivo del nuovo parroco; i suoi interventi, dopo i primi momenti di titubanza, andranno tut-ti nella direzione di mantenere in vita una festa che sembra-va avviarsi verso un rapido ed inesorabile declino:
… questa festa che per me, diventava sì un pochettino strana, ma per certi aspetti caratteristica, non l’avevo mai vista… non era da buttarsi via come il prim’anno avevo intenzione di fare. Studiandola, studiandola avevo capito, m’ero accorto che do-vevamo un pochettino alla mentalità biblica di offrire le primi-zie... dei raccolti. Ora, poiché siamo nel periodo di primavera e cominciano negli orti a esserci le prime primizie di quello che c’è nella campagna alleronese, poteva essere una mentalità non solo pagana, di offrire al Dio pagano gli elementi della natura, ma noi risalivamo un pochettino alla Bibbia di offrire a Dio con Abele e Caino le bellezze della natura. Poteva averci un significato religioso molto importante anche se antichissimo, pagano, o cristiano, o biblico, ancora di più, addirittura. Poi... mi misi a studiare la vita di Sant’Isidoro e sapevo che Sant’Isidoro era stato proclamato protettore, patrono di quelli che lavoravano i campi, essendo lui contadino, con tutta la sua storia del contadino... e vedendo che questi Pugnaloni potevano essere anche un folclore, insieme al signor Sindaco, al presidente della Proloco, in riunione segretissima a casa mia,
183Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 182
da studiare che cosa, come si poteva sviluppare questa festa, nel senso che oltre all’aspetto religioso dare l’aspetto turistico, folcloristico della situazione d’Allerona76.
Il numero di coloro che partecipavano alla festa e il numero dei pugnaloni preparati andava diminuendo ogni anno, così la festa di Sant’Isidoro andava declinando sia sotto l’aspetto religioso che sotto quello folclorico:
…perché la festa era un po’ scaduta a partecipare poche perso-ne, anche sotto l’aspetto religioso. Il paesino è piccolo, se tutti lavorano, la processione si riduceva a pochi. Ora naturalmente a fa na processione pe poche persone dava anche fastidio. Le messe, sì, per carità partecipate, ma ora se na persona non c’è, non c’è, ecco… e i pugnaloni tre o quattro che c’erano proprio striminziti77.
L’idea lungamente meditata e attuata al momento opportu-no è quella di trasferire la festa alla domenica successiva, spostandola da un giorno feriale immediatamente a ridosso della festa del patrono ad un giorno comunque festivo. L’o-perazione incontra difficoltà in modo particolare da parte di alcuni “festaroli” più attaccati alla tradizione ma un altro gruppo di festaroli più “ragionevoli” accoglie in seguito la proposta innovativa:
Perché era na tradizione antichissima… cambià le tradizioni in un paese tradizionalista, non è na cosa semplice… e un anno che ebbi tre o quattro contadini che mi sembravano più in-telligenti di altri passati... eh all’inizio della preparazione della festa, un anno prima perché è un lavoro lungo, feci… la propo-sta: “Ma se noi la festa invece di lunedì la celebriamo di dome-nica voi che ne pensate?78”.
76. Cit. seGhetta a.1999-2000: inf. 29.77. Ibidem.78. Ibidem.
Oggi, a distanza di tempo lo spostamento, avvenuto nel 1978, sembra unanimemente considerato in modo positivo, anzi decisivo per dare nuovo vigore ad una manifestazione che si andava lentamente esaurendo:
So io che l’ho portata de domenica la festa de Sant’Isidorio… Sì, sì, dico: “Regà portamola la domenica… la festeggiamo mejo”. E dopo, la domenica, avemo cominciato a fa tutto pe bene, co le pugnalone come se deve erano tutte al lavoro… Era na festa così… L’operaie andavano tutte al lavoro… pareva che Sant’Isidorio n era stimato, nvece era n Santo come Sant’An-sano. Prima, sinnò, mica c’erano le pugnalone tanto grande… Adesso è più bello pe tante cose…79.
Proprio in considerazione della rivitalizzazione della festa di Sant’Isidoro, che, posta di domenica, richiamava sempre più persone e non solo dal comune di Allerona, le autorità lo-cali (sindaco, parroco e pro-loco) decisero di inserire come elemento di novità, ma nello stesso tempo come motivo di raccordo con la tradizione e stimolo per una rivisitazione del passato, il corteo storico, introdotto nei primi anni ottan-ta (1981-1982) e ritenuto, quasi unanimemente, in grado di arricchire ulteriormente la festa, rendendola stabilmente un evento in grado di richiamare un consistente flusso turistico:
Si è arricchita anche dal 1982 del corteo, così detto corteo sto-rico… si è arricchita anche per quel che riguarda... la organiz-zazione del pomeriggio della festa. Una volta la festa di Sant’I-sidoro con il pranzo finiva... con il pranzo finiva perché la gente doveva ritornare alle proprie occupazioni. I contadini dovevano tornà alle stalle, ai campi… l’innovazione che invece c’è stata nella festa è quella che è animato anche il pomeriggio. I carri il pomeriggio vengono esposti in vari angoli del paese, ai carri esposti si affianca anche la riedizione di antichi mestieri, si... di-mostra anche una spiccata accoglienza nei confronti dei visitato-
79. Idem: inf. 20.
185Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 184
ri offrendo loro i prodotti tipici del posto che sono quelli della stagione, insomma, no? Dai prodotti orticoli, ai biscotti, al vino ecc... quindi sicuramente la festa si è arricchita… 80.
un’altra Festa?
Le trasformazioni subite dalla festa di Sant’Isidoro sembra-no alla maggior parte degli alleronesi correttamente motiva-te e ritenute necessarie proprio allo scopo di mantenerla in vita. Quasi tutti notano come lo spostamento alla domenica sia stato imposto dalle trasformazioni economiche e sociali che hanno modificato gli stili di vita tradizionali:
….de lunedì, che la gente va a lavoro, nun è come prima che so tutte contadine. Diciamo se un giorno nu lavoravono, nu lavo-ravono. Invece adesso, col cambiamento che è stato il lunedì, è na giornata de lavoro e allora avemo dovuta spostalla, diciamo, alla domenica doppo81.
Non tutti però la pensano allo stesso modo, non tutti vedono di buon occhio le trasformazioni subite dalla festa. Le parole di un’anziana donna, nata in una grande famiglia colonica, consentono di interpretare le inevitabili e indispensabili tra-sformazioni secondo un’altra ottica:
Mo te lo dico io, e se l’hai d’annà a ridì nun me interessa! Al-lora era la festa del contadino; e le paesane stesse d’Allerona nun c’annavono n processione. Certe non partecipavono; … e adesso vengono a cercà lue che je deve fa l carro, je deve fa l bifolco [si riferisce al fatto che gli organizzatori della festa si rivolgono al marito per la costruzione dei pugnaloni]… Ecco come è nato, nvece prima se scostavono… e ora hanno bisogno
80. Idem: inf. 1.81. Idem: inf. 6.
de lue, prima stavano tutte là sotto, sotto fosso a guardacce perché eravamo contadine, a noe non ce si avvicinavono82.
Alcuni di coloro che nel piccolo ambiente di Allerona pro-vengono “dall’altra metà della terra”, da quel mondo colo-nico fisicamente, economicamente e culturalmente separato dal borgo, sentono di essere stati espropriati di una festa che era sempre stata la loro e solo la loro perché, un tempo, gli abitanti del borgo, ostentatamente, non partecipavano alla festa di Sant’Isidoro:
Seh!! No, sei matta?! Adesso vengono, venivono a vedé, così, però se scansavono; “La festa de le contadine” dicevono... nvece… la festa de Sant’Ansano. Quella, allora... eh tutte, ce s’andava…83.
L’opposizione culturale derivante dalla rigida separazione e dalla netta sperequazione sociale esistente nel passato, sem-bra aver trovato, almeno in una parte, quella del borgo, una concreta espressione in processi di identificazione in figure del sacro che permettessero di marcare in modo ancora più netto e risoluto le differenze.
Per tale motivo, per analizzare più compiutamente il sen-so della festa di Sant’Isidoro appare indispensabile fare al-cune considerazioni sulla festa di Sant’Ansano, che, prima delle innovazioni apportate negli ultimi anni, si svolgeva il giorno precedente la festa di Sant’Isidoro.
la Festa Di sant’ansano
Il culto di Sant’Ansano è diffuso in un areale relativamente vasto che comprende grosso modo la Toscana meridionale,
82. Idem: inf. 12.83. Ibidem.
187Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 186
l’Umbria ed il Lazio settentrionale. Il patrono di Allerona, ma anche di Siena, secondo la tradizione agiografica fu un martire romano che dopo varie vicissitudini morì decapitato nelle campagne al confine tra la diocesi di Siena e quella di Arezzo il primo dicembre dell’anno 30384.
Si tramanda che Ansano, nel corso della sua fuga da Roma a Siena, passando per la via Cassia, si sia fermato an-che ad Allerona. Testimonianza di questa sua tappa, secon-do la tradizione dovrebbe essere il toponimo Santo Sano, località che dista solo pochi chilometri dal borgo. Ad Alle-rona si racconta di un miracolo, compiuto dal santo proprio in questa zona: una giovane donna si stava recando alla fonte per riempire d’acqua la sua brocca che le cadde, rompendosi in molti pezzi. Ansano miracolosamente ricompose la broc-ca e la restituì alla donna:
84. Nato in una famiglia pagana, egli, fin da fanciullo, si accostò ad ambienti cristiani che lo iniziarono alla conoscenza del vangelo. Secon-do la tradizione Ansano fu battezzato all’età di dodici anni, senza che suo padre lo sapesse, dal sacerdote romano Protasio che sarebbe stato avvertito in sogno da un angelo del desiderio del giovane di convertirsi. Il padre, scoperta la conversione, non riuscì a persuadere il figlio a ritor-nare al vecchio credo così lo denunciò all’imperatore. Ansano non ebbe paura di proclamare anche di fronte ai giudici la propria fede e così fu condannato al carcere. Evaso, fuggì per la via Cassia arrivando fino a Siena, predicando e compiendo miracoli. Qui il Cristianesimo si stavano diffondendo anche grazie ad altri fedeli che avevano abbandonato Roma temendo le persecuzioni dell’imperatore Valeriano. Ansano venne arre-stato e incarcerato dal proconsole romano Lisia, governatore della città toscana, che decise di giustiziarlo gettandolo in una caldaia di olio bol-lente da cui uscì miracolosamente illeso. Per il timore di una sommossa popolare, Ansano venne rilasciato ma fu di nuovo catturato dai soldati che lo trascinarono oltre il fiume Arbia e lo decapitarono. Viene solita-mente raffigurato mentre battezza i catecumeni o mentre è condotto in prigione, oppure in un calderone d’olio sotto il quale è acceso il fuoco. In alcune opere lo si trova invece abbigliato come un guerriero, con il vessillo e la palma del martirio, al quale può essere appeso un grappolo di datteri, oppure con in mano una trachea alla quale sono sospesi due polmoni, un cuore e un fegato (cfr. urBani c. 1992).
Je s’è scocciata la brocca a na signora, com’era? Pe da da beve... e poi je s’è risaldata85.
Ad Allerona il santo è festeggiato due volte l’anno: il primo dicembre e la seconda domenica di maggio. La prima data è quella in cui ufficialmente il calendario liturgico pone la commemorazione del santo e tale occasione prevede una liturgia esclusivamente religiosa all’interno della chiesa par-rocchiale.
La seconda ricorrenza, quella di maggio, è più articolata ed unisce a momenti religiosi anche elementi di festività ci-vile. L’organizzazione è affidata, com’è consuetudine, ad un comitato, la “Compagnia di Sant’Ansano”, divisa in undici squadre che si alternano annualmente nelle attività di allesti-mento: fondata verso la metà dell’Ottocento oggi annovera circa centocinquanta iscritti.
La festa di maggio inizia dal venerdì sera, intorno alle ore 21.00, con una processione che parte da Santo Sano, laddove è conservata un’immagine votiva del Santo, fino ad arrivare ad Allerona. Altri momenti di aggregazione e ricrea-zione sono la presenza della banda locale, l’innalzamento del globo aerostatico, il gioco della tombola ed uno spettacolo pirotecnico, vanto della comunità alleronese, che sembra co-stituire un forte elemento di scarto tra la festa di Sant’Ansa-no e la festa di Sant’Isidoro:
Ma... beh, m’allora Sant’Ansano era più importante. Doppo je facevono le foche, invece a Sant’Isidorio nun je facevono ste cose come c’erano pe Sant’Ansano. Era più poretto insomma Sant’Isidorio...86.
La domenica è il giorno in cui si svolge la processione, im-ponente sia per l’affluenza di fedeli, sia per il percorso che si
85. Cit. seGhetta A.1999-2000: inf. 3.86. Ibidem.
189Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 188
snoda per tutta Allerona. A metà mattinata (dopo la messa delle undici) dalla piazza della chiesa di Santa Maria, parte il corteo al cui centro svetta un grande baldacchino detto popolarmente “la macchina”, poggiato su aste e portato da sedici ragazzi della compagnia di Sant’Ansano, sotto il qua-le, come in una nicchia, è posta la statua del santo.
Esaminando la diversa qualità delle macchine proces-sionali utilizzate nelle due feste si impongono alcune con-siderazioni. La macchina del santo urbano è una macchina completamente artefatta in cui l’aspetto culturale domina sulle componenti naturali, mentre le macchine di Sant’Isi-doro, i pugnaloni, vedono la prevalenza di elementi naturali scarsamente elaborati. Anche questo aspetto esprime una differenza, una opposizione tra culturale e naturale che ha costituito, per lungo tempo in epoca medievale e moderna, un luogo comune del conflitto tra città e campagna: la so-cialità e la cultura formavano l’elemento distintivo della vita urbana rispetto ad un mondo rurale che sembrava immerso in ritmi naturali senza tempo. Se consideriamo la struttura di altre macchine processionali ben più conosciute come i ceri di Gubbio, di costruzione estremamente raffinata ed elabo-rata, potremmo pensare che tale caratteristica acquista un senso palese solo se collegata agli alti alberi appena sbozzati che nelle aree montane circonvicine tutt’ora continuano ad essere innalzati nel passaggio tra il mese di aprile e quello di maggio.
Non è il luogo questo per analizzare in dettaglio la festa di Sant’Ansano, ciò che preme rilevare è che non esiste un motivo preciso per cui essa debba necessariamente cadere nella seconda domenica di maggio. La spiegazione climati-co-logistica, impossibilità di manifestazioni all’aperto a di-cembre, da tutti addotta, è perfettamente congrua e pratica-ta in molte aree della nostra regione in rapporto a ricorrenze invernali - Sant’Antonio abate, 17 gennaio, San Domenico abate, 22 gennaio - che vengono solennizzate nei mesi pri-
maverili ed estivi, ma non giustifica la precisa collocazione proprio nel giorno che precede la festa di Sant’Isidoro:
Perché l primo dicembre è sempre freddo, la stagione è catti-va... nun se poteva fa la processione; allora l’hanno spostata, la festa solenne se fa a maggio ma... l primo dicembre è sempre festa, de che giorno azzecca, azzecca... Per quella de maggio c’è la processione, pe quella de dicembre, no. Dicembre se fa la fe-sta de chiesa, la festa solenne; ma però na festa solo de chiesa87.
Perché è più caldo... l vero S. Ansanino sarebbe de dicembre, però d’inverno, ha visto, piove... nun possono fa na bella pro-cessione88.
Il calendario liturgico pone, tra l’altro, la ricorrenza di Sant’Isidoro il 15 maggio e, anche in questo caso, non esiste nessuna ragione di ordine religioso che ne abbia potuto mo-tivare la collocazione in una data mobile, così strettamente “dipendente” dalla festa del patrono.
La motivazione che emerge non ha niente a che vedere con il calendario liturgico ma molto invece a che fare con la situazione di netta divisione sociale esistente fino a un re-cente passato e con i conseguenti processi di egemonia cul-turale. Sant’Ansano è il santo patrono di tutti gli alleronesi, mentre Sant’Isidoro è il santo contadino e il patrono dimi-diato dei soli contadini e quindi necessariamente subordina-to, così come sono e debbono restare subordinati i contadini agli abitanti del borgo:
Sì, c’è stato n periodo de tempo perché siccome, ...tempi de prima, le campagne erano dei contadini, erano tutte intorno al podere diciamo, ed ora invece purtroppe le contadine sono dovute venì al paese, allora magari il vero paesano era più pe Sant’Ansano che pe Sant’Isidoro; allora c’era n po’ de discrimi-
87. Idem: inf. 3.88. Idem: inf. 24.
191Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 190
nazione. Invece adesso è stato calmato gni cosa, la gente, voglio dì, tanto partecipa pe Sant’Ansano, tanto pe Sant’Isidoro89.
Non sappiamo quando sia avvenuta, ma certamente tale collocazione strategica, senza alcuna giustificazione di tipo liturgico, della festa di Sant’Ansano non risponde a esigenze di tipo religioso ma alla necessità di esprimere e ribadire, anche attraverso la pregnante simbologia del sacro, la realtà dei rapporti di subordinazione e di dominio:
Era la festa dei contadini, cioè già dire così, trenta quaranta anni fa, già voleva dire discriminare. Magari adesso è diverso però... questi delle campagne che venivano quasi come fosse una festa separata però agganciata al patrono, una festa cioè di “serie B”...90
Essendo na festa contadina e... allora, magari, essendo più im-portante la festa del patrono, di Sant’Ansano, questa qui era na festicciola de lunedì, del giorno dopo e cosiddetta “festa dei contadini”: è questa la verità91.
Un elemento mostra chiaramente la subordinazione di un mondo all’altro attraverso la subordinazione di un santo all’altro; sino vent’anni fa, la processione di Sant’Isidoro do-veva porgere omaggio a Sant’Ansano. Giunta nella chiesa di Santa Maria, il quadro raffigurante Sant’Isidoro era portato davanti alla “macchina” entro la quale era ed è tuttora con-servata la statua di Sant’Ansano:
Sant’Isidoro era tanto minore che doveva venire a rendere omaggio al patrono, nella loro mentalità, per rendere omaggio,
89. Idem: inf. 6.90. Idem: inf. 5.91. Idem: inf. 22.
ossequio e c’era una preghiera che si doveva recitare dentro questa Chiesa92.
In tempi più recenti, le modificazioni subite alla festa di Sant’Isidoro hanno portato anche alla cancellazione dell’o-maggio: da circa vent’anni, infatti, la processione si limita a sfiorare la piazza ove è situata la chiesa di Santa Maria, senza però entrarvi e, tanto meno, senza recitare la tradizionale preghiera a Sant’Ansano. Tale cambiamento, secondo l’opi-nione comune, si è reso necessario perché, negli anni, i pu-gnaloni sono aumentati di numero e di volume; risulterebbe impossibile, quindi, farli entrare nella parrocchiale:
Adesso nun ce possono passà più, perché le carre so ingrandite e allora nu c’entrano93.
Esaminando una fotografia degli anni Trenta si nota un gran-de pugnalone posteggiato proprio nella piazza della chiesa parrocchiale; evidentemente anche allora i grandi pugnalo-ni con pianale non potevano (fisicamente) entrare in chiesa, ma ciò non impediva che si attuasse comunque il rituale di omaggio a Sant’Ansano. La spiegazione va probabilmente trovata in altra direzione: nel corso dei recenti riassestamenti subiti dalla festa di Sant’Isidoro ciò che un tempo pareva ovvio, la subordinazione del santo dei contadini al santo pa-trono, è stato invece avvertito come stridente in rapporto alla mutata situazione sociale e, di conseguenza, eliminato.
Resta, come elemento residuale di una sorta di assogget-tamento del santo contadino al santo patrono, la presenza e la precedenza, nella processione di Sant’Isidoro, dello sten-dardo di Sant’Ansano:
92. Idem: inf. 29.93. Idem: inf. 24.
193Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 192
Mi sembra che per Sant’Isidoro c’è anche addirittura lo stendardo di Sant’Ansano, viene portato in processione anche per Sant’Isidoro... Mi sembra, non vorrei giurarci... a ma me sembra che pe la festa ce portano tutte li Santi, le Madonne e lo stendardo de Sant’Ansano94.
Le due feste si svolgevano a stretto contatto perché, in un periodo nodale del ciclo lavorativo agricolo che precede-va di poche settimane la mietitura del grano, dal punto di vista della reintegrazione delle risorse alimentari una sorta di capodanno, non era possibile che si manifestasse all’in-terno del borgo una manifestazione, sia pur religiosa, che compattava le masse coloniche, senza anteporle, a convalida ed ostentazione dei rapporti di dipendenza esistenti, una si-tuazione festiva posta sotto l’egida di un santo non di parte come Sant’Isidoro, ma di tutti, come Sant’Ansano. Un santo che unisca e non che divida che induca e realizzi una at-mosfera festiva che sotto la veste rituale della unanime so-lidarietà possa occultare il malessere storico radicato nella sperequazione economica, che mistifichi, nel segno della comune appartenenza, le fratture sociali e culturali esisten-ti95, in un momento, quello che precede il raccolto, allorché, come ogni anno al momento delle ripartizioni, i rapporti tra proprietari e coloni si faranno più tesi e conflittuali.
Che Sant’Ansano, festeggiato dagli abitanti del borgo, non potesse essere proprio il santo di tutti qualcuno l’aveva capito:
De la festa de Sant’Ansano… beh, de quella nun parlo io! Per-ché nun è che ce so stato mai io... perché ce rimane fori... fori zona… perché nu me piace... in paese nu me tira annacce. Ad Allerona ce so capitato, ecco, pe Sant’Isidoro perché me piace a vedello, perché ce so tutte le cose... tutte l’attrezzature, nsom-
94. Idem: inf. 7.95. Cfr. Di nola a. m. 1976: 254-255.
ma, agricole… nsomma dà piacere ricordalla tutta... nvece, pe Sant’Ansano nun c’è proprio n bon rapporto96.
a ciascuno il suo (santo)
Dalle testimonianze emergono, anche se con profonda rilut-tanza, quelle che costituivano, fino ad un recente passato le distinte modalità di fruizione sociale delle due feste:
Ma … Sant’Ansano credo che era... nel cuore, nell’anima di tutti gli alleronesi. Mentre quella di Sant’Isidoro era na festa sì sentita ma programmata, ideata dalla gente della campagna. E siccome prima cinquanta anni fa, sessant’anni fa tra la gente della campagna e la gente del paese, se non c’era un vincolo di parentela c’era un po’ di... eh... era come adesso veneti e napoletani, c’è il polentone e il terrone e così era... e perciò... mentre qualcuno magari sfuggiva quella festa, quelli del paese Sant’Isidoro, quelli della campagna magari sfuggivano quella di Sant’Ansano, ma molto meno perché Sant’Ansano, diciamo, era il patrono di Allerona, Sant’Isidoro era il patrono dei lavo-ratori dei campi, allora c’era questa distinzione...97
Alcuni ricordano con vivezza di particolari l’ostentato ostra-cismo a cui era soggetta dagli abitanti del borgo la festa di Sant’Isidoro:
… pe li Pugnaloni c’annavo... comunque erono tutte nasco-ste pe queli vicoletti come se c’erono le cannibali n giro! N pochetto anche adesso, però nun è che la colpa è de uno o dell’altro. Nsomma così, ce so ste cose tra paese98.
Ce credo, ce credo che me dispiaceva, perché dico: “Vede ste stupide, se scanzono e noe tutte n processione”. Era na festa
96. Cit. seGhetta a.1999-2000: inf. 21.97. Idem: inf. 7.98. Idem: inf. 13.
195Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 194
contadina, Sant’Isidorio era contadino, ha capito? E loro nvece se facevono grande99.
Altri pur ammettendo l’esistenza di una sorta di subordina-zione del santo contadino al santo patrono non la imputano a problemi di ordine sociale ma ad una specie di oggettiva gerarchia in ambito sacrale:
Sant’Ansano è il patrono!… lue è il protettore e nu je se pos-sono fa li torti a li santi. Quest’altro è così... ma mica perché voglio dì che è n contadino, è n santo come tutte100.
Sant’Ansano magari se risente n po’ di più perché è l patrono de... de la festa… de Allerona, però come religione Sant’An-sano e Sant’Isidoro è uguale. Tutt’e due uguali. Insomma Sant’Ansano, certo, è n po’ più caro per noi, ma anche Sant’I-sidoro, eh, Sant’Ansano è l patrono, lo pregamo n po’ più. In-vece, Sant’Isidoro lo pregamo, ma è n po’ più lontano101.
Anche una breve riflessione sulle risorse economiche a di-sposizione degli organizzatori delle due feste mette in evi-denza le disparità esistenti. Le offerte raccolte dai “festaroli” di Sant’Isidoro erano sempre inferiori a quelle raccolte per Sant’Ansano perché provenienti esclusivamente dalle que-stue eseguite nella campagna:
… na festa anche poverina, poverina in quanto dopo la proces-sione davano qualche biscotto, così: na cosa anche, perché an-che economicamente la festa non c’aveva i soldi per fare grandi cose, perché raccoglievano dai contadini. Era difficile che pas-savano dal paesano per la raccolta anche delle offerte. Allora non è che se raccoglieva tanto, insomma, perciò anche la festa diventava na festa de poche cose. Ecco, offrivano magari un biscotto fatto da loro, dalle loro donne, il vino di loro, ecco...
99. Idem: inf. 12.100. Idem: inf. 24.101. Idem: inf. 8.
però si finiva lì, finiva lì la festa, ecco. Per cui c’è questa... io dico questo aspetto sociale che nei paesini, come noi, si notano molto: la divisione tra il paesano... che potrebbe essere con-siderato più sotto l’aspetto sociale e il contadino un po’ giù perché ehm... perché è giù102.
L’effetto delle diverse risorse disponibili per le due ricorren-ze si fa sentire essenzialmente riguardo allo spettacolo piro-tecnico, uno dei punti di orgoglio della comunità alleronese, che tutt’oggi viene organizzato esclusivamente per la festa di Sant’Ansano:
Ma... beh, m’allora Sant’Ansano era più importante. Doppo je facevono le foche, invece a Sant’Isidorio nun je facevono ste cose come c’erano pe Sant’Ansano. Era più poretto insomma Sant’Isidorio...103
Molto interessante, proprio in relazione ai distinti ambiti so-ciali e insediativi di pertinenza dei due santi, è la presenza di una sorta di loro netta incompatibilità territoriale quasi a scongiurare che la eventuale commistione dei due ambiti del sacro potesse alludere ad altre possibili contiguità di ordine sociale e culturale. Un invisibile ma profondamente scavato confine separa i due ambiti “giurisdizionali”: al santo pa-trono spetta la chiesa parrocchiale che si erge al centro del borgo antico, al santo contadino la chiesa di San Michele Arcangelo, posta fuori del borgo, a dominare la sottostante piana contadina:
…. celebriamo la santa messa nella chiesa proprio della par-rocchia dei contadini, non questa che, dove stiamo qui è San-ta Maria... perché non si può portare il Santo, Sant’Isidoro in
102. Idem: inf. 29.103. Idem: inf. 3.
197Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 196
questa chiesa. Non vogliono. Nemmeno che Sant’Ansano però vada in quell’altra chiesa, eh, non se po…104
Assieme allo stendardo ed al gruppo plastico raffigurante il miracolo dell’aratura, anche la reliquia di Sant’Isidoro, un piccolo frammento osseo contenuto in un reliquiario, sulla quale non è più reperibile alcuna documentazione ecclesia-stica e storico-archivistica, viene abitualmente conservata nella chiesa di San Michele Arcangelo:
… perché la chiesa sua, quella di Sant’Isidoro, è quella chiesina giù, dietro, vicino al Comune. Quella è la chiesa di Sant’Isido-ro, cioè dedicata a San Michele Arcangelo; però la statua abita lì, Sant’Isidoro, ecco…105
Nel tempo che è durato, questo tratto squisitamente locale del più vasto ambito delle forme storicamente e culturalmen-te assunte dai rapporti di conflittualità tra città e campagna, ha prodotto anche una piccola aneddotica a conferma che l’opposizione tra i due santi ha sicuramente costituito uno dei momenti di coagulo culturale e simbolico dell’opposizio-ne tra il vasto mondo rurale e la piccola comunità del borgo. Sempre con una certa riluttanza emerge dalla memoria un episodio che vede come protagonista il campanaro che si rifiuta di suonare una particolare campana per la vigilia della festa di Sant’Isidoro perché quella campana è la campana di Sant’Ansano:
…perché disse: “Accidente a lue e io che je sono”, a Sant’Isi-doro106.
104. Idem: inf. 29.105. Idem: inf. 7.106. Ibidem.
…è vero, è vero che... c’è uno de campanaro che nun le sona!… in effetti je l’ho detto: “Ma scusa te”… M’ha detto che lui non suona, lui, a festa pe Sant’Isidoro, non suona107.
… sì c’era sta cosa... Comunque c’è na campana che è la campana proprio de Sant’Ansano, diciamo. La sonavono a mano, anzi la suonano sempre. Mo però la sonono sempre pe ogni festa, no? Ma nvece, prima, se sonava solamente pe Sant’Ansano… Però, quella sarebbe stata la campana del padrono... nfatti, guarda l sabato che esponevano Sant’Ansano, dava emozione sta campana, perché se sentiva na volta l’anno e te... ce se piangeva, io me ricordo che ce piangevo. Era na campana che te dava proprio... mesà che ce so rade le campane come questa qui eh... Questa nostra è na campana proprio... nu lo so, dice che c’è, dicevono che ce sia stato n affare d’oro108 dentro, io l’ho nteso dì sempre dall’antiche, che c’ha n sono diverso nsomma via, n sono bellissimo109.
Un cosiddetto “sonetto paesano popolare” pubblicato nel 1978 sul giornalino parrocchiale110, offre un’altra prova tan-gibile dell’atteggiamento di “esclusivismo culturale” che il borgo mantiene nei confronti del mondo mezzadrile come tentativo, spesso disperato, di sostenere una sua autonoma identità aggrappandosi in continuazione ai tratti della sua presupposta superiorità culturale.
107. Idem: inf. 4.108. Largamente diffusa a livello popolare la credenza che campane
antiche dal suono particolarmente potente e “argentino” debbano tale loro qualità all’immissione di metallo prezioso nel corso della fusione. Analisi chimiche effettuate recentemente su alcune campane non hanno confermato la credenza popolare che potrebbe aver avuto origine dal fat-to che la Chiesa, per la costruzione di nuove campane raccoglieva presso i fedeli offerte che potevano essere fatte anche sotto forma di monili di metallo prezioso.
109. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 9.110. “Il campanile”, III, 3, maggio 1978.
199Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 198
Il borgo come piccola isola che fonda il suo relativo be-nessere sull’indigenza e sulla penuria del vasto mare conta-dino che la circonda e trova la giustificazione dell’inegua-glianza e dello sfruttamento nella “inciviltà” e nella “igno-ranza” degli altri:
… la diversità fra il contadino che aveva sì, non soltanto una povertà materiale, aveva anche una povertà intellettuale, no? La non scuola, no? E dal paesano che dentro le mura si credeva nobile … e quell’altro schiavetto, no111?
Il componimento, un classico esempio di “satira del villa-no” identifica Sant’Isidoro con i suoi fedeli sino a definirlo “birbone”, indica la massa dei partecipanti alla processione come “turba malandrina” e infine esprime, nel dileggio de-gli “incivili” atteggiamenti subalterni, il senso della alterità e della diversità culturale:
Poi la folla arriva tosto,e con trivial manierecon una mano agguanta il biscottoe con quell’altra impugna il bicchiere:a noi sembra un’ignoranzama fra loro, invece, è d’usoche quel goccio che je avanzate lo tirano nel muso.
In una piccola, isolata porzione di mondo dove, pur nelle differenze insediative, sociali e culturali, non sempre è facile mantenere distanze e distinzioni su cui fondare la propria identità, queste si possono erigere anche su peculiarità che, a prima vista, potrebbero sembrare totalmente insignificanti:
Dei contadini, sì, che diciamo erano un pochino più grevi, più grezzi de... de questi de qua, se anche nemmeno qui le finezze
111. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 29.
abbondavano, però insomma. Quelle n po’ meno ce l’aveva-no… C’era na zia de mia moglie che diceva che lei non man-giava... l lesso ma mangiava l bollito. Lei era contadina e... una volta poi, dopo che era venuta, che aveva sposato uno de qui, lei contadina, ecco, già aveva assimilato l coso... della paesa-na…perché pe i contadini era l lesso, pe quelli del paese era... era bollito112.
Altre informazioni raccolte consolidano il modello interpre-tativo adottato; più volte è stato ricordato come, un tempo, gli abitanti del borgo si rivolgessero ai coloni indicandoli in senso dispregiativo con l’appellativo di Sant’Isidoro:
... tanto che la frase più offensiva che si può dire ad un uomo è: “Tu sei un Sant’Isidoriaccio, Sant’Isidoro”; “Senza offesa per il santo”, te dicono. Però, ecco, pe dì che tu sei un bifolco, “Tu sei un Sant’Isidoro”... che uno che sente sto linguaggio dice: “Che vogliono dì?”, ecco. Per loro Sant’Isidoro si identifica col contadino, col contadino ignorante; il contadino ignorante, il contadino un po’ povero perché non c’aveva niente, il contadi-no un po’ povero anche d’idee e via di seguito…113
…“Lascia sta che quello è un Sant’Isidoro”, pe dì “Quello è un contadino”… adesso non c’è più perché adesso non c’è più la gente di campagna, ma cinquanta, sessant’anni fa c’era, c’e-ra veramente: “Tirite là, passime a largo che, magari odori de stalla”. È vero. C’era questa discriminazione, diciamo; se senti-vano come superiori, che poi in effetti nvece…114
…infatti prima al contadino je dicevano “Sant’Isidoro” infatti è vero... Me ricordo che certe volte anche la mi mamma me diceva: “sto Sant’Isidoro!” Ma nun è che se voleva rivolge al
112. Idem: inf. 7.113. Idem: inf. 29.114. Idem: inf. 7.
201Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 200
santo: se voleva rivolge a la persona, capito, pe dì ch’era n con-tadino, insomma…115.
Altra espressione, meno diffusa rispetto alla precedente, con la quale il santo è totalmente associato con la fascia sociale che rappresenta e i coloni sono totalmente identificati con il misero santo verso il quale è stata fortemente indirizzata la loro devozione, è “Sant’Isidoro gunnellino” che allude, in tono sprezzante, al camice da lavoro un tempo indossato dai coloni e sottolinea e ribadisce, attraverso la diversità del loro abbigliamento e di quello del loro misero santo, lo scarto sociale e culturale con gli abitanti del borgo:
Quello era... è na frase de na pecora nera che nun va portata avante, nsomma... perché è brutto, nun è da... da persone civili, via... perché… c’evono la gente che lavorava ne la campagna, c’evono un camice e lo mettevono che era... corto, nsomma, n poco più lungo de na camicia, ecco... e lo mettevono sempre, secondo che lavore facevono, pe nu sporcasse sotto, ecco... perché portava quello, je dicevono gunnellino... ma nun è che... era detto da poche de gente... da pochissime116.
Un riflesso del fatto che l’epiteto “Sant’Isidoro” presentasse una valenza dispregiativa si rinviene anche nell’analisi an-troponimica, sia pure molto superficiale, svolta presso l’a-nagrafe del comune di Allerona. Negli ultimi settanta anni ben trenta nati nel comune di Allerona sono stati battezzati con il nome del loro patrono Ansano e nessuno, invece, ha ricevuto il nome del santo contadino Isidoro.
Un santo, quello contadino giunto ad Allerona da lonta-no, a suo tempo scelto da coloro che ne hanno alacremente sostenuto e incrementato la diffusione del culto, la Chiesa e la proprietà terriera, proprio perché esempio di vita total-
115. Idem: inf. 26.116. Idem: inf. 23.
mente accondiscendente e subordinata alla struttura della proprietà. Talmente esemplare, almeno così sembrerebbe, da non lasciare alcun margine a rielaborazioni subalterne che possano sostenere quel minimo di conflittualità o di ri-sentimento che permetta di non appiattire totalmente la pro-pria concezione del mondo e della vita su quella dominante.
Da un lato la scrupolosa attenzione da parte del mondo mezzadrile nell’evitare di attribuire il nome del santo ai pro-pri figli, sta a significare la profonda consapevolezza dello stigma sociale e culturale connesso al nome e il tentativo di non condizionare negativamente il futuro del nuovo nato con un “marchio di origine” inconfondibile, nel piccolo mondo dove gli è toccato di vivere. D’altro canto, la ripro-posizione ininterrotta da parte del mondo colonico, almeno fin quando è stato materialmente possibile, della “sua” festa del santo contadino, sta a dimostrare che anche in quella che potrebbe sembrare solo una pura forma di assoggettamento culturale, sono state elaborate e praticate forme di identità e di socialità collettiva autonomamente agite.
Solo il fatto di poter gestire con una qualche autonomia una festa, in una situazione di totale assoggettamento eco-nomico, sociale e culturale, presenta aspetti positivamente rilevanti e consente, tra l’altro, di compattare nel raggiungi-mento di un obiettivo comune la dispersa frammentazione del mondo mezzadrile. Le attività di questua, oltre a procu-rare le risorse necessarie per “fare” la festa, rinsaldano pe-riodicamente i legami tra le numerose famiglie coloniche; la partecipazione massiccia della campagna alla festa del santo contadino costituisce anche un rito collettivo di aggregazio-ne di una comunità altrimenti parcellizzata:
203Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 202
… quarant’anni, cinquant’anni fa, a la messa ce s’andava tutti. Però quel giorno, guai a non andà a la messa e a la processione de Sant’Isidoro117!
Anche il paziente bricolage invernale connesso alla prepara-zione dei pugnaloni consente di riflettere radicalmente sulla propria condizione. Il lavoro di miniaturizzazione degli ani-mali, delle piante, degli strumenti, degli oggetti, li trasforma da ovvi elementi del contesto quotidiano in segni da esibire nel rituale festivo: un aratro in miniatura, per quanto identi-co, sia pur in scala, all’originale, non potrà mai essere utiliz-zato per arare, il suo impiego non rientra quindi nell’ordine pratico ma nell’ordine segnico, serve assieme a tutto il resto, a ostentare e confermare il più compiutamente possibile la propria identità e la garanzia della propria presenza.
Proprio la centralità che assume la rappresentazione mi-niaturizzata della vita e del mondo contadino allestita sui pianali dei diversi pugnaloni costituisce un modo per af-fermare la propria complessiva identità puntigliosamente documentata, in modello ridotto e quindi immediatamente comprensibile e facilmente intelligibile con un solo sguar-do118, nei fondamentali aspetti della produzione economica e della sussistenza materiale. La costante presenza dell’even-to miracoloso di Sant’Isidoro in ogni allestimento indica pa-lesemente la direzione della devozione, serve a destorificare un mondo, ad affidare alla potenza del sacro gli elementi cardine che permettono alla comunità rurale locale di “stare stabilmente al mondo” e contemporaneamente costituisce un monito per i malfidi proprietari terrieri. La figura del santo contadino, ingiustamente sospettato di non svolgere il proprio lavoro, da tutti i pugnaloni continua incessante-mente a ripetere: tu non ti fidi del mio lavoro ed io te lo mo-
117. Cit. seGhetta a. 1999-2000: inf. 25.118. Cfr. esPosito v. 1995: 39.
stro in tutti i suoi aspetti assieme ai prodotti della mia fatica. Ma la miniaturizzazione, tipica quella presepiale, permette anche di illustrare e di cogliere nel suo insieme una realtà altrimenti complessa e sfuggente e quindi di manifestarla nella sua dura completezza: non a caso, nel giorno della fe-sta, i pugnaloni che salgono dalla campagna sino al borgo, dopo aver sfilato e sostato nella piazzetta antistante la porta principale del paese, vengono dislocati in diversi slarghi pre-senti entro le mura urbiche, quasi per mettere sotto gli occhi degli altezzosi abitanti del borgo quel mondo del lavoro dei campi da cui traggono il loro benessere ma da cui vogliono puntigliosamente distinguersi:
…anche si nun era n contadino, l pane di du viene? Da la terra, eh. Nun se po’... quello che è na persona cattiva, n ignorante perché, si cunsidere bene… le padrone ce vulìano male perché nun erono mae contente... Si noe se faceva cento quintali de grano, lore ne vulìano ducento... Noe faticassimo, si eravamo quindici persone, noe emo faticato pe trenta…119
Con la fine della mezzadria e lo spopolamento delle cam-pagne si è irrimediabilmente dissolto quel mondo contadi-no che costituiva la base materiale e culturale della festa di Sant’Isidoro e ne consentiva, col solidale impegno di tutta la comunità rurale, l’annuale ritorno. Per impedire che la festa si esaurisse la sua organizzazione è passata in altre mani, che non sono propriamente quelle del borgo, in quanto rappre-sentano tutta la comunità, ma che come tali sono invece viste da chi ancora rivendica con orgoglio l’autonomia della anti-ca festa contadina:
Adesso c’è! Adesso la fanno loro, no più noe. Però mo se so messe che semo venute via tutte noe contadine, allora mo dice: “Bisogna falla noe, mica la potemo perde”, capito? Sinnò era
119. Idem: inf. 24.
205Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 204
finita, perché se noe semo venute via dalla campagna e... anche dal paese e ora la fanno da loro... Noe ce se va, però, su uguale, eh120!
Gli scherzi Del Destino
Possiamo incominciare a riannodare le fila del discorso sin qui svolto, difficile sarebbe, infatti, parlare di conclusioni definitive, l’argomento trattato difficilmente le consente: le trasformazioni subite dalla festa stanno proprio a mostrare come mutate situazioni possano intervenire sul tessuto di una festa per riplasmarla e renderla più congrua alle rinno-vate esigenze, in un continuo processo di elaborazione cul-turale.
Il recente slittamento della celebrazione di Sant’Isidoro alla domenica successiva, oltre a rispondere a motivi di or-dine pratico, sembra in effetti un tentativo di spegnere defi-nitivamente anche gli echi e i ricordi di una conflittualità tra “città e campagna” che oggi, dopo la completa dissoluzione della mezzadria e lo spopolamento rurale, non sembra avere più alcun senso:
Da tutte le parte... na volta: “Ecco le contadinacce”, dicevono le paesane... nvece, adesso sta cosa è finita, perché chi c’è più? n c’è nessuno, tutte chiuse le contadine121.
Eh... era così, cinquant’anni fa, quarant’anni fa: li contadini facevano la festa pe conto suo, li paesani l giorno la festa de Sant’Ansano era de li paesani e quella di Sant’Isidoro de li con-tadini e... e c’era n po’ de discordia, nun è che se potevano vedé tanto; ma ora è tutto cambiato, ora122.
120. Idem: inf. 12.121. Idem: inf. 17.122. Idem: inf. 16.
Il distanziamento tra le due feste, la stabile collocazione do-menicale della festa di Sant’Isidoro, ha consentito inoltre di “confezionarla” non solo per la fruizione interna ma anche come evento attrattivo da un punto di vista turistico.
Alla completa e definitiva crisi del mondo mezzadrile tra-dizionale che organizzava in proprio la festa ed al contempo-raneo passaggio della sua gestione all’ambiente urbano (co-mune, pro-loco) deve inoltre essere collegata l’introduzione del corteo storico in cui sfilano figuranti vestiti con costumi ottocenteschi. Fenomeni di tal tipo sono largamente diffusi in altri contesti della nostra regione in cui la “invenzione del-la tradizione”, la creazione ex-novo di occasioni festive arti-ficiosamente “invecchiate”, collocate in un’epoca medievale o barocca resa più o meno realisticamente, cerca di afferma-re una continuità storica con un passato in cui si individuano e si situano le radici della propria identità locale.
Poiché ad Allerona la festa già esisteva e si è svolta senza soluzione di continuità, il tentativo di “ingabbiarla” nel pas-sato e quindi di trasformarla radicalmente, assume caratteri sicuramente più complessi, non si tratta dell’invenzione di una nuova festa ma della riplasmazione di un’antica festa. In effetti, con l’introduzione dei figuranti in costume, quel-la che si svolge nella seconda metà di maggio ad Allerona sembra presentarsi come la rievocazione, la citazione e la rappresentazione di una festa che fu, svuotata quindi di ogni altro significato che non sia quello della annuale ripetizione a scopo turistico. Anche l’unica innovazione che aveva inve-ce contribuito ad attualizzare la celebrazione festiva, l’inse-rimento nel corteo dei trattori, per motivi del resto perfet-tamente comprensibili, è stata abbandonata. D’altro canto la festa doveva mutare volto a causa della totale scomparsa di quel mondo contadino che l’aveva sorretta e non poteva essere riproposta secondo le forme tradizionali.
L’introduzione del corteo storico nella festa, attuata an-che inconsapevolmente nel tentativo di renderla più appeti-
207Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 206
bile e più fruibile, più che una citazione di altri esempi co-nosciuti, potrebbe collegarsi al tentativo di proporla svuo-tata del senso “conflittuale” che possedeva in quanto festa del santo contadino, dei contadini, gestita ed organizzata in proprio dai contadini. Proprio alcuni anziani provenienti da quel trascorso mondo rurale che sosteneva la festa, colgono nelle innovazioni questo aspetto negativo continuando, mal-grado tutti i tentativi di pacificazione a interpretare il mondo come diviso tra noi e loro:
… adesso è ridotta che so loro che vengono a cercà noe… Ha capito com’è il fatto. Noe l’emo fatto pe soddisfazione dell’an-gelo, de Sant’Isidorio. Perché eravamo lì e loro nvece se ne stavano tutte riprese, capito, che erano signore e nun volevano venì vicino a noe che eravamo contadine. Nvece ora so loro ch’hanno ngrandito la festa, che mettono l cappellino, l’om-brellino… A me, così, nun me piace più tanto, perché la festa è de Sant’Isidorio mica del corteo123.
Le recenti trasformazioni sembrano anche aver prodotto de-gli effetti paradossali, sicuramente non previsti al momento della loro attuazione.
La festa dei pugnaloni, non più festa dei soli coloni ma divenuta festa di tutto il paese, richiama un notevole flusso turistico e anno dopo anno sta crescendo, risulta sempre più seguita e quindi anche più importante di quella di Sant’An-sano:
Beh sì, direi proprio de sì. Forse adesso, negli ultimi anni, come presenza de gente c’è più Sant’Isidoro, sicuramente. Richiama molta più gente Sant’Isidoro. Gente da fuori124.
123. Idem: inf. 12.124. Idem: inf. 7.
La cosa non incontra il favore di molti abitanti del borgo che hanno, da sempre, considerato la festa del patrono come l’evento più rilevante del ciclo calendariale ad Allerona:
Perché da noi dice: “Ma ecco, questa festa è passata avanti a Sant’Ansano? Adesso, fate tutto questo ed è passata davanti a Sant’Ansano la festa; Sant’Ansano pe noi deve essere la festa più importante”, ma questo è un aspetto totalmente diverso. Ecco, se l’ha vista come festa o vedrebbe Sant’Ansano, se ren-de conto che dopo na bella messa solenne e na bella processio-ne, perché in effetti insomma ma... religiosa125.
Alcuni anziani ex mezzadri non nascondono invece la loro soddisfazione perché, nel ricordo di tutte le umiliazioni su-bite, il fatto che la festa di Sant’Isidoro stia soverchiando in importanza e rinomanza la festa di Sant’Ansano, sembra costituire una sorta di riscatto sociale e culturale:
Noe semo contente perché... je voglio dì anche questo: prima alla quèsta, come se dice, a faje l’offerte, la carità pe Sant’An-sano se dava n po’ de più, perché se cosava... perché era il pro-tettore e Sant’Isidorio un po’ meno; chissà com’era... nvece adesso, adesso dico la verità damo tanto pe Sant’Ansano, tanto pe Sant’Isidorio 126.
Quella de Sant’Ansano, prima, era più importante; quella de Sant’Isidorio de lunedì... ma mica facevono niente… Tutte co-sine così, nvece, adesso, le fanno tante, per bene. No, adesso quella de Sant’Isidorio è... vale tanto, nsomma… ha preso n po’ più... forza. Anche la processione è bella, bellissima... la ripiglia anche la tilivisione; quella de Sant’Ansano, no127.
125. Idem: inf. 4.126. Idem: inf.: inf. 17.127. Idem: inf.: inf. 18.
209Alberi e santi ad AlleronaGiancarlo Baronti 208
Dalla oPPosizione alla riconciliazione
Anche se abbiamo espresso alcune perplessità sulle trasfor-mazioni apportate alla festa nei tempi recenti, tali osserva-zioni non vogliono sicuramente mettere in dubbio il fatto che la festa, oggi come ieri, realizza per la comunità che la attua il bisogno di esprimere mediante simboli condivisi la propria identità sociale e culturale. Ieri la festa indicava e ribadiva una situazione sociale di netta divisione e di oppo-sizione, oggi vuole manifestare una nuova condizione che vede la comunità alleronese più unita e solidale.
Dall’attuale assetto della festa di Sant’Isidoro promana quindi un altro significato, opposto a quello che esprime-va l’antica festa, ma fortemente voluto, sentito ed espresso nell’attenzione e nella cura che, concordemente, le istituzio-ni locali, la parrocchia e le scuole mettono nell’allestire mi-nuziosamente quei pugnaloni che un tempo erano elaborati dai coloni nelle sere d’inverno e nella palese intenzione di valorizzare gli aspetti più tradizionali della vita contadina del passato.
La festa, ricevuta in eredità dalle generazioni passate, portava con sé, assieme agli aspetti folclorici, il peso di una connotazione di conflittualità che le nuove generazioni, nel-le mutate condizioni sociali ed economiche, non vogliono e non possono accettare come patrimonio proprio. I pugnalo-ni con le loro sempre più minuziose e attraenti ricostruzioni e la rievocazione degli antichi mestieri, in un’atmosfera forse un po’ troppo idilliaca, vogliono comunque trasmettere e rendere fruibile a tutti un forte messaggio di rassicurante pa-cificazione: l’esaltazione odierna del lavoro contadino vuole costituire una sorta di risarcimento simbolico nei confronti di un mondo mezzadrile un tempo rigidamente subordinato e rigorosamente marginalizzato.
Anche l’allestimento scenografico del corteo storico, l’at-tenzione maniacale e accurata nel ricercare e definire i co-
stumi, l’abbigliamento e i più minuti particolari dei figuranti che consentano di collocare cronologicamente la rappresen-tazione proprio in quel passato fortemente segnato dall’op-posizione e dal conflitto, costituisce una sorta di finzione rituale. La maschera del passato esibita nel corteo storico non è il passato reale, evoca un passato mitico fatto di dif-ferenze e di sfumature ma non di opposizioni e di conflitti, è un passato irreale in cui tutta l’antica comunità alleronese appare partecipare unanimemente alla festa del santo con-tadino. Solo la «ipocrisia cerimoniale»128 di un corteo stori-co storicamente illusorio, inserita corposamente all’interno del momento festivo, può riuscire a riscattare quella sorta di senso di colpa che ancora aleggia nella comunità alleronese e ad allontanare le ombre lunghe di un “cattivo passato”.
128. Cit. De martino e. 1962b: 215.
Daniele ParBuono
Il gruppo folcloristico Agilla e Trasimeno:Tradizione e innovazione1
[…] si cominciò a fare tutto come in città, aumentò l’amore per la pulizia, si accrebbero le comodità, si prese a imitare le maniere bor-ghesi, soprattutto a vestirsi, che era segno evidente di progresso. Fu tutto un accumularsi di novità disparate, un processo comunque graduale, più o meno avvertito. Tutto questo portò a sciogliere le maglie dei rapporti e delle costri-zioni tipici della vita comunitaria; la struttura tradizionale non andò a pezzi, si allentò, si dilatò permet-tendo nuovi intrecci e innesti sul tessuto tradizionale2.
Proprio le parole di Mario Tosti possono essere prese come punto di riferimento per descrivere la situazione
socio-culturale nella quale ha trovato terreno fertile l’idea di costituzione del gruppo folcloristico “Agilla e Trasimeno”.
Nell’anno 1957 alcuni stimati cittadini di Castiglione del Lago (Pg), prendendo esempio da gruppi folcloristici già operanti in contesti territoriali attigui al proprio comune di
1. Questo contributo è il risultato di una rielaborazione dei due saggi Vecchi e nuovi linguaggi dell’arte popolare (cfr. ParBuono D. 2007a) e “Agilla e Trasimeno”, la sua storia, il suo territorio (cfr. ParBuono D. 2007b) pubblicati in ParBuono D. (a cura di) 2007.
2. Cit. tosti m. 2007: 83.
213Il gruppo folcloristico Agilla e TrasimenoDaniele Parbuono 212
residenza, decisero di dedicare tempo libero e passione alla costituzione del “Gruppo Folcloristico Castiglionese”.
I fattori che spinsero Dino Monottoli e Sandra Lana, ini-zialmente coadiuvati dall’impegno di un ristretto gruppo di amici e dall’approvazione dell’Amministrazione comunale, a fondare, quasi per scherzo, questo gruppo folcloristico, non sono facilmente riducibili a un elenco schematico di motiva-zioni asettiche. La stessa longevità del gruppo suggerisce la necessità di approfondire l’analisi sul contesto territoriale, sulle condizioni sociali, sulle situazioni personali, che intrec-ciandosi, negli anni, ne hanno garantito la florida sopravvi-venza.
La «rivoluzione meccanica» di cui parla Tosti3, accompa-gnandosi a un significativo miglioramento delle condizioni di vita e ad un notevole cambiamento delle attività profes-sionali agricole, favorì un lento ma inesorabile incedere di mutamenti culturali e sociali che portarono gran parte della popolazione del territorio castiglionese a passare dalla con-dizione mezzadrile alla vita cittadina. Le dodici frazioni4, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, andarono incontro a un incessante spopolamento che, nonostante il decremento complessivo della popolazione comunale, favorì l’accresci-mento demografico, quindi urbanistico, del capoluogo5:
3. Idem: 80.4. Tredici se si considera Isola Polvese, che pur essendo, dal punto
di vista amministrativo, frazione di Castiglione del Lago, è ora proprietà della Provincia di Perugia, che dal 1995 l’ha dichiarata Parco scientifico-didattico nell’ambito del Parco Regionale del Trasimeno.
5. I dati riportati nello schema riassuntivo della popolazione residente nel capoluogo e nelle frazioni dal 1931 al 1971 sono tratti da istituto centrale Di statistica Del reGno D’italia 1933: 904-905; istituto cen-trale Di statistica 1954: 15-16; istituto centrale Di statistica 1965: 16-17; istituto centrale Di statistica 1973: 4-5; istituto centrale Di statistica 1984: 3.
1931 1951 1961 1971 1981Badia 827 891 819 462 312Casamaggiore 640 598 466 262 228Castiglione del Lago (capoluogo) 2028 2446 3022 3211 4075Gioiella 902 1015 862 604 546Isola Polvese 21 15 6 7Macchie 1113 1178 1155 1011 977Panicarola 813 970 1053 975 1089Petrignano 925 1050 876 606 541Piana 1207 1300 1037 930 901Porto 833 858 691 469 392Pozzuolo 2676 2853 2485 1881 1576Sanfatucchio 1734 1786 1990 1766 1690Vaiano 1321 1143 956 705 525Villastrada 1137 1340 1265 627 571TOTALE 16156 17449 16692 13515 13430
Nuove professioni, nuova attenzione per l’istruzione delle giovani generazioni, nuovi spazi pensati per il possibile svi-luppo dell’attività turistica, una nuova dimensione del tem-po libero originata dalle diverse condizioni lavorative, cam-biarono l’intero apparato delle relazioni familiari e amicali, favorirono il formarsi di nuovi punti di incontro e resero fisiologica la necessità di ricostruire le trame di un nuovo tessuto sociale.
Allo stesso tempo, il notevole cambiamento socio-econo-mico e professionale rese desuete certe forme culturali tra-dizionali che fino a quel momento erano risultate funzionali alla stessa sopravvivenza degli individui. Così come l’agri-coltura cedeva il passo all’impiego nel terziario, la medicina popolare cedeva il passo alla medicina scientifica; così come l’abitare in frazione cedeva il passo all’abitare “in paese”, la casa colonica cedeva il passo alla villetta o all’appartamento castiglionese; così come la famiglia allargata patriarcale ce-deva il passo alla famiglia mono-nucleare, l’importanza dei rapporti di parentela cedeva il passo a nuovi legami sociali; così come la concezione dell’utile cedeva il passo al consu-mo, l’abitudine al riuso e all’utilizzo oculato delle risorse cedeva il passo all’accumulo e all’investimento; così come
215Il gruppo folcloristico Agilla e TrasimenoDaniele Parbuono 214
l’arte popolare cedeva il passo ai nuovi mezzi di comunica-zione mediatica, “Trescone” e “Saltarello” cedevano il passo all’“Alligalli” e al “Festival di Sanremo”.
La nuova realtà socio-culturale e le migliori condizioni economiche favorirono l’ideazione di momenti aggregativi che, anche se in parte derivanti dalle tradizionali abitudini festive, apparivano ormai disgiunti dai cicli agrari, dai cicli della vita e dalle attività tradizionali. La precedente struttura sociale, “allentata”, doveva essere rinsaldata attraverso l’uso dei mezzi che la nuova realtà poteva fornire: quasi contem-poraneamente, a Castiglione del Lago, nacquero la pro-loco, la “Festa del Tulipano” e il “Gruppo folcloristico castiglio-nese” (primo nome del gruppo).
Per quanto riguarda la nascita del gruppo folcloristico, l’esigenza di trovare un momento di unione e di aggrega-zione per i ragazzi di un paese in espansione, ma privo di attività che attirassero la loro attenzione, incontrò da un lato il bisogno di arricchire lo spettacolo offerto ai visitato-ri dell’annuale “Festa del Tulipano” organizzata dalla pro-loco, dall’altro la passione per la tradizione popolare, unita all’intraprendenza, di Dino Monottoli e la competenza tec-nico-musicale di Alessandra Lana, insegnante di musica per professione. La loro intuizione, concretizzata in una iniziale attività esclusivamente paesana, si rafforzò grazie al contri-buto di altri amici e collaboratori, dell’Amministrazione co-munale e di un nutrito gruppo di giovani che negli anni si è rigenerato costantemente.
Dopo le prime esibizioni castiglionesi (o comunque in paesi contigui), il gruppo, dalla metà degli anni Sessanta, iniziò ad essere contattato per esibizioni e scambi culturali con città italiane sempre più distanti. Nel 1971, poi, per la prima volta – fatta eccezione per lo spettacolo a San Ma-rino del 1966 – oltrepassò i confini nazionali per recarsi a Trappes, sobborgo parigino gemellato con Castiglione del Lago. A questo punto oltre alla funzione culturale di tutela,
aggiornamento e rilancio delle arti etno-coreutico-musicali tradizionali e alla funzione sociale di cui si è accennato, il gruppo acquisì un’altra importante funzione, quella di far toccare con mano, ai suoi giovani componenti, realtà total-mente altre da quella del loro territorio: la forza centripeta, data dalle motivazioni iniziali di aggregazione e tutela cul-turale, si arricchì unendosi alla forza centrifuga data dal de-siderio di conoscere l’Italia e il mondo, attraverso l’attività folcloristica.
Il gruppo, ormai rodato, negli anni Settanta, fu organiz-zato accuratamente anche dal punto di vista burocratico; dopo la creazione dell’associazione culturale e la registrazio-ne dello statuto, fu scelto il nome che poi è rimasto invariato fino ad oggi: “Gruppo folcloristico castiglionese” fu sostitu-ito con gruppo folcloristico “Agilla e Trasimeno”6.
Dal punto di vista tecnico-artistico un importante pun-to di svolta fu la prima partecipazione al Festival Mondiale
6. «Il nome del gruppo deriva da antiche leggende di origine etrusca. Una di queste narra le vicende della ninfa Agilla e del principe Trasimeno. Il principe, in una sua escursione, mentre attraversava le terre del Centro-Italia, fece sosta vicino ad un lago. In questa occasione la sua straordinaria bellezza fu notata dalla ninfa Agilla che dopo averlo sedotto lo trascinò nel lago attirandolo col proprio canto, facendolo morire in quelle acque che da lui presero il nome. La leggenda vuole che, da allora, nelle sere di agosto, quando un leggero vento accarezza gli alberi e le acque del lago, si senta il triste e malinconico lamento della ninfa Agilla, eternamente alla ricerca del suo principe Trasimeno. Una seconda versione, racconta che mentre l’etrusco Amno, figlio di Fauno, spadroneggiava sul lago, il principe etrusco Tirreno, proveniente dal monte Amato, occupò alcune zone circostanti. Per sedare le dispute riguardanti i confini, nate fra le due popolazioni, fu combinato il matrimonio fra Trasimeno, figlio di Tirreno e Agilla, figlia di Amno, che portò in dote il lago a cui fu attribuito il nome dello sposo. Più verosimilmente il nome Trasimeno deriva dalla posizione geografica del lago stesso: ‘oltre il monte Imeno (o Menio)’, come antica-mente si chiamava il monte che lo delimita a settentrione. Nel corso della storia esso ha avuto anche altri nomi: Clitonio, Agillino, Plestino, Lago di Perugia, Lago di Castiglione»; cit. ParBuono D. 2006: 76.
217Il gruppo folcloristico Agilla e TrasimenoDaniele Parbuono 216
del Folklore “Castello di Gorizia”, nel 1973. Il giudizio de-gli studiosi di tradizioni popolari presenti, ma soprattutto il confronto con il lavoro certosino dei gruppi folcloristici provenienti da diversi paesi dell’Est europeo, contribuì a ge-nerare, nei componenti dell’“Agilla e Trasimeno”, dirigenti e “artisti”, il bisogno di approfondire le ricerche sul reperto-rio e sugli abiti da portare in scena. A partire dalla metà degli anni Settanta il gruppo visse una nuova nascita: maggiore attenzione nelle prove, maggiore attenzione all’attività cultu-rale, maggiore attenzione alla realtà esterna al paese.
L’esempio del festival di Gorizia fu determinante anche per la nascita della “Rassegna Internazionale del Folklore”, organizzata nella sua prima edizione del 1978, grazie al lavo-ro fattivo dell’“Agilla e Trasimeno”, dell’“Azienda Autono-ma di Cura, Soggiorno e Turismo del Trasimeno” e dell’Am-ministrazione comunale di Castiglione del Lago.
L’acquisto del primo autobus, nel 1988, garantì la pos-sibilità di viaggiare in libertà e a costi accessibili, favoren-do, inoltre, la possibilità di ospitare un maggior numero di gruppi stranieri – per i quali altrimenti sarebbe stato indi-spensabile affittare autobus da aziende private – durante la rassegna.
L’attività del gruppo è rimasta stabile dalla fine degli anni Ottanta all’inizio del nuovo millennio, quando la prepara-zione del viaggio negli Stati Uniti d’America (2004), ha re-stituito nuova linfa ai dirigenti e ai componenti. Da allora si è aperta una nuova fase di progettazione continua, di revi-sione dell’attività, nel tentativo di coniugare l’esperienza cin-quantennale alle nuove necessità umane, sociali e culturali, dei componenti, delle istituzioni e del pubblico. Un rinnova-to spirito di ricerca ha permesso di ricostruire un repertorio di oltre venti canti tradizionali e di intervenire sul repertorio coreutico, curando nel dettaglio il rapporto musica-danza.
Attualmente l’“Agilla e Trasimeno” continua le proprie attività abituali, la danza, la musica, il canto; aggrega decine
di ragazzi, ormai non soltanto castiglionesi, ma provenienti da tutte le frazioni e dai comuni vicini; coltiva rapporti di reciproca collaborazione con molte associazioni del paese e con l’Amministrazione comunale; organizza la “Rassegna Internazionale del Folklore”, giunta alla sua trentacinque-sima edizione; porta il suo spettacolo folcloristico in Italia e nel mondo; da qualche anno, inoltre, dedica molta atten-zione alle questioni che riguardano il folclorismo a livello nazionale e mondiale, infatti alcuni membri del gruppo ri-coprono incarichi di primo piano all’interno della F.A.F.It. (Federazione Associazioni Folkloriche Italiane) e della se-zione C.I.O.F.F. (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels) Italia. Oggi, agli obiettivi dell’aggregazione sociale e del buono spetta-colo folcloristico, si è aggiunto quello di impegnarsi nella ricerca etno-coreo-musicologica, nella ricerca demologica e nella riflessione sul ruolo socio-culturale dei gruppi folclori-stici in Italia.
Cosa hanno ancora da dire il canto, la musica e la danza dei gruppi folcloristici? Di quali forme comunicative possono ancora essere portatori? Quali sono, oggi, le funzioni delle arti etnomusicali ed etnocoreutiche riproposte nel palcoscenico del folclorismo? Quali gli esecutori, quali i destinatari?
L’importanza di una riflessione critica su queste domande risulta particolarmente attuale se si pensa al proliferare dei fenomeni di folk music revival7 che, a partire dalla fine degli anni Trenta del Novecento, hanno incentivato la ripropo-sizione del repertorio musicale e canoro tradizionale, negli Stati Uniti prima, in Europa e in Italia poi8. Risulta ancora
7. Una puntuale analisi del fenomeno si trova in lomBarDi satriani l.m. 1975.
8. A tal proposito è necessario far menzione del concetto di “folklore progressivo” su cui, in Italia, il dibattito è iniziato a partire dagli anni Cin-quanta del Novecento. Per un inquadramento generale di questa tematica si rimanda a sePPilli t. 2008b.
219Il gruppo folcloristico Agilla e TrasimenoDaniele Parbuono 218
più attuale se l’oggetto della riflessione si amplia fino a inglo-bare le danze tradizionali e il campo del festivo per spostarsi nel tempo fino a raggiungere le lussuose manifestazioni “et-niche” e i grandi eventi legati alla tradizione popolare che stanno proliferando in questi ultimi anni9, ingenerando un vivo dibattito sulle funzioni ma, soprattutto, sui fini che i promotori delle stesse si prefiggono di raggiungere.
Dall’altra parte del selciato stanno i gruppi folcloristici che, nella penisola italica, a partire dai primi decenni del di-ciannovesimo secolo10, hanno rappresentato un importante punto di contatto tra la tradizione popolare delle diverse aree e l’incedere della modernizzazione, dalla quale ha mosso i sui primi passi quella che con Giovanni Sartori potremmo definire società dell’«Homo videns»11. Proprio sulle funzio-ni performative della comunicazione di queste associazioni (riconosciute e non riconosciute) diffuse nell’intero territo-rio nazionale e sulle connessioni prossemiche che possono essere individuate nei linguaggi che mediano il rapporto tra la loro attività e la società che le circonda, si incentrerà gran parte di questo contributo.
9. A titolo esemplificativo potremmo ricordare alcuni macro-casi, riferiti a zone diverse dell’Italia, in cui le retoriche relative alla “tradi-zione”, all’“identità”, al “folklore”, fondendosi alla costruzione politica del marketing territoriale e turistico, hanno portato a nuove forme di utilizzo delle forme tradizionali: le dinamiche di “patrimonializzazione” del tarantismo nel Salento (cfr. Pizza G. 2004), l’inserimento del “canto a tenore” della Sardegna tra i “Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity” dell’UNESCO (cfr. macchiarella i. - Pilosu s. 2007), il complesso rapporto tra le dinamiche festive locali e i tentativi politici di ambire a forme istituzionalizzate di riconoscimento nazionale (Ministero per i Beni e le Attività culturali) e internazionale (UNESCO) nei casi umbri della Corsa dei Ceri di Gubbio e della Giostra della Quin-tana di Foligno (cfr. cirino P. 2012).
10. Cfr. Gri G. P. - zolDan c. 2007.11. Cit. sartori G. 1999: titolo.
Prima, però, appare fondamentale fornire un chiarimen-to sulle differenze esistenti tra il termine “lingua” e il termi-ne “linguaggio” che, assai di frequente, nella quotidianità, vengono adoperati, come sinonimi. In realtà i due termini rimandano a concetti assolutamente diversi sui quali in que-sta sede sarà bene far chiarezza.
La parola “linguaggio” fa riferimento alla comunicazione tout court, rimanda all’intera serie delle possibilità comuni-cative, verbali e non verbali, che possono essere riscontrate nel rapporto tra uomo e uomo, tra uomo e animale, tra uomo e natura, tra animale e animale, tra animale e natura; insom-ma, in qualunque luogo esista un qualsiasi tipo di comunica-zione, si può riscontrare la presenza di un linguaggio. Si può parlare quindi di linguaggio del corpo12, linguaggio degli animali13, linguaggio della natura14. In generale potremmo definire “linguaggio”, qualsiasi sistema di rappresentazioni simboliche comprese da un “destinatario” e generate da un “mittente”.
I modelli di linguaggio riportati possono essere adoperati singolarmente, ma anche simultaneamente, in diversi conte-sti: si pensi ad uno spettacolo teatrale in cui più forme co-municative si integrano nella composizione della scena per offrire il maggior numero di sensazioni possibili al pubblico. Nell’impiego dello stesso linguaggio verbale entrano in ballo fattori comunicativi legati ad altri modelli di linguaggio, che
12. Si pensi al linguaggio gestuale adoperato per la comunicazione con i sordomuti, alla mimica teatrale o, più semplicemente, alla comuni-cazione tra corpi che esiste nel rapporto sessuale.
13. Come è noto la capacità di parlare è esclusiva competenza dell’es-sere umano, ciò non significa che gli animali non comunichino tra loro o non comunichino con l’uomo attraverso diversi linguaggi.
14. Possono essere considerati linguaggio, non volontario ma comun-que comunicativo, anche i messaggi che uomini e animali percepiscono osservando la vegetazione, i venti, gli agenti atmosferici, l’ambiente ad essi circostante.
221Il gruppo folcloristico Agilla e TrasimenoDaniele Parbuono 220
possono risultare in accordo, in conflitto o anche indipen-denti rispetto ai significati letterali delle parole e delle frasi impiegate: la mimica, la maggiore o minore distanza, il lin-guaggio del corpo in generale.
Secondo lo svizzero Ferdinand de Saussure, considerato il padre della linguistica moderna, è importante, innanzi-tutto, fissare una differenza tra la lingua come particolare insieme organizzato di segni, socialmente riconosciuto e il linguaggio come facoltà generale di cui la lingua è prodot-to. Il problema centrale è chiarire quale rapporto esista tra lingua e natura. In questa ottica vanno gli studi che hanno come oggetto l’analisi delle interconnessioni tra il significan-te (sequenza fonica o grafica) e il significato ad esso correla-to; per esempio, la sequenza fonica “c-a-n-e” corrisponde al mammifero quadrupede che abbaia per convenzione, oppu-re perché questo rapporto è già dato in natura? Lo stesso de Saussure e gli studi linguistici della scuola strutturalista che dalle sue teorie hanno tratto spunto, concordano sul fatto che, come il rapporto tra il segno linguistico e il suo corri-spettivo fonema, il rapporto tra significante e significato è del tutto arbitrario15. Emerge, quindi, la dicotomia tra “lin-guaggio” come sistema di comunicazione ampio e “lingua” come codice definito, cosciente e arbitrariamente accettato, quindi possibile modello di linguaggio, ma non unico, né superiore agli altri, anzi, ad essi correlato.
Per “lingua” intendiamo, dunque, l’insieme delle con-venzioni necessarie per la comunicazione orale fra i singoli individui di una comunità. A partire dagli studi di de Saus-sure, Roman Jakobson – linguista russo che fondò, insieme a Vilem Mathesius, il circolo linguistico della Scuola di Pra-ga (Pražský Lingvistický Kroužek) –, definendo l’uso della lingua come atto comunicativo linguistico, ne individua sei elementi indispensabili per la realizzazione: un mittente (il
15. Cfr. saussure (De) F. 1967 [1916].
parlante); un destinatario (l’ascoltatore); il messaggio che si vuole trasmettere; un contesto (la realtà cui ci si riferisce); un contatto (canale di comunicazione: aria, fili del telefono, car-ta, ecc.); un codice conosciuto da mittente e destinatario16.
Per semplificare la questione potremmo portare qualche esempio: è corretto parlare di “linguaggio del corpo” ma non di “linguaggio italiano”, è corretto parlare di “lingua francese” ma non di “lingua musicale”, è corretto parlare di “linguaggio pittorico” ma non di “linguaggio latino” ecc..
A partire da questa distinzione possiamo procedere con cautela e, intanto, definire il canto, la danza e la musica po-polari come linguaggi che permettono agli stessi esecutori di comunicare tra loro e di comunicare con il mondo esterno. Investigando questi fenomeni come sistemi simbolici, attra-verso un’analisi semiotica, sarà possibile, poi, approfondire la conoscenza dei rapporti tra i significanti (in questo caso le forme coreutiche, le sequenze fonico-vocali e le strutture musicali) e i significati ad essi correlati (cioè la dimensione semantica a cui fanno riferimento). Antonino Buttitta nel 1975 scriveva:
Le ricerche antropologiche e le analisi semiologiche sulla musi-ca di tradizione orale sono spesso tenute distinte, oppure negli esempi migliori sono considerate cooconcorrenti. In entrambi i casi si tratta di ricerche parziali in quanto, come cercherò di di-mostrare, nella valutazione dei fatti musicali etnici le prospet-tive antropologiche e quelle semiologiche sono indissociabili. Ciò è dovuto alla particolare natura della comunicazione mu-sicale. Seguendo Jakobson noi dobbiamo prendere in carico, ai fini dell’analisi di ciascun fatto musicale in quanto atto di comunicazione, un messaggio, un mittente, un destinatario, un contesto, un codice, un contatto17.
16. Cfr. JaKoBson R. 1966 [1963].17. Cit. Buttitta a. 1975: 117.
223Il gruppo folcloristico Agilla e TrasimenoDaniele Parbuono 222
Proprio seguendo Roman Jakobson, attraverso l’analisi dei sei elementi che individua come indispensabili all’atto co-municativo, sarà possibile riflettere sulle funzioni delle arti popolari in esame, su come queste siano mutate nel tempo, accompagnandosi allo stesso mutamento delle società com-plesse.
La danza, il canto, la musica popolare, fino ai grandi mu-tamenti socio-economici del Novecento, hanno avuto un ruolo strettamente funzionale ai cicli agrari, ai cicli di vita, ai passaggi da uno stato esistenziale ad un altro18, alla vita stessa delle classi subalterne italiane:
[…] occorrerà anche tener presente la funzione pratica che il canto stesso ha nella vita di quei gruppi sociali in mezzo a cui è diffuso. […] il canto serve al popolo per uno scopo preciso, per un uso pratico: sia ninna-nanna o mattinata, chanson de toile o vòcero, canto carnascialesco o canzone di trincea, preghiera o scongiuro, il canto risponde ad una necessità vitale, serve per cullare o bloccare il bimbo, per fare la dichiarazione d’amore alla ragazza, per piangere, nel quadro delle cerimonie funebri, il fratello ucciso, il marito scomparso; serve per alleviare la fa-tica del telaio, per eccitare gli animi in un giorno di sfrenata baldoria, per non far sentire l’incubo dei bombardamenti o il morso della fame in trincea, per invocare l’assistenza divina, per ottenere la guarigione di una malattia. […] Adunque nei tre momenti essenziali dell’esistenza umana, nascita, matri-monio, morte, noi troviamo presso la tradizione popolare, la poesia congiunta alla vita, chiamata a una funzione specifica, adoperata con un preciso scopo. Altrettanto avviene nel corso dell’anno, col succedersi delle varie feste e usanze secondo il calendario: canti d’augurio e di questua per il Capodanno e la Befana, canti carnascialeschi, canzoni per il calendimaggio, per il Sangiovanni e per le altre più importanti feste stagionali e periodiche, insomma tutta quella produzione che si suol distin-guere col nome di “poesia folklorica”, è adoperata dal popolo
18. Cfr. van GenneP a. 1981 [1909].
come elemento costitutivo ineliminabile, dell’avvenimento cui si accompagna. […] Il canto per il popolo, è anche arte, ma è insieme, anche azione: perciò appare come una necessità in-derogabile, come un bisogno naturale, non come un semplice passatempo, o lusso […]19.
Parole simili a quelle che Paolo Toschi ha speso per descri-vere la funzione vitale che il canto ha avuto per le classi so-ciali subalterne fino alla metà del secolo scorso, potrebbero essere spese per descrivere le funzioni della danza: la “Pizzi-ca” e il suo fine terapeutico, la “Furlana”20 e il “Saltarello” legati al tema del corteggiamento, il “Trescone” e il periodo della battitura21, il “Ballo tondo” e la scansione dei cicli di vita in Sardegna22 ecc.. Più in generale si potrebbe definire la danza tradizionale come un mezzo adoperato dall’esecutore per comunicare le proprie sensazioni, le proprie frustrazio-ni, i propri sentimenti, attraverso un linguaggio non verbale, ma coreutico-gestuale. A tal proposito illuminante, per gli studi coreutico-demologici italiani, è stata l’opera scientifica di Ernesto de Martino23, culminata nella pubblicazione de La terra del rimorso24, lavoro complesso, frutto di una ricerca etnografica portata a temine, tra il 20 giugno e il 10 luglio 1959, grazie alla collaborazione di una équipe di specialisti: oltre a lui, Diego Carpitella musicologo, Letizia Comba psi-cologa, Vittoria de Palma assistente sociale, Giovanni Jervis
19. Cit. toschi P. 1947: 8-26.20. Per un approfondimento su questa danza si veda Dalla valle
m. - Pinna G. - tomBesi r. 1987.21. Per un approfondimento sulla danza del “Trescone” si vedano
nocentini a. 1991 e staro P. 1990.22. Per un approfondimento sul “Ballo tondo” si veda staro P. 1990;
in generale sul ballo sardo si vedano carta mantiGlia G. - tavera a. (a cura di) 1997; Gala G.m. (a cura di) 1998.
23. Per un approfondimento sull’opera scientifica e sui percorsi di Ernesto de Martino si veda Gallini c. (a cura di) 1986.
24. Cfr. De martino e. 1961.
225Il gruppo folcloristico Agilla e TrasimenoDaniele Parbuono 224
psichiatra, Franco Pinna fotografo, Annabella Rossi gior-nalista, Amalia Signorelli antropologa culturale25. Tema del libro è il fenomeno del “tarantismo”, studiato e descritto nei suoi aspetti terapeutico-rituali26, nella sua profondità diacro-nica, nella sua comparabilità con fenomeni simili diatopica-mente diffusi (de Martino studiò riti simili in Sardegna, in Spagna, in Africa centrale, fino ai riti voodoo dell’America latina), nella sua commistione sincretica con il culto catto-lico di San Paolo. De Martino si impegnò, in questa ottica, a dare una profondità spazio-temporale al “tarantismo”, al-trimenti soggetto al rischio della mitizzazione decontestua-lizzante che, a parer suo, avevano praticato i sociologi fran-cesi e gli struttural-funzionalisti britannici nello studio delle popolazioni colonizzate. Studiando capillarmente questo fenomeno popolare – fondendo in una nuova epistemologia etnologica il suo particolare storicismo, mediato attraverso l’analisi marxista, ad una notevole sensibilità umana forni-tagli dall’esperienza etnografica sviluppata “sul campo”, de Martino giunse a scoprirne il significato socio-culturale più profondo, che individuò nella capacità di “resistenza” del popolo alla pressione della classe dirigente e delle regole da essa dettate. “Tarantismo”, “magismo”, ritualità subalterne si configurano come una innata forza popolare di contrap-posizione; contrapposizione alla modernizzazione, contrap-posizione alla gestione politica egemone, “resistenza” ad una cultura non sentita come propria.
25. Per una guida sui materiali d’archivio inerenti la ricerca etnogra-fica sul tarantismo, condotta dall’équipe di studiosi diretta da Ernesto de Martino, si veda siGnorelli a. 1986.
26. Suddivise la danza della donna posseduta in due fasi: quella “oriz-zontale”, in cui la donna è sdraiata nell’immedesimazione col ragno che la possiede e quella “verticale”, in cui la donna, in piedi, danza scacciando la possessione e recuperando sé stessa. Da questo particolare si può evincere che de Martino interpretò il rito, non come una possessione, ma come un esorcismo coreutico-musicale.
Attraverso la contestualizzazione socio-culturale i feno-meni etno-coreutico-musicali possono essere compresi nella loro dimensione reale ed analizzati proprio come una for-ma particolare di comunicazione, come un linguaggio che, per tornare alle categorie di Jakobson, è necessariamente generato da un “mittente”, percepito da un “destinatario”, si adopera in un determinato “contesto”, è compreso da “mittente” e “destinatario” perché decifrato attraverso un “codice” condiviso, che si diffonde per mezzo di un canale (“contatto”) funzionale ed è portatore di un “messaggio” se-manticamente significativo.
Prendiamo come esempio i comportamenti e i canti di “incanata”, diffusi in molte regioni d’Italia, interpretabili come «comportamento rurale subalterno proprio dei pro-letari e dei sottoproletari della fascia bracciantile»27. Nella loro realizzazione tradizionale il “mittente” era il bracciante o il gruppo di braccianti al lavoro; il “messaggio” da tra-smettere era il disagio e la frustrazione per la fatica inumana del lavoro; il “contesto” era la società mezzadrile antece-dente alla meccanizzazione delle campagne, in particolare il periodo della mietitura del grano, nello specifico l’area geografica nella quale il comportamento o il canto erano ri-scontrabili; il “contatto” era l’aria attraverso la quale le onde sonore si diffondevano raggiungendo gli organi percettivi auricolari del “destinatario”, che poteva essere un passante, casuale bersaglio dello sfogo bracciantile o il padrone del podere. In questo caso, tra bracciante e padrone, il “canale” poteva cambiare dall’aria al contatto fisico, nei casi in cui l’“incanata” si trasformava in persecuzione rituale del supe-riore ad opera del subalterno. Il “codice” adoperato, condi-viso da “mittente” e “destinatario”, era il linguaggio verbale unito al linguaggio musicale nel caso dei canti di “incanata”
27. Per una approfondita conoscenza dell’“incanata” si veda Di nola a. m. 1983.
227Il gruppo folcloristico Agilla e TrasimenoDaniele Parbuono 226
e il linguaggio verbale unito al linguaggio gestuale-prossemi-co nel caso dei comportamenti di “incanata”.
Lo stesso approccio epistemologico potrebbe essere adoperato nello studio di qualsiasi forma d’arte popolare, analizzandola non come una forma culturale fine a sé stessa ma come una forma di comunicazione, tanto da scoprirne le connessioni con la società circostante:
L’importanza di ogni pratica culturale è proporzionale alla sua utilità sociale, utilità naturalmente non solo in senso immedia-tamente produttivo, ma nel più ampio senso dello sviluppo del pensiero umano28.
Analizzando un fenomeno etno-coreutico-musicale come un sistema simbolico comunicativo, come un linguaggio, sarà possibile distinguerne il piano del significante dal piano dei significati, la dimensione estetica dalla dimensione se-mantica. Ancora un esempio che potrebbe tornare utile: il “ritmo dei battipali” diffuso a Venezia29. Il “mittente” era il battipali o il gruppo dei battipali, il “destinatario” era il battipali o i battipali compagni di lavoro; il “contesto” era la laguna veneziana in un periodo antecedente alla meccaniz-zazione dell’edilizia; il “messaggio” era il coordinamento dei colpi del maglio sul palo da piantare, attraverso l’uso della ritmica del canto; il “contatto” era l’aria attraverso la quale si diffondevano le onde sonore del canto; il “codice” con-diviso era il linguaggio verbale unito al linguaggio ritmico-musicale. Aggiungere all’analisi testuale e musicale del canto popolare un’analisi di questo tipo, aiuta a metterne in luce le funzioni sociali, a far chiarezza sul contesto dal quale esso aveva origine. L’analisi del modello comunicativo amplia il campo di indagine, superando i limiti dell’analisi puramente
28. Cit. De mauro t. - liBerovici s. - natali P. - sitti r. 1977: 10.29. Per un approfondimento sul “Ritmo dei battipali” si vedano cor-
nolDi a. 1968 e leyDi r. 1973.
stilistico-formale e restituisce il fenomeno popolare alla sua dimensione di riferimento. A tal proposito sono significative le parole di Luigi Maria Lombardi Satriani:
[…] non si può non disconoscere la recente esigenza di non considerare più il canto soltanto come documento filologico-letterario, ma come testimonianza di una precisa condizione socio-culturale, come spia significativa di un ambito storico-politico da individuare esattamente per cui si potrebbe soste-nere che all’estetica del canto popolare cui aveva tentato di abi-tuarci una certa impostazione oscillante tra valenze romantiche e valenze positivistiche […] si sia andato sostituendo sempre più saldamente una sociologia del canto popolare, di indubbia rilevanza culturale e politica30.
Anche la danza, dunque, può essere analizzata come una forma di comunicazione funzionale e studiata31, seguendo l’approccio semiotico, nelle connessioni tra il significante coreutico e i relativi significati. Attraverso la danza, facendo uso del linguaggio fisico-gestuale, l’operatore tradizionale poteva comunicare i propri stati d’animo, sfogare i propri istinti ma anche corteggiare, tentare di stabilire un contatto con altre dimensioni, cercare il buon auspicio degli astri o delle divinità, per il raccolto o per la buona salute. Concre-tamente prenderemo ad esempio il “Saltarello”32, danza di corteggiamento diffusa nell’Italia Centrale. Il “mittente” di questa forma comunicativa era il ballerino, maschio o fem-mina, a seconda delle fasi del ballo; il “destinatario” era il secondo ballerino coinvolto, maschio o femmina, a seconda delle fasi del ballo; il “contesto” era la società mezzadrile anteriore alla modernizzazione, in particolare le sere di fe-
30. Cit. De mauro t. - liBerovici s. - natali P. - sitti r. 1977: 57.31. Placida Staro parla di «linguaggio della danza», cit. staro P.
1990: 213-214. 32. Per un approfondimento sulla danza del “Saltarello” si vedano
Gala G.M. (a cura di) 1993, PalomBini G. 1991 e ParBuono D. 2006.
229Il gruppo folcloristico Agilla e TrasimenoDaniele Parbuono 228
ste calendariali o legate al ciclo agrario; il “messaggio” era il corteggiamento, tentare di conquistare la persona dell’al-tro sesso attraverso lo sfoggio del virtuosismo nel ballo; il “contatto” era lo spazio tridimensionale in cui il ballo veniva eseguito; il “codice” era il linguaggio coreutico unito ai lin-guaggi mimico-gestuale, prossemico, musicale e, nel caso del “Saltarello” cantato, verbale.
Proprio la funzione comunicativa, quindi sociale, di un fenomeno coreutico-musicale popolare, ne garantiva la so-pravvivenza stessa. In una dimensione in cui l’“utile” – in-teso non secondo l’accezione capitalistica, ma secondo l’ac-cezione popolare (utile è ciò che si usa) – ha, per evidenti motivazioni socio-economiche, una posizione predominate rispetto all’“estetico”, ciò che non risulta funzionale alla vita stessa, risulta superfluo, quindi non più utilizzabile. Per que-sta ragione, la società di riferimento, accettava o non accet-tava come proprio un fenomeno culturale, assicurandone o meno la diffusione. A tal proposito Bogatyrëv e Jakobson parlano di «censura preventiva della comunità»:
Insomma nel folclore si conservano solo quelle forme che sono funzionali per una data comunità. E naturalmente una certa funzione formale può essere soppiantata da un’altra; ma non appena una forma cessa di essere funzionale, essa muore […]. […] appare chiaramente che l’esistenza di un’opera di folclore non può non presupporre un gruppo sociale che l’accolga e la sanzioni. Nelle ricerche folcloriche non bisogna mai perdere di vista il principio fondamentale della “censura preventiva della comunità”33.
La funzione del fenomeno culturale popolare si modifica di pari passo con la stessa società che lo accoglie e lo rende proprio, si evolve con l’evolversi dei suoi membri, ne san-cisce il pensiero, le fatiche, le gioie e i dolori. Ma quando
33. Cit. BoGatyrëv P. - JaKoBson r. 1967 [1929]: 226.
un modello socio-economico-culturale, che per centinaia di anni si è mosso lentamente, a passi impercettibili, nell’ar-co di pochi decenni, muta totalmente la sua struttura, cosa succede? Succede che un immane bagaglio di esperienze e di produzione popolare perde la sua abituale funzione e «muore», succede che altri prodotti culturali soppiantano, lentamente, ma inesorabilmente, i modelli precedenti, dai quali al massimo i nuovi traggono spunto. Questo è acca-duto in Italia con la meccanizzazione delle campagne, con la meccanizzazione del lavoro, con la fine della mezzadria. Ciò non significa che insieme a questo modello economico-produttivo sia finita anche la cultura popolare, la quale, di pari passo al netto cambiamento sociale, si è modificata sot-to la forza di una rinnovata e “modernizzata” censura collet-tiva. Così come si trasforma il modello socio-economico, si trasforma il modello culturale ad esso legato. Bruno Pianta, a tal proposito, parla della produzione folclorica «in termi-ni di deliberati atti creativi (remakes letterari) rivolti ad una captatio benevolentiae da parte della collettività sancente»34.
La modernizzazione del secolo scorso ha portato ad un bivio netto e facilmente individuabile, proprio perché emerso in un ristretto lasso di tempo: da una parte le nuo-ve forme d’arte popolare, non più necessariamente legate ai cicli agrari, alle feste calendariali, non più strettamente funzionali al lavoro, al corteggiamento, ai passaggi da uno stato esistenziale all’altro, alla vita o alla morte; dall’altra il desiderio di conservare e riproporre il repertorio tradiziona-le defunzionalizzato. Dalle nuove classi sociali subalterne, operaie inurbate, proletarie e sottoproletarie, sono veicolati nuovi stili musicali e canori (dalla “Canzone all’italiana”, alla “Canzone d’autore”, dalla “Musica leggera”, alla più recen-te diffusione del “Bit”, del “Pop”, del “Rock”, del “Blues”, dello “Ska”, fino ad arrivare ai contemporanei movimenti
34. Cit Pianta B. 1987: p. 13.
231Il gruppo folcloristico Agilla e TrasimenoDaniele Parbuono 230
legati alla “Word music”) nuove famiglie di balli (la “Polka” e il “Valzer” da balera, il “Fox trot”, il “Tango”, i balli di gruppo degli anni Sessanta e, più recentemente, i “Latino-americani”). Contemporaneamente, a partire dal secondo dopoguerra, ha avuto luogo un proliferare significativo di associazioni, più o meno amatoriali, che si sono prefisse di conservare e riproporre il repertorio etno-coreutico-musica-le tradizional-popolare; la seconda strada del bivio è, appun-to, quella percorsa dai gruppi folcloristici, l’opera dei quali sarà presa in esame nel seguito di questo contributo.
A tal proposito si rende necessaria, una prima analisi del-le due parole maggiormente adoperate nel descrivere l’at-tività di queste associazioni: “conservare” e “ri-proporre”.
L’intenzione nobile di ogni gruppo folcloristico italiano è strettamente connessa alla pratica della conservazione del repertorio tradizionale legato alla propria zona di provenien-za. La conservazione di un fenomeno di tipo tradizional-po-polare, senza entrare nel merito della correttezza epistemo-logica sulla quale si basa il lavoro dei gruppi folcloristici, può essere analizzata e interpretata secondo punti di vista differenti: da una parte permette di non lasciare all’oblio del tempo fenomeni culturali altrimenti destinati ad eclissarsi, dall’altra immobilizza ciò che per sua natura si modifica, imbalsama e mette in teca l’oggetto culturale, in una ope-razione “museificatrice” che lo rende natura morta. Nella stessa area semantica del verbo “conservare” trova posto la terza parola di cui spesso si abusa nel descrivere l’opera dei gruppi folcloristici: “autenticità”. Si sente parlare di “danza autentica”, “canto autentico”, “costume autentico”, come a voler giustificare il proprio operato, cercando riparo in una dimensione del giusto che rimanda ad una purezza ancestra-le, mitica, divina. Scrive a tal proposito Marco Aime:
Danze non autentiche, quindi? Se è così occorre allora fissare un punto nel passato, a partire dal quale sarebbe avvenuta la
rottura di una tradizione preservatasi fino a quel momento in-tatta. […] tende a prevalere una concezione dell’autenticità, secondo cui è vero ciò che segue la tradizione, ciò che è sem-pre stato così. L’autenticità comporta un senso di confine tra diverse serie di regole e convenzioni; si è inclini a pensare che è autentico ciò che è “naturale”, come se ci fosse qualcosa di preesistente alla nostra capacità di attribuire o meno l’etichetta di genuinità. Se pensiamo che è “autentico” ciò che è “natura-le” e quindi vero, ne consegue che quanto è falso è per forza innaturale. E se “vero” significa antico, “nuovo” deve necessa-riamente coincidere con “falso”. In realtà però non c’è nulla di infinitamente antico: la conoscenza e la verità sono “create” e non scoperte dalla mente umana; noi entriamo nella società in un certo momento, ma la cultura è un processo sempre vivo. […] La questione dell’autenticità ruota attorno a un presup-posto che […] non sembra mai essere messo in discussione: che cioè esista una sorta di grado zero dell’autenticità di una cultura, superato il quale iniziano le contaminazioni, con la conseguente perdita dell’autenticità stessa35.
L’“autenticità” come alibi euristico, mistifica l’importan-za della seconda operazione che i gruppi folcloristici pre-sentano come propria, la “ri-proposizione” del repertorio tradizionale e ne adombra l’utilità comunicativa. Facendo riferimento alla categoria dell’“autentico”, l’operatore che “ri-propone”, corre il rischio di presentare al destinatario del suo messaggio un fenomeno culturale statico come un modello di pseudo-purezza non corrotta dalla modernità. “Ri-proposti” in questo senso i significanti delle manifesta-zioni etno-coreutico-musicali tradizionali corrono il rischio di assumere significati travianti e incomprensibili ai fini della comunicazione. Sarebbe utile farsi forti della consapevolez-za che da un lato l’opera dei gruppi folcloristici ha spostato il piano dell’azione artistico-popolare «dal rito al teatro»36,
35. Cit. aime m. 2005: 117-127.36. Cit. turner v. 1986 [1982]: titolo.
233Il gruppo folcloristico Agilla e TrasimenoDaniele Parbuono 232
dall’altro, l’atto del “ri-proporre” mantiene una sua dignità proprio in funzione del fatto che fornisce sia al “mittente” sia al “destinatario” un prodotto culturale nuovo, evolutosi seguendo i cambiamenti delle categorie di “spazio” e “tem-po”: «riproduzione non significa accettazione passiva»37. L’aspetto fuorviante della “ri-proposizione”, qualora esso si manifesti, è proprio l’errore metodologico di trattare la materia folclorica come oggetto inerte ed immobile. Tale fraintendimento nasce già nell’errata concezione del termine “conservare”, interpretato soltanto come ‘rendere intocca-bile’. Il fenomeno artistico popolare in questo senso, si al-lontana definitivamente dalla sua natura e, dopo aver perso la sua funzione sociale tradizionale, legata ai cicli agrari, alle feste calendariali, al corteggiamento ecc., perde definitiva-mente anche la sua funzione comunicativa, separandosi del tutto dalla vita dei suoi nuovi “mittenti” e dei suoi nuovi “destinatari”.
Incidentalmente, dal nostro discorso ci pare risulti anche illu-sorio il convincimento […] di alcuni sostenitori del folk-revival che basta ripetere fedelmente i canti popolari per conservarne lo “spirito”. È chiaro infatti […] che ogni qualvolta è diverso rispetto a quello originario il contesto della loro fruizione, ne risultano radicalmente stravolti il significato e il senso38.
Le categorie adoperate da Antonino Buttitta riportano la riflessione sull’operazione del “ri-proporre” all’analisi se-miotica dei significanti e dei significati, trascinano l’oggetto culturale popolare in una nuova dimensione comunicativa in cui l’oggetto stesso risulta ri-funzionalizzato e impiega-to in un rinnovato “contesto”, da un diverso “mittente”, da un diverso “destinatario”, attraverso “codici” e “contatti” trasformati, per veicolare nuovi “messaggi”. Là dove nell’e-
37. Cit. BoGatyrëv P. - JaKoBson r. 1967 [1929]: 231.38. Cit. Buttitta a. 1975: 120.
secuzione tradizionale del fenomeno etno-coreutico-musi-cale il “mittente” era il bracciante/battipali/mezzadro, per riprendere gli esempi sopraccitati, nei gruppi folcloristici si ha il ballerino, a volte amatore a volte professionista; là dove il “destinatario” era il passante casuale (o padrone)/battipa-li compagno di lavoro/partner da corteggiare, ora si ha un pubblico; là dove il “contesto” era la campagna mezzadrile o la laguna in un periodo anteriore alla meccanizzazione, ora è la festa di piazza in cui per il gruppo è stato allestito un palcoscenico o il ristorante che organizza una presentazione di prodotti “tipici”, alternando “assaggini” a balli e canti in costume; là dove il “contatto” era l’aria o lo spazio tridi-mensionale del ballo, ora è l’aria in cui si diffonde la voce amplificata dai microfoni o lo spazio circoscritto del palco. Anche i “codici”, che apparentemente potrebbero sembrare rimasti intatti, in realtà sono profondamente cambiati. Spes-so è assai cambiata la tecnica di esecuzione musicale; i brani sono “ri-proposti” da musicisti con una cultura musicale dif-ferente da quella tradizionale, che quasi mai improvvisano o giustappongono schemi da loro conosciuti39, intersecandoli al ballo o al canto. Diverso è il linguaggio coreutico-gestua-le adoperato, ora, da ballerini, a volte atleti, che provano i movimenti centinaia di volte, curando la simmetria delle coreografie. Diverso è anche il linguaggio verbale del canto: la leva obbligatoria, l’innalzamento degli obblighi scolastici e la capillare diffusione dei televisori, il sensibile aumento della cultura media, ma anche l’introduzione di un gran nu-mero di “esterismi”, l’avvento della «lingua tecnologica»40,
39. Interessante, in tal senso, è ricordare la tecnica “caleidoscopica” di cui parla da Giovanni Giuriati per descrivere la Tarantella di Montemara-no (cfr. Giuriati G. 1982).
40. Pier Paolo Pasolini nell’intervento a una conferenza, poi pubblica-to in “Rinascita” del 16 dicembre 1964, con il titolo Nuove questioni lin-guistiche, portò la riflessione scientifica a una nuova fase della “questione della lingua”. Introducendo la categoria di «lingua tecnologica», attraver-
235Il gruppo folcloristico Agilla e TrasimenoDaniele Parbuono 234
hanno partecipato all’aumento della conoscenza media della lingua italiana, alla mutazione delle sue strutture ma, allo stesso tempo hanno agito sulle capacità fono-articolatorie dei parlanti, trasformando i dialettofoni in semi-italofoni o italofoni e molti dialetti rurali in dialetti regionali o italiani regionali41. Il verso «Se mé déte ‘na sargìccia» di un canto registrato da Diego Carpitella e Tullio Seppilli il 26 gennaio 1958 a Santa Lucia di Stroncone (Tr)42, pronunciato dal cantante non specialista di un gruppo folcloristico nel 2007, potrebbe, con buona probabilità, diventare “Se mé déte ‘na salcìccia” o “Se mé date ‘na salsiccia”, potrebbe cioè perdere quei fenomeni caratterizzanti il dialetto rurale, come l’assi-milazione regressiva a distanza di “é”, il rotacismo di “l” o la sonorizzazione dell’affricata alveo-palatale sorda, per essere pronunciato come italiano regionale43.
Sicuramente differente risulta il “messaggio” trasmesso. Il fenomeno artistico popolare “ri-proposto” perde la sua tradizionale funzione comunicativa per assumere accezioni
so un’analisi di tipo marxista-gramsciano, individuò nell’industrializzato Settentrione il nuovo centro di irradiazione della lingua italiana unitaria che, grazie all’azione di una classe borghese egemone, si stava imponendo, in maniera omogenea, sulle classi sociali subalterne. Per un approfondi-mento su questo tema si veda Pasolini P. P. 1972.
41. In generale, su queste tematiche, si vedano BanFi e. - sorBero a. a. (a cura di) 1992, Bruni F. (a cura di) 1992, canePari l. 1980, carDona G. r. 1974, cortelazzo m. a. - mioni a. m. (a cura di) 1990, De mauro t. 1972 [1973], De mauro t. 1973, De mauro t. - loDi m. 1993 [1979], Devoto G. 1974, Grassi c. - sorBero a. a. - telmon t. 2003, marazzini c. 1994, renzi l. - cortelazzo m. a. (a cura di) 1977, serianni l. - tri-Fone P. 1994.
42. Tratto da PalomBini G. 2005: 41.43. Per uno studio approfondito sui dialetti dell’Umbria si vedano
Bruschi r. 1980, Bruschi r. 1983, catanelli l. 1995, mancini F. 1960, mattesini e. - uGoccioni n. 1992, mattesini e. 2004, moretti G. 1973, moretti G. 1987, ParBuono D. 2011b, Pasquini D. 1993, rosa e. 1907; santucci F. 1984-1991; silvestrini m. 1983; uGolini F. a. 1970; uGolini F. a. (a cura di) 1977.
semantiche condivise dai nuovi “mittenti” e dai nuovi “de-stinatari”, nel nuovo “contesto”, attraverso nuovi “codici” e nuovi “contatti”. I nuovi linguaggi di cui sono portatori i gruppi folcloristici parlano di rapporto tra pubblico ed ese-cutore, di rapporto amicale tra gli esecutori professionali, di aggregazione sociale all’interno delle stesse associazioni, parlano di nuove condizioni sociali e di nuove condizioni lavorative, di nuovi valori, nuovi problemi e nuove felicità. Paradossalmente i gruppi folcloristici, inscenando lo “spet-tacolo del folklore”, comunicano avvalendosi di “codici”, “canali” e “messaggi” non più ascrivibili al campo semantico tradizionale della parola folklore, producendo nuove forme comunicative, celate dietro la “ri-proposizione”, più o meno valida, dei fenomeni popolari. Parlando del folklore stesso, generano una nuova dimensione di “meta-folklore” che non è affatto folklore, nell’accezione più diffusa del termine (cul-tura tradizionale), ma folklore nell’accezione etimologica del termine: folk-lore, ‘dottrina del popolo’, il popolo dell’anno 2007.
Solo a una condizione la poesia orale non rientra più, per sua stessa natura, nel campo del folclore e non rappresenta più una creazione collettiva: nel caso cioè che una compagnia di professionisti ben coordinata e dotata di una salda tradizione professionale prenda di fronte a determinati prodotti poetici un atteggiamento di ossequio inteso a cercare in tutti i modi di conservarli immutati44.
I gruppi folcloristici, «musica in testa […] entrano nel XXI secolo con i loro vestiti della domenica, garanti insieme del-la continuità e dello spettacolo»45, partecipando, allo stes-so tempo, della tradizione e della “ri-proposizione”, della cultura e della performance, del profitto e dell’aggregazione,
44. Cit. BoGatyrëv P. - JaKoBson r. 1967 : 237.45. Cit. auGé m. 1999: 56.
Daniele Parbuono 236
della promozione territoriale e dell’identità sociale, della go-liardia e della cultura.
Messa in luce la sfasatura tra ieri e oggi, può nascere la voglia di “riprendersi la parola” riscoprire il proprio linguaggio […]. Un linguaggio, però, forse non uguale a quello di ieri: molte cose sono cambiate a livello economico e di rapporti sociali […]. Bisogna fare i conti proprio con quelle realtà […] in cui […] si sono creati nuovi momenti di aggregazione, di partecipazione e produzione politica e culturale di base, bisogna far i conti con le esigenze di oggi, che sono diverse da quelle di ieri. Si tratta di scoprire, attraverso la ricerca collettiva, la partecipazione e il rapporto con il passato, i nuovi linguaggi di oggi, innestati, però, su tutto il patrimonio culturale delle classi subalterne46.
L’interrogativo sul quale ci si dovrebbe soffermare non è tan-to legato alla maggiore o minore “autenticità” del materiale conservato e “ri-proposto”, quanto alla possibile efficacia di questi nuovi orizzonti comunicativi: i nuovi linguaggi attra-verso i quali comunicano i gruppi folcloristici sono ancora efficaci? Lo saranno in futuro? Cosa hanno ancora da dire il canto, la musica e la danza popolari? Di quali forme comu-nicative possono ancora essere portatori? Quali sono, oggi, le funzioni delle arti etnomusicali ed etnocoreutiche? Quali gli esecutori, quali i destinatari?
Queste domande dimostrano, ora più che mai, tutto il loro peso sociale, epistemologico e culturale.
46. Si riporta un frammento dell’intervento di Giuliano Scambia inse-rito in De mauro t. - liBerovici s. - natali P. - sitti r. 1977: 173.
Daniele ParBuono
Il gruppo folcloristico di Castelraimondo:la storia, l’attività, le voci1
Il nostro numeroso e allegro Gruppo Folkloristico prima e dopo l’ultima guerra si è esibi-to in molte città d’Italia, e in qualcuna all’estero, raccoglien-do ovunque i meritati applausi. Sempre pronto a partire, accetta ogni invito e si reca volentieri a rappresentare le nostre zone con gli sgargianti antichi costumi, con i canti dialettali e specie col ballo del vispo Saltarello. Recentemen-te è stato anche a Roma, dove fu ospitato nel Castel S. Angelo, presenti Alte Personalità, facen-dosi tanto onore che si disse: “Castelraimondo ha conquistato Castel S. Angelo” 2.
Raccontare oggi la storia, una parte della storia o meglio la genealogia3 della percezione contemporanea di alcuni
degli aspetti caratterizzanti l’attività di un gruppo folcloristi-
1. Questo saggio è già stato pubblicato in moriconi P. (a cura di) 2001 con il medesimo titolo (cfr. ParBuono D. 2011a).
2. Cit. GaGGiotti G. 1986: 138. 3. Si fa esplicito riferimento all’approccio genealogico che Michel
Foucault contrappone al classico approccio storico, ponendo l’attenzione sul concetto di “discontinuità” piuttosto che su quello di “continuità”. Cfr., per es., Foucault m. 1980 [1961], Foucault m. 1978 [1976], Fou-cault m. 1994 [1984], Foucault m. 1996 [1984].
239Il gruppo folcloristico di CastelraimondoDaniele Parbuono 238
co, che sia quello di Castelraimondo, come in questo caso o che sia quello di qualsiasi altro piccolo paese d’Italia, vuol dire rendere conto dell’intreccio complesso e articolato che negli anni si istaura tra una comunità specifica, quella defi-nita intorno al gruppo stesso, sempre mutevole, dinamica, progressiva e la comunità più ampia che si riconosce nel-le vicende passate e presenti del luogo di riferimento, co-struendo attraverso di esse sentimenti di appartenenza, le-gami, affezioni, orgoglio, nostalgie. Il racconto delle vicende che riguardano una comunità o una comunità di comunità, non può prescindere però dall’attenzione al particolare delle memorie e delle narrazioni dei soggetti che queste comu-nità compongono e che in alcuni casi hanno rappresentato collanti importanti tra le diverse articolazioni della vita col-lettiva, a livello amicale, sentimentale, ma anche associativo, politico, istituzionale. In questa prospettiva si può pensare alla vita di un gruppo folcloristico come alla componente attiva e partecipe, non tanto delle dinamiche di tutela e di conservazione di pratiche “autentiche” riferite a una stagio-ne passata ormai superata, quindi da imballare e proteggere in naftalina per poi tirare fuori come si fa con un “vestito buono” nel giorno della festa, quanto della costruzione nel contemporaneo di un rapporto, sempre rinnovato e comun-que stretto, tra i soggetti e il luogo di riferimento, con le sue “storie minori” così come con le sue apologie rispetto alle ambizioni di centralità nei processi politico-economici micro e macro, con i suoi trascorsi illustri così come con il ricordo delle sofferenze subalterne, con i suoi patrimoni storico-artistici così come con i suoi patrimoni demoantro-pologici materiali e immateriali, con il suo passato così come con il suo presente4. In questo senso le pratiche folcloris-
4. Daniele Jalla, nella presentazione della traduzione italiana di Le radici del futuro, testo che raccoglie le esperienze teoriche e pratiche del quarantennale operato di Hugues de Varine, ci offre una sintetica descri-
tiche «“Géo-indicateurs” tout à la fois des sentiments d’ap-partenances, des perceptions et des dynamiques territoriales, elles constituent également un agent susceptible de modifier les rapports affectifs au territoire5», di definirlo e ridefinirlo come pratica del presente e non come retorica del passato.
Rispetto a questo tipo di impostazione, a questa pro-spettiva di analisi del folclorismo in Italia, ancora poco si è lavorato; per riprendere le parole di Cristina Papa, «Il di-battito antropologico ed etnomusicologico si è, infatti, per lo più rivolto con accenti negativi ai modi con cui da molti di questi gruppi viene utilizzata la cultura popolare. Ne è stata messa in evidenza la tendenza alla spettacolarizzazione, a una riproposizione filologicamente non sempre avvertita e a una manipolazione dilettantesca non sufficientemente consapevole delle fonti […]. L’attenzione degli antropologi si è rivolta, finora, soprattutto alla produzione, alla trasmis-sione, alla riproposizione culturale piuttosto che ai contesti e ai soggetti»6. Il dibattito contemporaneo evidenzia inve-ce la necessità di guardare queste particolari associazioni di «[…] militanti locali del patrimonio»7 tenendo conto da un lato del fatto che le finalità, nonché i presupposti sottesi alla loro attività sono anche e soprattutto di carattere sociale, ag-gregativo – io stesso ho più volte definito i gruppi folclori-stici «[…] “agenti di coesione sociale”»8, tenendo presente
zione di come, a suo parere, dovrebbe essere rivisto il concetto di “museo diffuso”, assolutamente calzante anche rispetto alle esigenze del nostro ragionamento: «[…] una logica operativa e una proposta organizzativa: per integrare la tutela con la valorizzazione, per trasformarla così da pas-siva in attiva, per non limitarsi più solo a vietare ma per individuare crea-tivamente i modi, non solo per conservare ma anche per “utilizzare” […] il patrimonio culturale assicurandone, sì, la protezione e l’integrità, ma soprattutto un’effettiva vitalità», cit. Jalla D. 2005: IX.
5. Cit. Guiu c. 2007: 52. 6. Cit. PaPa c. 2007: 18. 7. Cit. De varine h. 2005 [2002]: 22.8. Cit. ParBuono D. 2009: 37.
241Il gruppo folcloristico di CastelraimondoDaniele Parbuono 240
che in molti contesti proprio all’interno dei gruppi possono innescarsi anche fenomeni di forte tensione, ciò comun-que non fa altro che confermare la pertinenza del livello di analisi –, dall’altro che l’ambizione di rifarsi a una qualche presunta forma di tradizione va necessariamente collocata nelle dinamiche del presente. La “tradizione” alla quale i gruppi folcloristici, così come il gruppo di Castelraimondo, si riferiscono è, quindi, una tradizione dell’oggi costruita su spaccati di vita, elementi, pratiche, narrazioni del passato che divengono forme di autoriconoscimento e, al contempo, strategie di autopresentazione del soggetto, della micro-co-munità (il gruppo) e della comunità di comunità (il paese), del territorio.
In cosa consiste, dunque, la tradizione? Non è un prodotto del passato, un’opera di un altro tempo che i contemporanei rice-verebbero passivamente, quanto […] un “punto di vista” che gli uomini del presente sviluppano su ciò che li ha preceduti, una interpretazione del passato condotta in funzione di criteri rigorosamente contemporanei. […] In questa accezione la tra-dizione non è ciò che è sempre stato, ma ciò che la si fa essere. Di conseguenza, l’itinerario da seguire per chiarirne la genesi percorre non il tragitto che va dal passato al presente, ma il cammino con il quale ogni gruppo umano costituisce la sua tra-dizione: e cioè dal presente verso il passato. […] La tradizione istituisce una “filiazione inversa”: non sono i padri a generare i figli, ma i figli che generano i propri padri, non è il passato a produrre il presente, ma il presente che modella il passato. La tradizione è un processo di riconoscimento di paternità9.
Per questa ragione, allora, vale la pena oggi raccontare il gruppo folcloristico di Castelraimondo, baypassando la retorica dei lustri campanilistici – e forse è per questo che a scriverne è stato chiamato un antropologo che proviene da un altro luogo – per guardare alla storia degli ultimi ot-
9. Cit. lencluD G. 2001 [1987]: 131.
tant’anni di paese, in occasione della ricorrenza del sette-centenario della fondazione, immaginando in queste poche pagine, l’esperienza, il sentimento e il pensiero di chi in tutti questi anni ne ha fatto parte e di chi ancora oggi decide che ballare il salterello o cantare uno stornello possa essere uno dei modi possibili per “stare al mondo”, per giocare la pro-pria partita del presente:
Ogni generazione ha avuto di certo delle motivazioni materiali: poter viaggiare, frequentare un ambiente festoso in cui è garan-tita la presenza di entrambi i sessi, poter godere della notorietà data da un passaggio televisivo. Ma chi intraprende un’attività del genere ha bisogno di una motivazione interiore più profon-da. Indossare un costume implica comunque una rif1essione su sé stessi10.
Si tratta quindi di provare a «[…] comprendre comment les acteurs locaux s’approprient et négocient les valeurs assignées aux manifestations “traditionnelles”»11, di capire come questi si innestano nella vita delle persone, nelle dinamiche di co-esione e tensione associativa che si intrecciano con le forme di riappropriazione del territorio, della sua profondità dia-cronica e sincronica12, ma anche con le vicende personali dei componenti con le loro potenzialità, con i loro limiti.
10. Cit. calzia F. 2005: 571.11. Cit. Guiu c. 2007 : 40. 12. In questo senso è forse utile rifarsi alla nozione di “iperluogo”
che secondo Berardino Palumbo definisce come «[…] il carattere com-posito, articolato, stratificato di uno spazio sociale. Iperluogo come luogo di luoghi […] in cui gli abitanti non paiono affatto presi in un processo, sur o post moderno, in ogni caso ipotizzato come lineare, di accelerazione incontrollabile della storia [ma] abili protagonisti di un gioco complesso, nel quale i rapporti di storia, memoria, racconto, oggetti, identità e agency sono resi operativi da specifiche politiche dello spazio/tempo, diverse tan-to da quelle di una modernità del disincanto, quanto da quelle a-centrate, de o pluri-localizzate di una postmodernità planetaria, quanto, infine, da una supposta strutturalità di una ideale condizione pre-moderna. Un
243Il gruppo folcloristico di CastelraimondoDaniele Parbuono 242
Una storia di vita che ci racconta al contempo un pezzo importante della storia del gruppo folcloristico di Castelrai-mondo è sicuramente quella di Ennio Carolini, recentemen-te scomparso, che ho avuto modo di intervistare all’interno della sua casa di Castelraimondo, nel marzo del 2011. Nato nel 1921 a Pollenza (Mc), entrò in contatto con il gruppo folcloristico fin dalla metà degli anni Trenta del Novecen-to invitato dal maestro Enzo Vinicio Biondi – altra figura centrale nella genesi e nello sviluppo delle attività legate al gruppo – come emerge dal suo stesso racconto:
E.C.: io ho cominciato nel 1936 a Cerreto […] quando hanno fatto la Festa dell’uva e quella festa m’è piaciuta molto per-ché mi sono divertito un mondo
D.P.: ma lei che faceva? E.C.: io niente… io suonavo la fisarmonica… allora c’era il ma-
estro Biondi lui mi ci portò la prima volta… allora c’èra anche mio padre… io sono sempre stato molto contento e anche mio padre si è divertito molto lassù
[…]D.P.: ma lei già suonava bene nel 1936 anche se era giovane?E.C.: bè… oddio suonavo la fisarmonica a bottoni… a semi-
tono D.P.: l’organetto?E.C.: si l’organetto… lo chiamano organetto ma semitonato…
ho suonato quello per tre anni dopo il maestro Biondi ha detto che quello per me non andava bene e m’ha fatto com-prare l’organetto a piano… di suonare l’organetto dopo ho smesso… ho suonato fino a circa tre anni fa
gioco nel quale alla continua, incorporata e insieme strategica, manipo-lazione di oggetti e segni del passato, si lega un’incessante produzione di senso e di trame sociali fondate sul conflitto, la lotta, la segmentazione e la scissione. Un iperluogo nel quale, al di sotto delle icone immobilizzanti prodotte dai diversi processi di mercipatrimonializzazione in atto nei di-versi “luoghi” del mondo attuale, non è certo difficile, per uno sguardo etnografico, vedere pulsare il magma vitale di una socialità aggressiva e iridescente», cit. PalumBo B. 2006: 46-47.
D.P.: ha suonato per settant’anni? E.C.: settanta no ma vedrai… dal 1936 al 2007 anche 2008…
quasi che per la festa dei ceri ancora mi chiamavano e avevo ottantasei o ottantasette anni… adesso ne ho quasi novan-ta13
La vita di Ennio scorre lungo tutto il secondo cinquantennio del Novecento di pari passo con le attività del gruppo folclo-ristico. Ciò che vale la pena esplicitare è la sua caratteristica fisica più evidente, la cecità, che se da una parte può aver limitato le possibilità professionali, sociali, di vita di Ennio, dall’altra lo ha stimolato a dedicarsi fino a che le forze glielo hanno permesso alla musica, passione coltivata a tempo pie-no con impegno, con passione, con sacrificio:
E.C.: tante ne ho imparate… guardi che io so suonare cinque-mila e più canzoni… ma quelle che ho imparato stanno tut-te in cassetta… sono cinquemilaquattrocento
La passione per la musica mescolata al desiderio di condurre uno stile di vita simile ai suoi coetanei, alla necessità di tes-sere relazioni, di creare legami con la comunità, nonostante quella che lui definisce “la mia condizione”, lo legano forte-mente al gruppo folcloristico che vede nascere e rinascere più e più volte; gruppo folcloristico che in qualche modo deve guadagnarsi insieme alla emancipazione rispetto all’ap-
13. Le due interviste più volte citate in questo saggio – la prima a Ennio Carolini, dalla quale è tratto questo frammento, la seconda a Luca Barbini e Carlo Lesti – sono state da me effettuate il 19 marzo 2011 a Castelraimondo (Mc). Le lettere puntate all’inizio di ogni capoverso sono le iniziali del nome e del cognome delle persone che hanno preso parte alle interviste e cioè: E.C., Ennio Carolini, 1921, nato a Pollenza (Mc) e vissuto a Casteraimondo (Mc), pensionato; L.B., Luca Barbini, 1959, Castelraimondo (Mc), insegnante; C.L., Carlo Lesti, 1930, nato a San Se-verino (Mc) e vissuto a Castelraimondo (Mc), pensionato-ex insegnante; D.P., Daniele Parbuono.
245Il gruppo folcloristico di CastelraimondoDaniele Parbuono 244
prensione dei familiari, rispetto anche al pregiudizio nei confronti di una malattia, sì invalidante, ma non al punto di escluderlo completamente dalla vita comunitaria:
E.C.: sì… andavamo in treno… mio padre non è che gli pia-ceva perché siccome io sono in queste condizioni allora gli dispiaceva mandarmi con altre persone… ma io un po’ in-sistevo e dopo qualcosa ottenevo perché a me mi piaceva proprio… mi piaceva perché io ci tenevo ad andarci… mio padre diceva non è per te tu sei così… ma dopo a forza di parlare si otteneva qualcosa
La “condizione” della quale lo stesso Ennio parla serena-mente, quasi senza dispiacere, si trasforma quindi in una spinta propulsiva che lo proietta a radicarsi profondamen-te nelle dinamiche e nelle vicende del gruppo folcloristico. Così nelle narrazioni a posteriori che i componenti dello stesso gruppo costruiscono intorno alla loro storia, alla loro attività folcloristica, trasformano Ennio in un “personaggio di paese”, in un riferimento importante per quella parte di memoria musicale, ma anche associativa, che la comunità individua come possibile ancoraggio a una selezione dei tra-scorsi collettivi ancora buoni per rappresentarla nell’oggi e nel domani:
C.L.: Ennio è stato sempre presente è l’unico[…]L.B.: quelli coreografici sono una cosa molto più recente…
per il vecchio gruppo ho in mente una foto dove ballano a due… quindi quello è saltarello ma cos’altro facessero non è facile dirlo… per ciò che riguarda le musiche c’è stata la continuità di Ennio
[…]C.L.: sì sì i pezzi musicali sono rimasti quelli dell’inizio tramite
Ennio che è la memoria storica […]
L.B.: allora io nel 1979 ero il più giovane… avevo vent’anni… questo per dirti che non c’era la gioventù nel gruppo… dopo piano piano iniziarono ad entrare i bambini… la pri-ma bambina che è entrata e aveva quattro o cinque anni era Silvia Zampetti… dopo di lei sono entrati altri bambini e si è costituito piano piano il gruppetto dei bambini… ovvia-mente ai bambini non potevamo far ballare la mazurca ecc. quindi abbiamo inventato delle coreografie sempre sulla base delle musiche che ci suonava Ennio
D.P.: musiche comunque di ispirazione popolare?L.B.: sempre… il suonatore era sempre Ennio tant’è vero che
c’era una musica che si era inventato lui… mi pare si chia-masse “Teresina”
Già da questi primi stralci della testimonianza di alcuni componenti di lungo corso, emergono due aspetti centrali: la longevità del gruppo e le modalità di costruzione del re-pertorio.
Dalle parole di Ennio, confermate anche nell’intervista a Carlo Lesti, abbiamo evinto che la prima formazione del gruppo risale agli anni Trenta del Novecento, lo stesso En-nio dice di aver sentito che la fondazione fosse avvenuta nel 1932. Nella didascalia posta sotto una fotografia riportata nel volume Castelraimondo di Giuseppe Gaggiotti si legge invece: «Ussita (Visso). Il gruppo di Castelraimondo parte-cipa alla gara folkloristica. 1930». Il riferimento temporale che emerge, indipendentemente dal mese o dall’anno esatto, va legato al contesto più generale e agli indirizzi politici del momento, infatti «Durante il periodo del Fascismo ci fu un fiorire di gruppi folcloristici o popolareschi, come venivano chiamati»14, soprattutto grazie all’azione dell’O.N.D. (Ope-ra Nazionale Dopolavoro) istituita il primo maggio 1925, utilizzati quale strumento di promozione del folklore paral-
14. Cit. Gri G. P. - zolDan c. 2007: 32.
247Il gruppo folcloristico di CastelraimondoDaniele Parbuono 246
lelamente a – come si legge nel Bollettino mensile dell’Opera n. 1, novembre-dicembre 1927 –:
a. mostre regionali di costume e di arte popolare; b. riprodu-zione per mezzo della cinematografia di costumi e di scene di vita popolare; c. raccolta di canti e leggende per mezzo di di-schi; d. concorsi e saggi critici sul folklore e le leggende; e. or-ganizzazione delle feste tradizionali più significative e di spetta-coli cine-teatrali miranti a far conoscere le più belle tradizioni regionali della nostra patria15.
Il gruppo prosegue così la sua attività partecipando, come molte altre formazioni simili, anche agli eventi di propagan-da del regime, come racconta Ennio: «E.C.: si siamo andati a Napoli… a Macerata no perché quella volta non stavo tan-to bene… era il 24 ottobre e veniva Mussolini. D.P.: cioè il gruppo folcloristico è andato là? E.C.: il gruppo folcloristico si… io non potevo andare perché non stavo tanto bene». Prosegue la sua attività almeno fino all’inizio della guerra quando «per ovvi motivi, i gruppi si sciolsero, venendo a mancare non solo le occasioni di festa, ma anche e soprattut-to i giovani maschi richiamati alle armi e le ragazze costrette ad emigrare come domestiche nelle grandi città, per soppe-rire alle necessità delle famiglie, private del lavoro degli uo-mini, non solo per la guerra, ma anche per la disoccupazione che già imperava da anni»16. La guerra rallenta l’attività dei gruppi, così come quella del gruppo di Castelraimondo, fino a bloccarla nelle fasi culminanti e più disperate; Ennio ri-corda comunque alcune sporadiche occasioni di esibizione, racconta per esempio di uno spettacolo a Tolentino (Mc) del 1941.
Con la fine della guerra il gruppo si prepara a iniziare la sua seconda fase, «dopo si è riformato… nel 1948… 1949 si
15. Cit. Bonalanza c. 2003-2004: 22.16. Cit. Gri G. P. - zolDan c. 2007: 34.
è cominciato a riformare»17, potendo contare su un bagaglio ormai consolidato e rodato «[…] su repertori o su frammen-ti o su ricordi diretti di vecchi componenti; inoltre, in molti casi, erano stati conservati i costumi, i testi dei canti, gli spar-titi e questo non solo favorì la ripresa, ma contribuì anche a difendere una certa “originalità”, allontanando, almeno al momento, la tentazione di inventare»18.
Fino a questo punto l’organizzazione e la gestione del gruppo ruota fondamentalmente intorno alla figura del ma-estro Enzo Vinicio Biondi, tra l’altro incaricato fin dal 1934 di dirigere la banda del paese dall’Amministrazione comu-nale. «Era un maestro di banda e di tutto… era un musicista completo ed era un impiegato comunale… all’epoca c’era anche un piccolo coro… cantavamo in chiesa… la musica a Castelraimondo ha sempre attecchito molto», ricorda Carlo Lesti. Tanto è centrale ed efficace la figura di Biondi che con la sua morte, avvenuta il 2 luglio 1969, l’attività del gruppo folcloristico subisce una seconda e brusca battuta d’arresto.
Nel 1979, dopo una decina d’anni di inattività, il gruppo folcloristico di Castelraimondo si riorganizza; ancora una volta Ennio Carolini è presente e garantisce una certa con-tinuità di repertorio, insieme a lui ci sono il già citato Carlo Lesti, che presiederà e dirigerà il gruppo per anni, Augusto Barbini, Elio Pievani, Luca Barbini, al quale durante l’inter-vista Lesti ricorda: «C.L.: la voglia e il desiderio della ripresa è stato di tuo padre». Lo stesso Luca ci ripropone un fram-mento di memoria interessante, legato a quel momento: «la voglia già era nata… la volontà era stata… io mi ricordo che papà aveva dato degli inviti a voce e si radunarono nella can-tina di casa nostra… è nata tra un bicchiere di vino… c’èra Lesti… c’era Elio… c’era zio Nello». Per la terza volta il gruppo riprende quota ma, rispetto al passato, le condizioni
17. Cit. intervista a Ennio Carolini.18. Cit. Gri G. P. - zolDan c. 2007: 35.
249Il gruppo folcloristico di CastelraimondoDaniele Parbuono 248
contestuali sono radicalmente cambiate. È vero che tra la prima e la seconda fase c’è stata la guerra che già profonda-mente ha inciso sugli stili di vita, sulle modalità di rappor-tarsi agli affetti, sulle condizioni anche materiali di esistenza, ma tra la fine della seconda fase e l’inizio della terza qualcosa di irreversibile ha ridefinito il rapporto delle persone con le storiche relazioni familiari, con le sfere professionali, con i luoghi, con la terra. «Da notare un fatto curioso: prima del 1950, circa 3.000 persone risiedevano nelle campagne e nelle frazioni, e solo poco più di un migliaio stava in paese. Dopo quella data le cose si sono invertite; cioè ora 3261 sono in paese e appena 780 risiedono fuori», scrive nel suo volume Giuseppe Gaggiotti a proposito del comune di Castelrai-mondo. Ci troviamo quindi al cospetto di quel complesso e rapido processo di cambiamento, come mai se ne erano visti nella storia, che con le parole di Tullio Seppilli possiamo de-finire “deruralizzazione delle campagne”19.
Allo stesso tempo, il notevole cambiamento socio-economico e professionale rese desuete certe forme culturali tradizionali che fino a quel momento erano risultate funzionali alla stessa sopravvivenza degli individui. Così come l’agricoltura cedeva il passo all’impiego nel terziario, la medicina popolare cedeva il passo alla medicina scientifica; così come l’abitare in frazione cedeva il passo all’abitare “in paese”, la casa colonica cedeva il passo alla villetta o all’appartamento […]; così come la famiglia allargata patriarcale cedeva il passo alla famiglia mono-nucle-are, l’importanza dei rapporti di parentela cedeva il passo a nuovi legami sociali; così come la concezione dell’utile cedeva il passo al consumo, l’abitudine al riuso e all’utilizzo oculato delle risorse cedeva il passo all’accumulo e all’investimento; così come l’arte popolare cedeva il passo ai nuovi mezzi di co-municazione mediatica, “Trescone” e “Saltarello” cedevano il passo all’“Alligalli” e al “Festival di Sanremo”. La nuova realtà socioculturale e le migliori condizioni economiche favorirono
19. Cfr. sePPilli t. 2008c.
l’ideazione di momenti aggregativi che, anche se in parte de-rivanti dalle tradizionali abitudini festive, apparivano ormai disgiunti dai cicli agrari, dai cicli della vita e dalle attività tra-dizionali. La precedente struttura sociale, “allentata”, doveva essere rinsaldata attraverso l’uso dei mezzi che la nuova realtà poteva fornire […]20.
Questo terzo inizio si deve non alla pressione, all’intervento o al sollecito delle istituzioni, ma alla necessità che sentono alcuni abitanti di Casteraimondo, di ricollocarsi nei nuovi spazi urbani, di riaffermare una centralità dei rapporti uma-ni nelle nuove condizioni dei legami familiari e professionali, di ricostruire una relazione aggiornata al presente con quel-la selezione di “radici” riconosciuta come utile rispetto alle esigenze delle nuove contingenze, infatti «[…] nel momen-to stesso in cui andava annientando intorno a sé le culture differenti e i particolarismi, la società industriale produceva la nostalgia di ciò che distruggeva e parallelamente susci-tava il desiderio e il bisogno di conservarne i segni»21. Una spinta dal basso22, quindi, che immagina il gruppo folclori-stico come un strumento efficacemente votato a ridefinire una parte importante della nuova «dimensione del paese, spazio degli affetti e delle relazioni sociali, microcosmo che sta nel cosmo, spazio da cui è possibile dialogare a partire da un preciso punto di vista, luogo delle radici e dei ritorni possibili»23.
20. Cit. ParBuono D. 2007b: 86.21. Cit. Kilani m. 1994 [1989]: 160.22. Un percorso simile è stato compiuto dal gruppo folcloristico
“Agilla e Trasimeno” di Castiglione del Lago (PG) da me studiato, così come dai gruppi folcloristici sardi di Ittiri e Florinas di cui scrive Fabio Calzia: «La spinta per la formazione del gruppo parte dal basso, svinco-lata da un intervento delle istituzioni locali, per iniziativa di singoli indivi-dui membri della stessa comunità paese», cit. calzia F. 2005: 551.
23. Cit. mirizzi F. 2007: 60.
251Il gruppo folcloristico di CastelraimondoDaniele Parbuono 250
In questo quadro generale, come per molti altri gruppi italiani, va inserita quella che può essere definita la “svolta istituzionalizzante” del gruppo di Castelraimondo. L’am-pliamento della base sociale, quindi decisionale, unita a una certa emancipazione gestionale rispetto agli organismi pub-blici istituzionali, implica l’adozione di strumenti che possa-no permettere una attività condotta con il massimo grado di democrazia interna e di trasparenza, quantomeno a livello formale; va infatti sempre tenuto presente che i processi di gestione del potere, a tutti i livelli, sono soggetti a dinami-che, strategie, tensioni, alleanze, forze esterne solo in parte gestibili attraverso criteri normativi:
L.B.: dal 1979 è stato fatto un atto costitutivo e uno statuto… l’atto costitutivo è stato firmato dalle sette o otto persone che si trovarono a merenda a casa mia tra le quali c’è Car-lo… c’era mio papà… c’era Elio
D.P.: e lo statuto è rimasto lo stesso? L.B.: no lo statuto è stato cambiato in diverse occasioni e ag-
giornato anche con la normativa fiscale attuale… è stato registrato ecc.
D.P.: come vi eravate organizzati dal punto di vista delle cari-che?
L.B.: c’era un direttivo… il presidente… l’assemblea C.L.: oltre al presidente c’era il direttore L.B.: c’era il vicepresidente, il cassiere… io facevo il segretario D.P.: il primo presidente è stato lei Carlo?L.B.: il primo per pochissimo per partire mi pare sia stato Nel-
lo Rocci… poi c’è stato Carlo per parecchi anni… poi c’è stato Alberto Mazzanti
C.L.: e io ero direttore… all’inizio facevo l’uno e l’altro L.B.: dopo Mazzanti sono diventato presidente io… poi Die-
go Orfei… poi mio padre Augusto… poi Fabio Pascucci… poi di nuovo io… poi Marco Ciciani per un anno e poi di nuovo io fino ad ora
Da questo punto di vista il gruppo di Castelraimondo, come molti altri gruppi “storici” in Italia, compie un percorso a
parabola, cioè passa dall’essere gestito sotto il forte control-lo di istituzioni esterne – regime prima, amministrazione comunale poi –, alla riorganizzazione dal basso, al divenire istituzione di sé stesso, istituzione che si relaziona con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali.
D.P.: quali sono i rapporti tra il gruppo e le istituzioni… Co-mune… Proloco… Provincia?
L.B.: non sempre… dipende come sempre da chi c’è e dalla persona… oggi ti posso dire che c’è una disponibilità uni-ca… cioè ci danno i locali… c’hanno dato tre stanze del pa-lazzo comunale… si vede la sensibilità e il clima positivo… non è stato sempre così… per quanto riguarda la Proloco loro organizzano soprattutto l’infiorata e gestiscono altre manifestazioni… tra l’altro gestiscono anche molte attrez-zature per cui se ci serve qualcosa facciamo richiesta a loro
[…]D.P.: perché sento sempre dire che Marco Ciciani è presidente
dei piccoli… come funziona?L.B.: questa l’abbiamo fatta come riconoscimento all’interno
della Federazione F.A.F.It. essendo un gruppo molto nu-meroso
D.P.: quindi il gruppo ha due presidenti?L.B.: siD.P.: e come vi coordinate?L.B.: bene… facciamo i consigli insieme… diciamo che è una
proforma… una sorta di incarico… il presidente del grup-po dei piccoli deve essere un componente del direttivo e una persona fidata
[…]D.P.: oggi dentro al direttivo quali cariche sono previste? L.B.: oggi la cosa è diventata più corposa cioè l’assemblea eleg-
ge nove consiglieri… all’interno del consiglio direttivo si sceglie il presidente… c’è un vicepresidente c’è un cassiere e un vicecassiere c’è un segretario e un vicesegretario poi ci sono i consiglieri
[…]D.P.: d’estate organizzate anche un festival del folklore
253Il gruppo folcloristico di CastelraimondoDaniele Parbuono 252
L.B.: si d’agosto D.P.: e quanti gruppi ospitate?L.B.: più o meno quattro in un finesettimana con un gruppo
che viene dall’estero con il quale si fa solitamente lo scam-bio… quello che viene dall’estero… il nostro e di solito altri due gruppi italiani
In tempi più recenti il consolidamento istituzionale, unito all’implemento delle attività performative, ma anche orga-nizzative e festive, porta il gruppo a passare da una sostan-ziale attrazione centripeta rivolta alle esigenze della micro-comunità o della comunità di comunità, rivolta agli eventi organizzati in paese, alle occasioni da sfruttare per rodare il repertorio riorganizzato – «C.L.: si io mi ricordo che ci siamo dati parecchio da fare… poi abbiamo fatto la prima esibizione sotto al loggiato del comune. D.P.: che anno era? C.L.: 1979 e c’era un gruppo polacco… noi facemmo qual-cosa quattro balli»24 – a una spinta centrifuga che proietta l’attenzione dell’istituzione gruppo folcloristico verso la ri-cerca di spettacoli e di pubblici esterni al paese, oltreché alla ricerca del maggior numero possibile di tournée estere:
D.P.: quando è avvenuto il passaggio alla dimensione interna-zionale?
L.B.: nel 1987 siamo stati in Turchia… nel 1985 io ero militare sono stati in Francia
C.L.: poi siamo andati in SardegnaL.B.: in Sicilia… l’Italia l’abbiamo girata un po’ tuttaD.P.: l’Italia da subito? L.B.: subito subito no… mi ricordo che all’inizio ci furono an-
che un po’ di battaglie… qualcuno diceva restiamo qui in-torno… c’èra chi non voleva uscire e chi invece voleva fare anche uscite un po’ più…
C.L.: è normale perché all’inizio non avevamo un programma da presentare
24. Cit. intervista a Luca Barbini e Carlo Lesti.
L.B.: finché non puoi fare un’ora di spettacolo non puoi andare […] dopo c’erano gli stornellatori pure… Lucio Afrile c’è stato fin da subito quindi anche quelli tiravano… facevano un paio di interventi durante lo spettacolo… stavano den-tro al gruppo… avevano il costume come noi […] dopo siamo stati nella ex Jugoslavia… siamo stati in Ucraina… in Polonia e poi quando era presidente Pascucci sono stati in Spagna… poi da quando sono presidente io siamo stati in Romania… siamo stati in Croazia… siamo stati in Olan-da… siamo stati in Grecia quindi negli ultimi cinque anni siamo stati spesso all’estero
La spinta centrifuga di cui si è parlato crea dunque un pro-cesso per il quale «Dalla produzione locale destinata a un contesto locale, si potrebbe dire una forma di “artigianato culturale”, si è passati a una produzione e a una distribuzio-ne che non può non tenere conto di stili espressivi, di tec-niche, di retoriche e di pratiche adattate per rispondere alle esigenze del consumo globale e alle regole economiche della cultura»25; essa sollecita inoltre i dirigenti a creare solide re-lazioni con organismi regionali e nazionali del settore – il gruppo è infatti sia membro dell’U.G.F.M. (Unione Gruppi Folklorici Marchigiani), sia della F.A.F.It. (Federazioni As-sociazioni Folkloriche Italiane) – le quali da un lato garanti-scono al gruppo visibilità esterna, dall’altro lo inseriscono in una rete di contatti collaborativi che portano in generale Ca-stelraimondo a una certa centralità rispetto alle dinamiche politico-decisionali del folclorismo italiano: la Federazione F.A.F.It., oltre ad aver allestito a Castelraimondo il “Museo nazionale del costume folcloristico” di cui meglio si parlerà nel prosieguo del testo, ha individuato i locali del medesimo Museo quale sede permanete del proprio Collegio Scientifi-co Federale.
25. Cit. PaPa c. 2007: 20.
255Il gruppo folcloristico di CastelraimondoDaniele Parbuono 254
Nello stesso processo di istituzionalizzazione vanno inserite le scelte di lavorare per ottenere una sede sociale autonoma, messa poi a disposizione dall’Amministrazione comunale, all’interno della quale i componenti del gruppo provano il repertorio due volte alla settimana, organizzano i consigli direttivi, stoccano i materiali utilizzati nelle diverse iniziative annuali, conservano attestati e premi ottenuti nelle esibizioni nazionali e internazionali; in generale conservano la memoria di quella parte di vita collettiva, che in diver-se forme associano alla propria storia di vita e attraverso di essa alla propria visione delle storie di paese. La sede del gruppo passa quindi dall’essere luogo fisico all’essere per-cepita come luogo degli affetti, come spazio di condivisione dei momenti collettivi, come dimora situata di una serie di relazioni interne ed esterne alla comunità e alla comunità di comunità. Una funzione simile svolge anche l’autobus recen-temente acquistato, che rispetto agli autobus fino ad ora af-fittati di tanto in tanto, in base alle necessità, si trasforma in un “oggetto d’affezione”26 all’interno del quale ogni compo-nente inscrive il suo bagaglio di “pratiche viaggianti”; pra-tiche relazionali, pratiche artistico-performative, pratiche affettive, pratiche di condivisione delle esperienze27:
26. Cfr. clemente P. - rossi e. 1999; ray m. 1970.27. È interessante riportare le parole di un componente (autista e
ballerino) del gruppo folcloristico “Agilla e Trasimeno” di Castiglione del Lago, Giuseppe Gasparella, che descrive un’esperienza del tutto simile: «Fu un notevole salto di qualità. I ragazzi facevano la fila per andare a vederlo. Finalmente avevamo un mezzo di trasporto nostro, molto confor-tevole e soprattutto sempre a nostra disposizione, anche per attività non strettamente legate al gruppo: andavamo insieme al mare, siamo andati a “Mirabilandia” con i bambini; solo con i ragazzi, nel 1990, andammo all’“Oktoberfest” di Monaco. Siamo stati molto legati a questo pullman. A quel tempo eravamo uno dei pochissimi gruppi folcloristici a possederne uno, per noi era un motivo di grande soddisfazione. […] Ho un’infinità di ricordi e tanti non possono essere raccontati. Trascorrere tutte quelle ore a stretto contatto con gli amici, dormendo, mangiando, ridendo, piangen-
D.P.: adesso avete comprato anche il pullman che è un aspetto non trascurabile dell’attività di un gruppo
L.B.: quello l’abbiamo comprato nel 2010… ti dico solo che siccome è un autobus privato siamo passati da settanta soci a oltre duecentocinquanta nel giro di sei mesi… soci non significa ballerini
D.P.: quindi il pullman diventa un bene della comunità diciamoL.B.: esatto28
L’analisi dell’attività di un gruppo folcloristico oggi non può limitarsi, quindi, esclusivamente alla riflessione sul canto, sul ballo o sulle musiche, ma deve necessariamente rapportarsi con le molteplici sfaccettature che presentano gli aspetti re-lazionali (con le persone, con le memorie, con i luoghi, con gli oggetti), associativi, politici; ciò non toglie però che un gruppo folcloristico, rispetto a una associazione sportiva, ri-spetto a un circolo ricreativo, rispetto a un oratorio, presenti quale proprio elemento costituivo anche una serie di rela-zioni stabili con alcuni frammenti di quelli che potremmo definire beni culturali materiali e immateriali29, soprattutto per quanto attiene agli aspetti più legati alla performance, agli abiti di scena e ai repertori dello spettacolo. Ancora una volta vale la pena ribadire, però, che i processi di costru-
do, gridando, parlando, abbiamo costruito rapporti che negli anni sono rimasti solidissimi. È intuibile come in trenta o quaranta ore di viaggio, in centinaia di uscite, tra quei sedili si è visto di tutto. Nel pullman sono nati tanti momenti goliardici, hanno avuto luogo tante discussioni sullo sport come sulla politica, sulle donne come sul folklore; nel buio dei viaggi di ritorno sono nati tanti amori dei quali molti sono giunti al matrimonio. Il pullman oltre a permetterci di viaggiare a basso costo, quindi di viaggiare parecchio, è stato un collante unico, una sezione indispensabile per l’atti-vità dell’“Agilla e Trasimeno”», cit. ParBuono D. 2007c: 136-137.
28. Cit. intervista a Luca Barbini e Carlo Lesti.29. Cfr., per es., Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice
dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137; “Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage”, UNESCO, Parigi, 17 ottobre 2003.
257Il gruppo folcloristico di CastelraimondoDaniele Parbuono 256
zione di un repertorio vanno sempre collocati nello spazio del contemporaneo. In questo senso gli stessi elementi del repertorio devono essere analizzati non tanto come elementi precostituiti dai quali si è sviluppata una storia di azioni fu-ture, quanto come risultati di un processo di creazione e di autoriconoscimento a posteriori. Per questa ragione, osser-vando uno spettacolo folcloristico, dovremmo interrogarci sulla filogenesi di determinati elementi della performance più che sulla loro ontogenesi. È con questo spirito di analisi che, in linea con la gran parte del dibattito attuale, possiamo rag-giungere un sostanziale e «[…] conseguente superamento della dicotomia folklore-folklorismo, e l’apertura allo studio dei fenomeni della cultura di massa e dei processi locali e globali di “invenzione” di identità culturali»30, utili a trovare nuovi spazi di collocazione fisica e metafisica nella contem-poraneità. Parlando delle tecniche e delle strategie di am-pliamento del proprio repertorio musicale, che in seguito è divenuto repertorio musicale dello stesso gruppo folcloristi-co, quindi della comunità, poi della comunità di comunità, Ennio Carolini racconta:
D.P.: senta io ho un’altra domanda… ma lei le musiche che faceva con il gruppo come le aveva imparate?
E.C.: e io siccome ne ho imparate poche… qualcuna così… dopo per mezzo della radio… si sentivo le canzoni e dopo queste me l’hanno insegnate… il maestro Biondi
D.P.: e dopo queste canzoni le facevate nello spettacolo e loro ci ballavano sopra?
E.C.: si […]D.P.: quindi le imparava tramite la radio e altre le sentiva anche
in giro a orecchio come le… tipo i saltarelli come li impa-rava?
30. Cit. Dei F. 2002: 19.
E.C.: io non è che sono tanto speciale per i saltarelli… li facevo ma così… come li potevo fare
D.P.: ma perché li aveva sentiti per le campagne... come aveva fatto a impararli?
E.C.: si si per le campagne… le canzoni che imparavo per suo-nare poi quando c’erano le giostre qui no… andavo sempre lì… per me quella era una scuola
Luca Barbini e Carlo Lesti, sui canti e sui balli, raccontano:
L.B.: le sorelle del maestro Biondi che facevano parte del vec-chio gruppo… loro cantavano perché ci sono anche canti polifonici a quattro voci che poi Carlo Lesti ha ripreso
D.P.: che vi sono arrivati dal gruppo degli anni Trenta?L.B.: esatto quelli tipo Liviabella, Ginobili… Lesti li ha ripresi
nel 1979 tant’è vero che facevamo altri cantiD.P.: che canti erano per intenderci?L.B.: “Mari tu ce lo sai”C.L.: “Ienno a ccaccia” L.B.: “Ienno a caccia” è nostra però è a una voce… questa l’ha
scritta uno di Castelraimondo D.P.: cioè il repertorio era costituito anche da musiche scritte
da componenti del gruppo?C.L.: comunque erano canzoni che già facevano nei tronconi
precedenti D.P.: ma sono canzoni che voi definireste popolari o contadi-
ne? C.L.: certo c’erano gli stornelli anche amorosi D.P.: ma per esempio “Ienno a caccia” dove l’avete trovata?
Cioè come facevate andavate in giro per la campagna a cer-care?
C.L.: no uno del precedente gruppo aveva scritto le parole mi pare poi dopo c’era il maestro Biondi che naturalmente ha organizzato la parte musicale
[…]C.L.: comunque Ennio ha mantenuto sempre la linea che te-
neva BiondiL.B.: poi sono entrati anche altri… grandi ma giovani… quindi
a quel punto abbiamo iniziato a fare un po’ di coreografia,
259Il gruppo folcloristico di CastelraimondoDaniele Parbuono 258
perché quando entrava un ragazzo di tredici o quattordici anni dopo un paio d’anni era pronto per fare il balletto in maniera coreografica
C.L.: anche durante la sfilata… ti ricordi?L.B.: si i movimenti c’erano… però ecco si faceva sempre o il
saltarello o la polka o la mazurka D.P.: poi avete dato anche dei nomi ai balli che avete coreo-
grafato?L.B.: si piano piano si… nomi che ti posso dire… ti dico l’ul-
timo che abbiamo fatto è “Lu vallo de lu corvellu” per esempio che richiama il momento successivo alla raccolta del grano… e allora il ballo richiama alcune coreografie che imitano gli ingranaggi del mulino del macinare ecc. e si usa anche questo oggetto qui… poi ci sta “Lu vallu de lu mat-tarellu”… cose di questo genere… poi le altre quelle più coreografiche sono venute fuori in diversi modi… mi ricor-do per esempio “Tarantella marchigiana” è venuta fuori da una canzone del maestro Castellani
[…]D.P.: quindi facevate la coreografia poi davate anche un nome
successivamente ed erano balli fatti anche su musiche d’au-tore
L.B.: si… quando avevo sei anni o otto anni i mie genitori mi portavano a cantare in giro e in quelle occasioni conobbe-ro il maestro Castellani il quale dopo un po’ di tempo che stavo cantando mi mandò una busta grande con dentro gli spartiti di “Tarantella marchigiana” scritta da lui… allora noi l’abbiamo presa… cominciata a suonare e a cantare e è diventato quasi l’inno e in più c’abbiamo creato sopra un balletto… quindi la cantiamo la balliamo ma è una cosa re-lativamente recente
D.P.: e i canti per esempio gli stornelli… anche qui i percorsi sono misti diciamo?
L.B.: gli stornelli diciamo… dopo abbiamo cominciato a docu-mentarci un po’… per esempio sono riuscito ad avere e poi ho condiviso tutto con il gruppo… fotocopie e pubblicazio-ni degli anni Quaranta… Cinquanta… Sessanta… sempre di questi qui… Liviabella e Ginobili ecc. sulle costumanze marchigiane… sui proverbi… sulle tradizioni ecc. e da li
abbiamo cominciato a creare anche una sorta di presenta-zione e di preparazione
[…]D.P.: adesso quanti pezzi fa il gruppo?L.B.: facciamo otto balletti dei grandi e altri otto o dieci dei
piccoli più abbiamo la sfilata che è a parte… per quanto riguarda i canti attualmente non abbiamo più nessuno che ci coordina e ci dirige per cui non ne abbiamo fatti più… in questo momento si è sviluppato di più l’altro settore… inoltre in qualche occasione sporadica abbiamo cominciato a fare qualche scenetta dialettale che presentiamo ovvia-mente solo nei posti dove possono capirci
Ascoltando e rileggendo le descrizioni coscienti dei compo-nenti, emerge chiaramente che nella definizione del termine “tradizione” o meglio, nella loro concettualizzazione “emi-ca” del senso generale del termine, per altro in linea con quanto fin dagli anni Venti del Novecento avevano posto in evidenza Bogatyrëv e Jakobson31 nel loro celebre saggio, la “tradizione” implica necessariamente un processo di “crea-zione” in tutto e per tutto “autonoma” rispetto alla copia ori-ginale, alla prima stesura. Di conseguenza quando si pensa al repertorio della performance folcloristica, quindi anche al repertorio del gruppo di Castelraimondo, va tenuto presen-te, in prima battuta che «Le rappresentazioni sono sempre rappresentazioni di qualcosa, quindi sono ri-presentazioni, non la cosa in sé»32 e, subito dopo, che le “ri-presentazioni” sono il risultato di un costante “lavorio culturale”, sulla base del quale, una serie di elementi popolari, passati e presenti, culti e semiculti, tramandati e inventati, tagliati e ricuciti, si configurano come forma ridefinita di auto-riconoscimento dei soggetti e delle comunità:
31. Cfr. BoGatyrëv P. - JaKoBson r. 1967 [1929].32. Cit. GooDy J. 2000 [1997]: 34.
261Il gruppo folcloristico di CastelraimondoDaniele Parbuono 260
[…] questo genere di gruppi utilizza un mélange di danze pro-venienti dalla pratica popolare, arricchito da elementi semicolti nella coreografia, nella musica, nel costume, e da altri elementi creativi. La principale funzione dei gruppi folkloristici è quindi quella di raffigurare l’identità del gruppo sociale. Ogni gruppo si autorappresenta scegliendo, ovviamente, il meglio di sé stes-so e ordinandolo sulla base dei valori estetici più apprezzati dall’ambito in cui va a presentarsi33.
Il risultato finale del “lavorio”, che in genere viene messo insieme e ricomposto, da un esperto, da un dirigente del gruppo, da un coreografo, da uno scenografo, per tornare a Bogatyrëv e Jakobson e attraverso di loro a Ferdinand de Saussure34, è un nuovo atto di parole, di creazione individua-le della forma espressiva che muove dalla multivocalità delle esperienze di cui si è parlato, per giungere, negli anni, a nuo-ve componenti di langue condivise e sentite come funzionali alle traiettorie di vita e di azione dei singoli o delle comunità. Per chiarire fino in fondo il concetto: una persona qualche secolo fa inventa un canto o un passaggio musicale (atto di parole, creazione individuale); una determinata comunità accetta questa forma espressiva come propria e, per ragioni funzionali, la utilizza tramandandola, attraverso un processo di tradizionalizzazione, di generazione in generazione, quin-di modificandola, aggiornandola, lavorandola, tenendo però alcuni suoi punti stabili, che potrebbero essere relativi alla metrica, alla ritmica, a determinati passaggi melodici (l’atto di parole diviene componente della langue, cioè patrimonio sistematizzato e condiviso); a questo punto nella operosità simbolica e performativa di un gruppo folcloristico di metà Novecento, una serie di elementi di una langue ormai in via di abbandono – non più funzionale rispetto alle vecchie esigen-ze esistenziali già mutate, né tantomeno rispetto alle nuove,
33. Cit. staro P. 1991: 24.34. Cfr. De saussure F. 1967 [1916].
all’interno delle quali quelle forme espressive non hanno più spazio – trovano una seconda (una terza o una quarta) vita, giustapposti e rimescolati da una qualche figura creativa che li reinventa come nuovo atto di parole. Il seguito della storia è che dalla metà del Novecento a oggi, questo nuovo atto di parole, nelle pratiche, nelle poetiche e nelle retoriche del gruppo folcloristico, della sua comunità diacronica e sincro-nica, fa in tempo a trasformarsi in nuova componente di una langue contemporanea il cui lessico è sentito come proprio e condiviso dalla stessa comunità, ma anche dalla comunità di comunità, quindi dal paese. Proprio per questo, il fatto che “Tarantella marchigiana”, non sia quello che qualche purista definirebbe un “pezzo autentico”, il fatto che sia sta-ta scritta da un maestro di musica, che la tarantella non sia proprio una forma coreutico-musicale assimilabile alla realtà di Castelraimondo, che la coreografia affiancata alla musica sia stata inventata da qualcuno sulla scorta di elementi stori-co-coreutici di varia natura, sono tutti elementi emicamente marginali: il processo di tradizionalizzazione continua a fare il suo corso e questa nuova forma espressiva – che «è diven-tato quasi l’inno» del gruppo –, funzionale ai nuovi “mit-tenti”, ai nuovi “destinatari”, ai nuovi “contesti”, ai nuovi “codici”, ai nuovi “canali”35, si configura come oggetto e soggetto di rapporto tra la comunità che la sente propria e le esigenze di riposizionamento nelle dinamiche del presente.
«La fedeltà alla tradizione è allora tutta nei modi di fare e disfare, di “fabbricare” e di “disfabbricare”, secondo logiche filologicamente scorrette […]»36 e proprio a partire da questo presupposto il gruppo folcloristico di Castelrai-mondo in collaborazione con il Collegio Scientifico Federa-le F.A.F.It., ha progettato e realizzato, nei locali del palazzo
35. Cfr. ParBuono D. 2007a. 36. Cit. PalumBo B. 2006 [2003]: 161.
263Il gruppo folcloristico di CastelraimondoDaniele Parbuono 262
comunale, il “Museo nazionale del costume folcloristico”37, inaugurato il 14 giugno 2009. Il Museo oggi diretto da Luca Barbini, coadiuvato da un Comitato Scientifico da me pre-sieduto, è proprio pensato, non tanto come luogo per la conservazione di elementi attinenti alla cultura materiale o all’oggettistica dei gruppi folcloristici, quanto come punto di inizio per una riflessione futura sull’attività processuale e potenziale dei gruppi stessi. In questo senso il museo non ce-lebra la più o meno presunta “autenticità” dei pezzi esposti, non feticizza gli oggetti o i costumi di scena in funzione dei loro maggiori o minori valori artistici, artigianali, storici, ma segna in qualche modo il passaggio di queste particolari “as-sociazioni culturali” nelle dinamiche della contemporaneità, raccontandone pregi e difetti, limiti e potenzialità, azioni e creazioni, selezioni, reinvenzioni e tradizioni.
Porre il Museo nonché il Gruppo folcloristico nell’oggi e non immaginarli come una sorta di macchina del tempo con-geniata per rivivere il passato; questo mi pare possa essere il senso complessivo e il contributo del presente saggio. Inse-rito nelle pratiche dell’oggi il gruppo folcloristico può assu-mere, allora, anche una significativa centralità nelle riflessio-ni per lo più etiche del dibattito scientifico, proprio perché una contestualizzazione «[…] nel tempo storico permette dunque, senza dubbio, di percepire delle concatenazioni e degli effetti di contesto, ma soprattutto ci conduce fino al cuore della fabbrica sociale del senso […]»38, di quel senso che ogni componente, per se stesso o in relazione al resto delle comunità, costruisce e attribuisce alla propria dimen-sione di ballerino, di musicista, di cantante, di performer, di donna, di uomo, di persona socialmente embedded.
Sentire oggi la storia, una parte della storia o meglio la ge-nealogia di un gruppo folcloristico come quello di Castelrai-
37. Cfr. BarBini l. (a cura di) 2009.38. Cit. FaBre D. 2001 [1987]: 117-118.
mondo ci rende un po’ di quell’effetto, di quelle sensazioni, che si provano leggendo una poesia di Bertolt Brecht, con i suoi frammenti di vita costruita dal basso o ascoltando la storia complessa e affascinante di qualche personaggio ben situato cantato da Bruce Springsteen, da Francesco Guccini, da Georges Brassens; ci aiuta a guardare il percorso storico di un determinato luogo liberandoci dal vizio idealista di le-gare i trascorsi di una comunità solamente alle grandi tappe, alle battaglie epocali (locali o sovra-locali), ai nomi definiti “illustri”, rendendo a ciascuno quella parte di merito che gli spetta per aver agito da protagonista della propria vicenda umana e sociale.
FerDinanDo mirizzi
Gruppi folcloristici e valorizzazione delle culture locali1
Quando, circa venti anni fa, cominciai a prestare un po’ della mia attenzione ai gruppi folcloristici attivi in Basi-
licata – la regione dove avevo da poco iniziato la mia carriera di ricercatore e docente universitario – a seguito soprattutto delle premurose sollecitazioni di Pinuccio Adduci, Presiden-te del gruppo folclorico “La Pacchianella” di Pisticci (Mt) e allora consigliere nazionale della F.I.T.P.2, ricordo che intor-no a tali gruppi prevalevano, in ambito accademico, atteg-giamenti di indifferenza e diffidenza insieme. Indifferenza perché essi non erano ritenuti meritevoli di interesse a causa del loro dilettantismo nella ricerca e, conseguentemente, per la fragilità delle conoscenze alla base della loro riproposizio-ne di situazioni e aspetti della cultura popolare, attraverso i canti e i balli di tradizione orale; diffidenza a causa della ideologia conservatrice e nostalgica che sembrava ispirare la loro attività di ricerca e di divulgazione.
Non nascondo che anch’io mi avvicinai con una certa cautela a quella realtà che, come altri miei coetanei, avevo fino ad allora considerato distante da una partecipata adesio-ne al “vero” mondo popolare e da una sua corretta rappre-sentazione, caratteristiche che invece sembravano ritrovarsi nei protagonisti del cosiddetto folk revival, quel movimen-
1. Questo saggio è già stato pubblicato in ParBuono D. (a cura di) 2007 con il medesimo titolo (cfr. Mirizzi F. 2007).
2. Federazione Italiana Tradizioni Popolari.
267Gruppi folcloristici e valorizzazione delle culture locali Ferdinando Mirizzi266
to cioè che tendeva alla riproposta della musica popolare quale riscoperta di autentiche radici culturali ed espressione di una consapevolezza politica interessata a utilizzare reper-tori e stili popolari di diversa provenienza e, anche, creati-vamente rivisitati, contaminati, variamente mescolati, come elementi di contestazione sociale e di affermazione di una cultura anticonsumistica e antagonista.
Molti della mia generazione si sono avvicinati, nel cor-so degli anni Settanta, alla cultura tradizionale e agli studi antropologici richiamati dall’attività del “Folkstudio”, dai dischi del “Nuovo Canzoniere Italiano” o della “Nuova Compagnia di Canto Popolare”, da spettacoli come il Ci ra-giono e canto, portato sulle scene da Dario Fo, e il Bella Ciao con, tra gli altri, Caterina Bueno e Giovanna Marini. Come ricorda Fabio Dei, la cultura popolare era allora fortemente attrattiva per la sua «connotazione politica» e il suo «valo-re potenzialmente “rivoluzionario” e alternativo all’ordine borghese», per il fatto che nei testi folclorici si ritrovavano tratti che «facevano per lo più parte della nostra memoria viva», perché «la cultura popolare rappresentava allora un ottimo investimento in capitale culturale per gruppi in asce-sa, desiderosi di tracciare demarcazioni verso il basso ma al contempo privi di rendite acquisite»3.
Purtuttavia la mia formazione iniziale, un po’ diversa da quella di Dei, per esempio meno incline al rapporto tra studi demologici ed esperienza etico-politica e meno attenta del-la sua a temi come quelli del “folklore progressivo” o del-l’“intellettuale rovesciato”, ma piuttosto caratterizzata, su un piano storico-filologico, da una concezione della cultura popolare come cultura di base e da una marcata propensio-ne a guardare ai fatti tradizionali nella loro connessione con le dinamiche di tipo territoriale, mi faceva guardare con un certa curiosità – e sia pure come detto con qualche cautela
3. Cit. Dei F. 2002: 8-12.
– al mondo dei gruppi folcloristici, soprattutto per il loro radicamento in una specifica realtà locale, identificata a volte con una regione o sub-regione geografica e culturale, ma in particolare e soprattutto con la dimensione del paese, spazio degli affetti e delle relazioni sociali, microcosmo che sta nel cosmo, spazio da cui è possibile dialogare a partire da un preciso punto di vista, luogo delle radici e dei ritorni pos-sibili. E proprio su questo presupposto, con il passare degli anni, ho maturato la convinzione che la realtà dei gruppi folcloristici vada considerata in relazione alle pratiche e alle retoriche della valorizzazione delle tradizioni e dei patrimo-ni culturali locali.
Devo dire che questa era, in fondo, pur enunciata con un lessico differente e all’interno di un diverso orizzonte di senso, già tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento, la posizione di quegli studiosi di tradizioni popolari che, lonta-ni dall’idea del folklore come cultura antagonista e di conte-stazione, si collegavano piuttosto alla tradizione degli studi demologici italiani che, negli anni tra le due guerre, aveva fatto riferimento soprattutto agli orientamenti e alle posizio-ni, pur con le dovute distinzioni, di Paolo Toschi e Giuseppe Cocchiara, Vittorio Santoli e Giuseppe Vidossi. Era il caso, ad esempio, di Giovanni Battista Bronzini, con cui mi sono peraltro laureato presso l’Università di Bari nel 1980, il qua-le ha a lungo seguito l’attività dei gruppi folcloristici italiani come Presidente del Comitato Nazionale Arti e Tradizioni Popolari e della Consulta Scientifica della F.I.T.P. In occa-sione di una Tavola Rotonda svoltasi nel 1982 a Montesano (SA), in margine al VII Congresso Nazionale della F.I.T.P., a cui era stato dato il titolo L’apporto dei Gruppi Folclorici per valorizzare la Cultura Popolare, Bronzini, pur dichiarando la sua contrarietà al termine “valorizzazione” applicato ap-punto alla cultura popolare, in quanto «la cultura popolare ha dei valori in sé e l’operazione di valorizzare la cultura popolare è sempre rischiosa», riconosceva come parlare di
269Gruppi folcloristici e valorizzazione delle culture locali Ferdinando Mirizzi268
valorizzazione da parte di molti in quel momento significas-se cercare di dare un senso non solo all’«attività pratica dei Gruppi Folcloristici», ma anche «ai nostri studi rispetto alla fase di emarginazione di una certa cultura». In questa pro-spettiva, a suo avviso, si poneva l’attività dei gruppi, il cui compito doveva essere quello non di valorizzare la cultura folclorica, proprio in quanto essa possedeva una sua dinami-ca e non aveva alcun bisogno di essere valorizzata dall’ester-no, ma di “evidenziarla”, “scoprirla”, “riproporla”. Ecco, l’operazione condotta dai gruppi folcloristici doveva legger-si nei termini della «riproposta […] di forme, di contenuti e anche di ideologie della cultura popolare»4.
Credo che la nozione di “riproposta”, su cui Bronzini insisteva, costituisse allora e costituisca oggi la chiave per la comprensione delle attività, delle funzioni e degli scopi dei gruppi. Riproposta intesa non come iterazione o rinno-vamento di qualcosa di già esistente e in altri tempi e altre situazioni già proposto, quindi non come l’ennesima ripro-posizione delle stesse forme e degli stessi temi, ma come scoperta, evidenziazione, messa in valore di fatti, aspetti, situazioni connessi alla vita delle società tradizionali. Il che ovviamente fa accostare il termine a quello, rischioso e am-biguo secondo Bronzini, almeno se, ripeto, applicato alla cultura popolare, di “valorizzazione”. Oggi credo, però, che riproposta e valorizzazione possano utilmente interagire e quasi sovrapporsi, quando ovviamente, anche alla luce delle più recenti riflessioni sul tema in riferimento alle pratiche e alle politiche attuate e da attuare nel campo dei patrimoni culturali5, si liberi la parola valorizzazione dalla genericità che l’ha sempre accompagnata e che rendeva allora partico-larmente diffidente Bronzini nei suoi riguardi.
4. Cit. Bronzini G.B. 1982a: p. ?????????????????????5. Cfr. ad esempio rosati c. 2004.
Ora, se la valorizzazione consiste essenzialmente in una operazione tesa all’accrescimento di un bene culturale at-traverso interventi che consentano di metterne in rilievo e sfruttarne le potenzialità inespresse o trascurate, evidente-mente si sta parlando di un bene già in possesso di un va-lore, che ha solo bisogno di essere accresciuto perché sia conosciuto, valutato, opportunamente apprezzato. Sarebbe insomma un errore sul piano concettuale ritenere la valoriz-zazione come qualcosa di estrinseco e di aggiuntivo rispetto al bene, come un fatto che si colloca al di là dell’esistenza del bene in quanto tale.
Ecco, a me sembra che i dubbi e le diffidenze di Bronzini fossero da collegare soprattutto a questa idea errata della valorizzazione come un processo che dà valore dall’esterno e a posteriori all’oggetto di cui ci si occupa, ma anche e so-prattutto che egli probabilmente non si riferisse alla cultura popolare come a un patrimonio culturale, nei cui riguardi occorresse operare nel senso della conservazione, della co-noscenza e della fruizione, bensì la considerasse ancora tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta del Novecento come una cultura viva e praticata in contesti so-ciali che, sia pure investiti dalla modernizzazione, conser-vavano organicamente i loro assetti di tipo tradizionale o a volte rivelavano nelle forme e nei modi della vita quotidiana un arcaico sostrato contadino6.
6. In un saggio pubblicato nel 1982, ricordando il terremoto in Irpinia e in altre aree del Mezzogiorno d’Italia avvenuto il 23 novembre 1980, Bronzini scriveva come quell’evento avesse messo a nudo tutto il «magma arcaico» della cultura contadina meridionale, «ponendola con la visione macabra dei grandi cataclismi sotto gli occhi di tutti, anche dei non me-ridionali e degli intellettuali che ne avevano e ne hanno una conoscenza indiretta o libresca» (Bronzini G.B. 1982b: 17). Nello stesso saggio, lo studioso affermava la vitalità della cultura contadina non sul piano mitico, bensì su quello storico, intesa come il complesso di tutto ciò che «il conta-dino pensa e fa» e che egli fa interagire in modo funzionale «a una società in corso di sviluppo» (idem: 19).
271Gruppi folcloristici e valorizzazione delle culture locali Ferdinando Mirizzi270
Dopo oltre venti anni, mi sembra che la prospettiva deb-ba però radicalmente cambiare, in considerazione non tanto della graduale trasformazione di quella cultura popolare di matrice contadina in sé di cui Bronzini parlava, quanto del progressivo ridursi degli elementi che complessivamente connotavano il quadro della vita tradizionale di molte co-munità, soprattutto rurali. Mi riferisco, in particolare, alla contrazione massiccia delle forme di trasmissione culturale sul piano intergenerazionale, fondate essenzialmente sullo strumento dell’oralità, ma non solo, che in passato favori-vano l’acquisizione di conoscenze riguardo alle modalità di organizzazione e regolamentazione della vita sociale comu-nitaria, alle condizioni delle produzioni materiali e delle pra-tiche espressive, agli aspetti connessi al sistema cerimoniale e religioso relativo al ciclo dell’anno e a quello dell’esistenza individuale e collettiva. Il che ha comportato la trasforma-zione della percepita tradizione culturale contemporanea in un patrimonio di cui evitare la dispersione, da “recuperare”, come spesso si usa dire, come fattore di identità locale e come strumento in grado di favorire sensi di appartenenza. Per cui quella tradizione da vissuta è diventata sempre più oggetto di rappresentazione, attraverso forme di riproposta che ri-sultano funzionali alla sua valorizzazione, nel senso prima indicato. La riproposta, pertanto, è lo strumento mediante cui si realizza il processo di valorizzazione, con riferimento nel caso specifico alla riproposizione spettacolare di pratiche dell’espressione connesse alla tradizione, alla conferma del legame di appartenenza tra gli attori, i cantori, i ballerini e il proprio territorio, alla funzione di trasmissione della cono-scenza del mondo popolare e della dimensione del passato che sono oggetto della rappresentazione scenica.
Mi sembra dunque evidente che, procedendo su questa strada, il modo di considerare e valutare oggi l’attività dei
gruppi folcloristici o folclorici7, sia quella di non considerar-la tanto in relazione alla loro opera di reinvenzione o di este-tizzazione delle forme espressive di matrice popolare nella loro pretesa e presunta autenticità, su cui a lungo hanno di-battuto gli studiosi, così come molto bene evidenziano tra l’altro nel loro saggio in questo stesso libro Gian Paolo Gri e Carlo Zoldan, quanto soprattutto nella prospettiva delle pratiche connesse al patrimonio inteso come eredità del pas-sato sottoposto a processi di elaborazione nel presente per essere trasmesso, secondo esigenze e modelli propri della realtà contemporanea, alle generazioni future.
In questo senso, i gruppi potrebbero ritenersi mediatori culturali e costruttori di tradizione attraverso azioni che si collocano nella prospettiva della cosiddetta “patrimonializ-zazione”, che comporta da parte dei protagonisti di quelle azioni una appropriazione di ciò che, appartenendo a un passato non vissuto e, quindi, anche non condiviso, rispon-de a una condizione di alterità, in quanto non è solo lo spa-zio, ma anche il tempo a produrre alterità8. Per questa via, dunque, non ha alcun senso guardare all’attività dei gruppi
7. Direi che la discussione tra folcloristico e folclorico, con riferimen-to ai gruppi di riproposta della cultura tradizionale, sia ormai piuttosto datata e abbia in passato riguardato non tanto l’opposizione “folklore-folclorismo” e la nozione di quest’ultimo come “folklore applicato”, quin-di, come uso consapevole e finalizzato del patrimonio culturale locale, su cui si sono articolati la riflessione e il dibattito negli studi tedeschi (cfr. muGnaini F. 2001; Dettmer e. 2001 [1991] e, soprattutto, BausinGer h. 2001 [1966]), quanto la consunzione del termine folclorismo nel contesto italiano e il bisogno di distinguere i gruppi tra quelli che riproponevano semplicemente canti e balli in funzione ludico-spettacolare (folcloristici) e quelli che, come sostenuto da Aurelio Rigoli nella citata Tavola Rotonda di Montesano (cfr. riGoli a. 1982), se la loro intenzione fosse stata quella di porsi come mediatori culturali, sarebbero dovuti andare al di là dei can-ti e dei balli per farsi interpreti di una cultura popolare integrale a seguito di una rigorosa attività di ricerca (folclorici).
8. Cfr. remotti F. 2000, in particolare alle pp. XXII-XXV.
273Gruppi folcloristici e valorizzazione delle culture locali Ferdinando Mirizzi272
in relazione alla sua maggiore o minore aderenza al quadro culturale di riferimento, in quanto la riproposizione del pa-trimonio folclorico non è mai la fedele ricostruzione di origi-narie pratiche dell’espressione appartenenti a un passato che non c’è più, ma una ricomposizione più o meno coerente di frammenti di vita sociale e culturale percepita come tradizio-nale e in quanto tale portata sulla scena per soddisfare biso-gni di appartenenza e di coesione comunitaria ed esigenze di autorappresentazione in un mondo plurale.
È chiaro che, in questa prospettiva, le forme proposte e, ripeto, ritenute tradizionali, per quanto non corrispondenti a situazioni e contesti reali di vita materiale, nella loro dimensione spettacolare e ludica, risultano essenzialmente evocative di un mondo che esiste ormai solo nella memoria e nel desiderio nostalgico di coloro che fanno parte delle stesse comunità degli attori. Comunità che si riconoscono nella riproposizione scenica solo sul piano della evocazione e del ricordo – a volte edulcorato e del tutto privato degli elementi negativi – finendo con il parteciparvi in quanto spettatrici. E il gradimento per le operazioni di riproposta di forme culturali desuete, non più funzionali e, in ogni caso, sempre diverse da quelle praticate nella realtà storica, si spiega anche con la difficoltà per molti di padroneggiare compiutamente l’orizzonte culturale entro cui si vive nel presente e l’ancoraggio sicuro che pare costituire il mondo della giovinezza o quello dei padri e dei nonni.
La tradizione viene così vissuta indirettamente e quasi mitizzata dai giovani che in gran parte costituiscono le com-pagini dei gruppi folcloristici, alimentando il loro protagoni-smo e facendoli sentire depositari di valori culturali, in realtà per lo più lontani dalle loro storie personali, ma facenti parte di una vicenda collettiva di cui si sentono emotivamente par-tecipi, da custodire orgogliosamente e trasmettere al futuro. In tal modo, i giovani cantori e ballerini, avvertono il pro-prio impegno e l’uso del proprio tempo libero come inseriti
in un progetto complessivo il cui scopo è dare alla comunità di appartenenza un senso e una consapevolezza di continui-tà intergenerazionale.
Certo, il rischio è che la tradizione codificata nelle esecu-zioni tante volte provate e perfezionate di canti e balli si ste-reotipizzi e dia l’impressione di una rappresentazione che, così com’è, appartiene a un’altra epoca e che semplicemen-te di quell’epoca è testimonianza nel presente, laddove noi oggi siamo coscienti del fatto che le “tradizioni” non sono più da considerarsi permanenze del passato nel mondo at-tuale, ma sono scelte di un possibile passato fatte nel presen-te in funzione del futuro. Ecco, le «tradizioni si scelgono», come ha scritto Pietro Clemente a proposito dei balli tradi-zionali in Sardegna, «che i sardi si porteranno appresso e che saranno per loro ancora compagnia della vita nel prossimo millennio»9. I gruppi folcloristici scelgono, a volte anche del tutto inconsapevolmente, le tradizioni e decidono di inserir-le nelle proprie storie di vita, che stanno dentro la contem-poraneità e non nel passato dei loro padri e dei loro nonni.
Come leggere e valutare, dunque, la frequente stereoti-pia, quasi l’ingessamento dei canti e dei balli interpretati dai gruppi? Da un punto di vista ideologico e sociale, come si è detto, in base alla interiorizzata convinzione di essere de-positari di una tradizione non vissuta che, proprio in quanto tale, deve essere rigidamente incorporata per assumerne in pieno i significati; da un punto di vista tecnico, perché le forme portate sulla scena sono apprese da “maestri” che le “insegnano” puntando sulla iterazione di gesti, movimenti, moduli espressivi che garantiscano loro qualità e originalità. Ciò, in fondo, quando non finisca per prevalere la tenden-za alla spettacolarizzazione e consenta ai protagonisti delle performance di impossessarsi pienamente degli stili esecutivi vigenti nel passato per poter poi ridefinirli e adeguarli alle
9. Cit. clemente P. 1998 : 17.
275Gruppi folcloristici e valorizzazione delle culture locali Ferdinando Mirizzi274
mutate esigenze del tempo presente, favorisce il pieno ra-dicamento delle forme espressive tradizionali dotandole di funzioni e significati nuovi rispetto al passato, favorendo la loro tesaurizzazione, la loro comprensione e il loro legittimo inserimento nei patrimoni locali, potendone intendere, con le parole ancora di Clemente sempre a proposito dei balli sardi, il loro spirito nel nostro tempo, «presente del passato, alterità dell’identico, identità del diverso»10. Ma – e questo è uno dei punti cruciali – perché tali forme espressive ripropo-ste scenicamente possano essere una risorsa culturale in più del presente nel suo rapporto con la storia lunga delle co-munità locali e, quindi, una competenza in più per le società contemporanee, è necessario che dietro quelle riproposte ci sia una ricerca rigorosa, metodologicamente e filologica-mente corretta, attenta a cogliere la complessità delle forme, finalizzata a evitarne la facile semplificazione e a verificarne la diversa e specifica funzionalità nel passato e nel presente.
Questo è sempre stato il problema posto, in maniera a volte anche ossessiva, dal mondo accademico vicino e non ostile all’attività dei gruppi folcloristici: così, ad esempio, Bronzini, venticinque anni fa, insisteva continuamente sul collegamento tra l’attività spettacolare e quella scientifica, che riteneva dovesse essere sistematico per poter cogliere il popolare nella sua dinamica storica e, quindi, giustificare l’operazione di riproposta su un piano spettacolare e di ri-elaborazione del popolare per la sua fruizione nelle mutate condizioni della società contemporanea.
La ricerca, dunque, dovrebbe porsi in una condizione di connubio indissolubile con la riproposta ed è proprio la ri-cerca che può consentire la consapevole rielaborazione della tradizione ed evitare la fissità nella riproposizione di situa-zioni, moduli narrativi, gesti iterati in forma stereotipata. Ma il discorso qui da generale deve necessariamente essere por-
10. Idem: 18.
tato sul terreno della specificità dei gruppi e della loro storia. Per cui non vado oltre, lasciando, a chi vorrà assumerselo, il compito di studiare, capire, raccontare la storia dei singoli gruppi, che è anche l’insieme delle storie personali di chi li ha fondati, ne ha fatto parte in passato e ne fa parte nel presente, perché solo così sarà possibile distinguere l’atti-vità di quelli che più consapevolmente vivono la tradizione, facendola interagire con le ragioni della contemporaneità, elaborando progetti nuovi ed evitando di cadere in taluni degli stereotipi derivanti dai motivi per cui molti gruppi sono nati durante il ventennio fascista o subito dopo e dalle esigenze introdotte più di recente dai moderni mezzi di co-municazione di massa: ad esempio, la funzione oleografica, la mercificazione dei canti e dei balli, la spettacolarizzazione televisiva11.
Ma vorrei ora concludere queste riflessioni col ribadire che qualsiasi discorso sui gruppi folcloristici in Italia, che voglia far luce e discutere sul ruolo da essi esercitato o che potrebbero assumere nella società contemporanea, debba non tanto attardarsi sulla legittimità degli scopi spettacolari e, spesso più nel passato che nel presente, oleografici dell’as-sociazionismo coreutico-musicale relativo alle forme espres-sive di tipo tradizionale, quanto collegare l’attività degli stes-si gruppi ai processi, avviatisi soprattutto negli anni Ottanta del Novecento, ma decisamente accentuatisi in quelli a noi più vicini, di ricerca e affermazione delle differenze e delle varietà territoriali, del riuso delle tradizioni locali e, com-
11. Da questo punto di vista, vorrei segnalare l’informato lavoro di Fabio Calzia, a cui si deve una valutazione aggiornata della situazione dei gruppi folcloristici in Sardegna, «con uno sguardo particolare verso le attività più recenti intraprese dai gruppi, che […] non si limitano più alla riproposizione in forma spettacolarizzata di un repertorio di danze, ma consistono in nuovi progetti che fanno pensare a una forte presa di coscienza da parte di alcune aree della Sardegna sul ruolo della tradizione e sul nuovo modo di viverla» (cit. calzia F. 2005: 546).
277Gruppi folcloristici e valorizzazione delle culture locali Ferdinando Mirizzi276
plessivamente, delle pratiche conoscitive e rappresentative connesse alla costruzione dei patrimoni culturali come risor-sa identitaria e, possibilmente, economica insieme.
In questa prospettiva, i componenti dei gruppi folclo-ristici potrebbero essere inclusi tra coloro che Hugues de Varine chiama «i militanti locali del patrimonio»12, al cui servizio essi potrebbero mettere la loro capacità di costru-ire rappresentazioni del passato in funzione dei bisogni del presente e delle ricadute nel futuro. Ma ciò può verificar-si solo a condizione che essi non intendano la tradizione come lo “ieri” che persiste nell’“oggi” ma, così come hanno dimostrato etnologi francesi quali Jean Pouillon e Gérard Lenclud, come qualcosa che non esiste in quanto già dato, nella sua oggettività e autoevidenza, ma come un prodotto del presente scaturito da forme di filtrazione e riappropria-zione selettiva degli elementi culturali ereditati dal passato e spesso depositati nella memoria individuale e collettiva che, divenuti così patrimonio, servano a soddisfare istanze socia-li interamente connesse al mondo attuale13. Se così sarà, i gruppi riusciranno a fare del proprio repertorio la risposta a una domanda di tradizione come fattore di collegamento tra generazioni diverse che si riconoscono in uno stesso luo-go, una stessa matrice culturale, una memoria condivisa che avverte il bisogno di essere riproposta alle successive genera-zioni, adattata ai nuovi contesti e, insomma, continuamente riplasmata. Una memoria che, per questo, ha la necessità di ricorrere, come ha scritto Aleida Assmann, a «mediatori di deposito e pratiche culturali»14. Ecco, penso che, se i grup-pi folcloristici, al di là delle ragioni che ne hanno orientato in passato l’attività, riusciranno a interpretare la tradizione come cambiamento, ferma restando una sua riconoscibile
12. Cit. De varine h. 2005 [2002]: 22.13. Cfr. lencluD G. 2001 [1987].14. Cit. assmann a. 2002 [1999]: 20.
coerenza nel rapporto di continuità intergenerazionale, allo-ra essi riusciranno a porsi come «mediatori di deposito» e a rendere i loro repertori e le loro rappresentazioni «pratiche culturali» in grado di contribuire alla comunicazione di una parte dell’insieme di valori sui quali finiscono con il costitu-irsi i principi etici e il profilo identitario del proprio gruppo sociale e comunitario. Credo che questa sia, al di là della loro storia e delle critiche che fino a oggi si sono complessi-vamente riversate su di essi, la sfida su cui si misurerà la loro capacità di essere risorse per la promozione del territorio e della cultura locale.