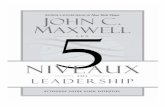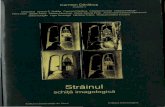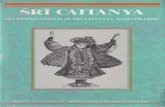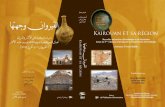Cherchez la vache: i riti del bue nell’Italia Centrale
Transcript of Cherchez la vache: i riti del bue nell’Italia Centrale
Il I Convegno Nazionale dell’Anuac (Associazione Nazionale Universitaria An-tropologi Culturali), svoltosi a Matera dal 29 al 31 maggio 2008 e dedicato al tema dei“Saperi antropologici: media e società civile nell’Italia contemporanea”, ha celebratopubblicamente, a distanza di due anni dalla sua creazione il 6 giugno 2006, la nascitadi una nuova associazione demoetnoantropologica italiana, la quale ha da subito intesodi portare avanti le necessarie politiche di promozione delle figure professionali col-legate alla formazione demoetnoantropologica, un campo oggi ancora poco fertile inItalia, ove la figura dell’antropologo è spesso di difficile collocazione, per quanto vene siano le condizioni e per quanto vi siano forti richieste, che vengono dal mondodel lavoro, rivolte a profili le cui caratteristiche aderiscono ai percorsi DEA.
LE CURATRICILuisa Faldini, etnologa, è professore ordinario di Etnologia presso il Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova. Coordinatrice di diversiprogetti di ricerca e valutatrice per diverse istituzioni, anche internazionali, è attual-mente presidente dell'Anuac, di cui è stata socia fondatrice. Americanista, da diversianni svolge ricerche sulle religioni afroamericane, nell'ambito delle quali, dalla finedegli scorsi anni '90, svolge ricerche sulla struttura dello spazio simbolico presso alcunisantuari di candomblé brasiliani dell'area paulistana, in relazione alle quali ha pubbli-cato saggi su riviste e collettanee, ha curato volumi ed è stata autrice di alcune mono-grafie, tra le quali Il Vodu (1999) e Biylù (2009).
Eliana Pili, antropologa, è collaboratrice alla didattica presso la sezione di Etno-logia del Dismec (Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea) dell’Universitàdegli Studi di Genova. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Antropologichepresso l’università di Torino, con una tesi dal titolo Ayne tila: l’ombra dell’occhio. At-tori e saperi della cura ad Addis Abeba. Dal 2001 svolge ricerche sui saperi e sulle pra-tiche di cura tradizionali delle popolazioni amhara dell’Etiopia. Nell’ambito delProgetto di Rilevante Interesse Nazionale “Turismo e sostenibilità in Africa” (2004-2006) si è occupata del fenomeno turistico che interessa la città di Lalibela, nell’Etiopiasettentrionale.
GLI AUTORIBruno Barba, Ivan Bargna, Paride Bollettin, Suomi Bombelli, Massimo Bressan,
Maria Luisa Ciminelli, Chiara Cipollari, Pietro Clemente, Antonino Colajanni, Ar-mando Cutolo, Fabio Dei, Ugo Fabietti, Adriano Favole, Antonella Iacovino, MicheleIannuzzi, Eugenio Imbriani, Alexander Koensler, Franco Lai, Vito Lattanzi, SilviaLelli, Vanessa Maher, Francesco Marano, Carlo Maxia, Caterina Miele, FerdinandoMirizzi, Gabriella Mondardini, Cristina Notarangelo, Berardino Palumbo, GiancarloPichillo, Sandro Piermattei, Eliana Pili, Sandra Puccini, Veronica Redini , FrancescoRemotti, Bruno Riccio, Annamaria Rivera, Emanuela Rossi, Pino Schirripa, AmaliaSignorelli, Alessandro Simonicca, Barbara Sorgoni, Gianfranco Spitilli, Davide Torsello,Sabrina Tosi Cambini, Valeria Trupiano, Dorothy Louise Zinn
In copertina: un’immagine della città di Matera.
Questo libro, sprovvisto del talloncino a fronte, deve considerarsi «copia saggio, campionegratuito» non in commercio e, quindi, non può essere venduto o ceduto ad alcun altro ti-tolo. (Vendita e altri atti di disposizione vietati: Art. 1, comma 2, legge 633/1941). EsclusoIVA Art. 2, comma 3, lettera d) DPR 633/72.
ISBN 978-88-7975-524-5
FALDINI PILI
9 788879 755245
cop_faldini_matera_1_copertina terrorismo 26/09/11 13.41 Pagina 1
SAPERI ANTROPOLOGICI, MEDIA E SOCIETÀ CIVILE
NELL’ITALIA CONTEMPORANEAATTI DEL
1° CONVEGNO NAZIONALE DELL’ A.N.U.A.C.
MATERA, 29-31 MAGGIO 2008
A cura diLuisa FALDINI e ELiaNa PILI
Il CISU ringrazia gli Autori, i collaboratori e i Lettoriche con i loro suggerimenti consentono
una sempre migliore qualità dei libri pubblicati.
Tutti i diritti sono riservati.Questo volume non può essere riprodotto, archiviato o trasmesso, intero o in parte, in qualunque modo (digitale, elettronico, ottico, meccanico o regi-strato).
Le fotocopie per uso personale del lettore sono consentite nei limiti del 15% di ciascun volume solo dietro pagamento alla SIAE del compenso previ-sto dall’art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e in base all’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, Confartigianato, CASA, CLAAI, Con-fcommercio, Confesercenti il 18 dicembre 2000.
Le riproduzioni per uso differente da quello personale, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, necessitano dell’autorizza-zione scritta dell’Editore.
ISBN 978-88-7975-524-5
2011 © CISU Centro d’Informazione e Stampa Universitaria di Colamartini Enzo s.a.s.
Via dei Tizii, 7 – 00185 Roma Viale Ippocrate, 97 – 00161 Roma Tel. 06491474 – Fax 064450613 E-mail: [email protected] Internet: www.cisu.it
SOMMARIO
Introduzione, Luisa Faldini e Eliana Pili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9
I SESSIONELUOGhI, PERCORSI, INCONTRI:
ANTROPOLOGIA E GLOBALIZZAZIONE
Ugo Fabietti
Relazione introduttivaL’antropologia e il paradigma della contemporaneità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29
INTERVENTI
Franco Lai
A partire dal villaggio elettronico di McLuhan: innovazione tecnologica, crea-tività, globalizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 43 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 46
eUgenio imbriani
Parlare per gli altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 51 Macaronico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 51 L’ironia all’opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 55 Finalino. Un etnografo sul campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 58Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 59
Pino SchirriPa
Chiese e globalizzazione nelle antropologie africanistiche contemporanee . . . » 61 Gli antropologi e le chiese africane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 61 Dalle chiese indipendenti africane alle chiese pentecostali-carismatiche . . . . . . . . . . » 63 Il vangelo della prosperità e gli spiriti del neoliberismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 64 Diaspore e cittadinanza: il caso delle chiese ghanesi in olanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 67Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 69
II SESSIONESOSTANZE MAGIChE: LA COSTRUZIONE DELLE IDENTITÀ
Franco remotti
Relazione introduttivaIdentità e impoverimento culturale. Contro l’identitarismo in antropologia . » 73 L’identità e la cassetta degli attrezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 73 Il fascino della “sostanza” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 77 Costruzione, finzione, illusione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80 Il riconoscimento dei “noi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 83 À rebour. Il tema dell’impoverimento culturale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 87Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 91
4 Indice
INTERVENTIarmando cUtoLo
Autoctonia, cittadinanza e politiche della vita in Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 97 Autoctonia, cittadinanza e naturalizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 98 La postcolonia e il governo della vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 101 Governamentalità, popolazione, popolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 103 Autoctonia e tanatopolitica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 106La lunga durata della “ingenuità”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 107Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 110Fabio dei
Identità, culture e mondi della vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 115 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 115 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 116 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 117 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 119Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 121aLeSSandro Simonicca
Note sugli spazi della cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 123 Pensare il territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 123 Etnografia multi situata: soluzione o problema? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 126 La questione dei giovani adulti e la “identità toscana” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 128Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 133
III SESSIONEMIGRAZIONI, TRA DIRITTI, DESIDERI, PAURA E REPRESSIONE
Relazione introduttivaVaneSSa maher
Il rimpatrio dell’antropologia e l’espatrio dei suoi soggetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 137 Le migrazioni fondative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 138 Le migrazioni contemporanee come esito di esperienze storiche . . . . . . . . . . . . . . . . . » 140 Le politiche nei confronti delle migrazioni e la formazione di minoranze subal- terne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 142 Come si producono le minoranze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 144 La produzione delle minoranze in italia e il ruolo della scuola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 146 Diventare stranieri, diventare autoctoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 148 L’incertezza dei migranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 149 Le incertezze degli autoctoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150 Antropologia: l’arte di muoversi nell’incertezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 151 Gli antropologi di fronte al senso comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 153 1. All’università le ragazze musulmane possono fare le proprie scelte . . . . . . . . . . . . » 155 2. La diaspora di una famiglia rom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 156 3. Il ragazzo ghanese: dal Sudafrica a Verona. Estate 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 157 4. Incontri di buona volontà nei tendoni di Verona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 157 La storia degli studi antropologici sulle migrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 158 Rimpatrio dell’antropologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 159 L’espatrio dei soggetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 160Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 163
Indice 5
INTERVENTIbrUno riccio
Migrazioni e sviluppo: opportunità metodologiche nello studio di un legameambivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 169 Il nesso migrazioni-sviluppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 169 Co-sviluppo e associazioni di migranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 170 Ambivalenze translocali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 172 Opportunità metodologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 174Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 176annamaria riVera
Fra i migranti: per un’antropologia simmetrica e riflessiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 179 Il metodo biografico: fra empatia e distacco critico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 179 Immigrati non si è, si diventa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 181 A proposito di alcuni fantasmi collettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 182 Per un uso critico di transmigrazione e transnazionalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 184 Tradizione/modernità e lavoro salariato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 185 L’economico, il soggettivo, il simbolico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 186Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 187dorothy LoUiSe Zinn
«Guardo me che guardo loro che da sempre mi guardano». La letteratura dei migranti in Italia come critica culturale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 189Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 199
IV SESSIONEISTITUZIONI, AUTORITÀ, POTERI
Relazione introduttivaberardino PaLUmbo
La somiglianza è un’istituzione: classificare, agire, disciplinare. . . . . . . . . . . . . . . . » 205 Amichevole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 205 Classificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 206 Agire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 218 Disciplina e governamentalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 227 I topi sono più facili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 235Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 238
INTERVENTIadriano FaVoLe
Per un’antropologia della democrazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 247 Le democrazie degli altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 249 La retorica della democrazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 250 I limiti interni della democrazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 251 I limiti esterni della democrazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 251 Democratizzare l’etnografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 252Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 253
6 Indice
barbara Sorgoni
Alcune note etnografiche su politiche istituzionali e pratiche sociali nellagestione dei richiedenti asilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 255 Operatori e utenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 257 Strumenti di controllo e classificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 261Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 264daVide torSeLLo
Fiducia e corruzione tra retorica e cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 267 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 267 Il fallimento della cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 270 Retorica tra idee e azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 273 Conclusione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 277Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 277brUno barba
La magia della persuasione. Potere religioso, potere politico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 281 Il capo: un uomo sempre straordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 283 Magia e incertezza: la benedizione della massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 285 Chi vuole la guerra? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 288Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 290
V SESSIONELA MEMORIA E LE COSE: ANTROPOLOGIA DEI PATRIMONI
Relazione introduttivaPietro cLemente
L’antropologia del patrimonio culturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 293 Una pratica post-classica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 293 Scrivere con i musei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 296 La scena europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 297 Gli Usa e il mondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 301 Unesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 303 Politiche e pratiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 306 Il contemporaneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 308Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 313
INTERVENTImaria LUiSa cimineLLi
Ritorno a Mashpee: alcuni problemi antropologici trasversali nei nuovi stru-menti internazionali a difesa delle culture locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 319Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 326Vito LattanZi
Culture della diaspora, musei e dialogo interculturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 329 Diaspore al Mibac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 329 Diaspore e museo collaborativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 331 Nella rete europea dei musei etnologici: verso una nuova missione . . . . . . . . . . . . . . » 333Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 337
Indice 7
Ferdinando miriZZi
Unesco, patrimonio, museo: il caso di Matera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 339Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 346
VI SESSIONEPADRI E FIGLI: GENEALOGIE INTELLETTUALI
NELL’ANTROPOLOGIA ITALIANARelazione introduttivaamaLia SignoreLLi
Tra Ernesto De Martino e Franz Boas: La nascita dell’antropologia culturalein Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 351Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 364
INTERVENTISandra PUccini
Alla ricerca degli antenati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 367 Antropologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 368 Caratteri nazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 370 Italiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 371 La grande rimozione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 372 Umanesimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 374 Ritardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 376 Per concludere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 379Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 380antonino coLajanni
Genealogie indirette e oblique di una parte dell’antropologia italiana: note sui rap-porti tra l’antropologia sociale britannica e le ricerche italiane negli anni ’60-’80 » 383 Le tradizioni antropologiche. Genealogie interne ed esterne nella formazione delle correnti di studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 383 L’autonomia della tradizione italiana. I tre “campi” e le loro interrelazioni (Tradi- zioni Popolari, Etnologia, Antropologia Culturale) negli anni Sessanta-Settanta » 386 Protezioni della tradizione italiana ed esterofilìe. Le prime difficoltà nei contat- ti con l’estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 389 La Social Anthropology britannica in Italia negli anni Sessanta: consensi, critiche e affiliazioni precoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 393 Derive autarchiche nell’antropologia culturale italiana. Un dibattito mancato . . » 403Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 407FranceSco marano
I padri dell’antropologia visuale italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 409Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 417
LAVORI IN CORSO1. SpazimaSSimo breSSano e Sabrina toSi cambini
Etnografia urbana e periferie italiane in trasformazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 421 Dove ci collochiamo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 421
8 Indice
Cosa si gioca in queste aree della città? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 425 Spazio urbano e metafore del cambiamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 429Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 430SiLVia LeLLi
Zone di transazione. Mercati come luoghi di costruzione sociale: scambi di mer-ci e di significati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 433 Dal linguaggio alla città. Nota teorico-metodologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 433 Il mercato come nodo sociale e politico, tra commercio e dono . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 436 L’imprevisto, anche linguistico, fa società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 437 Strategie economico-politiche locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 439 Conclusioni politiche, temporanee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 439Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 440aLexander KoenSLer
Cambiare il mondo e aprire il cuore? Negoziare modelli di convivenza nelNegev (Israele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 443 Note sul contesto dei movimenti sociali nel negev: un laboratorio delle politiche dell’identità? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 443 Come ordinare i modelli di convivenza promossi dagli attivisti? . . . . . . . . . . . . . . . . » 444 Mettere a fuoco due attività contro le demolizioni nei paesi non ufficiali . . . . . . . . » 446 Considerazioni conclusive: oltre le ambiguità delle politiche multiculturali? . . . » 448Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4492. Turismo e processi di globalizzazioneiVan bargna
Arte e paesaggio alla Chefferie di Bandjoun (Camerun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 451Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 458chiara ciPoLLari
Il “passato” da esibire, vedere e portare a casa. Il caso del turismo rurale inMaramureş (Romania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 461Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 468Veronica redini
Il Made in Italy delocalizzato. Autenticazione, valore e proprietà delle merciitaliane prodotte in Romania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 471Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 477Sandro Piermattei
“Coltivare contributi”, “Vendere paesaggi”: scene di vita sociale di tre dispo-sitivi della politica agraria comune nelle pratiche e nei discorsi di alcuni impren-ditori agricoli del Parco Nazionale dei Monti Sibillini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 479Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4853. Identità memoria saperigabrieLLa mondardini
Emozioni del mondo marinaro: tradizioni declinate al futuro . . . . . . . . . . . . . . . . » 487 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 487 Un “terreno” in trasformazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 488 Emozioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 489 Tradizioni declinate al futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 491Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 494
Indice 9
VaLeria trUPiano
Il parco genetico del Cilento e del Vallo di Diano. Una “ricerca genetica” tra scienza e politica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 497 Biopotere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 498 Partecipazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500 Bioetica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 502 Parentela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 503 Isolamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 504 Patrimonializzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 505 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 507Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 507caterina mieLe
Italiani in Libia. Discorsi e politiche coloniali, memorie ed identità postcoloniali » 509Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 515eLiana PiLi
I Bahlawi Hakim di Addis Abeba. Saperi della cura e pratiche terapeutichedi una metropoli africana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 517Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 523gianFranco SPitiLLi
Cherchez la vache: i riti del bue nell’Italia Centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 525 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 525 Censimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 527 Modelli paradigmatici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 529 Santi, Madonne e buoi. Sistema mitico e costruzione festiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 531 Un caso esemplificativo: la Madonna di costantinopoli, i buoi, i “partiti”, il paese » 532Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5384. Politiche, istituzioni, economieParide boLLettin
Le merci dei Kuben, stranieri, i Kukradja, ed il prestigio tra i Mebengokré-Xi-krin del fiume Bakajá in Amazzonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 541Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 547criStina notarangeLo
I movimenti islamisti in Marocco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 549Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 555SUomi bombeLLi
Clientelismo ed etnicizzazione: dinamiche nella scelta del voto dei francesi di ori-gine magrebina a Marsiglia durante le elezioni nazionali e locali (anni 2007-2008) » 557Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 565gianFranco PichiLLo
Poteri “tradizionali” e democrazia liberale nel Ghana postcoloniale: brevissimenote da una ricerca antropologica in corso su alcune istituzioni tradizionali neldistretto Ahanta West, Ghana sud-occidentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 567 Breve introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 567 L’analisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 568Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 574
10 Indice
5. PatrimoniantoneLLa iacoVino
Musei demoetnoantropologici lucani in Rete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 577 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 577 Descrizione del progetto di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 578 L’attività svolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 578Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 585carLo maxia
Coiài su ferru (sposare i campanacci). L’estetica dei suoni nel pastoralismo sardo » 587 Funzioni: l’utilità dei suoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 590 Estetiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 592Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 594micheLe iannUZZi
La scrittura negli ex voto e altre forme di scrittura votiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 595Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 603emanUeLa roSSi
Musei e mondo postcoloniale: un progetto canadese sulle culture aborigenedella regione dei grandi laghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 605 Preambolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 605 Preparando il terreno: verso il paradigma collaborativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 606 Il modello collaborativo in canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 608 Il Grasac e le sue finalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 612 La necessità di una collaborazione a livello internazionale nello studio del patri- monio dei nativi della regione dei grandi laghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 613 La sfida del Grasac: ricomporre i saperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 614 L’urgente necessità di trasferire competenze e saperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 615 Il digitale come opportunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 615Riferimenti bibliografici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 616
CHERCHEZ LA VACHE: I RITI DEL BUE NELL’ITALIA CENTRALE
Gianfranco Spitilli1
Premessa
Cherchez la vache: con questa espressione Evans-Pritchard rappresentava la centralità del bestiame nella vita dei Nuer.2 Era un consiglio immaginario per chi volesse studiarne i comportamenti e la vita quotidiana, scandita dalla presenza dei bovini, dalla loro essenzialità. Siamo nel Sudan anglo-egiziano, nel 1930.
Trasferita nell’Italia centrale e nell’ambito della presente ricerca, l’indicazione non cambia di significato. Il bue e la vacca sono, in tale contesto, animali di grande forza evocativa: nella memoria culturale e nella dimensione rituale continuano ad essere un fondamentale dispositivo simbolico la cui utilizzazione nel tessuto festi-vo è documentata nelle forme più sorprendenti e diffuse.3
Vincenzo Padiglione sintetizza con grande efficacia descrittiva questa valenza significativa dell’animale:
«Bisogna aver osservato il bovino maschio intento al lavoro. Quando spesso in coppia – procede ciondolante sulla strada trainando un enorme carro di fieno o quando in mezzo al campo, con fare lento ma continuo, rompe le zolle. Maestro dell’aratura profonda, da ogni altro animale insuperato in questo onere e solo in parte sostituibile per efficienza e duttilità dal trattore meccanico. Bisogna, altresì, essere stati sorpresi dal profondo muggito che inquieta la notte contadina – un ele-mento che tanto caratterizzava il paesaggio sonoro del passato –, e aver partecipato a veglie tra parenti e vicini dove si raccontano leggende di strani buoi, ad un tempo mansueti e testardi, comunque interpreti al meglio con i loro gesti del volere divino. Storie di improvvisi inginocchiamenti al passare di reliquie o racconti di cocciute soste indotte dai buoi e grazie alle quali si sarebbero ritrovate miracolose icone o localizzata la fondazione di santuari» (Padiglione, 2004, p. 15).
Se questa attitudine appare molto diffusa ciò sembra corrispondere ad una specifica dimensione storico-economica, la cui rilevanza è in rapporto alla funzio-
1 Sapienza. Università di Roma.2 «Cherchez la vache è il miglior consiglio che si possa dare a chi desideri capire il comportamento
nuer» (Evans-Pritchard, 2003, p. 51).3 Il presente articolo è la rielaborazione di alcune sezioni della mia tesi di dottorato, centrata
sull’individuazione di un complesso di riti con partecipazione di animali bovini nell’area dell’Italia centrale, per i quali si definisce una proposta interpretativa fondata sull’analisi di nove contesti fe-stivi: G. Spitilli, I riti del bue nell’Italia centrale, tesi di dottorato in Etnoantropologia, Letterature e pratiche simboliche, Rito e mito, Università degli Studi di Roma La Sapienza, A.A. 2005-2006; desidero esprimere il mio ringraziamento ad Antonello Ricci e Giordana Charuty per aver sostenuto la mia ricerca e guidato la stesura del testo in tutte le fasi della sua complessa costruzione.
526 Gianfranco Spitilli
ne concreta che gli animali bovini hanno assolto nella storia del territorio indagato, analogamente alla gran parte delle regioni dove l’agricoltura o la pastorizia sono state al fondamento delle attività produttive. La stretta relazione fra funzioni eco-nomiche e funzioni rituali, con riferimento alla domesticazione del bovino e alla sua utilizzazione nella quotidianità fino all’epoca attuale, apre tuttavia il campo a considerazioni che evidenziano come la sfera ideologica non possa essere deter-ministicamente ricondotta ad una semplice conseguenza delle necessità di ordine materiale. Questa interpretazione riduttiva, che vede nell’uso rituale dell’animale bovino o nella sua presenza in un articolato ma coerente corpus di leggende un semplice mezzo di trasporto o più in generale di lavoro, appare piuttosto inade-guata a rendere conto dell’estrema complessità di utilizzo riscontrata non solo nell’area interessata dalla presente ricerca, ma in tutte quelle culture dove tale rap-porto acquisisca tratti significativi.
Con riferimento alle società pastorali africane che, con le dovute differenze rispetto ai contesti qui documentati, testimoniano in maniera estremamente ricca i caratteri di questa specifica relazione, Savino Di Lernia scrive:
«Il ruolo centrale che gli animali possiedono, e in particolare i bovini, si ma-nifesta in moltissime espressioni di queste società, dall’organizzazione insediativa (craal o pen al centro del sito), all’arte figurativa (la costante presenza delle man-drie in gran parte delle opere d’arte rupestre preistorica e in quelle più recenti dei pastori Fulani). In questo senso, una prospettiva esclusivamente determinista non appare sufficiente, e l’equazione mutamento climatico = adattamento culturale… deve essere necessariamente integrata da un approccio che tenga pienamente conto degli aspetti simbolici» (Di Lernia, 1999, p. 13).
L’osservazione è utile ad inquadrare un tema centrale nelle riflessioni di nu-merosi antropologi,4 primo fra tutti dello stesso Evans-Pritchard, che dedica al complesso rapporto dei Nuer con il loro bovini un ampio capitolo di apertura dal significativo titolo L’interesse per il bestiame, dove è a più riprese messo in luce come gli animali occupino trasversalmente ogni attività significativa della vita quotidiana, dai rapporti sociali agli atti rituali, dalle concezioni religiose alle arti plastiche e poetiche (Evans-Pritchard, 2003, p. 51-93).5
L’attenzione che le società mediterranee hanno manifestato per il bovino sin da epoca remota, ponendolo nel cuore della sfera religiosa e qualificandolo come animale preferenziale nell’ambito della speculazione mitologica e della costruzio-ne rituale, si ritrova con straordinaria diffusione anche nella realtà contemporanea:
4 La bibliografia di riferimento è amplissima e si arricchisce, inoltre, del significativo contributo di archeologi ed etnoarcheologi; per un panorama esaustivo degli studi sulla relazione simbolica uomo-bovino nelle società pastorali e agricole si vedano le bibliografie contenute in Arioti M., Ca-sciarri B. (a cura di), 1999, La Ricerca Folklorica, 40, ottobre.
5 La riflessione è ulteriormente ampliata in un’altra opera dell’antropologo britannico, dove si definisce il particolare vincolo che lega gli uomini agli animali nei rituali di iniziazione; cfr. La religione dei Nuer, in particolare il paragrafo La funzione sacrificale del bestiame (Evans-Pritchard, 1965, p. 69-118).
Cherchez la vache 527
«Si aujourd’hui… j’avais à rechercher une unité dans la Méditerranée, à la lumière des résultats de nos travaux, c’est dans l’importance des bovins et des ovins dans les religions de la Méditerranée que j’aurais tendence à la trouver. En ef-fet, leur rôle est primordial dans tout le bassin méditerranéen… Les vaches dans l’Egypte ancienne, les taureaux en Crète et en Asie Mineure, pour ne parler que des exemples les plus connus… Si, dans ces temps aussi reculés et dans des lieux aussi différents que Mycénes, Cnossos ou la Syrie, le taureau était un des éléments essen-tiels des rites religieux, n’est-il pas pour le moins intéressant de constater qu’aujou-rd’hui au XXe siècle chaque fête religieuse espagnole s’accompagne de rites taurins dont la plupart sont des sacrifices?» (Pitt-Rivers, 2001, p. 62).
Le considerazioni di Julian Pitt-Rivers conducono nel cuore della presente ricerca. L’interesse maturato nel corso degli anni per la complessità delle relazioni che le comunità centro-italiane intrattengono con la specie bovina mi ha portato a tentare di approfondire questo legame all’interno di contesti specifici, al fine di porne in risalto i tratti distintivi. La ricerca ha perseguito due obiettivi principali: individuare dei caratteri sistematici nelle feste con partecipazione di animali bovini e restituirne la complessità simbolica, attraverso un duplice percorso di mappatura generale e di verifica contestuale tramite la pratica etnografica, cui segue una pro-posta di lettura ed interpretazione dell’insieme di ritualità osservate.
Un’analisi morfologica finalizzata alla costruzione di un sistema di relazioni deve necessariamente prendere le mosse da una quantità significativa di dati, perché siano evidenziabili le situazioni paradigmatiche, qualora se ne riscontri la presenza. Cherchez la vache ha significato, nel quadro concettuale indicato, condurre un percorso di ricerca territoriale contestualizzato in una vasta area dell’Italia centrale, sulle tracce di una specifica configurazione rituale e con un preciso obiettivo: ren-dere manifesta, attraverso un’accurata ricognizione, la centralità dell’animale bovi-no nell’elaborazione ed articolazione di riti e festività patronali; sul piano simboli-co la densità territoriale riscontrata si è trasformata in chiave di accesso, dispositivo interpretativo del ruolo in esse giocato dagli animali bovini, in un rimando costante ad una dimensione leggendaria e arcaica del rapporto uomo-animale, ricontestua-lizzata con grande duttilità plasmatoria nelle figurazioni festive contemporanee.
Censimento
Il territorio di riferimento preso in considerazione per il rilevamento, inqua-drato inizialmente nell’area delle regioni Abruzzo, Molise e Lazio, ha avuto in realtà confini fluttuanti in rapporto alla costante ridefinizione delle località delle feste individuate; nel corso della ricerca alcune aree non preventivate nel progetto iniziale, corrispondenti alle province di Ascoli Piceno e Macerata nelle Marche e alla dorsale collinare e pedemontana delle province di Caserta, Benevento e Avelli-no in Campania, hanno assunto una rilevanza tale da dover essere necessariamente incluse nell’indagine.
528 Gianfranco Spitilli
I criteri di selezione delle feste sono stati anch’essi, nella fase iniziale, di carat-tere comprensivo più che esclusivo: scopo preliminare era individuare quelle feste dove la presenza dei bovini fosse documentata nell’attuale svolgimento del rito o in un passato più o meno recente. Questa direttiva interna ha permesso di include-re nel quadro del rilevamento quelle feste dove il bovino sembrava investito di un ruolo del tutto accessorio, in genere relegato a funzioni di trasporto: approfondi-menti in merito avrebbero trovato spazio in seguito, per evitare di censurare a pri-ori in base ad impressioni di superficie. In alcuni casi questa prudenza si è rivelata significativa e ha portato alla definizione di nuove tipologie rituali.
Come riferimento generale, tuttavia, l’attenzione era rivolta a quei rituali dove il bovino acquisiva un ruolo di evidente centralità o di marginalità apparente, in-tendendo con quest’ultima espressione il sospetto, frequentemente emerso, che nell’attuale svolgimento di uno specifico cerimoniale l’animale avesse assunto for-malmente un ruolo secondario pur costituendone di fatto l’elemento fondante.6
La modalità pratica di attuazione del censimento è stata complessa e non priva di difficoltà; si è sviluppata utilizzando quattro sistemi differenti e complementari di rilevamento: Internet, il mezzo postale, lo spoglio bibliografico e la consulta-zione di ricercatori.
Il censimento ha portato al rilevamento di 95 feste nell’area indicata: 58 risul-tano essere ancora attive, tra le quali 12 hanno visto la sostituzione dei bovini con mezzi meccanici e dunque una sorta di continuità del rito; 33 sono le feste estinte, 26 nel corso del Novecento, 5 nell’Ottocento, 2 nel Settecento, 1 nel Seicento, 2 nel Cinquecento, 1 nel Quattrocento;7 delle restanti non si hanno notizie che per-mettano di appurare la data di estinzione.
Nella valutazione della diffusione regionale delle feste i dati emersi sono i se-guenti: Lazio 31, Molise 13, Abruzzo 24, Marche (due province) 5, Umbria 3, Campania (tre province) 19, Puglia (una provincia) 1.8 In relazione alle 95 feste documentate, la concentrazione di 39 di esse in quattro “cardini” temporali precisi (fine aprile, 13 giugno, metà agosto, inizio settembre), sembra essere un elemento significativo, da valutare anche in connessione con i culti cui tali termini calenda-riali fanno riferimento: S. Antonio da Padova, la Madonna Incoronata, l’Assun-zione di Maria, S. Rocco e in misura minore S. Michele Arcangelo, la Madonna della Neve, la Madonna delle Grazie, la Madonna della Misericordia, S. Isidoro, la
6 È il caso, ad esempio, della festa di S. Urbano a Bucchianico (Ch), dove il vitello riveste anche agli occhi dei partecipanti un ruolo marginale rispetto alle forme spettacolari che ha assunto nel tem-po l’articolazione processionale, pur aprendo di fatto la processione ed essendo oggetto di una messa a morte rituale e di un consumo comunitario delle carni nei banchetti festivi.
7 L’incongruenza tra il dato generale delle feste estinte e la classificazione dell’epoca di estinzione dipende dalla presenza di rituali differenti in alcune località.
8 La provincia di Foggia non è stata oggetto di una vera e propria ricognizione: il dato risulta dall’inserimento nel complesso generale di feste della corsa dei carri di Chieuti, ritenuta fortemente assimilabile al contesto culturale contiguo delle tre corse di carri molisane e pertanto presa in con-siderazione.
Cherchez la vache 529
SS. Croce, S. Anna. Le Madonne, viste come generico insieme, assorbono la mag-gior parte dei culti registrati (38).
I dati si prestano anche a considerazioni di tipo areale:9 la categoria del solco dritto, divisa in gare e tracciature, è la più rappresentata dopo le processioni (36), con una maggiore concentrazione nell’area dell’alto viterbese e lungo la fascia ap-penninica; si definiscono inoltre alcune tipologie precise identificate nella corsa dei carri (concentrate nel basso Molise) e la caccia (prevalentemente nell’area umbro-marchigiana), queste ultime estinte quasi ovunque ma dotate di una propria iden-tità rituale e vicine alla categoria della lotta fra tori, riscontrata per una sola volta; anche la pratica del trasporto del santo con bovini tende a concentrarsi nel basso Molise, nelle festività dedicate a Sant’Antonio da Padova o come esito della gara nelle corse dei carri, in rapporto ai culti della Madonna di Costantinopoli, San Giorgio, San Leo e della SS. Croce.10
Modelli paradigmatici
La definizione di una classificazione tipologica e areale dei rituali censiti con-sente l’individuazione di un sistema circoscritto di elementi, dai caratteri abba-stanza omogenei. L’insieme delle feste distinte dalla partecipazione di animali bo-vini presenta situazioni paradigmatiche, da cui è possibile ricavare un delimitato quadro rituale di modelli tipologici ricorrenti:A. Solco (tracciatura o gara)B. Corsa dei carriC. Caccia D. Lotta fra toriE. InginocchiamentoF. Processione di carri fioratiG. Processione del grano e/o “Giglio”h. Processione di buoiI. “Maggio” e/o trasporto rituale di legnaJ. Messa a morte e consumo ritualeK. Trasporto statua/effige/palio
Le prime tre categorie sono quelle più sistematiche e chiaramente definite; la lotta fra tori è un caso unico ma sufficiente a delineare una specifica tipologia; l’inginocchiamento invece, è sempre parte di un complesso festivo sovrastruttu-rato, ma costituisce un modello rituale dai tratti precisi e distinguibili, tanto da essere di frequente il centro cerimoniale delle stesse feste cui è vincolato. I tre tipi processionali, pur presentando delle similarità e a volte delle intersecazioni di ele-
9 Non è possibile in questa sede riportare nel dettaglio tutti i dati emersi dal censimento; per un approfondimento si veda Spitilli, 2005-2006, p. 37-71.
10 Il trasporto della statua su carro è anche nella festa di Sant’Adamo del 2 giugno a Guglionesi (CB) e nella festa di Sant’Anna del 26 luglio a Jelsi (CB).
530 Gianfranco Spitilli
menti, hanno un proprio contrassegno specifico che li identifica e li distingue. Le processioni dei carri fiorati, secondo quanto analizzato in precedenza, si svolgono per tutto il mese di maggio fino al 13 giugno, ricorrenza della festa di Sant’Antonio da Padova cui sono prevalentemente dedicate. Le processioni del grano si divido-no in tre sottoinsiemi: processioni dei covoni, processioni delle “treglie”, tiro del “giglio”; con netta prevalenza sono dedicate a San Rocco e alla Madonna e cadono tra la seconda metà di luglio e la metà di agosto, momento nel quale si verifica la massima concentrazioni di feste. Le processioni di buoi presentano alcune varie-tà, come le processioni degli armenti per Sant’Antonio da Padova o la Madonna Incoronata, quelle dei bifolchi o dei bambini su buoi per lo stesso Sant’Antonio o per la Madonna Assunta, ma sono in gran parte estinte; le processioni dei bambini sui buoi sono abbinate con ricorrenza al modello dell’inginocchiamento.
Il “maggio” è anche un trasporto rituale di legna, mentre un generico trasporto di legna non sempre è un rito del “maggio”; sebbene si tratti di categorie assimila-bili per l’affine costruzione formale del trasporto – e in tal senso sono intese nella classificazione all’interno dello stesso modello –, appare tuttavia necessario man-tenere distinte le denominazioni.
Infine la messa a morte dell’animale, cui segue il consumo delle carni da parte della comunità festiva, assume tratti distintivi che la definiscono come modello tipo-logico a sé stante anche se associato sempre ad altre categorie nello svolgimento ri-tuale, così come il trasporto della statua o di un’effige del santo avviene a volte come unica azione rituale all’interno di una festa, configurandosi come categoria distinta.
Gli undici modelli possono frequentemente abbinarsi tra di loro, nell’ambito di un reale contesto festivo; la complessità morfologica riscontrata in molte delle feste documentate definisce una ricorrente configurazione multisemantica quale componente costitutiva dei riti del bue. Tale poliedricità cerimoniale, all’interno di una stessa festa o nel tessuto di relazioni percorribili tra molte di esse, lascia in-travedere un comune sostrato simbolico che funge da richiamo per l’elaborazione delle differenti azioni rituali.
La proposta di classificazione risponde alla necessità di sistematizzare i dati per la messa in luce di costanti e di regole all’interno del materiale festivo do-cumentato, ed è in tal senso soggetta ad eventuali revisioni. La concretizzazione del percorso di indagine si determina nella verifica etnografica, contestualizzando quanto emerso dall’analisi morfologica nell’osservazione di precisi eventi festivi, sulla base dei modelli tipologici individuati.
La ricerca sul campo è avvenuta tra la primavera del 2004 e l’estate del 2006, articolata in una serie di documentazioni corrispondenti alla distribuzione delle feste lungo l’arco dell’anno: per il 2004 il 30 aprile la festa della SS. Croce a Pa-stena, il 16 maggio la festa dei Banderesi a Bucchianico, il 30 e 31 maggio la festa di San Zopito a Loreto Aprutino, il 5 agosto la festa della Madonna della Neve a Bacugno di Posta, il 21 e 22 agosto la gara del solco a Rocca di Mezzo; per il 2005 il 4 febbraio il Bov Fint a Offida, il 16 maggio la corsa dei carri a Portocannone, il 26 maggio la processione di San Pardo a Larino; per il 2006 il 24 febbraio la par-
Cherchez la vache 531
ziale rifrequentazione della festa di Offida e, il 14 agosto, la tracciatura del solco a Valentano. Come definizione complessiva del quadro di indagine, si aggiungono alle documentazioni effettuate quelle condotte nel triennio precedente a Loreto Aprutino (2001-2002-2003) e a Bucchianico (2003), e un’occasionale visita alla sfi-lata dei carri aprutini di Atri (TE) il 15 agosto 2005, esterna alla selezione delle nove feste. Sono stati documentati direttamente due rituali di tracciatura (Valen-tano e Rocca di Mezzo), una corsa dei carri (Portocannone), una caccia (Offida), due inginocchiamenti (Loreto Aprutino e Bacugno di Posta), due processioni di carri fiorati (Bucchianico e Larino), una processione del grano (Bacugno di Posta), due processioni di bovini (Loreto Aprutino e Bacugno di Posta), un “maggio” e trasporto rituale di legna (Pastena).
Santi, Madonne e buoi. Sistema mitico e costruzione festiva
Una prospettiva ricorrente nel valutare la partecipazione di animali bovini agli eventi festivi è l’immediato confinamento nella dimensione strumentale del trasporto. Questa interpretazione preclude a priori qualsiasi forma di approfon-dimento contestuale, che ponga in luce nel dettaglio la costruzione del rapporto concreto tra l’animale e il rito, la sua presenza o meno nella leggenda di fondazione della festa, la relazione con il culto di riferimento. Nell’ambito di questa ricerca, in base ai dati emersi, la funzione del trasporto non risulta essere preponderante nel complesso delle azioni classificate nel sistema processionale; dal punto di vista della varietà rituale, inoltre, soltanto tre dei modelli individuati risultano contrassegnati dal trasporto in senso stretto, essendo gli altri sei qualificati da un differente utiliz-zo e da una precisa caratterizzazione delle funzioni svolte dall’animale (solco, cor-sa, caccia, lotta, inginocchiamento, processione di bovini), svincolate da qualsiasi forma di relazione strumentale con l’uso praticato nella dimensione quotidiana.11
Un elemento da valutare con attenzione è la natura del vincolo instaurato tra il bovino e il santo: tale aspetto definisce, nella costruzione delle feste, la posizione dell’animale e la sua funzione, in un rimando costante alla vicenda mitica di istitu-zione del culto e dell’evento festivo.
Sul piano leggendario l’associazione trova una sua definizione qualificante; ad una rilettura del quadro generale delle feste, un dato emerge con chiarezza: la
11 La solcatura con animali da tiro, dove essa si è mantenuta, acquisisce nell’attuale contesto una qualificazione puramente rituale, poiché gli animali sono utilizzati per l’aratura solo in occasione della festa. Anche nel caso del trasporto, in ogni modo, sarebbe opportuno verificare, per ogni caso disponibile, se esso abbia una precisa collocazione nella leggenda o sia riconducibile alla semplice funzione di traino legata al bovino; in tal senso appare significativo che il trasporto non sia stato comodamente veicolato da trattori o altri mezzi meccanici, al di là di ipotetiche ragioni finalizzate al mantenimento di una certa spettacolarità del rito, essendo di fatto riscontrato l’avvicendamento in pochissimi casi rispetto alla grande maggioranza di feste in cui gli animali continuano a svolgere la loro funzione, spesso con notevole dispendio di risorse e complesse iniziative locali.
532 Gianfranco Spitilli
connessione del bovino con un preciso sistema di leggende. Un terzo delle feste individuate lega in un nesso inscindibile le modalità di svolgimento della festa con i racconti di fondazione, nei quali i bovini compiono la stessa azione ripetuta nell’at-tualizzazione del rito in un processo di continuo adattamento al contesto locale.
La valutazione di questa ricorrente presenza è delineata attraverso un percorso contestuale, il cui cardine e modello di riferimento è la festa di San Zopito a Loreto Aprutino, la più documentata e quella dove sembrano delinearsi con maggiore chiarezza elementi fondanti della ritualità legata all’animale bovino. Nelle nove feste osservate otto presentano leggende di fondazione, vincolate con un diverso grado di prossimità allo svolgimento rituale. In alcuni casi, in minoranza rispetto alla generalità delle feste, si tratta di leggende extra-locali o in cui il bovino, nella forma in cui ci sono giunte, risulta assente. Nello specifico contesto di Offida, infine, l’appartenenza al Carnevale impone a priori la dissociazione da una forma cultuale, anche se, per alcuni paralleli tipologici della caccia, la dimensione religio-sa è presente e con essa l’accostamento a localizzate leggende di fondazione.
Il percorso interpretativo propone una lettura della leggenda e della festa come un unico complesso, valutando, in una sequenza progressiva, i differenti gradi dell’identificazione tra l’animale e il santo (Charuty, 2001).12 I risultati ottenuti sono, in alcuni casi, sorprendenti; in altri l’insieme dei dati disponibili non ha con-sentito che l’accenno ad una possibile direzione d’analisi.
Le indagini sul terreno rivelano, in definitiva, un principio esplicativo la cui persistenza appare inequivocabile: la predisposizione dell’animale bovino ad esse-re oggetto di specifici processi mitopoietici, quale mediatore rituale tra la dimen-sione mitica e la comunità umana.
Un caso esemplificativo: la Madonna di Costantinopoli, i buoi, i “partiti”, il paese
Nei tre paesi albanesi di Ururi, Chieuti e Portocannone, localizzati nella bassa provincia di Campobasso e nella porzione settentrionale della provincia di Foggia, la struttura mitica ricalca il medesimo nucleo tematico della traslazione, su cui è innestato il complesso leggendario della migrazione: i buoi, aggiogati ad un carro, interpretano la volontà del santo individuando il luogo dove desidera dimorare, fondando contemporaneamente una comunità, un paese, e l’edificio sacro in cui lo stesso sarà collocato e venerato.
«Per farla breve la leggenda è: vennero questa massa di albanesi dall’Albania approdarono sulle spiagge dell’Adriatico, io parlo della nostra zona. Una volta rag-giunta la spiaggia, là c’erano gruppi di famiglie con le masserizie che si portavano dietro misero su un carro l’immagine della Madonna di Costantinopoli e decisero: 12 Dall’identificazione santo/animale all’animale prossimo alla dimensione del quotidiano. Nel
quadro concettuale tracciato dall’etnologa francese il cristianesimo è valutato come complesso sim-bolico e non come istituzione, con un approccio ispirato all’analisi strutturale dei miti che fa riferi-mento al contenuto propriamente mitologico del messaggio cristiano.
Cherchez la vache 533
“facciamo partire i buoi. Dalla spiaggia, dove si fermeranno i buoi, vuol dire lì na-scerà la nostra comunità”. Ecco perché la comunità nacque a Portocannone, altri di-ranno a Chieuti, nei paesi di lingua albanese. Intorno alla chiesa nacque il paese».13
Il tema sembra ripercorrere il modello di antiche leggende migratorie, docu-mentate nell’area centro-italiana con particolare riferimento al territorio occupato dai Sanniti, in cui l’animale bovino «conduce un gruppo etnico o un antenato mitico in quello che sarà il suo nuovo territorio e indica col suo tragitto la via che bisogna percorrere attraverso luoghi non solo ignoti, ma potenzialmente pericolosi o sicu-ramente ostili».14 Riconfigurato nel quadro della dimensione religiosa cristiana in relazione al culto del Legno della Croce, di San Giorgio e della Madonna di Co-stantinopoli, il racconto eziologico dello stanziamento si innesta sull’evento sto-rico della terza migrazione albanese (1461-1470), e la scelta operata dagli animali avviene di frequente come conseguenza di una contesa, secondo quanto eviden-ziato nella versione della gara tra i santi, in cui è possibile rinvenire la dimensione politica della traslazione sotto forma di spartizione e controllo del territorio15.
«… è necessario ricordare che la corsa di Portocannone è legata all’odissea di un po-polo oppresso dalla dominazione turca. Infatti molti albanesi abbandonarono, in-torno al 1460, la madrepatria e sbarcarono nella pianura del Saccione, nei pressi del bosco di Ramitello di Campomarino. Nel contrasto di opinioni se dirigersi a nord o a sud, fu posto il quadro della Madonna di Costantinopoli su un carro trainato da buoi, i quali scelsero liberamente la via di Portocannone, dove si fermarono. Qui dunque, il giorno precedente la festa della Madonna, si svolge la corsa dei carri con 4 buoi a ricordo dell’avvenimento.»16
Tuttavia i dati storici fanno propendere per una dipendenza delle carresi alba-nesi dalle più antiche gare di Larino e San Martino, in rapporto all’assimilazione degli albanesi alle tradizioni culturali e religiose locali per la soppressione del culto greco-ortodosso nel secolo XVIII (Spitilli, 2005-2006, p. 202).
L’insieme delle leggende documentate appaiono vincolate al modello della tra-slazione del corpo di San Leo di San Martino in Pensilis.17 Secondo quanto riferito
13 Saverio Di Legge, Portocannone, 16 maggio 2005.14 Il tema leggendario del viaggio di santi – in particolare di reliquie – su carri trainati da bovini,
è un tema mitico di grande diffusione e parte di un più vasto complesso di leggende appartenenti, secondo la definizione di Carlo Donà, al “modello oracolare” dell’animale guida. La presenza del bovino ha un’eccezionale rilevanza in tutta l’area centro-italiana ed è ereditata all’interno del sistema simbolico cristiano da un più antico substrato religioso, di matrice arcaica, in cui l’animale «funge es-senzialmente da rivelatore del fato, da interprete del destino». Il tema mitico presenta una medesima struttura ma nel processo di ricollocazione operato dal Cristianesimo il bovino diviene uno “stru-mento della Provvidenza” in connessione alla figura del santo, la cui differenziazione rispetto agli antichi eroi è marcata dall’incarnazione di un più vasto potere, la grazia divina, della quale è sovente il diretto depositario e non un semplice intercessore (Donà, 2003, p. 62, 67, 83).
15 Idem, p. 71-72.16 Le “Carresi”, www.forchecaudine.it. 17 Scrive Luigi Ciarfeo: «Non siamo in grado… di stabilire, per mancanza di documenti, neppure
quando ad Ururi fu istituita la festa del Legno della Croce. Sappiamo soltanto che la “Reliquia” conser-vata nella chiesa di Ururi apparteneva alla famiglia Giammiro che in seguito la donò alla Parrocchia.
534 Gianfranco Spitilli
da varie fonti (Tria, 1744, p. 788-797),18 il conte normanno Roberto di Loretello, durante una battuta di caccia, scoprì il dimenticato sepolcro di San Leo trovando il suo cavallo inginocchiato presso una lapide. Nella versione riportata da Alberto M. Cirese (1955, p. 29-30), i signori che partecipavano alla caccia provenivano da differenti paesi, e ne nacque una contesa per il possesso delle reliquie; si decise di affidare la scelta al santo aggiogando ad un carro una coppia di buoi. Gli animali, in base alle numerose varianti, vagarono per più giorni, si diressero verso il mare, infine presero la direzione di San Martino e nel tragitto il bosco di Ramitello si apriva al passaggio del carro;19 giunti davanti alla chiesa i buoi scoppiarono e l’urna sparì, e in seguito alle preghiere del popolo ricomparve per essere deposta da an-geli sull’altare (Mancini, 2002, p. 105).20 Nel racconto di Giovanni A. Tria il carro era trainato da due tori, e le reliquie furono portate direttamente nella chiesa di S. Maria in Pensulis il 2 maggio; l’evento della traslazione fonda anche la consue-tudine della gara e la ricompensa simbolica destinata al carro vincitore:
«… ed in sua memoria sogliono il giorno prima della vigilia della medesima, con pia, divota emulazione condursi i Massari a correre co’ loro Carri, e il primo, che entra la porta dell’abitato suole avere la prerogativa di portare il Pallio, che cor-rono il giorno della Festa, e chiamano il Carro Trionfale, ben adornato, e parato nobilmente» (Tria, 1744, p. 789).
La relazione fra il tragitto compiuto al seguito dei buoi e la configurazione dell’attuale corsa emerge con chiarezza in una delle tante versioni della leggenda documentate a Portocannone, in una manifesta sovrapposizione con la tradizione agiografica di San Martino in Pensilis:
«È una tradizione della Madonna di Costantinopoli, questo si dice che il san-to in tempo antico l’hanno trovato a Ramitello e l’hanno andato a prendere con un carretto coi buoi, così, e i buoi dice che sono venuti qua, e fanno questa festa
Alla data della donazione, la Carrese si svolgeva già o fu istituita per celebrare la nuova festa? È un dubbio che difficilmente sarà risolto, a meno che non venga alla luce una fonte documentaria per ora inesistente. Oggi come oggi si possono fare solo ipotesi. Una dovrebbe essere quella che lega le manife-stazioni dei vari paesi alla sola leggenda di S. Leo che, trasportato dal carro trainato dai buoi, prima di fermarsi definitivamente a S. Martino, andò nei vari casali della zona tra i quali forse Chieuti, Portocan-none e Ururi», Ciarfeo L., 1992, Ururi e la corsa dei carri, in www.ururi.com. Cfr. L. Ciarfeo, La corsa dei carri a Ururi, in Doganieri D., Doganieri G., 1992, San Leo nella storia e nel folklore, Pescara, Age.
18 Tria riferisce quanto contenuto in Polidori G.B., 1741, Vita Sancti Pardi, ecc., Roma, Zempel. Entrambe le fonti sembrano riproporre in parte quanto contenuto in de Mattheis N., 1728, Relazio-ne storica dell’ultima solenne traslazione del corpo di San Leo al Duca di Termoli; cfr. Mancini M., 2002, La primavera, il carro e il bue. Contributo alla conoscenza di un’antica tradizione mediterra-nea, Campobasso, Palladino Editore, p. 101.
19 In alcune varianti i buoi o i tori erano “indomiti” e corsero fino allo sfinimento (Mancini, 2002, p. 104, 159, 181-182, nota 134); la leggenda trova una sua rappresentazione visuale nell’icono-grafia di San Martino, dove i buoi sono raffigurati nell’atto di correre, Idem, p. 143.
20 Quest’ultima versione fa riferimento alla leggenda riportata da D. Sassi (1985). Secondo altre fonti i buoi caddero fulminati: vedi Sassi L., 1940, San Martino in Pensilis ed i suoi dintorni, in Man-cini, 2005, p. 245.
Cherchez la vache 535
dalla vecchia tradizione diciamo così chissà a quanti anni fa, non lo so mo’. E c’è questa carrese che si fa così».21
La direzionalità è un fattore evidentemente simbolico e definisce un percorso rituale che conduce all’interno dello spazio abitato. La corsa dei carri avviene a Por-tocannone come in tutte le località in cui è effettuata, dal mare verso il paese, secon-do una direttrice che ripropone un tragitto significativo, soprattutto per le comunità albanesi: il cammino in direzione di una terra abitabile dopo lo sbarco dall’Adriati-co, guidato dai buoi interpreti della volontà espressa dalla protettrice. Il luogo scelto come traguardo della corsa corrisponde a questa specifica configurazione: l’arco che immette nella piccola piazza antistante la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, dove è con-servata l’icona della Madonna di Costantinopoli. Questo senso di riappropriazione spaziale in forma competitiva garantisce il ristabilirsi di un ordine culturale, il rin-novamento di una presa di possesso dello spazio abitato, contrassegnato in alcune località22 da un rigido percorso celebrativo della vittoria negli stretti vicoli del paese e attuato a Portocannone in una forma più libera al termine della gara.
L’importanza che assume l’arco di Borgo Costantinopoli è sottolineata anche dalla consuetudine rituale di accendere, la sera della domenica di Pentecoste, una lunga batteria di spari a terra collegati da una miccia la cui esplosione, progressiva-mente sempre più forte e intensa, percorre il medesimo tragitto della gara conclu-dendosi sotto l’arco nell’apice del frastuono. Il particolare andamento delle esplo-sioni è oggetto di pratiche divinatorie, così come nel vicino paese di San Martino l’esecuzione del canto della Carrese è utilizzata per predire il vincitore della corsa (Mancini, 2002, p. 172).
La configurazione rituale della gara ripercorre le indicazioni contenute nella leggenda: il percorso compiuto dai buoi coincide, verosimilmente, con quello ef-fettuato nel trasporto dell’icona della Vergine, fino al luogo di edificazione della chiesa attorno alla quale fu costruito il paese e si insediò la comunità; lo stesso qua-dro della Madonna di Costantinopoli, ritenuto miracoloso per aver protetto gli avi nel lungo e pericoloso viaggio, è l’oggetto conteso attraverso la corsa ed è portato in processione sul carro vincitore il giorno seguente, il martedì dopo la Pentecoste (Flocco, 1985, p. 49, 108-109).
«Noi corriamo in onore della Madonna di Costantinopoli, non è che è un pre-mio! Il nostro premio è che chi vince ha l’onore di portare, dietro la processione, il quadro della Madonna, questo è il premio che c’è, capito? Quindi si rischia la vita, perché si rischia anche la vita… tante persone hanno avuto incidenti che i medici l’hanno dati per spacciati, ma gli addetti ai lavori, la storia dice che non è morto mai nessuno. No, ci sarà un motivo? E qui a me piace pensare che la Madonna aiuta e protegge, a me piace pensare questo».23
Alla dimensione religiosa e dedicatoria della gara si innesta una forte conno-tazione sociale e politica, che affonda le sue radici nella storia di Portocannone e
21 Giuseppe Ebreo, Portocannone, 16 maggio 2005.22 Come a San Martino in Pensilis.23 Saverio Di Legge, Portocannone, 16 maggio 2005.
536 Gianfranco Spitilli
nelle particolari modalità di svolgimento della corsa in atto fino agli ultimi anni dell’Ottocento, quando i buoi e i carri erano reperiti presso le famiglie dei pro-prietari terrieri, rappresentate nella competizione, e guidati dai rispettivi massari, i dipendenti addetti alla cura del bestiame chiamati anche gualani.24 Il processo di identificazione tra famiglie, buoi e carri era già allora molto forte, anche se la dimensione agonistica era attenuata dall’uso di animali utilizzati nella quotidianità per l’aratura dei campi, dunque non particolarmente veloci nonostante le pratiche di addestramento cui si ricorreva nel mese precedente la corsa. A Portocannone il passaggio dalla corsa gestita dalle famiglie della borghesia agraria all’organizza-zione di carri da parte di associazione di giovani sembra sia avvenuto con anticipo rispetto agli altri paesi delle carresi, con la fondazione degli attuali carri in gara, dei Giovani e dei Giovanotti, rispettivamente nel 1894 e 1897: a San Martino in Pensilis il primo carro allestito dalle associazioni è quello dei Giovani nel 1897 ma si deve attendere il 1919 per la fondazione del secondo, il carro dei Giovanotti, e il 1958 per il terzo carro in gara con gli altri ancora oggi, quello della Cittadella; a Ururi la linea di confine si colloca agli inizi degli anni Sessanta del Novecento, quando compaiono gli attuali carri dei Giovani e dei Giovanotti fondati rispetti-vamente nel 1927 e nel 1961, cui si è aggiunto per un breve periodo il carro della Cittadella (1978-1988) e il nuovo carro dei Giovanotti in gara dal 1992, distinto dall’omonimo per la differenza dei colori sociali.25
Nella corsa di Portocannone la lunga presenza delle associazioni a carattere popolare ha determinato il progressivo consolidamento di una dimensione pret-tamente agonistica, soprattutto negli ultimi decenni in seguito alla definitiva affer-mazione di due soli carri nella gara. L’identificazione con l’una o con l’altra fazione è marcata, e corrisponde anche ad una scelta di carattere politico e sociale, intuibile anche nell’esplicita consuetudine di denominare le due associazioni partiti. Questa contrapposizione tra due sezioni del paese determina una forma di solidarietà e di coesione investita all’interno delle stesse fazioni, vincolata anche dalla necessità della condivisione economica delle elevate spese per l’allestimento di un carro; la configurazione che ne deriva è una sorta di sistema bipolare, nel quale due poteri sono in continua opposizione tra loro e la gestione del conflitto è regolata dalla corsa dei carri.26 In tal senso la carrese è uno strumento politico.
24 La Carrese. Storia di una tradizione mediterranea, Comune e Pro Loco di Portocannone, San Martino in Pensilis e Ururi, Pescara, Zemrude & Co., 1994 (s.p.). Nell’opuscolo si ricordano anche i nomi delle principali famiglie proprietarie dei carri, cui davano anche il nome: per San Martino le famiglie Bevilacqua, Sassi, Tozzi, Mancinetti, Raimondo e Facciolla; per Ururi le famiglie Plescia, Musacchio, Licursi.
25 Per ulteriori dettagli si vedano Mancini 2002, in particolare, p. 155-162 e La Carrese. Storia di una tradizione mediterranea, op. cit. (s.p.). Va ricordato inoltre che la demarcazione fra corsa gestita dalle famiglie o dalle associazioni non è così netta, poiché è frequentemente documentato il caso di fa-miglie che, pur non prendendo più parte direttamente alla gara, continuano a sostenere uno dei carri.
26 Un preciso regolamento, con norme e provvedimenti disciplinari, codifica la partecipazione alla gara dalla preparazione alle modalità di svolgimento della corsa.
Cherchez la vache 537
La divisione in partiti si esprime visivamente nel frazionamento cromatico del-la piazza principale, piazza Scanderberg, in una metà giallorossa e una biancazzur-ra: i due gruppi si identificano con due differenti porzioni dello spazio, occupan-dole stabilmente, e frequentano in modo quasi esclusivo due differenti bar, posti alle estremità opposte. Tale rivalità, che raggiunge il culmine nei giorni della gara, investe anche la vita quotidiana, le amicizie, il lavoro:
«Diciamo simbolicamente la piazza è divisa in due, perché purtroppo c’è que-sta grande rivalità, capito? E anche poi nelle questioni che vengono dopo, sul cam-po del lavoro, su tutto. Qua si ripercuote tutto sul fatto dei carri. Si ripercuote sul lavoro, sulle cose…E sì, perché per esempio noi abbiamo l’assessore Pino Gallo, l’assessore regionale, è fazione dei Giovanotti. È uno che insomma se gli si va a chiedere una cosa, il posto di lavoro, ti crea il posto perché ha conoscenze, però se sei dell’altra parte è restio. Pensa più alla fazione di là che non a noi di qua. È tutta una questione…sì, purtroppo è la realtà, questa è la pura realtà che abbiamo in questo paese. A prescindere che poi comunque rimane sempre bella».27
La diversificazione cromatica dei due carri ha come conseguenza estrema la divisione di tutto il paese in due entità politiche, economiche, sociali giallorossa e biancazzurra, in rapporto ai rispettivi colori del carro e dei buoi. La sovrappo-sizione simbolica fra carro e partito è manifesta nella stessa terminologia: con la parola carro si intende sia l’oggetto materiale, sia il partito, sia la più complessa unità costituita dal carro e dai buoi aggiogati nella dimensione festiva della corsa.
A Portocannone non è praticata una vera e propria vestizione degli animali, contraria al carattere agonistico del rito poiché non funzionale allo svolgimento della gara; è tuttavia documentato l’uso di avvolgere le corna e le zampe anteriori con fasce corrispondenti ai colori dei rispettivi carri, e di fissare sulla fronte dei buoi o ai lati del carro una piccola icona della Madonna.
Ma soprattutto è investito di valenza simbolica l’atto di mettere i buoi sotto al carro, con il quale è sancita l’identificazione tra i due elementi in un’unità figurati-va che ripropone l’immagine del carro della migrazione:
«Noi abbiamo una casa dove lì si prepara il carro e da lì parte per andare in chiesa per ricevere la benedizione. Cioè il lato ufficiale della cosa è: da un punto del paese mettere i buoi sotto il carro e lì è il momento che si ufficializza la partenza».28
In quel preciso momento si entra definitivamente nella realtà della corsa e della leggenda: guidati dagli uomini gli animali interpretano quanto contenuto nel mito, e a loro è affidata buona parte della competizione. Solo l’esito della gara deciderà quale, tra i due, sarà il carro della Madonna di Costantinopoli.
«… alle due e mezza ci sarà la benedizione in chiesa, il parroco benedirà i due carri e dirà: “tornate a memoria della Madonna di Costantinopoli”».29
27 Giuseppe Polenta, Portocannone, 16 maggio 2005.28 Saverio Di Legge, Portocannone, 16 maggio 2005.29 Giuseppe Polenta, Portocannone, 16 maggio 2005.
538 Gianfranco Spitilli
Riferimenti bibliografici
Albert J.-P., 1990, “Destins du mythe dans le christianisme médiéval”, L’Homme, XXX, 113, p. 53-72.
Albert-Llorca M., 1991, L’ordre des choses: les recits d’origine des animaux et des plantes en Europe, Paris, Éditions du Cths.
Apolito P., 1993, Il tramonto del totem. Osservazioni per una etnografia delle feste, Mila-no, FrancoAngeli.
Ariño A., Lombardi Satriani L.M. (a cura di), 1997, L’utopia di Dioniso. Festa fra tradizio-ne e modernità, Roma, Meltemi.
Bloch M., 2005, Da preda a cacciatore. La politica dell’esperienza religiosa, Raffaello Cor-tina Editore, Milano (ed. or. 1992, Prey into Hunter. The Politics of Religious Experi-ence, Cambridge, Cambridge University Press).
Charuty G., 2001, “Du catholicisme méridional à l’anthropologie des sociétés chré-tiennes”, in Albera D., Blok A., Bromberger C. (Orgs.), L’anthropologie de la Médi-terranée, Paris, Maisonneuve & Larose, p. 359-385.
Bronzini G.B., 1990, “Santi taumaturghi e taumaturgia dell’ex-voto”, Lares, LVI, 4, p. 493-494.
Cirese A.M., 1955, “Le corse dei carri nel basso Molise”, La Lapa, III, 1-2, p. 26-30.Delehaye h., 1906, Le leggende agiografiche, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina (ed. or.
1955, Légendes agiographiques, Bruxelles, Société des Bollandistes).Digard J.P., Vialles N., 2005, Antropologie des relations hommes-animaux, Annuaire.
Comptes rendus des cours et conférences 2003-2004, Paris, École des hautes Études en Sciences Sociales, p. 782-783.
Doganieri D., Doganieri G., 1992, San Leo nella storia e nel folklore, Pescara, Age.Donà C., 2003, Per le vie dell’altro mondo. L’animale guida e il mito del viaggio, Catan-
zaro, Rubbettino Editore.Evans-Pritchard E.E., 2003, I Nuer. Un’anarchia ordinata, Milano, FrancoAngeli (ed. or.
1968, The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic people, Oxford, Oxford University Press).
—, 1965, “La religione dei Nuer”, in Leslie C. (a cura di), Uomo e mito nelle società primi-tive, Firenze, Sansoni, p. 69-118 (ed. or. 1956, “Nuer Religion”, in Leslie C., Anthro-pology and Folk Religion, New York, Vintage Books).
Di Lernia S., 1999, “Alle origini del pastoralismo africano. Riflessioni su alcune forme di gestione animale nell’antico Olocene”, in Arioti M., Casciarri B. (a cura di), La Ricerca Folklorica, 40, ottobre, p. 13-24.
Flocco M., 1985, Studio su Portocannone e gli albanesi in Italia, Portocannone, s.e.La Carrese. Storia di una tradizione mediterranea, 1994, Pescara, s.p., Comune e Pro Loco
di Portocannone, San Martino in Pensilis e Ururi, Zemrude & Co. Mancini M., 2002, La primavera, il carro e il bue. Contributo alla conoscenza di un’antica
tradizione mediterranea, Campobasso, Palladino Editore.—, 2005, Tra terra e cielo. Aspetti della religiosità popolare tra passato e presente in San
Martino in Pensilis e dintorni, Campobasso, Palladino Editore.Padiglione V., 2004, “Il bue ossequioso: da bestia a simbolo a bene culturale”, in Marinelli
R. (a cura di), Le radici della ritualità, Atti del Convegno, Steccato di Bacugno (Posta) 2 agosto 2003, Rieti, Provincia di Rieti, p. 15-17.
Cherchez la vache 539
Pitt-Rivers J., 2001, “La conférence de Burg Wartenstein”, in Albera D., Blok A., Brom-berger C. (Orgs.), L’anthropologie de la Méditerranée, Paris, Maisonneuve & Larose, p. 59-63.
Rocchia A.M., 1991, Cronistoria di Guglionesi e delle tre gloriose traslazioni di S. Adamo Abate suo protettore, ristampa a cura di Gabriele Morlacchetti, Vasto, Arte della Stam-pa/Cannarsa.
Saintyves P., 1907, Les saints successeurs de dieux, Paris, E. Nourry. Sassi D., 1985, ‘A storie de Sande Lé, Campobasso, Edizioni Enne.Stellati N., 1992, Larino. Carri e Carrieri di San Pardo 1990/91, Campobasso, Edizioni
Enne.Tria G.A., 1989 (1744), Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della Città e Diocesi di
Larino metropoli degli antichi Frentani, Isernia, Cosmo Iannone.