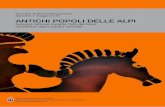Celti ed Etruschi nell’Etruria Padana e nell’Italia settentrionale, in “Ocnus” 11, 2003, pp....
Transcript of Celti ed Etruschi nell’Etruria Padana e nell’Italia settentrionale, in “Ocnus” 11, 2003, pp....
Il tema che mi propongo di affrontare conquesto contributo (1) è un tema molto ampioall'interno del quale è assolutamente indispensa-bile fare numerosi tagli e molte selezioni. Vorreipertanto limitarmi ad una breve introduzione dicarattere generale, nella quale riassumere alcunidegli aggiornamenti più significativi di questiultimi anni nell'ambito dell'”archeologia celtica”in Italia e in modo particolare nell'Italia setten-trionale, pur nella consapevolezza di dovernecessariamente ripetere cose ben note. Dopodi che vorrei fare alcune brevi considerazionisulla presenza dei Celti in Italia settentrionale,prendendo in esame soprattutto la documenta-zione epigrafica che ad essi si ricollega ancheperché sono dell'opinione che tale documenta-zione epigrafica consenta di prendere in esamela presenza celtica in Italia in modo assai piùapprofondito e raffinato di quanto non sia pos-sibile fare sulla base della sola documentazionearcheologica.
E' ben noto ormai e pressoché universal-mente accettato che la cultura di Golasecca siada identificare etnicamente con genti di linguaceltica. Il punto di partenza di questo radicalecapovolgimento sul piano degli studi è stata lariconsiderazione da un punto di vista cronolo-gico della iscrizione di Prestino, sia sotto il pro-filo archeologico che sotto il profilo linguistico.
A tale riconsiderazione cronologica si sono poiaggiunti altri elementi molto importanti, come ilrinvenimento di nuove iscrizioni o anche nuoveacquisizioni sul piano linguistico di "vecchi"documenti epigrafici, dai quali è giunta unapuntuale conferma a questa nuova sistemazionestorica, sempre più solida da un punto di vistacronologico (mi riferisco in particolare alladatazione molto alta di alcune iscrizioni dell'a-rea di Golasecca e alla loro classificazione come"leponzie") (2).
Il “leponzio” è una lingua notata in un alfa-beto “non latino”, oggi potremmo quasi dire inun alfabeto derivato dall'etrusco e col tempoadattato alle esigenze fonetiche della lingua equindi trasformato in alfabeto “leponzio”. E'una lingua sicuramente celtica, che qualcunopreferisce chiamare protoceltico o paleoceltico,riconoscendone comunque il fondo celtico, unalingua tradizionalmente non ascritta ai Galli equindi di fatto anteriore alla gallicità storica earcheologica che si identifica con la fase cultu-rale e cronologica del La Tène. Mi preme sotto-lineare questo dato delle nuove iscrizioni moltoantiche e classificate come leponzie, perchéoggi non è più necessario collocare così in alto
Tra mondo celtico e mondo italico. La necropoli di Monte Bibele,Atti della Tavola Rotonda, Roma 1997, a cura di D. Vitali - S. Verger, Bologna 2008, pp. 323-348
323
Celti ed Etruschi nell'Etruria Padana e nell'Italia settentrionale
Giuseppe Sassatelli
(1) Nelle more della pubblicazione degli Atti di questaTavola Rotonda ho presentato questo testo in Ocnus2003: SASSATELLI 2003.
(2) Per tutti questi problemi mi limito a ricordare alcunilavori di A. L. Prosdocimi e di R. De Marinis: DEMARINIS 1988, pp. 159-247, con ampia bibliografia diriferimento; PROSDOCIMI 1986, pp. 67-92; PROSDOCIMI1987, pp. 561-581; PROSDOCIMI 1991a, pp. 51-59;PROSDOCIMI 1991b, pp. 138-176, tutti con altra biblio-grafia sul problema.
nel tempo l'iscrizione di Prestino per sostenerela presenza di una "celticità" linguisticanell'Italia nord-occidentale, cioè nell'area diGolasecca, dove evidentemente gruppi celtici(o protoceltici) sono attivi e radicati assai primadelle invasioni storiche di cui parlano le fonti.Mi riferisco alle iscrizioni di Castelletto Ticinoe di Sesto Calende (fig. 1), su cui dovrò tornaretra poco, la prima delle quali datata agli inizi delVI secolo, e la seconda, per la quale esistevauna divergenza di opinione relativamente allalingua (etrusca per G. Colonna, leponzia perA.L. Prosdocimi), oggi definitivamente risolta afavore del "leponzio", datata addirittura allafine del VII secolo (3).
Questa certezza sul piano linguistico, che siè via via sempre più consolidata, ha come ine-vitabile conseguenza il fatto che la cultura diGolasecca presente nell'Italia nord-occidentaleè già la cultura dei Celti in Italia, diversa daquella dei Celti arrivati agli inizi del IV secolo.Ciò significa che la base etnico-linguistica è lastessa, anche se le diversità sul piano culturalesono notevoli, essendo dovute alle diversevicende storiche e formative dei due ambiti inquestione.
Si costituisce così un importante (oltre che
nuovo sul piano degli studi e delle acquisizioni)polo di riferimento nel panorama dell'Italia set-tentrionale in età preromana. Accanto aiVeneti, ai Reti, agli Etruschi ci sono anche iCelti, e da data antichissima.
Una volta varcato il limite del V secolo lecose cambiano di molto e diventa persino irri-levante tutta la questione della tradizione livia-na sulla irruzione dei Celti di Belloveso agli inizidel VI secolo. Come hanno più volte osservatosia G. Colonna che R. De Marinis, i passaggiveramente importanti nella storia di quest'areasono avvenuti molto prima, al tempo delle ori-gini della stessa Cultura di Golasecca (4).Sull'antichità della presenza dei Celti in Italianon è la saga di Belloveso a informarci, come siera costretti a sostenere fino ad alcuni anni fa.Anche perché Belloveso potrebbe essere statoenfatizzato dalla tradizione storica o per i suoilegami con Marsiglia o forse anche come anti-cipatore delle invasioni di IV secolo. Certo lacalata di Belloveso non sembra aver lasciatotracce concrete e verificabili sul piano archeolo-gico.
Sull'antichità della presenza dei Celti in Italiaè ora la stessa Cultura di Golasecca a informar-ci in modo assai più puntuale e circostanziato.E all'interno di questa cultura non solo non esi-stono cesure apprezzabili tra VII e VI secolo,ma si registra al contrario una straordinariacontinuità sul piano culturale, continuità chearriva fino all'età del bronzo, proprio come
Giuseppe Sassatelli
324
(3) Per l'iscrizione di Castelletto Ticino: GAMBARI,COLONNA 1988, pp. 119-164 e successivamentePROSDOCIMI 1990, pp. 288-298; PROSDOCIMI 1991b, pp.142-145. Per l'iscrizione di Sesto Calende: GAMBARI, G.COLONNA 1988, pp. 140-141 (con bibliografia preceden-te), considerata etrusca; e successivamente PROSDOCIMI1991b, pp. 148-149, considerata leponzia. Per la suarecente classificazione come leponzia anche da parte diG. Colonna e con proposta di una nuova lettura (iuntana-ka) si veda COLONNA 1998 a, p. 263 e nota 20.
(4) Mi limito a citare a questo riguardo il lucido interven-to di G. Colonna in Atti del II Convegno ArcheologicoRegionale, Como 1984, Como 1986, pp. 579-580, oltreall'ampia trattazione di DE MARINIS 1988.
Fig.1. Iscrizioni leponzie da Castelletto Ticino (a) e da Sesto Calende (b).
a b
nelle altre grandi aree culturali dell'Italia setten-trionale preromana. Le variazioni che si riscon-trano sono assai più recenti e si datano tra il VIe il V secolo (DE MARINIS 1981; DE MARINIS1986 a, pp.25-35; e in particolare GAMBARI1998, pp.136-146), ma soprattutto sono deltutto interne ai singoli gruppi, ancora una voltacon un parallelismo cronologico assai significa-tivo che coinvolge, oltre a Este e Bologna,anche Golasecca e la sua area.
Tutto questo ha una prima importante con-seguenza: anche l'area nord-occidentale, carat-terizzata sul piano archeologico dalla cultura diGolasecca e sul piano linguistico da un dialettoceltico (per cui si parla giustamente di una cel-ticità pregallica in Italia), risulta in perfetta sin-tonia con quanto si registra nelle altre culturedell'età del ferro e, in analogia con queste ulti-me, partecipa di alcuni fenomeni storici moltoimportanti quali il processo formativo moltoantico e l'identità etnica molto precoce, lo svi-luppo e le trasformazioni interne che, anche seradicali, non mutano il quadro etnico dei singo-li gruppi.
Il poter avvicinare quest'area nord-occiden-tale alle altre aree dell'Italia settentrionale e piùin generale alle altre aree culturali dell'Italia pre-romana non è cosa di poco conto, soprattuttodopo averne riconosciuto la sua “celticità”.Anche i Celti o proto-Celti golasecchiani, a par-tire dal momento della loro "formazione", sicu-ramente molto antica, partecipano a tutti igrandi fenomeni storico-culturali dell'Italiaantica: si pensi soltanto all'acquisizione dellascrittura e dell'alfabeto che serve per realizzar-la, avvenuta pressoché contemporaneamente aEste e Golasecca per il tramite e per l'impulsodegli Etruschi di Bologna, come mostranorispettivamente l'iscrizione di Castelletto Ticino
per l'area golasecchiana (vedi nota 3) e l'iscri-zione di Lozzo di Este per l'area atestina(PROSDOCIMI 1968-1969; COLONNA 1980a, pp.189-190; PROSDOCIMI 1990, pp. 244-250). Neconsegue che anche il problema delle più anti-che invasioni celtiche, sotto la guida diBelloveso, si ridimensiona notevolmente ediventa meno rilevante il contrasto tra chi lenega o le sottovaluta molto e chi ne sostieneinvece la veridicità e l'importanza.
Anche se per certi versi può sembrare para-dossale, il dato più concreto della saga diBelloveso è in fin dei conti la battaglia delTicino. Lo zilath di uno dei due cippi di Rubieranell'Emilia occidentale (fig. 2), forse uno zilathdel territorio di "Sala" (Valle del Secchia?)secondo l'opinione di De Simone (5), per altropoco condivisa, viene ormai concordementeinterpretato, anche in considerazione della suaalta cronologia, come un "capo militare", a pro-posito del quale non è difficile pensare ad epi-sodi come la battaglia del Ticino, emblematicadi una situazione di palese e antica conflittuali-tà tra gruppi che stavano a ridosso del Po per ilcontrollo e il mantenimento di territori acquisi-ti già da lungo tempo: “cum iis qui interAppenninum Alpesque incolebant gli Etruschi saepeexercitus gallici pugnavere” (6). Quel saepe lasciaintravedere una micro conflittualità tra popoliconfinati e la battaglia è forse l'indizio di unadelicata fase di assestamento politico militarefra due entità che, pur avendo rapporti moltostretti sul piano commerciale e culturale, non
Celti ed Etruschi nell’Italia settentrionale
325
(5) DE SIMONE 1992, pp. 14-15. La prima edizione deicippi è di BERMOND MONTANARI 1988, pp. 239-244, e,pressoché contemporaneamente, MALNATI, BERMONDMONTANARI 1989, pp. 1567-1577.(6) Cenni a questo tipo di interpretazione sono inCOLONNA 1988, p. 35 e in SASSATELLI 1990, pp. 57-58.
Fig.2. Iscrizione etrusca del cippo di Rubiera con il nome femminile Kuvei Puleisnai e la menzione di uno zilaθ.
sempre hanno convissuto pacificamente, forseanche in conseguenza di qualche tentativo disconfinamento.
Tra questa fase più antica, caratterizzata dailunghi processi formativi degli ethne e delleculture, oltre che da scontri militari e da episo-di di assestamento territoriale a ridosso del Po(saga di Belloveso, battaglia del Ticino), e leinvasioni “storiche” degli inizi del IV secolo, ein modo particolare tra VI e V secolo, si collo-ca un periodo di convivenza relativamente paci-fica e di relazioni culturali e commerciali moltostrette tra i Celti, ormai solidamente attestati anord del Po, e le popolazioni vicine dell'Italiasettentrionale, in particolare gli Etruschi dislo-cati a sud del Po e i Veneti dell'area nord-orien-tale. E' ben noto infatti che le invasioni “stori-che” del IV secolo furono precedute da contat-ti commerciali e forse anche da spostamenti diindividui tra queste aree, che però non solo nonprovocarono reazioni o rivalse, ma trovaronoanzi una perfetta integrazione all'interno deigruppi interessati. Mi riferisco al fatto che inmolti siti di queste due aree sono ben docu-mentati sia fibule cosiddette tardo-halstattianeoccidentali, sia ganci di cintura traforati e anel-li con coppiglia mobile (Koppelringe) (fig. 3), rife-ribili, le prime, a semplici contatti commerciali,i secondi forse anche a guerrieri isolati prove-nienti dall'area transalpina (7). Non è semprefacile distinguere l'oggetto semplicementeimportato da quello che invece comporta unmutamento nel costume, specie quando si trat-ta di un mutamento che ha tutta l'aria di voler-si mantenere etnicamente connotato rispettoall'ambiente, culturalmente ed etnicamentediverso, in cui è inserito.
Tali presunti arrivi di persone fisiche dall'a-rea transalpina o anche dall'area golasecchiana
non hanno nulla a che vedere con le invasioni ogli spostamenti di massa degli inizi del IV seco-lo, invasioni che coinvolsero “molte decine dimigliaia di giovani bellicosi che conducevanocon sé un numero ancora maggiore di fanciullie di donne” secondo la ben nota testimonianzadi Plutarco, nella Vita di Camillo (Plutarco, Vitadi Camillo, 15, 2). Questi precoci contatti dovu-ti a una larga circolazione di merci, ma anche diartigiani e di tecnologie, oltre che di mercenari(nel caso di individui connotati come guerrieri),piuttosto che i prodromi di tali invasioni, vanno
Giuseppe Sassatelli
326
(7) Sulle fibule ha richiamato per primo l'attenzione FREY1971, pp. 355-386. Molti gli interventi successivi sullostesso problema tra i quali mi limito a ricordare RUTASERAFINI 1984, pp. 7-33; DE MARINIS 1987, pp. 89-99;VITALI 1992, pp. 394-397. Sui ganci di cintura traforati:FREY 1974, pp. 129-142; KRUTA 1978, pp. 152-161. Peruna discussione generale sul problema CALZAVARACAPUIS, CHIECO BIANCHI 1979, pp. 19-25.
Fig.3. Gruppo di fibule tardohallstattiane occidentali (a) e gancidi cintura traforati (b), provenienti da varie località della pianu-ra padana e dell’Italia settentrionale.
Celti ed Etruschi nell’Italia settentrionale
327
considerati e inseriti in un quadro generale diampia mobilità e di larga permeabilità all'inter-no dei vari gruppi che accolgono ed assorbonocon facilità individui di altre aree, i quali si inte-grano e si fondono con le usanze locali purmantenendo una qualche traccia della loro terrad'origine: Etruschi nell'ambito delle comunitàgolasecchiane; Celti di Golasecca e Celti d'ol-tralpe tra gli Etruschi; Celti tra i Liguri o nellaGenova etrusca; Celti tra i Veneti e più a sudforse anche tra gli Umbri. Si tratta di fenomeniche vanno ben oltre le rigide classificazioni delleculture e degli ethne e che trovano un puntualeriscontro nella documentazione epigrafica,come vedremo tra poco.
Molto chiare e ormai pienamente acquisiterisultano le motivazioni storico economiche, ladinamica e le conseguenze sul piano degli asset-ti territoriali delle invasioni galliche degli inizidel IV secolo. Sono cose notissime sulle qualinon è il caso di soffermarsi troppo. In un'Italiaa loro ben nota per la bontà dei prodotti, per ilclima e per la fertilità delle terre, ma anche perla qualità delle sue produzioni artigianali,cominciano a trasferirsi migliaia di Celti transal-pini, forse coinvolgendo anche qualcuno diquelli che da tempo stavano trans Padum. Varicordata a proposito delle attività artigianali lavicenda di Helico, un celta del popolo degliElvezi che nel V secolo aveva soggiornato aRoma come fabbro, e che poi se ne tornò nellasua terra d'origine con tutto il bagaglio delleconoscenze e delle esperienze tecnologicheacquisite nel cuore della penisola (8). Ai fichi,all'olio e al vino di Arrunte si devono quindiaggiungere anche le tecnologie artigianali diquesto fabbro che al suo ritorno in patriapotrebbe avere contribuito ad attirare il popolodei Galli e a spingerli verso l'Italia.
La grande invasione del IV secolo si realizzain modo relativamente rapido ed è chiara nellesue tappe e nei suoi esiti. In tutta la tradizione
storica è ben presente questo concetto delleondate migratorie che si succedono in regolareprogressione: prima gli Insubri che fondanoMilano; poco dopo (subinde) i Cenomani che siinstallano più a est (Verona e Brescia); quindi iBoi (Bologna) e infine, recentissimi advenarum, iSenoni in area adriatica, fino all'Esino e forseanche più a sud. Questo dicono le fonti (9).Restano tuttavia ancora da chiarire due puntiimportanti nell'ambito della tradizione storica.Il primo riguarda la ben nota “CronacaCumana” riportata da Dionigi di Alicarnasso(VII, 3, 1): “Durante la 64° Olimpiade e l'arcon-tato di Milziade ad Atene, i Tirreni che abitanosul golfo ionico, quelli che di lì a poco coltempo furono cacciati dai Celti, si unirono agliUmbri, ai Dauni e a parecchi altri barbari eintrapresero la distruzione di Cuma”. Non c'èrelazione di causa/effetto fra i Celti, la loro pre-coce presenza in Italia settentrionale, la loroostile pressione sugli Etruschi e la spedizionemilitare di questi ultimi contro Cuma. Quella diDionigi di Alicarnasso è solo una digressioneesplicativa, per chiarire che gli Etruschi autori epromotori della spedizione contro Cuma nonsono quelli della costa tirrenica, ma quelli dell'a-rea padana (solo loro, più tardi [sun chrono]saranno cacciati dai Celti) (10). E' quindi deltutto arbitrario arguire una presenza dei Celti inarea etrusca già nella seconda metà del VI seco-lo, una presenza importante e decisiva dovutaallo spostamento di grandi masse o comunquedi gruppi etnici consistenti, in un periodo tral'altro di notevole prosperità economica pertutto il comparto etrusco della pianura padana.I Celti eventualmente presenti in questa fasecosì antica tra le popolazioni dell'Italia setten-trionale, e in particolare tra gli Etruschi, sonoben altra cosa essendo di fatto individui isolatiche non alterano in alcun modo la compagine
(9) Per un esame organico e completo della tradizionestorica su questi avvenimenti rimando a VITALI 1991, pp.220-235 e PEYRE 1992, pp. 7-45.(10) VITALI 1996, pp. 253-254 ha riesaminato il passomettendo a confronto le diverse esegesi fino ad ora pro-poste e approdando a questa convincente interpretazio-ne.
(8) Su Helico si veda, di recente, VITALI 1996, pp. 262-264; VITALI 2000, pp.115-122; ma si vedano anche, più ingenerale, le osservazioni di COLONNA 1998 a, pp. 263-264.
Giuseppe Sassatelli
328
che gli accoglie.L'altro punto su cui occorre fare chiarezza è
il passo dello Pseudo-Scilace relativo all'altoAdriatico, nel quale i Keltoí sono collocati in unastretta fascia della regione deltizia del Po, inposizione intermedia tra gli Etruschi, posti piùa sud, e i Veneti posti più a nord (fig. 4) (11).Anche sulla presenza di questa enclave celtica inAdriatico si è molto discusso: essa si intrecciatra l'altro con il problema, molto complesso,della cronologia del Periplo e della distinzione,ormai pienamente acquisita, tra una stesura ori-ginaria e più antica e una serie di interpolazionisuccessive. Chi accetta la cronologia alta delbrano sui Celti ne sottolinea la probabile rela-zione con tutta una serie di indizi che lascianointravedere una mobilità diffusa, sia pure a livel-lo individuale, ed una presenza relativamenteconsistente di Celti in Italia, anche in una fasepre-La Tène. Se però si accetta il fatto che ilPeriplo fosse sostanzialmente un manuale prati-co per la navigazione, con l'indicazione deitempi di percorrenza e degli ethne che via via siincontravano lungo la costa, è pensabile cheanche relativamente ai Celti esso si riferisse aqualcosa di stabile e di strutturato, non a pochiindividui, per di più assorbiti nelle realtà vicinemolto ben consolidate. E allora non resta chepensare ai resti delle truppe mercenarie diDionisio il Vecchio che, come sappiamo, agliinizi del IV secolo si era fatto promotore di ungrande progetto antietrusco, progetto che pre-vedeva azioni combinate contro gli Etruschi, siain ambito tirrenico che in ambito adriatico,sempre con un forte coinvolgimento dei Galli.Risulta in conclusione assai più semplice riferi-re la compilazione del brano sui Celti non allastesura più antica del Periplo, cioè al V secolo,ma ad una interpolazione più tarda, forse di IVsecolo e considerare i Galli della piccola encla-ve alto-adriatica non tanto i superstiti della spe-dizione contro Roma, quanto piuttosto quello
che restava delle truppe mercenarie utilizzate daDionigi di Siracusa nelle sue incursioni in altoAdriatico.
Anche se la documentazione archeologica ciaiuta ben poco in questo senso, la cronologiadel brano alla metà del IV risulta comunque piùplausibile, soprattutto per quello che riguardagli altri popoli nominati nello stesso punto, inparticolare agli Umbri per i quali, nel V secolo,è difficile pensare a un paraplo che arrivi fino aRimini.
In questo tratto di costa infatti, almeno pertutto il V secolo, dovevano esserci stabilmentegli Etruschi di Rimini e di Verucchio. Solo piùtardi, quando proprio la calata dei Celti costrin-ge gli Etruschi della pianura padana, e quindianche quelli della costa, a concentrarsi e adarroccarsi nell'area deltizia tra Spina e Adria,solo allora non è improbabile che gruppi diUmbri provenienti dall'interno e da zone mon-tane, dove si erano installati molto tempoprima, si siano spinti verso il mare ed abbianooccupato settori ed aree che gli stessi Etruschierano stati costretti ad abbandonare
Fig. 4. La sequenza dei popoli italici lungo la costa dell’AltoAdriatico secondo la ricostruzione di PERETTI 1979, fattasulla base del Periplo di Scilace.
(11) Anche per questo passo e per i problemi di interpre-tazione e di cronologia che esso ha posto rimando a duelavori recenti dello stesso D. Vitali: VITALI 1993, pp. 65-69 e VITALI 1996, pp. 255-256.
Celti ed Etruschi nell’Italia settentrionale
329
(SASSATELLI 1996, pp. 265-267 e SASSATELLI1999, pp. 71-107). Tornando alle grandi invasio-ni degli inizi del IV secolo credo si possa tran-quillamente affermare che, nonostante la speci-ficità dei singoli gruppi e la diversità dei lorocomportamenti, un fatto risulta abbastanzachiaro: tutte le aree interessate - e in particolarela zona controllata dagli Etruschi - subisconoun forte trauma che coinvolge sia gli assettiurbani delle singole città che l'organizzazionedell'intero agro circostante.
Anche questo è un punto ben noto e ormaisufficientemente acquisito, che però meritaqualche precisazione, soprattutto alla luce delfatto che nell'ambito di una sostanziale rivaluta-zione dei Celti, del loro livello culturale, del pro-cesso di forte integrazione con gli Etruschi,negli ultimi tempi si tende sempre di più ad atte-nuare gli esiti di tale impatto (12). In questa pro-spettiva di ridimensionamento, da un lato si èposto l'accento su alcune fonti, e in particolaresul noto passo di Plutarco nella “Vita diCamillo” (16,3), nel quale si fa cenno al fattoche i Galli, cacciati gli Etruschi dalle loro città,“ben diciotto, belle, grandi e ben organizzate”,vi si sarebbero installati a loro volta [autoi kate-schon], desumendone una sorta di continuitàurbana peraltro smentita da altre fonti, come adesempio Polibio (II, 17, 9).
Dall'altro lato si è proceduto ad una rivaluta-zione generalizzata e non sempre coerente diquella parte di documentazione archeologicache sembrerebbe costituire una conferma aquesta visione blanda ed addolcita della grandeinvasione gallica del IV secolo. Ma su questo siimpongono almeno due brevi precisazioni. Sulpiano delle fonti storiche è vero che anche aiGalli vengono attribuite fondazioni urbane: ésufficiente ricordare Mediolanum fondata daBelloveso (Livio V, 34, 9), alla quale lo stessoStrabone riconosce la qualifica di metropolis degliInsubri, pur sottolineando che sul piano urbani-stico altro non era che una kòme (Strabone
V,1,6), in sintonia con altre fonti come Polibio(II,17,9), che sottolinea il carattere diecistico,comunque lontano da qualsiasi consapevolezzaurbana, del popolamento gallico. La contraddi-zione di Strabone è solo apparente. Milano è lametropolis degli Insubri per il ruolo avuto nelprocesso della loro etnogenesi, così comeCortona e Pyrgi lo sono per gli Etruschi (13),oltre che per un ruolo politico e direttivo chepoteva anche non tradursi in fatti rilevanti sulpiano urbanistico.
D'altro canto sul piano archeologico trovia-mo solo conferme al fatto che l'arrivo improv-viso dei Galli provoca una forte cesura al siste-ma urbano creato dagli Etruschi, oltre che allaorganizzazione territoriale che faceva capo atale sistema urbano. Credo sia sufficiente richia-mare qui, sia pur brevemente, alcune situazionidavvero emblematiche a questo riguardo.
A Bologna (14) si verifica una interruzioneimprovvisa nella stratigrafia orizzontale deisepolcreti, per cui si torna a seppellire in settoripiù vicini alla città, non per semplici ragionirituali, a mio modo di vedere, quanto piuttostoin conseguenza di una contrazione o di unospostamento dell'area dell'abitato. Senza conta-re il fatto che compaiono tombe in un settore(via del Pratello) che dall'VIII secolo fino al Vaveva sempre fatto parte dell'area urbana e chesi riutilizzano per sepolture alcuni pozzi perl'acqua dell'abitato, le cui strutture perdono pro-gressivamente identità e funzione originaria.
E anche la recente scoperta a Casalecchio diReno (ORTALLI 1995, pp. 189-238; ORTALLI1998, pp. 565-606) di una necropoli gallica piùantica e con caratteri più spiccatamenteLateniani rispetto alle analoghe testimonianzedi Bologna è stata giustamente attribuita all'arri-vo precoce di un gruppo di Galli che si insedianelle vicinanze della città etrusca, non certo con
(12) Esemplare in tal senso la sintesi fra dati archeologi-ci e tradizione storica di MALNATI, VIOLANTE 1995, pp.97-120.
(13) Come ha sottolineato di recente G. Colonna all'in-terno di una doppia tradizione sulla loro etnogenesi:Colonna 1980 b, pp. 5-7; Id. 1993, pp. 131-134.(14) In generale si veda VITALI 1985; VITALI 1992 conampia discussione sul problema. Ma si veda ancheMALNATI, VIOLANTE 1995, pp. 106-108 con valutazionileggermente diverse da quelle che qui si propongono).
Giuseppe Sassatelli
330
intendimenti pacifici o alla ricerca di semplicirapporti commerciali, come lasciano intenderesia la posizione di questo villaggio subito al di làdel Reno, e quindi in grado di effettuare unapolitica di controllo a distanza ravvicinata neiconfronti della città etrusca, sia il suo arrocca-mento sul piano culturale che si manifesta inuna marcata persistenza degli originari caratterilateniani.
A Marzabotto (VITALI 1985; VITALI 1992con discussione del problema; MALNATI,VIOLANTE 1995, pp. 106-108) la cesura provo-cata dalla invasione gallica è ancora più eviden-te e macroscopica, proprio perché si manifestain un contesto urbano di straordinaria rilevanza:qui si costruiscono povere case di abitazionesulle ampie aree stradali; si adibiscono a luoghidi sepoltura interi settori dell'area urbana usan-do i vani delle case come recinti funerari e uti-lizzando come sepolture numerosi pozzi perl'acqua.
Anche nel mantovano (DE MARINIS 1986b,pp. 183-187; DE MARINIS 1989, pp. 37-45) siregistra qualcosa di analogo, con la brusca inter-ruzione dell'abitato del Forcello e un probabilespostamento dell'abitato etrusco verso Mantovache, proprio in virtù della sua posizione strate-gicamente favorevole, forse riuscì a mantenereil suo status urbano, il nomen etrusco e forseanche la lingua ben oltre la fine degli altri centripadani.
Spina (e per certi versi anche Adria) ha undestino diverso (15). Pur registrando unmomento di crisi nella prima metà del IV seco-lo in conseguenza dell'alleanza antietrusca traDionigi di Siracusa e i Galli, sembra che la cittànon solo sia uscita indenne dalla calata dei Galli,ma abbia addirittura potuto essere un punto diraccolta e di coagulo per molti Etruschi padaniqui fuggiti dall'interno, anche con l'intento dicercare nella guerra da corsa e nella pirateria unmodo per sopravvivere allo scardinamento eco-
nomico del loro entroterra provocato dai Galli.Questi mutamenti così radicali in tutti i prin-
cipali centri urbani del sistema etrusco-padanosi riverberano in modo altrettanto drastico sulterritorio. Cambia complessivamente la fisiono-mia del popolamento e cambiano le direttriciviarie e commerciali. Il nuovo assetto si caratte-rizza infatti per una accentuazione della ruralitàe per la dispersione del popolamento in piccolinuclei sparsi, non più coordinati da un fortecentro urbano che fungeva da capitale. Perquanto riguarda le direttrici commerciali credosia sufficiente ricordare che l'obiettivo dei Gallidi assumere in prima persona il ruolo di inter-mediari fra Mediterraneo e continente europeosi realizza in primo luogo imponendo l'abban-dono e lo svuotamento dei vecchi itinerari com-merciali (si pensi solo a Marzabotto e alla valledel Reno); e in secondo luogo riorganizzandovie nuove e alternative, specie per quanto con-cerne i transiti appenninici, complessivamentepiù spostate verso est e verso la Romagna(SASSATELLI 1977, pp. 27-35 e, più di recente,VITALI 1984, pp. 24-35).
Che il controllo delle vie appenniniche fosseimportante anche per i Galli lo dimostra il fattoche negli “abitati di montagna” il numero deiguerrieri è assai maggiore che negli “abitati dipianura” (VITALI 1998, pp. 266-272; VITALI1984, pp. 24-35). Il centro di Monte Bibele èesemplare da questo punto di vista, specie inrapporto a Bologna. A monte Bibele infatti unprimo nucleo di Etruschi, forse fuggito dallapianura, viene raggiunto da individui stranieri,di sicura origine transalpina, indiziati dallarepentina comparsa delle armi nelle tombe. Adessi si affianca ben presto una componentemaschile non guerriera legata verosimilmentead attività mercantili. Per cui dopo una primafase di assestamento si registra una intensa eprogressiva etruschizzazione dei vertici dellasocietà gallica attraverso l'esibizione di utensiliin bronzo per il banchetto e quindi l'adesione agiochi simposiaci oltre che a ideali atletici, finoa forme di eroizzazione del defunto che riman-dano addirittura al mondo macedone, sia pure
(15) Per il ruolo di Spina in età tarda, quando ormai sonoquasi scomparsi o comunque molto ridimensionati i cen-tri etruschi dell'interno, rimando a SASSATELLI 1990, pp.96-100.
Celti ed Etruschi nell’Italia settentrionale
331
attraverso la mediazione del mondo etrusco-ita-lico (VITALI 1987 a, pp. 365-376). A quest'ulti-mo riguardo resta ancora da approfondire l'e-ventuale ruolo che elementi etruschi poteronoavere nel vasto programma di riorganizzazionee di rilancio sul piano economico di gran partedel territorio di Bologna tra il IV e il III secolo,con una forte ripresa delle relazioni commercia-li con l'Etruria, in un progetto complessivosicuramente gestito dai Galli, ma realizzatoanche grazie a una forte partecipazione degliEtruschi superstiti. Anche su questo punto avròoccasione di tornare più avanti, prendendo inesame proprio la documentazione epigrafica diMonte Bibele.
Dopo queste considerazioni di caratteregenerale, vorrei soffermarmi ora su alcune que-stioni di epigrafia nella convinzione che ladocumentazione epigrafica consenta di affron-tare il nostro problema in modo assai piùapprofondito di quanto non sia possibile farecon la sola documentazione archeologica. Equesto vale sia per la dinamica interna alle sin-gole comunità padane, come ad esempioBologna e Monte Bibele, sia per la più generalemobilità di individui, e in modo particolare diCelti, all'interno delle grandi comunità dell'Italiasettentrionale, vale a dire gli Etruschi, i Veneti ei Liguri.
Sono ben noti a tutti i progressi delle nostreconoscenze relativamente alla acquisizione del-l'alfabeto e alla pratica della scrittura in tuttal'Italia settentrionale, a cominciare dall'Etruriapadana, dove fino a qualche anno fa si pensavache la scrittura non fosse più antica del V seco-lo, mentre oggi sappiamo che essa è conosciutae praticata fin dagli inizi del VII secolo; per fini-re all'area atestina e golasecchiana dove si è veri-ficato qualcosa di molto simile, sia pure con unlieve scarto cronologico rispetto a Bologna.
Per l'area golasecchiana che qui ci interessapiù da vicino ne sono una prova l'iscrizioneleponzia di Castelletto Ticino, datata agli inizi ocomunque alla prima metà del VI secolo; l'iscri-zione di Sesto Calende, datata al tardo VII seco-lo, sulla cui classificazione da un punto di vista
linguistico fino a poco tempo fa non c'eraaccordo fra gli studiosi: G. Colonna la conside-rava etrusca, mentre A.L. Prosdocimi la consi-derava leponzia, più per il fatto che si trova inun'area leponzia che per tratti linguistici riferibi-li al leponzio (ma anche su questa si è registrataproprio di recente una convergenza sulla primaproposta di A.L. Prosdocimi); e poi l'iscrizionemonumentale di Prestino, già del VI secoloinoltrato (e forse anche del V) dalla quale è par-tito il riconoscimento di una celticità linguisticaanteriore al V secolo (vedi note 2 e 3). Ma nellastessa area di Golasecca ci sono altri importan-ti documenti epigrafici come l'inizio di unaiscrizione da Villa del Foro presso Alessandria(GAMBARI, VENTURINO 1987, p. 425, fig. 39 n.20), e l'inizio di un'altra iscrizione da CastellettoTicino (GAMBARI 1987, pp. 412-413, fig. 33, n.4), entrambe di incerta classificazione, data laloro brevità, ma soprattutto un'altra iscrizioneancora inedita, ma visibile al museo di SestoCalende dove è esposta, in corso di studio daparte di chi scrive (16).
Prescindendo da alcuni problemi di classifi-
(16) Una prima notizia è stata data da G. Rocca nellaRivista di Epigrafia Italica, in Studi Etruschi LIII, 1997(ed.1999), pp. 443-447, con una lettura e una interpreta-zione, a mio avviso, poco convincenti e che comunquevanno riviste. L’ipotesi di una pseudoiscrizione, cioè diuna sequenza lineare di lettere, ma anche di segni che nonassomigliano a lettere, realizzata non per essere letta, masolo per evocare la scrittura mi sembra debole e pocosostenibile in questa età e in questo ambito culturale dovele prime rare testimonianze di scrittura assumonocomunque una straordinaria importanza sia sul pianosociale che su quello storico. Ho avuto occasione diriconsiderare questo importantissimo documento epigra-fico in una comunicazione tenuta al III ConvegnoArcheologico Regionale ''La Protostoria in Lombardia''tenutosi a Como nell'Ottobre del 1999, per i cui Atti nonho fatto in tempo a consegnare il testo della mia comu-nicazione. Ne ho comunque in corso lo studio e ho avutooccasione di formulare per ora solo qualche considera-zione preliminare nella nuova Guida del Museo di SestoCalende, nella direzione comunque di considerarla unavera iscrizione, lunga e complessa, quasi sicuramenteleponzia, forse accompagnata però da un lemma etrusco,isolato, che potrebbe costituire un riferimento allo stessoesercizio della scrittura (SASSATELLI 2000).
Giuseppe Sassatelli
332
cazione linguistica sui quali rimane ancora qual-che incertezza, risulta evidente il debito che l'a-rea di Golasecca ha nei confronti degliEtruschi, ai quali deve la trasmissione dell'alfa-beto e l'insegnamento della scrittura e in talunicasi anche l'accoglimento di alcune struttureonomastiche e testuali, come proverebbe l'acco-stamento proposto da G. Colonna tra la formaleponzia osioio e le forme etrusche lar urus oplikasnas per indicare il possesso del vaso su cuisono graffite (GAMBARI, COLONNA 1988, p.141). Si ha così l'impressione di un rapportomolto stretto tra le due aree forse reso possibi-le e alimentato anche dallo spostamento fisicodi alcuni individui in entrambe le direzioni: loproverebbero da un lato le iscrizioni etrusche, ocomunque legate all'ambito etrusco, documen-tate in area golasecchiana, come vedremo trapoco. Ma lo provano anche alcuni documentiarcheologici, come ad esempio una tomba delsepolcreto Certosa di Bologna che, avendocome unico oggetto del corredo un bicchieregolasecchiano enfaticamente collocato vicinoalla testa del defunto (fig. 5), è stata riferita ad unindividuo proveniente da quest'area che cometale intendeva segnalarsi all'interno della comu-nità etrusca in cui aveva vissuto ed era morto(SASSATELLI 1989, p. 64).
Ma i rapporti fra l'Etruria padana e l'area di
Golasecca toccano anche importanti aspettidella linguistica e dell'onomastica. È noto cheesiste una serie di gentilizi etruschi caratterizza-ti dal formante -alu, tipici, per non dire esclusi-vi, dell'area padana. E' altrettanto noto che esi-ste sicuramente una relazione tra il formanteetrusco -alu e quello leponzio -alo, utilizzato performare appositivi e/o patronimici. SecondoA.L. Prosdocimi se -alu dell'etrusco ha a chefare con -alo del leponzio, la direzione del pre-stito va dal celtico all'etrusco e non viceversa(PROSDOCIMI 1991b, pp. 167-170; PROSDOCIMI1997, pp. 460-463 e 468-470). Alle conseguenzepuramente linguistiche di questo prestito siaccompagnano anche delicate questioni ono-mastiche, le quali dipendono a loro volta da pre-cise esigenze strutturali e sociali, come ad esem-pio l'emergere delle gentes all'interno di comuni-tà molto avanzate come potevano essere quelledell'Etruria Padana e in particolare di Bologna.Lo stesso formante -alu/-alo poteva avere quin-di funzioni diversificate (appositivo, patronimi-co, gentilizio) a seconda della struttura socialeche vigeva nell'ambito in cui esso era utilizzato,ma costituisce comunque una prova ulterioredelle strettissime relazioni che intercorrono traqueste comunità dell'Italia settentrionale purcosì diverse nella loro struttura e nella loro arti-colazione sociale.
Ma è dalla documentazione epigrafica, e inparticolare dalla documentazione onomastica,che specie negli ultimi anni sono venute novitàimportanti sulla mobilità e sulla provenienza dialcuni individui ricollegabili all'ambito celticosia direttamente, cioè attraverso l'esplicito riferi-mento al loro ethnos, sia indirettamente, cioèattraverso peculiarità linguistiche della loro areadi appartenenza o di origine che i loro nomi dipersona conservano e palesano. Il fenomenocoinvolge in primo luogo gli Etruschi, sia quel-li dell'Etruria propria che quelli dell'EtruriaPadana, entrambi con un forte potere di attra-zione nei confronti del mondo celtico che stavapiù a nord; ma riguarda anche l'ambito atestino,verso il quale evidentemente non mancò unflusso analogo, anche se minore, di individui
Fig. 5. Bologna, Museo Civico Archeologico: bicchiere gola-secchiano, unico oggetto del corredo, deposto accanto alla testadel defunto, nella tomba Certosa 57.
provenienti dallo stesso mondo celtico. In que-sta prospettiva vanno considerate in primoluogo alcune iscrizioni che contengono unesplicito e diretto riferimento all'ethnos deiCelti/Galli.
L'iscrizione mi celθestra da Cerveteri, graffitasu una ciotola di bucchero del tardo VI secolo,viene divisa in celθes + tra (= suffisso che indi-ca “a favore di...”) da G. Colonna, che conside-ra kelθe/kelte una etruschizzazione del grecokeltòs (COLONNA 1985, pp. 270-271). Si tratte-rebbe quindi di un celta giunto a Cerveteri ecome tale indicato all'interno della comunitàetrusca, interpretazione a mio avviso convin-cente, anche se non sono mancate letture diver-se per questa iscrizione (17).
A Spina è sicuramente documentato, siapure più tardi, un keltie (COLONNA 1993, p. 140e VITALI 1996, p. 262) (fig. 6). L'iscrizione, incorretta grafia settentrionale, è graffita su unaciotola a vernice nera, purtroppo fuori conte-sto, ma databile tra la fine del IV e gli inizi delIII secolo, e si riferisce ad un individuo cheall'interno della comunità etrusca di Spina siconnotava come “il Celta”, cioè con un etnoni-mo complessivo e generale rispetto al suoambito di provenienza, analogamente acreice/craice, cioè “il Greco”.
Dal nome “celtie/keltie” deriva il gentilizio dietà recente, documentato a Chiusi, ma portatoda individui di probabile provenienza padana,*celtalu (femminile celtalui), da intendersi come ilfiglio o il discendente di un “Celta” (così comeil kraikalu di Marzabotto è figlio o discendentedi un kraike, il “Greco”) (SASSATELLI 1991, pp.710-713).
Molto più interessanti alcuni nomi su cui haportato l'attenzione di recente D. Vitali (VITALI
1996, pp. 262-265), che contengono indicazio-ni puntuali sulla provenienza dal mondo celticodi alcuni individui perfettamente inseriti all'in-terno delle comunità etrusche dell'area padanao dell'Etruria settentrionale. A Mantova(Vicolo della Pace) è documentato il nome elu-veite (fig. 7), graffito su una ciotola di pasta gri-gia, databile tra la fine del IV e gli inizi del IIIsecolo. Anche in questo caso l'iscrizione contie-ne un riferimento etnico, assai meno genericodi Celtie, e costituisce la più antica menzione delnome degli Elvezi. Si tratta ancora una volta diuna affermazione di autoidentità celtica, daparte di un individuo che all'interno della realtàlocale egemone di Mantova, che è una realtàetrusca, viene indicato come “l'Elvezio”. Lostesso D. Vitali, prendendo spunto da questaiscrizione, non ha mancato di sottolineare alcu-ni legami sul piano archeologico tra l'area nord-
Celti ed Etruschi nell’Italia settentrionale
333
(17) Nella stessa discussione suscitata dalla lettura e dallainterpretazione di G. Colonna e M. Cristofani(COLONNA, CRISTOFANI 1985 p. 271), propone di inse-rire il nome celθe nella serie dei nomi in -θe/-te, suddivi-dendolo in cel + θe, dove cel sarebbe il nome della dea eθe sarebbe un suffisso che indica provenienza, comenegli antroponimi da etnici del tipo mauθvate o lotiθe.Dubbi sulla interpretazione di G. Colonna sono espressianche da PROSDOCIMI 1987, pp. 575.
Fig. 6. Spina. Iscrizione keltie graffita su una ciotola a v.n.databile tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C.
Fig. 7. Mantova (Vicolo della Pace). Iscrizione eluveitiegraffita su una ciotola di pasta grigia databile tra la fine delIV e gli inizi del II secolo a.C.
italica e la regione degli Elvezi, e di ricordare lanotizia di Plinio (Nat. Hist. XII, 5) relativa aHelico, un elvezio che soggiornò a Roma comefabbro e che, dopo aver acquisito un bagaglioconsistente di tecnologie artigianali nel settoredella metallurgia, se ne tornò in patria stimolan-do, al pari di Arrunte e dei suoi prodotti agrico-li, i propri connazionali alle grandi invasioni delIV secolo. Sempre a D. Vitali (VITALI 2000), pp.115-122) si deve ora un altro importante rico-noscimento sul piano onomastico, che va adaggiungersi ai precedenti e che costituisce unulteriore tassello per la ricostruzione della dina-mica dei rapporti tra Celti ed Etruschi, e di que-sta mobilità degli individui. Il nome rutanies (fig.8), usato come gentilizio in una iscrizione diBolsena (III secolo) e il nome rutania, docu-mentato a Chiusi con funzione di cognomen,nomi nei quali già Rix aveva riconosciuto paral-leli interessanti con l'onomastica celtica, vengo-no ricollegati o alla popolazione dei Ruteni, dis-locati nel sud-est della Gallia, oppure al nomedel Rodano (Rodanos-Ροδανον). Ne discendeche tali iscrizioni potevano indicare all'internodelle comunità etrusche di Bolsena e di Chiusi“l'uomo del Rodano” o “il Ruteno”, entrambicomunque provenienti (loro o i loro antenati)dal mondo celtico transalpino.
Stesso valore e stesso significato potrebbeavere l'iscrizione atestina Ego Fremai BoialnaiRebetoniai, databile alla fine del V secolo o agliinizi del IV, nella quale si riconosce una donna,Frema Rebetonia, moglie di un Boialos (= Boialna),nome in cui si riconosce agevolmente il discen-
dente di un Boios (MARINETTI 1992, pp. 150-153e 157-159; VITALI 1996, pp. 258-259). Anche inquesto caso ci troviamo di fronte ad un indivi-duo che conserva nel nome con cui viene inte-grato nella comunità che lo accoglie i segni e letracce della sua identità etnica. Non mancanonello stesso ambito atestino altre attestazionionomastiche che rimandano alla popolazioneceltica dei Boi, come ad esempio Moldo Boiknos,Lemetor Boios e Viseio Boios, oppure più generica-mente ai Galli, come ad esempio Ukona Galknos(PROSDOCIMI 1988, pp. 275 e 282; MARINETTI1992, pp. 137 e 145; VITALI 1996, pp. 258-259).
E per finire, sia pure con qualche incertezzaper la sua grande diffusione nell'Etruria pro-pria, si potrebbe ricordare anche il nome cale(fig. 9), relativamente diffuso, che forse rispec-chia sul piano onomastico la discesa dei Galli asud del Po e dell'Appennino, dovendosi inten-dere cale come etruschizzazione del latinoGallus (18).
Esempi analoghi per quanto riguarda questotipo di mobilità si trovano anche in altre areedell'Italia settentrionale e con il coinvolgimentodi realtà etniche diverse da quelle dei Celti. Li
Giuseppe Sassatelli
334
(18) PALLOTTINO 1984, p. 403. Per gli esempi qui illustra-ti alla fig.4 si vedano rispettivamente CIE II, I, 4 n. 5713e Rivista di Epigrafia Etrusca, in “SE” XLV, 1977, p. 309 n.43.
Fig. 8. Iscrizione onomastica (prenome, gentilizio e patroni-mico) apposta su un cippo funerario da Bolsena databile alIII-II secolo a.C. Il gentilizio è rutanies.
Fig. 9. Iscrizioni dal teritorio di Chiusi con il nome cale,usato sia come gentilizio che come cognomen. La prima èapposta su un cippo di nenfro (CIE II, I, 4 n.5713); laseconda su un'urna fittile a stampo (REE 1977, n.43).
ricordo brevemente, se non altro per mostrarecome questa prassi fosse relativamente fre-quente. Mi riferisco in particolare alla iscrizionevenetica ego Nercai Trostiaiai, della tombaRicovero 23 di Este - una tomba straordinariaper la qualità e la quantità del suo corredo -dove la base del nome Trost- è stata accostata aTurst(o)- e, pur non avendo la stessa evidenzaformale di quest'ultimo, è stata considerata undiverso modo per venetizzare un etrusco “turs”,inteso come nome degli Etruschi. Si è così pen-sato a una donna etrusca venetizzata che, all'in-terno della comunità che l'aveva accolta, venivaindicata con un nome in cui erano palesi i rife-rimenti alla sua terra d'origine (19).
Più chiara in tal senso l'iscrizione Reiθvi, suuna stele di Tombarelle nel territorio diBologna (fig. 10). Si tratta di una iscrizione fem-minile formatasi probabilmente sul nomemaschile reitu, documentato a Sanzenonell'Anaunia, dal cui femminile reitui potrebbeessere derivata la forma reitvi/reiθvi, nome die-tro il quale si cela con ogni probabilità l'indica-zione di una origine retica. Si tratterebbe quin-di una defunta che in ambiente etrusco si qua-lificava come “la Retica” (SASSATELLI 1989,pp.67-69).
Va sottolineato che in entrambi questi dueultimi casi si tratta di donne “straniere”, il cuiinserimento nella comunità che le accoglieavviene attraverso il matrimonio, con ogni pro-babilità nel caso di Nercai Trostiai, con assolutacertezza nel caso di Reiθvi, indicata comemoglie di Keisna, cioè di un etrusco individua-to dal suo gentilizio.
Accanto a questa categoria di documenticosì puntuali nelle loro indicazioni etniche, cene sono altri costituiti da nomi propri che, puressendo formalmente inseriti nella lingua e nel-l'onomastica del gruppo egemone in cui vengo-no a trovarsi, conservano tracce palesi di unalontana origine celtica.
In uno dei due cippi di Rubiera, nel preno-me femminile Kuvei, di Kuvei Puleisnai, unadonna con gentilizio etrusco e per di più mogliedello zilaθ ricordato nella stessa iscrizione, DeSimone riconosce un nome celtico maschileKuve-Covos-Covius che intende come formazioneipocoristica del nome celtico Covirus/Covirius(DE SIMONE 1992, pp. 11-12).
Poco più tardi abbiamo ad Orvieto dueiscrizioni, mi Aviles Katacinas e Vercena, che sem-pre De Simone considera due Celti di nomeCatacos/Catacios e Vercos, trapiantati a Orvieto equi etruschizzati addirittura nella prima metàdel VI secolo (DE SIMONE 1978, pp.370-395).
Celti ed Etruschi nell’Italia settentrionale
335
(19) PROSDOCIMI 1992, pp. 464-465. L'ipotesi di unadonna veneta filoetrusca avanzata dallo stessoProsdocimi in alternativa alla prima, mi pare meno plau-sibile.
Fig. 10. Bologna, Museo Civico Archeologico: Stele daTombarelle (Bologna) con iscrizione etrusca ReiθviKeisnas.
Non tutti però sono d'accordo su questa pro-posta e A.L. Prosdocimi in particolare ha nega-to la celticità della base onomastica di Katacina,riconducendola invece a nomi italici comeTursikina, Vestiricina e altri di questo stesso tipo(PROSDOCIMI 1986, pp. 86-89; PROSDOCIMI1987, pp. 574-575). Va detto però che mentreper questi ultimi esiste un italico Tursikis oVestiricis, non pare sia documentato un nomeKatacis. E su questa assenza insiste molto C. DeSimone nel sostenere la sua teoria.
Sempre in una età relativamente antica vaconsiderata anche l'iscrizione epuniana presen-te a Vulci su un'anfora etrusca della fine delVII, con un nome del quale è stata riconosciu-ta una base celtica -epo- ricollegabile aEppius/Epinius del latino (MARTELLI 1987, pp.199-202, n. 5; DE SIMONE 1993, pp. 27-28 conposizione sfumata al riguardo).
In una tomba del sepolcreto Arnoaldi diBologna, databile alla fine del V secolo, sotto ilpiede di una coppa-skyphos attica è graffita l'i-scrizione mi uva (fig. 11). La base tematica delnome Uva è la stessa del nome personaleUvamokozis di Prestino e Uvezaruapus di unastele della Lunigiana, ed è stata pertanto ricolle-gata all'onomastica di ambito leponzio(MACELLARI 1994, pp. 97-105).
Arrivando, per concludere, a episodi crono-logicamente più recenti, collocabili tra la secon-da metà del IV e la prima metà del III secolo, sipossono ricordare alcune iscrizioni tarde diSpina come Mutalu, Pratalu, Raukvalu (ora peròriletta da Vitali in Rautialu) (COLONNA 1993, p.140; VITALI 1996, pp. 260-261) la cui base ono-mastica rimanda all'ambito leponzio e che per-tanto testimonierebbero comunque l'avvenutaintegrazione di Celti nella comunità etrusca diSpina, come del resto è provato dal suffissoetrusco-padano -alu, anche se è difficile stabili-re esattamente a quale periodo tale integrazionepossa risalire.
Importante sotto questo aspetto anche l'i-scrizione Treute, sempre da Spina, perché essarimanda a Drutos/Drouto/Dreuto, cioè ad unnome inconfondibilmente celtico (COLONNA
1993, p. 140).Allo stesso orizzonte cronologico appartie-
ne il nome muceti, che M. Cristofani consideraceltico, documentato non a caso a Volterra,profondamente inserita nei circuiti commercia-li di IV e III secolo, che coinvolgevano moltidei siti e dei territori controllati dai Galli(CRISTOFANI 1978, p.72).
Nomi celtici o comunque di lontana origineceltica sono presenti anche in ambito venetico,dove, con un procedimento analogo a quellifino ad ora considerati, vengono adattati all'o-nomastica locale, mantenendo comunque letracce del loro ceppo originario. Ne sono testi-monianza alcune iscrizioni venetiche su ciotto-li, sulle quali ha portato l'attenzione più volteA.L. Prosdocimi: a) Tivalei Bellenei; b) FugioiTivalioi Andetioi ecc.; c) Voltiginei Andetiaioi ecc.;d) Fugiai Andetinai Fuginiai ecc. (PROSDOCIMI1984 a, pp. 199-224; PROSDOCIMI 1986, pp. 84-86; PROSDOCIMI 1987, pp. 575-577). Da unesame complessivo di queste tre iscrizioni, chehanno evidenti segni di colleganza, lo stessoProsdocimi ha potuto ricostruire nei minimidettagli tutte le varie tappe di inserimentosociale e di adattamento onomastico degli indi-
Giuseppe Sassatelli
336
Fig. 11. Bologna, Museo Civico Archeologico: Cup-skyphos attica a f.r. dal sepolcreto Arnoaldi con iscrizioneetrusca mi uva.
vidui coinvolti. Il capostipite di questa impor-tante sequenza onomastica è Tival- Bellen-, che èuno straniero e viene a Padova dal di fuori(forse da Andes); qui ha un figlio, Fugios, che neassume il patronimico (Tivalios) e un secondoappositivo (Andetios), che forse indica l'avopaterno e che comunque rimanda al loro luogodi origine (Andes?); Fugios ha a sua volta unfiglio da una schiava Andetia, figlio che chiamacol nome venetico Voltigenes e da qui in poi lagenerazione mostra di aver raggiunto una posi-zione sociale piena all'interno del gruppo vene-tico che l'ha accolta. Di questa lunga e interes-sante sequenza famigliare quello che qui inte-ressa è il nome del capostipite Tival- Bellen-,sicuramente estraneo all'onomastica veneta ericollegabile invece ai nomi in Bello-, ai qualiappartiene anche il nome di Bellovesus, con unasignificativa proiezione, ancora una volta, versoil mondo celtico. In parallelo a tutto questoanche per l'iscrizione sekenei di Bagnolo SanVito (Mantova) è stato proposto di riportare laradice seken- ai nomi celtici in Sego/Seco, tra iquali va compreso anche il nome di Segovesus,mitico fratello di Bellovesus (20). Mi paiono duecasi molto interessanti di integrazione in ambi-to venetico di due individui di chiara origineceltica, muniti, a questo proposito, quasi di duenomi “parlanti” e con esplicito riferimento allapiù antica storia dei Celti nel loro rapporto conl'Italia.
Osservazioni molto simili si possono fareper alcune iscrizioni di Oderzo (PROSDOCIMI1984b, pp. 423-445), sempre in ambito veneti-co, oltre che per alcune iscrizioni su stele dellaLunigiana (21). Anche se i pochi documenti dicui possiamo disporre rendono molto incerte lerispettive classificazioni sia linguistiche cheonomastiche.
Fenomeni ancora più complessi di mobilitàindividuale tra gruppi vicini, ma culturalmenteed etnicamente diversi, e con integrazioni assaipiù sfumate e complesse, che investono nonsolo l'aspetto sociale ed onomastico, ma anchelivelli più squisitamente culturali, si registranonell'area golasecchiana e nei vicini territori etru-schizzati della Liguria, oltre che nella stessaEtruria settentrionale. Mi riferisco all'iscrizioneetrusca rinvenuta a Busca in Piemonte (22)(fine del VI o inizi del V secolo), incisa su unsegnacolo per indicare l'appartenenza dellatomba cui si riferiva a un larθ muθikus (fig. 12),con una formula onomastica bimembre, costi-tuita da un classico prenome etrusco e da unnome individuale con funzione di gentilizioavvicinabile a nomi gallici come Mottius e Mottuso come Motucus e Moticius. E' evidente che si
Celti ed Etruschi nell’Italia settentrionale
337
Fig. 12. Iscrizione etrusca mi suθi larθial muθikus inci-sa su un ciottolo-segnacolo da Busca (Cuneo).
(20) DE MARINIS, CRISTOFANI 1985, pp.202-204 n.3 (DeMarinis) e p.278 (Cristofani che la considera venetica). Siveda anche PROSDOCIMI 1986, p. 86; PROSDOCIMI 1987,pp. 575-576.(21) MAGGIANI, PROSDOCIMI 1976, pp. 258-264(Maggiani), pp. 265-266 (Prosdocimi); PROSDOCIMI1986, pp. 76-79 e VITALI 1996, p. 259 con altri riferimen-ti.
(22) Per questa iscrizione ricordata in molti lavori di que-sti ultimi anni mi limito a citare le cose più recenti:GAMBARI, COLONNA 1988, p. 154; COLONNA 1998 b,pp. 299-303; e soprattutto COLONNA 1998 a, pp. 261-266, con ampia trattazione del problema e relativi riman-di.
tratta di un indigeno che non solo ha volutoetruschizzare il proprio nome, ma ha volutoaccostarvi un prenome squisitamente etrusco,adottando una formula onomastica bimembree un tipo di scrittura tra rotaie che enfatizzanoulteriormente questa sua piena adesione almondo etrusco. Si è ipotizzato che questa suaforte acculturazione in senso etrusco sia avve-nuta nell'Etruria settentrionale. Di qui, con unitinerario analogo a quello del faber elvezioHelico, il nostro personaggio sarebbe poi parti-to per tornare alla sua terra d'origine, doverimase fino alla morte e dove fu sepolto.
Pur nella diversità dell'esito finale, qualcosadi simile si può ipotizzare per l'iscrizione minemeties (fig. 13) incisa su un ciottolo-peso rinve-nuto a Genova (prima metà del V secolo)(BERMOND MONTANARI 1979, pp. 296-297, n.1;COLONNA 1980c, p. 185), anch'essa etruscanella lingua e nel formulario, ma costituito daun nome indigeno etruschizzato, evidentemen-te un celto-ligure che da nord si era trasferito aGenova e qui si era a tal punto integrato all'in-terno della comunità etrusca che controllava lacittà (23), da non fare più ritorno alla sua terrad'origine così come invece aveva fatto larθmuθiku, forse anche perché aveva raggiuntoanche un ruolo sociale ed economico di rilievo,visto che il suo nome va probabilmente intesocome garante del peso espresso dal ciottolo sucui si trova inciso, in analogia con quanto siverifica per l'iscrizione mi latuvnies di
Marzabotto (fig. 14), anch'essa incisa a titolo digaranzia su un ciottolo-peso (SASSATELLI 1994,pp. 15-18 n. 1, con riferimenti).
Processi analoghi sono inoltre ipotizzabiliper nomi come il Keivale di CastelnuovoBerardenga (seconda metà del VII secolo) el'Enistale di Ameglia (inizi del III secolo)(COLONNA 1998 a, pp. 261-266). Per entrambisi pensa naturalmente a individui di originecelto-ligure che, una volta scesi in Etruria pro-pria, hanno etruschizzato il proprio nome,come mostra la trasformazione in -ale del suf-fisso leponzio -alo (sa la stessa etruschizzazionefosse avvenuta in Etruria Padana avrebbe avutocome esito gentilizi del tipo Keivalu e Enistalu),pur mantenendone la originaria struttura uni-membre. Diversamente dal larθ muθiku diBusca, anche questi ultimi tuttavia non sonoritornati nella loro terra d'origine, ma sonorimasti nelle terre d'Etruria, dove si erano tra-sferiti e dove si erano perfettamente integrati.
A questi indigeni spintisi verso sud e poietruschizzatisi fa riscontro un gruppo diEtruschi della Val d'Arno insediatisi a nord, nelcuore del territorio celto-ligure, come prova tral'altro la stele iscritta di Mombasiglio (fig. 15)(COLONNA 1998 a, pp. 261-266).
Sono tutti segni di una grande mobilità indi-viduale che coinvolge gruppi vicini o comun-que con strettissimi rapporti culturali e com-merciali, lasciando intravedere fenomeni diintegrazione che vanno ben al di là di quelloche si può dedurre dalla sola documentazione
Giuseppe Sassatelli
338
(23) Qualcosa di molto simile si verifica per uci (iscrizio-ne di possesso ucial) di Lattes, in Provenza, un altro per-sonaggio di origine celtica che, a contatto con gliEtruschi presenti all'interno di questo importante oppi-dum costiero, ha etruschizzato il proprio nome forse perragioni matrimoniali. Per questa iscrizione si vedaCOLONNA 1980 c, pp. 181-185.
Fig. 13. Iscrizione etrusca mi nemeties incisa su un ciot-tolo-peso da Genova. Il nome indica il garante del peso.
Fig. 14. Iscrizione etrusca mi lavtunies incisa su un ciot-tolo-peso da Marzabotto. Il nome indica il garante del peso.
archeologica. Le ideologie e le culture si assimi-lano e si mutano con una certa facilità, la linguae l'onomastica sono più radicate e più difficilida cambiare. E anche quando cambiano, attra-verso processi di integrazione sociale ed ono-mastica, mantengono sempre qualche tracciadella loro origine e dei loro ambiti di partenza,consentendoci di cogliere fenomeni assai com-plessi e del tutto inafferrabili sul piano dellasemplice documentazione archeologica.
In questa stessa prospettiva, se concentria-mo la nostra attenzione sul caso di MonteBibele la documentazione consente di fareimportanti progressi nella definizione dellastruttura e delle dinamiche sociali della comuni-tà celtica che qui si era insediata, oltre che nellaricostruzione dei rapporti che essa intrattenevacon le comunità vicine, e in particolare con gliEtruschi, rendendo così assai più concreti sulpiano storico non solo quel processo di etru-schizzazione delle élites celtiche che ben cono-sciamo, ma anche il ruolo che Celti ed Etruschiebbero nella rivitalizzazione economica di unaparte consistente dell'area padana tra IV e IIIsecolo.
A Monte Bibele sono attestate fino ad ogginove iscrizioni (24) che qui elenco grossomodo in ordine cronologico:
1. Fulu (fig. 16).
Dalla Tomba 42, a inumazione, con defuntomaschio e guerriero.
Nome maschile al caso zero, nome bene attesta-to nell'Etruria settentrionale sia come prenome checome gentilizio (oltre che cognomen), che si inseri-sce perfettamente nella tradizione dei nomi indivi-duali in -u frequenti in area padana, dove il più dellevolte sono usati come gentilizi.
Cronologia: seconda metà del IV secolo a.C..Bibliografia: Rivista di Epigrafia Etrusca, in Studi
Etruschi LVI, 1989-1990 (ed.1991), pp. 292-293 n.3 (D.Vitali).
2. Petnei (fig. 17).
Celti ed Etruschi nell’Italia settentrionale
339
(24) Tranne la n. 5, che è inedita e che posso presentarequi per la prima volta, grazie alla cortesia dell'amicoDaniele Vitali, le iscrizioni di Monte Bibele sono statespesso ricordate dallo stesso Vitali in diversi lavori di sin-tesi sul sito e sul sepolcreto. Mi limito qui a ricordareVITALI 1985; VITALI 1987a, pp. 370-371.
Fig. 15. Iscrizione etrusca husi <e>vete[s] zalle incisa suuna stele funeraria da Mombasiglio presso Ceva (Cuneo).
Fig. 16. Monte Bibele (Monterenzio). Tomba 42. Iscrizionefulu graffita all'interno di una ciotola di pasta grigia.
Fig. 17. Monte Bibele (Monterenzio). Tomba 14. Iscrizionepetnei graffita sulla parete esterna di una kylix a v.n.
Dalla tomba 14, a cremazione, con defuntomaschio e guerriero
Gentilizio femminile al caso zero.Cronologia: ultimi decenni del IV secolo a.C..Bibliografia: Rivista di Epigrafia Etrusca, in Studi
Etruschi L, 1982, pp. 260-261 n. 1 (D.Vitali).
3. mi laθialus (fig. 18).Dalla tomba 103, a inumazione, con defunto
maschio, ma non connotato come guerriero.Formula onomastica di possesso costituita da un
gentilizio maschile (con il formante -alu tipico edesclusivo dell'area padana) al genitivo, preceduto dalpronome mi.
Cronologia: ultimi decenni del IV secolo a.C..Bibliografia: Rivista di Epigrafia Etrusca, in Studi
Etruschi LVI, 1989-1990 (ed.1991), pp. 294-295 n.4 (D.Vitali).
4. mi titaias (fig. 19).Dalla tomba 40, a inumazione e sicuramente
femminile.Gentilizio femminile con segnacaso del posses-
sivo, preceduto dal pronome mi.Cronologia: fine del IV-inizi del III secolo a.C..Bibliografia: Rivista di Epigrafia Etrusca, in Studi
Etruschi LIII, 1985 (ed.1987), p. 196 n. 1 (D.Vitali).
5. mi maθuris (fig. 20).Dalla Tomba 87, a inumazione. L'iscrizione è
graffita dopo la cottura sulla spalla di un'olla dipasta grigia che apparteneva al corredo della tomba,unitamente a due ciotole, due bicchieri e due piattel-li e ad uno skyphos a vernice nera, che indicherebbeuna sepoltura femminile, essendo questo tipo divaso solitamente deposto in tombe femminili (così
come la kylix appare invece esclusiva delle tombemaschili).
L'iscrizione è sinistrorsa con lettere abbastanzaregolari e ben distanziate: nasali con aste di egualealtezza e punti di unione marcatamente arrotonda-ti; alpha con asta verticale, gamba sinistra fortemen-te arcuata e traversa discendente nel verso dellascrittura; theta romboidale; ypsilon con i due trattistaccati; rho ad occhiello grande e panciuto; sadefinale con tratti divaricati e obliqui, usato comesegnacaso del possessivo. Vi si riconosce una for-mula onomastica unimembre, costituita da un nome
Giuseppe Sassatelli
340
Fig. 18. Monte Bibele (Monterenzio). Tomba 103.Iscrizione mi laθialus graffita all'esterno della vasca di unakylix a v.n.
Fig. 19. Monte Bibele (Monterenzio). Tomba 40. Iscrizionemi titaias graffita sulla parete esterna di una ciotola dipasta grigia.
Fig. 20. Monte Bibele (Monterenzio). Tomba 87.Iscrizione mi maθuris graffita sulla spalla di un'olla dipasta grigia.
flesso al genitivo e preceduto dal pronome mi, inuna ben nota formula di possesso: “io sono dimaθuri”. Il nome maθuri non è documentato altro-ve. Ricorda comunque nomi desinenti in -ri comeserturi, gentilizio femminile rispetto ad un maschileserturie; ancari usato come gentilizio sia con preno-mi maschili (vel, lar, aule) che con prenomi femmini-li (ana, fasti, larθi, ecc.); vari, anch'esso gentilizio fem-minile rispetto a varie; heiri, usato come gentilizio informula binomia assieme al prenome ravnθu. E'probabile quindi che anche il nostro ma uri sia ungentilizio femminile usato in una formula onoma-stica monomia per indicare la proprietaria del vaso,del quale, trattandosi di un'olla, sono tra l'altro facil-mente intuibili le connessioni con l'ambito domesti-co e con la sua gestione.
Cronologia: inizi del III secolo a.C..Bibliografia: inedita (la possa rendere nota grazie
alla cortesia di Daniele Vitali).
6. petnei (fig. 21).Dalla tomba 87, a inumazione, con defunto
maschio, ma non connotato come guerriero.Gentilizio femminile al caso zero.Cronologia: prima metà del III secolo a.C..Bibliografia: Rivista di Epigrafia Etrusca, in Studi
Etruschi LVI, 1989-1990 (ed.1991), pp. 290-291 n.1 (D.Vitali).
7. pav (fig. 22).Dalla tomba 75, con defunto maschi e guerriero.Nell'iscrizione è stato proposto di riconoscere la
forma abbreviata del nome individuale pava/pave, dicui però non è facile identificare il genere e di con-seguenza il tipo di rapporto che esso ha con ildefunto della tomba, che invece è sicuramentemaschio.
Cronologia: prima metà del III secolo a.C..Bibliografia: Rivista di Epigrafia Etrusca, in Studi
Etruschi LVI, 1989-1990 (ed.1991), pp. 291-292 n.2 (D.Vitali).
8. mi cavias ataiasx [...] (fig. 23).Dall'area dell'abitato.Iscrizione femminile di possesso, costituita da
prenome e gentilizio al genitivo, preceduti dal pro-nome mi.
Celti ed Etruschi nell’Italia settentrionale
341
Fig. 21. Monte Bibele (Monterenzio). Tomba 87.Iscrizione petnei graffita all'esterno della vasca di unakylix a v.n.
Fig. 22. Monte Bibele (Monterenzio). Tomba 75.Iscrizione pav graffita sul fondo esterno di una kylix a v.n.
Fig. 23. Monte Bibele (Monterenzio). Area dell'abitato.Iscrizione mi cavias ataiasx […] graffita sul fondo inter-no di una ciotola o kylix a v.n.
Cronologia: III secolo a.C.Bibliografia: Rivista di Epigrafia Etrusca, in Studi
Etruschi XLVII, 1979, pp. 304-305 n. 17 (G.Bermond Montanari) e Rivista di Epigrafia Etrusca,in Studi Etruschi LIII, 1985 (ed.1987), pp. 196-197n. 2 (D.Vitali).
9. [...]θuiteri (fig. 24).Dall'abitato.Nonostante qualche problema di lettura dovuto
alla grafia poco accurata dei singoli segni, non sem-pre identificabili con sicurezza, e nonostante lalacuna iniziale, vi si riconosce con ogni probabilitàla parte terminale di un nome femminile al casozero.
Cronologia: III secolo a.C.Bibliografia: LENZI 1983, pp. 183-191.
Nonostante qualche incertezza sulla n. 9,lacunosa e in una grafia approssimativa, tutte leiscrizioni di Monterenzio (fig. 25) sono etruscheper alfabeto, lingua e onomastica. Ciò significache all'interno della comunità insediata a MonteBibele la scrittura veniva praticata (o forsemeglio la pratica della scrittura veniva esibita)solo dalla componente etrusca, diversamenteda quanto si verifica nello stesso periodo aBologna, come vedremo tra poco. A questacompattezza sul piano linguistico si accompa-gna una forte omogeneità anche sotto l'aspettopaleografico: le alpha sono tutte piuttosto lar-ghe e generalmente costituite da un'asta vertica-le e da un tratto molto arcuato, con traversasempre discendente nella direzione della scrit-tura; epsilon e digamma sono quasi sempre incli-nati (o anche coricati) nella direzione della scrit-tura; l'asta verticale dell'epsilon si unisce al trattoinferiore della lettera in un unico segno curvili-
neo; nel tau il tratto superiore non taglia l'astaverticale ma vi si unisce obliquamente e su diun lato soltanto; anche le nasali con aste dieguale altezza sono piuttosto informi; in tutte leiscrizioni, infine, il sade si caratterizza per i trat-ti esterni fortemente divaricati e obliqui. Si trat-ta di elementi che ritroviamo nel sistema grafi-co vigente sia nell'Etruria settentrionale chenell'Etruria padana, in particolare nelle iscrizio-ni tarde di Spina, a conferma dell'inserimentodi Monte Bibele in una rete di traffici e di con-tatti che coinvolgeva pienamente questi dueambiti geografici.
Relativamente alla pratica della scrittura vasottolineato che, oltre alle iscrizioni, ci sonomoltissimi graffiti di una o più lettere, per iquali, comunque li si voglia interpretare, è evi-dente il riferimento alla scrittura e alla serie alfa-betica che serviva per realizzarla. Non è esclu-so tra l'altro che alcuni di essi possano essereinterpretati come inizi di alfabetari (ac) o comegraffiti con la prima e l'ultima lettera dell'alfabe-to (aχ) (25), a conferma dell'interesse e dell'at-tenzione che questo gruppo di Etruschi inseri-to all'interno della comunità celtica di MonteBibele aveva per la scrittura e per la sua esibi-zione, quasi a voler continuare una tradizioneassai ben radicata nelle città etrusche dell'areapadana, dove i numerosissimi graffiti alfabeticidi questo stesso tipo vengono solitamenteinterpretati come una allusione alla conoscenzae alla pratica della scrittura, intesa come attivitàdi prestigio.
Ancora più interessanti le considerazioniche si possono fare sui dati onomastici. Dellenove iscrizioni fino ad ora documentate ben seisono riferibili a donne (petnei, titaia, maθuri, pet-nei, cavia ataia e [...]θuiteri), una è incerta (pav) edue sono riferibili a maschi (fulu e laθialu). Inprimo luogo risulta quindi evidente l'assoluta
Giuseppe Sassatelli
342
Fig. 24. Monte Bibele (Monterenzio). Area dell'abitato.Iscrizione […]θuiteri graffita sul fondo interno di unacoppa a v.n.
(25) Si vedano a titolo puramente esemplificativo i graf-fiti pubblicati da LENZI 1983, pp. 183-189. I due graffiticui faccio cenno nel testo sono rispettivamente il n. 13 dip. 189 e il n. 19 di p. 191. Molti altri sono inoltre i graffi-ti di singole lettere o di gruppi di lettere su ceramichecome ho potuto constatare osservando i disegni dellapubblicazione integrale del sepolcreto: VITALI 2003.
prevalenza di nomi femminili, la maggiorparte dei quali sono dei gentilizi e si rife-riscono quindi a personaggi di rango ele-vato. La ripetizione di uno stesso gentili-zio (petnei) lascia inoltre intravedere la pre-senza non marginale, all'interno dellacomunità, di diversi membri di una stessafamiglia. All'interno quindi della comuni-tà di Monte Bibele, che le armi e il ritualedi sepoltura connotano senza alcun dub-bio come celtica, almeno per quantoriguarda i suoi vertici politici e militari, erapresente anche un consistente nucleo diEtruschi, e in primo luogo un consisten-te numero di donne etrusche, evidente-mente andate spose a capi-guerrieri. Chequesta integrazione fra Celti ed Etruschi,di cui sono ben noti gli esiti sul piano cul-turale e dello stile di vita (assimilazione daparte dei nuovi venuti di ideali atletici e diabitudini simposiache di chiara matriceurbana e di evidente tradizione etrusca),passasse anche attraverso vincoli matri-moniali è dimostrato chiaramente dallaiscrizione petnei della tomba 14 (n. 2 del-l'elenco): il corredo della tomba infattinon lascia dubbi sulla natura maschile deldefunto, oltre che sul suo rango di guer-riero e di capo, mentre l'iscrizione va rife-rita ad una donna, quasi sicuramente lamoglie del defunto, proprietaria e donatri-ce del vaso sul quale è graffita l'iscrizione,il cui caso zero lascia intendere un procedimen-to di identificazione con l'oggetto donato, bennoto in aree periferiche come quella padana eancora più significativo se si considera che ilvaso in questione, una kylix, è tipico ed esclusi-vo dei corredi maschili nella necropoli diMonte Bibele. Di grande interesse anche l'iscri-zione dei graffiti pe ed ei, da intendersi rispetti-vamente come l'inizio e la fine dello stessonome petnei, su un piattello e su una coppetta diquesta stessa tomba, quasi a voler marcare colproprio nome anche altri vasi del corredo,all'interno dello stesso processo di identifica-zione con l'oggetto donato cui si è fatto cenno.
Qualcosa di analogo va ipotizzato per l'altraiscrizione petnei (n. 6 dell'elenco), anch'essafemminile e al caso zero, graffita su una kylix avernice nera, esattamente come nel caso dellatomba 14, e anch'essa inserita in un corredoprivo di armi, ma sicuramente maschile per lapresenza della stessa kylix e del mortaio, oltreche per una sostanziale identità del corredoceramico con quello della stessa tomba 14. Inquesto caso manca la connotazione del defun-to come guerriero, ma, come ha giustamentesottolineato D. Vitali, non è lecito attribuireschematicamente i corredi con segni distintivimaschili (kylix, mortaio, strigile), ma privi diarmi, ad Etruschi e non a Celti, visto che la
Celti ed Etruschi nell’Italia settentrionale
343
Fig. 25. Monte Bibele (Monterenzio). Quadro generale di tutte le iscri-zioni rinvenute fino ad ora (i numeri corrispondono a quelli del catalogoqui presentato).
mancanza di armi può essere spiegata anche inun altro modo (VITALI 1998, pp.278-280). Sullabase di precisi dati antropologici si è infattiappurato che i defunti con armi sono giovani oadulti fino a 45-50 anni di età, mentre i defuntimaschi senza armi e con corredo di tipo etru-sco-italico sono individui morti oltre i 60 anni,cioè anziani che adottano come segno distinti-vo il servizio simposiaco e gli strumenti delbanchetto, non avvertendo più la necessità diesibire il loro status di guerrieri, ormai lontanonel tempo. In assenza di altri elementi più pre-cisi, come ad esempio le testimonianze epigra-fiche (per un caso del genere si veda oltre), èpreferibile quindi astenersi da qualsiasi classifi-cazione di tipo etnico-culturale in casi comequello della tomba 87, che potrebbe essere latomba di un “anziano” celta a cui l'etrusca pet-nei dell'iscrizione era andata sposa.
Oltre alle due donne che portano lo stessogentilizio (e appartengono quindi alla stessafamiglia) e che hanno presumibilmente sposatodue individui di rango, all'interno della comuni-tà celtica di Monte Bibele ci sono altre donneetrusche, anch'esse di alto lignaggio visto l'usodel gentilizio, che come tali intendono conno-tarsi al momento della morte e della sepoltura.Ad esse si riferiscono le iscrizioni n. 4 (gentili-zio), n. 5 (gentilizio), n. 8 (prenome e gentilizio)e n. 9 (incertezza sul nome). La n. 8 e la n. 9provengono dall'abitato; la n. 4 e la n. 5 da duecorredi relativamente modesti, ma chiaramenteconnotati come femminili. In assenza delleiscrizioni sarebbe stato impossibile individuarequesti connotati di innegabile etruscità, essen-do i relativi corredi assai poco caratterizzati alriguardo, così come lo sono in genere i corredifemminili di Monte Bibele, all'interno dei qualimancano elementi di costume che consentanodi identificare le donne celtiche e di distinguer-le da quelle di ceppo etrusco o di origine locale(26). E' evidente pertanto che le iscrizioni etru-
sche femminili acquistano un ruolo e un'impor-tanza notevoli, essendo demandata ad esse esolo ad esse l'identificazione e la segnalazionedi donne etrusche, presumibilmente di originepadana, all'interno della comunità.
Più complessa, ma anche più ricca di indica-zioni, la presenza di due iscrizioni maschili. Peruna di esse (la n. 3 dell'elenco) ci troviamo difronte ad un defunto maschio che non solo èsenza armi, ma che mostra di aderire piena-mente alle abitudini simposiache e agli idealiatletici (strigile e “vaso a gabbia”) di tipo elle-nizzante e di matrice etrusca, nel quale, sullabase del gentilizio in -alu, va riconosciuto concertezza un Etrusco di origine padana. Inbuona sostanza si tratta di un individuo dirango, con un ruolo importante all'interno dellacomunità di Monte Bibele, pur essendo estra-neo alla compagine etnica ivi prevalente, oltreche alla sua ideologia funeraria, che general-mente prevedeva l'esibizione delle armi. Ciòsignifica che accanto ad una componente guer-riera, sicuramente dominante, si afferma un'al-tra componente maschile non guerriera, daiforti connotati simposiaci e atletici, evidente-mente legata a funzioni e a ruoli diversi, com-ponente all'interno della quale elementi di origi-ne etrusca giocarono indubbiamente un ruolodecisivo. Senza volere indulgere a troppo facilischematismi, non è improbabile che ci trovia-mo di fronte al riemergere di un gruppo etru-sco che sembrava emarginato dal nuovo tessu-to sociale e politico, costituito da una compo-nente celtica vistosamente guerriera e netta-mente dominante, e che ora sembra invece ingrado di dedicarsi di nuovo a proficue attivitàproduttive e commerciali, le quali, in una ritro-vata fase di stabilità e di equilibrio fra compo-nenti etniche diverse, finiscono col provocareun generale risollevamento dell'economia edello scambio in tutta l'area padana, coinvol-gendo, da un lato, l'Etruria settentrionale e, dal-
Giuseppe Sassatelli
344
(26) La stessa cosa si verifica anche in altri sepolcreti del-l'area padana, come ad esempio a Bologna, e potrebbedipendere da una acquisizione più rapida e più profondada parte dell'elemento celtico femminile di quegli stessi
costumi greco-etruschi che tanto fascino esercitavanosui maschi di rango, senza tuttavia privarli delle loro ori-ginarie prerogative guerriere. Sul problema si vedaVITALI 1987b, p. 30.
l'altro, Adria e Spina sulla costa adriatica, dove,guarda caso, sono ancora presenti e attivi grup-pi di Etruschi sopravvissuti al contraccolpodella calata gallica e fortemente impegnati acoinvolgere la nuova compagine celtica nel col-laudato settore del commercio e degli scambi(SASSATELLI 1990, pp. 96-100).
Anche dalle necropoli galliche di Bolognaarrivano indizi importanti a questo riguardo.Qui le tombe di guerrieri sono assai menonumerose che a Monterenzio, forse in conse-guenza del diverso ruolo e della diversa disloca-zione territoriale che i due centri avevano edella maggiore importanza militare e strategicadel castellum di Monte Bibele (VITALI 1987 a, pp.375-376). A Bologna mancano completamentein questa fase iscrizioni femminili, sia in etruscoche in altre lingue, mentre sono invece docu-mentate due importanti iscrizioni su elmi dibronzo, una in alfabeto e in lingua umbri (elmodi Casa Pallotti) e una, di difficile classificazio-ne, considerata gallica da G. Colonna e sud-picena da A. Marinetti (elmo da una tomba delsepolcreto Benacci-Caprara) (Per entrambeVITALI 1992, pp. 377-379 e 359-360, con biblio-grafia precedente). La notevole eterogeneità diquesti documenti epigrafici è una prima conse-guenza della capacità di attirare componentietniche diverse da parte di Bologna, che sembrariproporsi nel suo ruolo di grande crocevia cul-turale, commerciale ed etnico della precedentefase etrusca. In questa situazione, assai piùcomplessa e meno coerente di quella diMonterenzio, abbiamo a Bologna una sola iscri-zione etrusca (27), proveniente da un corredodel sepolcreto Benacci, che, pur essendo privodi armi, contiene elementi sufficienti (kylix,mortaio e rito della cremazione) per poter esse-re identificato come maschile. Sulla kylix a ver-nice nera è graffita l'iscrizione mi titles (nomederivato da tite forse con carattere di diminuti-
vo: tite>titele>title), la quale attesta l'origine etru-sco-settentrionale del titolare della tomba, unindividuo che, analogamente al laθialu di MonteBibele, risulta estraneo alla comunità celtica deiguerrieri e sembra avere invece un ruolo impor-tante in quella riorganizzazione economica ecommerciale della regione, a cui sicuramentediedero il loro contributo anche gli Etruschi“sopravvissuti” al contraccolpo della calata deiGalli.
Tornando a Monte Bibele, restano ora daprendere in considerazione le ultime due iscri-zioni. La prima (n. 7 del nostro elenco) provie-ne da una tomba maschile con armi e non èfacilmente classificabile, trattandosi di un'ab-breviazione, per cui su di essa è preferibilesospendere il giudizio (nell'ipotesi di una iscri-zione femminile avremmo una situazione ana-loga a quella dei nn. 2 e 6). La seconda (n. 1 delnostro elenco) costituisce invece una forte ano-malia rispetto al sistema interpretativo che viavia si è andato configurando. Si tratta infatti diuna iscrizione maschile, costituita da un gentili-zio al caso zero, che si riferisce ad un defuntomaschio e guerriero. Il fatto che il nome mostri,come sembra, di avere legami con l'onomasticaitalica non risolve il problema. Resta infatti l'in-congruenza di un individuo etrusco che haassunto tutti i caratteri della élite guerriera dellacomunità di Monterenzio in modo del tuttoinsolito e non facile da spiegare.
Ma credo sia ormai tempo di concludere.L'esame della documentazione epigrafica, siaper quanto riguarda l'Italia settentrionale cheper quanto riguarda il sito di Monterenzio, haconsentito di fare notevoli passi avanti nellostudio e nella ricostruzione delle dinamichesociali e di integrazione tra i diversi gruppi chequi si sono stanziati più o meno stabilmente trala metà del IV e il III secolo, consentendoci diandare ben al di là di quanto fino ad ora era
Celti ed Etruschi nell’Italia settentrionale
345
sulla scia della precedente tradizione etrusca per i qualirimando sempre a VITALI 1992, p. 102, tav. 2; p. 180, tav.19; pp. 214-215, tav. 23; pp. 242-243, tav. 26; pp. 256-257, tav. 27; pp. 274-276, tav. 30; pp. 298-299, tav. 40; p.325, tav. 45; p. 358, tav. 54; p. 368, tav. 57.
(27) VITALI 1992, pp. 330-331 con riferimenti bibliogra-fici. Mentre sono molto numerosi i graffiti alfabetici, chelasciano trasparire un forte interesse per la scrittura e lasua pratica. Si vedano ad esempio i graffiti costituiti dalettere singole o da gruppi di lettere, ancora una volta
stato fatto solo sulla base della documentazio-ne archeologica. La grande mobilità tra gruppivicini e le dinamiche interne di integrazione e diacculturazione sono oggi relativamente piùchiari grazie soprattutto alla documentazioneepigrafica, che di giorno in giorno si rivela sem-pre di più come una importantissima e insosti-tuibile fonte di conoscenza.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
BERMOND MONTANARI 1979 = G. BERMONDMONTANARI, in “Rivista di Epigrafia Etrusca”, inStudi Etruschi XLVII, 1979, pp. 296-297.
BERMOND MONTANARI 1988 = G. BERMONDMONTANARI, I cippi di Rubiera, in Studi Etruschi LIV,1986 (ed. 1988), pp. 239-244.
CALZAVARA CAPUIS, CHIECO BIANCHI 1979 = L.CALZAVARA CAPUIS, A. M. CHIECO BIANCHI,Osservazioni sul celtismo nel Veneto euganeo, inArcheologia Veneta II, 1979, pp. 19-25
COLONNA 1980a = G. COLONNA, Rapporti artisti-ci tra il mondo paleoveneto e il mondo etrusco, in “Este e laciviltà paleoveneta a cento anni dalle prime scoper-te”, Atti dell'XI Convegno di Studi Etruschi eItalici, Este 1976, Firenze, 1980, pp. 177-190.
COLONNA 1980b = G. COLONNA, Virgilio,Cortona e la leggenda etrusca di Dardano, in ArcheologiaClassica XXXII, 1980, pp. 1-14.
COLONNA 1980c = G. COLONNA, Graffiti etruschiin Linguadoca, in Studi Etruschi XLVIII, 1980, pp.181-185.
COLONNA 1985 = G. COLONNA, in “Il commer-cio etrusco arcaico”, Atti dell'Incontro di Studio,Roma 1983, Roma 1985, pp. 270-271.
COLONNA 19896 = G. COLONNA, in “Atti del IIConvegno Archeologico Regionale”, Como 1984,Como 1986, pp. 579-580.
COLONNA 1988 = G. COLONNA, Il lessico istituzio-nale etrusco e la formazione della città (specialmente inEmilia Romagna), in “La formazione della città pre-romana in Emilia Romagna”, Atti del Convegno,Bologna-Marzabotto 1985, Bologna 1988, pp. 15-36.
COLONNA 1993 = G. COLONNA, La società spine-tica e gli altri ethne, in “Spina. Storia di una città traGreci ed Etruschi”, Catalogo della Mostra, Ferrara
1993, pp. 131-143.COLONNA 1998a = G. COLONNA, Etruschi sulla
via delle Alpi Occidentali, in L. MERCANDO, M.VENTURINO GAMBARI (a cura di), “Archeologia inPiemonte. La Preistoria”, Torino, 1998, pp. 261-266.
COLONNA 1998b = G. COLONNA, L'iscrizionedella stele di Mombasiglio, in L. MERCANDO, G. PACI,“Stele romane in Piemonte”, Roma 1998, pp. 299-303.
COLONNA, CRISTOFANI 1985 = G. COLONNA, M.CRISTOFANI, Contributi alla discussione, in “Il commer-cio etrusco arcaico”, Atti del dell'Incontro diStudio, Roma 1983, Roma 1985, pp. 270-271.
CRISTOFANI 1978 = M. CRISTOFANI, Recensione a”I Galli e l'Italia”, Catalogo della Mostra, Roma1978, in Prospettiva 15, 1978, pp. 71-73.
DE MARINIS 1981 = R.C. DE MARINIS, Il periodoGolasecca III A in Lombardia, in Studi Archeologici I,1981, pp. 43-244.
DE MARINIS 1986a = R.C. DE MARINIS, L'abitatoprotostorico di Como, in “Como fra Etruschi e Celti”,Catatalogo della Mostra, Como 1986, pp. 25-35.
DE MARINIS 1986b = R.C. DE MARINIS, Il man-tovano tra invasioni galliche e romanizzazione: appunti peruna ricerca, in “Gli Etruschi a nord del Po”, Catalogodella Mostra, Mantova 1986, II, pp. 183-189.
DE MARINIS 1987 = R.C. DE MARINIS, Fibule tar-dohallstattiane occidentali dall'abitato etrusco del Forcello(Bagnolo S.Vito), in D. VITALI (a cura di), “Celti edEtruschi nell'Italia centro-settentrionale dal V seco-lo alla romanizzazione”, Atti del Convegno,Bologna 1985, Bologna-Imola 1987, pp. 89-99.
DE MARINIS 1988 = R.C. DE MARINIS, Liguri eCelto-Liguri. I. La cultura di Golasecca: Insubri, Orobi eLeponzi, in “Italia omnium terrarum alumna”,Milano 1988, pp. 159-247.
DE MARINIS 1989 = R.C. DE MARINIS, Problemie prospettive della ricerca protostorica nel mantovano, in“Gli Etruschi a nord del Po”, Atti del Convegno,Mantova 1986, Mantova 1989, pp. 37-45.
DE MARINIS, CRISTOFANI 1985 = R. DEMARINIS, M. CRISTOFANI, in “Rivista di EpigrafiaEtrusca”, in Studi Etruschi LI, 1983 (ed. 1985), pp.202-204, n. 3 (De Marinis) e pp. 278 (Cristofani).
DE SIMONE 1978 = C. DE SIMONE, Un nuovo gen-tilizio etrusco di Orvieto (Katacina) e la cronologia dellapenetrazione celtica (gallica) in Italia, in “La Parola delPassato” XXXIII, 1978, pp. 370-395.
DE SIMONE 1992 = C. DE SIMONE, Le iscrizioni
Giuseppe Sassatelli
346
etrusche dei cippi di Rubiera, Reggio Emilia, 1992.DE SIMONE 1993 = C. DE SIMONE, Le iscrizioni
chiusine arcaiche, in “La civiltà di Chiusi e del suo ter-ritorio”, Atti del Convegno, Chianciano 1989,Firenze 1993, pp. 25-38.
FREY 1971 = O. H. FREY, Fibeln vom westhallstät-tischen Typus aus dem Gebiet südlich der Alpen. ZumProblem der Keltischen Wanderung, in “Oblatio.Raccolta di Studi di Antichità ed Arte in onore di A.Calderoni”, Como 1971, pp. 355-386.
FREY 1974 = O. H. FREY, DurchbrocheneFrühlatènegürtelhaken aus Slowenien, in Situla 14-15,1974, pp. 129-142.
GAMBARI 1998 = F. GAMBARI, Gli insediamenti e ladinamica del popolamento nell'età del bronzo e nell'età delferro, in L. MERCANDO E M. VENTURINO GAMBARI(a cura di), “Archeologia in Piemonte. LaPreistoria”, Torino 1998, pp. 136-146.
GAMBARI, COLONNA 1988 = F. GAMBARI, G.COLONNA, Il bicchiere con iscrizione arcaica da CastellettoTicino e l'adozione della scrittura nell'Italia nord-occidenta-le, in Studi Etruschi LIV, 1986 (ed. 1988), pp. 119-164.
GAMBARI, VENTURINO GAMBARI 1987 = M.GAMBARI, M. VENTURINO GAMBARI, Villa del Foro,in “Scavi e Scoperte”, in Studi Etruschi LIII, 1985(ed. 1987), p. 421-425.
KRUTA 1978 = V. KRUTA, Celtes de Cispadane etTransalpins aux IVe et IIIe siècle avant notre ère: donnéesarchéologiques, in Studi Etruschi XLVI, 1978, pp. 149-174.
LENZI 1983 = F. LENZI, La documentazione epigra-fica, in “Monterenzio e la Valle dell'Idice.Archeologia e storia di in territorio”, Catalogo dellaMostra, Bologna 1983, pp. 183-189.
MACELLARI 1994 = R. MACELLARI, Una nuovaiscrizione etrusca da Bologna, in “Ocnus. Quaderni dellaScuola di Specializzazione in Archeologia(Bologna)” 2, 1994, pp. 97-105.
MAGGIANI, PROSDOCIMI 1976 = A. MAGGIANI,A. L. PROSDOCIMI, in “Rivista di Epigrafia Italica”,in Studi Etruschi XLIV, 1976, pp. 258-264(Maggiani) e pp. 265-266 (Prosdocimi).
MALNATI, BERMOND MONTANARI 1989 = L.MALNATI, G. BERMOND MONTANARI, Nuove iscrizio-ni etrusche da Rubiera (Reggio Emilia), in “II CongressoInternazionale Etrusco”, Firenze 1985, Roma 1989,pp. 1567-1577.
MALNATI, VIOLANTE 1995 = L. MALNATI, A.VIOLANTE, Il sistema urbano di IV e III secolo in Emilia
Romagna tra Etruschi e Celti (Plut., Vita Cam. 16, 3), in“L'Europe celtique du Ve au IIIe siècle avant J. -C.”,Actes du deuxième Symposium Internationald'Hautvillers, 1992, Sceaux, 1995, pp. 97-120.
MARINETTI 1992 = A. MARINETTI, EstePreromana, epigrafia e lingua, in “Este Antica dallapreistoria all'età romana”, Este 1992, pp. 125-172.
MARTELLI 1987 = M. MARTELLI, in “Rivista diEpigrafia Etrusca”, in Studi Etruschi LIII, 1985(ed. 1987), pp. 199-201, n. 5.
ORTALLI 1995 = J. ORTALLI, La necropoli celticadella zona ''A'' di Casalecchio di Reno (Bologna). Note pre-liminari sullo scavo del complesso sepolcrale e dell'area diculto, in “L'Europe celtique du Ve au IIIe siècleavant J. -C.”, Actes du deuxième SymposiumInternational d'Hautvillers, 1992, Sceaux, 1995, pp.189-238.
ORTALLI 1998 = J. ORTALLI, Archeologia topografi-ca: la ricostruzione dell'ambiente e dell'insediamento anticonell'esperienza di Casalecchio di Reno, in “XLIII Corsodi Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina”,Ravenna 1997, Ravenna 1998, pp. 565-606.
PALLOTTINO 1984 = M. PALLOTTINO, Oriundiforestieri nella onomastica e nella società etrusca, in “Studidi Antichità in onore di Guglielmo Maetzke”, Roma1984, pp. 401-405.
PEYRE 1992 = C. PEYRE, L'historiographie greco-romaine et la celtisation de Bologne étrusques, in D. VITALI,“Tombe e necropoli galliche di Bologna e territo-rio”, Bologna 1992, pp. 7-45.
PROSDOCIMI 1968-1969 = A.L. PROSDOCIMI,Un'iscrizione inedita dal territorio atestino. Nuovi aspettiepigrafici, linguistici, culturali nell'area paleoveneta, in “Attidell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti”CXXVII, 1968-1969, pp. 123-183.
PROSDOCIMI 1984 a = A.L. PROSDOCIMI,Venetico. Due nuovi ciottoloni patavini (*PA 27, *PA 28).Morfologia e sistema onomastico. Nuovi dati da *PA 28, inStudi Etruschi L, 1982 (ed. 1984), pp. 199-224.
PROSDOCIMI 1984 b = A. L. PROSDOCIMI, Unanuova iscrizione venetica da Oderzo (Od. 7) con elementi cel-tici, in “Studi di Antichità in onore di G. Maetzke”,Roma, 1984 pp. 423-445.
PROSDOCIMI 1986 = A..L. PROSDOCIMI, I piùantichi documenti del Celtico in Italia, in “Atti del IIConvegno Archeologico Regionale”, Como 1984,Como 1986, pp. 67-92.
PROSDOCIMI 1987 = A.L.PROSDOCIMI, Celti inItalia prima e dopo il V secolo, in D. VITALI (a cura di),“Celti ed Etruschi nell'Italia centro-settentrionale
Celti ed Etruschi nell’Italia settentrionale
347
dal V secolo alla romanizzazione”, Atti delConvegno, Bologna 1985, Bologna-Imola 1987, pp.561-581.
PROSDOCIMI 1988 = A.L. PROSDOCIMI, La lingua,in G. Fogolari, A. L. Prosdocimi (a cura di), “IVeneti antichi. Lingua e cultura”, Padova 1988, pp.221-420.
PROSDOCIMI 1990 = A. L. PROSDOCIMI,Insegnamento e apprendimento della scrittura nell'Italiaantica, in M. PANDOLFINI, A. L. PROSDOCIMI,“Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruriae nell'Italia antica”, Firenze 1990, pp. 155-298.
PROSDOCIMI 1991a = A.L. PROSDOSICMI, Linguae scrittura dei primi Celti, in “I Celti”, Catalogo dellaMostra, Milano 1991, pp. 51-59.
PROSDOCIMI 1991b = A.L. PROSDOCIMI, Note sulceltico in Italia, in Studi Etruschi LVII, 1991, pp. 138-176.
PROSDOCIMI 1992 = A L. PROSDOCIMI,Sull'etruschità linguistica e culturale, in “EtruscherNördlich von Etrurien”, Akten des Symposions,Wien 1989, Wien 1992, pp. 460-463, 468-470.
ROCCA 1999 = G. ROCCA, in “Rivista diEpigrafia Italica”, in Studi Etruschi LIII, 1997(ed.1999), pp. 443-447.
RUTA SERAFINI 1984 = A. RUTA SERAFINI,Celtismo nel Veneto: materiali archeologici e prospettive diricerca, in Études Celtiques XXI, 1984, pp. 7-33.
SASSATELLI 1977 = G. SASSATELLI, Brevi note criti-che sulle ceramiche di importazione delle tombe galliche diBologna, in Rivista di Archeologia I, 1-2, 1977, pp.27-35.
SASSATELLI 1989 = G. SASSATELLI, Ancora sui rap-porti tra Etruria Padana e Italia settentrionale: qualcheesemplificazione, in “Gli Etruschi a nord del Po”, Attidel Convegno, Mantova 1986, Mantova 1989, pp.49-81.
SASSATELLI 1990 = G. SASSATELLI, La situazionein Etruria padana, in “Crise et transformation desSociétés archaïques de l'Italie antique au Ve siècleav. J. -C.”, Actes de la Table Ronde, Rome 1987,Roma, 1990, pp. 51-100.
SASSATELLI 1991 = G. SASSATELLI, Nuovi dati epi-grafici da Marzabotto e il ruolo delle comunità indigene nella''fondazione'' della città, in Archeologia ClassicaXLIII, 1991, pp. 693-715.
SASSATELLI 1994 = G. SASSATELLI (a cura di),Iscrizioni e graffiti della città etrusca di Marzabotto,Bologna, 1994.
SASSATELLI 1996 = G. SASSATELLI, Verucchio, cen-
tro etrusco “di frontiera”, in Ocnus. Quaderni dellaScuola di Specializzazione in Archeologia (Bologna)4, 1996, pp. 249-271.
SASSATELLI 1999 = G. SASSATELLI, Spina e gliEtruschi Padani, in “La dalmazia e l'altra sponda.Problemi di Archaiologìa Adriatica”, Atti delConvegno, Venezia, Firenze 1999, pp. 71-107.
SASSATELLI 2000 = G. SASSATELLI, Le iscrizionidella cultura di Golasecca, in “Museo Civico di SestoCalende. La raccolta archeologica e il territorio”,Gallarate 2000, pp. 50-57.
VITALI 1984 = D. VITALI, Una tomba di guerrieroda Castel del Rio (Bologna), in “Atti e Memorie. R.Deputazione di Storia Patria per le Province diRomagna” n. s. XXXV, 1984, pp. 24-35.
VITALI 1985 = D. VITALI, Monte Bibele(Monterenzio) und andere Fundstellen der KeltischenEpoche im Gebiet von Bologna, Kleine Schriften,Marburg 16, Marburg, 1985.
VITALI 1987a = D. VITALI, Monte Bibele traEtruschi e Celti: dati archeologici e interpretazione storica,in D. VITALI (a cura di), “Celti ed Etruschi nell'Italiacentro-settentrionale dal V secolo alla romanizza-zione”, Atti del Colloquio Internazionale, Bologna1985, Bologna-Imola 1987, pp. 365-376.
VITALI 1987b = D. VITALI, I Galli a Bologna, in W.Tega (a cura di), “Storia illustrata di Bologna”, SanMarino 1987, pp. 21-39.
VITALI 1991 = D. VITALI, I Celti in Italia, in “ICelti”, Catalogo della Mostra, Venezia 1991, pp.220-235.
VITALI 1992 = D. VITALI, Tombe e necropoli gallichedi Bologna e territorio, Bologna 1992.
VITALI 1993 = D. VITALI, I Celti da Rimini al Po.Osservazioni e spunti per una discussione, in P. L.DALL'AGLIO (a cura di), “Storia di Bellaria-Bordonchio-Igea Marina”, Rimini 1993, pp. 65-69.
VITALI 1996 = D. VITALI, I Celti a Spina, in“Spina e il delta padano. Riflessioni sul Catalogo esulla Mostra ferrarese”, Atti del Convegno, Ferrara1994, Ferrara 1996, pp. 253-273.
VITALI 1998 = D. VITALI, La necropoli di MonteBibele (Monterenzio, Prov. Bologna, Italia), in“Münsingen-Rein, ein Markstein der KeltischenArchäologie”, Akten Internationales Kolloquium,Münsingen-Bern 1996, Bern, 1998, pp. 266-272.
VITALI 2000 = D. VITALI, Un Hélvète chez lesEtrusques vers 300 av.J.-C., in Archeologia Svizzera23, 2000, pp.115-122.
Giuseppe Sassatelli
348