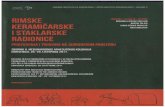Determinants of eating habits among older adults - Mattioli ...
Stefano Santocchini Gerg, L'apparato decorativo della ceramica dell'Etruria padana, in C. Mattioli...
Transcript of Stefano Santocchini Gerg, L'apparato decorativo della ceramica dell'Etruria padana, in C. Mattioli...
“Studi e Scavi” è la collana del Dipartimento di Archeologia – ora Sezione di Archeologia del Dipartimento di Storia Culture Civiltà – dell’Università di Bologna, nata nel 1994 e rinnovata nella Nuova Serie a partire dal 2002.La collana accoglie studi e contributi di docenti, collaboratori e giovani studiosi del Dipartimento, miscellanee, atti di convegni e giornate di studio, coprendo un ampio arco cronologico e tematico, sia per quanto riguarda le attività di scavo sia per quanto riguarda le attività di ricerca del Dipartimento nel suo complesso.
La tipologia generale della ceramica etrusca prodotta in area padana fra la metà del VI a.C. e il declino del sistema etrusco-padano risponde alla necessità di dare ordine a una straordinaria quantità di materiale vascolare fino ad ora studiato in modo settoriale e segmentato. Il lavoro si pone fondamentalmente due obiettivi. Anzitutto si vuole dare un quadro per la prima volta complessivo di questa produzione ceramica locale presente in un’area molto vasta, stabilmente occupata dagli Etruschi e quindi con caratteristiche di grande omogeneità storica. In secondo luogo si intende proporre uno strumento di analisi utile per quanti si confronteranno con questa produzione vascolare all’interno di singole aree di scavo. Una prima analisi territoriale della documentazione fa emergere caratteri di uniformità e di standardizzazione, ma anche differenze che mettono in luce, specie nelle aree di confine, fenomeni di interazione culturale con le realtà limitrofe. a
tla
nt
e tipo
log
ico
delle fo
rm
e c
era
mic
he d
i pro
du
zio
ne lo
ca
lein
etru
ria
pad
an
a
alma mater Studiorum - università di Bolognadipartimento di Storia culture civiltà
Sezione di archeologia
€ 50,00
chiara mattioli
atlante tipologico delle forme ceramiche di produzione locale
in etruria padana
chiara m
attioli
Chiara Mattioli è laureata in Lettere Classiche con una tesi in Etruscologia e Archeologia italica, specializzata in Archeologia, dottore di ricerca in Scienze Archeologiche. Attualmente è Tecnico laureato-Responsabile del Laboratorio materiali archeologici presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà (Sezione di Archeologia) dell’Università di Bologna. Lo studio tipologico della ceramica etrusca prodotta in area padana è stato l’oggetto delle sue tesi di Specializzazione e di Dottorato. Tra gli ambiti d’interesse si segnala, oltre alle dinamiche di diffusione della ceramica etrusca nei territori limitrofi con particolare riguardo al mondo veneto, la ricostruzione delle economie produttive della città di Marzabotto, dove si concentra la sua pluriennale attività di scavo.
In copertina: Piatto su alto piede, da Marzabotto (Bologna), Regio IV - Insula 2, Casa 1 Studi e Scavi
nuova serie 37KAINUA 3
37
Studie
Scavi
nuovaserie
copertina_def.indd 1 31/01/14 16.14
Alma Mater Studiorum - Università di BolognaDipartimento di Storia Culture Civiltà
Sezione di Archeologia
Studi e Scavinuova serie
37
KAINUA 3
00 Indice.indd 1 24/01/14 11.53
Alma Mater Studiorum - Università di BolognaDipartimento di Storia Culture Civiltà
Sezione di Archeologia
Chiara Mattioli
ATLANTE TIPOLOGICO DELLE FORME CERAMICHE DI PRODUZIONE LOCALE
IN ETRURIA PADANA
con contributi di
Giulia Morpurgo, Stefano Santocchini Gerg
00 Indice.indd 3 24/01/14 11.53
Volume realizzato con il contributo di: Alma Mater Studiorum - Università di BolognaDipartimento di Storia Culture Civiltà - Sezione di Archeologia
© 2013 Ante Quem soc. coop.© 2013 Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna
Ante Quem soc. coop. Via Senzanome 10, 40123 Bologna - tel. e fax +39 051 4211109www.antequem.it
ISBN 978-88-7849-080-2
00 Indice.indd 4 24/01/14 11.53
5
IndIce
Presentazione di Elisabetta Govi, Giuseppe Sassatelli 9
PARTE I
Introduzione 15
I. Per una storia della tipologia 21
II. La tipologia generale della ceramica etrusco-padana 27 II.1. La struttura della tipologia generale della ceramica etrusco-padana 31 II.2. Lo scheletro tipologico 35 II.3. Le forme ceramiche 37
PARTE II
Premessa alla tipologia 43
FORME APERTE
1. Famiglia Bacile-mortaio 47 1A. Bacile-mortaio 50 1B. Bacile-mortaio con beccuccio versatoio 61
2. Famiglia Calice 64 2A. Calice emisferico 68 2B. Calice emisferico su alto piede 68 2C. Calice troncoconico 69 2D. Calice troncoconico su alto piede 70 2E. Calice carenato 71 2F. Calice carenato su alto piede 72
3. Famiglia Catino 76 3A. Catino 77 3B. Catino biansato 78
4. Famiglia Colatoio 80 4A. Colatoio 82 4B. Colatoio biansato 83 5. Famiglia Coperchio 85 5A. Coperchio a calotta 90 5B. Coperchio troncoconico con cilindro anulare interno 92 5C. Coperchio troncoconico 94 5D. Coperchio carenato 94 5E. Coperchio a corpo discoidale 95
6. Famiglia Coppa 97 6A. Coppa emisferica 104
00 Indice.indd 5 24/01/14 11.53
6
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
6B. Coppa emisferica su alto piede 137 6C. Coppa carenata 141 6D. Coppa carenata su alto piede 167 6E. Coppa troncoconica 169 6F. Coppa troncoconica su alto piede 172
7. Famiglia Coppa-coperchio 181 7A. Coppa-coperchio 183
8. Famiglia Kantharos 197 8A. Kantharos 198
9. Famiglia Kylix 199 9A. Kylix emisferica 201 9B. Kylix carenata 202
10. Famiglia Patera ombelicata 206 10A. Patera ombelicata 207
11. Famiglia Piatto 208 11A. Piatto 212 11B. Piatto su alto piede 221 11C. Piatto su fondo piano (o leggermente concavo) 227
12. Famiglia Recipiente da fuoco 231 12A. Recipiente da fuoco 233
13. Famiglia Tazza 237 13A. Tazza monoansata 239 13B. Tazza biansata 243
14. Famiglia Teglia 248 14A. Teglia 249
FORME CHIUSE
15. Famiglia Anfora 255 15A. Anfora 257
16. Famiglia Anforetta 262 16A. Anforetta 263
17. Famiglia Brocca 267 17A. Brocca a bocca rotonda 271 17B. Brocca a becco obliquo 278 17C. Brocca a bocca trilobata 282
18. Famiglia Cratere 289 18A. Cratere a colonnette 290 18B. Cratere a volute 290
19. Famiglia Dolio 291 19A. Dolio 294 19B. Dolio con prese a pomello 296
20. Famiglia Kyathos 297 20A. Kyathos 297
21. Famiglia Lekythos 299 21A. Lekythos 300
00 Indice.indd 6 24/01/14 11.53
7
Indice
22. Famiglia Olla 302 22A. Olla 310 22B. Olla biansata 345 22C. Olla con prese a bugnetta 354 22D. Olla con prese a linguetta 356 22E. Olla con prese a pomello 362 22F. Olla con cuppelle versatoio 365
23. Famiglia Pisside 371 23A. Pisside 372
24. Famiglia Skyphos 374 24A. Skyphos 375
25. Piedi e fondi: tipologia generale 379
26. Anse e prese: tipologia generale 380
Parte III. La ceramica grigia Giulia Morpurgo 381
Premessa 381
Introduzione alla classe ceramica 382
Note preliminari al catalogo 387
FORME APERTE
1. Famiglia Bacile-mortaio 391 1A. Bacile-mortaio 394 2. Famiglia Calice 397 2D. Calice troncoconico su alto piede 398 2F. Calice carenato su alto piede 399 5. Famiglia Coperchio 400 5B. Coperchio troncoconico con cilindro anulare interno 400 6. Famiglia Coppa 402 6A. Coppa emisferica 408 6B. Coppa emisferica su alto piede 419 6C. Coppa carenata 421 6E. Coppa troncoconica 427 9. Famiglia Kylix 428 9B. Kylix carenata 428 10. Famiglia Patera ombelicata 429 10A. Patera ombelicata 429 11. Famiglia Piatto 431 11A. Piatto 433 11B. Piatto su alto piede 440 11C. Piatto su fondo piano (o leggermente concavo) 444 13. Famiglia Tazza 445 13A. Tazza monoansata 446 13B. Tazza biansata 448
FORME CHIUSE
15. Famiglia Anfora 451 15A. Anfora 451
00 Indice.indd 7 24/01/14 11.53
8
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
16. Famiglia Anforetta 454 16A. Anforetta 454 17. Famiglia Brocca 458 17A. Brocca a bocca rotonda 460 17B. Brocca a becco obliquo 462 17C. Brocca a bocca trilobata 464 18. Famiglia Cratere 466 18A. Cratere a colonnette 467 18B. Cratere a volute 469 20. Famiglia Kyathos 470 20A. Kyathos 470 21. Famiglia Lekythos 471 21A. Lekythos 471 22. Famiglia Olla 473 22A. Olla 475 22B. Olla biansata 480 22C. Olla con prese a bugnetta 481 22D. Olla con prese a linguetta 482 24. Famiglia Skyphos 483 24A. Skyphos 485
Considerazioni conclusive sulla classe 489
Appendice. L’apparato decorativo della ceramica dell’Etruria padana Stefano Santocchini Gerg 495
Conclusioni 537
Bibliografia 549
00 Indice.indd 8 24/01/14 11.53
495
AppendiceL’AppArAto decorAtivo deLLA cerAmicA deLL’etruriA pAdAnA
Stefano Santocchini Gerg
introduzione
Obiettivo di questo lavoro, attraverso la presentazione di un repertorio della decorazione ceramica1 che sia d’aiuto nel lumeggiare il complesso linguaggio figurativo dell’Etruria padana fra VI e IV secolo a.C., è comprendere i caratteri, i modelli di riferimento e le principali linee evolutive, diacroniche e to-pografiche, delle correnti dell’artigianato artistico locale, che copre un territorio assai vasto. A tal fine si è ritenuto opportuno approntare uno strumento che, sulla scorta di un regesto che per la prima volta tenta di essere quanto più completo possibile e di approcciare questo aspetto della produzione con un’ottica non settoriale e non condizionata da confronti con altre realtà culturali, permettesse di cogliere tali linee evolutive e stabilire quanto queste abbiano risentito dei sostrati della tradizione locale e quanto intensi siano stati invece gli apporti esterni2. Un obiettivo ulteriore è quello di appurare se tale linguaggio deco-rativo sia condiviso in tutto il comparto padano e verificare se esso risponda a criteri di standardizzazione come per le forme ceramiche, un indicatore che sottende processi storici complessi, riflesso di un vasto e articolato fenomeno di organizzazione su scala regionale. Di conseguenza verranno messe in luce una serie di peculiarità locali, espressione di una produzione in parte differenziata tra realtà urbane e rurali, tra aree etrusche e “etruschizzate” (come parte della Romagna). Il linguaggio figurativo della ceramica, grazie anche alla sua semplicità, si è rivelato dunque un campo di indagine privilegiato per l’osservazione dei complessi fenomeni produttivi e culturali che investono l’intero comparto padano.
Una prima e generale considerazione riguarda il fatto che non esiste in Etruria padana una produzione di ceramica figurata vera e propria3 come in Etruria tirrenica. Questa circostanza riflette un fenomeno com-plesso e articolato, troppo ampio per essere affrontato in questa sede. Tuttavia, in breve, si può accennare ad alcune concause che ne sono verosimilmente alla radice. Innanzitutto, e per la fase più antica, l’estrema spo-radicità delle importazioni di ceramica corinzia e delle sue imitazioni dell’Etruria meridionale cui si associa il fatto che l’avvio della ceramica figurata dell’Etruria tirrenica è dovuta anche all’arrivo di artigiani greci e a una presenza di elementi allogeni di cui con ogni verosimiglianza non ha goduto l’Etruria padana. Le botte-ghe dei ceramisti e ceramografi padani hanno perciò inizialmente (v. tab. 5) attinto soprattutto al repertorio della propria tradizione villanoviana, dedicandosi principalmente alle decorazioni eseguite con la tecnica della stampigliatura. Questa aveva mostrato fino a tutto il Villanoviano IV una ricchezza e varietà altrove difficilmente riconoscibili, che proseguono in parte nel periodo successivo con motivi per lo più di carattere geometrico e con qualche attardamento di motivi fitomorfi e zoomorfi originari del bestiario orientalizzante.
1 Questo lavoro trae spunto dalla tesi di laurea Espressioni artistiche in Etruria padana. L’apparato decorativo tra VI e IV sec. a.C., presentata a Bologna nell’A.A. 2004/2005, sotto la guida del Prof. Giuseppe Sassatelli e della Prof.ssa Elisabetta Govi, che ringrazio con tutto il cuore per il sostegno che da allora, e per tutti questi anni, mi hanno sempre dimostrato; in particolare la Prof.ssa Govi che, con pazienza e dedizione, ha seguito questo lavoro in tutte le sue fasi. La tesi, impostata su scheda-tura e creazione di un data base di ornati, oltre alla decorazione ceramica, prendeva in considerazioni tutte le decorazioni accessorie su supporti diversi come i laterizi, la pietra, il bronzo, gli ossi e gli avori. L’originaria completezza ha permesso di contestualizzare e valutare a pieno l’apparato decorativo, con un orizzonte ad ampio spettro che ha consentito di cogliere al meglio le relazioni fra i diversi materiali. Alcuni primi risultati, dedicati in particolare all’Emilia occidentale (con una sezione destinata alle tecniche esecutive), sono confluiti in SANTOCCHINI GERG 2009, cui si rimanda. Ringrazio inoltre sentitamente la dott.ssa Chiara Mattioli, per il proficuo scambio di esperienze ed opinioni, e la dott.ssa Paola Desantis per avermi concesso l’opportunità di studiare alcuni materiali inediti del Museo Nazionale Etrusco “P. Aria” di Marzabotto.
2 Per quanto riguarda le particolarmente consistenti relazioni con il confinante comparto dell’Etruria settentrionale si ri-manda ad un precedente lavoro specificatamente dedicato al tema (SANTOCCHINI GERG 2012).
3 Se si eccettua un’esperienza di Adria molto circoscritta e che non ha lasciato seguiti, comunque sotto discussione (GOVI 2012).
04 Appendice.indd 495 24/01/14 14.35
496
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
Quando poi, durante la seconda metà del VI secolo, inizia la produzione standardizzata della ceramica etrusco-padana, e si registra un forte incremento di vasellame in ceramica fine e depurata, gli artigiani locali hanno beneficiato di una maggiore libertà espressiva, data dalle possibilità offerte dall’utilizzo di pennelli e vernici in varie tonalità (v. tab. 6). Ciò in particolare rispetto alle precedenti produzioni in ceramica d’impasto e bucchero, che limitavano le decorazioni a motivi incisi o impressi a stampiglia.
Ciò che potrebbe colpire, anche a questo stadio evolutivo, è la mancanza di una fioritura figurativa della cultura materiale locale, che continua a limitarsi principalmente a motivi geometrici piuttosto elementari, affiancati da pochi ornati fitomorfi e da limitatissime esecuzioni figurate antropomorfe o zoomorfe. Come detto sopra il fenomeno è di estrema complessità e, come per il periodo precedente, può difficilmente e solo in parte essere spiegato con i mancati apporti esterni; infatti nella seconda metà del VI secolo, nonostante una pur copiosa circolazione di ceramica attica in Etruria padana, i motivi figurati continuano a non compa-rire: si registra dunque una parziale (ma del tutto apprezzabile) impermeabilità agli influssi portati da que-sta ceramica4. Questa impermeabilità è testimoniata, come verrà meglio detto nell’analisi ai singoli motivi decorativi, dall’assenza o dalla estrema scarsità di motivi geometrici come i denti di lupo o fitomorfi come la vite, l’uva, l’edera e altri e, soprattutto, di tutto il repertorio figurato delle produzioni ateniesi. In parte ciò si può spiegare con il fatto che, non avendo i ceramografi locali sviluppato una propria tradizione figurativa nel periodo precedente, il “gusto locale” si fosse ormai indirizzato e stabilizzato verso le decorazioni geometriche lineari, ma anche questa circostanza, da sola, non spiega la complessità del fenomeno. Un’altra concausa, pro-babilmente determinante, è il fatto che – come osservato da C. Mattioli nelle conclusioni di questo volume – la ceramica etrusco-padana risulta essere una produzione “di massa” di tipo standardizzato; ciò si riflette nel suo patrimonio esornativo che si limita a motivi semplici e di rapida esecuzione, che rendono manifesto un quadro (molto relativamente) “povero” e parzialmente limitato nelle sue capacità espressive. Un pano-rama che tuttavia, se escludiamo le decorazioni figurate, non risulta poi così distante da quello dell’Etruria tirrenica, in particolare dei territori di Chiusi e Orvieto. Si spiega così anche l’originalità e disomogeneità delle poche decorazioni figurate padane, molto meno legate alle canonizzazioni stilistiche e sintattiche delle classi figurate dell’Etruria tirrenica, che rispettano una lunga e consolidata tradizione iconografica. Infine, è del tutto verosimile che, per soddisfare particolari esigenze di esibizione e affermazione sociale, le élites locali ricorressero direttamente al vasellame attico ed alle locali produzioni in bronzo, come testimoniato specialmente dai corredi funerari.
Tutt’altro problema, di estrema complessità, è trovare origine e modello dei motivi e della sintassi della decorazione più comune della ceramica etrusco-padana, che si estrinseca nella giustapposizione di fasce, bande e linee dipinte, cui si aggiungono meandri ad onda e linguette dipinte (vedi Figg. 4, 7). Per la ge-nesi di questo “gusto locale”, come per tutte le decorazioni estremamente semplici e lineari, si può pensare ad una linea evolutiva interna e autonoma. Tuttavia si possono proporre anche alcuni influssi esterni, ciò comunque in considerazione del fatto che tutte le decorazioni a carattere geometrico lineare pongono ovvi problemi metodologici di riconoscimento e classificazione5. Ceramica etrusca con decorazione lineare si trova fin dalle produzioni geometriche o italo-geometriche, ma è con la produzione etrusco-corinzia che le assonanze si fanno più stringenti, seppur ancora lontane cronologicamente dagli esemplari di tardo VI e V secolo dell’Etruria padana. La decorazione a fasce e bande dipinte, anche ondulate, con linguette sulla spalla appare su oinochoai etrusco-corinzie prodotte ad Orvieto dagli ultimi decenni del VII secolo a tutta la prima metà del secolo successivo6. Questa tradizione decorativa è poi confluita nella successiva produzione etrusca a figure nere, che trova in Etruria interna, in particolare nel “Gruppo di Orvieto”7, la possibile connessione con la ceramica dipinta dell’Etruria padana. La ceramica orvietana, d’impasto rosato o giallognolo dipinto
4 Il limitato apporto di influssi attici si registra anche per quei monumenti che esprimono al massimo grado le espressioni artistiche dell’Etruria padana, ovvero le stele felsinee. Come osservato da E. Govi e G. Sassatelli (GOVI, SASSATELLI 2004, pp. 256-261; SASSATELLI, GOVI 2009, p. 74) il quadro generale delle decorazioni accessorie dei monumenti sepolcrali mostra, quan-to poco incisivo sia l’apporto della ceramica attica e che molti stimoli vanno ricercati nella più genuina tradizione decorativa locale e tirrenica, mentre gli schemi delle scene figurate sono di più chiara matrice greca (v. da ultimo GOVI 2010b).
5 A questo proposito si rimanda ai lodevoli tentativi di approccio alla problematica di V. Bellelli e L. Cerchiai in FRÉRE 2007. Tentativi di sistematizzazione della ceramica a fregi ornamentali arcaica di Orvieto in DONATI 1978 e SCHWARZ 1979.
6 DONATI 1978, pp. 5-8; figg. 1, 4, 5. Decorazioni simili appaiono anche su altre forme come anfore, stamnoi, olpai, calici e piatti.
7 Cfr. DONATI 1978, pp. 24-25 (per le oinochoai vedi Fig. 15); SCHWARZ 1979, pp. 81-82; Fig. 3.
04 Appendice.indd 496 24/01/14 14.35
497
Appendice
in bruno e rosso-bruno, oltre alla decorazione lineare vera e propria, mostra una serie di fregi ornamentali molto semplici (meandri ad onda, linguette, motivi a “S”, file di punti e altro), che sono comuni anche alle produzioni del distretto chiusino8. Queste produzioni parrebbero aver influenzato il linguaggio decorativo della ceramica etrusco-padana9, i cui ornati – per i motivi di cui sopra – sono più semplificati e talvolta corsivi e dunque non seguirebbero pedissequamente il modello dell’Etruria tiberina, ma ne trarrebbe co-munque ispirazione. Non solo per apparato decorativo, ma anche per aspetto formale, si possono inoltre richiamare a confronto della produzione di brocche a becco padane, le Plumpekannen del tipo A10 prodotte lungo l’asse Vulci-Chiusi a partire dagli ultimi tre decenni del VI secolo. Fra queste si segnala un esemplare isolato proveniente da Populonia (centro “vicino” all’Etruria padana per tanti aspetti di cultura materiale), che – oltre alla consueta decorazione a fasce e linguette – presenta due occhioni dipinti ai lati del becco, un motivo che compare su una serie di brocche da Covignano (Rimini) e che consente una serie di riflessioni di cui si dirà nell’analisi al motivo decorativo (III.C.1). Proprio questo centro della Romagna, come si dirà poco oltre, potrebbe rappresentare una delle possibili direttrici di diffusione dei modelli per la ceramica a decorazione lineare dell’Etruria padana.
Come tutte le aree etrusche, anche il comparto padano non si dimostra essere una realtà unitaria e omogenea, ma mostra al contrario, come lecito aspettarsi, una serie di peculiarità e di variabili che de-nunciano autonomie più o meno marcate delle singole aree che la compongono. L’Etruria padana palesa una realtà storico-archeologica e geografica assai complessa, tipica dei territori di confine, da cui sorge una fittissima rete di relazioni (Fig. 1); il tutto però inquadrato sullo sfondo di alcune caratteristiche fon-damentali che le uniscono e sulle quali primeggia Felsina, princeps Etruriae, che in qualche modo impone alcune “linee guida”. Questo comune sottofondo si estrinseca nella standardizzazione (anche per tipologia di forme) che si coglie in modo particolare con la produzione di ceramica fine dipinta etrusco-padana; in questo senso la decorazione a fasce e meandri di vario tipo appare come una “produzione di serie” di varie botteghe distribuite su tutto il territorio padano11. Una produzione tipica che pare diffondersi durante il V secolo anche a sud dell’Appennino, in particolare nell’agro fiesolano12, con una sorta di possibile “in-flusso di ritorno”, dopo tanti stimoli ricevuti dall’Etruria settentrionale.
L’Emilia occidentale, con i meglio conosciuti territori di Modena e Reggio Emilia e quelli di Parma e Piacenza che vanno sempre meglio delineandosi, sono già stati oggetto di più attenta analisi13, cui si rimanda.
I centri principali di Spina, Marzabotto e, in parte, anche del Forcello di Bagnolo San Vito e, in misura minore, di San Polo Campo Servirola, denunciano anche nel sistema decorativo la realtà urbana che li caratterizza. Questa si esprime ovviamente al massimo grado nelle decorazioni architettoniche, rappre-sentate al meglio dalle attestazioni di Marzabotto. Come si evince dalla decorazione delle ceramiche d’uso quotidiano, esemplificate dalle singole attestazioni analizzate qui di seguito, i centri urbani mostrano un repertorio in parte più evoluto, con motivi (come il fiore di loto della “Serie Spina A”) che sono limitati ai primi tre centri, e ornati (soprattutto quelli di Marzabotto) che mostrano più forti contatti con l’Etruria settentrionale e con i distretti di Chiusi e Orvieto.
Un discorso a parte merita il panorama esornativo della Romagna. Come per alcune forme ceramiche, anche alcuni ornati sono caratteristici e limitati a questo settore. Qui si apprezzano in particolare i contatti
8 Cfr. PAOLUCCI 1999-2000. Particolarmente significative sono anche le similitudini offerte dal sito del Petriolo (v. GASTALDI 2009, pp. 179-190); qui è stata riconosciuta una scansione interna in classi che vede una produzione di “ceramica depurata a decorazione lineare arcaica” (che affonda le radici nella tradizione etrusco-corinzia a decorazione lineare) che negli ultimi decenni del VI secolo propone un repertorio standardizzato simile alle produzioni padane. Successiva evoluzione di questa classe è la “ceramica etrusca tardo arcaica a v.n. con fregi ornamentali” che affianca la precedente con una grande quantità di forme in ceramica fine da mensa e che potrebbe aver giocato un ruolo importante nella trasmissione di motivi e sintassi decorative verso la pianura padana. Anche la ceramica grezza offre alcuni spunti, con il motivo della doppia fila di punti alternati a bande dipinte presenti presso l’orlo di un bacino (GASTALDI 2009, Fig. 144) che ricorda la decorazione di un bacile-mortaio da Poggio Rusco (vedi qui nr. I.9.30); il motivo decorativo trova inoltre un confronto puntuale su un piatto da Marzabotto (vedi qui nr. I.2b.4).
9 Cfr. anche GOVI 2003, pp. 65-70; EAD. 2012.10 DONATI 1993. Lo stesso A. (p. 245) nota la particolare influenza esercitata da Orvieto sul comparto padano. 11 Cfr. CASINI 2005, p. 253.12 Cfr. SANTOCCHINI GERG 2012, pp. 243-246, con una sezione dedicata alla ceramica etrusco-padana a decorazione dipinta
ed ai suoi collegamenti con le ceramiche fini dipinte dell’Etruria settentrionale.13 SANTOCCHINI GERG 2009 e più in generale tutti i contributi in Atti Milano 2009.
04 Appendice.indd 497 24/01/14 14.35
498
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
con il mondo umbro e piceno, esemplificati da alcune forme particolari come le coppe quadriansate, le pic-cole olle a due o quattro bugnette-presa o i bicchieri a doppie anse verticali accostate. Anche le decorazioni mostrano tali contatti, relazioni che andrebbero maggiormente approfondite in altra sede e che hanno fatto ipotizzare la compresenza di realtà etniche diverse14. Una delle caratteristiche salienti della Romagna è quel-la di presentare fenomeni di parziale attardamento della tradizione decorativa villanoviana, sia per motivi che per sintassi compositiva. Questa e altre peculiarità trovano spiegazione nella varietà e complessità di
14 Cfr. COLONNA 1974a, pp. 11-24; ID. 1985, pp. 44-65; ID. 1987, pp. 37-44; SASSATELLI 1990, pp. 91-96; ID. 2008.
1. Mappa distributiva delle tecniche decorative (da SANTOCCHINI GERG 2012, fig. 1)
04 Appendice.indd 498 24/01/14 14.35
499
fenomeni che investono la regione, terra di confine che registra influenze umbre e picene da sud e venetiche da nord e la cui documentazione riflette una miglior conoscenza delle realtà sepolcrali rispetto ai pochi scavi d’abitato. Fra le concause dei fenomeni di attardamento si segnalano il probabile mancato sviluppo in Romagna di centri pienamente urbani e il fatto di aver goduto in età Villanoviana della preponderante presenza sul proprio suolo di Verucchio, uno dei centri più fiorenti di tutta l’Etruria. Un’ottima esempli-ficazione di questo fenomeno è offerta da alcuni esemplari da Russi e San Martino di Gattara (Fig. 2), che infatti non sono stati inclusi in questo repertorio, per le ragioni che seguono. Primo motivo di esclusione è rappresentato dalla cronologia, a causa della datazione quasi certa alla prima metà del VI secolo, cui si possono aggiungere alcune altre considerazioni. Per gli esemplari da San Martino in Gattara si tratta di parte del vasellame di corredo delle Tombe 1615 e 1716 (più una decina di frammenti singoli della Tomba 817) caratterizzati da una decorazione complessa a fregi di stampiglie a cerchiello, croce, linguette e motivi a “S”; questi sono stati esclusi, oltre che per la datazione alta, anche per le forti influenze allogene di marca umbra e picena percepibili pure nell’aspetto formale, come dimostra un bicchiere con doppie anse verticali appaiate18, che infatti non è inserito nel catalogo delle forme ceramiche di C. Mattioli. Per motivazioni ana-loghe sono state escluse due olle biansate e uno skyphos da Russi19, nei quali – analogamente a quanto avviene a San Martino – si percepisce evidente tale attardamento. Infatti si nota come le stampiglie vengano usate per formare motivi complessi (come un meandro ad onda ottenuto con stampiglie a croce obliqua20), o come l’utilizzo di un motivo, quello della svastica21 (unica attestazione di VI secolo), che ripropone un elemen-to decorativo assai frequente nei secoli precedenti. Un altro esempio di attardamento nell’area romagnola riguarda la tipologia formale di alcuni vasi, fra i quali si segnala (come evidenziato anche da C. Mattioli nel capitolo conclusivo di questo volume) il caso dei calici su alto piede in bucchero, retaggio formale dei più antichi calici tirrenici di VI secolo (ipotesi valida in genere anche per tutte le coppe su alto piede della Romagna). Un quadro completamente diverso da questi attardamenti, è offerto invece dal sito del Colle di Covignano (Rimini), che mostra un repertorio decorativo assai ricco e variegato, con motivi innovativi che rappresentano degli unica nel panorama padano. Il sito, i cui scavi hanno messo in luce una fase particolar-mente attiva riferibile al V secolo22, deve in qualche modo aver ricoperto il ruolo che fu di Verucchio23, cen-tro a vocazione commerciale di collegamento con l’Etruria propria. Testimonianza di questi contatti diretti
15 Olla biansata in VON ELES 1993, p. 93, n. 2.16 Otto esemplari fra olle, coperchi, coppe (BERMOND MONTANARI 1985, Figg. 11 e 14).17 BERMOND MONTANARI 1969, Tav. XLII, c.18 EADEM 1985, Fig. 14, n. 16.8.19 Ibidem, Figg. 4, 1-2; 6, F. Anche per Russi sono stati evidenziati contatti con il mondo umbro-piceno (cfr. VON ELES 1981, p. 228).20 Ibidem, Fig. 4, n. 1.21 Ibidem, Fig. 4, n. 2.22 Scavi Gentili del 1969 (vedi SCARPELLINI 1981, p. 295). 23 Su queste posizioni G. Colonna (COLONNA 1987, pp. 37-42), che considerava la Rimini di VI-V secolo come un’enclave
etrusca in territorio sostanzialmente umbro.
2. Olla da Russi (BERMOND MONTANARI 1985, fig. 4, 1); olla e tazza biansata da S. Martino (Ibidem, nn. 17.2; 16.8)
Appendice
04 Appendice.indd 499 24/01/14 14.35
500
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
sono offerti da un frammento di vaso decorato a fasce e bande proveniente dall’Etruria meridionale24 e un gruppo di oinochoai decorate ad occhioni, qui analizzate in seguito (III.C.1; Fig. 3). Influssi diretti dall’Etru-ria interna si registrano invece nel caso di due coppe carenate (Fig. 3) che per sintassi decorativa sembrano liberamente ispirarsi alle ceramiche fini dipinte di Chiusi e Orvieto, anche nel dettaglio di alternare punti singoli e doppi su motivi ondulati, che in Etruria interna si presentano spesso in forma di tralcio d’edera25. Questi elementi concordano con quanto già aveva segnalato G. Colonna26 che, per il motivo della spirale (v. oltre I.8a), attestato sempre a Covignano, postulava la presenza di artigiani etruschi immigrati da Orvieto, che avrebbero poi dato impulso alla restante produzione padana27.
Altro capitolo meriterebbe l’analisi della situazione nel capoluogo padano di Felsina. Purtroppo man-cano quasi completamente i resti dell’abitato etrusco, noto da limitati e sporadici lembi residui da scavi urbani d’emergenza, non sempre adeguatamente pubblicati. Le notizie principali sono dunque ricavabili quasi esclusivamente dal vasellame di corredo delle tombe d’età felsinea. Sfortunatamente anche per quanto riguarda le decorazioni delle ceramiche di produzione locale che accompagnano i corredi sepolcra-li, possediamo pochissimi dati. Ciò per l’evidente motivo che i corredi stessi sono composti in massima parte da ceramica attica e da vasellame e instrumenta in bronzo, che sono esclusi da questa trattazione. La ceramica locale d’accompagnamento è in generale limitata ad alcune forme atte a contenere offerte di cibo e altro, forme che solitamente non accolgono decorazioni complesse che vadano al di là di semplici linee e bande dipinte. Alcune eccezioni e casi singoli, come alcune oinochoai e olle di produzione locale, verranno esaminate nell’analisi alle singole attestazioni.
La situazione riscontrata a Bologna, si ripresenta anche in altri siti nei quali sono meglio noti i conte-sti sepolcrali e più evidenti sono le lacune nella documentazione disponibile per gli insediamenti, come Spina e parti del Modenese (con i sepolcreti di Savignano, San Cesario e Castelvetro). Dove invece la si-tuazione appare rovesciata, ovvero in siti nei quali meglio documentato è l’abitato, come Marzabotto e il Forcello, il quadro appare più ricco e variegato, essendo la ceramica locale di uso quotidiano nettamente predominante rispetto ai bronzi ed alle importazioni attiche. Ne scaturisce un quadro generale eteroge-neo, espressione di uno stato di conoscenze frammentario e talvolta lacunoso.
Tutto quanto qui anticipato circa il sistema decorativo dell’Etruria padana, trova ampie rispondenze nelle considerazioni generali della produzione ceramica padana, espresse da Chiara Mattioli in questo stesso volu-me. Nell’analisi dei singoli motivi decorativi che segue, e prendendo spunto da questi, verranno proposte al-
24 RICCIONI 2000, p. 342; fig. 3, 12. Fr. proveniente non dagli scavi dell’area del Seminario di Covignano, ma dall’area ex-Vescovado di Rimini.
25 A titolo esemplificativo si veda il repertorio di fregi ornamentali del territorio chiusino, in PAOLUCCI 1999-2000, in parti-colare fig. 32, nn. 14-16 e fig. 33, nn. 47, 66.
26 COLONNA 1985, p. 37 e ss.27 Sul ruolo della Romagna e della zona costiera per la diffusione in area padana dei motivi e stimoli provenienti dall’ambito
tirrenico si veda ora GOVI 2012.
3. Covignano, Oinochoe (SCARPELLINI 1981, fig. 200); coppe (ibidem, tav. 167, nn. 165-166)
04 Appendice.indd 500 24/01/14 14.35
501
cune ipotesi ricostruttive circa la possibile finalità delle decorazioni presso la bocca delle oinochoai (v. motivi a tridente, volute e occhi apotropaici; Fig. 8); sulla possibile esistenza di “servizi” di vasellame ed il loro utilizzo (vedi meandro a onda; Fig. 5); sulla tecnica dello stralucido (vedi reticolo di losanghe); sulla decorazione della ceramica grigia (v. motivo a palmetta); o ancora sui rapporti con la ceramica attica (v. decorazioni con edera).
In conclusione, anche questo repertorio vuole essere, più che la sede per rispondere a questioni com-plesse, uno strumento per offrire dati utili allo studio della cultura materiale dell’etruscità padana, che fra VI e IV secolo – pur sullo sfondo di una certa povertà figurativa – mostra un panorama decorativo piuttosto ricco e variegato.
premessA AL repertorio
Questa indagine è sicuramente incompleta, vista la gran messe di pubblicazioni archeologiche dall’ini-zio degli studi sull’Etruria padana, ma la quantità di ornati identificati – superiori alle trecento unità, realizzati su oltre duecentocinquanta supporti – dovrebbe ritenersi esaustiva ai fini degli scopi prefissati.
L’apparato decorativo è stato innanzitutto diviso in tre grandi classi: I. decorazioni geometriche; II. fito-morfe; III. figurate (queste ultime a loro volta suddivise in: A. antropomorfe; B. zoomorfe; C. diverse). Al loro interno i singoli motivi sono divisi per tipo (indicato con numerazione araba) e sue varianti (indicate con lettera alfabetica). Le singole attestazioni sono presentate in semplice ordine topografico, partendo da Bolo-gna, Spina, Marzabotto, seguiti dai territori Modenese, Reggiano, Mantovano, per finire con la Romagna.
Per quanto riguarda la cronologia, ogni esemplare è accompagnato da una datazione che può riferirsi tanto al singolo elemento (quando fornita nell’edizione) quanto al contesto di rinvenimento. Tali datazio-ni, quando fornite, sono tuttavia in molti casi da intendersi a titolo indicativo, per gli oggettivi proble-mi di inquadramento cronologico di questa classe di materiali, come detto nei capitoli introduttivi del volume. Alcuni esemplari qui censiti potrebbero riferirsi al periodo compreso fra il tardo VII e la prima metà del secolo successivo, e pertanto non essere compresi nel catalogo tipologico che precede. Tuttavia, in considerazione del fatto che in molti casi la cronologia proposta dagli editori si riferisce ad un generico “fine VII-VI sec. a.C.”, e per offrire un panorama decorativo quanto più ampio possibile, si è deciso di inserirli comunque in questo repertorio. Per quest’ultima ragione, e per le significative correlazioni con la ceramica vera e propria, sono stati qui censiti anche esemplari di rocchetti e fusaiole. Per l’importanza di alcuni motivi rappresentati, sono stati inoltre compresi – sotto la generica denominazione “Grandi For-me” – alcuni frammenti ceramici che potrebbero riferirsi a grandi olle, dolii e bacili, ma anche a kioniskoi, puteali e altri fittili non compresi nel catalogo delle forme ceramiche di C. Mattioli.
Questo repertorio non comprende la decorazione più comune in assoluto della produzione di cerami-ca locale, cioè le semplici decorazioni dipinte a linee, fasce e bande orizzontali; ciò per non appesantire inutilmente questo repertorio con un motivo talmente elementare e diffuso da non apportare significativi contributi alla conoscenza del patrimonio esornativo. Analoghe considerazioni valgono per le decorazioni lineari geometriche ottenute non a dipintura, ma a rilievo, mediante la realizzazione di listelli, moda-nature e cordonature, presenti soprattutto su grandi contenitori come olle e dolii, che non sono state di conseguenza inseriti in questo repertorio.
Sono stati altresì esclusi i numerosissimi graffiti28, segni incisi prima e dopo la cottura per i quali si propende per un valore alfabetico e/o numerale, anche se in alcuni rari casi si può forse congetturare un intento decorativo, soprattutto quando incisi in posizione ben visibile. Questi casi saranno messi in evi-denza nell’analisi ai singoli motivi decorativi che segue.
Per le forme ceramiche che conservano una parte del profilo sufficiente a consentire l’attribuzione tipologica, questa viene indicata fra parentesi di seguito alla forma; ove questa non sia indicata si deve intendere che si tratta di un frammento di parete o di parte del corpo che non consenta tale attribuzione.
Nella lista delle attestazioni, che segue, sono indicati in neretto gli esemplari la cui decorazioni sono raffigurate nelle tavole a fine testo. Dopo l’indicazione del sito di rinvenimento è segnalato fra parentesi il relativo territorio, con le seguenti sigle: Bologna (BO), Spina (SP), Marzabotto (MA), Modenese (MO),
28 Per una panoramica generale e indicazioni bibliografiche si rimanda a GOVI 1994 e SASSATELLI, GAUCCI 2010.
Appendice
04 Appendice.indd 501 24/01/14 14.35
502
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
Reggiano (RE), Mantovano (MN), Romagna (RO). Alcuni sporadici rinvenimenti dell’Emilia occidenta-le ad ovest del Reggiano, come Paderna presso Piacenza o Roncopascolo e Case Nuove di Siccomonte in provincia di Parma, sono state per brevità ricomprese nel territorio reggiano.
Nell’analisi ai motivi decorativi si fa riferimento ai singoli esemplari mediante richiamo al numero di attestazione preceduto da classe e tipo, così ad esempio la prima (1) attestazione del motivo fitomorfo (II) della palmetta a 5 foglie (1a) sarà: nr. II.1a.1; se l’attestazione compare come immagine anche nelle tre tavole relative alle tre classi l’indicazione sarà: Tav. II, nr. 1a.1)
Nelle tavole a fine testo viene raffigurato il solo motivo decorativo degli esemplari indicati in neretto nella sezione delle attestazioni e, in alto a destra nel riquadro del motivo decorativo, viene inoltre indica-to il numero complessivo delle attestazioni del motivo.
AnALisi dei motivi decorAtivi
Prima di esaminare in dettaglio i singoli motivi decorativi, al fine di meglio comprenderne la varietà di ornati e di tecniche per eseguirli, si propongono qui di seguito alcune tabelle con grafici per valutazio-ni e statistiche di carattere quantitativo e qualitativo relativi ai singoli materiali, tecniche e cronologie.
Come si evince dalla tabella 1, la classe ceramica privilegiata all’accoglimento di decorazioni è quella depurata (quasi 60%); ciò anche per il semplice motivo tecnico che tale supporto è adatto sia per la dipintura che per la stampigliatura, tecniche che assieme coprono l’80% del totale (vedi Tab. 2). Come detto nell’in-troduzione, la maggior parte degli elementi decorativi sono di tipo geometrico (vedi Tab. 3): alle semplici linee, fasce e bande orizzontali (non conteggiate nel totale), si aggiungono linee ondulate o a zig-zag, serie continue di punti o linguette, il tutto giustapposto a creare un’insieme coerente che caratterizza tanta parte del patrimonio decorativo padano (vedi esemplificazione in Fig. 5). Con il passare del tempo (Tab. 7) i mo-tivi geometrici tendono a flettere (fino a perdere quasi il 30% nel IV-III secolo) in favore delle decorazioni a carattere fitomorfo, in gran parte rappresentate da palmette e rosette, motivi estremamente diffusi in tutto il Mediterraneo e che rappresentano spesso un mero riempitivo. Con percentuali che non raggiungono mai il 10%, i motivi figurati mostrano invece una rarefazione costante nel tempo.
Dal punto di vista cronologico, in generale (Tab. 4), la produzione ceramica mostra una crescita co-stante di esemplari decorati, con i picchi massimi distribuiti lungo tutto il V secolo, per poi mostrare una brusca e consistente flessione nei primi decenni del IV secolo. Per quanto riguarda le due tecniche esor-native più utilizzate, queste mostrano un andamento condizionato dal supporto destinato ad accoglierle. Così la stampigliatura (Tab. 5) è più utilizzata durante il VI secolo29, quando maggiore è il numero di
29 Si precisa che il picco del 9,5% dell’ultimo quarto del V sec. a.C., si riferisce quasi esclusivamente alla ceramica stampi-gliata di Spina, in particolare alla “Serie A” classificata in PATITUCCI UGGERI 1983, p. 133 ss. Senza questo dato, la curva della tecnica della stampigliatura mostrerebbe un regolare andamento discendente dalla seconda metà del VI fino ad estinguersi nella prima metà del IV sec. a.C. Un altro picco si avrebbe tuttavia intorno al III secolo se in questo repertorio fossero state incluse le stampiglie della ceramica grigia di Spina (cfr. PATITUCCI UGGERI 1984).
Tab. 1. Classi ceramiche decorate Tab. 2. Tecniche decorative
04 Appendice.indd 502 24/01/14 14.35
Appendice
503
Tab. 3. Classi decorative
Tab. 4. Cronologia della ceramica decorata
Tab. 5. Cronologia ceramica stampigliata Tab. 6. Cronologia ceramica dipinta
Tab. 7. Classi decorative nel: a) VI sec.; b) V sec.; c) IV-III sec.
04 Appendice.indd 503 24/01/14 14.35
504
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
vasi in bucchero che non si prestano ad essere dipinti, mentre la dipintura (tab. 6), per converso, mostra uno scarto improvviso nel tardo VI secolo, grazie alla comparsa della ceramica depurata etrusco-padana.
i. motivi geometrici (tAv. i)
1. Cerchiello Di chiara ascendenza villanoviana, il cerchiello è fra i pochi motivi decorativi a stampiglia che prose-
gue fino alla tarda età arcaica, mentre termina l’impiego di motivi assai comuni fino al Villanoviano IV come le paperelle, le svastiche ed i triangoli campiti a linee sottili, che non hanno seguito. La redazione del cerchiello, in tutte le sue versioni, è a stampiglia ed il supporto preferito è il bucchero (58%), anche se non mancano esemplari in impasto (21%) e ceramica depurata (21%). La discendenza dal repertorio villanoviano rende più comune il motivo nel VI secolo, anche se alcuni esemplari scendono in piena età classica. Come detto in premessa, non sono stati qui inseriti alcuni esemplari romagnoli e le redazioni su bronzo (ben 11 esemplari) e osso; in questo caso, con 48 esemplari in totale, il cerchiello sarebbe stato il motivo decorativo più comune dell’Etruria padana, assieme alle linguette ed al meandro ad onda. Per ciò che concerne la distribuzione territoriale, il motivo è più comune nel Reggiano (54%) che altrove, con una significativa assenza a Spina, la cui produzione ceramica inizia in modo massiccio solo nel V secolo. Pur tenendo conto delle importanti lacune documentarie, pare inoltre interessante notare come, a differenza della precedente età Villanoviana, il motivo sia quasi assente nei contesti funerari e che la quasi totalità delle attestazioni provenga invece da contesti abitativi. Si segnala infine come l’intento decorativo sia reso evidente dalla posizione stessa delle stampiglie, solitamente impresse nel punto di maggior visibilità e “prestigio” del vaso; non sembra inoltre di cogliere una particolare preferenza per alcuni supporti, anzi, il cerchiello appare come la decorazione meno legata alle correlazioni fra motivo e supporto. Nel caso del cerchiello doppio, il cui esito è il segno a “8” o “infinito” (Tav. I, 1.c), il motivo si presta a formare le volute da cui sorge un motivo fitomorfo, come nel caso della palmetta del Forcello o del possibile fiore di loto di Bologna (vedi infra).
2. Punto Il motivo del piccolo punto dipinto può essere considerato in qualche maniera come l’erede del cer-
chiello. Analogamente a questo, non molte sono le correlazioni fra motivo e supporto, anche se si nota una certa preferenza per le spalle delle forme chiuse. Anche cronologicamente il puntino segue il cerchiel-lo, potendosi attribuire la maggior parte degli esemplari al V secolo. Per ovvie motivazioni tecniche il motivo non compare sul bucchero, ma solamente sulla ceramica depurata.
A differenza del cerchiello, il punto non compare mai isolato come motivo singolo e solitamente viene re-datto nella versione a fila di punti (tipo I.2b) a fascia orizzontale (in versione verticale sulle anse sormontanti di brocche). In un unico caso il motivo è realizzato in versione metopale, mediante una serie di quadrati di puntini a risparmio presso l’orlo di uno skyphos da Montecchio Emilia (Tav. I, nr. 2c.1). Una possibile eco, piuttosto che un vero modello, per questa particolare realizzazione può essere cercato nella vasta produzione di ceramica etrusco-corinzia a decorazione lineare dipinta, nella quale sono assai comuni sia le file di puntini sia le più complesse fasce, bande e metope di puntini dipinti o risparmiati. Pur trattandosi di un unicum, più consistenti e vicine sono simili decorazioni nella ceramica attica a f.n. e nella ceramica etrusca a decorazione geometrica lineare dell’Etruria interna. In Etruria padana le importazioni di ceramica etrusco-corinzia sono assai rare, ma un’esemplare può comunque essere richiamato a generico confronto: si tratta di uno skyphos da San Basilio di Ariano Polesine30 che presenta una decorazione complessa a linguette, file di punti e quelle che sembrano almeno due metope a puntini dipinti. Un’altra realizzazione particolare riguarda una coppa carenata da Covignano di Rimini (nr. I.2a.2; Fig. 3) che alterna punti singoli e doppi all’interno delle anse di un meandro ad onda, secondo la stessa sintassi compositiva di numerosi fregi della ceramica etrusca a figure nere dell’Etruria interna ed in particolare del territorio chiusino31.
30 SALZANI, VITALI 2002, p. 137, fig. 17.31 Si vedano, ad esempio, i fregi a tralci d’edera stilizzati in PAOLUCCI 1999-2000, figg. 22, 23, 25 e soprattutto figg. 32 (nn.
04 Appendice.indd 504 24/01/14 14.35
Appendice
505
3. Croce La croce è uno di quei motivi elementari che ci aspetteremmo di trovare in abbondanza, al contrario è
un motivo piuttosto raro, se si escludono gli esemplari – assai diffusi – realizzati, solitamente con valore alfabetico e numerale, con la tecnica del graffito e pertanto qui non considerati. Una relativa abbondanza, con stampiglie a piccoli croci oblique (singole, a fascia e disposte a formare meandri ad onda) è attestata da vari esemplari a Russi e a San Martino di Gattara (Fig. 2), che come detto non sono stati qui inseriti. I pochi esemplari qui censiti si trovano disomogeneamente realizzati in tutte le tecniche e su supporti diversi, in tutte le classi ceramiche. Il fregio continuo di motivi a “X” inciso sul collo dell’esemplare dal Forcello (nr. I.3.4) è mal realizzato (o conservato) e potrebbe voler rappresentare anche un meandro a zig-zag (motivo più comune, anche al Forcello).
4. Triangolo Gli ornati angoliformi sono rappresentati da una serie eterogenea di motivi decorativi, accomunati dal
fatto di presentare uno o più angoli acuti e dal fatto che alcuni dei sottotipi sono facilmente confondibili fra loro. Un dente di lupo reso rozzamente si confonde con un triangolo, se alcuni segni a “V” vengono accostati si ha un meandro a zig-zag, e così via. La suddivisione che segue è pertanto indicativa, anche se solitamente si riesce a cogliere l’intento di eseguire un dato motivo, come – ad esempio – un dente di lupo ad imitazione della ceramica etrusco-corinzia o attica oppure un meandro, sia esso reso con motivi angolati piuttosto che ondulati.
Il triangolo singolo è in due casi reso a stampiglia con un piccolo cerchiello singolo che lo sormonta (nrr. I.4a.2; 4a.3); questi esemplari si possono latamente riferire al VI secolo e sono verosimilmente il retaggio di un motivo assai comune durante il Villanoviano come il triangolo campito a linee incise (o realizzate a falsa cordicella) sormontato da cerchiello, motivo che non sopravvive in età Arcaica e Classica. Tutt’altra origine hanno invece i triangoli alternati e campiti a linee o a tratteggio che sono un motivo frequente nella decorazione accessoria delle stele felsinee dove compaiono, sulla cornice esterna, in ben 38 esemplari32. In questo caso, al di là delle evidenti diversità di supporto, l’origine non dovrebbe ricollegar-si al motivo villanoviano, essendo – fra l’altro – una produzione che si afferma verso il 470 a.C.
Degna di particolare menzione è la fascia di triangoli accostati a vertice alternato (tipo I.4b), tipici del territorio modenese e altrove attestati da un singolo rinvenimento a Marzabotto (nr. I.4b.1). Il motivo è solitamente inciso su ceramica grezza e bucchero, ed in un caso da Fiorano Modenese è anche dipinto su ceramica depurata (Tav. I, nr. 4b.2). La frequenza del motivo nel territorio di Modena potrebbe derivare dagli stretti contatti – tramite il Frignano ed i passi appenninici – con il mondo ligure, dove le file di triangoli incisi (pur nella resa solitamente più corsiva) sono ampiamente attestati. Testimonianza di que-ste produzioni, definite infatti “allogene”, si hanno proprio nel territorio modenese, con rinvenimenti a Castelfranco Emilia33, Rastellino34 e Riolo35.
L’altra attestazione non Modenese, il kantharos da Cacciola di Scandiano (nr. I.4b.6), trae origine da un repertorio completamente diverso, qui la fila di piccoli triangoli incisi a tacche ravvicinate sullo spigolo vivo della carena, vuole con tutta verosimiglianza essere la riproduzione della decorazione più comune fra i kantharoi prodotti in Etruria meridionale, ovvero le tacche a punta di diamante, caratteristiche soprat-tutto del tipo Rasmussen 3e, non a caso il più diffuso fuori dall’Etruria propria, anche oltremare.
5. Chevrons La serie di segni a “V” in orizzontale, o chevrons (Tav. I, 5), è un uno dei motivi geometrici più elementari
e diffusi in tutto il bacino mediterraneo, soprattutto in età preistorica, e non consente considerazioni più di tanto approfondite, anche se sorprende la sua rarità, con sole cinque attestazioni in tutta l’Etruria padana.
14-15) e 33 (meandri ad onda con puntini nn. 47, 66); per Sarteano si veda MINETTI, RASTRELLI 2001, p. 72, n. 30/4. Per le file di punti si veda anche quanto detto qui alla nota 8, circa un bacino decorato a doppia fila di punti dallo scavo del Petriolo (GASTALDI 2009, fig. 144).
32 Cfr. GOVI, SASSATELLI 2004.33 BUOITE, ZAMBONI 2008, p. 89 e fig. 15, n. 743.34 Modena 2009, p. 59, fig. 228, nn. 10-13; dove si dice esplicitamente che le ceramiche sono decorate con tecniche estranee
al patrimonio locale.35 Modena 2009, p. 60, fig. 230, n. 5.
04 Appendice.indd 505 24/01/14 14.35
506
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
6. Dente di lupo La sporadicità di questo motivo decorativo angoliforme, sorprende ancor più della rarità degli chevrons.
Si tratta infatti di uno degli ornati geometrici più comuni della tradizione greca, sia nelle produzioni corinzie che nella seguente ceramica attica, poi prontamente imitato nella ceramica etrusca figurata. Il motivo si trova solitamente dipinto nel punto di giunzione del ventre con il piede o sulla spalla delle forme chiuse, ed in questo senso è dipinto sulle tre oinochoai di Rubiera (nrr. I.6.1-3).
7. Segno a “S” In quanto probabile stilizzazione sia del “serpentello” che della “paperella”, questo ornato era uno dei
più frequenti del repertorio villanoviano, mentre nell’epoca successiva diventa assolutamente marginale. Un serpentello è forse ravvisabile solo nelle “S” stampigliate su una coppa da Faenza (Tav. I, nr. 7a.7), che sembrano mostrare l’ingrossamento della testa, sulla quale si intravedono due piccole appendici. In questo e in altri esemplari (nrr. I.7a.1, 2, 5, 7-9) il motivo è ripetuto in fascia orizzontale, secondo la tra-dizionale sintassi villanoviana. Nello stesso senso, tranne due casi (nrr. I.7a.6, 7b.1), il motivo è sempre reso a stampigliatura. Il motivo a “S”, adagiato orizzontalmente, fa parte della decorazione complessa degli esemplari di Russi e San Martino in Gattara di cui in premessa, mentre non vi sono attestazioni del motivo su materiali diversi come il bronzo, l’osso o la pietra.
Il caso più particolare è il frammento di collo di un’oinochoe da Baggiovara (Tav. I, nr. 7b.1; Fig. 4, a): qui il motivo si evolve nella versione a “S intrecciate”, un motivo che richiama la decorazione a volute complesse, già attestato nel Modenese (cfr. nr. I.8b.6; Fig. 4, b)36. Decorazioni pittoriche complesse che, come altrove già osservato37, sembrano caratterizzare l’Emilia occidentale ed in particolare il Modenese, che mostra una certa vitalità e autonomia rispetto ad altri comparti padani, come dimostra anche l’unico fregio pittorico zoomorfo d’Etruria padana (Tav. III, nr. B.2a).
36 Il motivo a “S intrecciate” è piuttosto frequente nei territori di Chiusi e Orvieto, dove compare ripetuto in serie su varie forme (soprattutto oinochoai, skyphoi e calici). Una realizzazione assai simile è il risultato della stilizzazione dei viticci a voluta dei fregi a tralcio d’edera, dagli stessi territori (cfr. DONATI 1978 e SCHWARZ 1978 per il Volsiniese e PAOLUCCI 1999-2000 per il Chiusino).
37 SANTOCCHINI GERG 2009, p. 236.
4. Brocche: a) Baggiovara (CATTANI 1988a, p. 18, fig. 3, 7); b) Magreta (Modena 2009, p. 272, fig. 457)
04 Appendice.indd 506 24/01/14 14.35
Appendice
507
8. Motivi a spirale e volute La spirale, quasi a sottolineare le tracce lasciate dal segno del tornio, si trova incisa (solo un caso, Tav.
I, nr. 8a.2) o dipinta38 sul fondo interno di coppe in ceramica depurata. L’unica eccezione è rappresentata dalla spalla di un olla da Adria (nr. I.8a.6), ma in questo caso, siccome si tratta praticamente di un cer-chiello, la spirale può essere il risultato (forse involontario) della realizzazione del punzone.
Più varia e complessa l’analisi del motivo a volute, che in alcuni casi (come i nrr. I.8b.3, 8b.5) si con-fonde con le spirali stesse, in altri rappresenta probabilmente la stilizzazione di palmette (vedi palmette tipo 1h). Degna di nota l’oinochoe dal podere Decima di Magreta (Tav. I, nr. 8b.6; Fig. 4, b), nella quale le volute di evolvono in modo complesso: quelle dipinte ai lati del becco sembrano riprodurre il motivo dell’occhio apotropaico (cfr. la serie di Covignano, III.C.1.1-5), mentre quelle dipinte sul collo sono rad-doppiate a formare un motivo del tutto analogo alle “S intrecciate” (Tav. I, nr. 7b.1).
Le volute come parti di motivi fitomorfi, in particolare delle palmette, registrano una peculiare evolu-zione e successo nelle stampiglie caratteristiche della regione a cavallo fra Etruria settentrionale interna e padana39.
M. Zuffa40, nel commento all’esemplare da Covignano (nr. I.8a.3), osservava che tipo e decorazione non trovano confronti al di fuori dell’ambito locale e che si riallaccerebbero a reperti della fase post-villanoviana di Verucchio. Per Giovanni Colonna41 la decorazione a spirale sul fondo interno del vasel-lame rimanderebbe alla tradizione decorativa di Orvieto. Qui la spirale è attestata sia ad incisione, nel bucchero, che a stralucido, nell’impasto. Egli ne deduce quindi la presenza di artigiani orvietani venuti a lavorare sull’Adriatico sul finire del VI sec. a.C. Egli ipotizza infine che dal Riminese abbia avuto impulso la restante produzione padana42, in particolare quella di Spina (analizzata nel saggio di Stella Patitucci Uggeri)43, e che lo scarno repertorio decorativo, basato sulle linee ondulate e sulle file di punti, apparireb-be come un’ulteriore semplificazione di quello dell’area riminese e, in generale, romagnola (che sarebbe echeggiata dai ritrovamenti di Fiesole)44.
La teoria generale di un’origine “riminese” di tutto il repertorio della classe ceramica etrusco-padana, alla luce anche di tutto quanto rilevato in questa trattazione, è forse in parte da rielaborare; mentre, per quanto riguarda specificatamente il motivo della spirale, l’origine orvietana potrebbe ritenersi valida. Per questa provenienza si segnala P. Tamburini45, dove il motivo è ampiamente documentato e compare su bucchero e sulla ceramica d’impasto rosso-bruno; da questa ne deriva la cronologia, cha va dalla prima metà del VI agli inizi del III sec. a.C. Ad ogni modo è da notare che il soggetto è molto semplice, so-stanzialmente un motivo archetipico, e così non se ne può escludere a priori l’origine autonoma; questo spiegherebbe anche il caso della distante Forcello (Tav. I, nr. 8a.2) realizzato ad incisione e stratigrafica-mente ben collocabile alla fine del VI sec. a.C. Gli altri casi dovrebbero risalire al pieno V secolo e sono tutti realizzati a pittura. Questa tecnica potrebbe essere una delle concause degli scarsi ritrovamenti: la vernice dipinta è quella che meno resiste all’aggressione degli agenti presenti nella terra, in particolare in quelle particolarmente acide come a Marzabotto. Ci sono infatti dei fondi di coppe inedite di questa località nelle quali sono visibili tracce molto evanidi di vernice che sembrano riprodurre il motivo; da notare inoltre che la campitura interna dei supporti è spesso effettuata con movimento rotatorio, questo produce in alcuni casi un non voluto, o all’opposto volutamente sottolineato, “effetto spirale”.
38 Le spirali sulle due coppe dal pozzo di Pian del Monte di Verucchio (nr. I.8a.4-5) in realtà non sono realizzate a dipintura vera e propria, ma a suddipintura; fra le attestazioni sono indicate come “dipintura” per non alterare le analisi statistiche.
39 Su questo aspetto si rimanda a quanto detto in SANTOCCHINI GERG 2012, v. in particolare tav. 3, nn. 11-19.40 ZUFFA 1969, p. 100.41 COLONNA 1985, p. 37 e ss.42 Su posizioni analoghe anche R. Macellari (MACELLARI 1990, p. 38) che, analizzando la produzione ceramica di San Claudio
(RE), ipotizza che la ceramica etrusco-padana sia iniziata su “insegnamento dei maestri vasai orvietani”.43 PATITUCCI UGGERI 1983, pp. 91-139.44 Cfr. MAGGIANI 1985, p. 308. Da una ricerca nei magazzini del locale museo civico di Fiesole, S. Bruni (BRUNI 1997, fig.
1-2, inv. 1125) ha trovato una coppa a decorazione lineare fuori e dentro la vasca con una spirale dipinta che si diparte dal centro. Bruni ha ipotizzato una importazione dall’Etruria meridionale (Orvieto) e la definisce phiale italo-geometrica, databile per confronti al 640-630 circa. Ciò confermerebbe sia l’origine orvietana del modello, che l’arrivo in Etruria padana attraverso la mediazione fiesolana/etrusco-settentrionale. Anche a Chianciano Terme è noto il motivo della spirale (PAOLUCCI 1999-2000, fig. 32, nn. 23-24).
45 TAMBURINI 1987, pp. 93-96 e figg. 24, 27.
04 Appendice.indd 507 24/01/14 14.35
508
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
Infine, nell’esemplare che adorna il fondo interno di una coppa da Marzabotto si è voluto vedere una chiocciola (vedi infra nr. III.B.5) ed è perciò stata inserita fra i motivi zoomorfi, altrimenti potrebbe essere qui compresa come semplice spirale.
9. Linguetta / baccellatura Le semplici linguette e trattini verticali dipinti sono, assieme ai meandri ad onda, il motivo decorativo
più comune fra quelli qui esaminati. Solo in alcuni casi vi è ravvisabile una baccellatura vera e propria, negli altri si tratta di imitazioni semplificate quando non di semplici riempitivi. Al limite fra motivo geometrico e fitomorfo, questi due temi figurativi – che spesso si possono confondere fra loro – sono stati qui inseriti anche se per essi si può richiamare una comune origine quale stilizzazione di una foglia. Sono le foglie geometrizzanti o schematizzate che nel DMA (pp. 169-171) sono indicate come feuille d’eau, languette, godron (foglie d’acqua, linguette, baccellatura). La differenza fra loro è che la foglia d’acqua ha nervatura centrale e bordo rilevato/sottolineato, la baccellatura ha solo la bordatura e la linguetta nes-suna delle due. Questi dettagli nei nostri casi specifici sono spesso inintelligibili, per questa ragione le due sono state riunite in un unico tipo. Non sono state qui incluse le baccellature più comuni e diffuse, ovvero quelle relative alle decorazioni architettoniche (lastre, antefisse, elementi di colonna), delle quali il miglior campionario è offerto dal centro urbano di Marzabotto.
Nel senso di baccellatura vera e propria si segnalano solamente tre coppe in bucchero con solcature radiali (nrr. I.9.1, 32, 33), che imitano verosimilmente coppe e patere baccellate in metallo, e un’oinochoe in bucchero con baccellatura a rilievo (nr. I.9.25), probabilmente ispirata alle produzioni in bucchero pesante di Chiusi e Orvieto.
Negli altri casi le semplici linguette possono essere incise (9%), stampigliate (12%) o dipinte (79%). In quest’ultimo caso le linguette sono per la maggior parte pitturate, tipo baccellatura, sulla spalla di brocche (50%) e sulla spalla di olle (27%); in altri casi si trovano su bacili mortaio (12%) o su altre forme (11%). Trattandosi in maggioranza di dipintura su ceramica depurata, la gran parte delle attestazioni sono conseguentemente databili al V e IV secolo.
10. Meandro Il meandro, motivo prodotto dall’accostamento in serie di semplici motivi geometrici ripetuti a costitui-
re un fregio orizzontale continuo, rappresenta la decorazione più comune dell’Etruria padana (cfr. Fig. 5). Fra le varie realizzazioni di questo motivo geometrico, la più frequente è la versione elementare formata da una semplice linea sinuosa, il meandro ad onda, seguita dalla versione con apici angolati, il meandro a zig-zag. Nel meandro ad onda, la linea ondulata è realizzata quasi esclusivamente a dipintura (94%), tranne due casi nei quali è incisa (nrr. I.10b.6; 10b.8) e una particolare realizzazione a stralucido (nr. I.10b.32); la linea è qua-si sempre singola e raramente raddoppiata in due linee sinuose parallele, mentre sulla ceramica non esiste la versione intrecciata, o guilloche, che è invece attestata sulla cornice di specchi in bronzo46 o, ad esempio, su due situle della “Tomba Grande” della necropoli dei Giardini Margherita di Bologna47. Per il motivo inciso su queste situle, a guilloches a treccia doppia o tripla ad occhielli puntinati, sono stati richiamati a modello le hydrie ceretane48, gli elmi tipo Negau49 e, più in generale, le cornici degli specchi etruschi50; il tipo è noto anche per le decorazioni architettoniche, come – ad esempio – le note lastre Boccanera. La più complessa versione ad “onda corrente” è attestata sulla ceramica in un solo caso (nr. III.C.2), mentre è assai comune come decorazione accessoria sulla cornice esterna delle stele felsinee (67 ricorrenze) e sulla base di quattro pu-teali di Marzabotto. Sempre per quanto riguarda il meandro ad onda, questo è solitamente dipinto su collo
46 Fra questi si segnalano cinque specchi dai sepolcreti di Bologna e il noto specchio della necropoli della Galassina di Castel-vetro (MO). G. Sassatelli (SASSATELLI 1981, p. 23) ha osservato come, sulla scorta di analisi delle componenti metalliche, la fabbricazione di questi specchi sia probabilmente da attribuire ad officine locali.
47 JURGEIT 1986, tav. XVIII, a-c. Come per gli specchi, anche per le due situle è stata proposta la produzione da parte di un atelier di bronzisti da collocarsi a Felsina e attivo dall’inizio del V sec. a.C. a tutto il terzo quarto del secolo stesso (cfr. Ibidem, p. 115 e ss.).
48 JURGEIT 1986, p. 109.49 MACELLARI 2002, p. 8150 JURGEIT 1986, p. 109. Anche G. Sassatelli (SASSATELLI 1981, p. 21) osserva che il motivo è frequente sugli specchi dei primi
decenni del V secolo, specialmente come cornice alla decorazione figurata sul rovescio.
04 Appendice.indd 508 24/01/14 14.35
Appendice
509
o spalla di brocche (33%), sulla vasca interna51 di bacili-mortaio (29%) e sulla spalla di olle (25%), mentre solo in sette casi (13%) è dipinto su forme diverse (di cui tre coppe). Il fatto che l’87% delle attestazioni del meandro ad onda siano riferibili a brocche, mortai ed olle, e che il 94% di questi sia realizzato in ceramica depurata52, induce ad una riflessione circa il loro utilizzo. La decorazione di questi vasi, che solitamente si arricchiscono sul corpo di fasce e bande dipinte, meandri e linguette, risulta particolarmente elaborata ed emerge rispetto a produzioni altrimenti piuttosto povere; il fatto che ornati analoghi si ritrovino su queste forme, le potrebbe qualificare come appartenenti ad un vero e proprio “servizio” (Fig. 5)53. La riflessione riguarda quindi la loro funzione: un possibile uso, certo non esclusivo, potrebbe riguardare il “servizio da simposio”. Secondo questa suggestiva ipotesi le olle assolverebbero la funzione di crateri per la preparazione della miscela di vino, acqua, spezie ed altro, mentre le brocche a quella delle oinochoai per la mescita della stessa. In quest’ottica i mortai a decorazione complessa, rispetto ad altre ipotesi legate alla produzione di impasti cremosi o formaggi54, potrebbero servire alla triturazione delle spezie da aggiungere al kykeion, o comunque essere contenitori polifunzionali adatti anche a quest’ultima finalità. La funzione di mortaio, anche per le spezie durante cerimonie conviviali, è stata già riconosciuta ai bacini di produzione fenicio-cipriota55, di cui molti esemplari provengono da contesti sepolcrali dell’Etruria propria e medio tirrenica in particolare56. Gli esemplari del territorio ceretano e veiente57 sono di forma assai simile a quelli etruschi e ne potrebbero essere stati (assieme alle produzioni corinzie) il modello, sopratutto per quelli del tipo I-II Mat-teucci58, in particolare il tipo II con decorazione a bande dipinte, databile al pieno VI secolo. Infine, alcune coppe di forma e decorazione particolarmente curata, come anche le piccole olle (anche definite bicchieri) in
51 Solo in tre casi dal Mantovano (nrr. I.10b.37, 40-41) il motivo è ripetuto sia all’interno che all’esterno della vasca.52 L’eccezione è rappresentata da tre olle in ceramica grezza (nrr. I.10b.6, 20, 25) e una in bucchero (nr. I.10b.32).53 In questo senso anche CASINI 2005, p. 263, che cita un “servizio” composto da mortai, ciotole e olle; si segnala tuttavia
che le ciotole (o coppe, come qui definite) sono solo tre esemplari (nrr. I.10b.14, 49-50), ben inferiori alle 16 brocche con analoga decorazione, che meglio si prestano a formare “servizio” con olle e mortai.
54 A parere di G. Baratti (in MENOTTI, BARATTI 2006, pp. 52-53) i bacili-mortaio in ceramica depurata, anche se a fondo cri-brato, servirebbero alla produzione in ambito familiare di impasti cremosi con macerazione di vegetali e mantecazione di formaggio; la ricca decorazione si spiegherebbe, secondo quest’ipotesi, perché il cibo in essi contenuto sarebbe stato servito in tavola direttamente in tali “mortai”. Secondo S. Casini (CASINI 2005, pp. 259-261), oltre all’utilizzo per la macinatura di cereali e la preparazione di pappe cremose (per le quali le dimensioni sarebbero troppo ridotte), è più probabile l’utilizzo per la produzione di formaggi. La polifunzionalità della forma bacile-mortaio si evince anche dalla varietà tipologica e di impasto con cui viene realizzato, vedi C. Mattioli, pp. 47-63, in questo volume, dove, in parziale contraddizione con la “nobilitazione” del vaso dato dalla sua ricca decorazione, si deduce un suo utilizzo limitato alla cucina, constatando che la maggior parte degli esemplari sono realizzati in ceramica grezza (in minor misura in ceramica depurata e grigia), ma mai in bucchero.
55 BELLELLI, BOTTO 2002, p. 300.56 Ibidem, pp.290-296.57 Ibidem, p. 295, figg. 8-9. In particolare si segnala l’esemplare da San Rocchino di Massarosa (fig. 9, c) che, assieme ad altri
esemplari versiliesi e da Pisa, Genova, Massa Marittima e Roselle, testimoniano un processo distributivo che da sud (in particolare da Caere dove si trovano le più antiche attestazioni) conduce verso nord. Per questa via il tipo può essere giunto in Etruria padana (come notato anche dagli AA., che citano in nota 117 gli “scodelloni” tipo 1A della Romagna in VON ELES 1981).
58 MATTEUCCI 1986. Cfr. anche BELLELLI, BOTTO 2002, pp. 300-302, tav. II.
5. Ipotetico “servizio da simposio”(olla: BALDONI 1981, tav. XL, 138; mortaio: PATITUCCI UGGERI 1983, fig. 11, 39c; brocca: MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, tav. LVIII, 2; “bicchieri”: sx. MALNATI 1993, fig. 11, 7; dx. DAMIANI et alii 1992, tav. XIX, 212 )
04 Appendice.indd 509 24/01/14 18.09
510
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
bucchero, fra le quali si segnalano quelle con decorazione a stralucido sulla spalla (nrr. I.10a.10-11; 10b.32; 11.2, 5), sarebbero da interpretare come vasi potori per il simposio stesso. Questa ipotesi di lavoro necessita di approfondimento, in quanto – ad esempio – non vi sono contesti, come quelli sepolcrali59, che abbiano restituito un tale “servizio” nella sua integrità. Tuttavia questa obiezione si può superare in parte sostenen-do che questo “set da banchetto” sarebbe da riferire ad un uso quotidiano e familiare, mentre per i corredi funerari e per le cerimonie più esclusive e di rappresentanza le élites etrusche si sarebbero rivolte ai più pre-stigiosi servizi in bronzo e ceramica attica. Si precisa, infine, che tale ipotesi, in un ottica multifunzionale, non implica necessariamente un’interdipendenza fra questi vasi, la loro decorazione complessa e un esclusivo utilizzo legato a cerimonie simposiache.
Il meandro a zig-zag può essere considerato una semplice variante, meno comune, della linea ad anda-mento sinuoso, soprattutto in quei casi nei quali il motivo è inciso, nella considerazione che lo strumento induce ad un ductus a linee rette spezzate e non curve. Di conseguenza è maggiore il numero di esemplari incisi rispetto alla versione ad onda (39% contro 4%), mentre gli esemplari dipinti sono 6 (46%) e quelli a stralucido due (15%). La maggior parte degli esemplari sono realizzati in ceramica depurata (54%), contro il 23% ciascuno dei pezzi in bucchero e ceramica grezza. Rispetto alle considerazioni espresse per il meandro ad onda circa un utilizzo del vasellame così decorato per il simposio, anche nel caso del me-andro a zig-zag la grande maggioranza (77%) delle attestazioni riguarda olle (46%), mortai e brocche. Delle olle, le due di piccola misura decorate a stralucido (nr. I.10a.10 e Tav. I, nr. 10a.11), possono essere interpretate anche come vaso potorio. Il meandro a zig-zag inciso sullo spigolo vivo della carena del kan-tharos in bucchero di Marzabotto (nr. I.10a.6) può invece essere considerato come tentativo di imitazione del motivo più comune sui kantharoi dell’Etruria meridionale (soprattutto il più diffuso ed esportato tipo 3e Rasmussen), ovvero le tacche a punta di diamante.
Il meandro ad archetti è attestato solo nel caso di due grandi forme fittili da Marzabotto (nrr. I.10c.1-2). Entrambi sono realizzati a rilievo presso l’orlo di due vasi di grandi dimensioni, forse interpretabili come bacili. In questo senso un suggestivo confronto è ipoteticamente richiamabile con i tre bacili sovrapposti dipinti fra i due lottatori (interpretati come premio per il combattimento) della Tomba degli Auguri di Tarquinia. In generale questo tipo di fregi geometrici a rilievo decora molti elementi architettonici di Marzabotto, come puteali e rivestimenti di colonna.
Il più comune e noto tipo di meandro della tradizione greca, il meandro a “G”, è attestato in Etruria padana da un solo esemplare “periferico”, non in fregio ma come stampiglia singola, impressa al centro del fondo esterno di un piede ad anello di una probabile coppa in bucchero esposta nel Museo Archeologi-co di Parma, vetrina 4 (“Siccomonte”), n. 1 (Tav. I, nr. 10d, 1). Altri casi, non inseriti in questo repertorio, sono realizzati ad incisione sulla cornice di uno specchio bronzeo dalla tomba 104 del sepolcreto Arnoaldi di Bologna60 e su alcune tegole di gronda dipinte di Marzabotto. Altre attestazioni non pervenute sono tuttavia certe, considerato che a San Polo-Campo Servirola (RE) è stato rinvenuto un punzone in osso con meandro semplice61. Un ulteriore possibile meandro a “G” è forse leggibile sul fondo dipinto di una forma aperta in ceramica depurata da San Cassiano (Rovigo)62; la sua parzialità ed il fatto di provenire da giacitura secondaria in contesto stratigraficamente compromesso, rende assai complessa l’interpretazione di questo particolare frammento (un fondo piano di una possibile forma aperta di grandi dimensioni), di cui non è neanche certa la produzione locale.
L’estrema rarità di questo motivo in Etruria padana, conferma l’impressione di generale indipendenza delle decorazioni locali dalle influenze della ceramica greca (e attica in particolare), nella quale i meandri complessi e a “G” mostrano tanta fortuna e una lunga tradizione.
59 A Spina, ad esempio, i bacili-mortaio sono proporzionalmente più frequenti in abitato che in necropoli; oltretutto i pochi esemplari di corredo funerario non di rado sono utilizzati come coperchio del dolio-cinerario (PATITUCCI UGGERI 1983, p. 118; EADEM 1984, p. 148).
60 MACELLARI 2002, p. 29, tav. 19, n. 11.61 Per ulteriore commento al punzone si rimanda a SANTOCCHINI GERG 2012, p. 225, nota 4.62 SALZANI 1987, p. 233, fig. 1, n. 11.
04 Appendice.indd 510 24/01/14 18.00
Appendice
511
11. Reticolo di losanghe Pur con poche attestazioni questo motivo è uno dei più interessanti per la quantità di relazioni che in
base ad esso è possibile ricostruire: il reticolo rappresenta infatti una sorta di “fossile guida” che permette di seguirne le evidenze lungo un percorso esteso e complesso.
Come si evince dalle attestazioni, tranne un caso di Spina (nr. I.11.1) (nel quale il motivo è dipinto, associato ad un meandro ad onda, sulla vasca interna al di sotto dell’orlo di un bacile-mortaio), il motivo è sempre realizzato con la tecnica dello stralucido. In ben tre casi il motivo è realizzato su collo e spalla di piccole olle (anche definite “bicchieri”) in bucchero, probabili vasi potori, a cui si possono aggiungere altri due esemplari con meandro a zig-zag da Rubiera (nrr. I.10a.10-11) e uno a onda da Siccomonte (nr. I.10b.32).
Il motivo del reticolo di losanghe può essere realizzato anche con la tecnica del graffito (tecnica affine allo stralucido, da cui questo discende), che come detto in premessa non è stata qui considerata; a titolo esemplificativo si cita una coppa in bucchero63 sul cui fondo esterno è graffito un reticolo di quadrati/losanghe.
Della tecnica dello stralucido si è trattato più diffusamente in altra sede64. Agli esemplari ivi citati, testimoni delle ampie connessioni che uniscono l’Etruria padana con quella settentrionale (San Rocchino, Artimino, Fiesole) e con le aree culturali atestina e di Golasecca, si possono aggiungere altre attestazioni che per motivi diversi non sono state qui censite: si tratta di due olle in impasto decorate a stralucido da Castelfranco Emilia (MO)65, non inserite perché decorate a semplici bande orizzontali, e una piccola olla/bicchiere da San Basilio (RO)66 il cui ventre è interamente campito con un fitto reticolo a stralucido; il pezzo, non censito perché si tratta di un bicchiere biconico di tradizione paleoveneta, è comunque par-ticolarmente interessante perché si trova sul percorso che dovrebbe aver portato il motivo dall’Etruria padana verso l’area atestina. La datazione di questo esemplare alla seconda metà del VI secolo, circa mezzo secolo dopo l’inizio delle attestazioni in Etruria padana, pone inoltre un importante tassello cronologico circa la probabile precoce trasmissione di motivo e tecnica in area atestina.
12. Segno a tridente Il segno a tridente, altrimenti definito anche “a freccia”, soprattutto nelle sue numerose attestazioni
realizzate a graffito (qui non censite), può assumere il valore alfabetico chi e perciò in molti casi inter-pretabile come firma/marchio di fabbrica67. Il carattere ornamentale degli esemplari qui presi in esame è invece chiarito dalla tecnica, dalle forme e – soprattutto – dalla posizione nel quale è dipinto (solo un caso è noto a stampiglia, nr. I.12.9). Inoltre, degli undici casi qui censiti, ben sei (nrr. I.12.1, 3,5-8) si riferiscono ad oinochoai sulle quali il motivo è dipinto presso il becco versatoio e spesso pende da questo. Questi esemplari sono particolarmente interessanti per la stretta connessione fra motivo e supporto in ra-gione della quale la decorazione assume un particolare significato. Motivi come il tridente, le volute (cfr. nrr. I.8b.4; 8b.6) e l’occhio apotropaico (nr. III.1, 1-5) dipinti presso la bocca dovrebbero infatti essere ricondotti al fatto di essere collocati nel punto dal quale fluisce il vino e creare quindi una sottolineatura del legame (stretto e di vero e proprio contatto fisico) con la sacralità del liquido e della cerimonia nella quale veniva consumato (vedi tavola sinottica in Fig. 8).
Il tridente dipinto sulle brocche costituisce un gruppo omogeneo in cui si nota appunto una sorta di interdipendenza fra ornato e supporto, mentre le altre attestazioni sono più eterogenee e possono in qualche modo essere spiegate in quanto eccezioni. Alcuni di essi infatti si avvicinano al motivo, ma sono diversi: fra questi il piatto di Casale (nr. I.12.3) non è un vero e proprio tridente, avendo quattro tratti verticali e non tre; il tridente interamente campito a pittura da Baggiovara (nr. I.12.2) potrebbe essere
63 GOVI 1994, tav. XIIa, 95.64 SANTOCCHINI GERG 2009, pp. 232-235 e ID. 2012, pp. 242-243.65 BUOITE, ZAMBONI 2008, fig. 6, 284; fig. 7, 293; fig. 9, 440; qui, a p. 80, si dice che la decorazione a stralucido è nota an-
che sulle ceramiche d’impasto dell’Etruria propria (cfr. TAMBURINI 1987, pp. 94-95), senza tuttavia confronti per finalità puramente decorativa.
66 DE MIN, IACOPOZZI 1986, p. 174, n. 3; tav. I, 3.67 Un ampio repertorio di questi, con valore quasi certamente alfabetico perché graffito sul fondo esterno del vasellame, è
documentato in SASSATELLI 1994a.
04 Appendice.indd 511 24/01/14 18.00
512
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
interpretato anche come stilizzazione di una palmetta; l’esemplare da Siccomonte (nr. I.12.10) è l’unico stampigliato e potrebbe dunque trarre origine dalla tradizione decorativa delle stampigliature e, infine, l’esemplare dipinto su un bacile-mortaio dal Forcello (nr. I.12.11; vedi Tav. I.2a), oltre ad essere l’atte-stazione probabilmente più tarda, è più complesso, essendo arricchito da quattro punti dipinti ai lati dei tratti. Un bell’esemplare di motivo a tridente, con le estremità che si evolvono in volute, proviene da Scarperia nel Mugello68, a segnare le forti connessioni della ceramica fine dipinta fra Etruria padana e Etruria settentrionale69.
Forse non del tutto casuale è la cronologia di questi esemplari, tutti realizzati in ceramica depurata: il primo è quello della Certosa di Bologna (nr. I.12.1) di fine VI – prima metà del V sec. a.C., cui segue l’esemplare del Modenese (nr. I.12.2), databile fra metà VI e metà V secolo, e quelli del Reggiano (tutti di V secolo), per finire con il mortaio dal Forcello (nr. I.12.11), riferibile alla seconda metà dello stesso V sec. a.C. Questa sequenza non rispecchia necessariamente un percorso evolutivo sistematico, anche se l’ipotesi è suggestiva.
13. Ruota raggiata Il motivo della ruota è piuttosto comune nella versione realizzata a graffito70, mentre ve n’è un solo
esemplare dipinto (nr. I.13.3), una ruota a otto raggi dipinta sul fondo interno di una coppa in ceramica depurata. Negli altri due casi si tratta della stessa stampiglia ripetuta in almeno due file orizzontali su collo e spalla di due piccole olle (anche definite “bicchieri”) in ceramica d’impasto. Queste stampiglie, che potrebbero rappresentare anche delle rosette stilizzate, sono probabilmente eredi della tradizione delle stampiglie villanoviane, nelle quali il motivo delle croce iscritta in un cerchio era assai comune e univa i due comparti etruschi a cavallo dell’Appennino71.
14. Altro motivo geometrico Si tratta di un unica attestazione di un motivo che ricorda un ferro di cavallo, dipinto fra due bande
orizzontali sulla spalla di una brocca in ceramica depurata da Casale di Rivalta nel Reggiano (Tav. I, nr. 14.1), che non trova altri confronti.
II. MotIvI fItoMorfI
1. Palmetta72 La palmetta è il motivo fitomorfo più diffuso d’Etruria padana, soprattutto se si considerano le realiz-
zazioni su supporti diversi dalla ceramica. Essa è attestata in una grande varietà di forme e stili diversi e, ai fini della tipologizzazione, i riferimenti nella letteratura d’area etrusca non offrono definizioni più precise rispetto a generici “di tipo ionico”, “attico”, “ceretano” e simili. Per questo motivo ci si è attenuti qui ad una classificazione quanto possibile neutra e descrittiva.
Questo ornato vegetale è attestato sia in contesti sepolcrali, e dunque indice della sua valenza anche fu-neraria, sia in contesti abitativi. Pur con una prevalenza (41%) degli esemplari provenienti da sepolcreti,
68 PALERMO 2003, p. 321, n. 1.69 Per le connessioni fra produzione ceramica fine dipinta padana e quella dell’agro fiesolano, si rimanda a SANTOCCHINI GERG
2012.70 Valga a titolo di esempio la ruota a otto raggi graffita sul fondo esterno di una coppa in depurata da Marzabotto (GOVI
1994, p. 234, tav. LXIV, n. 85).71 Cfr. SANTOCCHINI GERG 2012, in particolare Tav 5.72 La palmetta è un motivo decorativo onnipresente presso tutte le culture mediterranee fin dal III millennio a.C., con la con-
venzione iconografica di rappresentarla appiattita in visione bidimensionale. L’origine è prettamente orientale e giunge in Etruria attraverso la mediazione greca e levantina. Il suo frutto, il dattero, energizzante fondamentale in una dieta povera di zuccheri è anche ingrediente principale per la produzione di varie bevande alcoliche. In questo senso, assume valenze di alterità tipiche di tutte le sostanze inebrianti. La palma si carica così di una serie di significati simbolici relativi tanto al mondo dei vivi che a quello dei morti. Nella mitologia greca, la palma è collegata sia alla nascita di Apollo che al mito della risurrezione della Fenice (da cui il nome scientifico Phoenix dactylifera), venerata già a Creta come po-ni-ke, essa viene menzionata da Erodoto (Storie, II, 73) e Plinio (Naturalis historia, XIII, 42), che le accompagna una palma, legata dallo stesso destino di morte e rinascita spontanea.
04 Appendice.indd 512 24/01/14 18.00
Appendice
513
sono attestati anche contesti insediativi (24%) e aree sacre (17,5%), mentre per la restante parte (17,5%) il contesto non è indicato. La principale testimonianza d’ambito funerario è offerta da varie stele sepol-crali, soprattutto quando raffigurano una singola grande palmetta nel registro principale73. Per quanto riguarda invece il mondo dei vivi la palma può assumere un valore simbolico in quanto emblema della vittoria; tuttavia – anche se l’originario contenuto semantico della palma si era probabilmente perduto (la pianta non cresceva in Italia centro-settentrionale) – se in contesto funerario la palmetta mantiene un proprio valore ideologico e simbolico pregnante, negli altri casi, ovvero per produzioni di minor pregio e d’uso quotidiano, è più verosimile immaginare un intento meramente decorativo.
Per quanto riguarda la cronologia la maggior parte delle attestazioni (84%) riguarda il V secolo, a fronte di tre esemplari (16%) di VI sec. a.C. Questo dato tende ad escludere una preminente derivazione dalla tradizione villanoviana e confermerebbe l’avvento di modelli greci, diretti o mediati dall’Etruria propria, come prova anche un esemplare dipinto da Casale di Rivalta (nr. 1a.3), che si rifà alla più cano-nica versione attica.
La versione più comune in Etruria padana è la palmetta a cinque foglie arrotondate, solitamente circo-scritta in un archetto desinente a volute (nnr. II.1a-d), sostituite da due cerchielli nell’esemplare dal Forcello (Tav. II, nr. 1d.1). Molto interessanti per le intime connessioni con l’Etruria settentrionale, ed in particolare con l’agro fiesolano, sono le palmette “destrutturate”, sia l’esemplare con foglie scomposte rese da motivi guttiformi di Marzabotto (Tav. II, nr. 1g.1) che trova confronti a Fiesole, Artimino e nel Mugello74, sia la ver-sione a quattro volute testimoniata da due esemplari di Campo Servirola (nrr. II.1h.2-3) e da uno di Casale di Rivalta (nr. II.1h.1) per il quale si può proporre identità di punzone con uno degli esemplari da Servirola (nr. II.1h.3). Nelle quattro stampiglie con palmetta stilizzata il motivo è appena abbozzato, ma difficilmente interpretabile in altro modo. L’esemplare più dubbio, e che non trova confronti, è la coppa da Covignano (Tav. II, nr. 1i.4b), sulla quale sono impressi due diversi motivi: entrambi presentano un crescente lunare orizzontale dal quale sorgono una probabile palmetta stilizzata e un motivo semicircolare.
Le palmette a stampiglie radiali sul fondo di coppe, nel momento in cui diviene motivo principale e pressoché esclusivo della decorazione della ceramica attica a vernice nera (cfr. produzione delle petit estam-pilles), influisce sulle produzioni etrusche più tarde e infatti la troviamo solamente sulle produzioni di ceramica grigia di Spina75 e su due attestazioni sporadiche dalla vicina Voghiera76 e dal Castellazzo della Garolda (MN)77. La palmetta fiammata, motivo tipico delle produzioni ellenistiche e romane (come nella ceramica a vernice nera suddipinta), è anche in questo caso attestata nella sola ceramica grigia spinetica78; essa è tuttavia nota anche in una redazione “arcaica” dal sepolcreto Arnoaldi di Bologna (Tav. II, nr. 1e.1), databile alla seconda metà del V secolo.
73 A titolo esemplificativo si possono citare cinque stele del sepolcreto Arnoaldi, Tombe 4, 67, 110, 120 e 142, (MACELLARI 2002, tavv. 47, 83, 154, 176, 214), e, per gli influssi, una bella stele da Artimino, della classe delle “pietre fiesolane”, databile tra fine VI-inizi V a.C. (Museo di Artimino, Sala 1, inv. nr. 13698). Le stele felsinee con il registro principale raffigurante una grande palmetta sono in tutto 16 (GOVI 2009, nota 25), interpretata come messaggio salvifico di stampo dionisiaco in relazione alla rinascita dopo la morte (Ibidem, p. 458).
74 Per gli esemplari padani (con altre attestazioni di VII-prima metà VI sec.) ed i corrispondenti confronti d’Etruria setten-trionale, si rimanda a SANTOCCHINI GERG 2012, pp. 232-234 e Tav. 3. Agli esemplari ivi considerati, si può aggiungere un cilindro (probabile parte di rocchetto) in bucchero da Artimino (esposto nel locale museo, inv. nr. 105870) sul quale sono ripetute più volte due stampiglie, una a motivo zoomorfo (leone) e l’altra con archetto a volute convergenti e motivo guttiforme fra le volute. Questo esemplare, datato da metà VII a tutto il VI sec. a.C., richiama puntualmente l’esemplare di Marzabotto (nr. 1g.1) e un fittile di Via Montebello di Bologna (MORIGI GOVI 1969, p. 32, fig. 15), databile al Villano-viano IVB. Nella vetrina 1 del Museo Civico di Fiesole sono esposti altri due frammenti in bucchero con stampiglie simili. Dall’Etruria padana, su possibile impulso di Bologna e dei suoi stretti legami con il mondo atestino, il motivo potrebbe essere giunto a Este, dove è attestato da un’impressione su un’olla atestina (v. rivista Archeo nr. 240, p. 68). Circa l’origine di queste particolari realizzazioni, una linea di ricerca da approfondire conduce ancora una volta verso il territorio chiusino, dove motivi simili trovano frequente realizzazione nella tecnica dello stampo a cilindretto su bucchero, con il motivo detto “fregio fitomorfo stilizzato a S contrapposte con petalo centrale” (v. MARTELLI 2009, p. 139, Fig. 118.b.6-8).
75 v. PATITUCCI UGGERI 1984, figg. 10-11. Le decorazioni radiali con palmette sulla ceramica grigia di Spina non sono state ricomprese in questo repertorio, perché ritenute un fenomeno tardo e circoscritto, non avente relazioni con la tradizione decorativa padana, ma solo con le tarde produzioni a vernice nera. Per la ceramica grigia in generale si rimanda al capitolo a cura di G. Morpurgo in questo stesso volume.
76 PATITUCCI UGGERI 1974, fig. 3, n. 8.77 CASINI, FRONTINI 1989, p. 156, tav. IV, n. 12.78 PATITUCCI UGGERI 1984, p. 168, tav. I, b.
04 Appendice.indd 513 24/01/14 18.00
514
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
La palmetta è, come sopra accennato, il motivo decorativo più comune in Etruria padana anche fuori dal vasellame ceramico, come testimoniato dall’abbondanza di attestazioni relative alle decorazioni ar-chitettoniche79. Il motivo è inoltre attestato anche su oggetti in bronzo, come specchi, ciste e situle80, e su stele funerarie di Marzabotto, Crespellano, San Varano e su tredici stele felsinee. Queste ultime sono particolarmente interessanti perché le palmette sono realizzate in versione doppia contrapposta, sia sulla cornice (in sette casi) che in posizione di maggior prestigio, sulla lunetta (in sei casi), una redazione che richiama fortemente la ceramica attica a f.r. (ed i crateri in particolare), come era già stato messo in evi-denza da E. Govi81.
2. Ventaglietto Il motivo del ventaglietto è stato inserito in questa sezione in quanto stilizzazione di un ramo di pal-
ma; per il suo possibile significato si rimanda pertanto a quanto detto per la palmetta. Il ventaglietto, nelle sue versioni aperte e chiuse, orizzontali e verticali, realizzato a minuti puntini incisi, è il motivo decorativo principe delle produzioni in bucchero sottile dell’Etruria meridionale fin dal pieno VII secolo e sino alla fine delle produzioni di qualità, intorno alla metà del VI sec. a.C. Il motivo è molto meno presente nelle produzioni in bucchero pesante dell’Etruria interna, che si dedica a decorazioni più com-plesse realizzate a rilievo ed a cilindretto. Considerato che tanta parte degli stimoli decorativi dell’Etru-ria padana provengono dall’Etruria interna e settentrionale, è probabilmente per questo motivo che il ventaglietto qui sia quasi assente. Infatti le importazioni in Etruria padana dall’Etruria meridionale sono estremamente rare, e in età Villanoviana le botteghe padane si dedicano principalmente ai motivi geo-metrici incisi ed alle stampiglie.
Le uniche quattro attestazioni del motivo in Etruria padana si riferiscono tutte al territorio reggiano, a frammenti di parete in bucchero di VI secolo decorati a ventaglietti verticali. Si tratta di realizzazio-ni piuttosto corsive nelle quali è evidente l’imperizia dell’imitatore, tranne nel caso del frammento da Rubiera (Tav. II, nr. II.2.3), probabilmente riferibile ad un kantharos di cui si percepisce la carenatura a spigolo vivo, databile fra fine VII e prima metà del secolo successivo82, subito al di sotto del quale sono visibili due (e parte di un terzo) ventaglietti verticali aperti di buona qualità esecutiva, tanto da far pen-sare che possa trattarsi di un’importazione dall’Etruria tirrenica.
Il fatto che le uniche attestazioni provengano da questo territorio e che dei quattro frammenti l’unica forma ipotizzabile sia proprio un kantharos, conferma che il modello di riferimento per il bucchero reg-giano di VI secolo sia da cercare più nel bucchero tirrenico che nella tradizione locale, dove il classico kantharos (come ad esempio il tipo 3e Rasmussen) è una forma praticamente assente. Inoltre, questo dato si inserisce in quegli indizi che fanno ipotizzare l’esistenza di una “via secondaria” di collegamento fra Etruria padana e Etruria settentrionale costiera. Proprio in base al frammento di Rubiera e ad alcune stampiglie dell’Emilia occidentale, G. Colonna83 aveva ipotizzato l’esistenza di contatti diretti, e non mediati da Bologna, fra il Reggiano e l’Etruria settentrionale84.
79 Cfr. con i dati offerti dalla realtà urbana meglio nota, Marzabotto, nella quale si trovano decorazioni a palmette circoscritte a tre e cinque foglie su 109 antefisse, 12 lastre architettoniche, 3 tegole di gronda, 2 rivestimenti di colonna e un puteale.
80 Si tratta di cinque specchi bolognesi e uno di Marzabotto; quattro piedini di situla o cista da Bologna, un attacco di manico di situla di Verucchio e una cista di Marzabotto.
81 GOVI, SASSATELLI 2004, p. 253.82 Il frammento viene datato da C. Lasagna Patroncini (LASAGNA PATRONCINI 1990, p. 152) al tardo VII secolo, anche se L.
Malnati (MALNATI 1985d, p. 182), richiama a confronto per il supporto la forma delle scodelle carenate di VI sec. a.C.83 GAMBARI, COLONNA 1986, p. 155.84 La questione è stata poi ripresa da L. Malnati, A. Maggiani e G. Sassatelli; si rimanda a SANTOCCHINI GERG 2012, p. 248 e
nota 104, per i rimandi bibliografici relativi e per un approfondimento della problematica. Per i tre esemplari più corsivi un buon confronto per la realizzazione del motivo è richiamabile con un olla in bucchero da S. Rocchino Massarosa (MAGGIANI 1990, p. 82, lett. L, fig. 34, L) databile a fine VII-VI secolo; questo esemplare sembra segnare proprio questa via di collega-mento del Reggiano con l’Etruria mineraria, a sua volta in relazione con l’Etruria meridionale costiera, dove il motivo deco-rativo ha origine. Più difficile, come detto sopra, istituire un collegamento diretto con le poche attestazioni del ventaglietto in Etruria interna, come ad esempio gli esemplari su bucchero dallo scavo del Petriolo (v. MARTELLI 2009, p. 136), concentrati fra la seconda metà del VII e i primi decenni del VI sec. a.C.
04 Appendice.indd 514 24/01/14 18.00
Appendice
515
3. Rosetta Come la palmetta, anche la rosetta è un motivo universale, adottato in tutto il bacino mediterraneo.
Tuttavia quasi ovunque il suo significato iconologico è limitato e solitamente la rosetta è un mero motivo riempitivo. Come tale è noto soprattutto nelle produzioni di Corinto e nelle relative imitazioni etrusche, fra cui due interi gruppi di ceramica etrusco-corinzia figurata, il Ciclo dei Rosoni e il Gruppo delle Rosette a Punti, prendono il nome da tale riempitivo. Anche in Etruria padana il motivo è utilizzato soprattutto come riempitivo, anche se la sua dipendenza dalle suddette produzioni non è dimostrabile e l’origine appare assai sfuggente, essendo attestata almeno fin dall’VIII secolo85, realizzata conseguente-mente soprattutto a stampiglia.
In Etruria padana, fra VI e IV secolo, il motivo è limitato al vasellame ceramico86 e sono note versioni canoniche (a petali sia arrotondati che triangolari), puntinate e stilizzate (a stella). Le versioni canoniche sono tutte rese a stampiglia87 e, conseguentemente, la maggior parte sono riferibili al VI secolo, mentre le rosette puntinate sono realizzate anche a pittura su ceramica depurata (nrr. II.3b.4-6). Particolarmente interessanti sono due versioni stampigliate a quattro petali: in realtà il primo esemplare si riferisce ad una stampiglia a tre motivi ellittici (nr. II.3c.1), ma la visione autoptica permette di cogliere i dettagli interni e l’abbozzo di un quarto petalo; la versione con quattro petali contrapposti è invece attestata da un esemplare dall’insediamento di Siccomonte (Tav. II, nr. 3c.2), che trova un confronto puntuale a San Rocchino di Massarosa88. Le versioni stilizzate sono praticamente delle rosette a stella, in particolare l’esemplare di San Claudio (Tav. II, nr. 3d.2). Altri motivi a stella (cui J. Heurgon89 attribuisce valore apotropaico), soprattutto a cinque punte, sono realizzate con la tecnica del graffito sul fondo esterno del vasellame, mentre una rosetta a stella, simile alle realizzazioni a compasso, è incisa sulla punta di cippi funerari in marmo di Marzabotto90.
4. Fiore di lotoRispetto alla lunga tradizione e alle più varie testimonianze d’Etruria propria, in Etruria padana le
attestazioni su ceramica sono poche, ma comunque significative e cariche di suggestioni. Sono tutte rea-lizzazioni a stampiglia, anche se la maggior parte delle attestazioni riguarda la ceramica depurata (78%), di conseguenza sono maggiori anche gli esemplari riferibili al V secolo (5 attestazioni), rispetto ad altri tre esemplari a cavallo fra VI e V sec. e un solo esemplare databile fra fine VII e fine VI sec. (Tav. II, nr. 4c.1). Data la cronologia e la tipologia attestata sulle decorazioni architettoniche91, il modello parrebbe da ricercar-si negli anthémia di tradizione attica e nelle loro imitazioni etrusche. La valenza escatologica del fiore di loto è confermata dalle attestazioni su monumenti sepolcrali92 e su alcuni bronzi di corredo funerario93.
85 Per una panoramica di attestazioni, anche di età Villanoviana, con confronti con l’Etruria settentrionale, si rimanda a SANTOCCHINI GERG 2012, p. 235 e Tav. 4.
86 Le uniche tre realizzazioni su bronzo sono riferibili a due coperchi dalla necropoli della Galassina di Castelvetro (PIZZIRANI 2009, tav. 5, 6; tav. 9, 1), nei quali i pomelli sono interamente configurati a rosetta, e da una “paletta” metallica di Marza-botto (GOZZADINI 1865, tav. 18, n. 7) dove dal disegno ottocentesco sembra di riconoscere una rosetta di punti realizzata presso l’attacco del manico.
87 Nel caso delle due attestazioni di Marzabotto (nrr. II.3a.1-2) e di Imola (nr. II.3a.9) non si tratta di stampiglie vere e proprie: qui il motivo impresso occupa l’intero fondo interno di kylikes con umbone centrale rilevato, che forma il bottone centrale della rosetta, attorno al quale è impressa una baccellatura che forma i relativi petali.
88 MAGGIANI 1990, p. 85, fig. 35, nn. 29-30.89 HEURGON 1973, p. 555-556.90 SASSATELLI 1977, p. 128 e nota 89.91 Cfr. il puteale con ippocampi e le tegole di gronda di Marzabotto; a titolo esemplificativo, valga una tegola di gronda
(SCHIFONE 1967, p. 439, n. 4) con anthémion a loto e palmetta intrecciati, che sono decorazioni accessorie comuni nella ce-ramica attica figurata e si trovano anche su hydriai ceretane di fine VI secolo. Non è chiaro se il modello per le decorazioni architettoniche di Marzabotto debbano essere ricercate in queste produzioni o se siano il risultato di influssi chiusini, dove è attestata una tegola che offre un confronto puntuale (IOZZO, GALLI 2003, p. 53, fig. 71), anche se quest’ultima ipotesi pare più probabile. Altro esempio di decorazione architettonica con fiore di loto canonico è offerto da un’antefissa di Adria o suo territorio (M.G. BERTANI, tesi di Dottorato, L’architettura domestica dell’Etruria padana, Bologna A.A. 1992/1993).
92 Come, ad esempio, gli archetti intrecciati desinenti a fiori di loto che delimitano i registri principali di entrambi i noti Cippi di Rubiera (v. MALNATI 1989a, con bibliografia precedente). Questo motivo è attestato anche a Bologna, sulla stele felsinea nr. 168 della necropoli della Certosa (GOVI 1998, fig. p. 88), con anthémion a fiori di loto e palmette intrecciati. I due esemplari, nonostante lo scarto cronologico che li divide, mostrano come il fiore di loto sia in molti casi associato a monumenti funerari, confermando la valenza escatologica che tale fiore spesso assume. Fiori di loto singoli, in versione canonica, sono anche su un cippo a pigna di Marzabotto (SASSATELLI 1977, p. 109 e fig. 7).
93 Come, ad esempio, la situla della Tomba 231 della necropoli della Certosa (JURGEIT 1986, tav. XXVII, d), con fregio di
04 Appendice.indd 515 24/01/14 18.00
516
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
Particolarmente interessanti sono una serie di stampiglie a fiore di loto che fanno parte della “Serie A” delle stampiglie di Spina classificate da S. Patitucci Uggeri94, che sono attestate solo nei nuovi centri padani fondati – o rifondati – verso la fine del VI secolo, ovvero a Spina, Marzabotto e Forcello di Bagnolo San Vito. Queste stampiglie, che in alcuni casi mostrano identità di punzone, mostrano un interessante percorso geografico e cronologico, già analizzato in altra sede95. Più canoniche sono le due stampiglie da Baggiovara (nrr. II.4a.1-2), la cui iconografia rimanda alla forma più comune con bocciuolo triangolare sorgente da due petali, forma che ritroviamo più di frequente nelle incisioni su cippi e stele funerarie. L’esemplare di Bologna (Tav. II, nr. 4c.1) è il più antico e, nonostante la forte stilizzazione, viene qui in-terpretato come fiore di loto e mostra una particolarità, il fatto di sorgere da un cerchiello doppio, che lo accomuna ad una palmetta dal Forcello (Tav. II, nr. 1d.1).
5. EderaPianta sacra a Dioniso, di cui cinge il capo, veniva indossata dai partecipanti ai cortei bacchici e nel
corso del V secolo, quando gli attributi della divinità assumono contorni misterici, ne aumenta anche la valenza funeraria. In questo senso vanno lette la maggior parte delle attestazioni d’Etruria padana, che provengono infatti da contesti funerari: si tratta di sei cornici di stele felsinee decorate a foglie singole o tralci d’edera96, un cippo dal sepolcreto Arnoaldi di Bologna97 (decorato sulla sommità con una ghirlanda incisa, probabile riferimento alle vere ghirlande d’edera che si suppone venissero appese ai segnacoli fune-rari durante le cerimonie rituali in onore del defunto98), una stele di Crespellano (BO)99 e alcuni oggetti in bronzo di corredo funerario100.
Tutte queste attestazioni non si riferiscono a prodotti ceramici, e dunque non sono stati inseriti in questo catalogo, che conta invece un solo esemplare, dipinto su una Grande Forma fittile non determi-nabile, che potrebbe riferirsi ad un dolio o grande olla, proveniente dai Vecchi Scavi di Marzabotto (Tav. II, nr. 5.1). A questo se ne potrebbe forse aggiungere un secondo: un frammento di parete di Grande Forma d’impasto grezzo (inedito, Museo Nazionale Etrusco “P. Aria”, sala III, vetrina 13, inv. nr. 1316), la cui decorazione evanide è di difficile lettura: sembra di riconoscervi alcuni tralci con grappoli d’uva, che potrebbero altrimenti essere letti anche come corimbi d’edera. Un buon esempio di tralci d’edera con foglie e corimbi, ed anche un tralcio a foglie di vite e grappoli d’uva, che permettono di cogliere le dif-ferenze iconografiche fra i due, è inciso su entrambe le situle bronzee della Tomba Grande del sepolcreto dei Giardini Margherita di Bologna101.
L’estrema sporadicità di questo motivo nelle decorazioni ceramiche d’Etruria padana marca una forte divergenza rispetto all’Etruria tirrenica, dove l’edera è molto diffusa in tutte le botteghe di ceramica etrusca figurata (diventando anche eponima del Gruppo delle Foglie d’Edera) che si ispirano alla cerami-ca attica. Proprio questa ispirazione ai modelli attici dovrebbe spiegare l’assenza dal repertorio padano,
archetti intrecciati a fiori di loto e foglie d’edera; oppure due bronzi di Marzabotto, si tratta di uno specchio (GOZZADINI 1865, tav. 18, n. 12) che presso il manico mostra due volute dai lati delle quali sorgono una foglia d’edera e un fiore di loto con sferette alle estremità dei petali, che richiamano a confronto un altro bronzo di Marzabotto: un elemento bron-zeo (GOZZADINI 1865, tav. 18, n. 5) interpretato come cimasa di candelabro a forma di giglio (MUFFATTI 1969, p. 267, n. 491), che qui si propone di leggere come fiore di loto. Si tratta di due elementi mobili e distinti che si sovrappongono perfettamente, destinati ad essere collegati mediante una catenella; si potrebbe proporre, in via del tutto preliminare, di interpretarli come elementi mobili di un coperchio di incensiere, per la similitudine con gli incensieri con fiori di loto di VII secolo da Vetulonia, Casale Marittimo e Marsiliana (v. CELUZZA, CIANFERONI 2010, cat. nrr. 1.65, 2.1, 3.34, 4.9).
94 PATITUCCI UGGERI 1983, p. 133 ss.95 SANTOCCHINI GERG 2012, p. 234 e Tav. 3, nn. 22-24.96 V. GOVI, SASSATELLI 2004.97 MACELLARI 2002, p. 52, tav. 42.98 Cfr. E. Govi in GOVI, SASSATELLI 2004, p. 250. 99 SASSATELLI 1989, p. 68, figg. 24-25.100 Due situle dal sepolcreto dei Giardini Margherita (JURGEIT 1986, tav. XVIII, a-c); due specchi dai Vecchi Scavi di Mar-
zabotto e varie appliques degli attacchi di manico di situle nelle quali una foglia singola sorge dalle ampie volute rap-presentate dai fori per l’immanicatura. Ve ne sono attestazioni a Marzabotto, Galassina di Castelvetro, Campo Servirola e Bologna; nel commento a quest’ultimo R. Macellari (MACELLARI 2002, p. 278) osserva che questi attacchi di manico venivano applicati in genere a situle stamnoidi del tipo “C” della classificazione di M.V. Giuliani Pomes (GIULIANI POMES 1957, pp. 39-54). G. Caramella (CARAMELLA 1995, p. 121) nota come il centro di produzione della variante C1 dovrebbe essere individuato in un’officina dell’Etruria centrale o padana attiva nel V sec.
101 JURGEIT 1986, tav. XVIII, a-c.
04 Appendice.indd 516 24/01/14 18.00
Appendice
517
piuttosto restio – come già rilevato – all’accoglimento di tali modelli, in questo caso impermeabile anche alle sollecitazioni del territorio chiusino102, altrimenti piuttosto ricco di assonanze col territorio padano.
Le residue attestazioni padane si limitano ad alcuni fittili di Marzabotto e si riferiscono al puteale con ippocampi103, ad un rivestimento di colonna104 e ad una serie di tredici lastre architettoniche inedite dallo scavo del tempio urbano di Marzabotto, con fregi a rilievo formati da foglie singole legate da archetti e alternate a bocciuoli (interpretabili anche come ghiande), sovrapposto ad un altro fregio a palmette circo-scritte a tre foglie. In questi casi non pare doversi ricollegare al valore sacro che la pianta può assumere, ma ad un semplice intento decorativo.
Rispetto all’edera, sorprende l’estrema rarità delle rappresentazioni della vite o dell’uva, altro ovvio ri-ferimento a Dioniso, mai attestata sulle decorazioni ceramiche e presente solo in foglia singola o in tralcio sulla cornice esterna di sei stele felsinee e, in alternativa al tralcio d’edera, nel frammento di Grande For-ma di cui sopra. Questa assenza rimarca la parziale, ma forte, indipendenza dagli influssi della ceramica attica sul patrimonio decorativo padano.
6. Alberello / ramo seccoSono stati qui riuniti due motivi con origini assai diverse, ma che nelle realizzazioni in Etruria pa-
dana possono confondersi. L’origine dell’alberello dovrebbe essere il risultato della banalizzazione della palmetta e potrebbe derivare da influssi dal territorio chiusino, come mostra una serie di palmette da Chianciano Terme (Fig. 6).
Come già notato da E. Govi105, l’alberello stilizzato compare, oltre che negli esemplari di Bologna (nrr. II.6.1-2), anche sulla ceramica chiusina con fregi vegetali106, nel Gruppo di Orvieto107 e su due brocche dall’agro fiesolano108. Il territorio chiusino è particolarmente ricco di ornati vegetali e geometrici, soprat-tutto quando (fra il 510 e il 470 a.C. circa) la ceramica grigia o bruna sostituisce pressoché completa-mente la produzione in bucchero nero. Il territorio intorno a Chiusi (soprattutto Chianciano e Sarteano) presenta un repertorio e una sintassi decorativa molto vivace e innovativa nell’affrontare questa classe ceramica, forse più di Chiusi stessa (probabilmente più legata alla tradizione), e si candida ad essere uno dei centri deputati alla trasmissione di modelli in Etruria padana109. Oltre all’alberello ci sono anche altri
102 Dove l’edera, in tralci o foglie singole, diviene uno dei motivi decorativi principali (in alcuni casi anche unico) della cera-mica fine dipinta. Si veda PAOLUCCI 1999-2000; a titolo esemplificativo si veda anche MINETTI, RASTRELLI 2001, con atte-stazioni sia in versione naturalistica con foglia cuoriforme e corimbi a rosetta puntinata (n. 28.1), sia in versione stilizzata (nn. 30.3-4, 22-23).
103 DURANTE, GERVASINI 1987, p. 321, fig. 213, 8.104 SCHIFONE 1967, tav. LXVIII, a-b.105 GOVI 2003, p. 68. 106 PAOLUCCI 1999-2000, fig. 33, n. 68. A Chiusi (scavo del Petriolo) compaiono inoltre esemplari di alberello incisi sia su
bucchero (GASTALDI 2009, Fig. 118.b.4) che su ceramica grezza (Ibidem, Fig. 215).107 CVA Göttingen 2, D3681, Hu 574a, nn. 3-4. 108 DONATI 1987b, p. 102, n. 81, che cita altri confronti dal Museo Civico di Fiesole a dall’Impruneta (FI).109 Anche a Roselle (DONATI 1994, fig. 31, n. 351) è attestato un alberello, stampigliato sul fondo di una coppa in bucchero nero
di VI a.C. Questa attestazione richiama i collegamenti con l’Etruria settentrionale per i quali si rimanda a SANTOCCHINI GERG 2012.
6. Ornati vegetali da Chianciano Terme (rielaborazione da PAOLUCCI 1999-2000, fig. 32, nn. 6 ,1, 5; fig. 33, n. 68)
04 Appendice.indd 517 24/01/14 18.00
518
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
temi figurativi che possono trarre origine dal territorio chiusino: G. Paolucci110 ne presenta un repertorio di settanta motivi, fra i quali varie palmette (anche alcune con accenno precoce di fiammatura), edera, volute e spirali varie, meandri e motivi angoliformi.
Motivo assimilabile all’alberello, ma che appare già in forma più simile al ramo secco, è quello dipinto sulla Grande Forma di Marzabotto (nr. II.6.3). L’origine di questo tema è probabilmente legato a tutt’al-tra tradizione, ovvero quella di incidere il motivo su bronzo con valore numerale/ponderale, l’aes signatum delle fonti111. Il ramo secco compare piuttosto spesso graffito sulla ceramica, anche d’uso quotidiano, ed in qualche caso112 si può ipotizzare che oltre al valore funzionale si annetta un intento decorativo.
Vi sono infine casi nei quali una possibile versione del ramo secco viene realizzata a stampiglia: si tratta di tre coppe emisferiche con impressioni realizzate entro cartiglio guttiforme, che tuttavia sono state inserite fra i motivi a foglia stilizzata (nrr. II.7.1-2, 4) poiché il cartiglio ha forma di foglia e il ramo secco ricorda le sue nervature.
7. Foglia stilizzataCome detto sopra, tre di queste stampiglie potrebbero essere considerate anche come realizzazione a
stampiglia del motivo del ramo secco (nrr. II.7.1-2, 4). Negli altri tre casi il cartiglio è di forma ellittica non schiacciata ad una delle estremità e la realizzazione dei motivi interni a linee parallele (possibile tentativo di resa della nervatura delle foglie) è geometrica e molto schematica, tanto che vi si potrebbero leggere anche altri motivi, forse semplicemente geometrici113.
8. Altro motivo fitomorfoSi tratta di due frammenti di parete di forma non identificabile in bucchero con parte di una deco-
razione a rilievo a motivi sinuosi, forse parte di volute di un motivo fitomorfo più complesso, ma non meglio definibile.
III. MotIvI fIguratI
A. AntropomorfiI motivi antropomorfi sono attestati nel comparto padano solo realizzati a stampiglia o come elementi
plastici a rilievo da applicare al vasellame ceramico. La figura umana è uno dei motivi meno frequenti nel-le stampiglie etrusche, anche se in Etruria padana è il motivo figurato più attestato. Ai tre esemplari qui censiti, se ne potrebbe aggiungere un quarto, proveniente dallo Stradello della Certosa di Bologna114, che rappresenta un oplita con panoplia completa incedente verso destra in knielauf, stampigliato più volte su un
110 PAOLUCCI 1999-2000, figg. 32-33.111 Cfr. GOVI 1994, p. 236; tre attestazioni di Marzabotto (tav. LIII, nn. 42, 92, 290) con ulteriori confronti e rimandi biblio-
grafici. La tradizioni di marchiare la ceramica con graffiti a ramo secco perdura fino alla piena età romana (cfr. esemplari dal Modenese in Modena 2009, p. 117, fig. 269, 1; fig. 478, 2; e dal Reggiano, DAMIANI et alii 1992, tav. VIII, 83). Sull’aes signatum, più in generale, si veda anche NERI 1998.
112 A titolo esemplificativo si vedano i seguenti casi: a) Bologna (BO) – graffito, coppa (I, 1, b), depurata, 500-400 a.C. (MA-CELLARI 2002, tav. 2, 4); b) Marzabotto (MA) – graffito, brocca, grezza (DURANTE, GERVASINI 1987, p. 321, fig. 213, 8); c) Castelfranco E. (MO) – graffito, coppa emisferica (III, 1, a), depurata (BUOITE, ZAMBONI 2008, fig. 19, 914); d) Castelfranco E. (MO) – graffito, coppa emisferica (III, 1, c), depurata (BUOITE, ZAMBONI 2008, fig. 19, 947); e) S.Polo-Servirola (RE) – graffito, coppa emisferica, depurata (DAMIANI et alii 1992, tav. VIII, n. 83); f) Adria (RO) – graffito, coppa emisferica (I, 1, m), bucchero, 510-490 a.C. (DONATI, PARRINI 1999, fig. 12, 2); g) Adria (RO) – graffito, coppa, depurata, 500-450 a.C. (DONATI, PARRINI 1999, p. 588; tav. I, b). Questi esemplari sono stati scelti in quanto il motivo non compare sul fondo esterno del vasellame, ma è graffito in modo ben visibile, nella maggior parte sulla parete di coppe (anche con il motivo raddoppiato e contrapposto, lett. e, f). Particolarmente evidente l’intento decorativo del ramo secco graffito vicino alla bocca di un’oinochoe da Marzabotto (lett. b; Fig. 8, b), in posizione anomala e solitamente dedicata a motivi a forte valenza simbolica (come le volute, i tridenti e gli occhi apotropaici).
113 La stampiglia dell’esemplare da Brescello (nr. II.7.6) viene definita in PELLEGRINI, SALTINI 1992, p. 66, come motivo fito-morfo su ansa in ceramica d’impasto parzialmente depurato, si dice inoltre che è conservato al museo di Modena (n. 363). In realtà il pezzo è conservato nel museo di Reggio Emilia (piano II, vetrina “Brescello”, n. 22, bucchero), ed in effetti la visione autoptica conferma trattarsi di un’ansa di bucchero nero lucido.
114 MORIGI GOVI 1969, p. 30, fig. 8.
04 Appendice.indd 518 24/01/14 18.00
Appendice
519
vaso a diaframma in impasto, la cui datazione è stata abbassata da C. Morigi Govi115 alla metà del VI sec. a.C. L’esemplare è stato comunque precauzionalmente escluso perché sia la forma del vaso che i motivi e la sintassi decorativa (con fregi a ripetizione alternata di opliti, sfingi alate e cervi) sono riferibili alla tradizione della fase precedente. Degli esemplari qui censiti quello di Campo Servirola (Tav. III, nr. A.1b), pur essendo parziale e poco leggibile (potrebbe trattarsi anche di una rosetta mal riuscita), è tuttavia l’unico per il quale sia possibile richiamare a confronto alcuni esemplari d’Etruria settentrionale116. Le stampiglie di Spina (Tav. III, nr. A.1a, b) paiono essere realizzate con il castone della gemma di un anello; l’uso di un sigillo potreb-be suggerire la firma del vasaio, anche se la posizione ben visibile dell’impressione denuncia piuttosto un intento decorativo. È possibile che anche la particolare scena complessa della stampiglia di Baggiovara (Tav. III, nr. A.1d) risulti dall’impressione di un castone; qui, in cartiglio ellissoidale schiacciato, sono visibili due personaggi seduti affrontati che protendono le braccia verso un elemento ovoidale centrale, scena che potrebbe ricordare una originale scena di banchetto.
Il lotto più cospicuo è composto invece da applicazioni a rilievo a protome umana. Per le piccole ap-pliques in bucchero di Bologna (Tav. III, nr. A.1c.1) e Marzabotto (nr. III.A.1c.3), sempre che si tratti di produzione locale, si può richiamare a confronto la tradizione, profondamente radicata in Etruria interna, di applicare protomi umane (soprattutto muliebri) sulle produzioni in bucchero nero pesante dei territori di Orvieto e Chiusi (in particolare su brocche, presentatoi e foculi). L’esemplare spinetico (nr. III.A.1c.2), un vaso gemino fittile “a saliera”, dovrebbe invece trarre ispirazione dalla ceramica attica configurata. Tutt’altra tradizione è invece ravvisabile nelle altre due attestazioni di Marzabotto (nrr. III.A.1c.4-5), due protomi (delle quali una sicuramente femminile) di non piccole dimensioni applicate su Grandi Forme fittili. Qui il confronto immediato è con la produzione fittile di tipo architettonico, ben rappresentata a Marzabotto da otto antefisse a protome femminile dai Vecchi Scavi, due matrici per la loro produzione ed un gruppo omogeneo di sette testine fittili dai “Nuovi Scavi” degli anni 1960 nelle case della Regio IV, Insula 1117. Altrove in Etruria padana le testimonianze architettoniche non sono così comuni, anche se altre antefisse a protome femminile sono note a Spina118, Covignano119 e Forcello120.
B. ZooomorfiI motivi zoomorfi hanno una radicata tradizione padana nelle stampiglie villanoviane121, ed un attardamen-
to di questa tradizione è ravvisabile nelle stampiglie con felide da Cacciola di Scandiano (Tav. III, nr. B.1)122 e cervide, praticamente illeggibile nell’immagine edita123, da San Basilio di Ariano Polesine (Tav. III, nr. B.3). Sempre a stampiglia sono realizzati anche gli altri esemplari, tranne l’anfora dipinta da San Cesario sul Pa-
115 Ibidem, p. 30.116 Per la serie completa delle stampiglie padane e dei confronti con l’Etruria settentrionale, per i quali si ipotizza l’influsso di
modelli dipinti sulla ceramica etrusco-corinzia, si rimanda a SANTOCCHINI GERG 2012 e, per alcuni interessanti esemplari del Mugello editi successivamente, a PERKINS 2012a; ID. 2012b.
117 Si tratta di parti, alcune quasi integre, di piccole teste umane comprese fra i 5,4 e i 9,7 cm. di altezza (per le quali si può ipotizzare un altezza ricostruibile di ca. 10 cm), di cui una sola edita (MANSUELLI et alii 1982, p. 65, fig. 59), con un breve cenno alle altre in SALETTI 1970, p. 281. Confronti simili rimandano a testine votive, ma in questo caso sia il luogo di rinvenimento che il fatto di essere lavorate solo nella parte anteriore (volto e capigliatura), fanno pensare piuttosto ad applicazioni per elementi architettonici (anche se sono un po’ piccole per essere parti di antefissa) e grandi vasi. Alla stessa produzione sono riconducibili un’applique a testa di sileno (SCHIFONE 1971, p. 251, n. 2) e una testa di gorgone con canini sporgenti (MANSUELLI et alii, p. 65, fig. 60), che, dettaglio inedito, ha due fori sulla sommità del capo, subito dietro al diadema, atti all’inserimento di una probabile applicazione in metallo. A parte i canini sporgenti questa gorgone non presenta altri caratteri di mostruosità, fatto che induce a pensare che possa essere stata utilizzata la matrice di un normale volto muliebre.
118 SANI 1993, p. 352, n. 880.119 COLONNA 1987, p. 37, fig. 6.120 CASINI, DE MARINIS 2005, p. 43, fig. 12.121 Per una panoramica della produzione villanoviana, e per ulteriore commento e confronti agli esemplari più tardi qui pre-
sentati, si rimanda a SANTOCCHINI GERG 2012, pp. 230-232, Tav. 2.122 Per confronti della stampiglia con leone, si rimanda all’esemplare di Artimino (v. nota 74) e ad altri dall’Etruria setten-
trionale (SANTOCCHINI GERG 2012). Particolarmente stringente il confronto con una stampiglia con leone da Poggio Colla, Vicchio (PERKINS 2012b, Fig. 7).
123 DE MIN, IACOPOZZI 1986, tav. 3, 20. In DE MIN 1987, p. 89, n. 543, si dice trattarsi di una coppa troncoconica su alto piede (cfr. tipo 9 della necropoli di Montericco), con “figurina di cervo gradiente verso sinistra”; il pezzo viene datato a fine VI-inizi V sec. a.C.
04 Appendice.indd 519 24/01/14 18.00
520
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
naro (Tav. III, nr. B.2a; Fig. 7) per la quale, rappresentando un unicum nel panorama padano, essendo l’unico caso di decorazione figurata dipinta, po-trebbe essere messa in dubbio la produzione locale124. Tuttavia sia la forma, che richiama puntualmente le anfore catalogate in questo volume (del tipo II, 6, 2, ed in particolare esemplari da Bologna, come quello inedito dalla Tomba 7 della Certosa), sia il resto della decorazione accessoria, con bande e linee dipinte, meandri ad onda su collo e spalla e linguette sulle anse, sono perfettamente inserite nella tradizione dei ceramisti locali. Come già osservato nel commento ai motivi geometrici a file di triangoli, per il segno a “S” complesso e per le volute, anche questo particolare esemplare mette in risalto la vivacità e la parziale autonomia del territorio modenese125.
La possibile lepre (Tav. III, nr. B.4) e, soprattutto, la giumenta di Spina (Tav. III, nr. B.2b) sembrano realizzati per impressione del casto-ne di una gemma, come già osservato per due dei motivi antropomorfi; mentre, come già detto per i motivi geometrici spiraliformi, la possibile chiocciola (Tav. III, nr. B.5) può essere anche interpretata come semplice spirale.
C. Motivi figurati diversiDurante gli scavi del 1969 nell’area del seminario di Covignano (Rimini), in uno strato che G. V. Gen-
tili126, sulla base di ceramica e di muretti a secco di “ facies etruscoide”, interpretò come pertinente ad un insediamento di V secolo, furono rinvenute sedici oinochoai, di cui sette in argilla giallina depurata e com-patta. Di queste, ben cinque, tutte a bocca trilobata, sono dipinte nelle cavità ai lati del lobo del becco con due occhioni, realizzati con una linea semicircolare per rendere il contorno dell’occhio e un segno circolare ad indicare la pupilla. Queste brocche sono state messe in relazione con brocche rodie di stile orientalizzante, dalle quali dipenderebbero e ne è stata proposta l’importazione dall’Etruria propria127. Nonostante il motivo degli occhioni così realizzati risulti un unicum nel repertorio locale, non è del tutto da escludere che la pro-duzione di queste brocche possa essere locale. Ciò sia per la forma, che richiama puntualmente le brocche trilobate tipo I, 2, a del catalogo di C. Mattioli, sia per il resto della decorazione a linee e fasce, meandri ad onda e rosette puntinate, perfettamente coerente con il patrimonio locale. Anche la volontà di sottolineare tramite la decorazione il becco versatoio non è estranea alla tradizione padana, come già osservato per i motivi a tridente e le volute (cfr. nr. I.8b.6) (vedi panoramica in Fig. 8); in particolare queste ultime possono essere ipoteticamente interpretate come riferimento all’occhio apotropaico. Ancora un possibile riferimento a tale motivo può essere individuato in una brocca in ceramica depurata dal Reggiano128 (con brevi tratti in pittura rossa che si dipartono a raggiera da un punto) ed in una classe di brocche a becco obliquo di Spina129,
124 L. Malnati (MALNATI 1985d, p. 145) auspicandone uno studio approfondito, la collegava ai motivi tardo orientalizzanti. Più di recente E. Govi (GOVI 2003, p. 66 e nota 99) ha osservato che l’esemplare, pur non richiamando confronti puntua-li, eredita il gusto della tarda produzione etrusca a f.n. di raffigurare teorie di animali sulla spalla delle anfore. Un’altra produzione in qualche modo avvicinabile a questa è la ristretta classe di vasi a f.n. di Adria (MAMBELLA 1983, pp. 7-19), il “Gruppo di Adria”, adesso ripreso in esame in modo esaustivo in GOVI 2012.
125 Cfr. SANTOCCHINI GERG 2009, p. 236.126 Come riferito in SCARPELLINI 1981, p. 295. 127 SCARPELLINI 1981, p. 295. L’A., facendo riferimento a ZUFFA 1969, p. 116, 118-19, richiama a confronto anche la pro-
duzione picena di brocche trilobate simili, anche queste realizzate in argilla giallastra; si tratta di brocche dipinte (senza occhioni) che in LOLLINI 1977, p. 147, tav. 115, vengono attribuite alla fase picena IV A e sono considerate imitazione di prototipi etruschi. In SCARPELLINI 1981, p. 295, sembra che la discriminante per escludere la produzione locale di queste brocche sia il colore dell’argilla; si precisa che, pur in mancanza della visione autoptica dei materiali, l’argilla in varie tona-lità giallastre compare piuttosto frequentemente nella ceramica etrusco-padana (cfr. la specifica sezione in questo volume).
128 L. Patroncini in Studi Etruschi XLIV (1976), tav. LXVI, d. L’indicazione bibliografica viene data per esteso perché è tratta da SCARPELLINI 1981, p. 295, e perchè nell’edizione citata essa non viene descritta e non è visibile nell’immagine.
129 AURIGEMMA 1965, tav. 112, a (tomba 931). Si precisa che, come per l’esemplare della nota precedente, l’indicazione della decorazione è tratta da SCARPELLINI 1981, p. 295, mentre nell’edizione originale essa non viene descritta e non è visibile nell’immagine. Per gli altri esemplari di cui è stato possibile controllare le immagine fotografiche si ringrazia il dott. Andrea Gaucci per la disponibilità con la quale ha condiviso il dato, avendo in corso una ricerca su un lotto di tombe della necropoli di Valle Trebba (Dottorato di Ricerca, XXVI Ciclo, Università di Padova, dal titolo: Necropoli etrusca di Valle Trebba (Spina). Studio di un lotto di tombe del Dosso E e indagini archeometriche sulla ceramica a vernice nera dei relativi corredi).
7. Anfora da San Cesario s/P (MALNATI 1985d, p. 147, fig. 6)
04 Appendice.indd 520 24/01/14 18.00
Appendice
521
databili al V secolo, in ceramica depurata arancio con possibili occhi campiti a tratti verticali, orizzontali o obliqui. Si puntualizza tuttavia che la visione autoptica di alcuni di questi esemplari mostra come il motivo sia reso con semplici linee geometriche e che sia percepibile solo in visione laterale, mentre in quella frontale (ideologicamente più importante) il motivo non si distingue.
Queste decorazioni assumono una forte valenza ideologica dal momento che il motivo è dipinto nel punto dal quale scorre il vino durante le cerimonie conviviali. Tale valore è richiamabile anche per la nota produzione attica di kylikes a occhioni (realizzate sia a f.n. sia a f.r.), essendo dipinte nel punto sul quale si appoggiano le labbra durante la libagione. Sul legame degli occhioni con l’ambito dionisiaco (e dunque non solo e semplicemente un valore apotropaico) si è recentemente espressa E. Govi, nel commento ad un piatto del “Gruppo di Adria” con un grande occhione dipinto al centro della vasca130. La produzione
130 GOVI 2012, cat. nr. 1, con confronti e bibliografia di riferimento (note 15-23).
8. Oinochoai: a) Covignano (SCARPELLINI 1981, n. 105.106); b) Marzabotto (DURANTE, GERVASINI 1987, p. 321, fig. 213, 8); c) Magreta (KRUTA, MALNATI, CARDARELLI 1991, p. 364, fig. 30); d) Castellarano (PELLEGRINI, SERGES, SALTINI 1992, p. 261, n. 171)
04 Appendice.indd 521 24/01/14 18.00
522
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
attica di kyathoi e coppe ad occhioni potrebbe essere perciò stata il modello di ispirazione delle oinochoai di Covignano. Non pare invece verosimile una relazione con la classe delle oinochoai trilobate fenicie, pur se diffuse soprattutto durante il V secolo (con occhioni dipinti solitamente in rosso) nello stesso modo e posizione della produzione romagnola. Nel caso invece dell’interpretazione delle oinochoai di Covignano come prodotti importati dall’Etruria tirrenica, il modello di riferimento per la decorazione ai lati della bocca ha una lunga tradizione. La prima attestazione si ha con le oinochoai etrusco-corinzie del Pittore di Feoli131, cioè con la “seconda generazione” di pittori vulcenti, nel momento nel quale più forti sono i le-gami con le botteghe greco-orientali, dove il motivo ha origine132. In seguito, l’uso di dipingere occhioni ai lati della bocca diviene più comune e si riscontra presso vari pittori di “terza generazione”133 e nelle successive produzioni di ceramica etrusca figurata134.
Un altro caso di decorazione accessoria con occhi apotropaici è identificabile in tre attacchi di ansa in bronzo di situle a doppio manico da Bologna135, S. Polo Servirola (RE)136 e Galassina di Castelvetro (MO)137, nella quale il motivo è inciso sotto ai due fori passanti per l’alloggiamento del manico. Si tratta degli stessi attacchi di ansa in precedenza analizzati per le foglie singole d’edera che si trovano al di sopra dei fori passanti.
Le onde marine correnti, dal forte valore di alterità e perciò decorazione deputata a sottolineare tale valenza in contesti funerari, si trovano in Etruria padana come ornato accessorio della maggior parte delle stele felsinee, con ben 67 attestazioni138. Dato il loro manifesto collegamento con l’acqua rappresentano anche la decorazione più comune dei puteali, ornando tutti e quattro i puteali noti di Marzabotto. Su bronzo l’onda corrente compare incisa in un solo caso, sullo specchio dal sepolcreto della Galassina di Castelvetro139.
L’unico caso di utilizzo dell’onda corrente per la decorazione ceramica, su un feeder o poppatoio dal corredo di una sepoltura infantile di Spina (Tav. III, nr. C.2), rappresenta un unicum tanto per forma tipo-logica che per motivo decorativo e dovrebbe essere stato prodotto su ispirazione della comunità ellenica della città lagunare; anche se è piuttosto riconoscibile l’etruscità del committente, intuibile dalla richie-sta di decorare il poppatoio con un motivo che assume valenza escatologica più pregnante per un Etrusco che per un Greco.
131 SZILÀGYI 1992, p. 180 ss., tav. LXXVII, b. Gli occhioni compaiono poi anche nella produzione del Pittore di Pescia Ro-mana (Ibidem, tav. LXXXVII, e) e del Pittore di Volunteer (Ibidem, tavv. XCVI, a-d; XCVII, a-b).
132 Cfr. SZILÀGYI 1998, p. 439. A parere di M. Martelli (MARTELLI 1977, p. 3) gli occhioni riportano alla produzione vascolare orientalizzante delle botteghe dell’Asia Minore, in particolare “nordioniche”, per influenze dirette o mediate dai mercanti corinzi che a inizio VI seguono rotte di collegamento fra le coste microasiatiche e italiane. Dunque (Ibidem, p. 9) nella produzione del Pittore di Feoli si riscontrano influenze corinzie rielaborate dalle officine della Ionia settentrionale, filtrate attraverso la mediazione dei loro prodotti e poi riprese da altri pittori di seconda e terza generazione vulcente. Sulla deco-razione ad occhioni, in generale, si veda anche STEINHART 1995.
133 Si veda ad esempio SZILÀGYI 1998, Pittore della Hercle (tav. CXV, c) e sua Cerchia (tav. CXXX, c); Sequenza di Monaco 640 (tav. CXXXV, a); Pittore dei Rosoni (tav. CXL, e); Pittore delle Teste di Lupo (tav. CLXXIV, a, d; con il raro caso di una olpe con stessa decorazione: tav. CLXXV, b); Pittore senza Graffito (tav. CLXXX, e-f); per finire con il Pittore di Thiersch (tav. CCLIX, a-b).
134 A titolo esemplificativo si possono citare cinque anfore decorate con coppie di occhioni del Gruppo delle Foglie d’Edera (RIZZO 1994, p. 7); il motivo ricorre inoltre su anfore e altre forme vascolari del Gruppo degli Uccelli Acquatici e soprat-tutto del Pittore di Micali (cfr. GOVI 2012, p. 111, nota 19 con bibliografia di riferimento), il quale utilizza il motivo anche per due oinochoai (SIEVEKING, HACKL 1912, nn. 925-926). Il confronto più vicino alle brocche di Covignano è offerto da alcune oonochoai del Gruppo Pontico, in particolare del Pittore di Parigi (cfr. HANNESTAD 1974, tav. 33; IDEM 1976, tavv. 33, 54).
135 MACELLARI 2002, p. 40, tav. 30, n. 10.136 A. Maggiani in DAMIANI, MAGGIANI, PELLEGRINI 1992, p. 114; tav. LIII, n. 752.137 SQUADRINI 1988, p. 277, fig. 228, a. 138 Al motivo è dedicato ampio spazio in GOVI, SASSATELLI 2004, pp. 243-248, nel quale E. Govi osserva che il motivo entra nel
repertorio figurativo padano nel V sec. a.C. (dal 470 a.C. circa per le stele felsinee), mentre in Etruria propria era presente già dal tardo VII sec. sulla ceramica etrusco-corinzia, e dall’ultimo quarto del VI sec. sulla pittura parietale tarquiniese; in Grecia il motivo compare già su ceramica geometrica beotica, argiva e protoattica (sulla ceramica attica a f.n. e f.r. sarà poi presente con valore soprattutto decorativo accessorio). Per il contenuto semantico dell’onda marina corrente si rimanda anche a D’AGOSTINO, CERCHIAI 1999, capitoli 5-6; PIZZIRANI 2005.
139 Vedi SASSATELLI 1981, pp. 13-14; IDEM 1989, p. 58, fig. 7, nel quale si osserva che la produzione di questo specchio e di altri dalle necropoli felsinee, sulla scorta anche di analisi archeometriche sulle componenti metalliche, potrebbe essere riferita ad una bottega bolognese attiva nel V secolo. In particolare lo specchio della Galassina potrebbe aver visto la par-tecipazione congiunta, magari saltuaria, di artigiani bolognesi e di maestri veneto-alpini, esperti nell’arte delle situle (v. anche PIZZIRANI 2009).
04 Appendice.indd 522 24/01/14 18.00
Appendice
523
Altrettanto singolare è la rappresentazione di un oggetto, il motivo “a tenaglietta” impresso radial-mente tre volte su entrambe le estremità di un rocchetto in bucchero databile alla seconda metà del VI secolo da Rubiera (Tav. III, nr. C.3), che rappresenta perciò un altro unicum del patrimonio decorativo padano, e non solo, considerato che non si trovano confronti in Etruria propria, dove altrettanto rare sono le stampiglie con oggetti singoli. Altrettanto particolare il fatto che l’oggetto raffigurato pare uno strumento da lavoro riferibile alla sfera maschile, mentre il supporto – un rocchetto – rimanda al lavoro domestico del mondo muliebre.
attestazIonI
I. Motivi geometrici (Tav. I):
1a. Cerchiello semplice1) Marzabotto (MA) – stampiglia, coppa, bucchero, 600-500 a.C. (MASSA PAIRAULT 1997, tav. XXII, 3)2) Cittanova (MO) – stampiglia, kantharos, bucchero, 610-550 a.C. (CATTANI 1988c, p. 182, n. 23)3) Mirandola (MO) – stampiglia, parete, depurata, 600-550 a.C.? (SGARBI 1993, p. 59, tav. X, 2)4) Sant’Ilario d’Enza (RE) – stampiglia, fusaiola, grezza (SERGES 1992, p. 346, tav. C, 1715)5) Sant’Ilario d’Enza (RE) – stampiglia, olla, depurata (LOSI 1989a, p. 65, tav. XII, 3)6) Cacciola-Scandiano (RE) – stampiglia, oinochoe, bucchero, 600-500 a.C. (PELLEGRINI 1992b, p. 57, C102)7) Cacciola-Scandiano (RE) – stampiglia, coppa, bucchero, 610-550 a.C.(PELLEGRINI 1992b, p. 55, tav. 22, 242)8) San Claudio (RE) – stampiglia, olla?, bucchero, 600-500 a.C. (MALNATI, LOSI 1990, p. 87, n. 11)9) Case Nuove Siccomonte ([PR] RE) – stampiglia, parete, bucchero (MARINI CALVANI 2001, p. 52)10) Casola Valsenio (RO) – stampiglia, rocchetto, depurata, 525-490 a.C. (MASSI PASI 1981, p. 169, tav. 91)11) Imola-Montericco (RO) – stampiglia, fusaiola, grezza, 610-550 a.C. (VON ELES 1981, tav. 16, 19.12)
1b. Cerchiello multiplo1) Marzabotto (MA) – stampiglia, parete, bucchero, 600-550 a.C. (FORTE 1993, p. 77, n. 25)2) Tabina di Magreta (MO) – stampiglia, parete, grezza, 600-550 a.C. (CATTANI 1988b, fig. 132.22-23)3) Cittanova (MO) – stampiglia, parete, grezza, 610-550 a.C. (CATTANI 1989c, p. 182, n. 22)4) Mirandola (MO) – stampiglia, tazza monoansata (VII, 2, b), bucchero, 610-550 a.C. (MALNATI 1993, fig. 5, 4)5) Rubiera-Cave Guidetti (RE) – stampiglia, coppa, bucchero, 550-500 ? (MALNATI 1989a, p. 83, tav. XIV, 12)6) Rubiera-Cave Guidetti (RE) – stampiglia, coppa, bucchero, 550-500 ? (MALNATI 1993, p. 66, n. 8)7) Rubiera-Cave Guidetti (RE) – stampiglia, coppa, bucchero, 550-500 ? (LASAGNA PATRONCINI 1981, p. 81, 6)8) Rubiera-Cave Guidetti (RE) – stampiglia, rocchetto, bucchero, 550-500 ? (MALNATI 1989b, tav. 14, 16b)9) San Claudio (RE) – stampiglia e incisione, kantharos, bucchero, 600-500 a.C. (MALNATI, LOSI 1990, p.114, n. 5)10) San Claudio (RE) – stampiglia, parete, bucchero, 600-500 a.C. (MALNATI, LOSI 1990, p. 120, n. 5)11) San Claudio (RE) – stampiglia e incisione, parete, bucchero, 600-500 a.C. (MALNATI, LOSI 1990, p.120, n. 3)12) San Polo-Servirola (RE) – stampiglia, coppa, grezza (PELLEGRINI 1992a, p. 274, tav. 27, 322)13) Boccazzola-Poggio (MN) – stampiglia, parete, grezza, 500-400 a.C. (MENOTTI, BARATTI 2006, tav. 15, 167)
1c. Cerchiello doppio1) Bologna (BO) – stampiglia, parete, grezza, 610-510 a.C. (BENTINI, FERRARI 1987, p. 76, fig. 46, 8)2) Cacciola di Scandiano (RE) – stampiglia, coppa, bucchero (MALNATI 1993, p. 64, n. 10)3) Forcello (MN) – stampiglia, coppa, depurata, 450-400 a.C. (DE MARINIS 2005, p. 68, fig. 23, 2)4) Covignano (RO) – stampiglia, coppa, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, tav. 173, 105.334)5) Covignano (RO) – stampiglia, coppa, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, tav. 173, 105.335)
2a. Punti singoli1) Forcello (MN) – dipintura, bacile-m. (II, 6, a), depurata, 450-400 a.C. (CASINI 2005, p. 258, fig. 119)2) Covignano (RO) – dipintura, coppa, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, tav. 167, 105.165)
04 Appendice.indd 523 24/01/14 18.00
524
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
2b. Punti a fascia1) Bologna (BO) – dipintura, skyphos, depurata, 610-550 a.C. (GOVI 2003, pp. 67-68, tav. X)2) Spina (SP) – dipintura, olla (II, 8, k), depurata (BALDONI 1981, tav. XIX, 74)3) Marzabotto (MA) – dipintura, brocca, depurata, 500-300 a.C. (MASSA PAIRAULT 1997, tav. 8, n. 13)4) Marzabotto (MA) – dipintura, piatto, depurata, 600-400 a.C. (Museo “P. Aria”, vetrina 6, inv. 372)5) Castellarano (RE) – dipintura, brocca a becco, depurata, 600-500 a.C. (DAMIANI et alii 1992, p. 261, n. 171)6) Rubiera (RE) – dipintura, piatto su piede, depurata, 550-500 a.C. (LASAGNA PATRONCINI 1981, p. 88)7) Rubiera (RE) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 510-500 a.C. (MALNATI 1989a, p. 154, n. 1)8) Rubiera (RE) – dipintura, brocca a becco, depurata, ca. 450 a.C. (MALNATI 1989b, tav. XXXI, 1)9) Rubiera (RE) – dipintura, coperchio, depurata, 550-400 a.C. (MALNATI 1989a, tav. XV, 13)10) Casale-Rivalta (RE) – dipintura, kantharos/kyathos miniaturistico, depurata, 540-425 a.C. (MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 216, tav. LVII, 11)11) Casale-Rivalta (RE) – dipintura, coppa carenata (VI, 4, a), depurata, 500-400 a.C. (MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 229, tav. LXIX, 1)12) Casale-Rivalta (RE) – dipintura, olla biansata, depurata, 500-400 a.C. (MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 231, tav. LXXI, 1)13) San Polo-Servirola (RE) – dipintura, coppa, depurata (DAMIANI et alii 1992, p. 255, tav. IX, 102)14) Cà Rigo (RO) – dipintura, brocca rotonda (I, 2, a), depurata (LACCHINI 2009, p. 166, tav. 6, 2)15) Casola (RO) – dipintura, brocca trilobata (IV, 3, a), depurata, 525-490 a.C. (MASSI PASI 1981, 86.58, fig. 137)16) Covignano (RO) – dipintura, coppa, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, tav. 167, 105.166)17) Covignano (RO) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, n. 105.111)18) Covignano (RO) – dipintura, brocca rotonda (III, 3, a), depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, n. 105.119) 2c. Punti a metopa1) Montecchio E. (RE) – dipintura, skyphos (I, 1, a), depurata (MACELLARI, TIRABASSI 1997, tav. XVII, n. 20)
3. Croce1) San Claudio (RE) – stralucido, coppa carenata (I, 1, r), bucchero, 600-500 a.C. (MALNATI 1993, p. 66, n. 12)2) Casale-Rivalta (RE) – dipintura, coppa, depurata, 600-500 a.C. (MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 229, tav. LXIX, 5)3) Casale-Rivalta (RE) – dipintura, brocca a becco (IV, 4, g), depurata, 510-425 a.C. (MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 229, tav. LVIII, 1)4) Forcello (MN) – incisione, recipiente da fuoco (II, 1, i), grezza (CASINI, FRONTINI 1986b, fig. 167, 3-B2)5) Faenza (RO) – stampiglia, parete, depurata, entro 525 a.C. (PARMEGGIANI 1981, tav. 109, 89.115)
4a. Triangolo singolo1) Castelfranco E. (MO) – rilievo, dolio, grezza, 600-400 a.C. (BUOITE, ZAMBONI 2008, fig. 2, 25)2) S. Ilario (RE) – stampiglia, olla (XVI, 3, b), depurata, 600-500 a.C. (LOSI 1989b, p. 65, tav. XII, 3)3) Cacciola-Scandiano (RE) – stampiglia, coppa, bucchero, 610-500 a.C. (PELLEGRINI 1992b, tav. XXII, 242)4) Covignano (RO) – dipintura, bacile-m. (I, 6, a), depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, tav. 165, 105.132)
4b. Triangolo a fascia1) Marzabotto (MA) – incisione, parete, bucchero, 600-400 a.C. (Museo “P. Aria”, inv. 640)2) Fiorano M.se (MO) – dipintura, forma chiusa, depurata, 550-500 a.C. (GIANFERRARI 1989, tav. LVII, 4)3) Magreta (MO) – incisione, parete, bucchero, 600-500 a.C. (CATTANI, MACELLARI 1988, fig. 177, 4-5)4) Magreta (MO) – incisione, parete, grezza, 475-375 a.C. (CATTANI, MACELLARI 1988, fig. 177, 6)5) Castelfranco E. (MO) – incisione, olla?, grezza, 600-400 a.C. (BUOITE, ZAMBONI 2008, fig. 15, 743)6) Cacciola-Scandiano (RE) – incisione, kantharos (I, 3, a), bucchero, 610-525 a.C. (MALNATI 1993, fig. 4, 9)
04 Appendice.indd 524 24/01/14 18.00
Appendice
525
5. Chevrons1) Marzabotto (MA) – stampiglia, parete, bucchero, 600-400 a.C. (BOULOUMIÈ 1976, p.134, tav. IX)2) Marzabotto (MA) – stampiglia, parete, bucchero, 600-400 a.C. (BOULOUMIÈ 1976, p.134, tav. IX)3) Mirandola (MO) – stampiglia, parete, bucchero, 450-390 a.C. (CALZOLARI 1993b, tav. V, 6)4) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, olla, depurata, 540-425 a.C. (MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 216, tav. LVII, 3)5) Cavriago (RE) – stampiglia, coppa, bucchero (PATRONCINI 1991, p. 136, n. 5)
6. Dente di lupo1) Rubiera (RE) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (MALNATI 1989b, p. 105, tav. 26, 2)2) Rubiera (RE) – dipintura, brocca trilobata, depurata, ca. 450 a.C. (MALNATI 1989b, p. 111, tav. 32, 8)3) Rubiera (RE) – dipintura, brocca a becco (IV, 4, a), depurata, 600-400 a.C. (MALNATI 1989b, tav. 24, 4)4) San Claudio (RE) – incisione, olla, grezza, 600-500 a.C. (MALNATI, LOSI 1990, p. 125)5) San Bartolomeo (RE) – incisione, coppa, grezza, 600-500 a.C. (DAMIANI, PELLEGRINI, SALTINI 1990, p. 145)
7a. Segno a “S” semplice1) Bologna (BO) – stampiglia, olla (XII, 1, b), bucchero, ca. 550 a.C. (MALNATI 1993, p. 70, n. 4)2) Spina (SP) – stampiglia, bacile-m., depurata, 425-390 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, p.154, fig. 16)3) Spina (SP) – stampiglia, coppa, depurata, 425-400 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, tav. XX, b)4) Mirandola (MO) – stampiglia, anforetta (I, 1, b), depurata, 600-550 a.C. (SGARBI 1993, p. 59, tav. X, 1)5) Mirandola (MO) – stampiglia, parete, depurata, 600-550 a.C. (SGARBI 1993, p. 59, tav. X, 2)6) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, bacile-m. (I, 6, a), depurata, 500-400 a.C. (MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 230, tav. LXX, 16)7) Faenza (RO) – stampiglia, coppa?, depurata, entro 525 a.C. (PARMEGGIANI 1981,tav. 107, 89.70)8) Faenza (RO) – stampiglia, fusaiola, bucchero, entro 525 a.C. (PARMEGGIANI 1981,tav. 114, 89.200)9) Cesena (RO) – stampiglia, coppa carenata (I, 9, b), bucchero, 550-400 a.C. (FAROLFI 1981b, tav. 150, 103.59)
7b. Segno a “S” complesso (“S intrecciate”)1) Baggiovara (MO) – dipintura, brocca, depurata (CATTANI 1988a, p. 18, fig. 3, 7)
8a. Spirale1) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, coppa emisferica (IV, 3, a), depurata, 530-425 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 211, tav. LII, 5) 2) Forcello (MN) – incisione, coppa emisferica (I, 1, a), depurata, 510-500 a.C. (RAPI 2005, fig. 45, 2) 3) Covignano-Rimini (RO) – dipintura, coppa?, depurata, 500-400 a.C.? (COLONNA 1987, p. 37)4) Verucchio (RO) – dipintura, coppa, depurata, 600-490 a.C. (GUARNIERI 1987, p. 263)5) Verucchio (RO) – dipintura, coppa, depurata, 600-490 a.C. (GUARNIERI 1987, p. 263)6) Adria (RO) – stampiglia, olla, depurata, 525-475 a.C. (DONATI, PARRINI 1999, p. 602; tav. II, f)
8b. Volute1) Marzabotto (MA) – rilievo, Grande Forma, fittile (BRIZIO 1890, tav. IX, n. 18)2) Marzabotto (MA) – rilievo, Grande Forma, fittile (BRIZIO 1890, tav. IX, n. 24)3) Marzabotto (MA) – rilievo, Grande Forma, fittile (Museo “P. Aria”, vetrina 9, inv. 1059)4) Marzabotto (MA) – dipintura, brocca trilobata, depurata (MASSA PAIRAULT 1997, tav. XV, 1)5) Castelfranco E. (MO) – rilievo, dolio, grezza, 510-490 a.C. (MALNATI 1985b, p. 147)6) Magreta-Formigine (MO) – dipintura, brocca a becco (II, 2, a), depurata, 500-400 a.C. (KRUTA, MALNATI, CARDARELLI 1991, p. 364, fig. 30)7) Casale di Rivalta (RE) – stampiglia, coppa?, depurata, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 229, tav. LXIX, 4)
04 Appendice.indd 525 24/01/14 18.00
526
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
9. Linguetta / baccellatura1) Bologna (BO) – incisione, tazza monoansata (VII, 4, a), bucchero, ca. 550 a.C. (MALNATI 1993, fig. 5, 5)2) Bologna (BO) – incisione, anforetta (I, 2, b), grezza, 450-400 a.C. (MACELLARI 2002, tav. 17, 9)3) Spina (SP) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 475-450 a.C. (PARRINI 1993b, p. 279, n. 184)4) Spina (SP) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 475-450 a.C. (PARRINI 1993b, p. 279, n. 185)5) Spina (SP) – dipintura, olla biansata (XIX, 1, a), depurata, 500-400 a.C. (BALDONI 1981, tav. XXXVI, 127)6) Spina (SP) – dipintura, olla biansata (XVII, 3, a), depurata, 500-400 a.C. (BALDONI 1981, tav. XL, 138)7) Marzabotto (MA) – stampiglia, coppa, depurata (MASSA PAIRAULT 1997, tav. VII, 8)8) Magreta-Formigine (MO) – dipintura, brocca a becco (II, 2, a), depurata, 500-400 a.C. (KRUTA, MALNATI, CARDARELLI 1991, p. 364, fig. 30)9) Baggiovara (MO) – dipintura, brocca, depurata, 550-450 a.C. (STOPPANI, ZAMBONI 2009, tav. 9, 3)10) Mirandola (MO) – dipintura, anforetta (I, 1, b), depurata, 600-550 a.C. (SGARBI 1993, p. 59, tav. X, 1)11) Mirandola (MO) – stampiglia, parete, bucchero (CAMPAGNOLI 1990, p. 77, fig. 10, 1)12) Mortizzolo (MO) – dipintura, olla biansata (II, 1, i), grezza, 310-250 a.C. (Modena 2003, p. 70, fig. 20, 5)13) San Claudio (RE) – stampiglia, olla?, bucchero, ca. 550 a.C. (MALNATI, LOSI 1990, p. 87, n. 11)14) San Claudio (RE) – stampiglia, parete, bucchero, ca. 550 a.C. (MALNATI, LOSI 1990, p. 120, n. 3)15) Sant’Ilario (RE) – dipintura, brocca a becco (II, 2, a), dipintura, 500-400 a.C. (MALNATI 1989d, tav. LXIV, 3)16) Sant’Ilario (RE) – rilievo, brocca, bucchero, ca. 550 a.C. (MALNATI 1993, fig. 2, 4)17) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, brocca a becco (IV, 4, g), depurata, 500-400 a.C. (MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 217, tav. LVIII, 2)18) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, olla (X, 3, a), grezza, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, tav. LVI, 1)19) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, brocca a becco (IV, 4, g), depurata, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 217, tav. LVIII, 4)20) Rubiera (RE) – dipintura, brocca a becco (III, 2, a), depurata (MALNATI 1989b, p. 107, tav, XXVIII, 2)21) Rubiera (RE) – dipintura, olla biansata (XIX, 4, a), depurata, 500-400 a.C. (MALNATI 1989b, tav. XXV, 2)22) Rubiera (RE) – incisione, fusaiola, bucchero, 610-600 a.C. (MACELLARI 1989e, p. 57, tav. IX, 5)23) Rubiera (RE) – dipintura, brocca, depurata, 500-350 a.C. (MALNATI 1989b, tav. XXIV, 3)24) Cacciola-Scandiano (RE) – dipintura, olla, depurata, 500-400 a.C. (LOSI 1989a, tav. LIII, 4)25) S. Polo-Servirola (RE) – dipintura, olla (XVI, 8, k), depurata (DAMIANI et alii 1992, tav. XXI, 223)26) Forcello (MN) – dipintura, brocca trilobata (II, 2, a), depurata, 530-520 a.C. (CASINI 2005, fig. 41, 1)27) Forcello (MN) – dipintura, piattello, depurata, 510-500 a.C. (CASINI 2005, fig. 46, 4)28) Boccazzola (MN) – dipintura, bacile-m. (III, 2, a), depurata, 500-400 a.C. (MENOTTI, BARATTI 2006, t. 1, 4)29) Boccazzola (MN) – dipintura, bacile-m. (I, 1, i), depurata, 500-400 a.C. (MENOTTI, BARATTI 2006, tav. 1, 5)30) Boccazzola (MN) – dipintura, bacile-m. (II, 1, e), depurata, 500-400 a.C. (MENOTTI, BARATTI 2006, tav. 1, 6)31) Imola (RO) – dipintura, brocca a becco (I, 4, a), depurata, 510-450 a.C. (VON ELES 1981, tav. 56, 58.6)32) Imola (RO) – dipintura, brocca trilobata (III, 3, a), depurata, 500-450 a.C. (VON ELES 1981, tav. 44, 46.2)33) Villanova (RO) – incisione, coppa a. p. (I, 8, a), bucchero, 550-390 a.C. (VON ELES 1981, tav. 131, 98.37)34) Cesena (RO) – incisione, coppa carenata (I, 5, a), bucchero, 550-400 a.C. (VON ELES 1981, tav. 150, 103.55)35) Adria (RO) – incisione, olla, depurata, 525-475 a.C. (DONATI, PARRINI 1999, p. 602; tav. II, f)36) S. Cassiano (RO) – dipintura, forma aperta, depurata, 500-400 a.C. (SALZANI 1987, fig. 1, 11)37) San Basilio (RO) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (DE MIN, IACOPOZZI 1986, tav. 3, 23)
10a. Meandro a zig-zag1) Spina (SP) – incisione, olla, depurata, 500-400 a.C. (ALFIERI 1994, p. 159, tav. 4, c)2) Spina (SP) – dipintura, bacile-m. (II, 1, i), depurata, 450-400 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, fig. 11, 40a)3) Spina (SP) – dipintura, bacile-m. (II, 2, a), depurata, 425-400 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, fig. 10, 38a)
04 Appendice.indd 526 24/01/14 18.00
Appendice
527
4) Spina (SP) – dipintura, olla biansata (XVII, 3, a), depurata, 500-400 a.C. (BALDONI 1981, tav. XL, 138)5) Marzabotto (MA) – incisione, parete, grezza (Museo “P. Aria”, vetrina 13, inv. 1307)6) Marzabotto (MA) – incisione, kantharos?, bucchero, 600-550 a.C. (MALNATI 1993, fig. 4, 8)7) Castelfranco E. (MO) – incisione, olla, grezza, 450-350 a.C. (BUOITE, ZAMBONI 2008, fig. 15, 741)8) Castelfranco E. (MO) – dipintura, olla, depurata, 400-390 a.C. (BUOITE, ZAMBONI 2008, fig. 16, 805)9) Magreta (MO) – incisione, catino?, grezza? (Modena 2009, p. 264, fig. 445, 17)10) Rubiera (RE) – stralucido, olla (I, 3, a), bucchero, 550-500 a.C. (MALNATI 1993, p. 68, fig. 11, 14)11) Rubiera (RE) – stralucido, olla (I, 3, h), bucchero, 550-500 a.C. (PATRONCINI LASAGNA 1981, p. 84, n. 37 e MALNATI 1993, p. 68, fig. 11, 7)12) Castellarano (RE) – dipintura, bacile-m. (II, 1, e), depurata, 500-400 (DAMIANI et alii 1992, tav. XXX, 342)13) Covignano (RO) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, n. 105.112)
10b. Meandro a onda1) Spina (SP) – dipintura, bacile-m. (II, 8, g), depurata, 500-400 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, fig. 11, 39c)2) Spina (SP) – dipintura, olla biansata (I, 4, e), depurata, 310-250 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, fig. 13, 55b)3) Spina (SP) – dipintura, olla biansata (II, 4, g), depurata, 500-400 a.C. (BALDONI 1981, tav. XXVII, 102)4) Marzabotto (MA) – dipintura, piatto, depurata (Museo “P. Aria”, vetrina 6, inv. 372)5) S. Cesario s/P (MO) – dipintura, anfora (avv. II, 6, d), depurata, 510-500 a.C. (GOVI 2003, p. 66)6) Castelfranco E. (MO) – incisione, olla?, grezza, 600-500 a.C. (BUOITE, ZAMBONI 2008, fig. 10, 460)7) Baggiovara (MO) – dipintura, bacile-m. (I, 2, l), depurata, 500-400 a.C. (MENESCARDI, NUNZIATI, RESTELLI 2009, t. 20, 3)8) Baggiovara (MO) – incisione, fusaiola, depurata, 550-450 a.C. (STOPPANI, ZAMBONI 2009, tav. 12, 4)9) Mirandola (MO) – dipintura, bacile-m. (I, 1, i), depurata, 500-400 a.C. (CALZOLARI 1992c, tav. LXVa, 9) 10) Bondeno-Ferrara (MO) – dipintura, bacile-m. , depurata, 500-400 a.C. (CALZOLARI 1992d, tav. LXXVII, 9) 11) Casinalbo (MO) – dipintura, brocca?, depurata (Modena 2009, p. 263, fig. 444, 2)12) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, brocca a becco (IV, 4, g), depurata, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 217, tav. LVIII, 2)13) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, brocca a becco (IV, 4, g), depurata, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 217, tav. LVIII, 4)14) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, coppa carenata (VI, 4, a), depurata, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 229, tav. LXIX, 1)15) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, piatto su piede, depurata, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 230, tav. LXX, 5)16) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, olla biansata, depurata, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 230, tav. LXX, 11)17) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, bacile-m. (I, 1, a), depurata, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 214, tav. LV, 2)18) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, bacile-m. (I, 8, a), depurata, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 230, tav. LXX, 13)19) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, bacile-m. (II, 2, b), depurata, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 230, tav. LXX, 14)20) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, olla (X, 3, a), grezza(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 215, tav. LVI, 1)21) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, bacile-m. (II, 6, e), depurata, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 214, tav. LV, 1)22) Rubiera (RE) – dipintura, brocca, depurata, 600-500 a.C. (MALNATI 1989a, tav. XVI, 4)23) Rubiera (RE) – dipintura, brocca a becco (II, 2, a), depurata, 410-390 a.C. (MALNATI 1989b, tav. XXV, 6)24) Rubiera (RE) – dipintura, brocca a becco (II, 2, a), depurata, ca. 450 a.C. (MALNATI 1989b, tav. XXXI, 1)25) Cacciola-Scandiano (RE) – dipintura, olla (II, 4, h), grezza, 500-400 a.C. (LOSI 1989a, tav. LXIX, 8)26) Castellarano (RE) – dipintura, brocca, depurata, 500-400 a.C. (PELLEGRINI, SERGES, SALTINI 1992, p. 261)27) S. Polo-Servirola (RE) – dipintura, olla (I, 4, a), depurata (DAMIANI et alii 1992, tav. XIX, 209)28) S. Polo-Servirola (RE) – dipintura, olla (II, 4, a), depurata (DAMIANI et alii 1992, tav. XIX, 210)
04 Appendice.indd 527 24/01/14 18.00
528
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
29) S. Polo-Servirola (RE) – dipintura, olla (II, 4, b), depurata (DAMIANI et alii 1992, tav. XIX, 211)30) S. Polo-Servirola (RE) – dipintura, olla (II, 4, a), depurata (DAMIANI et alii 1992, tav. XIX, 212)31) S. Polo-Servirola (RE) – dipintura, olla (XVI, 8, k), depurata (DAMIANI et alii 1992, tav. XXI, 223)32) Siccomonte ([PR] RE) – stralucido, olla, bucchero, 600-400 a.C. (RAVASIO 1995/1996)33) Boccazzola (MN) – dipintura, bacile-m. (I, 1, i), depurata, 500-400 a.C. (MENOTTI, BARATTI 2006, tav. 1, 5)34) Boccazzola (MN) – dipintura, bacile-m. (II, 1, e), depurata, 500-400 a.C. (MENOTTI, BARATTI 2006, tav. 1, 6)35) Boccazzola (MN) – dipintura, bacile-m., depurata, 500-400 a.C. (MENOTTI, BARATTI 2006, tav. 10, 99)36) Boccazzola (MN) – dipintura, parete, depurata (MENOTTI, BARATTI 2006, tav. 15, 165)37) Forcello (MN) – dipintura, bacile-m. (II, 2, l), depurata, 500-400 a.C. (CASINI 2005, p. 258, fig. 119, A2)38) Forcello (MN) – dipintura, bacile-m., depurata, 500-400 a.C. (CASINI 2005, p. 258, fig. 119, B3)39) Forcello (MN) – dipintura, olla, depurata, 500-400 a.C. (CASINI 2005, p. 258, fig. 120, A1)40) Castellazzo Garolda (MN) – dipintura, bacile-m., depurata, 500-400 a.C. (CASINI, FRONTINI, GATTI 1989, fig. 315, 2-A4)41) Castellazzo Garolda (MN) – dipintura, bacile-m., depurata, 500-400 a.C. (CASINI, FRONTINI, GATTI 1989, fig. 315, 3-B5)42) Casola (RO), dipintura, brocca trilobata (IV, 3, a), depurata, 525-490 a.C. (MASSI PASI 1981, tav. 90, 86.58)43) Forlì (RO) – dipintura, brocca trilobata (V, 4, a), depurata, 525-490 a.C. (PRATI 1981, p. 259, tav. 135, 99a.4)44) Forlì (RO) – dipintura, brocca trilobata (I, 2, a), depurata, 525-490 a.C. (PRATI 1981, p. 259, tav. 135, 99a.5)45) Covignano (RO) – dipintura, brocca trilobata (I, 2, a), depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, 105.106)46) Covignano (RO) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, n. 105.107)47) Covignano (RO) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, n. 105.108)48) Covignano (RO) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, n. 105.111)49) Covignano (RO) – dipintura, coppa carenata (I, 4, a), depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, 105.165)50) Covignano (RO) – dipintura, coppa carenata (VI, 4, a), depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, 105.166)51) Cà Rigo (RO) – dipintura, brocca rotonda (I, 2, a), depurata (LACCHINI 2009, p. 166, tav. 6, 2)52) Cicese-Adria (RO) – dipintura, bacile-m., depurata, 500-400 a.C. (PERETTO, VALLICELLI, WIEL MARIN 2002, fig. 9, 7)53) San Basilio (RO) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (DE MIN, IACOPOZZI 1986, tav. 3, 23)
10c. Meandro ad archetti1) Marzabotto (MA) – rilievo, Grande Forma, fittile (BRIZIO 1890, tav. IX, 3)2) Marzabotto (MA) – rilievo, Grande Forma, fittile (BRIZIO 1890, tav. IX, 17)
10d. Meandro a “G”1) Case Nuove Siccomonte (RE [PR]) – stampiglia, parete, bucchero (MARINI CALVANI 2001, p. 52)
11 – Reticolo di losanghe1) Spina (SP) – dipintura, bacile-m. (II, 8, g), depurata, 500-400 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, fig. 11, 39c)2) Marzabotto (MA) – stralucido, olla, bucchero, 550-500 a.C. (MALNATI 1993, p. 68; fig. 11, 9)3) Castelfranco E. (MO) – stralucido?, olla?, grezza, 500-400 a.C. (BUOITE, ZAMBONI 2008, fig. 10, 457)4) Fiorano M.se (MO) – stralucido, olla (XVI, 3, b), bucchero, 600-550 a.C. (MALNATI 1993, p. 68; fig. 11, 13)5) Rubiera (RE) – stralucido, olla, bucchero, 600-500 a.C. (MALNATI 1993, p. 68; fig. 11, 8)6) Cesena (RO) – stralucido, coppa?, bucchero, 510-450 a.C. (FAROLFI 1981a, tav. 145, 102.75)
12. Segno a tridente1) Bologna (BO) – dipintura, brocca trilobata (I, 2, a), depurata, 610-550 a.C. (necropoli Certosa, T. 363)2) Baggiovara (MO) – dipintura, coppa (III, 1, c), depurata, 550-450 a.C. (STOPPANI, ZAMBONI 2009, tav. 20, 7)
04 Appendice.indd 528 24/01/14 18.00
Appendice
529
3) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, brocca a becco (IV, 4, g), depurata, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 217, tav. LVIII, 2)4) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, piatto su piede, depurata, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 230, tav. LXX, 5)5) Rubiera (RE) – dipintura, brocca a becco (VI, 1, a), depurata, 500-400 a.C. (MALNATI 1989b, tav. XXVI, 1)6) Rubiera (RE) – dipintura, brocca a becco, depurata, 500-400 a.C. (MALNATI 1989b, tav. XXVI, 2)7) Rubiera (RE) – dipintura, brocca a becco (III, 2, a), depurata, 500-400 a.C. (MALNATI 1989b, tav. XXVIII, 2)8) Castellarano (RE) – dipintura, brocca a becco, depurata, 500-400 a.C. (PELLEGRINI, SERGES, SALTINI 1992, p. 261, n. 171)9) Roncopascolo ([PR] RE) – stampiglia, coppa?, grezza (CATARSI DALL’AGLIO, DONDI 1998, fig. 5, 2)10) Siccomonte ([PR] RE) – dipintura, coppa, depurata, 600-400 a.C. (RAVASIO 1995/1996)11) Forcello (MN) – dipintura, bacile-m. (II, 6, a), depurata, 450-400 a.C. (CASINI 2005, p. 258, fig. 119, B1)
13. Ruota raggiata1) S.Polo-Servirola (RE) – stampiglia, olla, grezza (PELLEGRINI, SALTINI 1992, tav. XXXI, 349)2) S.Polo-Servirola (RE) – stampiglia, olla, grezza (PELLEGRINI, SALTINI 1992, tav. XXXI, 350)3) S.Rigo-Coviolo (RE) – dipintura, coppa, depurata (PELLEGRINI, SERGES, SALTINI 1992, p. 252, 64)
14. Altro motivo geometrico1) Casale di Rivalta (RE) – “ferro di cavallo” a dipintura, brocca, depurata, 500-400 a.C. (MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 231, tav. LXXI, 14)
II. Motivi fitomorfi (Tav. II):
1a. Palmetta a 5 foglie1) Spina (SP) – stampiglia, piatto, depurata, 425-400 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, p. 120; tav. XX, a)2) Marzabotto (MA) – stampiglia, coppa, depurata (SANTOCCHINI GERG 2012, tav. 3, 5)
1b. Palmetta a 5 foglie, circoscritta1) Spina (SP) – stampiglia, bacile-m., depurata, 425-390 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, p. 154, fig. 16)2) Spina (SP) – stampiglia, coppa, depurata, 425-400 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, p. 120; tav. XX, b)3) Casale di Rivalta (RE) – dipintura, brocca a becco, depurata, 510-425 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 217, tav. LVIII, 1)
1c. Palmetta puntinata a 5 foglie, circoscritta1) Verucchio (RO) – stampiglia, coppa carenata (II, 4, d), depurata, 600-390 a.C. (MIARI 2000, fig. 50, 25)2) Verucchio (RO) – stampiglia, coppa carenata (II, 4, d), depurata, 600-390 a.C. (MIARI 2000, fig. 50, 26)3) Verucchio (RO) – stampiglia, coppa emisferica (I, 1, a), depurata, 600-390 a.C. (MIARI 2000, fig. 53, 49)
1d. Palmetta a 5 foglie, circoscritta, sorgente da cerchiello doppio1) Forcello (MN) – stampiglia, coppa, depurata, 450-400 a.C. (DE MARINIS 2005, fig. 23, 2)
1e. Palmetta a 9 foglie, fiammata1) Bologna (BO) – dipintura, coppa, depurata, 450-400 a.C. (MACELLARI 2002, p. 32, tav. 22, 20)
1f. Palmetta a 11 foglie1) Marzabotto (MA) – stampiglia, brocca, bucchero, 550-500 a.C. (MALNATI 1993, p. 70, fig. 13, 1)
1g. Palmetta destrutturata1) Marzabotto (BO) – stampiglia, parete, bucchero, 600-550 a.C. (ricostruzione da FORTE 1993, p. 77, n. 25)
04 Appendice.indd 529 24/01/14 18.00
530
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
1h. Palmetta destrutturata a volute1) Casale di Rivalta (RE) – stampiglia, coppa, depurata, 500-400 a.C. (MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 229, tav. LXIX, 3)2) S. Polo-Servirola (RE) – stampiglia, coppa, depurata, 500-400 a.C. (PELLEGRINI 1992b, tav. IX, 107)3) S. Polo-Servirola (RE) – stampiglia, coppa, depurata, 500-400 a.C. (PELLEGRINI 1992b, tav. IX, 108)
1i. Palmetta stilizzata1a) Marzabotto (MA) – stampiglia, coppa, depurata (MASSA PAIRAULT 1997, tav. V, 17)2) Tabina-Magreta (MO) – stampiglia, fusaiola, bucchero, 550-490 a.C. (CATTANI 1994, p. 187)3) Casale di Rivalta (RE) – stampiglia, kantharos?, bucchero, 510-425 a.C. (MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 205, tav. XLVI, 14)4b) Covignano (RO) – stampiglia, coppa, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, tav. 173, 105.335)
2. Ventaglietto 1) San Claudio (RE) – incisione, parete, bucchero, 600-500 a.C. (MALNATI, LOSI 1990, p. 114, n. 4)2) San Claudio (RE) – incisione, parete, bucchero, 600-500 a.C. (MALNATI 1985b, fig. 108, 4)3) Rubiera (RE) – incisione, coppa?, bucchero, 610-600 a.C. (MACELLARI 1989e, tav. IX, 2)4) Casale di Rivalta (RE) – incisione, parete, bucchero, 600-500 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 219, tav. LIX, 10)
3a. Rosetta canonica (a petali arrotondati o triangolari)1) Marzabotto (BO) – stampiglia, kylix?, bucchero, 610-525 a.C. (FORTE 1993, p. 81, fig. 2, 2)2) Marzabotto (BO) – stampiglia, kylix?, bucchero, 610-525 a.C. (FORTE 1993, p. 81, fig. 2, 2)3) S. Polo-Servirola (RE) – stampiglia, coppa carenata (I, 3, b), bucchero, 600-500 a.C. (DAMIANI et alii 1992, tav. XXII, 244)4) S. Polo-Servirola (RE) – stampiglia, coppa, depurata (DAMIANI et alii 1992, tav. XI, 138)5) S. Polo-Servirola (RE) – stampiglia, coppa, grezza (DAMIANI et alii 1992, tav. XXVIII, 322)6) S. Rigo-Biasola (RE) – stampiglia, coppa, bucchero, 600-550 a.C. (GIANFERRARI 1990, tav. XL, 1)7) Casale di Rivalta (RE) – stampiglia, fusaiola, grezza, 500-400 a.C.(MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990, p. 227, tav. LXVII, 6)8) Rubiera (RE) – stampiglia, olla (I, 3, h), bucchero, 550-500 a.C. (MALNATI 1993, p. 68, fig. 11, 7)9) Imola (RO) – stampiglia, kylix (II, 3, a), depurata, 510-450 a.C. (VON ELES 1981, tav, 51, 53.5)
3b. Rosetta puntinata1) Bologna (BO) – stampiglia, parete, grezza, 650-550 a.C. (ORTALLI, PINI 2002, p. 83, n. 10)2) San Claudio (RE) – stampiglia, olla?, bucchero, ca. 550 a.C. (MALNATI 1989d, p. 177, fig. 7, 15)3) San Claudio (RE) – stampiglia, olla, bucchero, ca. 550 a.C. (MALNATI 1989d, p. 179, fig. 9a, 3)4) Covignano (RO) – dipintura, bacile-m. (I, 6, a), depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, tav. 165, 105.132)5) Covignano (RO) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, tav. 163, 105.108)6) Covignano (RO) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, tav. 163, 105.110)
3c. Rosetta a 4 petali1) S. Polo-Servirola (RE) – stampiglia, coppa, grezza (PELLEGRINI 1992a, tav. XXVIII, 315)2) Siccomonte ([PR] RE) – stampiglia, ansa, grezza, 600-400 a.C. (RAVASIO 1995/1996)
3d. Rosetta stilizzata1) San Rigo-Coviolo (RE) – stampiglia, coppa, depurata (PATRONCINI 1973, p. 136, C72)2) San Claudio (RE) – stampiglia, coppa, depurata, 600-500 a.C. (MALNATI 1985b, p. 179, 2)
4a. Fiore di loto canonico1) Baggiovara (MO) – stampiglia, coppa, depurata, 550-450 a.C. (STOPPANI, ZAMBONI 2009, tav. 21, 1)2) Baggiovara (MO) – stampiglia, coppa, depurata, 550-450 a.C. (STOPPANI, ZAMBONI 2009, tav. 21, 2)
04 Appendice.indd 530 24/01/14 18.00
Appendice
531
4b. Fiore di loto “Serie A Spina”1) Spina (SP) – stampiglia, bacile-m. (II, 1, h), depurata, 425-390 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, p. 117, fig. 11)2) Spina (SP) – stampiglia, bacile-m., depurata, 425-390 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, tav. XX, c)3) Spina (SP) – stampiglia, bacile-m., depurata, 425-390 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, p. 154, fig. 16)4) Marzabotto (MA) – stampiglia, coppa carenata (II, 4, p), bucchero, 550-490 a.C. (MALNATI 1993, p. 66, n. 10)5) Marzabotto (MA) – stampiglia, coppa, depurata, 500-300 a.C. (MASSA PAIRAULT 1997, tav. XXXIII, 9)6) Forcello (MN) – stampiglia, bacile-m., depurata, 450-400 a.C. (CASINI, FRONTINI, GATTI 1986a, fig. 154, 2)
4c. Fiore di loto stilizzato1) Bologna (BO) – stampiglia, parete, grezza, 610-510 a.C. (BENTINI, FERRARI 1987, p. 76, fig. 46, 8)
5. Edera1) Marzabotto (MA) – dipintura, Grande Forma, fittile (BRIZIO 1890, tav. IX, n. 26)
6. Alberello / Ramo secco1) Bologna (BO) – dipintura, skyphos, depurata, 510-450 a.C. (GOVI 2003, p. 67, tav. X)2) Bologna (BO) – dipintura, olla stamnoide, depurata, ca. 450 a.C. (GOVI 2003, p. 67, tav. X)3) Marzabotto (MA) – dipintura, Grande Forma, fittile (BRIZIO 1890, tav. IX, n. 26)
7. Foglia stilizzata1) Tabina-Magreta (MO) – stampiglia, coppa emisferica (III, 1, k), depurata, 500-400 a.C. (CATTANI 1994, fig. 27, 9)2) Baggiovara (MO) – stampiglia, coppa emisferica (IV, 3, b), depurata, 450-375 a.C. (MENESCARDI, NUNZIATI, RESTELLI 2009, tav. 14, 11)3) Rubiera (RE) – stampiglia, coppa, bucchero, 550-500 a.C. (MALNATI 1989a, tav. XIV, 15)4) S. Rigo-Coviolo (RE) – stampiglia, coppa emisferica (III, 1, d), depurata (PATRONCINI 1973, p. 136, n. C72)5) Brescello (RE) – stampiglia, ansa, bucchero (PELLEGRINI, SALTINI 1992, tav. XXIX, 331)6) Paderna ([PC] RE) – stampiglia, coppa, ceramica grigia (LASAGNA PATRONCINI 1990, p. 162)
8. Altro motivo fitomorfo
1) Marzabotto (MA) – rilievo, parete, bucchero, 600-500 a.C. (MASSA PAIRAULT 1997, tav. 38, 4)2) Marzabotto (MA) – rilievo, parete, bucchero, 600-500 a.C. (MASSA PAIRAULT 1997, tav. 38, 5)
III. Motivi figurati (Tav. III):
III.A. Antropomorfi:
1a. Figura umana intera1) Spina (SP) – stampliglia, piatto su piede, depurata, 500-400 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, tav. XXI, d)2) Spina (SP) - stampiglia, depurata, 500-400 a.C. (UGGERI 1988, fig. 3)
1b - Figura umana stilizzata1) S. Polo-Servirola (RE) – stampiglia, coppa, depurata (PELLEGRINI, SERGES, SALTINI 1992, tav. VI, 67)1c - Protome umana 1) Bologna (BO) – rilievo, anforetta, bucchero, 460-450 a.C. (GOVI 1999, p. 120, fig. 69, n. 99)2) Spina (SP) – rilievo, vaso gemino, grezza, ca. 450 a.C. (ALFIERI 1994, tav. 4, d)3) Marzabotto (MA) – rilievo, kyathos, bucchero, ca. 550 a.C. (MALNATI 1987i, p. 132, fig. 86, 7)4) Marzabotto (MA) – rilievo, Grande Forma, fittile (BRIZIO 1890, tav. IX, 8)5) Marzabotto (MA) – rilievo, Grande Forma, fittile (BRIZIO 1890, tav. IX, 36)
04 Appendice.indd 531 24/01/14 18.00
532
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
1d - Figure umane in scena complessa1) Baggiovara (MO) – stampiglia, coppa?, bucchero, 550-450 a.C. (STOPPANI, ZAMBONI 2009, tav. 11, 10)
III.B. Zoomorfi:
1 . Felino1) Cacciola-Scandiano (RE) – stampiglia, coperchio, bucchero, ca. 600 a.C. (PELLEGRINI 1992b, tav. XXIV, 267)
2a. Equide 1) S.Cesario s/P (MO) – dipintura, anfora, depurata, 510-500 a.C. (MALNATI 1985b, p. 147, fig. 6)
2b. Equide, giumenta1) Spina (SP) – stampiglia, coppa emisferica (IV, 1, c), depurata, 500-400 a.C. (PATITUCCI UGGERI 1983, p. 112, fig. 8, 27c)
3. Cervo1) San Basilio (RO) – stampiglia, coppa carenata, bucchero, 550-500 a.C. (DE MIN, IACOPOZZI 1986, tav. 3, 20)
4. Lepre ?1) Gaide-Valle Re (RE) – stampiglia, ansa, bucchero, 610-550 a.C. (LOSI 1989c, p. 67, n. 5)
5. Altro zoomorfo (chiocciola ?)1) Marzabotto (MA) – stampiglia, coppa, depurata, 500-300 a.C. (MASSA PAIRAULT 1997, tav. XIII, 8)
III.C. Motivi figurati diversi:
1. Occhio apotropaico1) Covignano (RO) – dipintura, brocca trilobata (I, 2, a), depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, 105.106)2) Covignano (RO) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, n. 105.107)3) Covignano (RO) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, n. 105.108)4) Covignano (RO) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, n. 105.109)5) Covignano (RO) – dipintura, brocca trilobata, depurata, 500-400 a.C. (SCARPELLINI 1981, n. 105.111)
2. Onda corrente1) Spina (SP) – dipintura, poppatoio, depurata, 400-350 a.C. (MUGGIA 2004, p. 61, fig. 12)
3. Oggetti, tenagliette1) Rubiera (RE) – stampiglia, rocchetto, bucchero, 550-500 a.C. (MALNATI 1989a, tav. XIV, 16)
04 Appendice.indd 532 24/01/14 18.00
534
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
Tav. II. Motivi fitomorfi
04 Appendice.indd 534 24/01/14 14.35
549
BiBliografia
Le abbreviazioni bibliografiche delle riviste seguono le norme dello Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. Le riviste non presenti in tale repertorio vengono abbreviate come segue:
«AarbNOH» = «Aarbger for nordisk Oldkyndighed og Historie» «AEmil» = «Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna» «AmAnt» = «American Antiquity»«AnnRevAnth» = «Annual Review of Anthropology» «ArchStorPr» = «Archivio Storico delle Province Parmensi» «BollStPc» = «Bollettino Storico Piacentino» «GeoArch» = «Geo-Archeologia» «Hesperìa» = «Hesperìa. Studi sulla grecità di Occidente» «MatHistHom» = «Materiaux pour l’Histoire de l’Homme» «MiscStArch» = «Miscellanea di studi archeologici e di antichità» «MinerPetrogrActa» = «Mineralogica et Petrographica Acta» «NotABerg» = «Notiziario. Soprintendenza Archeologica di Bergamo» «Ocnus» = «Quaderni della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. Bologna» «QuadAR» = «Quaderni d’Archeologia Reggiana» «QuadBassaModena» = «Quaderni della Bassa Modenese» «QuadMusMO» = «Quaderni del Museo Archeologico Etnologico di Modena» «ReStoria» = «Reggio Storia»
ACCONCIA 2004 = V. ACCONCIA, La tecnologia del bucchero. Alcune considerazioni sulle produzioni dell’Etruria meridionale e settentrionale, in Metodi e approcci archeologici. L’industria e il commercio nell’Italia antica. Ar-chaeological Methods and Approaches. Industry and Commerce in Ancient Italy, Oxford 2004, pp. 133-143.
ALBORE LIVADIE 1979 = C. ALBORE LIVADIE, Le Bucchero nero en Campanie: notes de typologie et de chronologie, in Atti del colloquio su “le bucchero nero étrusque et sa diffusion en Gaule méridionale”, in «Latomus» 160, 1979, pp. 91-110.
ALMAGRO 1955 = M. ALMAGRO, Las necropolis de Ampurias. Necropolis romanas y necropolis indigenas, Barcelona 1955.
ARCELIN PRADELLE 1984 = CH. ARCELIN PRADELLE, La céramique grise monochrome en Provence, Paris 1984.ARCELIN PRADELLE, DEDET, PY 1982 = C. ARCELIN PRADELLE, B.N. DEDET, M. PY, La céramique grise mono-
chrome en Languedoc oriental, in «RANarb» 15, 1982, pp. 19-55. ARSLAN 1971-1974 = E. ARSLAN, Spunti per lo studio del celtismo cisalpino, in «Notizie dal Chiostro del Mo-
nastero Maggiore» 7-10, 1971-1974, pp. 43-57.Artimino 1987 = G. CAPECCHI (a c.), Artimino (Firenze). Scavi 1974 (Catalogo della Mostra), Firenze 1987.Atti Bologna 1985 = La Romagna tra VI e IV secolo a.C. nel quadro della protostoria dell’Italia centrale (Atti
del Convegno, Bologna 1982), Imola 1985. Atti Bologna 1988 = La formazione della città preromana in Emilia Romagna (Atti del Convegno di Studi,
Bologna-Marzabotto 1985), Bologna 1988. Atti Bologna 1997 = S. SANTORO BIANCHI, B. FABBRI (a c.), Il contributo delle analisi archeometriche allo studio
delle ceramiche grezze e comuni. Il rapporto forma-funzione-impasto (Atti della I Giornata di archeometria della ceramica), Bologna 1997.
Atti Bologna 2005 = E. GOVI, G. SASSATELLI (a c.), Culti, forma urbana e artigianato a Marzabotto (Atti del Convegno, Bologna 2003), Bologna 2005.
Atti Bonn 2010 = M. BENTZ, C. REUSSER (hrsg.), Etruskisch-italische und römisch-republikanische Häuser (Atti del Convegno, Bonn 2009), Wiesbaden 2010.
05 Bibliografia.indd 549 24/01/14 14.36
550
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
Atti Como 2001 = La protostoria in Lombardia (Atti del Terzo Convegno Archeologico Regionale, Como 1999), Como 2001.
Atti Ferrara 1993 = Studi sulla necropoli di Spina in Valle Trebba (Atti del Convegno, Ferrara 1992), Ferrara 1993.Atti Glux-en-Glenne 1998 = P. ARCELIN, M. TUFFREAU-LIBRE (éd.), La quantification des céramiques. Condi-
tions et protocole (Actes de la Table Ronde, Glux-en-Glenne 1998), Glux-en-Glenne 1998.Atti Lido di Camaiore 1999 = D. COCCHI GENICK (a c.), Criteri di nomenclatura e di terminologia inerente alla
definizione delle forme vascolari del neolitico-eneolitico e del Bronzo-Ferro (Atti del Convegno, Lido di Cama-iore 1998), Firenze 1999.
Atti Mantova 1989 = D. BALDONI, E. BENEDINI (a c.), Gli Etruschi a nord del Po (Atti del Convegno, Man-tova 1986), Mantova 1989.
Atti Milano 1993 = M. BONGHI JOVINO (a c.), Produzione artigianale ed esportazione nel mondo antico: il buc-chero etrusco (Atti del Colloquio Internazionale, Milano 1990), Milano 1993.
Atti Milano 2009 = C. CHIARAMONTE TRERÉ (a c.), Archeologia preromana in Emilia occidentale. La ricerca oggi tra monti e pianura (Atti del Convegno, Milano 2006), Milano 2009.
Atti Preistoria Protostoria 1989 = Atti della XXVII Riunione scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. Dottrina e metodologia della ricerca (Ferrara 1987), Ferrara 1989.
Atti San Giovanni 1987 = Romagna protostorica (Atti del Convegno, San Giovanni in Galilea 1985), Viser-ba di Rimini 1987.
Atti Studi Etruschi 1999 = Protostoria e storia del “Venetorum Angulus” (Atti del XX Convegno Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, Portogruaro-Quarto d’Altino-Este-Adria 1996), Pisa-Roma 1999.
ALFIERI 1994 = N. ALFIERI, Spina e la ceramica attica, Roma 1994.ANGHINELLI, ANGHINELLI 1991 = A. ANGHINELLI, S. ANGHINELLI, Goito (MN). Località Corte Gaiole. Insedia-
mento etrusco-padano e romano, in «NotALomb», 1990 [1991], pp. 87-88.AURIGEMMA 1965 = S. AURIGEMMA, La necropoli di Spina in Valle Trebba, II, Roma 1965.Bagnolo S. Vito 2005 = R.C. DE MARINIS, M. RAPI (a c.), L’abitato etrusco del Forcello di Bagnolo S. Vito (Man-
tova). Le fasi di età arcaica (Catalogo della Mostra, Bagnolo S. Vito 2005), Mantova 2005.Bagnolo S. Vito 2007 = R.C. DE MARINIS, M. RAPI (a c.), L’abitato etrusco del Forcello di Bagnolo S. Vito (Man-
tova). Le fasi di età arcaica, Firenze 2007 (seconda edizione con aggiunte e correzioni).BALDONI 1981 = D. BALDONI, Spina. I doli di Valle Trebba, Ferrara 1981.BALDONI 1989 = D. BALDONI, Spina tra IV e III sec. a.C.: produttività locale alla luce dei recenti scavi d’abitato,
in Atti Mantova 1989, pp. 91-102. BALDONI, GIORDANI, MALNATI 1987 = D. BALDONI, N. GIORDANI, L. MALNATI, Alcune osservazioni sulla
romanizzazione della Valle Padana, in Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione (Atti del Colloquio Internazionale, Bologna 1985), Bologna 1987, pp. 397-404.
BALDONI, MORICO, PINI 2007 = D. BALDONI, G. MORICO, L. PINI, Materiali per una stratigrafia abitativa di Felsina: lo scavo bolognese di via Santa Caterina, in Comacchio 2007, pp. 49-107.
BARATTI 2005 = G. BARATTI, Gli scavi 1971-1973 nella Regio V, 5. Proposta per una classificazione della cera-mica depurata, in Atti Bologna 2005, pp. 239-245.
BARTOLONI et alii 1980 = G. BARTOLONI, A.M. BIETTI SESTIERI, M.A. FUGAZZOLA DELPINO, C. MORIGI GOVI, F. PARISE BADONI (a c.), Dizionari terminologici, 1, Materiali dell’età del Bronzo finale e della prima età del Ferro, Firenze 1980.
BATS 1988 = M. BATS, Vaisselle et alimentation à Olbia de Provence, v. 350-v. 50 avant J.-C. Modèles culturels et catégories céramiques, Paris 1988.
BEAZLEY 1947 = J.D. BEAZLEY, Etruscan Vase-Painting, Oxford 1947.BELLELLI, BOTTO 2002 = V. BELLELLI, M. BOTTO, I bacini di tipo fenicio-cipriota: considerazioni sulla diffusione
di una forma ceramica nell’Italia medio-tirrenica nel periodo compreso fra il VII e il VI secolo a.C., in Etruria e Sardegna centro-settentrionale tra l’Età del Bronzo finale e l’Arcaismo (Atti del XXI Convegno di Studi Etruschi ed Italici), Pisa-Roma 2002, pp. 277-307.
BENDI 2005 = C. BENDI, Materiali protostorici del Museo archeologico “Tobia Aldini” di Forlimpopoli, in «For-limpopoli» 16, 2005, pp. 1-18.
BENTINI 1989 = L. BENTINI, Fiorano, Cave Cuochi. I materiali, in Reggio Emilia 1989a, pp. 189-192.BENTINI, BOIARDI, VON ELES 1999 = L. BENTINI, A. BOIARDI, P. VON ELES, Il vasellame ceramico dell’età del
Ferro in Emilia e in Romagna, in Atti Lido di Camaiore 1999, pp. 335-349.
05 Bibliografia.indd 550 24/01/14 14.36
551
%LEOLRJUDÀD
BENTINI, FERRARI 1987 = L. BENTINI, D. FERRARI, Scavi nell’area dell’ex convento di San Domenico, in Bologna 1987, pp. 73-76.
BERGONZI 1985 = G. BERGONZI, Società della tarda età del Ferro, loro articolazioni e relazioni. L’area adriatica tra VI e IV secolo a.C., in Atti Bologna 1985, pp. 67-98.
BERMOND MONTANARI 1964-1965 = G. BERMOND MONTANARI, Arte Paleoveneta, in Arte e civiltà nell’Italia Settentrionale dalla repubblica alla tetrarchia (Catalogo della Mostra, Bologna 1964), II, Bologna 1964-1965.
BERMOND MONTANARI 1969 = G. BERMOND MONTANARI, La necropoli protostorica di S. Martino in Gattara (Ravenna), in «StEtr» 37, 1969, pp. 213-288.
BERMOND MONTANARI 1976 = G. BERMOND MONTANARI, Villa Rivalta (Comune di Reggio Emilia), in «StEtr» 44, 1976, pp. 408-409.
BERMOND MONTANARI 1985 = G. BERMOND MONTANARI, La Romagna tra VI e IV secolo nel quadro della protostoria italica, in Atti Bologna 1985, pp. 11-37.
BERMOND MONTANARI 1987 = G. BERMOND MONTANARI, Rubiera, in Bologna 1987, pp. 141-147.BERMOND MONTANARI 2005 = G. BERMOND MONTANARI, San Martino in Gattara (RA). Scavi 1969-1970,
in «Padusa» 41, 2005, pp. 193-221.BERMOND MONTANARI, MASSI PASI 1991= G. BERMOND MONTANARI, M. MASSI PASI, Pieve Sestina (Comune
di Cesena, Forlì), in «StEtr» 57, 1991, pp. 396-400.BERNABÒ BREA 1989 = M. BERNABÒ BREA (a c.), Quingento di S. Prospero fra II e I millennio a.C., Parma 1989.BERTANI 1997 = M.G. BERTANI, La Grotta del Re Tiberio, in Imola 1997, pp. 78-90.BERTI 1977 = F. BERTI, Valle Trebba; tombe n. 613 e n. 649, in «MusFerr» 7, 1977, pp. 120-132.BERTI 1987 = F. BERTI, Spina. L’abitato arcaico, in Bologna 1987, pp. 180-185.BERTI 2007 = F. BERTI, Su un gruppo di tombe di Spina da Valle Trebba, in Comacchio 2007, pp. 109-128.BERTI, GUZZO 1993 = F. BERTI, P.G. GUZZO (a c.), Spina. Storia di una città tra Greci ed Etruschi (Catalogo
della Mostra, Ferrara 1993-1994), Ferrara 1993.BIELLA 1971-1974 = S. BIELLA, L’Emilia occidentale, il Lodigiano ed il Pavese tra la fine dell’età del Bronzo e
l’inizio di quella del Ferro, in «EmPrerom» 7, 1971-1974, pp. 63-74.BIETTI SESTIERI 1999 = A.M. BIETTI SESTIERI, Classificazione, tipologia e terminologia in pratica, in Atti Lido
di Camaiore 1999, pp. 21-30. BINFORD 1962 = L.R. BINFORD, Archaeology as Anthropology, in «AmAnt» 28, 2, 1962, pp. 217-225.BINI, CARAMELLA, BUCCIOLI 1995 = M.P. BINI, G. CARAMELLA, S. BUCCIOLI, I bronzi etruschi e romani, Roma
1995.BOCCI 1965 = P. BOCCI, Catalogo della ceramica di Rusellae, in «StEtr» 33, 1965, pp. 109-190.Bologna 1960 = Mostra dell’Etruria padana e della città di Spina (Catalogo della Mostra, Bologna 1960),
Bologna 1960. Bologna 1979 = La necropoli villanoviana di Ca’ dell’Orbo a Villanova di Castenaso. Problemi del popolamento
dal IX al VI secolo a.C. (Catalogo della Mostra), Bologna 1979. Bologna 1987 = G. BERMOND MONTANARI (a c.), La formazione della città in Emilia Romagna. Prime esperienze
urbane attraverso le nuove scoperte archeologiche (Catalogo della Mostra, Bologna 1987-1988), II, Bologna 1987.
BOLOGNESI 1998-1999 = B. BOLOGNESI, Le necropoli Campelli-Stoppa e Bellucco in località Passetto (Adria), in «Padusa» 34-35, 1998-1999, pp. 245-316.
BONAMICI 1987 = M. BONAMICI, Necropoli della Cannicella. Le ceramiche di importazione e il bucchero, in «Ann-Faina» 3, 1987, pp. 99-110.
BONAMICI 1989 = M. BONAMICI, Contributo a Pisa arcaica, in Secondo congresso internazionale etrusco (Firenze 1985), Roma 1989, pp. 1135-1147.
BONAMICI 2003 = M. BONAMICI, Volterra. L’Acropoli e il suo santuario. Scavi 1987-1995, Pisa 2003.BONAMICI, STOPPONI, TAMBURINI 1994 = M. BONAMICI, S. STOPPONI, P. TAMBURINI, Orvieto. La necropoli di
Cannicella. Scavi della Fondazione per il Museo C. Faina e dell’Università di Perugia (1977), Roma 1994.BONDINI 2010 = A. BONDINI, La documentazione funeraria in Veneto tra l’età gallica e la romanizzazione, in
«Revista d’Archeologia de Ponent» 20, 2010, pp. 9-26.BONFATTI 1993 = L. BONFATTI, Mirandola, loc. Barchessone Barbiere, scavo di un pozzetto dell’età del Ferro, in
«QuadBassaModena» 24, 1993, pp. 65-74.
05 Bibliografia.indd 551 24/01/14 14.36
552
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
BONNET, BATIGNE VALLET 2001 = CH. BONNET, C. BATIGNE VALLET, Contribution à l’étude des céramiques grises kaolinitiques voconces d’après le mobilier issu des fouilles du tracé drômois du TGV méditerranée, in «Rei-CretActa» 37, 2001, pp. 73-88.
BONOMI, CAMERIN, TAMASSIA 2000 = S. BONOMI, N. CAMERIN, K. TAMASSIA, Aggiornamenti sulla ceramica alto-adriatica di Adria, in Adriatico tra IV e III sec. a.C. Vasi alto-adriatici tra Piceno, Spina e Adria (Atti del Convegno di Studi, Ancona 1997), Roma 2000, pp. 47-70.
BONOMI, CAMERIN, TAMASSIA 2002 = S. BONOMI, N. CAMERIN, K. TAMASSIA, Adria, via San Francesco, scavo 1994. Materiali dagli strati arcaici, in «Padusa» 38, 2002, pp. 201-213.
BONOMI, PERETTO, TAMASSIA 1993 = S. BONOMI, R. PERETTO, K. TAMASSIA, Adria. Appunti preliminari sulla necropoli tardoetrusca e romana di via Spolverin di Bottrighe, in «Padusa» 29, 1993, pp. 91-156.
BOTTAZZI 1985 = G. BOTTAZZI, Dieci anni di ricerche archeologiche in Val di Parma, in «ArchStorPr» s. IV, 36 (1984), 1985, pp. 377-393.
BOTTAZZI 1994 = G. BOTTAZZI, Archeologia territoriale e viabilità: spunti di ricerca sulle relazioni tra l’Emi-lia e il versante tirrenico dall’età del Bronzo al pieno Medioevo, in L’archeologia nei territori apuo-versiliese e modenese-reggiano (Atti delle Giornate di Studi, Massa 1993), Modena 1994, pp. 199-204.
BOULOUMIÉ 1975 = B. BOULOUMIÉ, Nouvelles traces d’habitat et tombes à Casalecchio di Reno (Bologne). Fouilles 1970 dans la propriété Melloni, in «MEFRA» 87, 1975, pp. 7-35.
BOULOUMIÉ 1976 = B. BOULOUMIÉ, La céramique locale de Marzabotto. Definition de quelques groupes, in «ME-FRA» 88, 1976, pp. 95-140.
BRANDT 1996 = J.R. BRANDT, Scavi di Ficana, 2.1, Il periodo protostorico e arcaico. Le zone di scavo 3b-c, Roma 1996.
BRIGHI 1990 = A. BRIGHI, Campegine. Tracce d’insediamenti, in Reggio Emilia 1990, pp. 157-159.BRIZIO 1887 = E. BRIZIO, Tombe e necropoli galliche della provincia di Bologna, in «AttiMemRomagna» 5,
1987, pp. 457-493.BRIZIO 1890 = E. BRIZIO, Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto presso Bologna dal novembre 1888 a tutto
maggio 1889, in «MonAnt» 1, 1890, cc. 249-426.BRIZIO 1899-1901 = E. BRIZIO, Il sepolcreto gallico di Montefortino presso Arcevia, in «MALinc» 9, 1899-
1901, cc. 617-791.BRUNI 1992 = S. BRUNI, Presenze di ceramica iberica in Etruria, in «RstLig» 58, 1992, pp. 37-65.BRUNI 1993 = S. BRUNI (a c.), Pisa. Piazza Dante. Uno spaccato della storia pisana. La campagna di scavo
1991, Pisa 1993.BRUNI 1997 = S. BRUNI, Materiali per Fiesole arcaica, in «AnnAcEtr» 51, 1995-1996 [1997], pp. 123-136.BRUNI 1998 = S. BRUNI, Pisa etrusca. Anatomia di una città scomparsa, Milano 1998.BRUSCHETTI 2012 = P. BRUSCHETTI, La necropoli di Crocifisso del Tufo a Orvieto. Contesti tombali, Pisa 2012.BUOITE, ZAMBONI 2008 = C. BUOITE, L. ZAMBONI, I materiali, in MALNATI, NERI 2008, pp. 51-136.CALZOLARI 1991 = M. CALZOLARI, Poggio Rusco (MN). Scoperta di due insediamenti della media età del Ferro,
in «QuadBassaModena» 20, 1993, pp. 5-18.CALZOLARI 1992a = M. CALZOLARI, Mirandola, località Miseria Vecchia. Resti d’abitato, in CALZOLARI, MAL-
NATI 1992, pp. 123-150.CALZOLARI 1992b = M. CALZOLARI, Mirandola, località Povertà. Tracce d’insediamento, in CALZOLARI, MAL-
NATI 1992, pp. 151-154.CALZOLARI 1992c = M. CALZOLARI, Mirandola, Area Barchessoni. Tracce di insediamenti, in CALZOLARI, MAL-
NATI 1992, pp. 155-169.CALZOLARI 1992d = M. CALZOLARI, Bondeno, località Barchessa e Zoccolina. Tracce di insediamenti, in CALZO-
LARI, MALNATI 1992, pp. 183-205.CALZOLARI 1993a = M. CALZOLARI, Nuovi siti dell’età del Ferro nelle Valli di Mirandola. Le ricerche di superficie
1991-1992, in «QuadBassaModena» 24, 1993, pp. 19-38.CALZOLARI 1993b = M. CALZOLARI, Mirandola, Loc. Barchessone Cappello. Insediamento di età etrusca con im-
pianto produttivo, in «QuadBassaModena» 24, 1993, pp. 75-114.CALZOLARI, GIORDANI 1990 = M. CALZOLARI, N. GIORDANI (a c.), Archeologia a Mirandola e nella Bassa
Modenese dall’Età del Bronzo al Medioevo, Mirandola 1990.CALZOLARI, MALNATI 1992 = M. CALZOLARI, L. MALNATI, Gli Etruschi nella Bassa modenese. Nuove scoperte e
prospettive di ricerca in un settore dell’Etruria padana, San Felice sul Panaro 1992.
05 Bibliografia.indd 552 24/01/14 14.36
553
%LEOLRJUDÀD
CAMERIN, TAMASSIA 1998-1999 = N. CAMERIN, K. TAMASSIA, Adria, via San Francesco. Scavo 1994. Edificio di tipo abitativo-artigianale di III-II secolo a.C., in «Padusa» 34-35, 1998-1999, pp. 209-243.
CAMPAGNOLI 1990 = P. CAMPAGNOLI, Lo scavo dell’Arginone, in CALZOLARI, GIORDANI 1990, pp. 74 ss.CAMPAGNOLI 1992a = P. CAMPAGNOLI, Mirandola, località Arginone, vasca per allevamento ittico. Resti di inse-
diamento, in CALZOLARI, MALNATI 1992, pp. 37-75.CAMPAGNOLI 1992b = P. CAMPAGNOLI, Mirandola, località Arginone, nord-est casa colonica. Abitato dell’Età del
Ferro. Ricerche di superficie: i materiali, in CALZOLARI, MALNATI 1992, pp. 85-94.CAMPOREALE 1970 = G. CAMPOREALE, La collezione Alla Querce: materiali archeologici orvietani, Firenze 1970.CAMPOREALE 2003 = G. CAMPOREALE, L’artigianato artistico, in Storia di Orvieto, Perugia 2003.CARAMELLA 1995 = G. CARAMELLA, Instrumentum da banchetto, in BINI, CARAMELLA, BUCCIOLI 1995, pp. 73-208.CARINI 2000 = A. CARINI, Il fegato di Piacenza, Piacenza 2000.CARINI SPROCCATO, BERNABÒ BREA 1990 = A. CARINI SPROCCATO, M. BERNABÒ BREA, Preistoria e Protostoria,
in Piacenza nella storia, Piacenza 1990, pp. 17-58, 523-529.Carpi 1985 = L. GERVASINI PIDATELLA (a c.), Ricerche archeologiche nel Carpigiano (Catalogo della Mostra,
Carpi 1984-1985), Modena 1985.CASINI 2005 = S. CASINI, La ceramica di produzione locale: impasto, bucchero, etrusco-padana, in Bagnolo S. Vito
2005, pp. 247-266. CASINI, DE MARINIS 2005 = S. CASINI, R. DE MARINIS, La città etrusca del Forcello, in Bagnolo S. Vito 2005,
pp. 35-53. CASINI, DE MARINIS, FANETTI 1999 = S. CASINI, R. DE MARINIS, D. FANETTI, L’abitato etrusco di Bagnolo S.
Vito (MN): lo scavo del terrapieno, in «NotABerg» 7, 1999, pp. 101-178.CASINI, DE MARINIS, RAPI 2001 = S. CASINI, R.C. DE MARINIS, M. RAPI, L’abitato protostorico di Como, in Atti
Como 2001, pp. 97-140.CASINI, FRONTINI 1989 = S. CASINI, P. FRONTINI, Prime osservazioni sulla ceramica grigia del Forcello e del
Castellazzo della Garolda (Mantova), in Atti Mantova 1989, pp. 147-160.CASINI, FRONTINI, GATTI 1986a = S. CASINI, P. FRONTINI, E. GATTI, La ceramica fine, in Mantova 1986, pp.
246-265.CASINI, FRONTINI, GATTI 1986b = S. CASINI, P. FRONTINI, E. GATTI, La ceramica grossolana, in Mantova
1986, pp. 266-280.CASINI, FRONTINI, GATTI 1987 = S. CASINI, P. FRONTINI, E. GATTI, Il Castellazzo della Garolda: la ceramica
fine, in Mantova 1987, pp. 193-199.CASSANI, DONAT, MERLATTI 2009 = G. CASSANI, P. DONAT, R. MERLATTI, La ceramica grigia nel Friuli Vene-
zia Giulia. Una proposta tipologica per olle e mortai, in «AquilNost» 80, 2009, pp. 133-170.CASSANI et alii 2007 = G. CASSANI, S. CIPRIANO, P. DONAT, R. MERLATTI, Il ruolo della ceramica grigia nella
romanizzazione dell’Italia nord-orientale. Produzione e cricolazione, in Aquileia dalle origini alla costituzione del ducato longobardo. Territorio, economia, società (Atti della XXXVII Settimana di Studi Aquileiesi, Aquileia 2006), Trieste 2007, pp. 249-281.
CATARSI, DALL’AGLIO 1987a = M. CATARSI, P.L. DALL’AGLIO, Il territorio piacentino dall’Età del Bronzo alla ro-manizzazione. Ipotesi sulla formazione dell’ethnos ligure, in Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale dal V secolo alla romanizzazione (Atti del Colloquio Internazionale, Bologna 1985), Imola 1987, pp. 405-414.
CATARSI DALL’AGLIO 1987b = M. CATARSI DALL’AGLIO, Rivergaro (Piacenza), in «StEtr» 53, 1987, pp. 366-368.CATARSI DALL’AGLIO 1997a = M. CATARSI DALL’AGLIO, Fidenza. Loc. Case Nuove di Siccomonte, in «AEmil»
I/2, 1997, pp. 39-42.CATARSI DALL’AGLIO 1997b = M. CATARSI DALL’AGLIO, Fidenza. Loc. Cà Il Pirlone, in «AEmil» I/2, 1997, p. 39.CATARSI DALL’AGLIO 1997c = M. CATARSI DALL’AGLIO, Fidenza. Loc. Cà Vecchia Cabriola, in «AEmil» I/2,
1997, p. 39.CATARSI DALL’AGLIO 1997d = M. CATARSI DALL’AGLIO, Campegine-Via Aldo Moro, in «AEmil» 1/2, 1997,
p. 44.CATARSI DALL’AGLIO 1998 = M. CATARSI DALL’AGLIO, L’insediamento etrusco di Case nuove di Siccomonte (Par-
ma), in Spina e il Delta Padano (Atti del Convegno Internazionale di Studi, Ferrara 1994), Roma 1998, pp. 247-252.
CATARSI DALL’AGLIO 2001 = M. CATARSI DALL’AGLIO, L’Età del Ferro, in Museo Archeologico Nazionale di Parma, Villanova di Ravenna 2001, pp. 49-54.
05 Bibliografia.indd 553 24/01/14 14.36
554
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
CATARSI DALL’AGLIO 2004 = M. CATARSI DALL’AGLIO, Il Parmense, in Genova 2004, pp. 241-243.CATARSI DALL’AGLIO, CARINI, MIARI 2004 = M. CATARSI DALL’AGLIO, A. CARINI, M. MIARI, Gli avamposti
etruschi verso il Po, in Genova 2004, pp. 241-245.CATARSI DALL’AGLIO, DONDI 1998 = M. CATARSI DALL’AGLIO, N. DONDI, Nuovi ritrovamenti dell’Età del
Ferro nel Parmense, in «AEmil» 2/1, 1998, pp. 61-73.CATARSI DALL’AGLIO, SASSATELLI 1991-1992 = M. CATARSI DALL’AGLIO, G. SASSATELLI, Fidenza (PR), Cabrio-
lo, loc. Case Nuove di Siccomonte, in «StDocA» 7, 1991-1992, pp. 120-122.CATTANI 1988a = M. CATTANI, La ceramica depurata, in Modena 1988, pp. 14-30.CATTANI 1988b = M. CATTANI, I resti di età etrusca, in Modena 1988, pp. 215-221.CATTANI 1988c = M. CATTANI, Età del Ferro. 428. Cittanova, in Modena 1988, pp. 180-183.CATTANI 1988d = M. CATTANI, Resti di età etrusca da Pasano (Savignano sul Panaro), in Modena 1988, pp.
255-258.CATTANI 1994 = M. CATTANI, Lo scavo di Tabina di Magreta, in «QuadMusMO» 1, 1994, pp. 186 ss.CATTANI, MACELLARI 1988 = M. CATTANI, R. MACELLARI, Età del Ferro. 901. Magreta (Formigine). Fossa del
Colombarone, in Modena 1988, p. 220.CELUZZA, CIANFERONI 2010 = M. CELUZZA, G.C. CIANFERONI (a c.), Signori di Maremma. Èlites etrusche fra
Populonia e Vulci (Catalogo della Mostra), Firenze 2010.CHANG 1967 = K.C. CHANG, Rethinking Archaeology, New York 1967.CHIARAMONTE TRERÉ 1999 = C. CHIARAMONTE TRERÉ, Tarquinia: scavi sistematici nell’abitato: campagne
1982-1988: i materiali, Roma 1999.CHIECO BIANCHI, CALZAVARA CAPUIS 1985 = A.M. CHIECO BIANCHI, L. CALZAVARA CAPUIS, Este I. Le necropoli
Casa di Ricovero, Casa Muletti Prosdocimi, Casa Alfonsi, Roma 1985.CHILDE 1960 = V.G. CHILDE, I frammenti del passato, Milano 1960.CIAMPOLTRINI 1981 = G. CIAMPOLTRINI, La ceramica “grigia” ellenistica del Valdarno inferiore, in «Erba d’Ar-
no» 3, 1981, pp. 65-73.CIAMPOLTRINI 1993 = G. CIAMPOLTRINI, Bucchero e ceramiche nella tradizione del bucchero nella Valle del Serchio
(VI-V secolo a.C.), in Atti Milano 1993, pp. 97-103.COGGI 1971-1974 = L. COGGI, Nuovi reperti dai fondi di capanna a Ca’ dei Dottori in territorio di Castell’Ar-
quato (Piacenza), in «EmPrerom» 7, 1971-1974, pp. 203-212.COLONNA 1974a = G. COLONNA, Ricerche sugli Etruschi e sugli Umbri a nord degli Appennnini, in «StEtr» 42,
1974, pp. 3-24.COLONNA 1974b = G. COLONNA, I Greci di Adria, in «RStorAnt» 4, 1974, pp. 1-21. COLONNA 1980a = G. COLONNA, Graffiti etruschi in Linguadoca, in «StEtr» 48, 1980, pp. 181-185. COLONNA 1980b = G. COLONNA, Problemi dell’archeologia e della storia di Orvieto etrusca, in «AnnFaina» 1,
1980, pp. 43-53.COLONNA 1984 = G. COLONNA, Il fegato di Piacenza e la tarda etruscità cispadana, in Culture figurative e ma-
teriali tra Emilia e Marche. Studi in memoria di Mario Zuffa, Rimini 1984, pp. 171-180.COLONNA 1985 = G. COLONNA, La Romagna fra Etruschi, Umbri e Pelasgi, in Atti Bologna 1985, pp. 44-65.COLONNA 1987 = G. COLONNA, Gli Etruschi della Romagna, in Atti San Giovanni 1987, pp. 37-44. COLONNA 1988 = G. COLONNA, Il lessico istituzionale etrusco e la formazione della città, specialmente in Emilia
Romagna, in Atti Bologna 1988, pp. 15-36.COLONNA 1993 = G. COLONNA, A proposito degli dei del Fegato di Piacenza, in «StEtr» 59, 1993, pp.
123-139.COLONNA 1999 = G. COLONNA, Felsina princeps Etruriae, in «CRAI» 1999, pp. 285-292. Comacchio 1996 = F. BERTI, S. BONOMI, M. LANDOLFI (a c.), Classico e anticlassico. Vasi alto-adriatici tra Pi-
ceno, Spina e Adria (Catalogo della Mostra, Comacchio 1996-1997), San Giovanni in Persiceto 1996.Comacchio 2006 = F. BERTI, M. BOLLINI, S. GELICHI, J. ORTALLI (a c.), Comaclum. Genti nel delta da Spina
a Comacchio. Uomini, territorio e culto dall’antichità all’alto medioevo (Catalogo della Mostra, Comacchio 2006-2007), Ferrara 2006.
COPPI 1871-1876 = F. COPPI, Monografia ed iconografia della terracimiteriale o terramara di Gorzano ossia mo-numenti di pura archeologia, I-II, Modena 1871-1876.
CORRADI CERVI 1940 = M. CORRADI CERVI, Appunti sulle stazioni etrusche del Parmense, in «ArchStorPr» s. III, 5, 1940, pp. 1-7.
05 Bibliografia.indd 554 24/01/14 14.36
555
%LEOLRJUDÀD
CREMASCHI 1975 = M. CREMASCHI (a c.), Preistoria e protostoria nel Reggiano. Ricerche e scavi 1940-1975, Reggio Emilia 1975.
CREMASCHI 1988 = M. CREMASCHI, Magreta (Formigine), in Modena 1988, pp. 341-346. CREMASCHI, MARCHETTI, DALL’AGLIO 1987 = M. CREMASCHI, G. MARCHETTI, P.L. DALL’AGLIO, Le direttrici
di traffico - Il settore emiliano, in Bologna 1987, pp. 13-43.CRISTOFANI 1973 = M. CRISTOFANI (a c.), Volterra. Scavi 1969-1971, in «NSc» 27, suppl., 1973, pp.
7-290.CRISTOFANI 1988 = M. CRISTOFANI, Processi di trasformazione socio-economica nell’Etruria Padana fra VI e V sec.
a.C., in Atti Bologna 1988, pp. 45-59.CRISTOFANI 1991 = M. CRISTOFANI, Introduzione allo studio dell’etrusco, Firenze 1991.CRISTOFANI 1997 = M. CRISTOFANI, Itinerari iconografici nella ceramografia volterrana, in Aspetti della cultura
di Volterra etrusca fra l’età del Ferro e l’età ellenistica (Atti del XIX Convegno Internazionale di Studi Etruschi ed Italici, Volterra 1995), Firenze 1997, pp. 175-192.
CROCE DA VILLA 1979 = P. CROCE DA VILLA, Osservazioni sulla ceramica grigia di Altino, in «AquilNost» 50, 1979, cc. 257-292.
CUOMO DI CAPRIO 2007 = N. CUOMO DI CAPRIO, La ceramica in archeologia 2: antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi di indagine, Roma 2007.
CUOZZO 1996 = M.A. CUOZZO, Prospettive teoriche e metodologiche nell’interpretazione delle necropoli. La post-processual archaeology, in «AnnAStorAnt» 3, 1996, pp. 1-37.
CUOZZO, D’AGOSTINO, DEL VERME 2006 = M. CUOZZO, B. D’AGOSTINO, L. DEL VERME (a c.), Cuma. Le for-tificazioni, II, I materiali dei terrapieni arcaici, Napoli 2006.
CUOZZO, D’ANDREA 1991 = M.A. CUOZZO, A. D’ANDREA, Proposta di periodizzazione del repertorio locale di Pontecagnano tra la fine del VII e la metà del V secolo a.C. alla luce della stratigrafia delle necropoli, in «An-nAStorAnt» 13, 1991, pp. 47-114.
CURINA et alii 2010 = R. CURINA, L. MALNATI, C. NEGRELLI, L. PINI (a c.), Alla ricerca di Bologna antica e medievale. Da Felsina a Bononia negli scavi di via D’Azeglio, Firenze 2010.
D’AGOSTINO, CERCHIAI 1999 = B. D’AGOSTINO, L. CERCHIAI, Il mare, la morte, l’amore. Gli Etruschi, i Greci e l’immagine, Roma 1999.
DALLEMULLE, MARZOLA 1977 = U. DALLEMULLE, E. MARZOLA, Una tomba di II sec. a.C. da Adria: la 45 di Ca’ Cima, in «Padusa» 13, 1977, pp. 3-53.
DAMIANI et alii 1992 = I. DAMIANI, A. MAGGIANI, E. PELLEGRINI, A.C. SALTINI, A. SERGES (a c.), L’età del Ferro nel reggiano. I materiali della collezione dei Civici Musei di Reggio Emilia, Reggio Emilia 1992.
DAMIANI, MAGGIANI, PELLEGRINI 1992 = I. DAMIANI, A. MAGGIANI, E. PELLEGRINI, Vasellame bronzeo, in DAMIANI et alii 1992, pp. 109-118.
DAMIANI, PELLEGRINI, SALTINI 1990a = I. DAMIANI, E. PELLEGRINI, A. SALTINI, San Rigo di Villa Coviolo. Tracce di insediamento, in Reggio Emilia 1990, pp. 169-175.
DAMIANI, PELLEGRINI, SALTINI 1990b = I. DAMIANI, E. PELLEGRINI, A. SALTINI, Canali. Insediamento con tracce di sepolture, in Reggio Emilia 1990, pp. 257-260.
DAMIANI, PELLEGRINI, SALTINI 1990c = I. DAMIANI, E. PELLEGRINI, A. SALTINI, San Bartolomeo. Insediamento con impianti produttivi, in Reggio Emilia 1990, pp. 141-146.
DEGANI 1951-1952 = M. DEGANI, Ragguagli sull’età del Ferro nel reggiano alla luce dei recenti ritrovamenti, in «EmPrerom» 3, 1951-1952, pp. 57-62.
DE MARINIS 1984 = R.C. DE MARINIS, Bagnolo S. Vito (MN), in «StEtr» 50, 1982 [1984], pp. 495-502.DE MARINIS 1986a = R.C. DE MARINIS, I commerci dell’Etruria con i paesi a nord del Po dal IX al VI secolo a.C.,
in Mantova 1986, pp. 52-89.DE MARINIS 1986b = R.C. DE MARINIS, Le necropoli, in Mantova 1986, pp. 288-299.DE MARINIS 1990 = R. DE MARINIS, L’età del Ferro, in Storia di Piacenza. Dalle origini all’anno mille, I/2,
Piacenza 1990, pp. 746-764.DE MARINIS 1999 = R. DE MARINIS, Il confine occidentale del mondo protoveneto e paleoveneto dal Bronzo finale alle
invasioni galliche del 388 a.C., in Atti Studi Etruschi 1999, pp. 511-564.DE MARINIS 2005 = R. DE MARINIS, Le iscrizioni etrusche del Forcello, in Bagnolo S. Vito 2005, pp. 57-76.DE MIN 1987 = M. DE MIN, L’abitato arcaico di S. Basilio, in Mantova 1987, pp. 84-91.DE MIN, IACOPOZZI 1986 = M. DE MIN, E. IACOPOZZI, L’abitato arcaico di S. Basilio di Ariano Polesine,
05 Bibliografia.indd 555 24/01/14 14.36
556
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
in L’antico Polesine. Testimonianze archeologiche e paleoambientali (Catalogo della Mostra, Adria-Rovigo 1986), Padova 1986, pp. 171-184.
DERIU, ZAMBONI 2008 = R. DERIU, L. ZAMBONI, Aspetti tecnologici, in MALNATI, NERI 2008, pp. 173-181.DESANTIS 1993 = P. DESANTIS, Spina. La città, in BERTI, GUZZO 1993, pp. 259-266.DESITTERE 1988 = M. DESITTERE, Reggio Emilia-Modena, in Paletnologi e studi preistorici nell’Emilia Romagna,
Reggio Emilia 1988, pp. 33-43.DE TOMMASO 1987 = G. DE TOMMASO, Ceramica grigia, in Artimino 1987, pp. 118-121.DONATI 1978 = L. DONATI, Ceramica orvietana arcaica con fregi ornamentali, in «AttiMemFirenze» 43,
1978, pp. 3-49.DONATI 1987 = L. DONATI, Ceramica fine a decorazione lineare dipinta, in Artimino 1987, pp. 100-102.DONATI 1993 = L. DONATI, Dalla Plumpe- alla Schnabelkanne nella produzione ceramica etrusca, in La civiltà
di Chiusi e del suo territorio (Atti del XVII Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Chianciano Terme 1989), Firenze 1993, pp. 239-263.
DONATI 1994 = L. DONATI, La casa dell’Impluvium. Architettura etrusca a Roselle, Roma 1994.DONATI, PARRINI 1999 = L. DONATI, A. PARRINI, Resti di abitazioni di età arcaica ad Adria. Gli scavi di
Francesco Antonio Bocchi nel Giardino Pubblico, in Atti Studi Etruschi 1999, pp. 567-614.DORAN 1970 = J.E. DORAN, Systems Theory, Computer Simulations and Archaeology, in «WorldA» 1, 3, 1970,
pp. 289-298.DUNNELL 1986 = R.C. DUNNELL, Methodological Issues in Americanist Artifact Classification, in «AMethTh»
9, 1986, pp. 149-207.DURANTE, GERVASINI 1987 = A.M. DURANTE, L. GERVASINI, Marzabotto, in Bologna 1987, pp. 316-325.FAROLFI 1981a = G. FAROLFI, Cesena. Casa del Diavolo, in VON ELES 1981, pp. 267-277.FAROLFI 1981b = G. FAROLFI, Cesena. S. Egidio, in VON ELES 1981, pp. 278-289.FAVARETTO et alii 2011 = I. FAVARETTO, F. GHEDINI, G. GORINI, I. COLPO (a c.), Tra protostoria e storia. Studi
in onore di Loredana Capuis, Roma 2011.Ferrara 1987 = Preistoria e Protostoria del bacino del basso Po (Atti del Convegno, Ferrara 1984), Ferrara 1987.FERRARI, MENGOLI 2005 = S. FERRARI, D. MENGOLI, I materiali di età celtica della struttura 2 di Casalecchio
di Reno (BO), zona “A”, in D. VITALI (a c.), Studi sulla media e tarda età del Ferro nell’Italia settentrionale, Bologna 2005, pp. 15-148.
FERRI, LOSI 1988 = F. FERRI, A. LOSI, La ceramica d’impasto, in Modena 1988, pp. 14-29.FESTANTI, GHERPELLI 1987 = M. FESTANTI, G. GHERPELLI, Storia illustrata di Reggio Emilia, Milano 1987. FINELLI 1987 = A. FINELLI, Materiali dall’abitato, in Bologna 1987, pp. 334-338.FIORENTINI 1963 = G. FIORENTINI, Prime osservazioni sulla ceramica campana nella valle del Po, in «RStLig»
29, 1963, pp. 7-52.FISTI 1993 = L. FISTI, Aspetti della produzione fiesolana in età ellenistica. La ceramica grigia, in «Atti e Memo-
rie dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria» 58, 1993, pp. 10-63.FOGOLARI 1981 = G. FOGOLARI, I Galli nell’Alto Adriatico, in Aquileia e l’Occidente (Atti della XI Settimana
di Studi Aquileiesi, Aquileia 1980), Udine 1981, pp. 15-49.FORTE 1989a = M. FORTE, Rubiera, Ca’ del Cristo. I materiali, in Reggio Emilia 1989a, pp. 125-137.FORTE 1989b = M. FORTE, Taneto. L’abitato. I materiali dal pozzo, in Reggio Emilia 1989b, pp. 87-91.FORTE 1989c = M. FORTE, Sant’Ilario d’Enza - località Bettolino: le strutture insediative, in Reggio Emilia
1989b, pp. 143-147.FORTE 1990 = M. FORTE, Villa Mancasale. Sepolcreto e tracce di abitato, in Reggio Emilia 1990, pp. 79-86.FORTE 1993 = M. FORTE, Qualche esempio di classificazione di immagini digitalizzate a proposito del bucchero di
Marzabotto, in Atti Milano 1993, pp. 73-86.FOUET 1970 = F. FOUET, Vases gaulois de la region toulousaine, in «Gallia» 28, 1970, pp. 11-23.FRANCOVICH, MANACORDA 2002 = R. FRANCOVICH, D. MANACORDA, Dizionario di archeologia. Temi, concetti
e metodi, Roma 2002.FRÈRE 2007 = D. FRÈRE (a c.), Ceramiche fini a decoro subgeometrico del VI secolo a.C. in Etruria meridionale e
in Campania, Roma 2007.FRONTINI, ONGARO 1996 = P. FRONTINI, G. ONGARO, Brescia tra l’età del Bronzo e l’età gallica, in ROSSI
1996, pp. 23-84. FROVA, SCARANI 1965 = A. FROVA, R. SCARANI, Parma. Museo Nazionale di Antichità, Parma 1965.
05 Bibliografia.indd 556 24/01/14 14.36
557
%LEOLRJUDÀD
GALLINA, MALNATI 1992 = M. GALLINA, L. MALNATI, Gli Etruschi e il loro ambiente, Cinisello Balsamo 1992. GAMBA 1987 = M. GAMBA, La ceramica etrusco-padana ad Este, in Mantova 1987, pp. 122-130.GAMBA, GAMBACURTA 1989 = M. GAMBA, G. GAMBACURTA, La ceramica etrusco-padana nel Veneto, in Atti
Mantova 1989, pp. 121-135. GAMBA, RUTA SERAFINI 1984 = M. GAMBA, A. RUTA SERAFINI, La ceramica grigia dallo scavo dell’area ex
Pilsen a Padova, in «AVen» 7, 1984, pp. 7-80.GAMBACURTA 1985 = G. GAMBACURTA, Coppe in ceramica semidepurata di età preromana provenienti dalle necro-
poli di Altino (Venezia), in «AVen» 8, 1985, pp. 149-199.GAMBACURTA 1987a = G. GAMBACURTA, La ceramica etrusco-padana di Altino, in Mantova 1987, pp. 131-
135.GAMBACURTA 1987b = G. GAMBACURTA, Ancora sulla ceramica semidepurata di età preromana proveniente dalle
necropoli di Altino (Venezia), in «AVen» 10, 1987, pp. 53-70.GAMBARI, COLONNA 1986 = F.M. GAMBARI, G. COLONNA, Il bicchiere con iscrizione arcaica da Castelletto Ticino
e l’adozione della scrittura nell’Italia nord-occidentale, in «StEtr» 54, 1986, pp. 119-159.GASTALDI 2009 = P. GASTALDI (a c.), Chiusi. Lo scavo del Petriolo (1992-2004), in «AIONArch» 17, Chiusi
2009. GAUCCI 2010 = A. GAUCCI, La ceramica etrusca figurata e a vernice nera, in GOVI, SASSATELLI 2010, II, pp.
45-76. Genova 2004 = R.C. DE MARINIS, G. SPADEA (a c.), I Liguri. Un antico popolo tra Alpi e Mediterraneo (Cata-
logo della Mostra, Genova 2004-2005), Ginevra-Milano 2004.GHIRETTI 1985 = A. GHIRETTI, Il popolamento preistorico nelle valli di Taro e Ceno, in «ArchStorPr» IV, 37,
1985, pp. 335-387.GHIRETTI, MACELLARI 1993 = A. GHIRETTI, R. MACELLARI, Un’iscrizione preromana rinvenuta sul Monte Ribo-
ne, nell’alta Val Taro, in «ArchStorPr» serie IV, 39 (1992), 1993, pp. 223-231.GIANFERRARI 1989 = A. GIANFERRARI, Fiorano modenese. Le strutture e i materiali, in Reggio Emilia 1989a,
pp. 163-178.GIANFERRARI 1990 = A. GIANFERRARI, San Rigo Biasola. Pozzetto di scarico, in Reggio Emilia 1990, pp. 165-167.GIANFERRARI, MACELLARI 1989 = A. GIANFERRARI, R. MACELLARI, Sant’Ilario d’Enza-Romei. Probabili tracce
d’abitato, in Reggio Emilia 1989b, pp. 165-167.GIULIANI POMES 1957 = M.V. GIULIANI POMES, Cronologia delle situle rinvenute in Etruria, II, in «StEtr» 25,
1993, pp. 39-84.GIUSTI 1993 = L. GIUSTI, Mirandola, loc. Barchessone Cappello, insediamento di età etrusca, scavo 1991: la cera-
mica d’impasto, in «QuadBassaModena» 24, 1993, pp. 76-101.GORI, PIERINI 2001 = B. GORI, T. PIERINI, Gravisca. Scavi nel santuario greco, 12, La ceramica comune, II, La
ceramica di argilla figulina, Bari 2001.GORI, PIERINI 2002 = B. GORI, T. PIERINI, Gravisca. Scavi nel santuario greco, 12, La ceramica comune, I,
Ceramica comune di impasto, Bari 2002.GOVI 1994a = E. GOVI, I graffiti, in SASSATELLI 1994a, pp. 213-236.GOVI 1994b = E. GOVI, Il Santuario per il culto delle acque della città etrusca di Marzabotto, Tesi di Specializ-
zazione in Archeologia, Università degli Studi di Bologna, a.a. 1993-1994.GOVI 1998a = E. GOVI, Il sepolcreto etrusco della Certosa di Bologna: rituale funerario e articolazione sociale, Dot-
torato di ricerca in Archeologia: città e produzione artistica (mondo greco, etrusco-italico, romano), Ciclo X, Università degli Studi di Padova, 1998.
GOVI 1998b = E GOVI, Il sepolcreto etrusco della Certosa, in G. PESCI (a c.), La Certosa di Bologna. Immortalità della memoria, Bologna 1998, pp. 83-89.
GOVI 1999 = E. GOVI, Le ceramiche attiche a vernice nera di Bologna, Bologna-Imola 1999.GOVI 2003 = E. GOVI, Ceramiche etrusche figurate dal sepolcreto della Certosa di Bologna, in «StEtr» 69, 2003,
pp. 43-70.GOVI 2009 = E. GOVI, Aspetti oscuri del rituale funerario nelle stele felsinee, in Etruria e Italia preromana. Studi
in onore di Giovannangelo Camporeale, Pisa 2009, pp. 455-463.GOVI 2010a = E. GOVI, Le tecniche di costruzione, in GOVI, SASSATELLI 2010, pp. 205-222.GOVI 2010b = E. GOVI, Le stele di Bologna di V sec. a.C. Modelli iconografici tra Grecia ed Etruria, in «Bol-
lettino di archeologia on line», 2010, pp. 36-48.
05 Bibliografia.indd 557 24/01/14 14.36
558
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
GOVI 2012 = E. GOVI, I vasi etruschi del “Gruppo di Adria”, in «Ocnus» 20, 2012, pp. 107-154. GOVI c.d.s. = E. GOVI, L’urbanistica etrusca in area padana, in J.A. BECKER, E.C. ROBINSON (a c.), Studies in
Italian Urbanism: the First Millennium BCE, in «JRA» Supplementary Series, c.d.s.GOVI, SASSATELLI 2004 = E. GOVI, G. SASSATELLI, Ceramica attica e stele felsinee, in «Hesperìa» 18, suppl.,
2004, pp. 227-265.GOVI, SASSATELLI 2010 = E. GOVI, G. SASSATELLI (a c.), Marzabotto. La Casa 1 della Regio IV – Insula 2,
Bologna 2010.GOZZADINI 1865 = G. GOZZADINI, Di un’antica necropoli a Marzabotto nel Bolognese, Bologna 1865.GRASSIGLI 1995 = G.L. GRASSIGLI, La ceramica grigia, in S. SANTORO BIANCHI (a c.), Castelraimondo. Scavi
1988-1990, II, Informatica, archeometria e studio dei materiali, Roma 1995, pp. 147-162.GRECO, PONTRANDOLFO 1990 = G. GRECO, A. PONTRANDOLFO (a c.), Fratte: un insediamento etrusco-campano,
Modena 1990.GREGNANIN 2002-2003 = R. GREGNANIN, Le tombe di romanizzazione e di età romana dallo scavo del 1959 di
G.B. Frescura nella necropoli meridionale di Este, in «AVen» 25, 2002-2003, pp. 7-90.GUALANDI 1970 = G. GUALANDI, Il santuario fontile a nord della città, in «StEtr» 38, 1970, pp. 217-223.GUARNIERI 1988 = C. GUARNIERI, Il pozzo di Pian del Monte, la ceramica acroma a vernice nera, in Atti Bologna
1988, pp. 263-264.GUARNIERI 2007 = C. GUARNIERI, Archeologia nell’Appennino romagnolo. Il territorio di Riolo Terme, Imola 2007.GUIDI 1988 = A. GUIDI, Storia della paletnologia, Roma-Bari 1988.GUIDI 2005 = A. GUIDI, I metodi della ricerca archeologica, Roma-Bari 2005.HANNESTAD 1974 = L. HANNESTAD, The Paris Painter, an Etruscan Vase-Painter, Copenhagen 1974.HANNESTAD 1976 = L. HANNESTAD, The followers of the Paris Painter, Copenhagen 1976.HARRIS 1971 = M. HARRIS, L’evoluzione del pensiero antropologico. Una storia della teoria della cultura, Bolo-
gna 1971.HEURGON 1981 = J. HEURGON, Les graffites d’Aleria, in J. JEHASSE, L. JEHASSE, La nécropole préromaine d’Ale-
ria, Paris 1973, pp. 547 ss.HUDSON 1981 = K. HUDSON, A Social History of Archaeology. The British Experience, London 1981.Imola 1997 = M. PACCIARELLI (a c.), Acque, grotte e Dei. 3000 anni di culti preromani in Romagna, Marche e
Abruzzo (Catalogo della Mostra, Imola 1997), Fusignano 1997. IOZZO, GALLI 2003 = M. IOZZO, F. GALLI, Guida al Museo Archeologico Nazionale di Chiusi, Chiusi 2003.JURGEIT 1986 = F. JURGEIT, Cistenfüsse etruskische und praenestiner Bronzewerkstätten, Roma 1986.KLEJN 1982 = L.S. KLEJN, Archaeology Typology, London 1982.KOHL 1981 = P.L. KOHL, Materialist Approaches in Prehistory, in «AnnRevAnth» l0, 1981, pp. 89-118.KRUTA, MALNATI, CARDARELLI 1991 = V. KRUTA, L. MALNATI, A. CARDARELLI, Magreta (Comm. De Formigine
prov. de Modène): “Podere Decina”, in «MEFRA» l03.1, 1991, pp. 361-365.LABATE 2006 = D. LABATE (a c.), Fiorano e la valle del torrente Spezzano. Archeologia di un territorio, Firenze
2006.LABATE, MALNATI 1989 = D. LABATE, L. MALNATI, Rubiera Ca’ del Cristo: testimonianze di un insediamento
rustico di età etrusca, in Reggio Emilia 1989a, pp. 115-124.LACCHINI 2009 = V. LACCHINI, Catalogo dei materiali, in San Marino 2009, pp. 159-177.LASAGNA PATRONCINI 1973 = C. LASAGNA PATRONCINI, Un cinerario della II età del Ferro a Corticella di Villa
Bagno, in «QuadAReggio» 2, 1973, pp. 150-153.LASAGNA PATRONCINI 1981 = C. LASAGNA PATRONCINI, Nuovi materiali etruscoidi dal greto del medio Secchia,
in «QuadAReggio» 4, 1981, pp. 65-108.LASAGNA PATRONCINI 1982 = C. LASAGNA PATRONCINI, Rubiera (Reggio Emilia), in «StEtr» 50, 1984, pp.
454-457.LASAGNA PATRONCINI 1990 = C. LASAGNA PATRONCINI, Materiali sparsi attribuibili all’età del Ferro, in «Qua-
dAReggio» 5, 1990, pp. 135-164.LEONARDI, PRACCHIA, VIDALE 1989 = G. LEONARDI, S. PRACCHIA, M. VIDALE, L’indicatore ceramico nei percorsi
archeologici, in Atti Preistoria Protostoria 1989, pp. 85-104.LEVI 2010 = S.T. LEVI, Dal coccio al vasaio. Manifattura tecnologia e classificazione della ceramica, Bologna 2010.LIPPOLIS 1998 = E. LIPPOLIS, Rubiera, Ca’ del Pino, in «AEmil» 2/2, 1998, pp. 40-41.LIPPOLIS 2000 = E. LIPPOLIS, Le importazioni greche in Emilia fra VII e VI secolo, in L. BRACCESI (a.c.),
05 Bibliografia.indd 558 24/01/14 14.36
559
%LEOLRJUDÀD
Dall’Adriatico greco all’Adriatico veneziano. Archeologia e leggenda troiana (Atti del Convegno, Venezia 1997), «Hesperìa» 12, 2000, pp. 98-118.
LIPPOLIS, PINI, SANI 1998 = E. LIPPOLIS, L. PINI, S. SANI, L’insediamento preromano di Monteacuto Ragazza, in «AEmil» 2/1, 1998, pp. 75-90.
LOCATELLI 2004 = D. LOCATELLI, Il modenese, in Genova 2004, pp. 239-240.LOCATELLI 2006 = D. LOCATELLI, Età etrusca: la fattoria di Cave San Lorenzo, in LABATE 2006, pp. 40-50.LOLLINI 1977 = D.G. LOLLINI, La civiltà picena, in Popoli e civiltà dell’Italia antica, V, 1977, pp. 107-195.LOLLINI 1985 = D.G. LOLLINI, Rapporto tra area romagnola e picena nel VI-IV sec. a.C., in Atti Bologna 1985,
pp. 323-350.LOSI 1989a = A. LOSI, Cacciola di Scandiano, in Reggio Emilia 1989a, pp. 143-157.LOSI 1989b = A. LOSI, Sant’Ilario d’Enza - Cave Gazzani. Tracce d’insediamento, in Reggio Emilia 1989b, pp. 71-75.LOSI 1989c = A. LOSI, Gaida - Valle Re. Tracce d’insediamento, in Reggio Emilia 1989b, pp. 67-69.LOSI 1990 = A. LOSI, Sant’Ilario d’Enza-Ceresola Nova, in Reggio Emilia 1990, pp. 57-65.LOSI 1999 = A. LOSI, Il materiale ceramico dello scavo di Zola Predosa, località Pilastrino, in T. RAVASIO, E.
SILVESTRI, A. LOSI, C. BENDI, R. BURGIO, S. CAMPAGNARI, G. MIGNARDI (a c.), Zola nell’età del Ferro. Gli scavi al Pilastrino, Savignano sul Panaro 1999, pp. 27-40.
LOWTHER 1962 = G.R. LOWTHER, Epistemology and Archaeological Theory, in «Current Anthropology» 3, 1962, pp. 217-225.
LUPPI 1992 = M.T. LUPPI, Finale Emilia, loc. Colombara Borsari. Tracce di insediamento, in CALZOLARI, MAL-NATI 1992, pp. 171-177.
MACELLARI 1981-1982 = R. MACELLARI, Due graffiti vascolari etruschi al museo di Parma, in «EmPrerom» 9-10, 1981-1982, pp. 278-280.
MACELLARI 1987 = R. MACELLARI, Casale di Villa Rivalta, in Bologna 1987, pp. 173-175.MACELLARI 1989a = R. MACELLARI, Castellarano. L’abitato sull’altura del castello. Le testimonianze più antiche,
in Reggio Emilia 1989a, pp. 193-199.MACELLARI 1989b = R. MACELLARI, Taneto. L’abitato. Le strutture e i materiali dei “forni”, in Reggio Emilia
1989, pp. 77-85.MACELLARI 1989c = R. MACELLARI, Sant’Ilario d’Enza-Romei. Il sepolcreto, in Reggio Emilia 1989b, pp. 169-192.MACELLARI 1989d = R. MACELLARI, Montecchio. Insediamento di tipo rustico in località il monte. Il sepolcreto
situato nei pressi del monte, in Reggio Emilia 1989b, pp. 215-224.MACELLARI 1989e = R. MACELLARI, Ca’ del Pino. Il sepolcreto e ritrovamenti sporadici, in Reggio Emilia 1989a,
pp. 51-58.MACELLARI 1990 = R. MACELLARI, L’età tardo-orientalizzante e arcaica, in Reggio Emilia 1990, pp. 33-37.MACELLARI 1996 = R. MACELLARI, Testimonianze preromane nel centro storico di Reggio Emilia, in Reggio Emilia
1996, pp. 25-29.MACELLARI 2000 = R. MACELLARI, Nuovi dati sul deposito votivo del Lago Bracciano presso Montese (Modena),
in «MiscStArch» 5, Modena 2000, pp. 7-12. MACELLARI 2002 = R. MACELLARI, Il sepolcreto etrusco nel terreno Arnoaldi di Bologna (550-350 a.C.), Bologna
2002.MACELLARI 2004 = R. MACELLARI, Gli Etruschi del Po, in «Ocnus» 12, 2004, pp. 145-160. MACELLARI 2008 = R. MACELLARI, Rapporti fra Etruschi e mondo ligure, in «AnnFaina» 15, 2008, pp. 365-400.MACELLARI, FORTE 1989 = R. MACELLARI, M. FORTE, Taneto: l’abitato, le strutture e i materiali dai “forni”, i
materiali dal pozzo, in Reggio Emilia 1989b, pp. 77-136.MACELLARI, LOCATELLI 2004 = R. MACELLARI, D. LOCATELLI, La colonizzazione etrusca nella Val Padana, in
Genova 2004, pp. 238-240. MACELLARI, MUTTI 1989 = R. MACELLARI, A. MUTTI, Fraore di S. Pancrazio (Parma). Testimonianze del II e
del I millennio a.C. al Museo di Parma, in «Padusa» 25, 1989, pp. 345-386. MACELLARI, SQUADRINI, BENTINI 1990 = R. MACELLARI, G. SQUADRINI, L. BENTINI, Casale di Rivalta. Inse-
diamento con impianti produttivi, in Reggio Emilia 1990, pp. 177-224.MACELLARI, TIRABASSI 1997 = R. MACELLARI, J. TIRABASSI, Catasto archeologico della provincia di Reggio Emi-
lia. Montecchio Emilia, Reggio Emilia 1997. MAGAGNINI 1953-1955 = E. MAGAGNINI, Tracce della civiltà etrusca nella Provincia di Reggio Emilia, in
«EmPrerom» 4, 1953-1955, pp. 45 ss.
05 Bibliografia.indd 559 24/01/14 14.36
560
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
MAGAGNINI 1993 = A. MAGAGNINI, La ceramica ellenistica, in La Collezione Casuccini 1, Roma 1993, pp. 37 ss.MAGGIANI 1979 = A. MAGGIANI, REE, in «StEtr» 47, 1979, pp. 326-327.MAGGIANI 1985 = A. MAGGIANI, Pisa, Spina e un passo controverso di Scilace, in Atti Bologna 1985, pp.
307-319.MAGGIANI 1990a = A. MAGGIANI, San Rocchino (Massarosa), in Pontedera 1990, pp. 69-96.MAGGIANI 1990b = A. MAGGIANI, Pozzi, Case Baldi (Serravezza). I materiali, in Pontedera 1990, pp. 138-
146.MAIOLI 1976 = M.G. MAIOLI, IV Periodo, in G. FOGOLARI, A.M. CHIECO BIANCHI (a c.), Padova preromana
(Catalogo della Mostra), Padova 1976, pp. 161-165.MALNATI 1981-1982 = L. MALNATI, L’insediamento della media età del Ferro a Serramazzoni (Modena), in
«EmPrerom» 9-10, 1981-1982, pp. 266-277.MALNATI 1984a = L. MALNATI, Campegine (Reggio Emilia), in «StEtr» 50, 1984, pp. 446-447.MALNATI 1984b = L. MALNATI, Quattro Castella (Reggio Emilia). Località Poggio Vendina, in «StEtr» 50,
1984, pp. 452-453.MALNATI 1985a = L. MALNATI, Note preliminari sullo scavo di un insediamento della media età del Ferro a Reggio
Emilia, in Atti Bologna 1985, pp. 171-184.MALNATI 1985b = L. MALNATI, Considerazioni sulla media età del Ferro in Emilia occidentale e rapporti con
l’area felsinea e romagnola, in Atti Bologna 1985, pp. 143-170.MALNATI 1985c = L. MALNATI, Il territorio carpigiano durante l’età del Ferro, in Carpi 1985, pp. 29-49. MALNATI 1987a = L. MALNATI, Casale di Villa Rivalta, in Bologna 1987, pp. 173-175.MALNATI 1987b = L. MALNATI, Quattro Castella (Reggio Emilia), in «StEtr» 53, 1987, pp. 452-453.MALNATI 1987c = L. MALNATI, Rubiera (Reggio Emilia), in «StEtr» 53, 1987, pp. 368-370.MALNATI 1987d = L. MALNATI, Rubiera, località Ca’ del Cristo, in Bologna 1987, pp. 170-172.MALNATI 1987e = L. MALNATI, Reggio Emilia, Loc. San Claudio, in «StEtr» 53, 1987, pp. 363-366.MALNATI 1987f = L. MALNATI, San Claudio, in Bologna 1987, pp. 160-165.MALNATI 1987g = L. MALNATI, Sant’Ilario d’Enza - località Bettolino, in Bologna 1987, pp. 151-159.MALNATI 1987h = L. MALNATI, Sant’Ilario d’Enza - località Burrasca, in Bologna 1987, pp. 175-176.MALNATI 1987i = L. MALNATI, Marzabotto: la fase arcaica, in Bologna 1987, pp. 125-137.MALNATI 1988a = L. MALNATI, Il bucchero, in Modena 1988, pp. 29-32.MALNATI 1988b = L. MALNATI, Lo scavo di una fattoria etrusca a Baggiovara - Località Case Vandelli, in Mo-
dena 1988, pp. 262-271.MALNATI 1989a = L. MALNATI, Rubiera, Cave Guidetti, in Reggio Emilia 1989a, pp. 73-91.MALNATI 1989b = L. MALNATI, I pozzi etruschi di Rubiera, in Reggio Emilia 1989a, pp. 93-112.MALNATI 1989c = L. MALNATI, Sant’Ilario d’Enza - località Bettolino. La necropoli, in Reggio Emilia 1989b,
pp. 149-163.MALNATI 1989d = L. MALNATI, Sant’Ilario d’Enza. Il pozzo etrusco in località Burrasca. I reperti e la cronologia,
in Reggio Emilia 1989b, pp. 203-213.MALNATI 1990 = L. MALNATI, L’Emilia centrale in età ellenistica: spunti di discussione, in «EC» 27, 1990, pp.
43-70.MALNATI 1993 = L. MALNATI, Il bucchero in Emilia. Elementi per una catalogazione preliminare, in Atti Milano
1993, pp. 43-71.MALNATI 2004 = L. MALNATI, Il ruolo dell’aristocrazia nell’affermazione del dominio etrusco in Val Padana tra
il IX e la fine del VII secolo a.C., in Guerrieri, principi ed eroi fra il Danubio e il Po dalla preistoria all’alto Medioevo (Catalogo della Mostra), Trento 2004, pp. 248-257.
MALNATI, BASONI 1991 = L. MALNATI, S. BIASONI, Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), in «StEtr» 57, 1991, pp. 401-402.
MALNATI et alii 1990 = L. MALNATI, M. CALZOLARI, P. CAMPAGNOLI, P. FARELLO, Nuovi dati sull’età del Ferro nella bassa pianura modenese, in CALZOLARI, GIORDANI 1990, pp. 59-83.
MALNATI, FORTE 1989 = L. MALNATI, M. FORTE, Sant’Ilario d’Enza - località Bettolino: il sepolcreto, le strutture insediative, la necropoli, in Reggio Emilia 1989b, pp. 137-163.
MALNATI, LOSI 1990 = L. MALNATI, A. LOSI, San Claudio. Abitato con impianti produttivi, in Reggio Emilia 1990, pp. 87-125.
MALNATI, NERI 2001 = L. MALNATI, D. NERI (a c.), La necropoli e l’abitato villanoviano “al Galoppatoio” di
05 Bibliografia.indd 560 24/01/14 14.36
561
%LEOLRJUDÀD
Castelfranco Emilia. Aspetti della vita e della morte degli Etruschi. La cultura villanoviana a Castelfranco Emilia (Mostra archeologica, Castelfranco Emilia 2001-2002), Firenze 2001.
MALNATI, NERI 2008 = L. MALNATI, D. NERI (a c.), Gli scavi di Castelfranco Emilia presso il Forte Urbano. Un abitato etrusco alla vigilia delle invasioni celtiche, Firenze 2008.
MALNATI, TIRABASSI 1982 = L. MALNATI, J. TIRABASSI, S. Ilario d’Enza, in «StEtr» 50, 1982, pp. 457-458. MALNATI, VIOLANTE 1995 = L. MALNATI, A. VIOLANTE, Il sistema urbano di IV e III secolo in Emilia-Romagna
tra Etruschi e Celti (Plut. Vita Cam. 16, 3), in Europe celtique du Ve au IIIe siècle avant J.-C. Contacts, échan-ges et mouvements de populations (Actes du Deuxième Symposium International d’Hautvillers 1992), Sceaux 1995, pp. 97-123.
MAMBELLA 1983 = R. MAMBELLA, Una classe di ceramica locale adriese, in «BMusPadova» 72, 1983, pp. 7-19.MANIERE 1978 = G. MANIERE, Fours de potiers gaulois, in «Gallia» 36, 1978, 1, pp. 21-41.MANINO 1971 = L. MANINO, Kioniskoi di Misano, in «StEtr» 39, 1971, pp. 231-248.MANSUELLI et alii 1982 = G.A. MANSUELLI, A.M. BRIZZOLARA, S. DE MARIA, G. SASSATELLI, Guida alla città
etrusca e al museo di Marzabotto, Bologna 1982.Mantova 1986 = R.C. DE MARINIS (a c.), Gli Etruschi a Nord del Po (Catalogo della Mostra, Mantova 1986-
1987), I, Mantova 1986. Mantova 1987 = R.C. DE MARINIS (a c.), Gli Etruschi a Nord del Po (Catalogo della Mostra, Mantova 1986-
1987), II, Mantova 1987. MARINI CALVANI 1978 = M. MARINI CALVANI, Prima dell’antichità. Dalla preistoria all’evo antico, in Parma
la città storica, Parma 1978, pp. 17-67.MARINI CALVANI 2001 = M. MARINI CALVANI, Guida al Museo Archeologico Nazionale di Parma, Ravenna
2001, pp. 49-54.MARINI CALVANI, CATARSI DALL’AGLIO 1988 = M. MARINI CALVANI, M. CATARSI DALL’AGLIO, Quingento di
San Prospero (Parma) e territorio parmense, in Aes signatum - Un aspetto dell’economia nell’Emilia preromana (Catalogo della Mostra), Reggio Emilia 1988, pp. 29-38.
MARTELLI 1976 = M. MARTELLI, Recensione a A. Emiliozzi. La Collezione Rossi Danielli nel Museo Civico di Viterbo, in «Prospettiva» 4, 1976, pp. 42-49.
MARTELLI 1977 = M. MARTELLI, Per il pittore di Feoli, in «Prospettiva» 11, 1977, pp. 2-12.MASSA PAIRAULT 1997 = F.-H. MASSA PAIRAULT (éd.), Marzabotto. Recherches sur l’Insula V, 3, Roma 1997. MASSI PASI 1981 = M. MASSI PASI, Casola Valsenio. Podere Monteroni, in VON ELES 1981, pp. 158-170. MATTEUCCI 1986 = P. MATTEUCCI, L’uso dei mortai di terracotta nell’alimentazione antica, in «StClOr» 36,
1986, pp. 239-277.MATTIOLI 1997 = C. MATTIOLI, La città etrusca di Marzabotto. Le campagne di scavo del Dipartimento di Archeo-
logia dell’Università di Bologna, in «Ocnus» 5, 1997, pp. 269-272.MATTIOLI 2005 = C. MATTIOLI, La ceramica etrusca di area padana. Verso una tipologia generale ed un linguaggio
comune, in Atti Bologna 2005, pp. 247-266.MATTIOLI 2009 = C. MATTIOLI, La produzione ceramica etrusco-padana in Emilia occidentale, in Atti Milano
2009, pp. 203-217.MATTIOLI 2010 = C. MATTIOLI, I materiali ceramici di produzione locale (depurata, grezza e bucchero), in GOVI,
SASSATELLI 2010, pp. 95-178.MATTIOLI 2011 = C. MATTIOLI, La ceramica etrusco-padana tra Etruschi e Veneti, in FAVARETTO et alii 2011,
pp. 119-129. MAZZANTI 1986 = R. MAZZANTI (a c.), Terra e Paduli: reperti, documenti e immagini per la storia di Coltano,
Pontedera 1986.MAZZEO SARACINO, GIANNOTTI 2005 = L. MAZZEO SARACINO, G. GIANNOTTI, Romanizzazione e mutamenti
del costume alimentare in territorio marchigiano; studio delle fonti e analisi dei materiali ceramici: il mortaio, in Communities and Settlements from the Neolithic to the Early Medieval Period (Atti del Convegno, Groningen 2003), Oxford 2005, pp. 376-389.
MELANI 2003 = C. MELANI, La ceramica grigia, in S. BRUNI, Il porto urbano di Pisa antica: la fase etrusca, il contesto e il relitto ellenistico, Cinisello Balsamo 2003, pp. 13-14.
MELLI 1993 = P. MELLI, Buccheri ed “impasti buccheroidi” in Liguria, in Atti Milano 1993, pp. 105-126.MENESCARDI, NUNZIATI, RESTELLI 2009 = S. MENESCARDI, F. NUNZIATI, E. RESTELLI, Il sito di Baggiovara-
Case Vandelli (MO), in Atti Milano 2009, pp. 267-347.
05 Bibliografia.indd 561 24/01/14 14.36
562
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
MENOTTI, BARATTI 2006 = E.M. MENOTTI, G. BARATTI, La Boccazzola Nuova di Poggio Rusco. Un sito etrusco nell’Oltrepò mantovano, Mantova 2006.
MIARI 2000 = M. MIARI, Stipi votive dell’Etruria padana, Roma 2000.MIARI, LOSI 2009 = M. MIARI, A. LOSI, Un insediamento dell’età del Ferro al Poggio di Carmiano (Vigolzone -
Pc), in Atti Milano 2009, pp. 115-131.MICHELUCCI 1982 = M. MICHELUCCI (a c.), Saturnia: ricerche nell’area urbana e nella necropoli del Puntone,
Pitigliano 1982.MILANESE 1986 = M. MILANESE, Rapporti fra Marsiglia e Genova dal V al I secolo a.C.: informazioni archeolo-
giche dai recenti scavi di Genova, in Studi in memoria di T.O. De Negri, I, Genova 1986, pp. 9-20.MILANESE 1987 = M. MILANESE, Scavi nell’oppidum preromano di Genova, Roma 1987.MINETTI 1993 = A. MINETTI, Materiale residui di età arcaica ed ellenistica, in BRUNI 1993, pp. 325-337.MINETTI 2006 = A. MINETTI, La Tomba della Quadriga Infernale nella necropoli delle Pianacce di Sarteano, Roma
2006.MINETTI, RASTRELLI 2001 = A. MINETTI, A. RASTRELLI, La necropoli della Palazzina nel Museo Civico Archeolo-
gico di Sarteano, Siena 2001.MINGUZZI et alii 1995 = V. MINGUZZI, N. MORANDI, M.C. NANNETTI, P. TRENTINI, C. MATTIOLI, M. MAR-
CHESI, T. TROCCHI, Caratterizzazione minero-geochimica e studi termici di varie tipologie di “Concotto” di età etrusca (Marzabotto, Bologna), in «MinerPetrogrActa» 38, 1995, pp. 1-9.
MINTO 1914 = A. MINTO, Pitigliano. Nuova scoperta di tombe nella necropoli etrusca, in «NSc» 1914, pp. 88-93.Modena 1988 = A. CARDARELLI (a c.), Modena dalle origini all’anno Mille. Studi di Archeologia e di Storia,
Modena 1988.Modena 2003 = A. CARDARELLI, L. MALNATI (a c.), Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena.
Volume I. Pianura, Firenze 2003.Modena 2006 = A. CARDARELLI, L. MALNATI (a c.), Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena.
Volume II. Montagna, Firenze 2006.Modena 2009 = A. CARDARELLI, L. MALNATI (a c.), Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena.
Volume III, 1-2. Collina e Alta Pianura, Firenze 2009.MONACO 1952 = G. MONACO, Sorbolo, in “Notiziario”, «RScPreist» 7, 1952, p. 254. MONTAGNA PASQUINUCCI 1972 = M. MONTAGNA PASQUINUCCI, La ceramica a vernice nera del Museo Guarnacci
di Volterra, in «MEFRA» 84, 1972, pp. 269-498.MONTELIUS 1874 = O. MONTELIUS, La suède préhistorique, Stockholm 1874.MONTELIUS 1885 = O. MONTELIUS, Sur la cronologie de l’Age du Bronze, in «MatHistHom» 28, 1885, pp.
38 ss.Montereggi 1985 = L. ALDERIGHI, E. BALDACCI, F. BERTI (a c.), L’abitato etrusco di Montereggi. Scavi 1982-
1985 (Catalogo della Mostra), Vinci 1985. MORANDI et alii 1996 = N. MORANDI, M.C. NANNETTI, V. MINGUZZI, S. MONTI, M. MARCHESI, C. MAT-
TIOLI, F. DESALVO, Ceramics from the Etruscan City of Marzabotto: Feological-mineralogical Approach and Connections with Raw Materials, in «MinerPetrogrActa» 39, 1996, pp. 341-350.
MORANDI et alii 1997 = N. MORANDI, M.C. NANNETTI, V. MINGUZZI, M. MARCHESI, C. MATTIOLI, Ceramiche e argille della città etrusca di Marzabotto, in Atti Bologna 1997, pp. 40-45.
MOREL 1963 = J.P. MOREL, Notes sur la céramique Etrusco-campanienne, vases à vernis noir de la Sardaigne et d’Arezzo, in «MEFRA» 75, 1963, pp. 5-58.
MOREL 1981 = J.P. MOREL, Cèramique campanienne. Les Formes, Roma 1981.MOREL 1987 = J.P. MOREL, La céramique à vernis noir en Italie septentrionale, in Celti ed Etruschi nell’Italia
centro-settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione (Atti del Colloquio Internazionale, Bologna 1985), Bologna 1987, pp. 111-134.
MORIGI GOVI 1969 = C. MORIGI GOVI, Problemi artistici e cronologici del Villanoviano IV a Bologna, in «At-tiMemBologna» 20, 1969, pp. 21-46.
MORIGI GOVI, COLONNA 1981 = C. MORIGI GOVI, G. COLONNA, L’anforetta con iscrizione etrusca da Bologna, in «StEtr» 49, 1981, pp. 67-93.
MORPURGO 2010 = G. MORPURGO, La ceramica grigia, in GOVI, SASSATELLI 2010, pp. 179-199.MORPURGO 2011 = G. MORPURGO, Il sepolcreto etrusco De Luca di Bologna, Dottorato di ricerca, Università
degli Studi di Padova, Ciclo XXIII, a.a. 2010-2011.
05 Bibliografia.indd 562 24/01/14 14.36
563
%LEOLRJUDÀD
MUGGIA 2004 = A. MUGGIA, Impronte nella sabbia. Tombe infantili di Valle Trebba, Firenze 2004. MÜLLER 1876 = S. MÜLLER, Bronzealderens perioder. En Undersgelse i forhistorik archaeologi, in «AarbNOH»,
1876, pp. 185-232. MUNSELL 2000 = A.H. MUNSELL, Soil Color Charts, New Windsor 2000.MUSSINI, LASAGNA PATRONCINI 1980 = P. MUSSINI, C. LASAGNA PATRONCINI, Un deposito di materiale della
seconda età del Ferro a Villa Moncasale (Reggio Emilia), in «QuadAR» 4, 1980, pp. 109 ss. NANNETTI et alii 2010 = M.C. NANNETTI, V. MINGUZZI, E. ZANTEDESCHI, E. ESQUILINI, Le analisi archeome-
triche, in GOVI, SASSATELLI 2010, II, pp. 421-437.NEGRELLI 2002 = C. NEGRELLI, I reperti della seconda età del Ferro: Periodo VI. Materiali dal fossato USN 190,
in ORTALLI, PINI 2002, pp. 85-86.NEGRELLI 2010 = C. NEGRELLI, La sequenza insediativa, in CURINA et alii 2010, pp. 15-52.NEGRINI 2007 = C. NEGRINI, L’età del Ferro, in GUARNIERI 2007, pp. 39-44.NERI 1998 = D. NERI, Aspetti premonetali e monetali nell’Emilia centrale: aes signatum e moneta greca da Ca-
stelfranco Emilia, Firenze 1998.NIGRO 2006 = M. NIGRO, La ceramica a vernice nera d’importazione e d’imitazione, in CUOZZO, D’AGOSTINO,
DEL VERME 2006, pp. 91-100.ORTALLI 1988 = J. ORTALLI, L’abitato preromano di Sarsina, in Atti Bologna 1988, pp. 143-180.ORTALLI, PINI 2002 = J. ORTALLI, L. PINI (a c.), Lo scavo archeologico di via Foscolo-Frassinago a Bologna: aspetti
insediativi e cultura materiale, Firenze 2002.ORTALLI, PINI 2007 = J. ORTALLI, L. PINI (a c.), Immagini divine. Devozioni e divinità nella vita quotidiana dei
Romani, testimonianze archeologiche dall’Emilia Romagna, Firenze 2007.Orvieto 1982 = Pittura etrusca a Orvieto: le tombe di Settecamini e degli Hescanas a un secolo dalla scoperta. Docu-
menti e materiali (Catalogo della Mostra, Orvieto 1982), Roma 1982.PADOVAN 2006 = S. PADOVAN, Bric San Vito. La collina dei Taurini nell’età del Ferro, Torino 2006.PAGLIANI 1983 = M.L. PAGLIANI, Esempi di vasellame domestico nell’insediamento di Monte Bibele, in Monteren-
zio e la Valle dell’Idice, Casalecchio di Reno 1983, pp. 101-113.PAGLIANI 1987 = M.L. PAGLIANI, Etruschi e Celti, in FESTANTI, GHERPELLI 1987, pp. 17-32.PAIRAULT 1972 = F.H. PAIRAULT, L’habitat archaïque de Casalecchio di Reno près de Bologne: structure plani-
métrique et technique de construction, in «MEFRA» 84, 1972, pp. 145-197.PALERMO 2003 = L. PALERMO, Scarperia - Podere Stecconata. Area T 10 BIS - 1996, in G. RONCAGLIA, A.
DONATI, G. PINTO (a c.), Appennino tra antichità e medioevo, Città di Castello 2003, pp. 321-326.PAOLI, PARRINI 1988 = L. PAOLI, A. PARRINI, Corredi di età ellenistica dalla necropoli di Spina, Ferrara 1988.PAOLUCCI 1999-2000 = G. PAOLUCCI, Forme e tipi della ceramica etrusca con fregi ornamentali. A proposito della
Tomba 162 di Chianciano Terme, in «ArchCl» 51, 1999-2000, pp. 33-83.PAOLUCCI, RASTRELLI 1999 = G. PAOLUCCI, A. RASTRELLI, Chianciano Terme I. Necropoli della Pedata (tombe
1-21). Necropoli di via Montale (tombe 2-4), Roma 1999.PARISE BADONI 2000 = F. PARISE BADONI (a c.), Ceramiche d’impasto dell’età orientalizzante in Italia. Dizio-
nario terminologico, Roma 2000.Parma 1991 = Testimonianze etrusche in Emilia occidentale (Catalogo della Mostra), Parma 1991.PARMEGGIANI 1981 = G. PARMEGGIANI, Faenza. Piazza d’Armi, in VON ELES 1981, pp. 197-220.PARMEGGIANI 1992 = G. PARMEGGIANI, Ferrara, Museo Archeologico Nazionale: problematiche presenze ceramiche
di tradizione protostorica, in «MusFerr» 12, 1982, pp. 9-26.PARRINI 1993a = A. PARRINI, La ceramica locale tardo-arcaica della necropoli di Valle Trebba, in Atti Ferrara
1993, pp. 55-87.PARRINI 1993b = A. PARRINI, Tombe di V secolo a.C., in BERTI, GUZZO 1993, pp. 279-286.PARRINI 1993c = A. PARRINI, Il corredo della tomba 128, in BERTI, GUZZO 1993, pp. 287-291.PASQUINUCCI, STORTI 1989 = M. PASQUINUCCI, S. STORTI, Pisa antica. Scavi nel giardino dell’Arcivescovado,
Pontedera 1989.PATITUCCI UGGERI 1979 = S. PATITUCCI UGGERI, Voghiera. Un nuovo insediamento etrusco del Delta padano, in
«StEtr» 47, 1979, pp. 93-105.PATITUCCI UGGERI 1983 = S. PATITUCCI UGGERI, Classificazione preliminare della ceramica dipinta di Spina, in
«StEtr» 51, 1983, pp. 91-139.PATITUCCI UGGERI 1984 = S. PATITUCCI UGGERI, Classificazione preliminare della ceramica grigia di Spina, in
05 Bibliografia.indd 563 24/01/14 18.24
564
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
P. DELBIANCO (a c.), Culture figurative e materiali tra Emilia e Marche. Studi in memoria di Mario Zuffa, Rimini 1984, pp. 139-169.
PATITUCCI UGGERI 1988 = S. PATITUCCI UGGERI, Aspetti della ceramica locale di Spina nel V e IV secolo a.C. La ceramica grigia, in ƗƯƠƩƲƨƩн ƲRƳ Ɲ,, ƋƨƤƧƬRхư ƙƳƬƤƣƯtRƳ .ƪƠƱƨƩпư $ƯƵƠƨRƪRƢрƠư ($ƧпƬƠ 4-10 ƙƤ�ƲƤƫơƯрRƳ 1983), 2, $ƧпƬƠ 1988, pp. 173-179.
PATRONCINI 1970a = L. PATRONCINI, Un saggio di scavo in località Canali, in «QuadAR» 1, 1970, pp. 90-96.PATRONCINI 1970b = L. PATRONCINI, I pozzi di Servirola, in «QuadAR» 1, 1970, pp. 98-104.PATRONCINI 1970c = L. PATRONCINI, Rinvenimenti di materiali preistorici. San Bartolomeo-Case Bigi, in «Qua-
dAR» 1, 1970, pp. 83-89. PATRONCINI 1973 = L. PATRONCINI, Tracce della civiltà etrusca nella provincia di Reggio Emilia, in «QuadAR»
2, 1973, pp. 125-149.PATRONCINI 1976 = L. PATRONCINI, Rubiera, in «StEtr» 44, 1976, pp. 397-399.PATRONCINI 1979 = L. PATRONCINI, Rubiera (Reggio Emilia), in «StEtr» 47, 1979, p. 476.PATRONCINI 1980a = L. PATRONCINI, Materiali erratici etruscoidi, in «QuadAR» 4, 1980, pp. 119-120.PATRONCINI 1980b = L. PATRONCINI, Una sepoltura a cremazione. Poggio Vendina-Quattro Castella, in «Qua-
dAR» 4, 1980, pp. 125-149.PATRONCINI 1985 = L. PATRONCINI, Gli Etruschi qui erano di casa, in «ReStoria» 28, 1985, pp. 14-21.PATRONCINI 1990 = L. PATRONCINI, Resti di una tomba villanoviana nel greto del Secchia a Rubiera, in «Qua-
dAR» 5, 1990, pp. 97-121.PATRONCINI, LASAGNA PATRONCINI 1977 = L. PATRONCINI, C. LASAGNA PATRONCINI, Pozzi preromani di Ru-
biera, in «QuadAR» 3, 1977, pp. 73-95.PELLEGRINI 1992a = E. PELLEGRINI, Ceramica comune, in DAMIANI et alii 1992, pp. 35-81.PELLEGRINI 1992b = E. PELLEGRINI, Bucchero e ceramica buccheroide, in DAMIANI et alii 1992, pp. 109-118.PELLEGRINI 1992c = E. PELLEGRINI, Ceramica grigia, in DAMIANI et alii 1992, pp. 61-62.PELLEGRINI, SALTINI 1992 = E. PELLEGRINI, A.C. SALTINI, Ceramica d’impasto, in DAMIANI et alii 1992, pp. 63-82.PELLEGRINI, SERGES, SALTINI 1992 = E. PELLEGRINI, A. SERGES, A.C. SALTINI, Ceramica fine acroma o con deco-
razione dipinta, in DAMIANI et alii 1992, pp. 35-54.PERETTO 1994 = R. PERETTO (a c.), Balone. Insediamento etrusco presso un ramo del Po, Rovigo 1994.PERETTO, VALLICELLI, WIEL MARIN 2002 = R. PERETTO, M.C. VALLICELLI, F. WIEL MARIN, L’entroterra di
Adria. Conoscenze archeologiche e paleoambientali, in «Padusa» 38, 2002, pp. 91-114.PERKINS 2012a = P. PERKINS, The Bucchero Childbirth Stamp on a Late Orientalizing Period Shard from Poggio
Colla, in «EtrSt» 15, 2012, pp. 146-201.PERKINS 2012b = P. PERKINS, Fantastic animal stamps on bucchero from Poggio Colla, in M.C. BIELLA, E. GIO-
VANELLI, L.C. PEREGO (a c.), Il bestiario fantastico di età orientalizzante nella penisola italiana (Aristhono-tos. Scritti per il Mediterraneo Antico, Quaderni 1), Trento 2012, pp. 171-188.
PERONI 1962-1963 = R. PERONI, La Romita di Asciano (Pisa). Riparo sotto roccia utilizzato dall’età neolitica alla barbarica, in «BPI» 71-72, 1962-1963, pp. 251-442.
PERONI 1994 = R. PERONI, Introduzione alla protostoria italiana, Roma-Bari 1994.PERONI 1998 = R. PERONI, Classificazione tipologica, seriazione cronologica, distribuzione geografica, in «Aquil-
Nost» 69, 1998, pp. 9-28.PEYRE 1965 = C. PEYRE, Une récolte de céramique étrusque dans l’Apennin bolonais, in «MEFRA» 77, 1965, pp. 7-34.Piacenza 1992 = Liguri, Etruschi e Celti in Emilia Occidentale (Catalogo della Mostra), Piacenza 1992.PIANU 2000 = G. PIANU, Gravisca. Scavi nel santuario greco, 10. Il bucchero, Bari 2000.PICON 1997 = M. PICON, Le passage des céramiques culinaires gauloises aux céramiques culinaires romaines, à La
Graufesenque (Aveyron, F): résultats et questions, in Atti Bologna 1997, pp. 71-74.Pietrasanta 1990 = E. PARIBENI (a c.), Etruscorum ante quam Ligurum. La Versilia tra VII e III secolo a.C.
(Catalogo della Mostra, Pietrasanta 1989), Pontedera 1990.PINI 2010 = L. PINI, Età etrusca: Periodo II, in CURINA et alii 2010, pp. 102-117.PIZZIRANI 2005 = C. PIZZIRANI, Da Odisseo alle Nereidi. Riflessioni sull’iconografia etrusca del mare attraverso i
secoli, in «Ocnus» 13, 2005, pp. 251-270. PIZZIRANI 2009 = C. PIZZIRANI, Il sepolcreto etrusco della Galassina di Castelvetro (Modena), Bologna 2009. PLOG 1975 = F.T. PLOG, System Theory in Archaeological Research, in «AnnRevAnth» 4, 1975, pp. 207-224.POGGIO 1974 = T. POGGIO, Ceramica a vernice nera di Spina. Le oinochoai trilobate, Milano 1974.
05 Bibliografia.indd 564 24/01/14 14.36
565
%LEOLRJUDÀD
PONTRANDOLFO 2009 = A. PONTRANDOLFO (a c.), Fratte. Il complesso monumentale arcaico, Salerno 2009.PRATI 1981 = L. PRATI, Forlì. Territorio, in VON ELES 1981, pp. 257-265.PRATI 2007 = L. PRATI, Tracce del passato, in ORTALLI, PINI 2007, pp. 37-39.PROSDOCIMI 1882 = A. PROSDOCIMI, Notizie della necropoli euganea di Este, in «NSc» 1882, pp. 5-37.PY 1993 = M. PY, Céramique grise monochrome, in «Lattara» 6, 1993, pp. 445-452.RAPI 2005 = M. RAPI, Materiali delle fasi arcaiche, in Bagnolo S. Vito 2005, pp. 101-121. RASMUSSEN 1979 = T.B. RASMUSSEN, Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979. RAUX 1998 = S. RAUX, Méthodes de quantification du mobilier céramique. Etat de la question et pistes de réflexion,
in Atti Glux-en-Glenne 1998, pp. 11-16.Reggio Emilia 1989a = G. AMBROSETTI, R. MACELLARI, L. MALNATI (a c.), Rubiera. Principi etruschi in Val di
Secchia (Catalogo della Mostra), Reggio Emilia 1989. Reggio Emilia 1989b = G. AMBROSETTI, R. MACELLARI, L. MALNATI (a c.), Sant’Ilario d’Enza. L’età della colo-
nizzazione etrusca. Strade, villaggi, sepolcreti (Catalogo della Mostra), Reggio Emilia 1989.Reggio Emilia 1990 = G. AMBROSETTI, R. MACELLARI, L. MALNATI (a c.), Vestigia Crustunei. Insediamenti
etruschi lungo il corso del Crostolo (Catalogo della Mostra), Reggio Emilia 1990. Reggio Emilia 1996 = G. AMBROSETTI, R. MACELLARI, L. MALNATI (a c.), Lepidoregio. Testimonianze di età
romana a Reggio Emilia (Catalogo della Mostra), Reggio Emilia 1996.RICCIONI 1952-1953 = G. RICCIONI, Il Sepolcreto felsineo Aureli, in «StEtr» 12, 1952-1953, pp. 233-285.RICCIONI 1971-1974 = G. RICCIONI, Il sepolcreto di Monte Avigliano. Contributi allo studio degli insediamenti
etruschi nell’Appennino bolognese, in «EmPrerom» 7, 1971-1974, pp. 227-261.RICCIONI 2000 = G. RICCIONI, Nuovi dati sulla più antica Rimini preromana, in L. MAZZEO SARACINO, Scritti
di archeologia di Giuliana Riccioni, Bologna-Imola 2000, pp. 339-348.RIZZO 1994 = M.A. RIZZO, Percorsi ceramografici tardo-arcaici ceretani, in «Prospettiva» 73-74, 1994, pp. 2-20.ROMAGNOLI 2010 = S. ROMAGNOLI, L’Acropoli etrusca di Villa Cassarini a Bologna, Tesi di Specializzazione
in Archeologia, Università degli Studi di Bologna, a.a. 2009-2010.ROSSI 1996 = F. ROSSI (a c.), Carta archeologica della Lombardia, V, Brescia. La città, 1, Modena 1996.ROSSI 2001 = S. ROSSI, I mortai in ceramica depurata e semidepurata in Veneto: tipo-cronologia e ipotesi su funzione
ed uso, in «Padusa» 37, 2001, pp. 199-227.ROSSI 2005 = S. ROSSI, Uso alimentare o ritualità alimentare? Il caso dei mortai in ceramica di tipo etrusco padano
in Veneto: analisi tipocronologica, aspetti tecnologici e ipotesi su funzione ed uso, in Communities and Settlements from the Neolithic to the Early Medieval Period (Atti del Convegno, Groningen 2003), Oxford 2005, pp. 426-434.
ROTROFF 1997 = S. ROTROFF, Hellenistic pottery: Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material, I-II, Princeton 1997.
RUBY 1993 = P. RUBY, Types et fonctions dans les typologies céramiques archéologiques. Quelques problèmes et quelques propositions, in «AnnAStorAnt» 15, 1993, pp. 289-320.
SALETTI 1970 = C. SALETTI, Problemi artistici di Marzabotto. Le espressioni figurative e decorative, in Studi sulla città antica (Atti del Convegno di Studi, Bologna 1970), Imola 1970, pp. 279-283.
SALZANI 1987 = L. SALZANI, S. Cassiano. Fondo La Romanina (comune di Crespino), in «Padusa» 23, 1987, pp. 233-236.
SALZANI, VITALI 2002 = L. SALZANI, D. VITALI, Gli scavi archeologici nel podere Forzello a San Basilio di Ariano Polesine, in «Padusa» 38, 2002, pp. 115-138.
SANDRI 1972 = P. SANDRI, Saggio preliminare sulle forme della ceramica acroma di Marzabotto, in «StEtr» 40, 1972, pp. 319-340.
SANI 1993 = S. SANI, Il corredo della tomba 823, in BERTI, GUZZO 1993, p. 352. San Marino 2009 = G. BOTTAZZI, P. BIGI (a c.), Primi insediamenti sul Monte Titano. Scavi e Ricerche (1997-
2004) (Catalogo della Mostra, San Marino 2006), Firenze 2009.SANTOCCHINI GERG 2009 = S. SANTOCCHINI GERG, Il patrimonio decorativo dell’Emilia occidentale tra VI e IV
secolo a.C., in Atti Milano 2009, pp. 219-247.SANTOCCHINI GERG 2012 = S. SANTOCCHINI GERG, Riflessioni sui contatti fra Etruria Settentrionale e Padana.
Motivi e tecniche decorative tra VII e V sec. a.C., in «Ocnus» 20, 2012, pp. 223-252.SARONIO 1965 = P. SARONIO, Nuovi scavi nella città etrusca di Misano a Marzabotto, in «StEtr» 33, 1965,
pp. 385-416.
05 Bibliografia.indd 565 24/01/14 14.36
566
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
SARONIO 1989 = P. SARONIO, L’età del Ferro a Quingento nel quadro della protostoria dell’Emilia occidentale, in BERNABÒ BREA 1989, pp. 107-122.
SARONIO 1991-1992 = P. SARONIO, Bardi (PR), Case Pietra Nera, cava Goggiano, in «StDocA» 7, 1991-1992, pp. 115-116.
SARONIO 1992 = P. SARONIO, Il Parmense, in Piacenza 1992, pp. 6-10.SARONIO 1993 = P. SARONIO, Pianello Val Tidone (PC). Abitato romano, in «StDocA» 8, 1993, p. 304.SARONIO 1999 = P. SARONIO, Rinvenimenti dell’età del Ferro dal Piacentino orientale, in «AEmil» 3/1, 1999,
pp. 11-25.SASSATELLI 1977 = G. SASSATELLI, L’Etruria padana e il commercio dei marmi nel V secolo, in «StEtr» 45, 1977,
pp. 109-147. SASSATELLI 1981 = G. SASSATELLI, Gli specchi dagli scavi di Bologna e territorio, in «CSE» 1, 1-II, 1981,
pp. 11 ss. SASSATELLI 1989 = G. SASSATELLI, Ancora sui rapporti tra Etruria padana e Italia settentrionale: qualche esempli-
ficazione, in Atti Mantova 1989, pp. 49-81. SASSATELLI 1990 = G. SASSATELLI, La situazione in Etruria Padana, in Crise et tran sformation des so ciétés archaiques
de l’Italie antique au V siè cle av J.-C. (Actes de la Table Ronde, Rome 1987), Rome 1990, pp. 51-100.SASSATELLI 1991 = G. SASSATELLI, Case nuove di Siccomonte, in Parma 1991.SASSATELLI 1993a = G. SASSATELLI, Il bucchero e le ceramiche affini come supporto per iscrizioni e graffiti in area
padana, in Atti Milano 1993, pp. 195-205.SASSATELLI 1993b = G. SASSATELLI, La funzione economica e produttiva: merci, scambi, artigianato, in BERTI,
GUZZO 1993, pp. 179-217.SASSATELLI 1994a = G. SASSATELLI (a c.), Iscrizioni e graffiti della città etrusca di Marzabotto, Imola 1994. SASSATELLI 1994b = G. SASSATELLI, Gli scavi nella città etrusca di Marzabotto (Bologna), in «Ocnus» 2, 1994,
pp. 247-254. SASSATELLI 1994c = G. SASSATELLI, Problemi del popolamento nell’Etruria Padana con particolare riguardo a
Bologna, in La presenza etrusca nella Campania meridionale (Atti del Convegno, Salerno 1990), Firenze 1994, pp. 497-508.
SASSATELLI 2001 = G. SASSATELLI, Gli Etruschi nella pianura padana, in G. CAMPOREALE (a c.), Gli Etruschi fuori d’Etruria, Verona 2001, pp. 168-191.
SASSATELLI 2008 = G. SASSATELLI, Gli Etruschi nella valle del Po. Riflessioni, problemi e prospettive di ricerca, in «AnnFaina» 15, 2008, pp. 71-114.
SASSATELLI 2011 = G. SASSATELLI, Città etrusca di Marzabotto. Una fornace per il tempio di Tina, in D.F. MARAS (a c.), Corollari. Scritti di antichità etrusche e italiche in omaggio all’opera di Giovanni Colonna, Pisa 2011, pp. 150-158.
SASSATELLI, GAUCCI 2010 = G. SASSATELLI, A. GAUCCI, Le iscrizioni e i graffiti, in GOVI, SASSATELLI 2010, pp. 315-395.
SASSATELLI, GOVI 1993 = G. SASSATELLI, E. GOVI, Testimonianze di età preromana: strade e monumentalizzazione, in Tecnica stradale romana (Atlante tematico di Topografia Antica, I), Roma 1993, pp. 125-139.
SASSATELLI, GOVI 2009 = G. SASSATELLI, E. GOVI, Ideologia funeraria e celebrazione del defunto nelle stele etrusche di Bologna, in «StEtr» 73, 2009, pp. 67-92.
SASSATELLI, MACELLARI 2002 = G. SASSATELLI, R. MACELLARI, Perugia, gli Umbri e la Val Padana, in «Ann-Faina» 9, 2002, pp. 407-434.
SCARANI 1963 = R. SCARANI, Repertorio di ricerche e scavi dell’Emilia e Romagna, in «Preistoria e Protostoria dell’Emilia Romagna» 2, 1963, pp. 175-634.
SCARANI 1971a = R. SCARANI, Civiltà preromane del territorio parmense, Parma 1971.SCARANI 1971b = R. SCARANI, La seconda età del Ferro e il periodo gallico nel territorio piacentino, in «BollStPc»
66, 1971, pp. 1-22.SCARPELLINI 1981 = D. SCARPELLINI, Covignano. Seminario, in VON ELES 1981, pp. 292-327.SCHIFONE 1967 = C. SCHIFONE, Terrecotte architettoniche, in Problemi e testimonianze della città etrusca di Mar-
zabotto, in «StEtr» 35, 1967, pp. 431-444.SCHIFONE 1971 = C. SCHIFONE, Antefisse fittili, in «StEtr» 39, 1971, pp. 249-265.SCHWARZ 1979 = S. SCHWARZ, The Pattern Class Vases of the “Gruppo di Orvieto” in the U.S. National Museum
collection, Smithsonian Institution, Washington D.C., in «StEtr» 47, 1979, pp. 65-84.
05 Bibliografia.indd 566 24/01/14 14.36
567
%LEOLRJUDÀD
SERGES 1992 = A. SERGES, Fuseruole, in DAMIANI et alii 1992, pp. 197-198.SERRA RIDGWAY 1996 = F.R. SERRA RIDGWAY, I corredi del fondo Scataglini a Tarquinia. Scavi della Fondazio-
ne Ing. Carlo M. Lerici del Politecnico di Milano per la Soprintendenza archeologica dell’Etruria meridionale, Milano 1996.
SGARBI 1992 = M. SGARBI, Mirandola, località Arginone, Nord-Est casa colonica. Abitato dell’età del Ferro. Saggio di scavo dell’agosto 1990, in CALZOLARI, MALNATI 1992, pp. 95-122.
SGARBI 1993 = M. SGARBI, Mirandola, località Barchessone Barbiere: strutture dell’età del Ferro. Scavo luglio-agosto 1991-1992, in «QuadBassaModena» 24, 1993, pp. 39-60.
SIEVEKING, HACKL 1912 = J. SIEVEKING, R. HACKL, Die Königliche Vasensammlung zu München, München 1912.
SIMON 1976 = E. SIMON, Die griechischen Vasen, München 1976.SPARKES, TALCOTT 1970 = B.A. SPARKES, L. TALCOTT, The Athenian Agora XII, 1-2. Black and plain pottery
of the VIth, Vth and IVth centuries B.C., Princeton 1970.SQUADRINI 1988 = G. SQUADRINI, Necropoli etrusca della Galassina di Castelvetro: la tomba 2 del 1879, in
Modena 1988, pp. 272-284.STEINHART 1995 = M. STEINHART, Das Motiv des Auges in der griechischen Bildkunst, Mainz 1995.STOPPANI, ZAMBONI 2009 = C. STOPPANI, L. ZAMBONI, L’insediamento di Baggiovara - Via Martiniana (MO),
in Atti Milano 2009, pp. 349-423.SZILÁGYI 1992 = J.G. SZILÁGYI, Ceramica etrusco-corinzia figurata, I, 630-580 a.C., Firenze 1992.SZILÁGYI 1998 = J.G. SZILÁGYI, Ceramica etrusco-corinzia figurata, II, 590/580-550 a.C., Firenze 1998.TADDEI 2009 = C. TADDEI, Volterra e la Valle del Cecina. Poggio ai Monti, un sito etrusco d’altura, in «Fastionline»
2009, pp. 1-15.TAGLIONI 1990 = C. TAGLIONI, Torretta di Villa Cella. Insediamento rustico, in Reggio Emilia 1990, pp. 261-
263.TAGLIONI 1999 = C. TAGLIONI, L’abitato etrusco di Bologna, Bologna 1999.TALOCCHINI 1986 = A. TALOCCHINI, Il Ghiaccioforte, Roccastrada 1986.TAMASSIA 1970 = K. TAMASSIA, Mantova. Scavi in Piazza Paradiso, in «NSc» 1970, pp. 5-29.TAMASSIA 1993 = K. TAMASSIA, La necropoli preromana di Adria, località Retratto-Donà, in «Padusa» 29,
1993, pp. 7-90.TAMASSIA, BELLINTANI, BONOMI 1997 = K. TAMASSIA, P. BELLINTANI, S. BONOMI, Adria. Aggiornamento sui
rinvenimenti archeologici nell’area dell’Azienda ospedaliera, in «Padusa» 31, 1997, pp. 41-91.TAMASSIA, PERETTO, BONOMI 1993 = K. TAMASSIA, R. PERETTO, S. BONOMI, Adria. Appunti preliminari sulla
necropoli tardo etrusca e romana di via Spolverin di Bottrighe, in «Padusa» 29, 1993, pp. 91-156.TAMBURINI 1985 = P. TAMBURINI, Todi. La produzione locale del bucchero grigio, in «ArchCl» 37, 1985, pp.
84-100.TAMBURINI 1987 = P. TAMBURINI, Contributo preliminare alla definizione della ceramica d’impasto volsiniese e
qualche nota sul bucchero mal cotto di produzione locale, in «AnnFaina» 3, 1987, pp. 83-98.TAMBURINI 2004 = P. TAMBURINI, Dai primi studi sul bucchero etrusco al riconoscimento del bucchero di Orvieto.
Importazioni, produzioni locali, rassegna morfologica, in Appunti sul bucchero (Atti delle Giornate di Studio), Firenze 2004, pp. 179-222.
TASSINARI 2010 = C. TASSINARI, I materiali di scavo della casa etrusca di via A. Costa a Bologna, in Etruskisch-italische und römische-republikanische Häuser, Wiesbaden 2010, pp. 89-103.
TIRABASSI 1981 = J. TIRABASSI, Catasto archeologico della provincia di Reggio Emilia. Supplemento 1. Campegine, Reggio Emilia 1981.
TOMAY 2008 = L. TOMAY, La necropoli del centro etrusco-campano di Fratte (1927-1929), Salerno 2008.TRAINA 1982 = G. TRAINA, Ceramica a pasta grigia e a vernice nera dal sepolcreto della Pila di Spinimbecco (Verona),
in «AquilNost» 53, 1982, pp. 261-270.TRIPPONI 1967 = A. TRIPPONI, L’esplorazione della porta e del settore sud-est dell’area urbana, I, Problemi generali
e particolari, in «StEtr» 35, 1967, pp. 389-410.TRIPPONI 1970 = A. TRIPPONI, Marzabotto. Saggio di classificazione della ceramica locale, Bologna 1970.TURCHETTI 2001 = M.A. TURCHETTI, L’abitato ellenistico di Casellina (località Poggerello, Scandicci, Firenze).
La ceramica grigia e a vernice nera, in «Florentia» 1, 2001, pp. 39-94.UGGERI 1988 = G. UGGERI, Contrassegni personali nella ceramica spinetica di produzione locale, in J. CHRI-
05 Bibliografia.indd 567 24/01/14 14.36
568
Atlante tipologico delle forme ceramiche in Etruria padana
STIANSEN, T. MELANDER (eds.), Ancient Greek and Related Pottery (Proceedings of the Third Symposium, Copenhagen 1987), Copenhagen 1988, pp. 617-623.
VALENTI 1995 = M. VALENTI, Carta archeologica della Provincia di Siena, I, Il Chianti senese (Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti), Siena 1995.
VANNINI 1985 = G. VANNINI (a c.), L’antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia, II, Indagini archeologiche, Firenze 1985.
VILLING, PEMBERTON 2010 = A. VILLING, E.G. PEMBERTON, Mortaria from ancient Corinth, in «Hesperia» 79, 2010, pp. 555-638.
VITALI 1983 = D. VITALI, L’età del Ferro nell’Emilia Occidentale: dati, considerazione e proposte, in Studi sulla città antica, Roma 1983, pp. 129 ss.
VITALI 1987 = D. VITALI, Monte Bibele tra Etruschi e Celti: dati archeologici e interpretazione storica, in Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione (Atti del Colloquio Interna-zionale, Bologna 1985), Bologna 1987, pp. 309-380.
VITALI 1992 = D. VITALI, Tombe e necropoli galliche di Bologna e del territorio, Bologna 1992.VITALI 2003 = D. VITALI (a c.), La necropoli di Monte Tamburino a Monte Bibele, Bologna 2003.VON ELES 1981 = P. VON ELES (a c.), La Romagna fra VI e IV sec. a.C. La necropoli di Montericco e la protostoria
romagnola (Catalogo della Mostra), Imola 1981. VON ELES 1993 = P. VON ELES, La ceramica buccheroide della Romagna: prime considerazioni, in Atti Milano
1993, pp. 87-96.VON ELES 1995 = P. VON ELES, Museo civico archeologico: Verucchio. Guida catalogo, Rimini 1995.VON ELES, MIARI 1997 = P. VON ELES, M. MIARI, Verucchio. Il pozzo di Pian del Monte, in Imola 1997, pp.
112 ss.WILLEY, PHILLIPS 1958 = G.R. WILLEY, P. PHILLIPS, Method and Theory in American Archaeology, Chicago
1958.WILLEY, SABLOFF 1980 = G.R. WILLEY, J.A. SABLOFF, History of American Archaeology, San Francisco 1980.ZAMBONI 2009 = L. ZAMBONI, Ritualità o riutilizzo? Riflessioni sul vasellame “miniaturistico” in Etruria pa-
dana, in Pagani e cristiani. Forme ed attestazioni di religiosità nel mondo antico in Emilia, 8, Castelfranco Emilia 2009, pp. 9-46.
ZANNONI 1876-1884 = A. ZANNONI, Gli scavi della Certosa di Certosa, Bologna 1876-1884.ZANNONI 1888 = A. ZANNONI, La fonderia di Bologna, Bologna 1888.ZANNONI 1892 = A. ZANNONI, Arcaiche abitazioni di Bologna, Bologna 1892.ZEC 2009 = A. ZEC, Le olle di ceramica grigia nel Veneto. Sintesi classificatoria, in «AVen» 32, 2009, pp. 43-87.ZUFFA 1969 = M. ZUFFA, Nuovi dati per la protostoria della Romagna orientale, in «AttiMemBologna» 20,
1969, pp. 99-124.
05 Bibliografia.indd 568 24/01/14 14.36
12
3
45
6
7
8
9
1011
1213
14
15
16
17
1819
202122
23
2425
262728
29
30
Studi e ScaviNuova Serie
SIMONE RAMBALDI, Monopteros. Le edicole circolari nell’architettura dell’Italia romana, Bologna 2003ILARIA DI COCCO, DAVIDE VIAGGI, Dalla scacchiera alla macchia. Il paesaggio agrario veleiate tra cen-turiazione e incolto, Bologna 2003MARIA TERESA GUAITOLI, NICOLÒ MARCHETTI, DANIELA SCAGLIARINI (a c.), Scoprire. Scavi del Dipartimento di Archeologia (Catalogo della Mostra, Bologna 2004), Bologna 2004PIER LUIGI DALL’AGLIO, ILARIA DI COCCO (a c.), Pesaro romana: archeologia e urbanistica, Bologna 2004MARIA CRISTINA GENITO GUALANDI (a c.), Musei, mostre e collezionismo negli scritti di Giorgio Gualandi, Bologna 2004MARCO DESTRO, ENRICO GIORGI (a c.), L’Appennino in età romana e nel primo Medioevo. Viabilità e popolamento nelle Marche e nell’Italia centro-settentrionale (Atti del Convegno di Corinaldo, 28-30 giugno 2001), Bologna 2004SANDRO DE MARIA (a c.), Nuove ricerche e scavi nell’area della Villa di Teoderico a Galeata (Atti della Giornata di Studi, Ravenna 26 marzo 2002), Bologna 2004EMANUELA PENNI IACCO, La basilica di S. Apollinare Nuovo di Ravenna attraverso i secoli, Bologna 2004CRISTINA SERVADEI, La figura di Theseus nella ceramica attica. Iconografia e iconologia del mito nell’Atene arcaica e classica, Bologna 2005SILVIA PASI (a c.), Studi in memoria di Patrizia Angiolini Martinelli, Bologna 2005GIUSEPPE SASSATELLI, ELISABETTA GOVI (a c.), Culti, forma urbana e artigianato a Marzabotto. Nuove prospettive di ricerca (Atti del Convegno di Studi, Bologna, S. Giovanni in Monte 3-4 giugno 2003), Bologna 2005DANIELE VITALI (a c.), Studi sulla media e tarda età del Ferro nell’Italia settentrionale, Bologna 2005CINZIA CAVALLARI, Oggetti di ornamento personale dall’Emilia Romagna bizantina: i contesti di rinveni-mento, Bologna 2005ANTONIO CURCI, DANIELE VITALI (a c.), Animali tra uomini e dei. Archeozoologia del mondo preromano (Atti del Convegno Internazionale, 8-9 novembre 2002), Bologna 2006ENRICO ACQUARO, BARBARA CERASETTI (a c.), Pantelleria punica. Saggi critici sui dati archeologici e riflessioni storiche per una nuova generazione di ricerca, Bologna 2006SARA SANTORO (a c.), Pompei. Insula del Centenario (IX, 8) - I. Indagini diagnostiche geofisiche e analisi archeometriche, Bologna 2007CARLOTTA FRANCESCHELLI, STEFANO MARABINI, Lettura di un territorio sepolto. La pianura lughese in età romana, Bologna 2007RICCARDO VILLICICH, I complessi forensi nei centri minori della Cisalpina romana, Bologna 2007RAFFAELLA FARIOLI CAMPANATI, CLEMENTINA RIZZARDI, PAOLA PORTA, ANDREA AUGENTI, ISABELLA BALDINI LIPPOLIS (a c.), Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo orientale (IV-X secolo). Il ruolo dell’autorità ecclesiastica alla luce di nuovi scavi e ricerche (Atti del Convegno Internazionale, Bologna-Ravenna, 26-29 novembre 2007), Bologna 2009BARBARA VERNIA, Leggere i muri. Analisi degli edifici di culto nella Ravenna del V secolo d.C., Bologna 2009VINCENZO BALDONI, La ceramica attica dagli scavi ottocenteschi di Marzabotto, Bologna 2009SIMONE RAMBALDI, L’edilizia pubblica nell’Impero Romano all’epoca dell’Anarchia Militare (235-284 d.C.), Bologna 2009ANTONELLA CORALINI (a c.), Vesuviana. Archeologie a confronto (Atti del Convegno Internazionale, Bologna, 14-16 gennaio 2008), Bologna 2009CHIARA PIZZIRANI, Il sepolcreto etrusco della Galassina di Castelvetro (Modena), Bologna 2009ENRICO GIORGI, GIUSEPPE LEPORE (a c.), Archeologia nella valle del Cesano da Suasa a Santa Maria in Portuno (Atti del Convegno per i venti anni di ricerche dell’Università di Bologna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, San Lorenzo in Campo, 18-19 dicembre 2008), Bologna 2010ELISABETTA GOVI, GIUSEPPE SASSATELLI (a c.), La Casa 1 della Regio IV - insula 2, I-II, Bologna 2010ANDREA AUGENTI (a c.), Classe. Indagini sul potenziale archeologico di una città scomparsa, Bologna 2011ISABELLA BALDINI, MONICA LIVADIOTTI (a c.), Archeologia protobizantina a Kos: la basilica di S. Gabriele, Bologna 2011ANDREA FIORINI (a c.), Il castello di Sorrivoli (Roncofreddo, Forlì-Cesena). Storia e archeologia dell’architettura, Bologna 2011ANTONELLA CORALINI (a c.), DHER Domus Herculanensis Rationes. Sito Archivio Museo, Bologna 2011
05 Bibliografia.indd 571 24/01/14 14.36
Studi e ScaviNuova Serie
SANDRO DE MARIA (a c.), Le ricerche delle Missioni Archeologiche in Albania nella ricorrenza dei dieci anni di scavi dell’Università di Bologna a Phoinike (2000-2010) (Atti della Giornata di Studi, Università di Bologna, 10 novembre 2010), Bologna 2012CLEMENTINA RIZZARDI, Il mosaico a Ravenna. Ideologia e arte (con contributi di Linda Kniffitz, Letizia Sotira, Barbara Vernia), Bologna 2011GIAMBATTISTA CAIRO, Pericle Ducati: il carteggio ritrovato, Bologna 2012FEDERICA BOSCHI, Tracce di una città sepolta. Aerofotografia e geofisica per l’archeologia di Classe e del suo territorio, Bologna 2012ANDREA AUGENTI, MARILISA FICARA, ENRICO RAVAIOLI, Atlante dei beni archeologici della provincia di Ravenna, I, Il paesaggio monumentale del Medioevo, Bologna 2012ENRICO GIORGI, JULIAN BOGDANI, Il territorio di Phoinike in Caonia. Archeologia del paesaggio in Al-bania meridionale, Bologna 2012CHIARA MATTIOLI, Atlante tipologico delle forme ceramiche di produzione locale in Etruria padana (con contributi di Giulia Morpurgo, Stefano Santocchini Gerg), Bologna 2013LETIZIA SOTIRA, Gli altari nella scultura e nei mosaici di Ravenna (V-VIII secolo), Bologna 2013
31
32
3334
35
36
37
38
Finito di stampare nel mese di dicembre 2013da Luoghinteriori, Città di Castello (Pg)
05 Bibliografia.indd 572 24/01/14 14.36
“Studi e Scavi” è la collana del Dipartimento di Archeologia – ora Sezione di Archeologia del Dipartimento di Storia Culture Civiltà – dell’Università di Bologna, nata nel 1994 e rinnovata nella Nuova Serie a partire dal 2002.La collana accoglie studi e contributi di docenti, collaboratori e giovani studiosi del Dipartimento, miscellanee, atti di convegni e giornate di studio, coprendo un ampio arco cronologico e tematico, sia per quanto riguarda le attività di scavo sia per quanto riguarda le attività di ricerca del Dipartimento nel suo complesso.
La tipologia generale della ceramica etrusca prodotta in area padana fra la metà del VI a.C. e il declino del sistema etrusco-padano risponde alla necessità di dare ordine a una straordinaria quantità di materiale vascolare fino ad ora studiato in modo settoriale e segmentato. Il lavoro si pone fondamentalmente due obiettivi. Anzitutto si vuole dare un quadro per la prima volta complessivo di questa produzione ceramica locale presente in un’area molto vasta, stabilmente occupata dagli Etruschi e quindi con caratteristiche di grande omogeneità storica. In secondo luogo si intende proporre uno strumento di analisi utile per quanti si confronteranno con questa produzione vascolare all’interno di singole aree di scavo. Una prima analisi territoriale della documentazione fa emergere caratteri di uniformità e di standardizzazione, ma anche differenze che mettono in luce, specie nelle aree di confine, fenomeni di interazione culturale con le realtà limitrofe. a
tla
nt
e tipo
log
ico
delle fo
rm
e c
era
mic
he d
i pro
du
zio
ne lo
ca
lein
etru
ria
pad
an
a
alma mater Studiorum - università di Bolognadipartimento di Storia culture civiltà
Sezione di archeologia
€ 50,00
chiara mattioli
atlante tipologico delle forme ceramiche di produzione locale
in etruria padana
chiara m
attioli
Chiara Mattioli è laureata in Lettere Classiche con una tesi in Etruscologia e Archeologia italica, specializzata in Archeologia, dottore di ricerca in Scienze Archeologiche. Attualmente è Tecnico laureato-Responsabile del Laboratorio materiali archeologici presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà (Sezione di Archeologia) dell’Università di Bologna. Lo studio tipologico della ceramica etrusca prodotta in area padana è stato l’oggetto delle sue tesi di Specializzazione e di Dottorato. Tra gli ambiti d’interesse si segnala, oltre alle dinamiche di diffusione della ceramica etrusca nei territori limitrofi con particolare riguardo al mondo veneto, la ricostruzione delle economie produttive della città di Marzabotto, dove si concentra la sua pluriennale attività di scavo.
In copertina: Piatto su alto piede, da Marzabotto (Bologna), Regio IV - Insula 2, Casa 1 Studi e Scavi
nuova serie 37KAINUA 3
37
Studie
Scavi
nuovaserie
copertina_def.indd 1 31/01/14 16.14