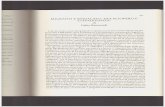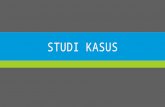Padanie. Il reclutamento dei panjabi indiani nel settore dell'allevamento in Pianura Padana. Paper...
Transcript of Padanie. Il reclutamento dei panjabi indiani nel settore dell'allevamento in Pianura Padana. Paper...
Padanie Il reclutamento dei panjabi indiani nel settore dell’allevamento in
Pianura Padana
Nell’intervento ci si focalizzerà su un punto di vista peculiare, che si distanzia dal bracciantato, ma che
nella sua specificità ci permetterà di problematizzare l’inserimento di forza lavoro migrante nel primo
settore, l’influenza del mercato e delle leggi sull’immigrazione (in particolare la Bossi-Fini), e più in
generale le trasformazioni sociali del tessuto locale. Nella relazione ci concentreremo infatti sul lavoro
dei panjabi indiani negli allevamenti bovini e più in generale sulla filiera del latte, in particolare in merito
alla produzione di Grana Padano e Parmigiano Reggiano. L’indagine è stata condotta utilizzando una
metodologia etnografica e qualitativa. In particolare il materiale è stato raccolto tra il 2011 e il 2013, e
comprende 52 interviste a migranti panjabi (e 42 a testimoni privilegiati) e sono state condotte
osservazioni nei contesti di vita e di lavoro sia in Panjab indiano sia in Italia. La tesi che si vuole
supportare parte dall’assunto secondo il quale in questo caso non è corretto parlare nella mansione di
sostituzione della popolazione autoctona, ma piuttosto di una trasformazione del processo di produzione
e centrale in questo è il sistema di reclutamento attuato dai panjabi attraverso gli intermediari. E' un
sistema dove le tre figure coinvolte, datore di lavoro, fruitore e mediatore, ne ottengono un beneficio
seppur di diversa entità ed è influenzato dal mercato del lavoro del settore e dalle politiche migratorie.
Le tre figure infine hanno qualcosa in comune, essere agricoltori a latitudini diverse.
Di Vanessa Azzeruoli
La realtà della Pianura Padana ha visto una crescita esponenziale del fenomeno migratorio,
dove Emilia Romagna, Lombardia e Veneto possiedono in quasi tutte le provincie una
percentuale di migranti stranieri superiore al 20% rispetto alla popolazione locale. La
migrazione è solo uno dei cambiamenti che hanno coinvolto la zona: negli anni ’90 e inizio
2000 l’apertura di nuove zone industriali sul territorio hanno portato ad un’urbanizzazione della
campagna, seppur eterogenea sul territorio. Grandi palazzi svettano ai margini dei nuclei abitati
e nelle frazioni, mentre tra i campi di grano e gli allevamenti emergono zone industriali, alcune
delle quali fortemente colpite dalla crisi economica, con capannoni dismessi o mai terminati.
Enormi stalle “moderne” si alternano a vecchi allevamenti di suini fatiscenti abbandonati con
il crollo del prezzo della carne del settore.
Parlare di agricoltura e migrazione in Pianura Padana nel 2014 dal punto di vista sociologico
impone uno sguardo policentrico e necessariamente multidisciplinare. Nell’intervento ci si
focalizzerà su un punto di vista peculiare, che si distanzia dal bracciantato, ma che nella sua
specificità ci permetterà di problematizzare l’inserimento di forza lavoro migrante nel primo
settore, l’influenza del mercato e delle leggi sull’immigrazione (in particolare la Bossi-Fini), e
più in generale le trasformazioni sociali del tessuto locale.
Nella relazione ci concentreremo infatti sul lavoro negli allevamenti bovini e più in generale
sulla filiera del latte che a queste latitudini significa per lo più Grana Padano e Parmigiano
Reggiano. Da oramai due decenni il reclutamento degli indiani nel settore è divenuto un
elemento caratteristico e per quanto non vi siano dati ufficiali alla mano, si parla oramai di più
del 50% di mungitori di tale nazionalità. La convivenza apparentemente è pacifica, di
collaborazione, e non di rado all’imbrunire famiglie di locali e italiani si alternano nelle
passeggiate lungo gli stradelli di campagna. La voce è arrivata fino al New York Times che,
nel 2011, ha sostenuto come uno sciopero degli indiani all’interno della filiera avrebbe
interrotto la produzione di Grana Padano® (e Parmigiano Reggiano®). Ma all’orizzonte non vi
è nessuna ombra di sciopero.
Sotto la calma apparente, un assordante frastuono?
L’indagine è stata condotta utilizzando una metodologia etnografica e qualitativa. In particolare
il materiale è stato raccolto tra il 2011 e il 2013, all’interno della ricerca per la tesi di dottorato
in Scienze Sociali presso l’università di Padova. Il tema studiato era più vasto e comprendeva
lo studio della figura degli intermediari nella migrazione panjabi indiana in Italia, in particolare
in merito all’arrivo, alla stabilizzazione e allo spostamento in un paese terzo e l’influenza delle
politiche migratorie e il mercato del lavoro su di essa. Per questa ricerca sono state effettuate
52 interviste a migranti panjabi (e 42 a testimoni privilegiati) e sono state condotte osservazioni
nei contesti di vita e di lavoro sia in Panjab indiano sia in Italia.
La tesi che si vuole tentare di supportare parte dall’assunto secondo il quale nel caso dei panjabi
negli allevamenti non è corretto parlare nella mansione di sostituzione della popolazione
autoctona con i migranti. Piuttosto le trasformazioni all’interno della filiera, in particolare del
processo di trasformazione, hanno coinciso con il reclutamento della forza lavoro migrante. Vi
è stata infatti negli ultimi venti anni una riduzione del numero delle aziende (dimezzate in tutte
le fasce altimetriche) e degli allevamenti, un ampliamento delle dimensioni degli allevamenti
esistenti, un raddoppio della produzione nel Parmigiano Reggiano e una triplicazione della
produzione del Grana Padano. Centrale in questo è il sistema di reclutamento attuato dai
panjabi, sotteso all’etichetta del buon lavoratore indiano propenso al lavoro con gli animali, in
particolare le mucche. Esso, secondo piani diversi, è favorevole per tutti gli attori coinvolti:
datore di lavoro, lavoratore e mediatore. Da una parte all’interno del frame della Bossi-Fini
questo sistema ha permesso di costruire la catena migratoria dal Panjab; d’altra parte ha
garantito la produzione 365 gg l’anno e ha gerarchizzato la componente migrante attraverso la
figura del mediatore. Tale figura acquisisce attraverso il capitale simbolico ed economico
accumulato durante l’attività una posizione privilegiata e di potere all’interno della catena
migratoria. E le tre figure hanno qualcosa in comune, essere agricoltori in luoghi diversi.
L'immigrazione indiana si concentra in Lombardia (55 417), Emilia Romagna (18 901), Veneto
(17 522), e Lazio (18 144); il bacino principale comprende la Provincia di Mantova la bassa
Bresciana, Bergamasca e il basso Piacentino, Reggiano, Modenese. I lavori nel primo settore
effettuati dai panjabi sono principalmente due: bracciante, in particolare nella zona di Latina, e
di operaio specializzato nella filiera della trasformazione del latte. L’impiego più noto è nella
filiera del Grana Padano e Parmigiano Reggiano, mentre ancora non vi sono ricerche specifiche
nella filiera della Mozzarella di Bufala tra le provincie di Salerno e Caserta, e negli alpeggi
prealpini e appenninici. La mansione più ricorrente è quella di mungitore, mentre testimonianze
ancora non sufficientemente supportate da ricerche scientifiche riportano l’inserimento in altre
mansioni della filiera, sia nel trasporto del latte sia nella trasformazione del parmigiano stesso
(caseificio).
Grafico 9 Distribuzione soggiornati indiani in Italia
Fonte: ISTAT
Peculiare è invece la distribuzione territoriale con una forte concentrazione nelle aree rurali
o in piccoli aggregati. Prendendo come riferimento i residenti in termini assoluti ritroviamo, tra
i primi 5 agglomerati, 3 piccole città: Suzzara, Arzignano e Sabaudia.
Tabella 12 Città maggiormente rappresentative per la migrazione indiana. Numeri assoluti e
comparazione con il totale di resistenti
Indiani Residenti Totali
Roma 6.291 2 641 93
Brescia 2.045 188 872
Suzzara (MN) 1.244 20 314
Arzignano (VI) 1 095 25.713
Sabaudia (LT) 985 19.287
Fonte: ISTAT, Dati 2010. Elaborazione nostra
La migrazione indiana è particolarmente rilevante in agricoltura: è la seconda nazionalità in Italia ad
essere occupata in tale settore, preceduta dalla sola Romania. I dati della Coldiretti sottolineano infatti
come, nel 2012, 27 789 lavoratori indiani era impiegati in tale settore, un terzo del totale dei lavoratori
(e lavoratrici) di tale nazionalità. Da notare il trend positivo negli anni della crisi economica.
Grafico 15 Occupati indiani per settore di attività economica (v.%). Serie storica 2007-2012
Fonte: MPLS.
I lavoratori di nazionalità indiana detengono la percentuale più elevata di lavoratori agricoli a tempo
indeterminato (6 057), che supera di gran lunga i rumeni (4 824), nonostante questi ultimi siano 5
volte più numerosi nel settore; la classe di reddito è superiore rispetto agli altri migranti extra EU.
Inoltre il tasso di disoccupazione è in linea con quello dei locali e notevolmente inferiore alle altre
nazionalità.
Grafico 13 Reddito medio per cittadinanza. Serie storica 2007-2012
Fonte: MPLS.
Grafico 14 Occupati per classe di reddito. Anno 2012
Fonte: MPLS [2013, p. 40]
Grafico 16 Tasso di disoccupazione per cittadinanza. Serie storica 2007-2012
Fonte: MPLS.
Il Punjab è un piccolo stato nell’India del Nord al confine con il Pakistan e ha un forte legame
con la diaspora mondiale tanto che alcuni autori parlano di Panjab de-centrato.
Gran parte di loro è di religione sikh, mentre la minoranza è hindu e ravidassia. La casta prevalente
in Italia è quella dei seini, storicamente inseriti nel settore della coltivazione di frutta e verdura,
seguita dai jat, la casta più influente in Panjab che corrisponde ai proprietari agricoli (riso/grano). Ad
esse da segnalare inoltre minoranze di bramini (hindu), rajput (hindu e sikh), lubana (sikh), e di quelli
che furono “fuoricasta”, in particolare di casta chamar (conciatori) e di religione ravidassia. I Panjabi
sono per lo più agricoltori poco istruiti che migrano per motivi “economici” legati alla diminuzione
dei proventi delle terre dovuti, ironicamente, dalle ripercussione delle trasformazioni economiche nel
primo settore in Panjab.
In Italia la migrazione è iniziata negli anni ’70 attraverso il canale del circo equestre, mentre
l’inserimento in agricoltura è avvenuto a partire dalla fine degli anni ’80 inizio ’90. La strategia
migratoria dei pionieri, in panjabi babas, è piuttosto standardizzata e vede l’uomo che va all’estero,
prende i documenti, si sposa e ricongiunge la moglie ed eventualmente i figli. Nonostante la
restrizione degli ingressi a cittadini terzi da parte dell’Italia, la presenza della migrazione indiana è
decuplicata negli ultimi 20 anni. Ma come hanno fatto a costruire una catena migratoria negli anni
della Bossi-Fini? Il meccanismo di reclutamento e la figura del mediatore risulta centrale.
Grafico 7 Soggiornanti Indiani in Italia
Fonte: ISTAT.1 Elaborazione nostra
Il lavoro nelle stalle.
Il lavoro nelle stalle, in particolare la mungitura, è svolto su doppia turnazione a distanza di 12 ore e
comprende un turno notturno e uno diurno (solitamente dalle 4 alle 8 e dalle 16 alle 20). È un lavoro
duro, che richiede capacità di lavorare in autonomia e specializzazione, in quanto la mungitura è
sempre più tecnologizzata. La selezione dei capi è inoltre centrale nella produzione: il latte prodotto
per capo è passato dai pochi litri della frisona locale ai 35-40 della vacca selezionata attraverso
inseminazione artificiale, l’olandese. La vacca, d’altra parte, una volta rimaneva nella stalla per una
ventina d’anni ora dopo 2/3 parti viene macellata e sostituita. Questo significa un forte ampliamento
delle dimensioni delle stalle, e in particolare della parte non produttiva, dettata dalla crescita del tasso
di rimonta interna. In altri casi i capi vengono divisi in più strutture, come le aziende specializzate
che si occupano dei vitelli da ingrasso. Le aziende piccole sono quindi scomparse, mentre in quelle
grandi la taylorizzazione delle mansioni e la richiesta di personale subordinato diviene centrale.
Spesso le vecchie aziende e proprietà sono state acquistate dalle aziende in espansione per costruire
nuove stalle sul terreno e coltivare a foraggio i terreni;2 questo vuol dire che i molti casolari siti su di
essi possono essere affittati o dati in comodato. Vedremo poi come questo è stato un punto importante.
La famiglia dei datori di lavoro non basta per coprire i ruoli all’interno della produzione, i membri
più giovani preferiscono lavorare in altri settori o adempiere alle mansioni d’ufficio; vi è stato infatti
un aumento della burocratizzazione dettata dall’aumento delle certificazioni e dei controlli. La figura
1 I dati del 1971 e 1981 non distinguono il genere. 2 Oltretutto il nuovo protocollo del Parmigiano Reggiano prevede la coltivazione in loco del foraggio.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
donne
uomini
storica del bergamino che spesso viveva a vita nella proprietà padronale con la famiglia e lavorava
con i datori di lavoro è stata sostituita da una serie di operai specializzati su una o più mansioni,
mentre il datore di lavoro si stacca sempre più dal lavoro manuale in sé. Nelle stalle è quindi difficile
vedere fisicamente il datore di lavoro, e i lavoratori devono adempiere agli impieghi in autonomia. I
datori di lavoro necessitano quindi di forza lavoro 365 giorni l’anno, sempre presente, specializzata,
autonoma. E l’hanno trovata nei migranti panjabi. Il “cappello culturalista” costruito dai datori di
lavoro locali in merito alla presunta propensione vocazionale nella mungitura dettata dalla sacralità
della vacca (sfatata anche dal fatto che la maggior parte dei mungitori è sikh o ravidassia, religioni
per le quali non vi è nessuna sacralizzazione della mucca) nasconde la scelta, dopo aver “testato”
lavoratori di diverse provenienze, dei migranti indiani proprio per il loro sistema di sostituzione che
garantisce la continuità della produzione.
Gli indiani sono un fenomeno positivo della globalizzazione. Negli anni 80 nessuno più si
fermava nella stalla ed è impossibile trovare dei ragazzi che si svegliano alle 4 di mattina ad
andare nella stalla, non li trovi. Ti dicono sì sì e dopo... non son capaci di lavorare pensano solo
allo stipendio […] e chiedono se sabato son liberi, domenica... quanto gli dai... in un'azienda
agricola non esiste il sabato e la domenica... ok non schiavizziamo... un ragazzo di Modena ha
lavorato 6 mesi e non ha mai lavorato una domenica... andava a Carpi... e poi se proprio
avevamo bisogno lo avvisavamo molto prima... ma l'approccio mentale è: “sabato sono libero
domenica sono libero?” […]. Gli indiani hanno usato una strategia. Negli anni ‘80 sono arrivati
i filippini e vietnamiti... noi non li abbiamo mai avuti... e gli altri ci han detto che erano
inaffidabili ed era vero... venivano e il giorno dopo andavano via... e uno rimaneva così... poi
sono venuti i neri ed è peggio che andar di notte... ne abbiamo avuti, alcuni incapaci, quello ci
sta, bianchi, neri... se uno non ha voglia di lavorare, non conta la pelle! Abbiamo avuto uno del
Congo, un'altro senegalese, uno della Costa d'Avorio che non possiamo dire che abbiano
lavorato male... tranne uno che era un disgraziato... erano bravi ma l'indomani arrivava
l'amichetto della comunità che diceva che alla TNT gli davano 10€ in più e andavano lì... E ne
ho visto tanti...che mi rincontravano dopo quando erano alla TNT e mi dicevano “Son sempre
per strada”. Ci dovevi pensar prima, devi aver l'attitudine, loro quando si presentano dicono che
non hanno mai problemi e fanno qualsiasi cosa... poi non è vero sono uomini come tutti... alcune
cose sono più propensi altri no... e da lì cos'è successo... che hanno iniziato a proporsi gli
indiani... guarda che son bravi! Ne abbiamo avuto uno all'inizio veramente bravo, era il 1997-
8, ha lavorato 4 anni e poi era un po' un esaltato, gli piacevano i muscoli ed è andato a fare il
buttafuori... se è contento lui! Poi ce ne han proposto un altro... ha lavorato benissimo... anche
lui ha fatto la scelta di fare il corriere di notte, gli piace distribuire i giornali, questo nel 2004-
5... Però gli indiani hanno un'accortezza che altre etnie non hanno... quella di preoccuparsi del
posto che lasciano... è una tendenza che mi han detto anche gli altri [agricoltori]... si
preoccupano del posto che lasciano... si preoccupano del datore di lavoro... cambio lavoro ma
attenzione se vuoi io c'avrei tizio che potrebbe venire al posto mio... ti vedi di fronte un operaio
che lavora bene, che ti dice, e ti propongo lui... ovvio se è bravo come te fallo venire... poi...
questo ragazzo qui aveva 2 fratelli uno bravissimo che ha lavorava con noi copriva i buchi
quando non c'era lui e andava in ferie... e l'altro fratello è quello che vive di su... questo qua...
ha la passione del bere, ciucca un po' e ha rischiato il licenziamento anche se siamo molto
pazienti... perché non sono lavori facili e cerchi di avere il massimo della comprensione... ma
abbiamo piazzato la figlia... che è maggiorenne ha detto che sarebbe venuta volentieri... è una
ragazza straordinaria... lei lavora con il papà. Della mungitura si occupa della stalla con una
precisione una cura... capisce tutto al volo e ti dà soddisfazioni... ha grosse difficoltà a capire
l'italiano... ma ha intuito... siamo contenti e il padre si affida a lei fa da parafulmine...anche lui
è bravo... sono persone che magari hanno dei vizi fuori dal lavoro... per dire... ha rischiato il
licenziamento perché è arrivato a lavorare sbronzo... ma nel lavoro in sé quando è sobrio lo fa
bene... non fa cazzate [Datore di lavoro, Prov. Parma, 01/10/2012].
Il sistema che emerge vede due figure: l’intermediario occasionale e quello di professione. Il primo
non reitera l’intermediazione e accumula come vedremo capitale simbolico; il secondo ne fa della
mediazione una vera e propria professione dove la Legge Bossi fini influenza la costruzione della
figura stessa e il guadagno è oltre che simbolico, anche economico. Vi sono due tipologie di
intermediario che abbiamo categorizzato in contractor, esterno all’azienda, o caporeparto, all’interno
dell’azienda. Il primo fornisce un nuovo contatto al datore di lavoro di un’altra azienda o della propria
azienda prima di andarsene; il secondo fornisce un nominativo da assumere all’interno dell’azienda
in cui già lavora o gestisce le sostituzioni temporanee.
In questo modo il datore di lavoro vede garantita la produzione; allo stesso tempo i lavoratori vengono
formati gratuitamente dall’intermediario. Ma perché fanno tutto questo?
Un lavoro strategico ai tempi della Bossi Fini.
Il lavoro nelle stalle è strategico per i panjabi in quanto ha permesso attraverso le sanatorie prima e i
decreti flussi poi la regolarizzazione dei migranti. Il lavoro nelle stalle nel Nord Italia è un lavoro
contrattualizzato e il salario è piuttosto cospicuo, e varia tra i 1 800 e i 2 500€ al mese. Molti per
arrivare a cifre così elevate si occupano anche dei parti. Il contratto e il salario elevato hanno permesso
di ottenere velocemente il ricongiungimento familiare e la carta di soggiorno, aiutati da un terzo
fattore fondamentale: la casa in comodato. Le famiglie così ricostituite spesso comprendono la moglie
i figli, i genitori/suoceri e talvolta fratelli e sorelle, parenti e conoscenti reclutati nel medesimo lavoro,
di cui parleremo pocanzi, o più semplicemente ospitati per un breve periodo durante la ricerca del
lavoro. Le case in comodato sono spesso grandi e permettono di ospitare diverse persone nonostante
siano prive di riscaldamento e piuttosto fatiscenti.
Il lavoro nelle stalle diviene quindi strategico per la prima parte del percorso di stabilizzazione sul
territorio. Allo stesso tempo la casa in comodato può divenire una sorta di gabbia: l’espressione di un
intervistato è risultata particolarmente felice nel definire la “seclusione” nella proprietà del padrone,
cioè essere “come il pulcino sotto gli occhi dell’aquila”.
Quando vivi dentro la proprietà, la casa in comodato ti trasforma in uno schiavo. Perché se vuoi
lasciare il posto di lavoro hai due problemi, o accetti tutto o devi trovare un altro lavoro e un’altra casa
contemporaneamente [Sunny, F, 49 anni, ND, Talvan ( Kapurthala ) , Prov. Reggio Emilia , 09-04-
2012].
Cambiare posto di lavoro significherebbe quindi perdere la casa contemporaneamente e questa
diviene una delle motivazioni della necessità di un sistema di sostituzione che garantisca nelle
modalità e nei tempi l’uscita dalla casa. Un’altra angolatura con la quale guardare il sistema di
reclutamento prende in considerazione l’ottica “generazionale” della migrazione. I primi ad essere
stati reclutati sono quei pionieri, babas, spesso arrivati o inseriti come primo lavoro nel circo che ha
permesso loro di conoscere la lingua e il territorio italiano e autonomamente hanno individuato la
stalla nella quale avrebbero poi lavorato. Il sistema di sostituzione garantisce loro di scegliere chi
chiamare; ovviamente in ultima istanza è il datore di lavoro a pronunciarsi in merito ma questo
permette di “chiudere” ai parenti e conoscenti l’accesso al lavoro in una determinata stalla che a loro
volta chiameranno i propri familiari. Occorre aggiungere come i panjabi negli anni ’80 e ’90
arrivavano in Italia senza documenti amministrativi attraverso viaggi rocamboleschi via terra o via
nave; dagli anni 2000 l’approdo irregolare è stato sostituito dall’arrivo via aereo con visto turistico,
grazie agli accordi bilaterali Italia-India, a cui sussegue la condizione di overstayer. I maggiori
controlli dei documenti in Italia settentrionale hanno portato alla creazione di un bacino di panjabi
senza documenti amministrativi nella zona del parco del Circeo (Latina) assunti come braccianti in
attesa di regolarizzarsi. Il reclutamento mediante intermediario permette di ottenere un lavoro
regolare anche senza aver prima acquisito sufficienti conoscenze della lingua e della società italiane;
tale dinamica provoca d’altra parte una dipendenza del fruitore nei confronti dell’intermediario che
si prolunga nel tempo, aggravata dall’isolamento geografico dettato dall’atomizzazione delle aziende
agricole in Pianura padana.
Il contratto di lavoro fornito mediante l’intermediario ha infine un costo diverso in base alla
funzione che esso svolge: basti pensare come un contratto che permetta l’emersione dall’irregolarità
amministrativa e l’ottenimento dei documenti sia sempre seguito da un pagamento anche nel caso dei
familiari, mentre l’arrivo diretto mediante decreto flusso l’importo decuplica, superando talvolta i 20
000€ da parte del fruitore, e implica una connessione con un agente in India, l’accordo del datore di
lavoro e altre figure sul territorio. Le politiche migratorie quindi non determinano le migrazioni
piuttosto influiscono sulla costruzione di gerarchie interne ai network e il costo di ipotetiche
regolarizzzazioni.
I datori di lavoro hanno quindi bisogno di lavoratori o di sostituti durante le assenze temporanee e i
licenziamenti; attraverso i mediatori adempiono alle proprie richieste con lavoratori come vedremo
formati e docili, in quanto sottoposti al ruolo disciplinatore dell’intermediario e spesso privi di
conoscenze linguistiche in merito all’italiano. Ma chi sono i mediatori?
“Per loro la mucca è sacra”. Il reclutamento e i mediatori panjabi
Nelle regioni della Pianura Padana considerate da questa ricerca (la provincia di Mantova, la bassa
Parmense, Reggiana, Modenese, cremonese e il Basso Bresciano e Bergamasco), gli intermediari
panjabi nel settore dell’allevamento sono principalmente lavoratori inseriti dagli anni ’80 e ’90 nelle
aziende zootecniche in qualità di mungitori di bovini da latte, i quali reclutano e formano connazionali
(spesso parenti) e in cambio acquisiscono capitale economico e/o sociale.
La storia di Amandeep e Darshan ci servirà come esempio per spiegare il funzionamento.
Amandeep arriva in Italia nel 1990 con un visto turistico per i mondiali di calcio. E’ rimasto oltre
la scadenza dello stesso e ha trovato un lavoro come stagionale nella zona di Latina. Ha lavorato 5
anni senza nessun tipo di contratto come bracciante e cameriere e ha deciso di trovare lavoro in Nord
Italia. E’ arrivato alla stalla di Mario con una borsina di plastica in mano. Il padre di Mario aveva
avuto alcuni problemi di saluti e decisero di assumere Amandeep in qualità di mungitore. Attraverso
la sanatoria del 1997 è stato regolarizzato e gli hanno fornito in comodato una delle case sulla
proprietà. Nel 1998 ha richiesto e ottenuto il ricongiungimento familiare della moglie e della figlia.
Altri allevatori del luogo sono interessati ad assumere nuova forza lavoro e chiedono a Luigi
nominativi e negli anni trova lavoro a decine di lavoratori. Franco è uno di essi. Amandeep stava
ospitando un compaesano, Darshan, che da alcuni anni viveva a Roma senza documenti, l’ha formato
come mungitore e l’ha proposto a Franco. Darshan ha ottenuto i documenti nel 1997. Franco negli
anni successivi ha deciso di aumentare la propria stalla e ha domandato a Darshan di reclutare altri
mungitori. Darshan chiama il fratello mediante il decreto flussi del 1998. Sia Darshan sia il fratello
“chiamano” moglie e figli l’anno successive mediante il ricongiungimento familiare. Nel 2008,
chiamano mediante la sanatoria badanti il fratello, poi assunto nella medesima azienda Agricola.
Darshan adesso non deve più alzarsi alle 3 di mattina, e provvede solo all’approvvigionamento del
cibo agli animali e alla direzione dei lavori in stalla, mentre i fratelli mungono. Mario decide di
allargare anch’egli la propria stalla, ma decide di non chiedere ad Amandeep. Piuttosto fonda assieme
a dei soci una cooperative di sostituzione manodopera e uno dei lavoratori dopo averlo “testato” è
stato assunto all’interno della stalla. Amandeep si licenzia nel 2012 e dopo qualche mese continuerà
la sola attività di mediatore in merito agli arrivi, grazie ai contatti costruiti negli ultimi 20 anni.
In entrambi i casi i lavoratori vengono formati prima di essere inseriti nella mansione dagli stessi
mediatori: l’identità imprenditoriale che si sono portati in valigia dal Panjab gli permette di capire le
esigenze del datore di lavoro. Questo è un nodo centrale per un lavoro specializzato come quello della
mungitura, e permette di costruire la fiducia necessaria con il datore di lavoro per evitare l’incursione
di esterni all’interno del sistema di reclutamento.
Amandeep e Darshan sono due figure molto diverse: la prima diviene un vero e proprio mediatore
di professione e svolge il lavoro contraccambiato con capitale sia economico sia simbolico. La
seconda è un mediatore occasionale che accumula capitale simbolico. Entrambe vedono come
centrale l’influenza delle politiche migratore che, attraverso un utilizzo strumentale, permettono la
regolarizzazione e allo stesso tempo stratificano la componente migrante.
Conclusioni. Gli imprenditori allo specchio.
I panjabi e la figura del mungitore in Pianura padana può difficilmente essere riassunto nel conflitto
tra lavoratori e datore di lavoro. I datori di lavoro in primo luogo non sono che un tassello della filiera
che deve sottostare alle logiche della GDO e i cambiamenti di produzione e di domanda
internazionali. Essi hanno trovato nei mungitori panjabi la possibilità di veder garantita la produzione
mantenendo il costo del lavoro basso, grazie al ricatto intrinseco alla legge Bossi-Fini. Le priorità del
migrante di veder garantita la propria presenza sul territorio e dei propri familiari porta a mettere in
secondo piano l’entità stessa del salario. Diciamo questo perché una delle dinamiche emerse, in
particolare negli anni della crisi economica, è di un abbassamento del salario per gli operai nella
mungitura. Sono gli stessi mediatori, decuplicati, che per piazzare qualcuno e rompere l’egemonia
“familiare” propongono il lavoratore ad un prezzo inferiore. Dinamica che sarebbe probabilmente
notevolmente ridimensionata senza la parte amministrativa legata alle politiche migratorie che in
Italia legano il permesso di soggiorno al contratto di lavoro. Si è arrivati a salari inferiori ai 1000€
mensili. In alternativa un secondo tipo di ricatto emerso è di pagare solo parzialmente le ore svolte
(vengono segnate 6 ore invece delle 8-10 ore realmente lavorare) o in alternativa è stato aumentato il
numero di capi da mungere, lasciando invariato il numero di mungitori.
Quando sono venuti quelli di Brescia [nuovi proprietari dell’azienda agricola, N.d.R.] loro
volevano pagarmi 6 ore... dicevano che erano 300 vacche... dicevano: “il computer di mia figlia
dice che ci vuole questo tempo per mungerle”. Poi le vacche sono aumentate in più c’erano i
vitelli... e il computer non ha detto niente.... e siamo rimasti lì... Poi hai quello malato, perdi
tempo, devi curarlo... gli facevo le punture, gli facevo tutto... Quando è morto mio marito ne
hanno voluto un po' approfittare perché oramai il mondo funziona così... mi hanno aiutato tanto
sono sempre stati bravi... poi dopo voleva più lavoro con la stessa paga... e ho detto no... perché
io lascio a casa i miei figli... io il mio lavoro lo faccio. Però non lavoro a gratis. Perché prima
io la domenica facevo festa non andavo a lavorare... dopo mi hanno chiamato ad andare a
lavorare anche domenica e per me non c'è problema.... Poi non è che quando finisco il lavoro
mi dai un pezzo di formaggio... e mi dai 10 uova. No tu mi dai quello che mi spetta le uova le
vado a comprare io [Sunny, F, vedova, 49 anni, non credente, Talvan (Kapurthala), Prov.
Reggio Emilia, 09-04-2012].
Dall’altra parte come abbiamo visto vi è il tentativo di alcuni datori di lavoro di sostituire il
reclutamento informale del mediatore con cooperative di sostituzione di proprietà degli stessi
allevatori che secondo gli stessi prevengono possibili forme di caporalato. Da un'altra prospettiva è
possibile leggere la formalizzazione del sistema di sostituzione come una forma di accaparramento
del padrone del profitto del mediatore. Notando che molti di essi continuano ad essere panjabi.
Tra i mungitori panjabi d’altra parte è possibile notare come molti di essi dopo un decennio hanno
lasciato tale lavoro perché considerato usurante e alcuni dei quali stanno costruendo aziende agricole
in Panjab di stampo “italiano”, dove la produzione del latte è intensiva e la mungitura è meccanizzata.
Negli ultimi dieci anni decine di macchinari agricoli sono stati acquistati smontati e spediti in Panjab
tanto da far lanciare all’Emilia Romagna un Progetto chiamato “campo prova” di inserimento delle
aziende produttrici di macchinari agricoli emiliane nel mercato indiano.
L’agricoltura in Pianura padana è in continua trasformazione. La lettura che si è cercata di dare
attraverso un caso ben specifico che è quello dei panjabi indiani nel settore dell’allevamento è che
focalizzarsi su un giudizio di valore sul ruolo dell’intermediazione è una modalità parziale che esula
dell’analisi in profondità delle complessità coinvolte. Esse coinvolgono politiche di mercato e
migratorie internazionali nelle quali i singoli cercano di trovare la propria dimensione.
Cadere in analisi semplicistiche in merito alla figura del mediatore sarebbe un po’ come ricordare,
celebrandolo, il tremendo naufragio dell’Isola dei Conigli occorso un anno fa, concentrandosi solo
sulla figura del trafficante.