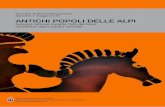Celti e Reti tra V e I sec. a.C.: contesto culturale e progetto di ricerca "Karnyx di Sanzeno"
Celti e Liguri. Rapporti tra la Cultura di Golasecca e la Liguria interna nella prima età del Ferro
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Celti e Liguri. Rapporti tra la Cultura di Golasecca e la Liguria interna nella prima età del Ferro
CELTI E LIGURI. RAPPORTI TRA LA CULTURA DI GOLASECCA E LA LIGURIA INTERNA NELLA PRIMA ETÀ DEL FERRO
Valentina Faudino (1), Luisa Ferrero (1), Marina Giaretti (2), Marica Venturino Gambari (1)
Riassunto. Il contributo si propone di mettere in luce i rapporti tra l’areale insubre occidentale della cultura di Golasecca e la Liguria interna ligure-piemontese, sulla base dei dati provenienti da nuove ricerche archeologiche (Villa del Foro, Castello di Annone, Montecastello, Valle Curone) e dalla revisione sia di materiali inediti conservati al Museo di Antichità di Torino, sia di dati bibliografici e d’archivio.Lo studio si concentrerà in particolare sull’analisi di alcuni indicatori cronologico-culturali, puntando a delineare gli areali e le modalità della presenza nel territorio ligure-piemontese di elementi di piccola metallurgia (in particolare oggetti di ornamento: fibule, pendagli etc.) significativi per evidenziare l’esistenza di rapporti connessi a influenze culturali, scambi commerciali, circolazione di persone o di innovazioni tecnologiche.
Résumé. Cette contribution vise à mettre en évidence les relations entre la région insubre occidentale de la culture de Golasecca et la Ligurie interne (entre la Ligurie et le Piémont d’aujourd’hui) en s’appuyant sur les données issues de nouvelles recherches archéologiques (Villa del Foro, Castello di Annone, Montecastello, Valle Curone) autant que sur la révision des quelques éléments inédits du Musée d’Antiquité de Turin et de plusieurs références bibliographiques et d’archive.L’étude se concentre en particulier sur l’analyse de quelques indicateurs chronologiques et culturels, en vue de déterminer les aires et les modalités d’occurrence, sur le territoire de la Ligurie et du Piémont, des petits objets métalliques (en particuliers les accessoires vestimentaires : fibules, pendeloques etc.) qui se révèlent très significatifs pour mettre en lumière réseaux de circulation, relations liés aux influences culturelles, échanges commerciaux, mouvements de personnes ou innovations technologiques.
(1) Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie, Piazza San Giovanni, 2 - I - 10122 Torino [email protected] - [email protected] - [email protected](2) Corso XI Febbraio, 21/A - I - 10152 Torino - [email protected]
Argomento del presente contributo è la diffusione di oggetti di abbigliamento, di ornamento e di utilizzo per-sonale (fibule, ganci di cintura, pendagli, dischi, anelli, perle, oggetti da toeletta) in bronzo e in ferro durante la Media Età del ferro (600-475 a.C.) nella Liguria interna piemontese, la parte del Piemonte meridionale collocata a sud del fiume Po e corrispondente ai territori delle attuali province di Alessandria, Asti e Cuneo (fig. 1). Quest’areale manifesta fin dall’Età del bronzo medio-re-cente (facies Alba-Scamozzina e Alba-Solero) (1450-1200 a.C.) e ancora nell’Età del bronzo finale (Protoli-gure) (1200-900 a.C.), nella Prima (Ligure II) (900-475 a.C.) e nella Seconda (Ligure III) (475-125 a.C.) Età del ferro una marcata autonomia culturale rispetto ai territori a nord del Po, autonomia che si esprime non solo
nell’adozione di differenti tipologie del repertorio vasco-lare ma anche in particolari manifestazioni del rituale funerario (come la copertura del cinerario con una lastra di pietra invece che con una scodella fittile capovolta) che documentano, dopo la Media Età del bronzo, il gra-duale avvio e il progressivo consolidarsi di un processo di etnogenesi delle popolazioni liguri nel confronto con i coevi gruppi rispettivamente delle culture di Canegrate, Protogolasecca e Golasecca dell’areale insubre (Gam-bari, 1998 ; Gambari, 2004 ; Gambari, Venturino Gam-bari, 2004)1.
1. Per la periodizzazione del Bronzo finale - Età del ferro dell’areale ligure si fa riferimento a Gambari, Venturino Gambari, 2004, con tabella cronologica di sincronizzazione a p. 30.
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012), 125p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
Valentina Faudino, Luisa Ferrero, Marina Giaretti, Marica Venturino Gambari
126 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012),p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
Si deve comunque segnalare che, nell’Età del bronzo come nell’Età del ferro, a una forte differenziazione delle forme della ceramica non corrisponde una analoga carat-terizzazione originale, con differenze apprezzabili nei due areali presi in considerazione, dei tipi degli oggetti metallici di ornamento e di abbigliamento personale (spilloni, fibule) che nella Liguria interna piemontese mostrano, ancora nell’Età del ferro, la coesistenza di tipologie caratteristiche dell’areale insubre accanto a fogge che esprimono una originale elaborazione locale (Ferrero, Venturino Gambari, 2008, p. 31).
In una prospettiva complementare a quella di studi avviati recentemente sulla diffusione di oggetti di piccola metallurgia di influenza golasecchiana a nord delle Alpi per comprendere meglio le modalità delle influenze della cultura di Golasecca sulle culture coeve dell’areale cel-tico transalpino2, questo contributo rappresenta l’avvio di una ricerca indirizzata a caratterizzare sul piano tipolo-gico anche a sud del Po gli oggetti di abbigliamento, di ornamento e di uso personale nella Media Età del ferro, attraverso la revisione di reperti e complessi provenienti da siti del Piemonte meridionale culturalmente inseribili
nel Ligure II (600-475 a.C.), prendendo lo spunto dallo studio dell’ingente quantità di reperti provenienti dal sito artigianale di Villa del Foro (Alessandria) (Venturino Gambari, 1994, con bibliografia precedente), certamente il complesso più rappresentativo in questo periodo, di prossima pubblicazione.2
I materiali presentati in questa sede provengono principalmente da indagini archeologiche condotte negli ultimi trenta anni dalla Soprintendenza per i Beni Archeo-logici del Piemonte a Villa del Foro e in siti di abitato, come il Guardamonte di Gremiasco, Montecastello e Serravalle Scrivia (inedito) (AL) (Chiaramonte Treré,
2. Ai fini del presente lavoro particolarmente utile per la sintesi delle problematiche e il repertorio iconografico dei ritrovamenti nelle aree celtiche transalpine è stata la tesi di dottorato di Veronica Cicolani Diffusion du mobilier de Golasecca au nord des Alpes au premier âge du Fer, sostenuta il 14 giugno 2010 presso l’Université François-Rabelais di Tours (Cicolani, 2010) ; l’accesso ai materiali e alla documentazione d’archivio per l’ambito piemontese è stato autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie con il coordinamento di Filippo Maria Gambari, allora funzionario archeologo presso la medesima Soprintendenza.
Fig. 1. Carta del Piemonte meridionale con i siti citati nel testo : Pontechianale (CN), 1 ; Crissolo (CN), 2 ; Sampeyre-Villaretto (CN), 3 ; Sampeyre-Mandam (CN), 4 ; Valdieri (CN), 5 ; Entracque (CN), 6 ; Villanova Mondovì (CN), 7 ; Mondovì-Breolungi (CN),
8 ; Alba (CN), 9 ; Cossano Belbo (CN), 10 ; Asti (Museo Civico), 11 ; Castello di Annone (AT), 12 ; Villa del Foro (AL), 13 ; Montecastello (AL), 14 ; Castelnuovo Scrivia (AL), 15 ; Rocca Grimalda (AL), 16 ; Serravalle Scrivia (AL),
17 ; Guardamonte di Gremiasco (AL-PV), 18 ; Brignano Frascata (AL), 19.
Celti e liguri. rapporti tra la Cultura di golaseCCa e la liguria interna nella prima età del Ferro
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012), 127p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
Baratti, 2004 ; Venturino Gambari, Cattaneo Cassano, 1995), Castello di Annone (AT) (Venturino Gambari et alii, 1996), Cossano Belbo e Mondovì-Breolungi (CN) (Venturino Gambari et alii, 1994 ; Bagienni, 2001) ; com-pletano il repertorio elementi di corredo provenienti da contesti funerari, come Rocca Grimalda (AL) (De Mar-chi, Pirotto, 2004), Alba, Crissolo, Entracque, Pontechia-nale e Valdieri (CN) (Venturino Gambari et alii, 2009 ; Gambari, Venturino Gambari, 1997 ; Molli Boffa, 1999 ; Mano, De Angelis, 2004 ; Valdieri, 2008), e rinvenimenti di superficie (Brignano Frascata3 e Capriata d’Orba) (Venturino Gambari, Crosetto, 2009) o comunque privi di dati di associazione e/o contesto, come Castelnuovo Scrivia (AL) (Venturino Gambari et alii, 1998), Asti4 (Tosello, 1996), Sampeyre-Villaretto, Sampeyre-Man-dam e Villanova Mondovì (CN) (Venturino Gambari, Mano, 1988 ; Venturino Gambari, 1991). Sarà oggetto di prossima analisi e riflessione l’approfondimento, basato sulla bibliografia disponibile, della distribuzione delle stesse tipologie di oggetti nella Liguria propria e nelle Alpi Marittime francesi, al fine di completare la carta di distribuzione dei tipi e meglio comprendere il quadro cronologico-culturale e i rapporti intercorrenti tra i diversi gruppi.
Come era logico aspettarsi, il maggior numero di reperti è costituito dalle fibule in bronzo e, meno frequen-temente, in ferro, nelle diverse varianti (ad arco serpeg-giante, a fettuccia, a navicella, a sanguisuga con anima in cotto, con inserti in materiale deperibile, ad arco bicon-vesso, miniaturizzate, tardo-alpino, tipo Certosa) (fig. 2-13) ; in numero ancora limitato sono allo stato attuale i pendagli (a secchiello, a melograno, a otto) (fig. 14, n° 1-17), i dischi fermapieghe (fig. 14, n° 18-20), gli anelli a globetti (fig. 14, n° 21-23), le perle (fig. 14, n° 24-25), gli oggetti da toeletta (fig. 15, n° 1-4) e i ganci di cintura (fig. 15, n° 5-7).
Ogni categoria di oggetti, in questa sede presentati secondo un ordine prevalentemente cronologico attraverso il riferimento alle principali periodizzazioni in uso, è stata analizzata evidenziando i confronti e le relazioni con l’am-bito della cultura di Golasecca, al fine di definirne l’appar-tenenza alla medesima sfera metallurgica o l’autonomia in ambito ligure della manifattura artigianale.
3. I materiali esaminati in questa sede sono inediti, per un inquadramento generale dei ritrovamenti nell’area di Brignano Frascata, cfr. Conquista Appennino, 2004.4. Si tratta di un complesso di reperti metallici in giacitura secondaria recuperati negli scavi (1875) di Giuseppe Fantaguzzi nella necropoli della Torretta all’uscita della città di Asti in direzione di Torino (Colligite fragmenta, 2009, p. 139-142 ; 381-383) ; si tratta probabilmente di nuclei di sepolture dell’ Età del ferro intercettate e sconvolte dalle tombe di età romana e di cui nel Museo Civico di Asti si conserva soltanto un numero limitato di fibule, pendagli a secchiello, anelli a globetti e oggetti da toeletta.
1. Fibule
1.1. Fibule ad arco serpeggiante (G I C-G III A1) (Ha C2-Ha D3)
L’unico esemplare in ferro finora noto proviene da Villa del Foro, con arco in verga a sezione circolare e nodulo fermapieghe (fig. 2, n° 1). Sembra essere il tipo più antico, comparendo in corredi tombali dalla seconda metà del VII secolo a.C. (G I C) (Castello Valtravaglia, t. XXIV, con urna globulare decorata a triangoli tratteg-giati incisi : le fibule in ferro, sempre molto frammentarie, sono spesso associate alla parure da toeletta, anch’essa in ferro - Batchvarova, 1969, fig. 1, t. XXIV e t. XXVI ; t. XI : fibula in ferro quasi intera, con nodulo più in basso del nostro esemplare, l’urna è biconica con decorazione a triangoli incisi - Saronio, 1970, tav. III, n°12).
Il tipo è attestato negli abitati nel corso del VI secolo a.C., come per esempio a Gamsen (Brig-Glis) (G II A - Cicolani, 2010, pl. S.18, 64.40). A Giubiasco è presente nella t. 2/1958 del G II A (Schindler, De Marinis, 2000, fig. 10, n° 6). Scompare dal V secolo a.C. ad eccezione di qualche esemplare in Canton Ticino. La scelta di utiliz-zare il ferro potrebbe caratterizzare questo tipo di fibula come un bene di prestigio legato al mondo maschile della cultura di Golasecca, dal momento che – oltre alle fibule di questo tipo e a parures da toeletta – vengono confezio-nati con questo metallo anche armi (lance, coltelli), spiedi ed elementi di carro (Cicolani, 2010, p. 208 ss.).
Decisamente più diffuso è il tipo serpeggiante in bronzo con arco in filo : a Villa del Foro (fig. 2, n° 2-3) si contano complessivamente venti esemplari, tutti fram-mentari ; almeno uno di essi sembra riferibile alla variante con grande disco fermapieghe (fig. 2, n° 4), più recente (corredi sconvolti da Verdello, G III A1 - Casini, 2000, fig. 6, n° 2). A Montecastello è attestato un esemplare frammentario, oltre ad almeno altri due pertinenti a una variante miniaturizzata ; da Castello di Annone, un solo frammento di arco (fig. 2, n° 5). Il tipo è prodotto dalla fine del VII secolo a.C. (G II A) (Castelletto Ticino - Pauli, 1971, Taf. 15, t. 19 ; Taf. 19, t. 27 ; Taf. 21, t. 36, in associazione con urne decorate a denti di lupo incisi ; Sesto Calende, necropoli di via Sculati, t. 14/1983, 625-560 a.C. - De Marinis, 2009b, p. 422, fig. 9, n° 5-6 e 8). Caratterizza le tombe maschili del VI secolo a.C. : ini-zialmente si presenta in filo di bronzo a sezione circolare o quadrata, con staffa corta e disco piccolo. Se gli esem-plari più antichi hanno la terminazione della staffa a glo-betto semplice, dal secondo quarto del secolo si afferma il gusto di un’appendice sferoidale o a vaso modanato pieno, caratteristica che si riscontra negli esemplari di Villa del Foro (fig. 13) ; nel G III A la terminazione diventa più elaborata e spesso cava (Cicolani, 2010, p. 210-212, fig. 59).
La variante con arco a fettuccia in bronzo (tipo Gajac-cio, G II A/B-G II B) (Ha D2-Ha D3) è documentata a
Valentina Faudino, Luisa Ferrero, Marina Giaretti, Marica Venturino Gambari
128 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012),p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
Castello di Annone con un esemplare (fig. 2, n° 6), ben aderente al modello golasecchiano (Cicolani, 2010, p. 212 ; S. Bernardino di Briona - Gambari, 1987, tav. XXVa, n° 3-4 ; tav. XXVb, n° 3-4 ; tav. XXVIa, n° 3-4), mentre a Villa del Foro (fig. 2, n° 7-8) si contano quattro esemplari incompleti, verosimilmente inornati e con disco piccolo, fuso in matrice e non inserito (Pombia, località Cimitero, t. 1/1987, G II B - Di Maio et alii, 2001, fig. 11, n° 7-8 ; Castelletto Ticino, Dorbié Supe-riore, t. 1, fine del VI secolo a.C. - Ruffa 1998, p. 13, tav. I, n° 3). Le fibule ad arco serpeggiante a nastro sono tipi-che dell’areale golasecchiano fin dalla fase iniziale del G II B. Le terminazioni della staffa seguono l’evoluzione del tipo serpeggiante in filo : si rileva a margine che nei siti piemontesi in esame non sembra presente il globetto semplice. A Cerinasca-Arbedo si trovano associate a fibule a sanguisuga con inserti in corallo (Primas, 1970, t. 82, Taf. 22, D, 3-3). Fuori dall’area golasecchiana la presenza è più rara, nota, ad esempio, a Minusio-Ceresol, tt. 13 e 18, datate al G II B (Schmid-Sikimić, 2000, fig. 6A, n° 1 e 13, n° 4).
1.2. Fibule ad arco semplice a fettuccia (525-475 a.C.)Due esemplari sono attestati a Castello di Annone e
Villa del Foro (fig. 3, n° 1-2) : il primo con arco a forma di losanga, particolarità non riscontrata altrove. Il tipo appartiene al gruppo delle fibule ad arco sinuoso ; l’arco è liscio o decorato da linee longitudinali. La diffusione è soprattutto nell’Italia nord-orientale (Este) (tra fine VI e inizi V secolo a.C. - von Eles Masi, 1986, tav. 175, n° 2365-2368 ; Casa di Ricovero, t. 13 - Michelini, Paiola, 1998, fig. 81, n° 3-4) e in area slovena. Più raro in ambito golasecchiano (Sesto Calende, Mulini Bellaria t. 5 : la fibula ha l’arco lanceolato e una nervatura centrale, che manca nei nostri esemplari, ed è associata a un penda-glio a secchiello a fondo arrotondato variante B - De Marinis, 2009c, p. 446, fig. 19, n° 1), a nord delle Alpi si trova in Francia e Svizzera (Oberriet-Montlingerberg, Cantone San Gallo, G II B - Cicolani, 2010, pl. S.8, 25.8 ; Mesocco-Coop t. 14, G II B - Schmid-Sikimić, 2000, fig. 21, n° 2).
1.3. Fibule a drago (G III A1) (Ha D3/LT A)L’unica attestazione di fibula a drago (fig. 3, n° 3)
proviene da Castelnuovo Scrivia. Il tipo è assente a Villa del Foro e negli altri siti del Piemonte meridionale, ma è attestato a Genova-S. Silvestro (Liguri, 2004, p. 324, V.2.23). La sua presenza nel Piemonte sud-orientale è evidentemente da collegarsi alla direttrice di contatti commerciali e culturali tra la costa ligure e l’area occi-dentale della cultura di Golasecca lungo le valli dello Scrivia e del Polcevera, determinata dalla fondazione etrusca di un emporio sulla collina di Castello a Genova nel corso del VI secolo a.C. (Pastorino, Venturino Gam-bari, 2008).
Fig. 2. Fibule ad arco serpeggiante in ferro (Villa del Foro, 1) e in bronzo (Villa del Foro, 2-4 ; Castello di Annone, 5). Fibule ad arco serpeggiante a fettuccia, tipo Gajaccio
(Castello di Annone, 6 ; Villa del Foro, 7-8). (Dis. M. Giaretti).
Celti e liguri. rapporti tra la Cultura di golaseCCa e la liguria interna nella prima età del Ferro
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012), 129p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
Compare nella cultura di Golasecca dal secondo periodo, a partire da modelli atestini o etruschi di VII o fine VIII secolo a.C. Agli inizi del V secolo a.C. il nodo fermapieghe viene sostituito dal disco (tipo Cerinasca d’Arbedo) (Cicolani, 2010, fig. 96, da Gamsen).
1.4. Fibule a navicella (G I C-G II B) (Ha C2-Ha D3)Caratteristico dei corredi femminili a partire dal G I
C, il tipo rappresenta un’alternativa tecnologica di quello a sanguisuga, a cui viene eliminata l’anima in argilla. Gli esemplari più antichi sono attestati in Italia nord-orien-tale e a Bologna ; a Golasecca accompagna le fibule ad arco costolato dalla fine del VII secolo a.C., come nella t. XXII di Valtravaglia (Saronio, 1970, tav. VIII, n° 11-12). Se in ambito golasecchiano la ripartizione dei tipi distin-gue il gruppo con arco a losanga, con o senza appendici laterali (assente nel Piemonte meridionale), e il gruppo ad arco semplice, a sua volta sviluppato con più varianti, in Piemonte si osserva piuttosto una netta distinzione tra un tipo di grandi dimensioni (occidentale) e una serie di esemplari più semplici, maggiormente legati al modello classico golasecchiano.
In quest’ultimo gruppo comprendiamo un esemplare incompleto dal Museo Civico di Asti (fig. 4, n° 1) (Tosello, 1996, fig. 2, n° 2), che sembrerebbe avvicina-bile al tipo Muletti Prosdocimi (von Eles Masi, 1986, n° 953, 957), con ampia apertura ventrale, soprattutto la variante A per lo schema decorativo con fascia centrale a reticolo : si trova a Este, Castelletto Ticino, Ca’ Morta, dalla fine del VII alla prima metà del VI secolo a.C. Due esemplari da Villa del Foro (fig. 4, n° 2-3) hanno la sem-plice decorazione lineare alle estremità, analoga al tipo a sanguisuga, mentre un terzo (fig. 4, n° 4), molto fram-mentario, è genericamente raffrontabile ai tipi golasec-chiani più comuni (Pombia-Monticello, pr. Planca, t. 2/93 - G II B), così come la fibula da Castello di Annone (fig. 4, n° 5) con terminazione a doppio globetto (Pom-bia-Monticello, pr. Planca, t. 1/93 - G II A/B) (Di Maio et alii, 2001, fig. 19, n° 11 e 17, n° 10).
1.5. Grandi fibule a navicella (Ligure II, VI secolo a.C.)Significativa la distribuzione concentrata in area
alpina occidentale : Crissolo, Tomba Gastaldi 1868 (fig. 5, n° 1), Sampeyre, Borgata Villaretto (fig. 5, n° 2),
Fig. 3. Fibule ad arco semplice a fettuccia (Castello di Annone, 1 ; Villa del Foro, 2). Fibula a drago (Castelnuovo
Scrivia, 3). (Dis. M. Giaretti, S. Salines).
Fig. 4. Fibule a navicella (Asti, 1 ; Villa del Foro, 2-4 ; Castello di Annone, 5).
(Dis. L. Tosello, M. Giaretti, S. Salines).
Valentina Faudino, Luisa Ferrero, Marina Giaretti, Marica Venturino Gambari
130 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012),p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
Fig. 5. Grandi fibule a navicella (Crissolo, 1 ; Sampeyre, 2 ; Val Varaita - ridisegnata da Rittatore 1947, 3 ; Valdieri, 4-5). (Dis. M. Giaretti, S. Salines).
Celti e liguri. rapporti tra la Cultura di golaseCCa e la liguria interna nella prima età del Ferro
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012), 131p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
Sampeyre-Mandam (al Museo di Como, fig. 5, n° 3) ; Valdieri, t. 1/94 (600-550 a.C.) e t. 3/94 (550-480 a.C.) (fig. 5, n° 3-4).
Hanno l’arco cavo decorato da fasci di linee, asso-ciati o meno a file di cerchielli, molla inserita, staffa lunga con terminazione globulare, o modanata, come nel caso dell’esemplare di Crissolo, e apice a disco decorato da cerchielli (Sampeyre e Crissolo).
Particolarmente per gli esemplari di Valdieri, la sin-tassi decorativa e le dimensioni corrispondono bene a un’ampia casistica attestata in area atestina e golasec-chiana (von Eles Masi, 1986, n° 981, 999, da Caverzano e da Castelletto Ticino, e n° 1011), tra la metà del VII e il VI secolo (Golasecca Monsorino, t. 26, G I C - Grassi, 2009, p. 484, fig. 3 : l’esemplare è inquadrato nel tipo a navicella a bottone profilato, evoluzione della navicella profonda tipo Chiavari : si vedano per esempio le tombe 61 e 73 - Liguri, 2004, p. 264, IV.1.27.1 ; p. 255, IV.1.8.3-4). Gli esemplari della valle Varaita, invece, interpretano il gusto decorativo a fasce lineari in modo più autonomo, anche se si può citare qualche parziale confronto con la Ca’ Morta (von Eles Masi, 1986, n° 946 e 952, per l’ab-binamento linee-cerchielli). Elemento caratterizzante il gruppo è infine la terminazione della staffa, che si disco-sta nettamente dai tipi di riferimento : tra questi, si può citare un esemplare da Borso del Grappa (TV), con appendice a vaso, e quello da Pornassio (IM), forse il più calzante (von Eles Masi, 1986, n° 949 e 1073A). A con-fortare l’attribuzione a modelli occidentali, confronti si propongono con Meurthe-et-Moselle, Saxon-Sion (mate-riali sporadici, ripostiglio, G I C-G II A) e Meyronnes, Saint-Ours (Alpes-de-Haute-Provence), da tombe a inu-mazione (G III A1) (Cicolani, 2010, p. 764, pl. F.9, fig. 43 e 47).
1.6. Fibule a sanguisuga con anima in cotto (G II A-G II B) (Ha D1-Ha D3)
È il tipo più comune ed è presente a Brignano Frascata con due esemplari (fig. 6, n° 1-2, uno con arco asimme-trico forse massiccio, il secondo di dimensioni maggiori con ampia fascia di linee incise) ; a Villa del Foro con sedici esemplari (fig. 6, n° 3-7), con una frequenza quindi quasi analoga a quella del tipo serpeggiante, e infine al Guardamonte di Gremiasco (Tosello, 1993, fig. 7, n° 1). Per alcuni esemplari di Villa del Foro, in particolare quelli di dimensioni ridotte, potrebbe trattarsi anche di un arco massiccio. La decorazione è sempre limitata a una breve fascia di linee trasversali alle estremità dell’arco.
Tipica dei corredi femminili, insieme al tipo a navi-cella, ha la molla monolaterale fusa insieme e solo nella seconda metà del VI secolo a.C. si afferma la molla inse-rita ; l’arco, tendenzialmente simmetrico a sezione ellit-tica, sembra evolvere negli esemplari più recenti verso l’asimmetricità, come nel caso di Brignano Frascata (Cicolani, 2010, fig. 109, p. 281-282).
Il tipo sembra comparire nel G II A, secondo M.P. Schindler, che distingue le fibule più antiche da quelle del G II B in base alle dimensioni dell’arco, inferiore a 4,5 cm ; secondo S. Casini il tipo è invece noto solo dal G II A/B (Casini, 2000, fig. 4, n° 2 e 5). È coevo alle fibule a sanguisuga con inserti e si sviluppa particolarmente nel G II B (ad esempio, Pombia-Monticello pr. Planca t. 2/93 - Di Maio et alii, 2001, fig. 19, n° 14). Oltralpe i confronti più significativi sono con Mesocco, in Mesolcina (Mesoc-co-Coop - Schmid-Sikimić, 2000, fig. 14 C, n° 1, special-mente per il particolare della doppia coppia di linee incise) e a Giubiasco, ancora nel G II B (t. 10/1958 - Schindler, De Marinis, 2000, fig. 16, n° 6).
Fig. 6. Fibule a sanguisuga con anima in cotto (Brignano Frascata, 1-2 ; Villa del Foro, 3-7 ; Guardamonte di Gremiasco, 8). (Dis. M. Giaretti, L. Tosello).
Valentina Faudino, Luisa Ferrero, Marina Giaretti, Marica Venturino Gambari
132 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012),p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
1.7. Fibule a sanguisuga con inserti (G II A/B-G III A1) (Ha D2-Ha D3/LT A)
Si caratterizza per la ricca decorazione composta da piccoli inserti circolari di materia biancastro-rosata, inca-stonati entro profondi forellini, associati alle due fasce di linee incise tipiche della sanguisuga. Tra gli esemplari più elaborati, quelli di Brignano Frascata (fig. 7, n° 1-3), uno dei quali conserva l’anellino ferma-ago in lamina, anch’esso con inserti. A Villa del Foro, tra i cinque esem-plari frammentari documentati (fig. 7, n° 4-8), si osserva una certa variabilità morfologica, dall’arco lenticolare pieno con forellini passanti (Mesocco-Coop, t. 11, G IIA/B - Schmid-Sikimić, 2000, fig. 14B, n° 1-2), all’arco largo e appiattito, privo per ora di confronti puntuali ; da Castello di Annone proviene un frammento di staffa (fig. 7, n° 9), di cui è attualmente in corso l’analisi della pasta bianca.
Si sviluppa dalla metà del VI alla metà del V secolo a.C., con alcune varianti (G II A/B-G II B - Cicolani, 2010, pl. S.10, 39 ; De Marinis, 1981, p. 217, fig. 4). Gli esemplari più antichi hanno arco più piccolo, a sezione tendenzialmente biconvessa con due o tre file di inserti circolari (sempre tra due fasce di linee trasversali, fig. 7, n° 4) ; negli esemplari più evoluti (G II B) gli inserti tendono
a invadere tutta la superficie superiore dell’arco, così come il globetto con appendice a vaso modanato e un secondo ingrossamento alla base della staffa (fig. 7, n° 1-3). Infine, con la variante Palestro (G III A1), parti-colarmente diffusa in Canton Ticino, le dimensioni della fibula aumentano, la sezione tende ad essere trapezoidale e si afferma il gusto del secondo nodulo all’estremità della staffa (Cicolani, 2010, pl. S.11, 49.12 ; Primas, 1970, Taf. 21, A, 3, in cui alla fibula con inserti tipo Pale-stro sono associate fibule serpeggianti in ferro). In realtà, almeno uno dei nostri esemplari di Brignano Frascata (fig. 7, n° 1) sembrerebbe documentare caratteristiche intermedie nell’ambito evolutivo del tipo, sia per le dimensioni dell’arco, non particolarmente sviluppato, sia per la terminazione della staffa, priva del secondo ingros-samento, elementi che potrebbero indicare un certo grado di autonomia nell’interpretazione dei modelli golasec-chiani.
A Pombia, il gusto degli inserti può trovarsi su fibule a sanguisuga con anima in cotto (come in fig. 7, n° 5), o decorare solo il globetto (località Monticello, pr. Planca, t. 4/93 - Di Maio et alii, 2001, fig. 19, n° 12 ; fig. 26, n° 7), mentre negli esemplari piemontesi ricorre l’ingros-samento alla base della staffa. A Genova-S. Silvestro, e a
Fig. 7. Fibule a sanguisuga con inserti (Brignano Frascata, 1-3 ; Villa del Foro, 4-8 ; Castello di Annone, 9). (Dis. M. Giaretti).
Celti e liguri. rapporti tra la Cultura di golaseCCa e la liguria interna nella prima età del Ferro
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012), 133p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
S. Maria in Passione, scavi 1997, si trovano il tipo con arco ad anima in cotto, globetto con inserti e staffa con incisioni e il tipo Palestro con globetto e ingrossamento (Liguri, 2004, p. 323, V.2.19-21).
1.8. Fibule ad arco pieno a sezione biconvessa (G II A/B-G III A3) (Ha D2-LT A)
Questa variante della fibula a sanguisuga è caratte-rizzata da dimensioni leggermente inferiori rispetto a quella con arco cavo ; a Villa del Foro (fig. 8, n° 1-6), dove si contano nove esemplari incompleti, l’unico inte-gro ha la staffa lunga desinente con globetto piccolo e appendice conica piena ; infilato nell’ardiglione conserva un elemento di catenella a doppio anellino, che nei corredi
golasecchiani si ritrova a formare le catenelle dei petto-rali (Pombia, località Monticello, t. 2/93, G II B - Di Maio et alii, 2001, fig. 19, n° 7). Altre attestazioni sono presenti a Brignano Frascata (fig. 8, n° 7) e al Guarda-monte di Gremiasco (Mordeglia, 2004, fig. 2, n° 7).
Il tipo viene assimilato al Ca’ Morta variante A, atte-stato in ambito golasecchiano solo nel G III A1 (De Mari-nis, 1981, tav. 25, n° 7-9 ; tav. 28, n° 13-14). A Genova-S. Silvestro, un esemplare frammentario viene inquadrato nel tipo tardo-alpino variante D, diffuso nel G III A3 nelle necropoli ticinesi e a Este (Liguri, 2004, p. 324, V.2.24). Tuttavia, a conforto di una possibile datazione più antica per alcuni dei nostri esemplari, si può citare una piccola fibula inornata da Castelletto Ticino-via Aronco, t. 5 (Gambari, Colonna, 1988, fig. 6, n° 10), dove è associata a una serpeggiante in ferro e ad una a drago (G II A/B).
Morfologicamente molto simili sono anche alcune fibule da tombe femminili di S. Ilario d’Enza, già avvici-nate all’ambito golasecchiano a partire dal G II B e note a Este nella fase III C (Damiani et alii, 1992, tav. LX, 894-895).
1.9. Fibule a sanguisuga miniaturizzata (Ligure II-Ligure III A, VI-prima metà V secolo a.C.)
Il gruppo è ben rappresentato nel Piemonte meridio-nale, con due esemplari incompleti da Villa del Foro (fig. 9, n° 1), quattro da Castello di Annone (fig. 9, n° 2-5), due da Cossano Belbo (fig. 9, n° 6-7). La molla monolaterale è fusa insieme ; l’arco, tendente alla forma a losanga, ha sezioni diverse, da appiattita a biconvessa, a pianoconvessa.
I riscontri più interessanti indirizzano verso l’Emilia occidentale (S. Ilario d’Enza-Bettolino, t. 7 - Malnati, 1989, p. 155 e tav. L ; Damiani et alii, 1992, tav. LX, n° 900-902), per cui vengono citati confronti a Felsina e alla Certosa nel pieno VI secolo, in area atestina dalla seconda metà del VII secolo. A Parma-Baganzola, t. 1, sono state recuperate molte piccole fibule con arco pieno a sezione biconvessa o ellittica, staffa media a termina-zione semplice, di dimensioni leggermente superiori ai nostri esemplari (Catarsi Dall’Aglio, 2004, fig. 4, n° 2-3, 5, 7-8). Nello stesso contesto, inserito nella facies Reme-dello - S. Ilario (prima metà VI secolo a.C.), si ritrova un interessante riscontro, in dimensioni leggermente infe-riori, per la fibula ad arco biconvesso da Villa del Foro (fig. 8, n° 1) (Catarsi Dall’Aglio, 2004, fig. 4, n° 12-13).
1.10. Fibule tipo Mazzucca di Montanaso (G III A1) (Ha D3/LT A)
Due esemplari da Asti (fig. 10) (Tosello, 1996, fig. 3, n° 4 e 7) documentano questa variante della fibula a sangui-suga a corpo cavo, con apertura inferiore piuttosto stretta. Le caratteristiche della decorazione a fasce di linee tra-sversali, il grosso globetto con appendice a goccia, la fascetta ferma-ago con decorazione lineare e la molla
Fig. 8. Fibule ad arco biconvesso (Villa del Foro, 1-6 ; Brignano Frascata, 7). (Dis. M. Giaretti).
Valentina Faudino, Luisa Ferrero, Marina Giaretti, Marica Venturino Gambari
134 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012),p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
Fig. 9. Fibule miniaturizzate (Villa del Foro, 1 ; Castello di Annone, 2-5 ; Cossano Belbo, 6-7). (Dis. M. Giaretti, S. Salines).
Fig. 10. Fibule tipo Mazzucca di Montanaso (Asti, 1-2). (Dis. L. Tosello).
Fig. 11. Fibule di tipo tardo-alpino (Pontechianale, 1 ; Asti, 2 ; Rocca Grimalda, 3). (Dis. S. Salines).
Celti e liguri. rapporti tra la Cultura di golaseCCa e la liguria interna nella prima età del Ferro
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012), 135p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
inserita le inquadrano perfettamente nel modello gola-secchiano (Cicolani, 2010, p. 286 ; De Marinis, 1981, p. 220, fig. 4, tav. 14, n° 5).
1.11. Fibule di tipo tardo-alpino (G III A) (Ha D3/LT A)Da Pontechianale, necropoli di Borgata Castello
(fig. 11, n° 1), un esemplare integro è attribuibile alla variante C della classificazione di De Marinis (1981, p. 219, fig. 4) (G III A3).
Altri due esemplari incompleti (fig. 11, n° 2-3), da Asti (Tosello, 1996, fig. 3, 2) e Rocca Grimalda (De Mar-chi, Pirotto, 2004, fig. 5, n° 1), sembrano inquadrabili, per le dimensioni relativamente contenute, nelle varianti A o B, datate comunque nella prima metà del V secolo a.C. (Zanica, corredi tombali sconvolti, G III A1 - Casini, 2000, fig. 9, n° 5-6).
1.12. Fibule tipo Certosa (G III A1-LT B) (Ha D3-LT B)Il gruppo è scarno ma diversificato : un esemplare
integro da Pontechianale, necropoli di Borgata Castello (fig. 12, n° 1), uno da Villanova Mondovì (un frammento di staffa corta e massiccia e grosso bottone biconvesso, fig. 12, n° 2), due da Cossano Belbo, rispettivamente in bronzo e in ferro (fig. 12, n° 3-4) ; infine, un piccolo
frammento di terminale di staffa con sezione a J e appen-dice a piccolo bottone aggettante da Villa del Foro (fig. 12, n° 5).
Generici riferimenti, particolarmente per il fram-mento da Villa del Foro, si propongono con il tipo tici-nese che perdura dalla metà V secolo a.C. al LT B (De Marinis, 1981, p. 225 ; Cicolani, 2010, fig. 144). È atte-stato ad Ameglia (Liguri, 2004, p. 411, VI.6.3.28), a Genova-S. Silvestro tra metà V e metà IV secolo a.C. (Liguri, 2004, p. 324, V.2.25), nella tomba di Savignone (Liguri, 2004, p. 280), corredo datato probabilmente al G III A1 sulla base della ciotola con decorazione a stralu-cido che non arriverebbe al G III A2. Al Forcello, il tipo con terminazione a testa di serpe (fig. 12, n° 5) si trova nelle fasi recenti, posteriori alla metà del V secolo a.C. (De Marinis, 1988, fig. 80, n° 1). Per l’esemplare di Pon-techianale, la molla di tipo La Tène a corda interna indica una precoce elaborazione del tipo Certosa in area alpina (dalla seconda metà del V secolo a.C.). Nella necropoli preromana di Genova, t. 30, in un corredo femminile par-ticolarmente ricco per lo standard ligure, per una donna forse di origini golasecchiane, si riscontrano tre fibule in lega d’argento derivate dal modello ticinese, di dimen-sioni leggermente inferiori alla nostra, con bottone sem-pre liscio, staffa corta e nodulo presso la molla, ma meno sviluppato (seconda metà V secolo a.C.) (Liguri, 2004, p. 343, V.3.7.7-9).
Gli esemplari in ferro, più rari, sembrerebbero limi-tati al G III A2 (De Marinis, 1981, p. 226). Ad Ameglia, necropoli di Cafaggio, Monumento B t. 7, l’esemplare è ritenuto affine al tipo Certosa in bronzo, fine IV-inizi III secolo a.C. (Liguri, 2004, p. 411, VI.6.3.27). A Geno-va-S. Silvestro si confronta nel Piceno, a Monte Bibele e Altino (IV secolo a.C.) (Liguri, 2004, p. 324, V.2.27).
1.13 Elementi frammentari di staffe di fibulaNei contesti presi in esame si conservano molti fram-
menti di staffa con terminazioni a globetto e appendici di vario tipo che per la loro lacunosità non possono essere attribuiti univocamente a un tipo specifico di fibula. In area golasecchiana il più comune è con appendice cava (o a vaso), caratteristica delle fibule serpeggianti del G II B (Alba-via Terzolo, Capriata d’Orba, Villa del Foro, fig. 13, n° 1-3), mentre l’appendice conica piena sembra più frequente nelle fibule a navicella. In particolare, per l’esemplare da Alba, con appendice particolarmente espansa e leggera modanatura, si ricorda la già citata fibula di Pornassio (von Eles Masi, 1986, n° 1073A).
Il globetto con appendice conica modanata si trova a Villa del Foro (fig. 13, n° 6-11) e a Brignano Frascata (fig. 13, n° 15-16) (Pombia-Monticello, pr. Planca - Di Maio et alii, 2001, fig. 19, n° 14 ; 11, n° 7, 9-10 ; Pombia, località Quara, pr. Bau, t. 3/95 - Di Maio et alii, 2001, fig. 49, n° 13) con ampia diffusione dal pieno VI agli inizi del V secolo a.C.
Fig. 12. Fibule tipo Certosa (Pontechianale, 1 ; Villanova Mondovì, 2 ; Cossano Belbo, 3-4 ; Villa del Foro, 5).
(Dis. S. Salines, M. Giaretti).
Valentina Faudino, Luisa Ferrero, Marina Giaretti, Marica Venturino Gambari
136 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012),p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
La variante con globetto e appendice sferoidale si trova a Villa del Foro e Brignano Frascata (fig. 13, n° 12-14) (Pombia-Monticello, pr. Planca, t. 1/93, G IIA/B - Di Maio et alii, 2001, fig. 17, n° 10 ; Mesocco-Coop -Schmid-Sikimić, 2000, fig. 14B, n° 3 e 14C, n° 1-2). Da Serravalle Scrivia proviene un frammento inedito con terminazione a globetto schiacciato, appendice sferoidale e tre modanature profonde alla base, che non ha altri riscontri tra i tipi piemontesi, per il quale si può citare un confronto con una fibula a navicella tipo Muletti Prosdo-cimi variante D da Castelletto Ticino, t. 46, della seconda metà del VI secolo a.C. (von Eles Masi, 1986, n° 965A).
Infine, i due esemplari più massicci, entrambi con appendice (lacunosa) a vaso, da Brignano Frascata (fig. 13, n° 17-18) sarebbero da inquadrare nel tipo della sanguisuga tardo-alpina, in particolare il secondo, che forse appartiene al gruppo con staffa in due pezzi (necro-poli preromana di Genova, t. 30, con appendice piena, in dimensioni leggermente maggiori dei nostri esemplari - Liguri, 2004, p. 343, V.3.7.4-5).
2. Pendagli
2.1. Pendagli a secchiello (G II A/B-G III A2) (Ha D2-LT A)
Si distinguono più varianti morfologiche. Quella a fondo conico appare relativamente poco diffusa : si trova ad Asti, con due esemplari a corpo cavo e uno a corpo pieno (fig. 14, n° 1-3) e a Rocca Grimalda (fig. 14, n° 4 - De Marchi, Pirotto, 2004, fig. 5, n° 2), tutti inquadrabili nel pieno V secolo a.C., con la possibilità che le due varianti a corpo pieno siano interpretazioni locali (Brembate Sotto, t. 8, G III A1 - De Marinis, 1981, p. 131, n° 19, tav. 16, n° 6 ; variante A del G III A1 - Cicolani, 2010, fig. 164).
Il gruppo dei pendagli a fondo arrotondato è docu-mentato ad Asti (fig. 14, n° 5-6), al Guardamonte (fig. 14, n° 7), a Villa del Foro (fig. 14, n° 8), a Breolungi, con un esemplare scartato durante la lavorazione (Bagienni, 2001, fig. 17 ; 131, n° 2), a Villanova Mondovì, variante D del tipo (fig. 14, n° 9 - Venturino Gambari, 1991, fig. 3). Sono attestate le varianti A (profilo a 8, linee incise sul corpo, ad Asti), B, senza decorazione e profilo continuo, e C. Ampia è la diffusione nelle tombe del G II B, ma la produzione sembra risalire al G II A o II A/B (Pombia, località Quara, pr. Baù, t. 3/95 - Di Maio et alii, 2001, fig. 49, n° 17-18). Le varianti C e D con profilo cilindrico sono più recenti, rispettivamente datate al G III A1 e al G III A1-III A2 (De Marinis, 1981, p. 231, fig. 5).
Un terzo gruppo, caratterizzato dalla terminazione a bottone su un corpo cavo conico (Villa del Foro, fig. 14, n° 10) o carenato, con due esemplari pressoché identici da Villa del Foro e da Castello di Annone (fig. 14, n° 11, 13), sembra costituire un’interpretazione locale semplifi-cata del modello golasecchiano profilato (Cicolani, 2010, p. 357). Se gli ultimi due sono in parte avvicinabili al tipo conico variante C (G III A2 - Cicolani, 2010, fig. 164) e trovano riscontro anche al Forcello di Bagnolo S. Vito (MN) (Fase E : 500-480 a.C.)5, il frammento di Cossano Belbo (fig. 14, n° 12) si rapporterebbe genericamente al tipo profilato variante A, cioè al G III A1 (De Marinis, 1981, p. 232, fig. 5). Al di fuori della Liguria interna piemontese, un interessante confronto è reperibile in due esemplari provenienti da ricerche non sistematiche, insieme a materiali di età romana, ad Avigliana (TO), borgata Malano (Ferrero, 2012, fig. 100).
5. Il pendaglio è in corso di studio e pubblicazione da parte del prof. R.C. De Marinis, che le Autrici desiderano ringraziare per la cortese segnalazione.
Fig. 13. Frammenti di staffa di fibule : con appendice a vaso (Alba, via Terzolo, 1 ; Capriata d’Orba, 2 ; Villa del Foro, 3-5) ;
con appendice profilata (Villa del Foro, 6-11 ; Brignano Frascata, 15-16) ; con appendice a globetto (Villa del Foro,
12-13 ; Brignano Frascata, 14) ; massiccia con appendice a vaso (Brignano Frascata, 17-18).
(Dis. S. Salines, M. Giaretti).
Celti e liguri. rapporti tra la Cultura di golaseCCa e la liguria interna nella prima età del Ferro
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012), 137p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
2.2. Pendagli a melograno (G II A-G II A/B) (Ha D1-Ha D2)
Un solo esemplare (fig. 14, n° 14) è documentato a Crissolo, e si data in base a confronti alla Ca’ Morta, t. 24 (Rittatore, 1965, tavv. XXXIX, LXV, LXVI, LXVII), Ca’
Morta-cava Manzoni, tomba III, 1921, inizio del VI secolo a.C. (von Eles Masi, 1986, n° 1105, tav. 92) ; Albate, t. III, G II A - G II A/B (De Marinis, 1991, fig. 15, n° 7) ; Albate, t. XII, G II A (De Marinis, Frontini, 1990, fig. 31).
Fig. 14. Pendagli a secchiello : a fondo conico (Asti, 1-3 ; Rocca Grimalda, 4) ; a fondo arrotondato (Asti, 5-6 ; Guardamonte, 7 ; Villa del Foro, 8 ; Villanova Mondovì, 9) ; a bottone (Villa del Foro, 10-11 ; Cossano Belbo, 12 ; Castello di Annone, 13) ;
a melograno (Crissolo, 14) ; a 8 (Entracque, 15-17). Dischi (Pontechianale, 18 ; Asti, 19 ; Entracque, 20). Anelli a globetti (Asti, 21 ; Valdieri, 22-23). Perle in lamina di bronzo (Asti, 24-25). (Dis. L. Tosello, S. Salines, M. Giaretti).
Valentina Faudino, Luisa Ferrero, Marina Giaretti, Marica Venturino Gambari
138 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012),p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
2.3. Pendagli a otto (G III A1-2) (LT A)Da Entracque, in un contesto misto di età romana
con alcuni elementi protostorici (Molli Boffa, 1999) verosimilmente riferibile ad un’area funeraria di lunga frequentazione, provengono tre esemplari con decora-zione a occhio di dado (fig. 14, n° 15-17), inquadrabili nel V secolo a.C. (G III A1-G III A2) (Guado di Gugnano, Castelletto Lodigiano - De Marinis, 1981, p. 179-180, tav. 66, n° 5).
3. dischi in lamina Per Fibule (g ii a/b-g iii a1) (ha d2-lT a)
Allo stato attuale dei ritrovamenti sono attestati nel Piemonte meridionale solo tre esemplari. I primi due, in corredi databili al L III A da Pontechianale (fig. 14, n° 18) e da Asti (fig. 14, n° 19), presentano una decorazione a cerchi concentrici, nel secondo caso anche associati a file di puntini a sbalzo. Si tratta di oggetti con dimensioni variabili in media da 2 a 5 cm, solitamente inseriti nell’ar-diglione di fibule a sanguisuga o a navicella e compaiono in area golasecchiana dagli inizi del VI secolo a.C. Atte-stazioni oltralpe sono note solo nel Vallese in contesti datati dalla metà VI almeno fino al primo quarto del V secolo a.C. (Cicolani, 2010, fig. 159 ; Pregassona t. 2, G II A/B - Schindler, De Marinis, 2000, fig. 12, n° 8).
Il disco da Entracque (fig. 14, n° 20), in lamina di bronzo forata al centro e decorata da due anelli di motivi a S e da cerchielli a occhio di dado, presenta analogie con i dischi fermapieghe del G III A1, come quello facente parte del corredo della Tomba del Carro della Ca’ Morta (G III A1 - De Marinis, 1981, p. 67 n. 9, tav. 28, n° 1).
Non più conservato è invece il disco proveniente dalla Tomba Gastaldi 1868 di Crissolo, databile alla prima metà VI secolo a.C. (Gambari, Venturino Gambari, 1997, p. 394, fig. 1), che richiama i dischi fermapieghe delle fibule del G II A/B di Pombia (t. 3/1995 e t. 16/1995 - Di Maio et alii, 2001, fig. 49, n° 14 ; 81, n° 8-9) e Castel-letto Ticino, Dorbiè (t. 4, fine del VI secolo a.C. - Ruffa, 1998, tav. I, n° 12).
4. Pendagli ad anello con globeTTi (g ii a/b-g iii a) (ha d2-lT a)
Questo tipo di pendagli è rappresentato tra i materiali di Asti (fig. 14, n° 21) e, in nove esemplari con sei glo-betti, a Valdieri nel corredo della tomba 3/94 (fig. 14, n° 22-23), databile fra la seconda metà del VI e gli inizi del V secolo a.C. (Ligure II).
Anelli simili, con tre o quattro lobi, associati a fibule a navicella, compaiono a Este dall’VIII secolo a.C. e per-durano poi per tutto il VI secolo, con particolare diffusione in ambito golasecchiano orientale, Canton Ticino, Este e Hallstatt orientale, con varietà di fogge caratterizzate da
otto, nove, undici, quattordici e sedici globetti e sezione della verga sub-circolare o biconvessa. La variabilità non sembra avere un significato cronologico (De Marinis, 1981, p. 229 ; Casini, 2000, p. 145).
5. Perle in lamina di bronzo (g iii a) (lT a)
Da Asti si segnalano due esemplari : il primo, con sezione a C (fig. 14, n° 24), rimanda ai tipi del G III A1 o G III A2 (De Marinis, 1981, p. 232-233, fig. 6) ; il secondo, di forma biconica, cavo all’interno (fig. 14, n° 25), richiama tipi abbastanza frequentemente associati alle fibule del V secolo a.C. a sezione carenata e inseriti nell’ardiglione con funzione decorativa, o cilindrici a sezione modanata con funzione di ferma-ago, soprattutto su fibule di tipo tardo-alpino (fig. 11). L’areale di diffu-sione oltralpe comprende Vallese, Vaud e Cantone di Ginevra nell’ambito del G III A2-III A3 (Cicolani, 2010, fig. 157).
6. oggeTTi da ToeleTTa (g ii b) (ha d2/d3)
La diffusione è per ora piuttosto limitata : da Villa del Foro, una pinzetta e un levacomedoni (fig. 15, n° 1-2), da Asti due elementi frammentari (fig. 15, n° 3-4). Le paru-res più antiche, in ferro, compaiono in tombe maschili del G I C (Valtravaglia e Canton Ticino), associate alla fibula serpeggiante in ferro, poi perdurano in bronzo in contesti di ambo i sessi. Gli esemplari piemontesi mostrano uno schema a piccoli noduli alternati a setti con linee trasversali e anello ingrossato, simile a quello delle pinzette del G II B di Minusio-Ceresol, t. 18 (Schmid-Sikimić, 2000, fig. 13, n° 5). Elementi di raffronto sono individuabili anche in una tomba maschile di Sesto Calende, località Gajaccio, dove si riscontra il manico a noduli ingrossati, come a Villa del Foro, e l’anello di sospensione più massiccio, come ad Asti (G II B, tra 525 a.C. e inizio V secolo a.C.) (De Marinis, 2009a, p. 205, fig. 2, n° 4-6).
7. ganci di cinTura
7.1. Ganci di cintura rettangolari in bronzo (G II A/B-G II B) (Ha D2-Ha D3)
Un esemplare di questo tipo, con decorazione a cer-chielli e costolatura centrale pronunciata (fig. 15, n° 5), è presente nel corredo della Tomba Gastaldi 1868 di Cris-solo, databile nella prima metà del VI secolo a.C., mentre un altro, inedito e frammentario, decorato con file di pun-tini a sbalzo, proviene da Serravalle Scrivia.
Si tratta di oggetti tipici delle sepolture femminili, avvicinabili, sulla base della forma e delle misure, al tipo Golasecca B, variante B2 (rapporto tra lunghezza e
Celti e liguri. rapporti tra la Cultura di golaseCCa e la liguria interna nella prima età del Ferro
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012), 139p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
larghezza 3:2 ; per la definizione tipologica, la caratteriz-zazione di ambito occidentale e la cronologia, cfr. Casini, 2000, p. 131-135 e Cicolani, 2010, fig. 185 e p. 390), datato al G II A/B-G II B, noto in Piemonte anche a Pom-bia (Di Maio et alii, 2001, p. 31).
7.2. Gancio a T in ferro (G II A/B-G II B) (Ha D2-Ha D3)
Tipo finora noto, per il Piemonte meridionale, in una sepoltura di Alba-via Terzolo (fig. 15, n° 6) ; è tipico delle sepolture maschili, in corredi della seconda metà del VI secolo a.C., come a Pombia, t. 17 del G II A/B (Di Maio et alii, 2001, p. 79, fig. 83, n° 6), e a Castelletto Ticino, tomba del Bicchiere, seconda metà del VI secolo a.C. (Gambari, Colonna, 1988, p. 123, fig. 6, n° 8).
7.3. Gancio di cintura con estremità a disco a linguetta ripiegata in ferro (G II-G III A1) (Ha D-LT A)
Unica attestazione è quella di Cossano Belbo (fig. 15, n° 7). Elemento caratteristico delle cinture maschili, trova confronto a Pombia, Brandopferplatz (Di Maio et alii, 2001, fig. 98, n° 16) e nella tomba 119 della Ca’ Morta, datata al G III A1 (De Marinis, 1981, p. 89, 21, tav. 33, n° 9). Il periodo di riferimento del tipo potrebbe forse essere retrodatato al G II, sulla base di un esemplare frammentario da Cerinasca d’Arbedo, t. 15, che si trova associato a fibule serpeggianti, forse in ferro (Mangani, Minarini, 2000, fig. 2)6.
6. Pur nella scarsa affidabilità della composizione dei corredi della necropoli di Cerinasca d’Arbedo (Canton Ticino), quello della tomba 15 sembra attendibile : si tratta di un corredo maschile con oggetti in ferro, tre fibule serpeggianti, un fermaglio da cintura, un coltello e un elemento da toilette. Si ringrazia il prof. R.C. de Marinis per il cortese scambio di idee.
Fig. 15. Oggetti da toeletta (Villa del Foro, 1-2 ; Asti, 3-4). Ganci di cintura (Crissolo, 5 ; Alba, via Terzolo, 6 ; Cossano Belbo, 7). (Dis. L. Tosello, S. Salines, M. Giaretti).
Valentina Faudino, Luisa Ferrero, Marina Giaretti, Marica Venturino Gambari
140 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012),p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
considerazioni conclusive
Tra le diverse tipologie di oggetti di abbigliamento, di ornamento e di uso personale della Media Età del ferro esaminate nel presente contributo, i reperti più numerosi sono costituiti dalle fibule. Gli esemplari piemontesi, da quelle ad arco serpeggiante in ferro e in bronzo e a drago tipiche dell’ambito maschile, a quelle a sanguisuga con anima in cotto e a navicella, più caratteristiche dell’abbi-gliamento femminile, anche ad arco pieno a sezione biconvessa o con inserti, trovano generalmente confronti nell’ambito della cultura di Golasecca.
Tra il 600 e il 475 a. C. (G II-L II) sembra di poter notare una maggiore aderenza alle tipologie golasec-chiane delle fibule di ambito maschile, peraltro attestate in numero decisamente inferiore rispetto a quelle di ambito femminile, molto più numerose, che mostrano anche una più ampia variabilità formale e dimensionale. Anche se le tipologie di riferimento per queste fibule riportano in genere al contesto insubre cisalpino, non senza riscontri nelle aree celtiche transalpine contermini alla cultura di Golasecca, va rilevato che alcuni partico-lari riscontrabili su esemplari piemontesi, come la limi-tata presenza del globetto semplice nelle fibule ad arco serpeggiante in filo di bronzo, la caratteristica della forma a losanga nella fibula ad arco semplice a fettuccia di Castello di Annone (fig. 3, n° 1) (una tipologia peraltro maggiormente attestata in Italia nord-orientale e nelle aree transalpine limitrofe alla cultura di Golasecca) e infine le dimensioni dell’arco, non particolarmente svi-luppato, e la terminazione della staffa, priva del secondo ingrossamento, di una delle fibule a sanguisuga con inserti di Brignano Frascata (fig. 7, n° 1), parlerebbero a favore di rielaborazioni in ambito locale delle principali tipologie di riferimento dell’epoca.
È questo del resto un periodo di grande vitalità dei centri liguri piemontesi sui quali l’espansione commer-ciale etrusca in Italia settentrionale agisce come un volano nel favorire crescita e sviluppo delle comunità locali (Liguri, 2004, p. 225-229 con bibliografia). Indizio di questa vitalità sembra potersi cogliere anche nell’ela-borazione di tipologie metalliche originali e peculiari della Liguria interna piemontese, come le fibule a sangui-suga miniaturizzata (Villa del Foro, Castello di Annone e Cossano Belbo : fig. 9), che trovano buoni confronti soprattutto in Emilia occidentale, o le fibule a navicella di grandi dimensioni, particolarmente diffuse (Crissolo, Sampeyre, Borgata Villaretto e Mandam, Valdieri : fig. 5) in contesti funerari sia a inumazione (Crissolo) sia a cre-mazione (Valdieri) di individui femminili, con riscontri anche in area alpina francese (Cicolani, 2010, p. 764, pl. F.9, fig. 43 e 47) ; se le fibule di Valdieri ben si inqua-drano nelle tipologie canoniche di area golasecchiana e atestina, gli esemplari alpini occidentali reinterpretano gli schemi decorativi più autonomamente con una
sovrabbondanza di elementi decorativi e con la creazione di una originale terminazione della staffa a disco piatto decorato a cerchielli.
A partire dal 480-475 a.C. (G III A-L III A) si con-stata la presenza sul territorio di tipologie più stretta-mente aderenti ai modelli golasecchiani, come le fibule tipo Mazzucca di Montanaso (Asti : fig. 10) o quelle di tipo tardo-alpino (Pontechianale, Asti e Rocca Grimalda : fig. 11) ; è possibile che la loro attestazione sia collegata alla persistente vitalità della cerchia metallurgica gola-secchiana in un periodo in cui i gruppi della Liguria interna piemontese abbandonano progressivamente gli insediamenti ubicati a controllo delle vie commerciali che li collegavano ai centri dell’Etruria Padana (lungo la valle del Tanaro) o all’emporio etrusco di Genova (lungo le valli del Lemme, della Scrivia e del Polcevera) e ini-ziano un lento fenomeno di arroccamento verso le aree appenniniche interne che perdurerà fino alle soglie della romanizzazione.
Una variabilità tipologica si riscontra anche nei pen-dagli, documentati sia da modelli golasecchiani, come per il tipo a secchiello a fondo arrotondato (Asti, Guarda-monte di Gremiasco, Villa del Foro, Breolungi e Villa-nova Mondovì : fig. 14), prodotto anche localmente (Breolungi, con un esemplare scartato durante la lavora-zione : Bagienni, 2001, fig. 17 ; 131, n° 2), o a melograno (Crissolo : fig. 14), sia dall’elaborazione di una variante originale per la forma del secchiello, caratterizzato dalla terminazione a bottone su un corpo cavo conico o care-nato (Villa del Foro e Castello di Annone : fig. 14), che trovano diffusione anche al di fuori dell’ambito ligure (Forcello di Bagnolo S. Vito). Una elaborazione locale sembra anche il pendaglio a secchiello con fondo conico pieno (Asti e Rocca Grimalda : fig. 14), ormai inquadra-bile nel pieno V secolo a.C.
L’appartenenza della Liguria interna piemontese alla cerchia metallurgica golasecchiana nella Media Età del ferro è testimoniata anche da altre classi di oggetti (fig. 14-15), purtroppo finora rinvenuti in numero troppo ridotto per consentire valutazioni statisticamente cor-rette, come i dischi fermapieghe in lamina di bronzo decorata, solitamente inseriti nell’ardiglione di fibule a sanguisuga o a navicella, i pendagli ad anelli con globetti (precocemente attestati a Valdieri nel corredo della tomba 3/94, databile tra la seconda metà del VI e gli inizi del V secolo a.C.), le perle in lamina di bronzo, gli oggetti da toeletta, attestati nel Piemonte sudorientale dove più forte appare l’influenza della cultura di Golasecca anche negli aspetti legati alla cura della persona (nella tomba di Alba-via Terzolo invece della pinzetta per rifinire la barba è presente il rasoio in ferro, come nella necropoli di Chiavari : Venturino Gambari et alii, 2009), e i ganci di cintura.
Lo stadio ancora iniziale della ricerca e l’analisi par-ziale del materiale archeologico proveniente dai siti della
Celti e liguri. rapporti tra la Cultura di golaseCCa e la liguria interna nella prima età del Ferro
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012), 141p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
Bagienni, 2001, venTurino gambari m. dir., Dai Bagienni a Bredulum. Il pianoro di Breolungi tra archeologia e storia, Mondovì, Omega Edizioni, 223 p., 165 fig. (Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte. Monografie, 9).
baTchvarova a., 1969, « La necropoli di Castello Valtravaglia (Varese) », Sibrium, IX, p. 85-148.
casini s., 2000, « Ritrovamenti ottocenteschi di sepolture della cultura di Golasecca nel territorio bergamasco », Notizie Archeologiche Bergomensi, 6, 1998 [2000], p. 109-154.
caTarsi dall’aglio m., 2004, « La seconda età del Ferro nel territorio parmense », in : venTurino gambari m., gandolFi d. dir., Ligures Celeberrimi. La Liguria interna nella seconda età del Ferro, Atti del Convegno interna-zionale, Mondovì 26-28 aprile 2002, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, p. 333-350.
chiaramonTe Treré c., baraTTi g., 2004, « L'insediamento ligure sul Monte Vallassa nella seconda età del Ferro : i risultati della nuove ricerche », in : venTurino gambari m., gandolFi d. dir., Ligures Celeberrimi. La Liguria interna nella seconda età del Ferro, Atti del convegno inter-nasionale, Mondovi 12-28 aprile 2002, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, p. 241-249.
cicolani v., 2010, Diffusion du mobilier de Golasecca au nord des Alpes au premier âge du Fer, voll. 1-2, Thèsedoctorales, Université Francois-Rabelais de Tours, 842 p., 351 fig., 47 pll.
Colligite fragmenta, 2009, venTurino gambari m., gandolFi d. dir., Colligite Fragmenta. Aspetti e tendenze del col-lezionismo archeologico ottocentesco in Piemonte, Atti del Convegno, Tortona 19-20 gennaio 2007, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 487 p.
bibliograFia
Media Età del ferro del Piemonte meridionale non consen-tono al momento considerazioni conclusive circa le moti-vazioni che stanno alla base della presenza di oggetti di abbigliamento e di uso personale caratteristici della cultura di Golasecca nella Liguria interna piemontese, quando la presenza di elementi analoghi in contesti funerari e di abi-tato a nord delle Alpi è stata messa in relazione al ruolo esercitato da questa cultura negli scambi a media e lunga distanza, implicando fenomeni di « métissage culturale, ... transfert technologique e ... mixité de population » (Cico-lani, 2010, p. 9).
Analogamente a quanto rilevato in area transalpina, con ben altra base statistica (Cicolani, 2010, p. 426-440), la categoria di oggetti più ricorrente è certamente rappresen-tata dalle fibule, intere e frammentarie ; seguono in numero decisamente inferiore gli anelli a globetti, i pendagli (a sec-chiello e di altra tipologia), le placche di cintura, i dischi fermapieghe, le perle in lamina di bronzo e gli oggetti da toeletta ; anche nella Liguria interna, come in area transal-pina, ad eccezione degli elementi da toeletta, tutti gli altri elementi accessori del costume sembrano appartenere nel loro insieme prevalentemente al mondo femminile.
Sono gli oggetti legati all’abbigliamento, sia maschile (fibule ad arco serpeggiante e a drago in ferro e in bronzo, oggetti da toeletta) sia femminile (fibule a navicella e a san-guisuga, fibule ad arco pieno a sezione biconvessa, alcune varianti di pendagli a secchiello, pendagli ad anelli con glo-betti, dischi fermapieghe in lamina di bronzo decorata, perle in lamina di bronzo, ganci di cintura in bronzo e in ferro), che hanno più strette affinità con i prototipi golasec-chiani. La loro attestazione, purtroppo quasi sempre da contesti di abitato o senza dati di associazione, potrebbe essere l’indizio della presenza di individui di entrambi i sessi inseriti all’interno delle comunità liguri del Piemonte
meridionale, all’interno delle quali avrebbero potuto svol-gere un ruolo legato prevalentemente al commercio o ad attività artigianali.
Certamente di impronta golasecchiana è la prevalenza degli oggetti della piccola metallurgia in bronzo e in ferro, che adottano o fanno riferimento alle tipologie degli ele-menti di abbigliamento, oltre che di uso personale, caratte-ristici dell’area insubre, verso la quale le comunità liguri piemontesi tra VI e V secolo a.C. sembrano debitrici, anche se varianti ed elaborazioni locali indicano la presenza di attività metallurgiche in loco. Tali attività potrebbero essere state esercitate direttamente da individui provenienti dall’area della cultura di Golasecca (si spiegherebbe così anche la diffusione di ceramica con decorazione a stralu-cido nel Piemonte meridionale, progressivamente meno consistente mano a mano che ci si sposta verso ovest) o da artigiani liguri formatisi nell’areale della medesima cultura e poi ritornati nei loro luoghi di origine, secondo modelli che troviamo documentati nello stesso periodo anche in relazione al mondo etrusco, come dimostra il caso di Larth Muthiku, un ligure etruschizzato sepolto a Busca (CN), la tomba del quale, databile intorno al 500 a.C., era contrasse-gnata da un ciottolo di quarzite locale con iscrizione in alfabeto etrusco che riportava il suo nome (Gambari, Colonna, 1988).
La mobilità di individui, prevalentemente femminili, è argomento che ha trovato del resto negli ultimi anni una solida base archeologica, anche con corredi funerari di pre-gio, che sembra indiziare una politica di strategie matrimo-niali messa in atto dalla cultura di Golasecca nell’ambito di un sistema di alleanze in funzione di consolidamento di accordi e transazioni a carattere prevalentemente commer-ciale (Liguri, 2004, p. 342 sgg. ; Casini, Chaume in questo volume di atti).
Valentina Faudino, Luisa Ferrero, Marina Giaretti, Marica Venturino Gambari
142 Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012),p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
Conquista Appennino, 2004, venTurino gambari m. dir., Alla conquista dell’Appennino. Le prime comunità delle valli Curone, Grue e Ossona, Torino, Omega Edizioni, 285 p., 238 fig.
damiani i., maggiani a., Pellegrini e., salTini a.c., serges a., 1992, L’età del Ferro nel Reggiano. I materiali delle collezioni dei Civici Musei di Reggio Emilia, vol. I, Reggio Emilia, 243 p., 103 fig. (Cataloghi dei Civici Musei di Reggio nell’Emilia).
de marchi a., PiroTTo s., 2004, « Le necropoli », in : venTurino gambari m., gandolFi d. dir., Ligures Celeberrimi. La Liguria interna nella seconda età del Ferro, Atti del Convegno internazionale, Mondovì 26-28 aprile 2002, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, p. 81-102.
de marinis r.c., 1981, « Il periodo Golasecca III A in Lombardia », Bergamo, p. 43-299 (Studi Archeologici, 1).
de marinis r.c., 1988, « L’abitato etrusco del Forcello di Bagnolo S. Vito », in : de marinis r.c. dir., Gli Etruschi a nord del Po, vol. I, catalogo della mostra, Mantova, p. 150-161.
de marinis r.c., 1991, « Tomba con situla bronzea dal Laz-zaretto di Golasecca », Sibrium, 1990-91, p. 157-200.
de marinis r.c., 2009a, « Sesto Calende, loc. Cascina Gajaccio : tomba del Golasecca II B », in : de marinis r.c., massa s., Pizzo m. dir., Alle origini di Varese e del suo territorio. Le collezioni del sistema archeologico provinciale, Roma, L'Erma di Bretschneider, p. 204-206.
de marinis r.c., 2009b, « Presualdo, Rastrel Rosso e Brivio (Sesto Calende), tombe del Golasecca I e II », in : de marinis R.C., massa S., Pizzo M. dir., Alle origini di Varese e del suo territorio. Le collezioni del sistema archeologico provinciale, Roma, L'Erma di Bretschneider, p. 416-430.
de marinis r.c., 2009c, « La necropoli di Mulini Bellaria di Sesto Calende (scavi 1977-1980) », in : de marinis r.c., massa s., Pizzo m. dir., Alle origini di Varese e del suo territorio. Le collezioni del sistema archeologico provin-ciale, Roma, L'Erma di Bretschneider, p. 431-454.
de marinis r.c., FronTini P., 1990, « La necropoli protosto-rica di Albate », in : aiani F. dir., Albate. La gente e la sua storia, Como, New press, p. 41-61.
di maio P., gambari F.m., gerneTTi F., PiroTTo s., squarzanTi m., 2001, « I corredi e i reperti », in : gambari F.M. dir., La birra e il fiume. Pombia e le vie dell’Ovest Ticino tra VI e V secolo a.C., Torino, Celid, p. 25-92.
von eles masi P., 1986, Le fibule dell'Italia settentrio-nale, München, Beck, 270 p., 189 fig. (Prähistorische Bronzefunde, XIV, 5).
Ferrero l., 2012, « Avigliana, borgata Malano. Nuove consi-derazioni sui reperti dell’età del Ferro », Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 27, p. 259-262.
Ferrero l., venTurino gambari m., 2008, « Preistoria e pro-tostoria nella valle del Gesso », in : venTurino gambari m. dir., Ai piedi delle montagne. La necropoli protostorica di Valdieri, Alessandria, LineLab.edizioni, p. 15-40.
gambari F.m., 1987, « La necropoli di San Bernardino di Briona : revisione critica alla luce dei risultati dei nuovi scavi », Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 6, p. 63-96.
gambari F.m., 1998, « Gli insediamenti e la dinamica del popolamento nell’età del Bronzo e nell’età del Ferro », in : mercando l., venTurino gambari m. dir., Archeologia in Piemonte, I. La preistoria, Torino, Allemandi, p. 129-146.
gambari F.m., 2004, « L’etnogenesi dei Liguri cisalpini tra l’età del bronzo finale e la prima età del Ferro », in : venTurino gambari m., gandolFi d. dir., Ligures Celeberrimi. La Liguria interna nella seconda età del Ferro, Atti del Convegno internazionale, Mondovì 26-28 aprile 2002, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, p. 11-28.
gambari F.m., colonna g., 1988, « Il bicchiere con iscri-zione arcaica da Castelletto Ticino e l’adozione della scrit-tura nell’Italia nord-occidentale », Studi Etruschi, vol. LIV, serie III, p. 121-164.
gambari F.m., venTurino gambari m., 1997, « Crissolo (Cuneo) : per una definizione archeologica dei Taurini nella prima età del Ferro », in : La Valle d’Aosta nel quadro della preistoria e protostoria dell’area alpina centro-occidentale, Atti della XXXI Riunione Scientifica dell’IIPP, Courmayeur 2-5 giugno 1994, Firenze, Istituto Italiano di preistoria e protostoria, p. 393-407.
gambari F.m., venTurino gambari m., 2004, « La medio-tarda età del ferro (V-II secolo a.C.) nella Liguria interna », in : venTurino gambari m., gandolFi d. dir., Ligures Celeberrimi. La Liguria interna nella seconda età del Ferro, Atti del Convegno internazionale, Mondovì 26-28 aprile 2002, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, p. 29-48.
grassi b., 2009, « Monsorino (Golasecca), tomba 26/1985 », in : de marinis r.c., massa s., Pizzo m. dir., Alle ori-gini di Varese e del suo territorio. Le collezioni del sistema archeologico provinciale, Roma, L'Erma di Bretschneider, p. 483-491.
Liguri, 2004, de marinis r.c., sPadea g. dir., I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e Mediterraneo, Catalogo della mostra, Genova 23 ottobre 2004-23 gennaio 2005, Ginevra-Milano, Skira, 655 p.
malnaTi l., 1989, « S. Ilario d’Enza - Loc. Bettolino. La necro-poli », in : ambroseTTi g, macellari r., malnaTi l. dir., S. Ilario d’Enza. La colonizzazione etrusca Strade Villaggi Sepolcreti, Reggio Emilia, p. 149-163.
mangani c., minarini l., 2000, « La necropoli di Cerinasca d’Arbedo », in : de marinis r.c., biaggio simona s. dir., I Leponti tra mito e realtà, Raccolta di saggi in occasione della mostra, Locarno, Gruppo archeologia Ticino, p. 259-268.
mano l., de angelis a., 2004, « La necropoli dell’età del Ferro di Pontechianale (Valle Varaita, Cuneo). Un corredo ritrovato », in : venTurino gambari m., gandolFi d. dir., Ligures Celeberrimi. La Liguria interna nella seconda età del Ferro, Atti del Convegno internazionale, Mondovì 26-28 aprile 2002, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, p. 261-268.
Celti e liguri. rapporti tra la Cultura di golaseCCa e la liguria interna nella prima età del Ferro
Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âges du fer). Actes du XXXVIe colloque international de l'A.F.E.A.F. (Vérone, 17-20 mai 2012), 143p. 125-144 (36e supplément à la R.A.E.) © S.A.E. et A.F.E.A.F., 2014.
michelini P., Paiola s., 1998, « Tomba 13 », in : bianchin ciTTon e., gambacurTa g, ruTa seraFini a. dir., ...“presso l’Adige ridente”... Recenti rinvenimenti archeo-logici da Este a Montagnana, Padova, ADLE edizioni, p. 155-163.
molli boFFa g. 1999, « Entracque, corso Francia. Tomba romana a incinerazione », Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 16, p. 230-233.
mordeglia l., 2004, « I materiali della seconda età del Ferro dagli scavi dell’insediamento ligure del Monte Vallassa », in : venTurino gambari m., gandolFi d. dir., Ligures Celeberrimi. La Liguria interna nella seconda età del Ferro, Atti del Convegno internazionale, Mondovì 26-28 aprile 2002, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, p. 251-260.
PasTorino a.m., venTurino gambari m., 2008, « Libarna preromana », in : rossi g., venTurino gambari m., zanda e. dir., La riscoperta di Libarna. Dall’antiquaria alla ricerca archeologica. Atti del Convegno, Genova 19 novembre 2004, Genova, De Ferrari, p. 77-89.
Pauli l., 1971, Studien zur Golasecca-Kultur, Heidelberg, F.H. Kerle Verlag, 167 p., 43 fig.
Primas m., 1970, Die Südschweizerischen Grabfunde der Älteren Eisenzeit und ihre Chronologie, Basel, Birkhauser Verlag, 156 p., 54. fig.
riTTaTore F., 1947, « Sepolcreti piemontesi dell'età del Ferro », Rassegna Storica del Seprio, VII, p. 1-12.
riTTaTore F., 1960-1965, « La necropoli preromana della Ca' Morta (scavi 1955-1965) », Rivista Archeologica dell’An-tica Provincia e Diocesi di Como, 143-147, p. 129-131.
ruFFa m., 1998, « La necropoli protostorica di Dorbié Superiore-Castelletto Ticino », Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 15, p. 11-39.
saronio P., 1970, « Le necropoli di Castello Valtravaglia (Va) Parte II », Sibrium, X, p. 109-152.
schindler m.P., de marinis r.c., 2000, « L’età del ferro nel Canton Ticino e nella Mesolcina », in : de marinis r.c., biaggio simona s. dir., I Leponti tra mito e realtà, Raccolta di saggi in occasione della mostra, 1, Locarno, Gruppo archeologia Ticino, p. 159-183.
Schmid-Sikimić B., 2000, « An den Wegen über die Alpen. Minusio und Mesocco : Referenzorte der älteren Eisenzeit in der Südschweiz », in : de marinis r.c., biaggio simona s. dir., I Leponti tra mito e realtà, Raccolta di saggi in occasione della mostra, 1, Locarno, Gruppo archeologia Ticino, p. 215-244.
Tosello l., 1993, « Materiali protostorici di Gremiasco, loc. Guardamonte », Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, XLV, p. 15-24.
Tosello l., 1996, « Materiali protostorici nel Museo Archeologico di Asti », Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, XLVIII, p. 7-24.
Valdieri 2008, venTurino gambari m. dir., Ai piedi delle mon-tagne. La necropoli protostorica di Valdieri, Alessandria, LineLab.edizioni, 142 p., 105 fig.
venTurino gambari m., 1991, « Montaldo di Mondovì. Una stazione dei “Ligures Montani” nel Monregalese », in : micheleTTo e., venTurino gambari m. dir., Montaldo di Mondovì. Un insediamento protostorico. Un castello, Roma, Leonardo-De Luca, p. 15-28.
venTurino gambari m., 1994, « Alessandria, fraz. Villa del Foro. Scavi nell' area degli abitati pre-protostorici », Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 12, p. 262.
venTurino gambari m., caTTaneo cassano a., 1995, « Montecastello, loc. Castello. Scavi nell'area degli inse-diamenti protostorici », Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 13, p. 304-305.
venTurino gambari m., croseTTo a., 2009, « Capriata d’Orba, località S. Nicolao. Ritrovamenti di età protostorica e romana in zona di insediamento medievale », Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 24, p. 181-184.
venTurino gambari m., mano l., 1988, « Sampeyre, loc. Baite di Villaretto. Fibula a navicella dell'età del Ferro », Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 7, p. 61.
venTurino gambari m., Ferrero l., giareTTi m., 2009, « Alba, via Terzolo. Tombe a cremazione sotto tumulo entro recinto funerario », Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 24, p. 200-205.
venTurino gambari m., luzzi m., occhi s., PeroTTo a., zamagni b., 1996, « Castello di Annone, loc. Collina di Castello. Indagine archeologica in sito pluristratificato », Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 14, p. 221-223.
venTurino gambari m., PeroTTo a., daviTe c., Traversone b., 1994, « Cossano Belbo, fraz. Scorrone, loc. Cascina del Vedovo. Insediamento dell'età del Ferro », Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 12, p. 286-288.
venTurino gambari m., seraFino c., zamagni b., 1998, « Castelnuovo Scrivia, Centro storico. Insediamenti e reperti pre-protostorici », Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 15, p. 205-207.