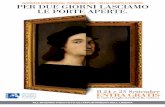Fama publica, fama sanctitatis. Zu Kommunikation und Information im Spätmittelalter
Sulla fama del "Correggio Insubre". Un primo sguardo alla fortuna di Giulio Cesare Procaccini nelle...
Transcript of Sulla fama del "Correggio Insubre". Un primo sguardo alla fortuna di Giulio Cesare Procaccini nelle...
a cura di
DANILO ZARDIN
LOMBARDIAED EUROPAINCROCI DI STORIA E CULTURA
VITA E PENSIERORICERCHESTORIA
PP_Zardin.indd 3 30/04/14 14:15
La presente pubblicazione è stata realizzata con il contributo di
Programma di alti studi dottorali «Lombardia ed Europa» (Univer-sità Cattolica del Sacro Cuore e Università degli Studi di Milano). Finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando «Pro-muovere la formazione di capitale umano di eccellenza» (id 2009 – 2948).
www.vitaepensiero.it
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Cen-tro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail: [email protected] e sito web www.clearedi.org
© 2014 Vita e Pensiero - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 MilanoISBN 978-88-343-2656-5
PP_Zardin.indd 4 30/04/14 14:15
INDICE
Prefazione, Enrico Decleva e Lorenzo Ornaghi IX
Introduzione, Danilo Zardin XVII
MARTA GRAVELA Modelli familiari nelle aristocrazie europee del tardo Medioevo. Confronti storiografi ci fra Italia e Gran Bretagna 3
FABRIZIO PAGNONIIl potere dei vescovi nel tardo Medioevo. Prospettive di ricerca nelle storiografi e italiana e anglosassone (spunti a partire dal caso lombardo) 23
CHIARA MARIA CARPENTIERIMinima hungarica. Appunti su manoscritti ed edizioni a stampa dei secoli XV-XVII in biblioteche lombarde 45
CRISTINA GEDDOLeonardeschi tra Lombardia ed Europa: i ‘Giampietrino’ della Mitteleuropa 69
GIACOMO VAGNILettere di Baldassarre Castiglione dalla Spagna (1525-1529) 109
DAVIDE GIAVINAIl secretum: Girolamo Cardano, Konrad Gessner, Guglielmo Gratarolo 129
BENEDETTA CRIVELLICommerci e affari tra Milano e la penisola iberica. L’integrazione dei mercanti-banchieri milanesi nel sistema imperiale spagnolo nella seconda metà del XVI secolo 145
VI INDICE
MARZIA GIULIANIIl barone Paolo Sfondrati tra Milano, Torino e Madrid. Diplomazia e affari di famiglia 169
ODETTE D’ALBOSulla fama del «Correggio Insubre». Un primo sguardo alla fortuna di Giulio Cesare Procaccini nelle collezioni europee tra Seicento e Ottocento 189
FRANCESCO PARNISARI«Absente dalla patria e fuori di questo dominio di Milano».Movimenti migratori dalle valli varesine in età moderna 219
MARCO ROCHINIOrientamenti della teologia politica tardo-settecentesca in Italia e in Francia. Giovanni Battista Guadagnini e Nicolas-Sylvestre Bergier 237
DANIELA SORALa Visitazione tra Lombardia e Francia: i casi di Milano e Grenoble. Linee di ricerca 257
ALESSANDRA SQUIZZATOTra Milano e l’Europa. Viaggiatori, eruditi e studiosi al museo Trivulzio nei secoli XVIII e XIX 275
RITA ZAMAAlessandro Manzoni: un fi losofo europeo del linguaggio 299
ALICE CROSTAGli esuli del Risorgimento in Inghilterra di fronte a Manzoni.Una ricezione ambivalente 319
VALENTINA MARCHESIRobert Samuel Turner (1819-1887). Peregrinazioni di manoscritti Bembo tra Italia e Inghilterra 337
FRANCESCA MISIANOVerso il cuore dell’Europa. Il tunnel del Sempione e l’Esposizione Internazionale del 1906 353
INDICE VII
GIACOMO DEMARCHILe burocrazie costituenti. Tecnici del diritto e circolazione giuridica fra le due guerre mondiali 373
GIULIA GRATALa ricezione di André Frénaud (1907-1993) a Milano. Dall’impegno alla neoavanguardia 393
ODETTE D’ALBO
Sulla fama del «Correggio Insubre»Un primo sguardo alla fortuna di Giulio Cesare Procaccini nelle collezioni europee tra Seicento e Ottocento*
Nell’Enciclopedia metodica critico-ragionata delle belle arti, data alle stampe nel 1821, don Pietro Zani menziona Giulio Cesare Procaccini come il «Correggio Insubre»1. Rubricata sotto il nome del celebre pittore della scuola di Parma, questa formula effi cace restituisce una visione dell’arti-sta che, pur ancorata geografi camente al contesto lombardo, rinvia al le-game imprescindibile, sotto il profi lo dello stile, con il protagonista del Rinascimento in Emilia. Non è trascurabile porre in evidenza che la cal-zante defi nizione del sacerdote fi dentino sembra echeggiare un passo della Nuova Guida di Milano pubblicata nel 1787 da Carlo Bianconi, in contatto con Zani dal 17832, nella quale il primo segretario dell’Accade-mia di Brera così commentava il San Sebastiano curato dagli angeli di Giu-lio Cesare già in Santa Maria presso San Celso e ora ai Musées Royaux des Beaux-Arts di Bruxelles [fi g. 12]:
La dolcezza e patetica espressione del volto dell’addolorato martiro, che guar-dando al cielo mostra consolarsi per la divina e immortal mercede, è così bene espressa che niente più. Amorosi e correggeschi sono gli angioli, che tengono in mano l’arco e le frecce strumenti del martirio, e l’opera tutta è tale da procu-rargli il titolo di nostro Correggio, come da qualcuno viene chiamato3.
* Sono molte le persone che mi hanno supportata in vista della pubblicazione di questo scritto. In particolare vorrei ringraziare i curatori delle istituzioni museali presso le quali ho condotto le ricerche, che, con grande disponibilità, hanno risposto alle mie molte domande e richieste di chiarimenti: Joost Vander Auwera, Andreas Henning, Zuzana Ludikova, Andreas Schumacher, Chris Stevens, Jacqueline Thalmann, Franziska Windt, Lucy Withaker. Per le indicazioni, i consigli e le osservazioni sono grata a Kira d’Albu-querque, Laura Aldovini, Marco Bona Castellotti, Massimo Fiorot, Francesco Frangi, Ma-riangela Giusto, Silvio Mara, Alessandro Morandotti, Mauro Pavesi, Alessandro Rovetta, Alessandra Squizzato.1 P. Zani, Enciclopedia metodica critico-ragionata delle belle arti, 28 voll., VII, parte prima, Parma 1821, p. 62. Nonostante le ricerche non mi è stato possibile, fi nora, risalire alla fonte dalla quale l’autore dell’Enciclopedia trasse la defi nizione di Giulio Cesare, ma non escludo che possa essere un suo conio. 2 Zani, Enciclopedia metodica critico-ragionata delle belle arti, I, parte prima, Parma 1819, pp. 4-5.3 C. Bianconi, Nuova Guida di Milano per gli amanti delle belle arti e delle sacre, e profane anti-chità milanesi, Milano 1787, pp. 140-141. È possibile che il «qualcuno» al quale Bianconi fa
190 ODETTE D’ALBO
È bene tenere presente, oltretutto, che le indicazioni fornite da Zani e da Bianconi giungono a conferma di una plurisecolare visione di Procac-cini, che trova le sue radici nella notissima lettera indirizzata da Girola-mo Borsieri a Scipione Toso, datata tradizionalmente tra il maggio e l’ot-tobre 1621, nella quale Giulio Cesare, ancora vivente, viene indicato co-me «prattico nelle maniere illustrate dal Parmigiano e dal Correggio»4.
Che il rifarsi alla tradizione emiliana rappresenti una delle motiva-zioni della fortuna europea del bolognese è stato messo in luce da Mar-co Rosci già nel 19645, mentre allo stesso tempo lo studioso registrava uno scarsissimo interesse nei confronti degli altri maestri della longhia-na «nobile famiglia» del primo Seicento lombardo, vale a dire Cerano, Morazzone e il più giovane Daniele Crespi. L’affi evolirsi della memoria di questi ultimi pittori si comprende innanzi tutto alla luce della più ge-nerale assenza di repertori di vite degli artisti attivi sulla scena milanese durante quel secolo, se si escludono i cenni offerti da Paolo Morigia ne La nobiltà di Milano del 1595 e da Borsieri, nel suo Supplimento a quel te-sto, del 1619, e anche l’abbondante messe di guide sulla città non risul-tò d’effettivo aiuto alla conoscenza del loro magistero su ampia scala6. Per un primo, fondamentale, resoconto relativo alle biografi e dei prota-gonisti di quegli anni di pittura ruggente e infervorata bisognerà infat-ti attendere l’Abecedario Pittorico di Pellegrino Orlandi del 1704 e le note che vi appose padre Sebastiano Resta7.
In controtendenza, la dinastia dei Procaccini si giova, in virtù delle origini bolognesi, dei profi li biografi ci redatti nella Felsina Pittrice, pub-blicata nel 1678, da Carlo Cesare Malvasia, che, come noto, intraprese un viaggio in Lombardia e si recò a Milano presso l’ultimo rappresen-tante della famiglia, Ercole il Giovane, per attingere a notizie di prima
riferimento sia Carlo Torre, che nel Ritratto di Milano, propone il paragone con Correggio in merito ai dipinti di Giulio Cesare nella cappella Acerbi in S. Antonio Abate: «Dite a vo’ stessi, se chiamandosi nuovo Antonio da Correggio, possa essere da voi corretto di troppo ardito chi lo dichiara tale» (C. Torre, Ritratto di Milano, Milano 1674, p. 45).4 In L. Caramel, Arte e artisti nell’epistolario di Girolamo Borsieri, in Contributi dell’Istituto di Storia dell’Arte Medievale e Moderna, 2 voll., Vita e Pensiero, Milano 1966, I, p. 174. Sulla datazione della lettera hanno avanzato alcuni dubbi sia Federico Cavalieri (F. Cavalieri in F. Frangi - A. Morandotti [a cura di], Dipinti Lombardi del Seicento, Collezione Kolli-ker, Milano 2004, p. 38) che Jacopo Stoppa (J. Stoppa in M. Rosci [a cura di] Il Cerano 1573-1632. Protagonista del Seicento Lombardo, catalogo della mostra, Motta, Milano 2005, p. 182).5 M. Rosci, Mostra del Cerano, catalogo della mostra, Banca Popolare di Novara, Novara 1964, p. 22.6 Per una sintesi su questi aspetti si rimanda ad A. Rovetta, Introduzione, in Id. (a cura di), Tracce di letteratura artistica in Lombardia, Edizioni Di Pagina, Bari 2004, pp. XII-XX.7 G. Nicodemi, Le note di Sebastiano Resta ad un esemplare dell’Abecedario pittorico di Pellegrino Orlandi, in Studi storici in memoria di Mons. Angelo Mercati, Giuffrè, Milano 1956, pp. 263-326.
SULLA FAMA DEL «CORREGGIO INSUBRE» 191
mano8. La presenza delle vite dei Procaccini9 all’interno di questo testo cardine della letteratura artistica, che godette di una particolare atten-zione oltre i confi ni italiani, e soprattutto francesi, già per volontà del-lo stesso autore che la dedicò a Luigi XIV10, rappresenta senza dubbio il trampolino di lancio per la conoscenza di questi pittori, che si traduce anche nei termini di una signifi cativa attenzione da parte di collezionisti al di qua e al di là delle Alpi, come è stato posto in evidenza, in tempi re-centi, da Alessandro Morandotti11. Se si passa invece a considerare il pa-norama degli studi riguardante la fortuna di Giulio Cesare nelle raccol-te europee tra Seicento e Ottocento, bisogna sottolineare come questo fi lone di ricerca appaia tuttora poco battuto: all’argomento ha dedicato qualche rapido cenno Marco Rosci, nel 199312, nel primo tentativo mo-nografi co che ha riguardato la cospicua produzione di Procaccini, ba-sandosi anche su alcune considerazioni che Hugh Brigstocke aveva for-mulato nel corso degli anni ottanta13. È invece soprattutto a un recente contributo dello studioso inglese, condotto nell’ambito della mostra Pro-caccini in America del 200214, che si deve una visione più ampia della cir-colazione e della conoscenza delle opere del bolognese fuori dai nostri confi ni nazionali. Se però Brigstocke considera al livello di «random ac-quisitions» l’ingresso di testimonianze dell’artista in numerose collezio-ni in tutta Europa, non si può escludere che Giulio Cesare non rientras-se nel novero dei maestri dei quali ‘valeva la pena’ procacciarsi dipinti, grazie soprattutto all’autorevolezza goduta dal testo di Malvasia. A ben vedere, la stessa citazione proposta da Brigstocke come la prima ‘vita’ dell’artista redatta fuori dal contesto italiano, vale a dire quella contenu-ta nell’Abrégé de la vie des plus fameux peintres di Antoine Joseph Dezallier D’Argenville, pubblicato nel 1745, appare modellata, per i dati biogra-fi ci, sullo scarno profi lo di Orlandi ma, per quanto concerne la visione generale e i topoi legati per tradizione alla letteratura sul pittore – quali,
8 A. Arfelli, Il viaggio del Malvasia a Milano e notizie su Ercole Procaccini il Giovane, «Arte antica e moderna», 4 (1961), pp. 470-476.9 Per le vite Procaccini, C.C. Malvasia, Felsina Pittrice, 2 voll., 1678, I, pp. 271-293.10 Sull’attenzione rivolta alla Felsina Pittrice nel contesto del Settecento europeo si riman-da a C. Gauna, M come Malvasia e Mariette: disegni, stampe e giudizi di stile tra Bologna, Parigi e Vienna, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofi a», 2011, 3/1, pp. 159-203.11 In A. Morandotti, Il collezionismo in Lombardia. Studi e ricerche tra ’600 e ’800, Offi cina Libraria, Milano 2008, p. XIV.12 M. Rosci, Giulio Cesare Procaccini, Edizioni dei Soncino, Soncino 1993, pp. 6-7.13 H. Brigstocke, G.C. Procaccini et D. Crespi: nouvelles découvertes, «Revue de l’art», 1980, 48, pp. 30-39 e Id., Giulio Cesare Procaccini (1574-1625): ses attaches génoises et quelques autres faits nouveaux, «Revue de l’art», 1989, 85, pp. 45-60. 14 H. Brigstocke, Procaccini’s critical reputation, in Id. (a cura di), Procaccini in America, catalogo della mostra, The Studley Press, New York 2002, pp. 63-71.
192 ODETTE D’ALBO
per sommi capi, la concorrenza della famiglia Procaccini con i Carracci, il passaggio di Giulio Cesare dalla scultura alla pittura, che lo condusse allo studio delle opere di Michelangelo, Correggio e Tintoretto durante i viaggi a Roma, Parma e Venezia e il soggiorno genovese – il riferimen-to è senza dubbio la Felsina Pittrice, circostanza che indica la centralità di quel testo nella fortuna dell’artista, come si avrà modo di porre in evi-denza anche in seguito15. Ulteriori indicazioni a riprova dell’apprezza-mento del maestro da parte degli amatori d’arte di tutta Europa, soprat-tutto per quanto riguarda l’attività grafi ca, sono state fornite nella mo-nografi a che, nel 2003, Nancy Ward Neilson ha dedicato a quell’aspetto della produzione di Giulio Cesare16.
È quindi sul doppio binario dell’ampia diffusione della Felsina Pittri-ce, che riconosce ai Procaccini un posto di rilievo nella storiografi a arti-stica, seppure assai più defi lato rispetto a quello ricoperto dai Carracci e dalla loro scuola, e alla capacità di ‘reinventare’17 il linguaggio di Cor-reggio e di Parmigianino, carattere peculiare dello stile di Giulio Cesa-re, che si gioca, con ogni probabilità, la non trascurabile presenza di di-pinti del pittore nelle raccolte straniere dal Seicento fi no all’Ottocento.
Alla luce dell’ampiezza dell’argomento, le indicazioni che qui si pre-sentano non hanno alcuna pretesa di esaustività: l’intento di questo stu-dio è piuttosto quello di soffermarsi su alcuni esempi, presentati in ordi-ne cronologico, che documentano l’ingresso di opere dell’artista all’in-terno di prestigiose collezioni, private e pubbliche, europee. I risulta-ti qui riuniti costituiscono quindi un primo abbozzo molto parziale, ma anche e soprattutto un nuovo punto di partenza all’interno di un lungo, e a volte impervio, work in progress.
Nonostante l’importanza cardine della Felsina Pittrice nell’attrarre l’attenzione dei collezionisti verso le raffi nate cadenze di Procaccini, è possibile affermare che alcuni dipinti di Giulio Cesare presero la via dell’estero già durante la vita dell’artista: in particolare, il centro pri-vilegiato di questa prima diffusione sembra essere la Spagna, cosa che d’altro canto non stupisce considerando che lo Stato di Milano rientra-va allora, e lo sarebbe stato fi no al 1714, sotto il dominio di quel regno. Come mi è stato possibile documentare di recente, si deve infatti, con ogni probabilità, alla commissione di Pedro de Toledo Osorio (1557-1627), quinto marchese di Villafranca del Bierzo e governatore del Mi-
15 A.J. Dezallier D’Argenville, Abrégé de la vie des plus fameux peintres, 3 voll., 1745, I, pp. 229-232; Brigstocke, Procaccini’s critical reputation, p. 64. 16 N.W. Neilson, Giulio Cesare Procaccini disegnatore, Nomos Edizioni, Busto Arsizio 2003, pp. 13-16.17 M. Spagnolo, Correggio. Geografi a e storia della fortuna (1528-1657), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2005, p. 102.
SULLA FAMA DEL «CORREGGIO INSUBRE» 193
lanesado tra il 1615 e il 1618, lo spettacolare ciclo di tele con le storie della Passione e della vita di Cristo, che comprende L’orazione nell’or-to degli ulivi al Prado di Madrid, la Cattura di Gesù di recente transita-ta sul mercato antiquario, la Flagellazione al Museum of Fine Arts di Bo-ston, l’Incoronazione di spine alla Graves Art Gallery di Sheffi eld, l’Innal-zamento della Croce della National Gallery di Edimburgo e, forse, la Pie-tà, in raccolta privata, la Trasfi gurazione ora nella chiesa di Saint James a Whiteheaven, in Cumbria, e il Battesimo di Cristo della Galleria Nazio-nale di Bratislava [fi g. 15]. Questo nucleo straordinario tanto per qua-lità dell’esecuzione pittorica che per invenzione, fu allestito nel salone del palazzo del Toledo a Madrid, ed è probabile che della collezione lì radunata dal marchese di Villafranca facesse parte anche la Madon-na col Bambino e due angeli entro una ghirlanda di fi ori, eseguita da Giulio Cesare e Jan Bruegel il Vecchio18, al quale si deve l’esecuzione dei fi o-ri che incorniciano la scena sacra. In aggiunta a queste informazioni, è possibile stabilire che la raccolta del governatore venne smembrata tra il marzo 1636 e il dicembre 1639. Tra gli acquirenti accorsi all’asta, anche se non è possibile stabilire di preciso quali pezzi furono vendu-ti e quindi se le scene della vita di Cristo vi furono comprese, emerge anche il marchese del Carpio19, nella collezione romana del quale fi -gurano, tra il 1682 e il 1683, tre opere attribuite a Giulio Cesare e una genericamente a un membro della famiglia Procaccini20, al momento non identifi cate.
Procedendo con la rassegna delle raccolte entro le quali compaio-no testimonianze di Giulio Cesare, è degna di nota la menzione, nell’in-ventario dei beni del cardinale Giulio Mazarino (1602-1661) redatto nel 1653, di una «Vierge tenant entre ses bras le petit Jésus, St. Jean Baptiste et un ange tenant une pomme dans sa main, sur bois, en hauteur plus que petit. Procaccino»21. Ancora attestato nella collezione del prelato
18 A. Morandotti, in D. Benati - F. Mazzocca - A. Morandotti (a cura di) Fiori. Natura e simbolo dal Seicento a Van Gogh, catalogo della mostra, Silvana Editoriale, Cinisello Balsa-mo 2010, pp. 102-103.19 Per tutte le considerazioni relative alla commissione e alla collezione del Toledo, mi permetto di rimandare al mio studio O. D’Albo, I governatori spagnoli a Milano e le arti: Pedro de Toledo, Giulio Cesare Procaccini e le “Historie grandi della vitta di nostro Signore”, «Nuovi Studi», 19 (2014), 20, in corso di stampa.20 M.B. Burke - P. Cherry, Collections of Paintings in Madrid 1601-1755, 2 voll., Getty In-stitute, New York 1997, I, pp. 726-786, nn. 284, 297, 529, 146, indicati in Brigstocke, Procaccini’s critical reputation, p. 63. Sulla collezione Carpio si veda anche il recente L.M. de Frutos Sastre, El Templo de la Fama. Alegoría del Marqués del Carpio, Fundación Arte Hispánico, Madrid 2009.21 H. d’Orleans duc d’Aumale, Inventaire de tous les meubles du Cardinal Mazarin dressé en 1653 et publié d’après l’original conservé dans le archives de Condé, London 1861, p. 302, n. 82.
194 ODETTE D’ALBO
nel 166122, del dipinto si perdono le tracce in tempi successivi23: seppur in entrambi i documenti non venga precisato se si tratti di una prova di Camillo o di Giulio Cesare, una conferma in favore di una composizio-ne di quest’ultimo viene dall’incisione di traduzione di un’opera [fi g. 2] del minore dei due fratelli, corrispondente all’iconografi a descritta, pubblicata nel 1884 da Gabriel-Jules de Cosnac24. In un suo studio re-cente riguardante la raccolta, Stephane Loire25 ha proposto di ricono-scere il dipinto riprodotto nella Madonna con il Bambino, san Giovannino e un angelo di Giulio Cesare Procaccini conservata alla Alte Pinakothek di Monaco [fi g. 1]26, ricordata per la prima volta nelle collezioni bava-resi nel 174827. Se lo studioso avanzava qualche riserva perché l’opera è indicata su tela nell’inventario del 1661, non appare trascurabile, come ulteriore indizio a favore dell’identifi cazione proposta, che venga inve-ce registrata su tavola, come appare dalla descrizione citata, nel primo inventario del 1653. In aggiunta a questa attestazione, rubricata generi-camente sotto il nome di Procaccini, compare, nell’inventario del 1661, una «Venus nue debout tenant une fl eiche, hault de cinq piedz un poul-ce et large de deux piedz six poulces»28, su tela, al momento non identi-fi cabile, anche se il soggetto descritto potrebbe trovare maggior riscon-
22 Indicato come «Un autre faict par Precaicine sur thoille, representant la Vierge tenant entre ses bras le petit Jésus, saint Jean Baptiste et un ange tenant une pomme a la main, hault de deux piedz deux poulces et large d’un pied neuf poulces garny de sa bordure de bois doré prisé la somme de cinq cents livres», in T. Yoshida-Takeda - C. Lebrun-Jouve (éds.), Inventaire dressé après le décès en 1661 du Cardinal Mazarin, Diffusion de Bocard, Paris 2004, p. 175, n. 928.23 S. Loire, Quelques précisions sur les tableaux de la collection Mazarin, in I. de Conihour - P. Michel (a cura di), Mazarin. Les lettres et les arts, Éditions Monelle Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau 2006, p. 160.24 Dell’opera riprodotta nell’incisione, realizzata da Anatole Alfred Théodore (?) Delan-gle su disegno di A. (?) Paquier (l’incertezza nell’identifi cazione degli autori si giustifi ca perché sulla stampa compaiono solo i cognomi, come si verifi ca anche in altri casi che verranno indicati con le stesse modalità all’interno del contributo), non viene fornita l’ubicazione e in una nota Cosnac la attribuisce a Camillo, G.-J. de Cosnac, Les richesses du Palais Mazarin, Paris 1884, pp. 290-291, n. 928. Sull’utilità delle incisioni di traduzione come fonti per la storia del collezionismo si rimanda a Morandotti, Il collezionismo in Lombardia, pp. 77-134.25 Loire, Quelques précisions sur les tableaux de la collection Mazarin, p. 160.26 Olio su tavola, 73,5 × 57,2 cm, C. Syre, Alte Pinakothek. Italienische Malerei, Hatje Cantz, München 2007, p. 186. Loire attribuisce l’opera alla bottega dell’artista, mentre secondo chi scrive si tratta di un dipinto autografo di Giulio Cesare.27 Inventaire des tableaux de la galerie et du beau apartement dans la Résidence de Munich, ms., 1748, n. 67 (come Camillo Procaccini). Una riproduzione del manoscritto si conserva presso la Alte Pinakothek di Monaco.28 Inventaire dressé après le décès en 1661 du Cardinal Mazarin, p. 202, n. 1136.
SULLA FAMA DEL «CORREGGIO INSUBRE» 195
tro all’interno della produzione di Giulio Cesare, se non altro per con-sonanza con la Venere e Amore già Visconti Borromeo Litta29.
Alla ricerca di motivazioni che, in linea generale, diano conto del-la presenza dei dipinti di Procaccini all’interno della raccolta di Mazza-rino, non si può escludere che l’acquisizione sia legata al ruolo di pri-mo piano che giocò, nel formare la collezione, il pittore Antonio Maria-ni detto Della Cornia (1584?-1654), «intendente della bontà dei quadri e della diversità delle mani»30, personaggio di spicco del mercato arti-stico romano della prima metà del Seicento, in contatto con i Ludovisi, i Barberini e i Savoia, che lo invitarono a Torino, nel 1635, per la com-pilazione dei loro inventari, nonché copista attivo anche per Federico Borromeo31. Conosciutisi probabilmente nell’entourage dei Barberini, i contatti tra Mariani e Mazzarino sono testimoniati a partire dal 1634 e, dopo un primo rifi uto, nel 1640, di recarsi nella capitale francese, Del-la Cornia soggiornò a Parigi tra il 1644 e il 1645, con grande probabili-tà per seguire i lavori di allestimento delle raccolte all’interno del palaz-zo del cardinale32.
Spostandoci, invece, sul fronte tedesco, una notevole importanza as-sume la presenza di opere di Giulio Cesare nella collezione dell’elettore Wilhelm von der Pfalz (1658-1716) a Düsseldorf, confl uita a Monaco nel 1805 a costituire uno dei nuclei più importanti della Alte Pinakothek33. Il nome dei Procaccini fi gura infatti due volte nelle tavole de La Galerie Electorale de Dusseldorf, data alle stampe nel 1778 ad opera dell’architet-to Nicolas de Pigage (1723-1796) e dell’incisore di Basilea Christian von Mechel (1737-1817). All’interno di questa sorta di maestoso campiona-rio che, mostrando le incisioni di traduzione dei dipinti in piccolo for-mato, rende in maniera effi cace l’idea dell’allestimento della raccolta, compaiono sia la Sacra Famiglia con sant’Elisabetta e san Giovannino [fi gg. 3, 4], che per l’intensità nella resa correggesca degli affetti e per la ste-sura pittorica smagliante e aggiornata sul lessico rubensiano, può essere
29 Brigstocke, Procaccini in America, pp. 110-114.30 M. Di Macco, Note su Antonio Mariani detto Della Corgna. Pittore «insigne nel copiare» e «sti-matore delle pitture», in Studi in onore di Giulio Carlo Argan, La Nuova Italia, Scandicci 1994, p. 210; si veda anche B. Di Sabatino, Mariani della Cornia (Della Corgna, Della Cornia), Antonio, in DBI, 70, 2008, pp. 309-310.31 A. Rovetta, in A. Rovetta - M. Rossi (a cura di), Pinacoteca Ambrosiana. Tomo secondo, Electa, Milano 2006, pp. 169-174.32 P. Michel, Mazarin prince de collectionneurs, Éditions de la Réunion des Musées natio-naux, Paris 1999, pp. 45-46.33 T.W. Gaehtgens, in T.W. Gaehtgens - L. Marchesano (a cura di), Making and illu-strated catalogue in the Enlightenment, in Display Art History. The Düsseldorf Gallery and its ca-talogue, catalogo della mostra, The Getty Research Institute, Los Angeles 2011, p. 1. Sulla collezione di dipinti dell’elettore palatino, R. Baumstark, Kurfürst Johann Wilhelms Bilder, catalogo della mostra, 2 voll., Hirmer, München 2009.
196 ODETTE D’ALBO
annoverato tra i capolavori di Giulio Cesare34, sia la Sacra Famiglia con il Bambino e due angeli, che però è, più probabilmente, un’opera di botte-ga dell’artista35. Non è al momento possibile stabilire la provenienza di questi dipinti, ma è plausibile pensare ad un’origine lombarda, dal mo-mento che Wilhelm von der Pfalz si avvalse come suo agente per lo Stato di Milano, a partire dal 1690, del marchese Cesare Pagani (1635-1707), uno dei più aggiornati e avveduti collezionisti della Milano del Settecen-to, tra gli estimatori di Sebastiano Ricci e di Paolo Pagani, che procurò all’elettore, nel 1693, anche le copie dei Quattro elementi di Bruegel con-servati presso l’Ambrosiana36.
In anni ancora piuttosto precoci, approdò in una prestigiosa collezio-ne europea anche la Sacra Famiglia con due angeli [fi g. 5] di Giulio Cesa-re, che compare per la prima volta nelle raccolte degli elettori di Sasso-nia nel 1728, con attribuzione a Caravaggio37. Tuttavia, questo primo ri-ferimento al pittore lombardo viene già corretto in favore di Procaccini nell’inventario stilato da Pietro Maria Guarienti nel 1750, nel quale vie-ne riportata anche la notizia della provenienza dalla famiglia Belgiojo-so di Milano38. Ad attestare il crescente riconoscimento di Giulio Cesa-re, un’incisione tratta da quest’opera fi gura nel Recueil d’estampes d’après les plus célèbres tableaux de la Galerie Royale de Dresde di Charles Henri De
34 Olio su tela, 195,7 × 144,3 cm. Incisione di Christian von Mechel su disegno di Joseph August Brulliot. Ringrazio Edouard Kopp e Christina Aube per le indicazioni relative al disegno preparatorio per la stampa, conservato al Getty Research Institute di Los Ange-les. In N. de Pigage - C. von Mechel, La Galerie Electorale de Dusseldorf, Basel 1778, n. 140, l’opera risulta riferita a Camillo come in tutti i cataloghi della galleria di Monaco ante-riori a H. Braune (a cura di), Katalog der Königlichen Älteren Pinakothek in München, Knorr & Hirth, München 1913, p. 112, n. 2111, nel quale viene riportata l’attribuzione orale di Adolfo Venturi a Giulio Cesare Procaccini.35 Olio su tela, 163,5 × 111,4 cm. Il dipinto è riprodotto e fi gura come autografo in Brigstocke, Procaccini in America, p. 179, ma alcune debolezze, specie nel volto della Vergine e nel Bambino, inducono a ritenerla un’opera di bottega.36 S. Tipton, “La passion mia per la pittura”. Die sammlungen des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz (1658-1716) in Düsseldorf im Spiegel seiner Korrespondenz, «Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst», 2006, 57, pp. 113, 208-209. Sulle relazioni tra il marchese Cesare Pagani e l’elettore palatino si veda anche A. Morandotti, Sebastiano Ricci a Milano (1694-1696) e la pittura lombarda, in G. Pavanello (a cura di), Sebastiano Ricci 1659-1734, Atti del convegno, Scripta Edizioni, Verona 2012, pp. 217-218.37 Olio su tavola, 162 × 107 cm, A. Henning, in H. Marx (a cura di), Gemäldegalerie Alte Meister Dresden. Band I. Die ausgestellten werke, Köln 2006, p. 178. Dall’inventario risulta che venne acquistata tramite Giuseppe Perodi, fi gura forse di intermediario riguardo al quale però non è stato possibile reperire notizie.38 H.M. de Riedmatten - A. Rüfenacht - T. Weddigen (a cura di), Pietro Maria Guarientis “catalogo” der Dresdner Gemäldegalerie von 1750, «Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlun-gen Dresden», 2004 (ed. 2007), 31, p. 125, n. 363. Un’ispezione del retro della tavola non reca tracce della provenienza milanese.
SULLA FAMA DEL «CORREGGIO INSUBRE» 197
Heineken, del 1753 [fi g. 6]39, accanto ai capolavori di Andrea del Sar-to, Tiziano e, naturalmente, dell’immancabile Correggio. Ma la buona reputazione goduta dall’artista si coglie in misura maggiore grazie al te-sto redatto a corredo dell’acquaforte, che, non essendo mai stato preso in considerazione, fi no ad ora, negli studi sul maestro, vale la pena di ri-portare per intero:
Non fu vana paura quella dei Carracci quando temettero d’entrare in compe-tenza con i Procaccini, i quali dal loro canto temendo anch’essi di rivali sì valo-rosi, presero la risoluzione di abbandonare la città di Bologna e di cercare al-trove una nuova patria e nuovo asilo, ove potessero senza timore esercitare il lo-ro sapere ed esservi considerati: Giulio Cesare Procaccini, a cui gli avanzamenti di suo fratello Camillo avevano fatto lasciar lo scalpello, per prendere anch’egli la tavolozza, trovò, al pari di Ludovico Carracci, tanto di bellezza e di sublimi-tà nelle pitture del Correggio, che portossi nei luoghi ov’erano, per istudiarle, e fatto ritorno, le di lui pitture poterono talvolta stare a fi anco di quelle del di-vino Correggio, tanto erasi riempito ed imbevuto di quella vivace e grandissima maniera. Facciano fede di questo le superbe pitture, che di lui si vedono in Mi-lano e in Genova, che sono le due città nelle quali à fatto più lunga dimora. Fac-ciane fede altresì quella che noi qui presentiamo, la quale dicesi dipinta in Mi-lano poco tempo dopo che fu ritornato da Parma, e che tanto più degna di sti-ma quanto che il vasto talento di questo pittore, non valendo a restringersi en-tro angusti limiti, non poté risolversi mai a lavorare in piccolo. Può giudicarsi del suo valore dal quadro, che qui presentiamo, il quale è a Dresda venuto dal-la casa Belgiojosi di Milano.
Il resoconto della vicenda biografi ca del pittore mostra ancora una vol-ta, come avviene nel testo, già menzionato, di Dezallier D’Argenville, un deciso legame con la Felsina Pittrice, ma il dato forse più signifi cativo che la lettura di De Heineken offre del percorso di Giulio Cesare è l’interes-sante parallelo con Ludovico Carracci, soprattutto riguardo alla comu-ne ‘devozione’ rivolta a Correggio. Di fatto, questa attestazione giunge quindi a riprova della centralità del testo di Malvasia per la conoscenza dell’artista bolognese.
Sebbene assai signifi cativa, la Sacra Famiglia non era l’unica opera del maestro presente in questa raccolta: a seguito della vendita di Francesco III d’Este a Federico Augusto III di Sassonia, nel 1746, dei cento dipin-
39 Incisione di Giuseppe Camerata su disegno di Charles-François Hutin, C.H. De Hei-neken, Recueil d’estampes d’après les plus célèbres tableaux de la Galerie Royale de Dresde, 2 voll., Dresde 1753-1757, I, 1753, n. 17. Il testo è presentato sia in francese sia in italiano. Per la realizzazione dei volumi, M. Shuster, Remarks on the development of the Recueil d’estampes d’après les plus célèbres tableaux de la Galerie Royale de Dresde by Carl Heinrich von Heineken 1753 and 1757, in C. Hattori - E. Leutrat - V. Meyer (a cura di), À l’origine du livre d’art. Les recueils d’estampes comme entreprise éditoriale en Europe (XVI-XVIII siècles), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2010, pp. 153-167.
198 ODETTE D’ALBO
ti più importanti della quadreria dei duchi di Modena, giunse a Dresda anche il Ratto di Elena [fi g. 7], perduto durante i bombardamenti del 194540. In aggiunta all’illustre provenienza al momento dell’approdo in Germania, è forse possibile ricostruire con maggior precisione la storia materiale di questa prova del pittore: un «quadro grande del rapimen-to d’Elena» viene infatti citato nel 1625 nell’inventario redatto alla mor-te di Procaccini41 e fi gura in uno dei lotti nei quali Cerano, nel 1627, di-vise tra le fi glie e la moglie del pittore le opere rimaste nella sua botte-ga42. Alla luce di recenti ritrovamenti documentari è forse possibile con-fermare la proposta, già formulata da Pevsner nel 192943, di identifi care il dipinto ricordato nello studio di Giulio Cesare con quello giunto in se-guito nel capoluogo sassone: è infatti plausibile che si tratti della tela di notevoli dimensioni che solo sette anni dopo la richiamata spartizione dei dipinti tra le eredi dell’artista, vale a dire nel 1635, venne comprata da Francesco I d’Este su indicazione dell’abate Roberto Fontana, il suo agente nello Stato di Milano. Le dinamiche e l’occasione dell’acquisto sono state approfondite di recente da Maria Cristina Terzaghi44: il fra-tello di Fontana aveva sposato una nobildonna milanese, rimasta vedova in giovane età, «imparentata con molte principali famiglie di questa cit-tà ed in particolare con i signori Visconti e Serbelloni». Con l’intento di pagare la dote alla sorella, il cognato del fratello di Fontana mise in ven-
40 Olio su tela, 265 × 250 cm. Si veda J. Winkler, La vendita di Dresda, Panini, Modena 1989, p. 261.41 ASMi, Notarile 27634, notaio Melchiorre Appiani quondam Francesco, 19 novembre 1625, pubblicato, per la parte relativa ai dipinti, in Brigstocke, Procaccini in America, pp. 134-135.42 ASMi, Notarile 27634, notaio Melchiorre Appiani quondam Francesco, 15 gennaio 1627, reso noto in V. Caprara, Nuovi reperimenti intorno ai Procaccini, «Paragone», 28 (1977), 333, pp. 98-99.43 N. Pevsner, Giulio Cesare Procaccini, «Rivista d’arte», 11 (1929), pp. 346, 353. Nell’ulti-mo inventario di Giovan Carlo Doria, redatto dopo il 1625 ed entro il 1641, è citato un dipinto di questo soggetto (V. Farina, Giovan Carlo Doria promotore delle arti a Genova nel primo Seicento, Edifi r, Firenze 2002, p. 209, n. 264) che Hugh Brigstocke ha proposto, con molta cautela, prima di identifi care con una variante del dipinto di Dresda (Brigstocke, Giulio Cesare Procaccini [1574-1625], p. 53) e poi con l’opera stessa (Brigstocke, Procac-cini in America, p. 48). Si tratta invece di due versioni distinte dello stesso soggetto, dal momento che il Rapimento di Elena già di Giovan Carlo Doria compare nell’inventario del fi glio Agostino nel 1641 (Farina, Giovan Carlo Doria promotore delle arti a Genova nel primo Seicento, p. 228, n. 377), quando l’altra versione era già a Modena dal 1635.44 L’acquisto del Procaccini venne indicato in J. Southorn, Power and display in the seven-teenth century. The arts and their patrons in Modena and Ferrara, Cambridge University Press, Cambridge 1988, p. 44, in seguito precisato in M.C. Terzaghi, Regesto, in F. Frangi (a cura di), Francesco Cairo, Allemandi, Torino 1998, pp. 315, 328. Nonostante le ricerche, non mi è stato ancora possibile identifi care la famiglia con la quale si imparentò quella del Fontana.
SULLA FAMA DEL «CORREGGIO INSUBRE» 199
dita, nel 1634, alcune opere della sua raccolta, tra le quali, ancora con le parole dell’abate, un «quadrone grande assai, di fi gure dal naturale, ori-ginal vero di Giulio Cesare Procaccino, pittore già in queste parti molto celebre e famoso»45. Che si trattasse di un «rapto d’Helena» viene speci-fi cato solo nell’inventario dei dipinti inviati al duca nel 163546, che con-tiene anche la spesa per il trasporto dell’ingombrante tela, portata a Mo-dena a spalla da due facchini.
In anni non troppo lontani dalla vendita di Dresda, anche Federi-co il Grande di Prussia, tra i più aggiornati collezionisti dell’Europa del Settecento, si procurava il Cristo e l’adultera [fi g. 8] di Giulio Cesa-re. Esposto nella grandiosa Bildergalerie presso la residenza di Sanssou-ci a Potsdam, non lontano da Berlino, fi n dal 176347, l’ingresso della te-la nella raccolta può risalire fi no al 1754, anno nel quale Federico ini-ziò a servirsi dell’agente Johann Ernst Gotzkowsky48 per l’acquisizione di dipinti in vista dello scenografi co allestimento della galleria. Un docu-mento di spedizione delle opere, non datato, informa che il Cristo e l’a-dultera venne pagato, insieme alla Leda con il cigno di Ludovico Pozzoser-rato49, 4800 talleri50. Intorno al 1769 anche da questa prova di Procacci-ni venne tratta un’incisione51 [fi g. 9], ma il consenso goduto dal dipinto si comprende anche attraverso una fonte che precede la stampa di tra-duzione, vale a dire l’Examen critique des différentes ecoles de peinture, pub-blicato nel 1768, nel quale Jean Baptiste de Boyer d’Argens, ciambella-no di Federico il Grande, menziona la tela di Procaccini a chiusura di un breve resoconto biografi co basato ancora una volta, come a questo pun-to non stupisce, sulle indicazioni contenute nella Felsina Pittrice. Ripor-tiamo le signifi cative considerazioni riguardanti il dipinto:
45 Questa citazione e la precedente sono tratte dalla stessa lettera, citata in Southorn, Power and display in the seventeenth century, pp. 44, 160, nota 37 e parzialmente trascritta da Terzaghi, Regesto, p. 328. ASMo, Cancelleria Ducale. Ambasciatori. Milano, cart. 105, 13 settembre 1634.46 ASMo, Archivio per Materie, Arti Belle, b. 18/2, 15 aprile 1635, in Terzaghi, Regesto, p. 328.47 Olio su tela, 130,5 × 108,5 cm. A.N. Bauer in H. Dorgerloh (a cura di), Die Schönste der Welt. Eine Wiederbegegnung mit der Bildergalerie Friederichs des Großen, catalogo della mostra, Deutscher Kunstverlag, Berlin - München 2013, p. 50, n. 50, p. 158, n. 58.48 N.S. Schepkowsky, Johann Ernst Gotzkowsky. Kunstagent und Gemäldesammler im friderizia-nischen Berlin, Akademie Verlag, Berlin 2009, p. 72.49 L’opera, perduta, è nota attraverso una riproduzione fotografi ca, Bauer in Dorgerloh (a cura di), Die Schönste der Welt, p. 52, n. 74.50 Schepkowsky, Johann Ernst Gotzkowsky, p. 465.51 Incisione di Johann Gottfried Seuter su disegno di Johann Conrad (?) Krüger, G. Bar-toschek - S. Hüneke in C. Sommer (a cura di), Die Bildergalerie in Sanssouci. Bauwerk, Sammlung und Restaurierung, Skira, Milano 1996, p. 224.
200 ODETTE D’ALBO
La composition de Cesar Procaccini a beaucoup de noblesse, et il a trouvé sou-vent le secret de placer avec gout, dans une toile de médiocre grandeur, plu-sieurs fi gures de grandeur humaine, sans qu’elles paroissent ni gênées, ni dis-gracieuses. Parmi les tableaux que le Roi de Prusse a de ce peintre il y en a un dans la grande galerie de Sans-souci, qui représente la Femme adultere où l’on voit combien Procaccini a pu exécuter de grandes compositions, et placer dans une toile de médiocre grandeur plusieurs fi gures de grande nature. Au mérite de la composition, ce tableau joint celui de toutes les qualités que possedoit Ju-les Procaccini: le dessein, la couleur et un pinceau facile et hardi52.
Nell’introdurre all’opera, d’Argens fa perno sulla piacevolezza della composizione, nella quale le fi gure a grandezza naturale sono inserite con grazia all’interno di uno spazio di non ampie dimensioni, ma non manca neppure di sottolineare le qualità del disegno, del colore e dell’e-secuzione pittorica.
Rifl ette invece i lunghi viaggi in Europa e in Italia del generale John Guise l’ingresso nella sua raccolta della Susanna con i vecchioni di Procac-cini [fi g. 10]53, da lui donata alla Christ Church di Oxford nel 1765. Già documentata nella dimora londinese di Guise nel 176154, la grande te-la compare sotto il nome di Agostino Carracci, comunque indicativo di una lettura in chiave emiliana, che l’ha accompagnata fi no alla restitu-zione a Giulio Cesare nel 196755. Non sono note le vicende attraverso le quali la Susanna giunse presso il generale, ma un’opera di questo sog-getto e di dimensioni compatibili con quella oggi nella prestigiosa isti-tuzione inglese viene menzionata nell’inventario di Amedeo Dal Poz-zo56, marchese di Voghera e cugino del più noto Cassiano redatto entro il 1644. In assenza di ulteriori riscontri che possano confermare questa
52 J.B. de Boyer d’Argens, Examen critique des différentes ecoles de peinture, Berlin 1768, pp. 311-312. Il passo relativo all’opera è riportato in Schepkowsky, Johann Ernst Gotzkowsky, p. 390.53 Olio su tela, 200 × 125,5 cm. Photograph by permission of the Governing Body of Christ Church, Oxford.54 London and its Environs described, printed for R. and J. Dodsley, 6 voll., London 1761, III, p. 27.55 J. Byam Shaw, Paintings by old masters at Christ Church Oxford, Phaidon, London 1967, pp. 98-99. 56 «Susana nuda sotto la fontana coi doi vechi di Giulio Cesare Procacino, alta rasi tre e un terzo, larga doi rasi et un quarto, cornise dorata», citato in A. Cifani - F. Monetti, “L’illu-strissimo cugino”: Cassiano e Amedeo Dal Pozzo. Le relazioni artistiche del Marchese di Voghera e la storia della sua quadreria, in F. Solinas (a cura di), I segreti di un collezionista. Le straordinarie raccolte di Cassiano Dal Pozzo 1588-1657, De Luca Editore, Roma 2001, p. 45, n. 148. Il raso sabaudo corrisponde indicativamente a 60 cm (A. Martini, Manuale di Metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli, Torino 1883, p. 834), quindi il dipinto Dal Pozzo misurava circa 200 × 135 cm e potrebbe corrispondere, sotto questo aspetto, alla tela di Oxford, che sembra essere stata rifi lata ai lati.
SULLA FAMA DEL «CORREGGIO INSUBRE» 201
ipotesi, un labile indizio a favore della provenienza piemontese potreb-be venire dalla presenza, presso il Museo di Chambéry, città territorial-mente legata ai domini dei Savoia fi no al 1860, di una copia della tela57, della quale però non si conosce la provenienza.
Con questi cenni riguardanti la raccolta del generale inglese si chiu-de il resoconto riguardante i dipinti di Procaccini nelle collezioni di An-tico Regime: a seguito della cesura causata dalla Rivoluzione francese e della traumatica dispersione di opere d’arte che ne seguì, è possibile ri-prendere il fi lo rosso della ricerca sulla fortuna di Giulio Cesare all’in-terno del più ampio contesto delle requisizioni napoleoniche destinate al Museo del Louvre58. Come è stato già evidenziato, la maggior parte dei membri della Commission Temporaire des Arts, costituita da Napo-leone nel 1794 al fi ne di riconoscere le testimonianze artistiche di mag-gior valore da requisire nelle terre conquistate dalle sue truppe per spe-dirle in Francia, nominata, per quanto riguarda l’Italia, l’11 maggio del 1796, era composta da artisti, architetti, musicisti o fi gure di formazio-ne diversa che avevano però avuto contatti con il nostro paese59. Nello svolgimento del loro compito, i commissari si giovavano sia della lettera-tura artistica in italiano, in particolare le Vite di Vasari, la Storia Pittorica di Lanzi e le Notizie dei professori del disegno di Baldinucci60, ma anche del-le guide redatte da stranieri, quali, ad esempio, l’accurato Voyage d’Italie di Charles-Nicolas Cochin, edito 1758 e ristampato nel 1773, e il Voyage d’un français in Italie di Joseph-Jérôme de Lalande, apparso nel 176961.
Ad indicare i ritmi serrati con i quali una parte consistente del no-stro patrimonio artistico venne convogliato a Parigi, il 25 maggio 179662, quindi a ridosso dell’incarico dato alla commissione, partiva da Parma lo Sposalizio della Vergine [fi g. 11] realizzato da Giulio Cesare per la chie-
57 Olio su tela, 219 × 139 cm (n. inv. M659), ringrazio Nelly Kadiebue per le informazioni sul dipinto.58 Per una visione generale sulle requisizioni napoleoniche, P. Wescher, I furti d’arte. Napoleone e la nascita del Louvre, Einaudi, Torino 1988. In particolare, sull’Italia, M.L. Blu-mer, Catalogue des peintures transportées d’Italie en France de 1796 a 1814, «Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français», 1936, 2, pp. 244-348, per le opere di Procaccini, p. 297.59 Sull’attività della commissione si rimanda a L. Blumer, La commission pour la recherche des objets de sciences et des arts en Italie 1796-1797, «La Révolution Française», 87 (1934), 1, pp. 62-88, 124-150, 222-259, sulle requisizioni a Milano, pp. 78-79.60 S. Sicoli, La dispersione del patrimonio artistico nell’età delle soppressioni con riguardo a Man-tova e a San Benedetto Po, in P. Piva - R. Simonelli (a cura di), Storia di San Benedetto Poliro-ne. L’età della soppressione, Patron, Bologna 2001, p. 109.61 In Wescher, I furti d’arte, p. 59.62 Parma, Biblioteca Soprintendenza Beni Storico e Artistici, Note des tableaux et des antiques des Stato de Parme trasportées á Paris par le Gouvernement Français.
202 ODETTE D’ALBO
sa cittadina della Steccata63. Alcuni anni più tardi, nell’ambito della rior-ganizzazione seguita al periodo delle grandi confi sche in tutta Europa, che prevedeva anche l’invio di dipinti presso i musei della nuova grande provincia francese, l’opera, secondo quanto si apprende dall’epistola-rio di Dominique Vivant Denon64, rischiò di essere inviata a Digione nel 1809, ma poi, a seguito della richiesta da parte del direttore del museo della Pentecoste di Van Dyck65, la grande tela di Procaccini rimase a Pari-gi e rientrò nelle raccolte parmensi nel 1816.
Una sorte differente toccò invece al San Sebastiano curato dagli ange-li [fi g. 12]66, al quale abbiamo accennato in apertura citando le parole d’elogio di Carlo Bianconi, già in Santa Maria presso San Celso e ora ai musei di Bruxelles. L’imponente tavola vi pervenne nel 181167 a segui-to dell’invio di una seconda tranche di opere dalla capitale francese, dal momento che il Belgio era stato conquistato dalle truppe napoleoniche nel 1794. Procedendo con ordine, è bene sottolineare che il dipinto, commissionato nel 160968 e saldato nel 161169, fu l’unico prelevato dal santuario milanese, che pure conservava capolavori di Paris Bordon, Ce-rano e Callisto Piazza, e fu consegnato ai francesi l’11 giugno 179670. In questa occasione mi è stato possibile reperire un promemoria71 che ri-
63 Olio su tela, 375 × 227 cm. Si veda N.W. Neilson, scheda, in Galleria Nazionale di Par-ma. Catalogo delle opere. Il Seicento, Franco Maria Ricci, Parma 1999, pp. 32-33. Fotografi a su concessione del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo - Galleria Nazionale di Parma.64 M.A. Dupuy - I. le Masne de Chermont - E. Williamson (a cura di), Vivant Denon, directeur des Musées sous le consulat et l’empire. Correspondance (1802-1815), 2 voll., Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris 1999, I, p. 584, n. 1646.65 Restituito nel 1815 al Re di Prussia, il dipinto si trova ora alla Bildergalerie di Potsdam, N. De Poorter, Van Dyck in Antwerp and London, in S.J. Barnes - N. De Poorter - O. Millar - H. Vey, Van Dyck. A complete catalogue of the paintings, Yale University Press, New Haven - London 2004, p. 44, n. I.28.66 Olio su tavola, 285 × 139 cm, in Rosci, Giulio Cesare Procaccini, pp. 70-71. Fotografi a © Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels/Photo d’art Speltdoorn & Fils, Brussels.67 Una copia del documento è conservata nel fascicolo relativo al dipinto presso i Musées Royaux des Beaux-Arts.68 ASDMi, Archivio di Santa Maria presso San Celso, Libro delle ordinazioni dal 9 gennaio 1600 al 24 aprile 1611, 31 maggio 1609, citato da S. Vigezzi, I primi anni di attività di Giulio Cesare Procaccini, «Rivista d’arte», 15 (1933), p. 487.69 Trascritti in G. Berra, L’attività scultorea di Giulio Cesare Procaccini, NED, Milano 1991, p. 125.70 ASDMi, Archivio di Santa Maria presso San Celso, Chiesa. Pittura e scultura. Fatture 1570-1690, cart. 16. La data è attestata grazie alla ricevuta di prelievo della pala, fi rmata dai pittori Jacques Tinet e Jean Berthelemy, entrambi membri della Commission Temporaire des Arts, in Sicoli, La dispersione del patrimonio, pp. 110-111.71 ASDMi, Archivio di Santa Maria presso San Celso, Chiesa. Pittura e scultura. Fatture 1570-1690, cart. 16. Segue la trascrizione della lettera: «1796 Pro memoria. Nell’anno 1796 il giorno 11 del mese di Giugno a mezzogiorno vennero nella chiesa di N[ostra] S[ignora]
SULLA FAMA DEL «CORREGGIO INSUBRE» 203
assume le modalità della requisizione: nella data già richiamata, due pit-tori francesi, con ogni probabilità Jacques Tinet e Jean Berthelemy72, si recarono nel santuario guidati dal milanese Giuseppe Gerli73 – seguen-do quindi la prassi, accertata in altri casi, che vedeva gli emissari di Na-poleone accompagnati da ‘informatori’ locali74 – e, dopo aver mostrato un’ordinanza del commissario Antoine Christophe Saliceti, visitarono la chiesa decidendo di prelevare solo il San Sebastiano, giudicata «opera tra le più belle» di Giulio Cesare. Nei giorni successivi la tavola venne re-staurata dallo stesso Gerli e fu portata in casa Greppi, dove alloggiava Sa-liceti75, per essere spedita a Parigi.
Oltre alla scelta, già di per sé eloquente, operata dagli incaricati fran-
presso San Celso due pittori francesi serviti dal Sig[nor] Gius[epp]e Gerli Pittore Mila-nese, ed avendo fatto chiamare il M[olto] R[everendo] D[on] Elia Bertolio Prefetto e Parroco di d[ett]a Chiesa, gli hanno presentato un ordine in scritto del Commissario francese Salicetti [sic], in cui ordinava ai detti pittori di visitare tutti li Quadri preziosi nelle ancone in d[ett]a Chiesa, e scegliere quelli che più essi stimavano, e di consegnare li d[ett]i quadri. Visitati, ed esaminati tutti i quadri fu scelto il solo rappresentante il martirio di S[anto] Sebastiano opera delle più belle fatte da Giulio Cesare Procaccino il quale pochi giorni fu fatto nettare e posto in nuovo dallo stesso sud[ett]o Gerli, e fatto levare dagli uomini che avevano con loro li d[ett]i Pittori, fu trasportato in casa Greppi, e consegnato allo stesso Salicetti, e da esso subito spedito a Parigi con altri quadri stac-cati d’altre Chiese. Avendo li stessi pittori fatto il confesso di ricevuta, e consegnato al sud[ett]o R[everendo] Prefetto, il quale partecipò l’occorrente all’Amministrazione, e da essa fatto riporre d[ett]o confesso in archivio tutt’ora esistente. Il s[udett]o quadro fu trasportato, e riposto in quest’ancona presso la porticina della nave laterale alla destra entrando in chiesa, e tutto ciò seguì anche in presenza non solo del R[everendo] Signor Prefetto ma anche di me sotto[scritto] Agente della V[eneranda] Fabbrica. Sott[oscritto] Gio[van] Ant[oni]o Cassano Ag[ent]e». Nello stesso fascicolo si conserva inoltre una lettera, datata 30 gennaio 1811, nella quale l’Amministrazione della Fabbrica chiedeva la restituzione del dipinto.72 I loro nomi non compaiono nella relazione, ma è molto probabile che si tratti di questi due artisti, dal momento che risultano fi rmatari della ricevuta redatta in occasione del prelievo della pala, vedi nota 70.73 Si tratta di Giuseppe o di Carlo Giuseppe Gerli, entrambi fratelli del più noto Agosti-no, per i quali si rimanda a D. Melani, Gerli, Agostino, in DBI, 53, 1999, pp. 434-436. Se Giuseppe è noto per gli interessi nell’ambito della chimica e della meccanica, ma non abbiamo sue notizie in merito al campo artistico, Carlo Giuseppe fu, a partire dal 18 febbraio 1797, membro della Commission Temporaire des Arts (Blumer, La commission, p. 124). Per aggiornamenti su Agostino e Carlo Giuseppe si rimanda a S. Mara, Agostino Gerli: un artista-mercante per Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone e Carlo Camillo Carcano, in A. Squizzato - E. Bianchi - S. Campagnolo - M. Marubbi (a cura di), Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone (1761-1842) collezionista cremonese nella Lombardia asburgica, Atti del convegno, in pubblicazione.74 Sicoli, La dispersione del patrimonio, p. 113.75 E. Puccinelli, Greppi, Paolo, in DBI, 59, 2002, p. 336. Si tratta, con ogni probabilità, di palazzo Greppi in via S. Antonio, già sede della collezione di Antonio Greppi – padre del Paolo Greppi che compare nel profi lo citato – per la quale si rimanda a E. Bianchi, La collezione di Antonio Greppi, «Archivio storico lombardo», 122 (1996), pp. 275-313.
204 ODETTE D’ALBO
cesi, si rivela indicativa del buon nome goduto da Procaccini l’incisione tratta dal San Sebastiano [fi g. 13] che compare nel primo tomo de La Gale-rie du Louvre, représentée par des gravures à l’eau forte exécutées par Madame Ma-ria Cosway, dedicato ai capolavori italiani e pubblicato nel 180276, parte di una grandiosa opera in folio che doveva contenere le riproduzioni dei dipinti secondo l’allestimento del museo e, per ciascuno di essi, una bre-ve descrizione. Realizzata su disegno della pittrice inglese Maria Cosway, l’acquaforte restituisce la posa serafi ca e sensuale del santo traducendola in linee inquiete e spezzate, in chiave quasi visionaria, alla maniera di Jo-hann Heinrich Füssli, per indicare il punto di riferimento dello stile del-la Cosway, ben inserita, grazie al marito Richard, artista affermato, tra i maestri di sensibilità preromantica del contesto anglosassone77.
Se le vicende d’età napoleonica appena richiamate, che pure è stato possibile precisare, sono già note da tempo nella letteratura riguardan-te il pittore, non è stato considerato fi no ad ora, nella bibliografi a spe-cifi ca su Procaccini, l’acquisto sul mercato antiquario parigino da par-te di Ferdinando Marescalchi (1754-1816), nel 1813, di una Giuditta at-tribuita a Giulio Cesare. Residente a Parigi nelle vesti di ministro delle relazioni estere del Regno d’Italia78, questo importante uomo di stato, che solo due anni prima aveva acquistato i Quattro santi di Correggio ora al Metropolitan Museum di New York, aveva radunato una cospicua rac-colta di dipinti a Parigi, trasferendola poi a Bologna tra il 1812 e il 1814. Proprio in una lettera indirizzata, alla fi ne del 1813, all’incisore France-sco Rosaspina, il suo consulente artistico di riferimento, Marescalchi in-dicava di aver comprato79 una Giuditta di Procaccini. Già parte della col-lezione del pittore e mercante Jean Louis Laneuville (1748-1826), allie-vo di Jacques-Louis David, l’opera è evocata in questi termini nel catalo-go d’asta del novembre 1813: «La célèbre Judith, la tête ornée de pana-ches et richement vêtue, va mettre dans un sac que lui apporte un vieille femme, la tête de l’amoureux et trop confi ant Holopherne. Ce tableau est d’une teinte vigoureuse et sévère qui s’accorde parfaitement avec le
76 La Galerie du Louvre, représentée par des gravures à l’eau forte exécutées par Madame Maria Cosway avec une description historique et critique de chaque tableaux qui compose cette superbe collection et un abrégé biographique de la vie de chaque peintre par J. Griffi ths écuyer, Paris 1802, n. 28. Il progetto della Galerie, con i disegni originali dell’artista, è conservato presso la Fondazione Maria Cosway a Lodi.77 Per i coniugi Cosway si rimanda a T. Gipponi (a cura di), Maria e Richard Cosway, Alle-mandi, Torino 1998.78 Per un profi lo si rimanda a E. Pigni, Marescalchi, Ferdinando, in DBI, 70, 2008, pp. 59-62.79 18 novembre 1813, Biblioteca Comunale Forlì, Fondo Piancastelli, sezione Carte Ro-magna, 396/474. L’opera fi gura l’ultima volta nell’inventario Marescalchi nel 1824. La lettera che informa dell’acquisto, insieme alle informazioni sugli inventari, sono state segnalate in M. Preti Hamard, Ferdinando Marescalchi (1754-1816). Un collezionista italiano nella Parigi napoleonica, 2 voll., Minerva Edizioni, Bologna 2005, I, pp. 156-157, II, p. 131.
SULLA FAMA DEL «CORREGGIO INSUBRE» 205
sujet»80. All’interno del testo non sono purtroppo riportate né le misu-re, né indicazioni relative al supporto del dipinto, al momento diffi cil-mente identifi cabile81, ma la descrizione accurata, oltre a rendere con-to della qualità vivace della stesura pittorica, si sofferma sul copricapo di piume, sulla ricchezza dell’abbigliamento della protagonista della sce-na e sul gesto preciso di porre la testa di Oloferne all’interno di un sac-co retto, come vuole peraltro la tradizionale iconografi a, da una vec-chia serva. Sebbene la Giuditta oggetto di queste rifl essioni non sia l’uni-ca che fi gura sotto il nome di Procaccini nelle aste, soprattutto francesi, nel corso dell’Ottocento82, è bene tener presente che, allo stato attuale degli studi, sono note solo due versioni di questo soggetto ritenute auto-grafe di Giulio Cesare. Si tratta, in primo luogo, della magnifi ca Giudit-ta con la testa di Oloferne ora in raccolta privata americana e già parte del-la collezione genovese di Marco Antonio Doria83: se dal punto di vista iconografi co il riferimento a questo dipinto non sembrerebbe fuori luo-go, la diffi coltà nell’identifi cazione sorge soprattutto considerando che nell’opera già Launeville l’eroina biblica presenta un’acconciatura ca-ratterizzata da piume, dettaglio che non compare nella tela statunitense. La seconda versione è invece conservata dal 1878 al Castello Sforzesco di Milano, dove pervenne per dono del conte Carlo Castelbarco Viscon-ti Simonetta (1808-1880)84 e rappresenta il momento, assai truculento, dell’uccisione di Oloferne, al quale Giuditta, che si volge brandendo la spada verso la serva, ha reciso solo parzialmente il capo, soluzione com-positiva che mostra quindi di differire in maniera sensibile dalla descri-zione dell’opera Marescalchi.
Lasciando ora alle spalle i protagonisti dell’epopea napoleonica85 e
80 Catalogue d’une précieuse collection de tableaux de trois écoles, catalogo asta Revenaz, 14-15 novembre 1813, Revenaz, Paris, p. 7, n. 7.81 Non potendo oltretutto contare su tracce visive dell’opera, l’identifi cazione con un dipinto autografo di Giulio Cesare deve essere molto prudente, come avviene sempre, peraltro, nello studio degli inventari delle collezioni. 82 Grazie al Getty Provenance Index Database, mi è stato possibile riunire alcuni dati su dipinti attribuiti al pittore raffi guranti questo soggetto (asta della collezione Lespinasse de Langeac, Parigi, 8 marzo 1808; asta della collezione Montignol, Parigi, 22-23 marzo 1816).83 Olio su tela, 133,9 × 99 cm. In Brigstocke, Procaccini in America, pp. 98-101.84 S. Coppa, scheda, in Museo d’arte antica del Castello Sforzesco. Pinacoteca. Tomo III, Electa, Milano 1999, p. 256. Per la collezione del Conte di Castelbarco si rimanda a Morandot-ti, Il collezionismo in Lombardia, pp. 92-93, 245-247. 85 Di notevole interesse risulta anche il fi lone di ricerca che riguarda la collezione di Eu-genio di Beauharnais (1781-1824), nella quale erano presenti alcune opere di Procaccini. In particolare, tra queste, la Deposizione di Cristo, attualmente al Museo Puškin di Mosca, proviene dalla raccolta milanese del generale Giovan Francesco Arese (1642-1721), come è stato possibile accertare grazie agli studi di Alessandro Morandotti. Su questi dipinti si
206 ODETTE D’ALBO
dei suoi fasti e muovendoci su terreni più certi, è possibile, in quest’oc-casione, confermare che la bella Sacra Famiglia con due angeli di Giulio Cesare, acquistata dal principe Albert nel 1845 e conservata presso la Royal Collection ad Hampton Court [fi g. 14]86, proviene dalla collezio-ne radunata da Giacomo Melzi (1722-1802), una delle più signifi cative nella Milano dell’età dei lumi. «La Beata Vergine genufl essa avente nel-la destra un fascetto di rose e nella sinistra il Santo Bambino che si sfor-za di alzarsi ad abbracciare la Madre, san Giuseppe all’indietro che sten-de la mano per presentare un frutto al Bambino; sulla sinistra due an-gioli in piedi. Sopra tavola per l’impiedi 18 × 24 once»87: così ci appa-re il dipinto nella descrizione dell’inventario del 1802 dei beni di Melzi, che l’aveva acquistata nel 1798. Passata successivamente in eredità a Gio-vanni Melzi d’Eril nel 1835, la Sacra Famiglia veniva indicata come per-duta da Giulio Melzi d’Eril nel 1973, mentre dieci anni dopo, John She-arman, nel suo catalogo delle opere italiane della collezione reale ingle-se, dava conto della provenienza dall’illustre famiglia lombarda, senza ulteriori precisazioni, sulla base di un cartellino apposto sul retro. Alla luce di queste informazioni è ora possibile confermare l’identifi cazione del dipinto già Melzi con quello ora presso la Royal Collection che corri-sponde infatti, nelle misure88, nel supporto e nell’iconografi a della Ma-dre in atto di reggere con delicatezza il Bambino, secondo una tipolo-gia compositiva cara alla produzione di Giulio Cesare, della quale fa fe-de, ad esempio, anche la Sacra Famiglia già Belgiojoso e ora a Dresda, già richiamata in queste pagine. Un’ulteriore conferma dell’originaria col-locazione viene anche dalla presenza, sul retro della tavola ad Hampton Court, del numero «53» vergato con un pennello, cifre che corrispon-dono a quelle con le quali l’opera compare nell’inventario di Giovanni Melzi d’Eril, stilato nel 1835, esattamente dieci anni prima del defi nitivo approdo della Sacra Famiglia in Inghilterra.
Questa panoramica che, attraverso alcuni casi esemplifi cativi, ha vo-luto aprire qualche spiraglio sull’amplissima fortuna di Giulio Cesare Procaccini nelle collezioni europee tra Seicento e Ottocento, si chiu-de, quasi circolarmente, con il Battesimo di Cristo della Galleria Naziona-
rimanda a Morandotti, Il collezionismo in Lombardia, pp. 84, 106 nota 38, 138, 146 note 28 e 29.86 Olio su tavola, 116,7 × 71,2 cm. J. Shearman, The early Italian pictures in the collection of her Majesty the Queen, Cambridge 1983, pp. 204-205.87 G. Melzi d’Eril, La galleria Melzi e il collezionismo milanese del tardo Settecento, Ed. Virgilio, Milano 1973, p. 136.88 La tavola misurava in origine, secondo la conversione delle once in metri (Martini, Manuale di Metrologia, p. 350) 118,8 × 89,1 cm circa ed è stata quindi decurtata ai lati di alcuni centimetri, come risulta evidente osservando che la manica dell’abito della Vergi-ne è stata tagliata.
SULLA FAMA DEL «CORREGGIO INSUBRE» 207
le di Bratislava89 [fi g. 15], che abbiamo già indicato all’inizio di questa rassegna tra le tele già probabilmente parte della raccolta del governa-tore spagnolo Pedro de Toledo. Pur considerando la raffi nata esecuzio-ne pittorica, questo dipinto è stato piuttosto trascurato nel dibattito cri-tico relativo al pittore, ma merita invece attenzione perché è attestato in una delle più rinomate collezioni mitteleuropee dell’Ottocento, quella radunata dal conte ungherese János Pálffy (1829-1908), divisa tra i palaz-zi di Parigi, Budapest, Vienna e le residenze a Bratislava e nei suoi din-torni. Nel 1909 l’opera è infatti ricordata, con la corretta attribuzione a Giulio Cesare, nella dimora del conte a Král’ová Pri Senci90, non lonta-no dalla capitale slovacca, dove Pálffy aveva deciso di collocare i dipinti del Seicento e del Settecento. Allo stato attuale degli studi non sono no-te le dinamiche di ingresso della tela di Procaccini nella raccolta, ma al-cune importanti ricerche condotte in anni recenti91 hanno indicato co-me il conte acquistasse sia in Italia, sia nelle grandi capitali quali Parigi, Londra e Vienna. Con il Battesimo di Cristo siamo quindi giunti alle soglie del Novecento: il sopraggiungere del nuovo secolo apre un’altra pagina nella fortuna delle opere di Giulio Cesare, che riguarda soprattutto si-gnifi cative acquisizioni da parte di istituzioni museali in gran parte bri-tanniche e americane ma anche, come è accaduto in anni molto recen-ti e già nel nuovo millennio92, australiane.
89 Reso noto in L. Konecný, Due segnalazioni per Giulio Cesare Procaccini, «Paragone», 36 (1986), 441, pp. 59-60; pubblicato di recente in Z. Ludikova, in Ead. (a cura di), Ta-lianska mal’ba/Italian Painting, catalogo della mostra, Slovak National Gallery, Bratislava 2013, pp. 96-99.90 Néhai nagyméltóságú Erdodi Gróf Pálffy János valóságos belso titkos tanácsos, cs. és kir. kamarás, Pozsony vármegye örökös fo ispánja, Bajmócz örökös ura és a forendiház örökös jogú tagja királyfai kastélyában található festmények, miniatureök és grafi kai lapok jegyzéke a vonatkozó leltári és becslési adatokkal, Budapest 1909, p. 43, n. 78.91 H. Horváth, The collection of Count János Pálffy. Summary of the PhD thesis, Adria-Typo Co., Budapest 2002, pp. 10-19, nel quale si sottolinea che a Milano Pálffy era in contatto con l’antiquario Giuseppe Baslini, fi gura chiave del mercato artistico della capitale lom-barda nel corso dell’Ottocento (per il quale si rimanda a A. Zanni, Dedicato a Giuseppe Baslini [1817-1887], in F. Flores D’Arcais - M. Olivari - L. Tognoli Bardin, Arte lom-barda del secondo millennio. Saggi in onore di Gian Alberto Dell’Acqua, Federico Motta Editore, Milano 2000, pp. 270-275). Sulla collezione si veda anche I. Ciulisová, Art collecting of the Central-European aristocracy in the nineteenth century. The case of Count Pálffy, «Journal of the history of collection», 18 (2006), 2, pp. 201-209.92 La Deposizione con la Maddalena e Sant’Agostino è stata acquisita nel 2005 dalla National Gallery of South Wales di Sydney (reso noto in Brigstocke, G.C. Procaccini et D. Crespi, p. 35, fi g. 17).
208 ODETTE D’ALBO
1. Giulio Cesare Procaccini, Madonna con il Bambino, san Giovannino e un angelo, Monaco di Baviera, Alte Pinakothek.
2. Anatole Alfred Théodore (?) Delangle su disegno di A.(?) Paquier (da Giulio Cesare Procaccini), Madonna con il Bambino, san Giovannino e un angelo, in G.-J. de Cosnac, Les richesses du Palais Mazarin, Paris 1884, p. 291.
SULLA FAMA DEL «CORREGGIO INSUBRE» 209
3. Giulio Cesare Procaccini, Sacra Famiglia con sant’Elisabetta e san Giovannino, Schleissheim, Neues Schloss (collezioni della Alte Pinakothek di Monaco di Baviera).
4. Christian von Mechel su disegno di Joseph August Brulliot (da Giulio Cesare Procaccini), Sacra Famiglia con sant’Elisabetta e san Giovannino, in N. de Pigage - C. von Mechel, La Galerie Electorale de Dusseldorf, Basel 1778, n. 140.
210 ODETTE D’ALBO
5. Giulio Cesare Procaccini, Sacra Famiglia con due angeli, Dresda, Gemäldegalerie.
6. Giuseppe Camerata su disegno di Charles-François Hutin (da Giulio Cesare Procaccini), Sacra Famiglia con due angeli, in H. De Heineken, Recueil d’estampes d’après les plus célèbres tableaux de la Galerie Royale de Dresde, I, Dresde 1753, n. 17.
SULLA FAMA DEL «CORREGGIO INSUBRE» 211
7. Giulio Cesare Procaccini, Ratto di Elena, già Dresda, Gemäldegalerie.
212 ODETTE D’ALBO
8. Giulio Cesare Procaccini, Cristo e l’adultera, Potsdam, Schloss Sanssouci, Gemäldegalerie.
9. Johann Gottfried Seuter su disegno di Johann Conrad (?) Krüger (da Giulio Cesare Procaccini), Cristo e l’adultera, collezione privata.
SULLA FAMA DEL «CORREGGIO INSUBRE» 213
10. Giulio Cesare Procaccini, Susanna con i vecchioni, Oxford, Christ Church Pic-ture Gallery.
214 ODETTE D’ALBO
11. Giulio Cesare Procaccini, Sposalizio della Vergine, Parma, Galleria Nazionale.
SULLA FAMA DEL «CORREGGIO INSUBRE» 215
12. Giulio Cesare Procaccini, San Se-bastiano curato dagli angeli, Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts.
13. Julius Griffi ths su disegno di Maria Cosway (da Giulio Cesare Procaccini), San Sebastiano curato dagli angeli, in La Galerie du Louvre, Paris 1802, n. 28.
216 ODETTE D’ALBO
14. Giulio Cesare Procaccini, Sacra Famiglia con due angeli, Hampton Court, Royal Collection © Her Majesty Queen Elizabeth II.













































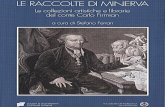


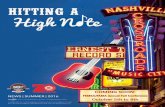

![Strumenti musicali nelle collezioni siciliane [Musical instrumentas in Sicilian collections], in Strumenti musicali in Sicilia, ed. by G. P. Di Stefano, S. G. Giuliano, S. Proto, Palermo,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63377df2d102fae1b607646b/strumenti-musicali-nelle-collezioni-siciliane-musical-instrumentas-in-sicilian.jpg)