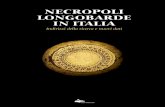Materiali per una storia del diritto in Italia meridionale. II. Tradizione, produzione e...
Transcript of Materiali per una storia del diritto in Italia meridionale. II. Tradizione, produzione e...
Direttori · EditorsMario Capasso · Giancarlo Prato
Comitato d’Onore · Honour BoardEsin Atil · Vasilis Atsalos · Antonio Bravo-García
Paul Canart · Ernst Gamillscheg · Francisco Gimeno BlayDieter Harlfinger · Louis Holtz · Birger Munk Olsen · Francis Newton
Giovanna Nicolaj · Colette Sirat
Comitato scientifico · Scientific BoardMalachi Beit-Arié · Carlo Carletti · Angel Escobar Chico · Pasquale Cordasco
Marco D’Agostino · Luisa D’Arienzo · Paola Davoli · Paola DegniGiuseppe De Gregorio · Flavia De Rubeis · Axinia Dzurova · Paolo Eleuteri
Maria Rosa Formentin · Christian Förstel · David GanzClelia Gattagrisi · Donald Jackson · Walter Koch
Judith Olszowy-Schlanger · Giulia Orofino · Paola OrsattiMauro Perani · †Paolo Radiciotti · Antonella Rovere
Alain Touwaide · Caterina Tristano
Comitato editoriale · Editorial BoardMarco D’Agostino (coordinatore) · Laura Albiero · Daniele Arnesano
Maria Clara Cavalieri · Corinna Drago · Paolo Fioretti · Natascia Pellé
«Scripta» is an International Peer-Reviewed Journal.The eContent is Archived with Clockss and Portico.
S C R I P TAAN INTERNATIONAL JOURNAL
OF CODICOLOGY
AND PALAEOGRAPHY
5 · 2012
PISA · ROMA
Fabrizio Serra editore
M M X I I
Amministrazione e abbonamentiFabrizio Serra editore®
Casella postale n. 1, succursale n. 8, i 56123 Pisa,tel. +39 050542332, fax +39 050574888, [email protected]
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabilipresso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.
Print and/or Online official subscription prices are availableat Publisher’s web-site www.libraweb.net.
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard)
Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa,tel. +39 050542332, fax +39 050574888,
Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, i 00185 Roma,tel. + 39 06 70493456, fax + 39 06 70476605,
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 21 del 14 giugno 2007Direttore responsabile: Fabrizio Serra
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti,per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm,
la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta dellaFabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.
Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
Proprietà riservata · All rights reserved
© Copyright 2012 by Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale,
Edizioni dell’Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa,Gruppo editoriale internazionale and Istituti editoriali e poligrafici internazionali.
Stampato in Italia · Printed in Italy
www.libraweb.net
issn 1971-9027issn elettronico 2035-2751
questo volume è dedicato alla memoria di paolo radiciotti (1961-2012),
cultore ed innovatore della paleografia sotto vari aspetti,
collaboratore sin dal primo numero della nostra rivista
SOMMARIO
Maria Luisa Agati, ¶·Ï·ÈÔÁÚ·ÊÈο. Supplemento ai copisti della Turcocrazia (1453-1600) e digrafismo meta-bizantino 11
Daniele Bianconi, Michele della lavra di Stilo. Qualche nuova attribuzione e considerazione 31
Antonio Ciaralli, Materiali per una storia del diritto in Italia meridionale. II. Tradizione, produzione e circo-lazione di testi di diritto romano giustinianeo in area longobardo-cassinese (secoli viii-xii) 43
Paola Degni, I documenti pubblici italogreci del periodo bizantino: qualche considerazione sugli atti pugliesi eil Brebion di Reggio 65
Teresa Martínez Manzano, Nuevos libros de Juan Páez de Castro en Salamanca 85
Outi Merisalo, The early tradition of the pseudo-Galenic De spermate (Twelfth-Thirteenth Centuries) 99
Martina Pantarotto, Per la biblioteca di Franchino Gaffurio: i manoscritti laudensi 111
Paolo Radiciotti, L’imitatio nelle scritture greche e latine 119
Indici «Scripta» · 5 · 2012 123
AbstractAlthough the historiography has always placed Irneriusand the school of Bologna at the center of the process thatled to the re-emergence of Roman law in the Middle Ages,an examination of the manuscripts that constitute themain surviving evidence tells a different and more com-plex story. Contemporary with Irnerius, and even earlierthan him, one finds multiple traditions witnessed by man-uscripts written in typified scripts such as romanesca andbeneventan. The subject of this essay is the tradition thatcirculated in southern Italy, which is one of the most im-portant of these “lost traditions”.
1.
prendere per buona la data del 554, solo quindi-ci anni separerebbero la definitiva estensione al-
l’Italia della normazione giustinianea dall’ingressonella regione dei Longobardi.1 Ma pure volgendo losguardo all’indietro per allargare la cronologia al periodo della restaurazione della Prefettura del preto-rio per l’Italia, certamente ricordata nel 538,2 e valu-tando che le modalità di penetrazione e stanziamentodegli invasori abbiano richiesto degli anni,3 rimarreb-be comunque esiguo il periodo di effettivo vigore go-
duto dal rinnovato e complesso sistema normativo im-periale nella Penisola. Quei pochi lustri trascorsi, tut-tavia, saranno determinanti per gli sviluppi futuri del-la storia giuridica europea, poiché consentiranno ailibri legales, ai codici cioè latori della legge, di giungerein Occidente (di essere inviati, almeno, in tutte quellecittà sedi di importanti sezioni dell’amministrazioneimperiale) e qui di rimanere.4 E se la calata longobar-da fu il colpo di grazia alle illusioni di una restaurazio-ne dell’autorità imperiale nelle province occidentali,essa si pose, dal punto di vista normativo, come una ce-sura discriminante. Mentre, infatti, nella Pars Orientisil progresso legislativo non si arrestò, ogni nuova leg-ge determinando – più per via di tacito assenso che perprecisa disposizione – la decadenza della precedente,nell’Italia, abbandonata al suo destino, avvenne unapiù marcata transizione da uno statuto giuridico, quel-lo romano, a altri e vari, tra i quali i barbarici, con solola chiesa a porsi quale garante di quanto rimaneva divitale, sotto tale aspetto, della romanità.
2.
Queste, nelle linee generali, le ragioni che giustifica-no la provenienza tutta occidentale dei relitti del nau-
* In memoria di Francesco Magistrale e Vincenzo Matera, ‘meri-dionalisti’. Il presente saggio è la prima parte di un più ampio contri-buto destinato a prossima pubblicazione.
** Università degli Studi di Perugia; [email protected].
1 O. Bertolini, Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi, Bologna1941, pp. 191-194. L’estensione della legislazione imperiale alle provin-ce italiane, formalmente recuperate nell’aprile del 553, ma in realtàancora per alcuni anni teatro di guerriglia gota e di precario control-lo statale, sarebbe avvenuta su richiesta di papa Vigilio con una pram-matica (in realtà un editto) promulgata, secondo quanto è noto, il 13agosto dell’anno 554 e inclusa in una serie piuttosto ampia di normetutte indirizzate al «riassetto amministrativo di Roma e dell’Italia»(ivi, p. 191). In realtà la norma, pervenutaci in forma epitomata e pre-sente in una appendix tradita da tre manoscritti e non inclusa nelleraccolte delle Novellae – cfr. M. Conrat, Geschiche der Quellen und Li-teratur des römischen Rechts im Frühen Mittelalter, Leipzig 1891, p. 131 –è chiara nello specificare che il corpus delle leggi era già stato estesoall’Italia e che ora era intenzione dell’imperatore di fare valere anchele norme successivamente promulgate: «Iura insuper vel leges codi-cibus nostris insertas, quas iam sub edictali programmate in Italiamdudum misimus, obtinere sancimus. Sed et eas, quas postea promul-gavimus constitutiones, iubemus sub edictali propositione vulgari»(ed. in R. Schöll-G. Kroll (hrsg.), Corpus iuris civilis, iii, Novellae,p. 800, § 11). Il riferimento è dunque alle novellae constitutiones poichéil grosso delle leggi (i codici) erano già stati imposti all’Italia con unprogramma edittale. La cosa era già chiara a Pietro Giannone che nescriveva nella sua Istoria civile del Regno di Napoli (pubblicata per la pri-ma volta a Napoli nel 1770, cfr. l. iii, cap. iv), ma si legga la chiaraesposizione contenuta in G. Ferrari delle Spade, La legislazione
dell’Impero d’Oriente in Italia, in «Atti del r. Istituto veneto di scienze,lettere ed arti» xcvi (1936-37), ii, pp. 171-202: 171-174. Si veda ancora R.Bonini, L’ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565), in G.G. Archi (ed.), Il mondo del diritto nell’epoca giustinianea. Caratteri eproblematiche, Ravenna 1985, pp. 139-171 (con rinvii alla precedente letteratura).
2 Così già F. A. Biener, Geschichte der Novellen Justinian’s, Berlin1824, p. 224; cfr. N. Tamassia, La Novella Giustinianea De praetore Si-ciliae, in Centenario della nascita di Michele Amari, ii, Palermo 1910, pp.304-331, poi in Studi sulla storia giuridica dell’Italia meridionale, Bari 1957,pp. 3-40; G. G. Archi, Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii, in Scritti,iii, Milano 1981, pp. 1971-2010.
3 Considerevole sarà stato il disinteresse da costoro mostrato, al-meno nei primi tempi, per gli aspetti amministrativi e legislativi delladominazione. L’approdo formale è ovviamente scandito dal 643, dataanche questa, però, da considerare con qualche elasticità, poiché la co-dificazione rotariana si configura come definitiva presa di coscienza diun problema già da tempo avvertito. I novanta anni di vacanza legi-slativa longobarda avranno pure consentito forme di sopravvivenzadella legislazione imperiale.
4 Quei territori «dove l’effettiva e diretta signoria politica bizantinanon si protrasse oltre il secolo viii, e perciò Venezia, l’Italia centrale(comprendente il Ducato Romano, l’Esarcato e la Pentapoli), la Sar-degna e la costa tirrena da Gaeta a Napoli, non avendo ricevuto nulla,o quasi nulla, dalla legislazione postgiustinianea, ebbero la funzionedi mantenere viva l’opera di Giustiniano e di trasmetterla al mondooccidentale», così F. Brandileone, L’Italia bizantina e la sua impor-tanza nella storia del diritto italiano, in Studi in onore di Pietro Bonfante,ii, Milano, 1930 poi in C. G. Mor (ed.), Scritti di storia giuridica del-l’Italia meridionale, Bari 1970, pp. 5-23: 15, ma vedi anche le pp. 5-6 e 12.
MATERIALI PER UNA STORIA DEL DIRITTOIN ITALIA MERIDIONALE. I I . TRADIZIONE, PRODUZIONE
E CIRCOLAZIONE DI TESTI DI DIRITTO ROMANO GIUSTINIANEOIN AREA LONGOBARDO-CASSINESE (SECOLI VIII -XII)*
Antonio Ciaralli**
A
44 antonio ciaralli
fragio normativo romano-giustinianeo: i rari palinse-sti, i pochi frammenti più o meno consistenti e, uniconella sua integrità, il manoscritto fiorentino dei Dige-sta. Queste, anche, le premesse per il relativo abban-dono del sistema o, per dirla con un termine che fucaro a Francesco Calasso, il suo volgarizzamento. Diqui, infine, intorno alle fasi aurorali, agli strumenti eai tramiti del suo recupero, la nascita di un noto teo-rema. Spesso pubblicate e con costanza ripetute sonole parole con cui Odofredo rievoca le origini dellascuola di diritto. Quei racconti, articolati intorno altrasmigrare di libri legales da Roma per la Pentapoli fi-no alla città felsinea su cui invano si è affaticata la cri-tica storica, rivelano, a ben guardare, una modulazio-ne che, all’apparenza secondaria, costituisce in realtàil fulcro dell’operazione narrativa del maestro bolo-gnese. Odofredo, infatti, sta ratificando con le sue fa-bulae il mito della fondazione: ecco allora chiarirsi ilcontinuo, insistito collegamento dei nostri libri e dellanostra scientia con la civitas ista,1 la Bologna ove egli in-segna e dove lo studium, intorno alla metà del xiii se-colo, ha stabilito la propria preminenza sulle altre se-di di elaborazione del diritto e mira ora, nel nobilitarele proprie origini, a giustificare e ratificare quel pre-dominio, gettando in tal modo le basi per una centra-lità che ancor oggi stenta a essere posta in discussio-ne. «Una mentalità collettiva – è stato scritto – prendeforma non solo dai fatti obbiettivamente vissuti, maancor più da come se li racconta: da come ha trasfor-mato gli eventi in memoria, la memoria in narrazio-ne, la narrazione in tradizione, la tradizione in identi-tà».2 Per la cultura occidentale il culto di Bolognaalma mater studiorum è ancora oggi precisamente que-sto: un mito identitario.3
Sul determinismo che guarda alla Bologna del xiiisecolo si è adeguata dunque, nelle sue linee generali,
la ricostruzione storica,4 cercando le tracce della rie-mersione del diritto romano dall’oblio alto medieva-le e, ovviamente, trovandole: da Marturi a Irnerio conla sua attività esegetica, non trascurando quella noneffimera schiera di giurisperiti e pratici del diritto dicui è costellata l’Italia centro-settentrionale (Toscanae Padania) sullo scorcio del secolo xi. Sebbene l’ireni-ca visione appaia storicamente determinatasi, e per-ciò stesso risulti a noi oggi ben comprensibile, quan-to è ancora in nostro possesso dimostra che le coseandarono diversamente e che quell’esito altro non è,se non la conseguenza della conquistata egemonia.Un predominio che ha spazzato via le tradizioni allo-trie, erasi e distrutti gli ormai inutili manoscritti chele tramandavano, dimenticata la loro esistenza: spet-ta alle ragioni della critica consentire che esse, ovepossibile, riemergano, rompendo il circolo chiusodell’egotismo bolognese.
3.
Una delle più importanti, ma anche la più negletta,fra le perdute tradizioni manoscritte dei testi giusti-nianei è quella che ha attraversato i comprensori storici e geografici che oggi siamo soliti indicare coltermine collettivo di Italia meridionale.5 Le pagineche seguono vorrebbero contribuire a una più ampiaconoscenza dei percorsi carsici compiuti dal dirittoromano nei secoli alto medievali nel nostro Mezzo-giorno.
Ma qui è opportuno fissare limiti e stabilire distin-zioni.6 Si è al cospetto, infatti, di un territorio fram-mentato e mosso nel quale coesistono, sin dal crollodell’unità politica, amministrativa e culturale dell’Im-pero romano, ripartizioni amministrative bizantine educati longobardi e dove poi i normanni, cuneo di-
1 «Or signori, dominus Irnerius fuit apud nos lucerna iuris, fuitenim primus qui docuit iura in civitate ista. Primo cepit studium essein civitate ista in artibus, et cum studium esse destructum Rome, li-bri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne et de Ravenna adcivitatem istam. De hoc studebantur in artibus libri legales, qui a civi-tate Ravenne fuerunt portati ad civitatem istam … Dominus Irneriusdocebat in civitate ista in artibus, cepit per se studere in libris nostriset studendo cepit velle docere in legibus. Et ipse fuit maximi nomi-nis et fuit primus inluminator scientie nostre», Odofredus, Lectura su-per Digestum vetus, 1.1.6, ma analogo il più breve passo a commentodi D. 35.2.82.
2 S. Levi Della Torre, Essere fuori luogo. Il dilemma ebraico tra dia-spora e ritorno, Roma 1995, p. 13.
3 La critica muove da R. W. Southern, Scholastic Humanism andthe Unification of Europe, i, Foundations, Oxford 1995, pp. 278-282 e èrecepita in J. Fried (mit einem Exkurs von G. Grebner), … “auf Bitten der Gräfin Mathilde”. Werner von Bologna und Irnerius, in K. Her-bers (hrsg.), Europa an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert. Beiträgezu Ehren von Werner Goez, Stuttgart 2001, pp. 171-206; A. Winroth,Les deux Gratien et le droit romain. In memoriam R. Weigand, in Le Décretde Gratien revisité. Hommage a R. Weigand, Strassbourg 1998 = «Revuede droit canonique» 48/2 (1998), pp. 285-298; Id., The Making of Gratian’s Decretum, Cambridge 2000, pp. 162-168; Id., The Teaching ofLaw in the Twelfth Century, in H. Vogt-M. Münster-Swendsen(eds.), Law and Learning in the Middle Ages. Proceedings of the SecondCarlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2005, Køben-havn 2006, pp. 41-62.
4 Con le dovute anticipatrici eccezioni tra le quali C. M. Radding,The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150, NewHaven-London 1988, seconda ed. riveduta e ampliata col titolo Le ori-gini della giurisprudenza medievale. Una storia culturale, Roma 2012.
5 Generale il silenzio intorno al tema se si esclude W. Kaiser, ZumAuf bewahrungsort des Codex Florentinus in Süditalien, in F. Theisen(hrsg.), Summe, Glosse, Kommentar: Juristisches und Rhetorisches in Kano-nistik und Legistik, Osnabrück 2000, pp. 95-124, un lavoro dedicato allastoria del manoscritto fiorentino delle Pandette, dov’è fatto cenno,con acume, all’interesse per il diritto romano in Italia meridionale.Non si trova accenno alla questione in G. Cavallo, La trasmissione deitesti nell’area beneventano-cassinese, in La cultura antica nell’Occidente la-tino dal vii all’xi secolo (Settimane di studio del cisam, xxii), i, Spoleto1975, pp. 357-414. Sulla presenza del diritto romano nel sud della Peni-sola cfr. Z. von Lingenthal, Il diritto romano nella Bassa Italia e lascuola giuridica di Bologna, in «Rendiconti del r. Istituto Lombardo» (26nov. 1885) s. ii, 18 (1885), pp. 894-899, ried. nelle Id., Kleine Schriften zurrömischen und byzantinischen Rechtsgeschichte. Sammlung der in Zeit-schriften und Serienwerken erschienenen selbständigen Abhandlungen 1840-1894, Bd. 2, Leipzig 1973, pp. 241-246. Del tutto generici R. Trifone, Ildiritto giustinianeo nel Mezzogiorno d’Italia, e F. Ciccaglione, Dirittogiustinianeo e diritto bizantino nell’Italia meridionale durante il Medioevo,entrambi in Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna-Roma, 17-27 aprile 1933), i, Pavia 1934, rispettivamente pp. 1-15 e pp. 17-32.Si vedano ancora F. Brandileone, L’Italia bizantina e la sua importan-za nella storia del diritto italiano, in Studi in onore di Pietro Bonfante, ii,Milano 1930, pp. 219-233; C. G. Mor, Considerazioni minime sulle istitu-zioni giuridiche dell’Italia Meridionale bizantina e longobarda, in L’ItaliaMeridionale nell’Alto Medioevo e i rapporti col mondo bizantino, Atti del iiiConvegno di studi sull’alto Medioevo, Benevento - Montevergine - Salerno -Amalfi 14-18 ottobre 1956, Spoleto 1959, pp. 139-152; N. Tamassia, Studisulla storia giuridica dell’Italia Meridionale, Bari 1959.
6 Per le difficoltà in merito a una precisa definizione territoriale sileggano le osservazioni di E. Condello, Una scrittura e un territorio.L’onciale dei secoli v-viii nell’Italia meridionale, Spoleto 1994, pp. ix-x.
materiali per una storia del diritto in italia meridionale 45
rompente prima e fattore unificante in seguito, im-primeranno un diverso volto istituzionale a tuttal’area. Al contempo intere regioni, come la Sicilia, opiù modeste enclaves subiranno per periodi più o me-no lunghi la dominazione araba, mentre altrove (peres. nella Benevento del dopo principato) si manifeste-ranno interessi diretti e concreti della Sede apostolica.Inevitabile, dunque, per realtà tanto varie, la coesi-stenza di differenti normazioni: dalla giustinianea al-le posteriori evoluzioni bizantine del diritto imperia-le, dalla longobarda alla normanna, a quella infineimperiale-germanica. Né andranno dimenticate, in si-mile contesto, le consuetudines locorum destinate benpresto a rivestire nella regione un ruolo di grande im-portanza.1 Da tali premesse deriva la restrizione,adottata per queste pagine, all’entità longobardo-cas-sinese identificativa di una comunione culturale ca-pace di collegare territori diversi e di escluderne altri(dentro, per es. la Puglia bizantina, ma fuori la Cala-bria, anch’essa bizantina, e la Sicilia, bizantina, arabae quindi normanna). Cartina di tornasole della “me-ridionalità” così intesa è la scrittura. Sarà proprio que-sta, interpretata come il concreto dispiegarsi dei sim-boli alfabetici, a porsi come fattore di inequivocaidentificazione, una volta che si prenda atto della pre-senza – dominante fino almeno a tutto il xii secolo –del canone grafico ormai stabilmente denominatobeneventano, di quell’Italia che ora, senza tema diequivoco, potremmo definire francamente meridio-nale.2 Il riferimento a una scrittura canonizzata e isolata rispetto alle altre esperienze grafiche coeveconsente, infatti, un’attribuzione geografica dei testi-moni pur munita di qualche fondamento, alleviandole aporie che possono riscontrarsi quando all’aspetto
propriamente scrittorio è attribuita una centralitànon altrimenti discutibile. Non vi è chi non colga, inverità, il fatto che uomini e libri hanno sempre circo-lato molto e che, dunque, la presenza in un mano-scritto di un testo vergato, per esempio, in scritturabeneventana, o in una grafia che mostri con questa affinità, non implica necessariamente l’origine meridionale di quel libro, né, a stretto rigore, che ilvolume abbia soggiornato in territori appartenentiall’areale di diffusione di quel tipo grafico. Fa aggiosull’intera questione, tuttavia, proprio il carattere“nazionale” (cioè territoriale)3 e la morfologia “origi-nale” (cioè non costituitasi ex archetypo)4 della bene-ventana: fattori questi tanto rilevanti da compromet-terne altrove il grado di leggibilità5 e dunque la stessafruibilità.6
Giustificata la restrizione alle testimonianze di di-ritto romano giustinianeo vergate in scrittura bene-ventana (o in scritture che con questa mostrano gra-di più o meno marcati di parentela), resta da precisareche non si affronterà, in questa sede, quella parte del-la tradizione indiretta rappresentata dalla conoscenzache delle fonti del diritto romano dimostrano di ave-re i pratici del diritto; quei notai e giudici che, in unatensione emotiva costante col loro concreto operare,sapranno sperimentare soluzioni diverse e alternati-ve, rispetto a quanto faranno gli omologhi colleghidel nord della Penisola, al problema della certificazio-ne dei diritti e della loro documentazione.7
4.«Leges quoque Romanorum, quarum prolixitas nimia eratet inutilis dissonantia, mirabile brevitate correxit [scil. Giustiniano]. Nam omnes constitutiones principum, quae
1 P. S. Leicht, Varietà di leggi e di consuetudini nelle provincie italianelegate all’Impero Bizantino, in «Rivista storica del diritto italiano» xxiv(1951), pp. 127-146.
2 Ci si lascia così alle spalle il problema, irto di difficoltà, di una pro-duzione di codici dal contenuto giuridico scritti col ricorso a altri si-stemi grafici (per esempio in onciale, ovvero, all’altro estremo crono-logico, in minuscola, ma qui si potrà, almeno per casi particolari,fornire qualche indicazione); per non parlare poi di quelle testimo-nianze vergate in scrittura e lingua greca di sicura origine meridiona-le che celano, fra le pieghe di una legislazione emanazione diretta dell’autorità imperiale bizantina, brani e frammenti di quella giusti-nianea e di quella longobarda, cfr. G. Cavallo, La circolazione dei testigiuridici in lingua greca nel Mezzogiorno medievale, in M. Bellomo(ed.), Scuole diritto e società nel Mezzogiorno medievale d’Italia, ii, Cata-nia 1987, pp. 331-422; C. E. Zachariae, Fragmenta versionis grecae regumRotharis Longobardorum regis. Ex codice Paris. gr. 1384, Heidelbergae 1835,nuovamente pubblicato in MGH, Legum, iv, Hannovarae 1868, pp.225-234, la descrizione del manoscritto alle pp. xliv-xlvi, si veda an-cora Th. E. van Bochove, Comprehensive Reading. Some remarks withreference to a treatise in cod. Paris. gr. 1384, in «Subseciva Groningana» 4(1990), pp. 27-37.
3 La beneventana è «scrittura nazionale dell’Italia meridionale nelmedioevo, l’unica che, ad onta della situazione di multigrafismo asso-luto e relativo di questa parte del nostro paese, meriti questo nome»,M. Palma, La nascita di una scrittura nazionale, ‹http://dida.let.uni-cas.it/links/didattica/palma/palmaa. html›.
4 E. Casamassima, Tradizione corsiva e tradizione libraria, Roma1987.
5 Intendi: leggibilità grafica, in merito alla quale si deve leggere A.Petrucci, Digrafismo e bilettrismo nella storia del libro, in «Syntagma» i(2005), pp. 53-75: 60-61; un riassunto della questione in A. Ciaralli,Studio per una collocazione storica dell’italica, in M. D’Agostino-P. De-gni (edd.), Alethes philia. Studi in onore di Giancarlo Prato, Spoleto
2010, pp. 169-189: 172-173. Utili per una corretta valutazione della pro-spettiva che qui si intende sostenere potrebbero risultare i concetti di«Erwartungshorizont des Lesers» e di «implizite Leser», elaborati daHans Robert Jauss, Wolfgang Iser e la Konstanzer Schule.
6 È quanto sceglie di trascurare S. Caprioli, La critica del testo comescienza giuridica, ovvero Ecdotica more iuridico demonstrata, in «Rivi-sta internazionale di diritto comune» 19 (2008), pp. 41-90: 82, n. 164.
7 Negli studi intorno alla storia del diritto si sono spesso rincorse letracce di citazioni di testi o istituti di diritto romano giustinianeo so-prattutto nella produzione documentaria medievale. Innumere la bi-bliografia al proposito; rimando per brevità a G. Nicolaj, Cultura eprassi di notai preirneriani. Alle origini del Rinascimento giuridico, Milano1991; E. Cortese, Il rinascimento giuridico medievale, Roma 19962 e, piùrecentemente, G. P. Massetto, Elementi della tradizione romana in attinegoziali altomedievali, in Ideologie e pratiche del reimpiego nell’alto me-dioevo (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo,xlvi), Spoleto 1999 pp. 511-590. Per il tanto discusso placito di Marturisi veda F. Theisen, Die Wiederentdeckung des römischen Rechts im Alltagdes 11. Jahrhunderts, dargestellt an einer Urkunde von 1076, in «Tijdschriftvoor Rechtsgeschiedenis» 62, 2 (1994), pp. 127-143; sulla tradizione delCodex in alcuni atti della prassi documentaria cfr. A. Ciaralli, «Uni-versali lex». Il Codex Iustinianus nei documenti veronesi tra xi e xii secolo,in A. Castagnetti-A. Ciaralli-G. M. Varanini (edd.), Medioevo.Studi e documenti, Verona 2005, pp. 111-160. Molti i lavori intorno al no-tariato meridionale, ma in generale tutti con scarso interesse versol’impiego nella documentazione di fonti normative giustinianee, li-mite per altro giustificato dalla ristrettezza di tale impiego (cfr. P.Frezza, L’influsso del diritto romano giustinianeo nelle formule e nella pras-si in Italia, in Ius Romanum Medii Aevi, pars i, 2, c ee, Mediolani 1974,pp. 15-18; ha interessi più tardi P. Vaccari, La pratica del diritto romanonell’Italia Meridionale (sec. xii-xiv), in Atti del Congresso internazionale didiritto romano e di storia del diritto, Verona 27-29 set. 1948, II, Milano 1953,pp. 391-399).
46 antonio ciaralli
utique multis in voluminibus habebantur, intra duodecimlibros coartavit, idemque volumen Codicem Iustinianumappellari praecepit. Rursumque singulorum magistra-tuum sive iudicum leges, quae usque ad duo milia pene libros erant extensae, intra quinquaginta librorum nume-rum redegit, eumque codicem Digestorum sive Pandecta-rum vocabulo noncupavit. Quattuor etiam Institutionumlibros, in quibus breviter universarum legum textus com-prehenditur, noviter composuit. Novas quoque leges, quasipse statuerat, in unum volumen redactas, eundem codi-cem Novellam noncupari sancivit».1
Così, con asciutta concisione, ma con informazionecompleta e corretta, l’ormai anziano Paolo Diaconodescriveva, nella Monte Cassino degli ultimi anni delsecolo viii, l’ingente lavoro di sistemazione delle fon-ti normative romane intrapreso, oltre tre secoli emezzo prima, per iniziativa del grande imperatore bizantino. Si tratta di una testimonianza da porre inassoluto rilievo poiché, come è stato osservato,«l’H(istoria) L(angobardorum) è la sola fonte storio-grafica a specificare in dettaglio l’opera giuridica diGiustiniano»,2 laddove l’annalistica bizantina nonprocede oltre la generica menzione e le fonti occi-dentali, invece, ne tacciono del tutto.
Dal passo, assai noto e discusso,3 emerge una co-noscenza di quella codificazione che dovrà intendersidiretta, se le fonti cui attinse Paolo Diacono fosseroproprio riconducibili, come pure una certa concor-danza di termini induce a credere, alle costituzioniproemiali del Codex (seconda edizione) e dei Digesta.4Sembra in particolare dipendere dalla Cordi (Codex, Deemendatione Codicis Iustiniani et secunda eius editione)quanto Paolo mostra di sapere del Codex: alla «super-vacua prolixitas» delle leggi descritta nella normaequivale, infatti, la «nimia prolixitas» della Historia,mentre i «dispersa volumina» delle «constitutionesprincipum» trovano corrispondenza nei «multa volu-mina» del racconto. La ripresa è invece letterale nelverbo che descrive l’operazione di sintesi compiuta
dall’imperatore e dalla sua commissione di giuristi:«coartare». È poi dalla costituzione Tanta (Digesta, Deconfirmatione Digestorum),5 come già precisato dallaCapo, che Paolo deriva il numero dei dodici libri neiquali è organizzata la materia. Ancora quest’ultima èalla base delle notizie sulla composizione dei Digesta:dalla corretta identificazione delle «omnes disputatio-nes et decisiones» con le «leges singulorum magistra-tuum sive iudicum», ai «duo milia pene libros» neiquali esse erano raccolte. Forse è ancora la medesimacostituzione l’origine dell’assimilazione compiuta aproposito delle Institutiones (qui definite «totius eru-ditionis prima fundamenta»), anche se analoga asso-nanza, e forse più significativa, si ritrova proprio nel-la Imperatoriam maiestatem premessa a quel medesimocompendio («totius legitimae scientiae prima ele-menta»), rispetto alla quale l’espressione presente nel-la Historia (quattro libri nei quali «universarum legumtextus comprehenditur») assume, a mio parere, il pro-filo di una libera parafrasi. Infine, sembra essere dinuovo la Cordi, con le notizie fornite in fine al commaiv, la fonte per la descrizione dell’ultima parte del Cor-pus, anche se lì compare una variante (l’uso al singo-lare del nome Novella) di indubbia rilevanza, perquanto di difficile inquadramento.
Paolo Diacono rappresenta certo un caso del tuttoparticolare nella cultura longobarda della secondametà dell’viii secolo: la formazione giovanile com-piuta presso il Palatium pavese e la frequentazione, inetà più matura, degli ambienti della corte carolingia,6non consentono di ascrivere in pieno la sua figura almondo cassinese, verso il quale egli si volgerà a con-clusione della sua vicenda umana.7 Ma se risulta im-possibile stabilire quando e dove Paolo abbia appresociò che gli è noto dell’attività codificatrice di Giusti-niano, è anche certo che il mondo longobardo-cassi-nese riannoderà con la Historia Langobardorum la trama di un discorso interrotto, intessendola all’ordi-to di una presenza costante, conosciuta forse nei suoi
1 Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, i, 25.2 Lo ricorda Lidia Capo in L. Capo (ed.), Paolo Diacono. Storia dei
Longobardi, [Vicenza 1992], p. 409.3 È riportato, da ultimo, in A. Belloni, Un’ipotesi per le Pandette fio-
rentine, in V. Colli-E. Conte (eds.), Iuris Historia. Liber Amicorum Ge-ro Dolezalek, Berkeley 2008, pp. 1-16: 14-15, dove il confronto è condot-to sulla base della sola costituzione Tanta.
4 Paolo, infatti, «dà un così giusto ragguaglio dei libri di Giusti-niano, che non si può [fare] a meno di credere che li abbia visti», ri-teneva già F. C. von Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mit-telalter, ii, p. 239 (xxv, 3, 84 = ed. it. con note e giunte inedite a curadi E. Bollati, i, Torino 18542, p. 420); cfr. ancora il giudizio espressoin R. Perla, Del diritto romano giustinianeo nelle provincie meridionalid’Italia prima delle Assise normanne, in «Archivio storico per le provin-cie napoletane» 10 (1885), p. 153 e la precisa e ricca analisi della Capo(Storia dei Longobardi cit., p. 409) con la sua ricostruzione delle fonticui attinse Paolo Diacono. Per la studiosa «In particolare è la Tantache ha la maggior consonanza con Paolo nella definizione delle ra-gioni e degli scopi dell’azione legislativa di Giustiniano … Sono nellaOmnem e nella Tanta anche i numeri (duemila libri, ecc.) che Paolodà e il termine leges per le sentenze dei giurisperiti; il nome di Codi-ce, Iustinianus, è invece nella costituzione Cordi premessa alla sua se-conda edizione (534). Manca, com’è ovvio, in queste costituzioniproemiali la citazione delle Novelle promanate da Giustiniano intempi anche molto successivi e delle quali non è in realtà sicura unapromulgazione ufficiale della raccolta, pur se prevista da Giustiniano
nella Cordi … La lezione Novella (lex), se giusta, potrebbe indicare ilnome con cui Paolo le conosceva». L’unica inesattezza, in un passoper il resto precisissimo, riguarda le Institutiones tanto che, ne con-clude la studiosa, è «probabile che Paolo non conoscesse diretta-mente le Institutiones …, ma tentasse una ricostruzione in proprio»,(ivi, p. 409).
5 La costituzione Tanta, proemiale nel manoscritto fiorentino deiDigesta, è confluita nel Codex (C. 1.17.2) donde, ovviamente, Paolo puòaverla tratta.
6 Dove però, è appena il caso di ricordare, non è noto esservi stataconoscenza della legislazione giustinianea.
7 Era quanto già notava Francesco Brandileone: «Quelle che pos-sono con sicurezza aversi come testimonianze dei libri giustinianei [inItalia Meridionale], sono un passo di Paolo Diacono … e un altro diPietro Diacono … dai quali si può dedurre, che negli scaffali della Bi-blioteca Cassinese esistevano ai loro giorni le compilazioni giustinia-nee. Ho detto si può, perché Paolo Diacono avrà potuto benissimo, neisuoi viaggi, prendere altrove conoscenza dei libri di Giustiniano», F.Brandileone, Il diritto bizantino nell’Italia Meridionale, comparsodapprima in «Archivio giuridico» 36 (1886), e poi stampato a parte: Bo-logna 1886, di questa edizione si ha una rist. anast. con una nota di let-tura di D. Simon, [Napoli 1987], pp. 29, nn. 2-30. Sul saggio di Brandi-leone si veda F. Schupfer, Il diritto romano nell’Italia meridionale durante i secoli di mezzo. A proposito di uno studio del prof. F. Brandileone,in «Rendiconti dell’Accademia dei Lincei, Classe di Scienze morali» s.4, 2 (1886), pp. 261-278.
materiali per una storia del diritto in italia meridionale 47
aspetti singolari, ma non nota nel suo paradigma generale: la presenza dei libri legales nel Sud della Penisola.
5.
La circolazione beneventana del diritto romano si so-stanzia di una precisa serie di testimonianze direttetutte di rilevante importanza. Il primo pensiero cor-re, com’è naturale, al manoscritto laurenziano dei Di-gesta (F), non tanto, o non solo, per una possibile suaorigine italiana e meridionale,1 quanto piuttosto peruna sua permanenza, probabile stavolta più che pos-sibile, in quei territori. A suggerirlo restano quelle no-te, scritte in beneventana, osservabili tra le righe e neimargini delle carte quadrate del volume e descrivibi-li come:2
1) traduzione (il termine ÔéÛ›· spiegato con id est sub-stantjam) alla c. i (il numero romano indica il tomodei due in cui il ms. fiorentino è diviso) 257r (al-meno due le mani, una scrive pronome e predica-to, l’altra il sostantivo; quest’ultima parola ha su-bito un intervento correttivo nella sillaba finaleeseguito da una mano che si direbbe diversa quel-la che ha scritto la prima parte della parola;3 sec.xi) [Tav. i, Figg. 1 e 2];
2) indicazioni fornite da un direttore di copia per lapreparazione di un exemplum cc. i 17r hic d(esine)(nel margine sinistro tra la r. 17 e la r. 18), i 17r hicap(pone) (nell’interlinea tra la r. 19 e la r. 20), i 52vusq(ue) huc (nell’angolo esterno del margine supe-riore), i 146v stinc, i 183v usq(ue) huc, i 256r stinc(mano unica, identificabile con chi scrive la glossaal n. 1) [Tav. ii, Figg. 2-6];
3) intervento correttivo (?): c. i 12v atis (nel margineinferiore in posizione centrale; sec. xi) [Tav. ii,Fig. 7];
4) prove di penna: cc. i, 163v e ii, 42v entrambe nota-zioni musicali di tipo beneventano, sec. xi primametà; c. i 422r es[.]sib[.] e si s (nel margine esterno,rispettivamente in corrispondenza di D. 29.1.15.5/6e di D. 29.1.16) scritte dalla medesima mano dell’intervento al n. 3, cc. ii 340v abcd (dove la a sidirebbe beneventana) e ii 378r ab de me (con a di disegno beneventano) mano unica bigrafica attri-buibile alla fine del sec. xi o, meglio, ai primi de-cenni del successivo;4
5) nota di possesso (?): c. ii 474r (sec. x?) [Tav. ii,Fig. 8].5
A parte le probationes al punto 4 e l’irrimediabilmenteperduta nota al punto 5, le altre scritture elencate trac-ciano un profilo della conservazione di F tutt’altroche passivo. Persino lo sconosciuto annotatore cheavvertì la necessità di postillare, a c. i 257v, il super-fluo6 e che Caprioli chiama, con sottile ironia ma no-tevole efficacia, il Maestro dell’aceto, non può definirsifrequentatore occasionale. È troppo singolare per es-sere un caso, infatti, che l’attenzione di quel lontanolettore sia stata attirata precisamente da uno dei pas-saggi concettualmente più significativi e da una dellekeywords della disputa sorta, tra il quarto e il settimodecennio dell’xi secolo, intorno al sacramento euca-ristico; un contrasto che vide opporsi a Berengario diTours la chiesa di Roma vigorosamente sostenutaproprio dal mondo cassinese.7 La controversia verte-va sulla mutazione, durante la messa, del pane e delvino in sangue e corpo di Cristo per il tramite dellaconsacrazione operata dal sacerdote. Sebbene le po-sizioni assunte dalle parti non sempre appaiano chia-re (conseguenza di una memoria storica sfilacciata eper lo più indiretta), Berengario risulta essere statocontrario alla trasformazione materiale del pane e delvino: pane e vino che egli sosteneva rimanere, in di-
1 Passa in rassegna le varie ipotesi sull’origine del manoscritto An-nalisa Belloni (Un’ipotesi per le Pandette cit.) allontanando, in conclu-sione, l’idea, che riscuote oggi maggiore credito, di un codice ap-prontato «nelle officine giustinianee in vista dell’amministrazionedella giustizia» (quindi Costantinopoli, ma anche qualche sede, percosì dire, ufficiale e italiana) per favorire la prospettiva di uno «scrip-torium dove la volontà di conservare il Digesto, ben più che l’amoreverso Bisanzio e la legislazione giustinianea» abbiano avuto un pesodeterminante nella sua copiatura: un atteggiamento di tipo antiqua-rio sarebbe dunque all’origine di F. Di qui la proposta di Vivarium come centro di copia. Si veda anche T. Wallinga, The ContinuingStory of the Date and Origin of the Codex Florentinus, in «Subseciva Groningana» 5 (1992), pp. 7-19. Sul manoscritto si veda ora: D. Baldi,Il Codex Florentinus del Digesto e il ‘Fondo Pandette’ della Biblioteca Laurenziana, con un’appendice di documenti inediti, in «Segno e testo», 8(2010), pp. 99-186.
2 Si veda, per quanto segue, Materiali per una storia del diritto in Ita-lia Meridionale. ‘Kleine Ergänzungen’ alla storia del Codex Florentinus, inIuris Historia cit., pp. 17-35.
3 Il segno abbreviativo finale beneventano per m sembra, a benguardare, depennato. Se così fosse (solo l’originale potrebbe togliereogni dubbio), sarebbe stato sanato l’errore dell’intervento emendati-vo che ha volto in accusativo la traduzione interlineare, forse in ciòtratto in inganno dalla presenza nel testo normativo dell’avverbio (ov-viamente interpretato come preposizione) prope.
4 A quest’ultima mano di devono attribuire anche le prove di pen-na alle cc. ii 341v abcde, ii 342r ab, ii 435v me fac de me, ii 449r ghm ghghm l abdefg ggg, ii 459v I(esu)s in nomine tuo salvu(m) me fac (dilavata),ii 469v […]b.e, ii 471r aas; ii 472v ad de me fg mem ab de me e 474v pulchraquasi stella. Per tutte cfr. Kaiser, Zum Auf bewahrungsort cit., p. 107.
5 L’annotazione è oggi per la più gran parte illeggibile per esserestata profondamente erasa. Secondo F. Di Benedetto, Leonzio, Ome-ro e le ‘Pandette’, in «Italia medievale e umanistica» 12 (1969), pp. 53-112:102 n. 2 si legge «hun[c] lib[rum] … l … filius quidem … pha … d .b . .pi . cxx . .», lettura che mostra, però, più cose di quante non sia possi-bile tuttora leggere. Più prudentemente Kaiser, Zum Auf bewahrun-gsort cit., pp. 96-98 trascrive «|[17 mm]lib[19 mm]|[20 mm]bus qui-de(m) […]» (dove|sta per lettera con asta alta).
6 «Povera cosa ‹si intenda quella nota› direte − e neppur segno digrande padronanza del lessico greco: il testo era già una sorta di tra-duzione interlineare −», così S. Caprioli, Visite alla Pisana, in Le Pan-dette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre, Due giornate distudio (Firenze 23-24 giugno 1983), Firenze 1986, pp. 37-98: 49. In effettil’inciso ove compare il termine greco sembra di per sé una glossa in-terpolata: «Plane si in nomine dissentiamus, verum de corpore con-stet, nulla dubitatio est, quin valeat emptio et venditio: nihil enim fa-cit error nominis, cum de corpore constat. Inde quaeritur, si in ipsocorpore non erratur, sed in substantia error sit, ut puta si acetum provino veneat, aes pro auro vel plumbum pro argento vel quid aliud ar-gento simile, an emptio et venditio sit. Marcellus scripsit libro sextodigestorum emptionem esse et venditionem, quia in corpus consen-sum est, etsi in materia sit erratum. ego in vino quidem consentio,quia eadem prope ÔéÛ›· est, si modo vinum acuit: ceterum si vinumnon acuit, sed ab initio acetum fuit, ut embamma, aliud pro alio ve-nisse videtur. in ceteris autem nullam esse venditionem puto, quotiensin materia erratur» D.18.1.9. 1 e 2.
7 Cfr., da ultimo, C. M. Radding-F. Newton, Theology, Rethoric,and Politics in the Eucharistic Controversy, 1079-1079. Alberic of Monte Cas-sino Against Berengario of Tours, New York 2003.
48 antonio ciaralli
rezione contraria all’insegnamento dei suoi avversari− destinato però a diventare ortodossia −, nella so-stanza immutati. Il passo di Ulpiano nel Digesto toc-ca appunto il problema delle conseguenze di un cam-biamento incisivo sulla substantia e non sul corpus diun bene posto in vendita: è valida la vendita di un vi-no trasformatosi in aceto? La risposta del giurista è,nello specifico caso, positiva perché, egli spiega, sitratta pressappoco della medesima sostanza («quiaeadem prope ÔéÛ›· est»).
Non solo il passo che attirò l’attenzione di quel let-tore è rilevante per i contenuti della controversia teo-logale, ma anche la presenza stessa della parola nelcontesto di quel dibattito appare assai significativa.Come ha mostrato Robert Somerville,1 il termine eb-be un uso consapevole nel trattato De corporis et san-guinis Christi veritate in eucharistia scritto da Guitmon-do, allievo di Lanfranco (noto con il geonimico diBec) e in seguito (nel 1088) vescovo di Aversa, tra il1073 e il 1078 e rappresentò «the concept-word which,in the adverbial form “substantialiter”, was a key fac-tor in the oath that Berengar was required to swear in1079».2 In quell’anno il concilio convocato a Roma perdiscutere, tra l’altro, anche della posizione di Beren-gario, si concluse infatti con la definitiva sottomissio-ne del dotto touronense alla dottrina della transu-stansazione. In oltre tre decenni di dure polemiche,Berengario si trovò a fronteggiare oppositori tenaci eagguerriti. Tra costoro un ruolo del tutto particolaredeve essere riconosciuto a Alberico, maestro di gram-matica a Monte Cassino, nonché, più in generale, almonastero cassinese che assunse l’onere specifico del-la difesa di Gregorio vii e delle istanze del partito ri-formatore anche contro i pericolosi cedimenti versouna dottrina ritenuta non ortodossa.3
Se veramente l’interesse dell’ignoto annotatore peril passo ulpianeo dovrà essere inquadrato nel conte-sto dottrinale della controversia in merito alla transu-
stansazione, allora quella ‘povera’ nota è destinata arivestire la medesima rilevanza storica di ciò che av-venne nella campagna di Poggibonsi nel 1076 (più omeno, dunque, nello stesso torno di tempo) quando,con sottile arguzia di legista, qualcuno seppe scovarenei Digesta un argomento (D. 4.6.26.4) capace di risol-vere una situazione che poteva assumere risvolti fran-camente imbarazzanti.4 E se a Marturi si può porre indubbio che la ricerca del passo sia stata compiuta «suun testo integro del Digestum vetus»,5 non si potrà ne-gare che il Maestro dell’aceto abbia avuto, almeno in po-tentia, la possibilità di consultare l’intero corpus dell’opera e qui abbia saputo individuare, nelle oltrecinquanta occorrenze presenti nell’intera opera deltermine substantia,6 il passo che meglio sembra adat-tarsi (ex post, s’intende) al caso in questione.7 Un’im-presa certo di non poco conto, pure quando la si pen-si facilitata da una attività di copiatura volta alladuplicazione anche di una sola parte dell’opera.
Se l’insieme delle annotazioni elencate costituisco-no dunque prova del transito e anzi, come si suggeri-va, della permanenza del manoscritto in uno scripto-rium meridionale8 (quattro mani beneventane, piùuna forse bigrafica) almeno per l’intero xi secolo (siva, sebbene dubitativamente, dalla fine del x agli ini-zi del xii), l’eventualità che un apografo scritto litterislangobardicis, cioè – per intenderci – in beneventana,sia stato effettivamente eseguito è ipotesi destinata arimanere, per ora, priva di precisi riscontri.
6.
Per quanto le sorti dei Digesta (e di quell’unico codicemiracolosamente superstite) continuino a attirare lagenerale attenzione degli studiosi, un posto di assolu-to rilievo in questa storia merita la tradizione del Co-dex Iustinianus.9 La raccolta delle costituzioni impe-riali, com’è ben noto, conobbe, nel breve volgere di
1 R. Somerville, The Case Against Berengar of Tours. A New Text, in«Studi Gregoriani» 9 (1972), pp. 55-75: 68-69.
2 Radding-Newton, Theology cit., p. 110.3 Radding-Newton, Theology cit., pp. 93-94.4 Cortese, Il rinascimento giuridico cit., p. 11. A Marturi, com’è no-
to, era in ballo anche la serietà dei tribunali matildici e l’honor equita-tivo dei Canossa. 5 Così Cortese nel luogo citato.
6 Cinquantuno per l’esattezza, cfr. M. J. Schermaier, Materia. Beiträge zur Frage der Naturphilosophie im klassischen römischen Recht,Wien-Köln-Weimar 1992, p. 143.
7 In una buona parte delle occorrenze il termine ha il significato ge-nerico di beni; altre volte indica la substantia iuris (per es. D. 38.10.4.2 o44.3.10.1), in una quindicina di casi, invece, è riferito alla substantia re-rum. La maggior parte di questi ultimi (circa i 2/3) ricade nella porzio-ne ascritta al Digestum vetus. Oltre al passo annotato, mostra attinenzacon possibili sviluppi dell’argomento D. 10.4.9.3 (ancora Ulpiano), do-ve, però, il senso opposto e la presenza di un comportamento deter-minato dolo malo avrebbero reso inutilizzabile il frammento: «Ulpianusxxiv Ad ed. Sed si quis in rem deteriorem exhibuerit, aeque ad exhi-bendum eum teneri Sabinus ait. sed hoc ibi utique verum est, si dolomalo in aliud corpus res sit translata, veluti si ex scypho massa facta sit:quamquam enim massam exhibeat, ad exhibendum tenebitur, nammutata forma prope interemit substantiam rei». Il passo è commenta-to in R. Fiori, La definizione della locatio conductio. Giurisprudenza ro-mana e tradizione romanistica, Napoli 1999, pp. 195-196 n. 34.
8 Concordava con simile prospettiva S. Caprioli, Visite alla Pisanacit., pp. 37-98: 50-51, che invece ora assume posizioni più sfumate:«Non meno dei libri, circolarono infatti gli scrivani, usando la penna
− dovunque si trovassero − come erano avvezzi ad usarla. Del restola leggenda pisana di F non può fornire alcuna riprova a favore di unao altra identificazione-localizzazione per il Maestro dell’aceto» (Ca-prioli, La critica del testo cit., p. 82, nt. 164).
9 La prima ricognizione dei manoscritti sopravvissuti del Corpus iu-ris civilis si legge nel E. Schrader-W. F von Clossius-G. L. F. Tafel(edd.), Prodromus Corporis Iuris Civilis, Berolini 1823, opera in cui però,nonostante il titolo, l’interesse fu prevalentemente rivolto alle Institu-tiones; per il Codex si veda P. Krüger, Kritik des Justinianischen Codex,Berlin 1867 destinata a confluire nell’edizione critica P. Krueger (ed.),Codex Iustinianus, Berolini 1877; G. Dolezalek-L. Mayali, Reperto-rium manoscriptorum veterum Codicis Iustiniani, 1, Frankfurt am Main1985; C. Tort-Martorell, Tradición textual del Codex Iustinianus. Unestudio del Libro 2, Frankfurt am Main 1989; si veda anche H. Lange, Rö-misches Recht im Mittelalter, Bd. 1, Die Glossatoren, München 1997, pp. 13,71-73 e C. Radding, Reviving Justinian’s Corpus: The Case of the Code, inP. Andersen-M. Münster-Swendsen-H. Vogt (eds.), Law beforeGratian. Law in Western Europe c. 500-1100. Proceedings of the Third Carls-berg Academy Conference on Medieval Legal History 2006, Copenhagen2007, pp. 35-50. Per questi aspetti cfr. A. Ciaralli, Per le AdnotationesCodicum domini Iustiniani (Summa Perusina). Perugia, Bibl. dell’Archi-vio Capitolare, ms. 32, in «Studia et documenta historiae et iuris» 76(2010), pp. 861-869. La quasi totalità dei manoscritti che verranno menzionati è schedata in quel formidabile strumento di lavoro che èG. Dolezalek-H. van de Wouw, Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600, Frankfurt 1972, ora sostituito dalla banca datiManuscripta juridica, [Principal Investigator G. R. Dolezalek] ‹http://manuscripts.rg.mpg.de›, cui è sempre inteso il rinvio.
materiali per una storia del diritto in italia meridionale 49
cinque anni, due edizioni. La prima versione (a. 529)fu infatti presto ritenuta obsoleta sia per la norma-zione nel frattempo intervenuta, sia, e ancor di più, inconseguenza dell’ulteriore lavoro di sistematizzazio-ne terminato con la promulgazione dei Digesta e lapubblicazione delle Institutiones. Se è comprensibile,dunque, e anzi logico che della prima stesura non siasopravvissuto che assai poco1 – tanto poco da potersiriassumere con certezza in due miseri frustoli di papiro, parte di un’unica pagina, contenenti un elen-co delle rubriche e delle inscriptiones delle costituzio-ni 11-16 del primo libro –,2 ben più sorprendente è lapovertà di testimonianze manoscritte della seconda edefinitiva databili ancora entro il vi secolo. Quando siescludano, infatti, le tre carte erase in età altomedie-vale e riutilizzate per raccogliere un glossario,3 e i
complessi Fragmenta Londiniensia recentemente pubblicati [Tav. v, Fig. 1],4 l’eredità più consistentepervenutaci del Codex è costituita dalle settantasettecarte, anch’esse palinseste (sono state riutilizzate nell’viii secolo per copiare la Concordia canonum diCresconio), della Biblioteca Capitolare di Verona5 eormai rese quasi del tutto illeggibili dai reagenti chimici impiegati da Krüger come ausilio alla lettura.Occorrerà arrivare all’xi secolo per trovare di nuovotestimoni, sia pure parziali, di quel testo. Sono, dap-prima, quelle raccolte conosciute con l’ambiguo termine di ‘epitomi’6 e tradite da manoscritti che ap-partengono, più che alla storia, all’epica della storio-grafia giuridica sul Corpus iuris civilis: i due codici ge-melli Pistoia, Archivio capitolare C 106 (= Krüger ms.P, Italia centro settentrionale, metà/terzo quarto del
1 «Die Neuredaktion vom Jahre 534 … hat in der Folgezeit Abschrif-ten des Codex vetus überflüssig gemacht. Es ist so verständlich, dasdie Erstausgabe des Codex Iustinianus verlorenging», R. Seider, Pa-läographie der lateinischen Papyri, II, 2, Literarische Papyri, 2. Halbband,Juristische und Christliche Texte, Stuttgart 1981, p. 98. Sempre valida l’in-vettiva di Gibbon contro gli scribi sacrileghi: «Before the invention ofprinting and paper, the labor and the materials of writing could bepurchased only by the rich; and it may reasonably be computed, thatthe price of books was a hundred fold their present value. Copies wereslowly multiplied and cautiously renewed: the hopes of profit tempt-ed the sacrilegious scribes to erase the characters of antiquity, andSophocles or Tacitus were obliged to resign the parchment to missals,homilies, and the Golden Legend. If such was the fate of the mostbeautiful compositions of genius, what stability could be expected forthe dull and barren works of an obsolete science?», E. Gibbon, Decli-ne and Fall of the Roman Empire, L. iv, cap. lxiv, Idea Of The Roman Ju-risprudence, parte iv.
2 Oxford, The Ashmolean Museum, P.Oxy. 1814 (CLA, Supplementn. 1713, Seider, Paläographie cit, n. 34). Si tratta dell’unica attestazionecerta della prima edizione dell’opera e, in quanto tale, risulta databilecon sicurezza tra il 529 e il 534. Il frammento è paleograficamente in-teressante perché, scritto da un amanuense grecofono (cfr. verso r. 3«impp. Leo et ZËno») in onciale non di tipo BR, suggerisce per questatipizzazione dell’onciale un’epoca di formazione coincidente o poste-riore al progetto codificatore giustinianeo. Pubblicato, tra gli altri, daP. De Francisci, Frammento di un indice del primo Codice Giustinianeo,in «Aegyptus» 3 (1922), pp. 68-79, si veda anche F. Schulz, Ein Blatt auseinem antiken Exemplar des Codex Iustinianus, in «Zeitschrift der SavignyStiftung, Romanistische Abteilung» 51 (1931), pp. 417-421, L. Wenger,Die Quellen des römischen Rechts, Wien 1953, pp. 572-576 e 918 e ora S.Corcoran, Justinian and his two Codes. Revisiting P.Oxy, 1814, in «TheJournal of Juristic Papyrology» 38 (2008), pp. 73-111. Altri frammenti dipiù dubbia attribuzione alla prima redazione del Codex sono i cinquefrustoli di Firenze, Biblioteca Laurenziana, PSI xiii 1347 (CLA, iii n.293, Seider, Paläographie cit., n. 35), editi in A. Segré, Tre papiri giuri-dici inediti, in Studi in onore di Pietro Bonfante, iii, Milano 1930, pp. 429-436, si veda Schultz, Ein Blatt cit., e Corcoran, After Krüger cit., p.431 e il P.Rein. n. 2219 dell’Institut de papyrologie della Sorbonne(CLA, v n. 700, Seider, Paläographie cit., n. 17 pubblicato per primo daS. de Ricci, Deux nouveaux papyrus juridiques, in Études d’histoire juri-dique offerts à Paul-Frédéric Girard, i, Paris 1912, pp. 273-282; per i dubbisull’appartenenza alla prima redazione si veda J. C. Naber, Scholia adPandectas Graeca in integrum restituta tria, in Studi in memoria di A. Al-bertoni, i, Padova 1935, pp. 21-23).
3 Köln, Hist. Archiv GB., Kasten, No. 130 + Münster in Westphalia,UB 718 (1186), (CLA, viii 1167; i due frammenti di Münster sono anda-ti distrutti, probabilmente per cause belliche, il 31 marzo 1945; nulla miè noto delle sorti del frammento di Colonia dopo il rovinoso crollodella sede dell’Archivio di quella città avvenuto nel 2009). Secondo Lo-we il codice cui appartenevano i frammenti era stato «Written presu-mably in Italy» a giudicare dalla prima scriptio posterior (mostrano diessere, infatti, due volte palinsesti) che tramanda un Glossarium lati-num, anch’esso in onciale, ma del secolo vii. Il primo frammento fupubblicato in G. Gundermann, Das Kölner Fragment des Codex Justi-nianus, in «Rheinisches Museum für Philologie» n.F., 45 (1890), pp. 361-370, si veda ancora Dolezalek-Mayali, Repertorium cit, 1, p. 229 e ora
Corcoran, After Krüger: Observations on some Additional or Revised Justinian Code Headings and Subscripts, in «Zeitschrift der Savigny Stif-tung, Romanistische Abteilung» 136 (2009), 423-439: p. 431.
4 Si tratta di diciassette frammenti di pergamena proprietà di un pri-vato e provenienti da una legatura affidati in custodia del centro “Vol-terra” dello University College di Londra per essere identificati e stu-diati (si veda S. Corcoran-B. Salway, Fragmenta Londiniensiaanteiustiniana, ‹www.ucl.ac.uk/history2/voltera/texts/fla.htm›). Si-mon Corcoran e Benet Salway ritengono i frammenti provenire da unaraccolta di costituzioni imperiali diversa dal Codex e a questo prece-dente. I testi identificati, infatti, rimandano a C. 7.62.3, 4 e 7 con l’ag-giunta, però, di costituzioni non altrimenti documentate nel Codex Iu-stinianus. Di qui l’ipotesi, formulata dai due studiosi, che i frammentiderivino da un manoscritto del Codex Gregorianus e una proposta di da-tazione, invero assai prudente, al v-vi secolo. Si noti però che, mentrein una prospettiva paleografica i frammenti si direbbero scritti in on-ciale di tipo BR (per la verità nell’unico riprodotto manca la B, tuttaviala forma assai caratteristica della R va nella direzione indicata), con laconseguenza di una loro possibile datazione al pieno vi secolo e unacompetizione diretta del testo da essi tradito col Codex, non sono in no-stro possesso testimonianze antiche dell’opera (i frammenti veronesi,pur annoverando passi del settimo libro non hanno quelli qui menzio-nati) utili per confermare l’attuale successione e consistenza delle co-stituzioni nello specifico punto così come ricostruita da Krüger.
5 È il ms. lxii (60), cc. 4-81 con porzioni dei libri 4-8 e 11-12 del Codex(CLA, iv n. 513) scoperto da Friedrich Bluhme e pubblicato in facsimi-le litografato con trascrizione diplomatica da P. Krüger, Codicis Iusti-niani fragmenta Veronensia, Berlin 1874, le glosse marginali in greco daZ. von Lingenthal, Die griechischen Scholien der rescribierten Handschrift des Domkapitels zu Verona, in «Zeitschrift für geschichtlicheRechtswissenschaft» 15 (1850), pp. 90-132; cfr. Dolezalek-Mayali, Repertorium cit., 1, p. 443.
6 Antologie le si dovrebbe più correttamente definire, visto che nédi sunto o di sinossi, né di altra forma di compendio si tratta, almenoper il corpo delle leggi, ma solo di selezione, scelta di testi normativi:eliminati gli ultimi tre libri e le costituzioni in greco, sono state inclu-se, nei codici della classe dei cosiddetti manoscritti epitomati, alcuneleggi e tralasciate altre. Le selezioni così operate (evidentemente piùd’una) saranno poi, nel corso dell’xi secolo, integrate di alcune dellecostituzioni omesse (non tutte) spesso copiandole nei margini dei me-desimi manoscritti. Le uniche parti a essere effettivamente abbreviatesaranno quelle protocollari (inscriptiones) e escatocollari (subscriptio-nes). Il concetto di Codex epitomatus deve essere sottoposto a verificaanche alla luce dell’osservazione che molti manoscritti ritenuti com-pleti presentano omissioni di leggi e alterazioni nel loro ordine. Acca-de questo, oltre che per i quattro manoscritti citati più oltre, anche perquelli di pieno e tardo xii secolo come Leipzig, UniversitätsbibliothekMs. 883; Montecassino, Archivio del Monumento Nazionale 49 (=Krüger ms. C, Italia centrale); Bamberg, Staatsbibliothek Ms. Jur. 20;München, Bayerische Staatsbibliothek Clm 22; Città del Vaticano, Bi-blioteca apostolica vaticana, Vat. lat. 1427 e Pal. lat. 762; Wien, Öster-reichische Nationalbibliothek, Cvpl 2267, cfr. G. Dolezalek-A. Cia-ralli, Codicis Justiniani Epitome Beinecke and Summa Perusina (11thcentury). Comments on and edition of manuscript 974 at Yale University’sBeinecke Library, in Ius Romanum - ius commune - ius hodiernum. Stu-dies in honor of Eltjo Schrage, Amsterdam-Aalen 2010, pp. 75-100: 78.
50 antonio ciaralli
sec. xi,1 e Paris, Bibliothèque Nationale lat. 4516 (=Krüger ms. L, Italia centro settentrionale secondametà del sec. xi2 e il più tardo Darmstadt, HessischeLandes- und Hochschulbibliothek 2000 (= Krügerms. D, Francia meridionale?, sec. xiex.-xiiin., un co-dice che mostra però assai poco dell’epitome).3 Esem-plari che per antichità e rilevanza testuale sono statiassunti da Krüger a fondamento della sua edizionecritica.4 Appartengono ancora alla serie ‘epitomata’,ma non erano noti al tempo di Krüger, il manoscrittoPesaro, Biblioteca Oliveriana 26 scoperto e studiatoda Patetta nel 18955 (Italia centrale, sec. xiex.-xiiin.),la singola carta di Stuttgart, Württembergische Lan-desbibliothek jur. fol. 72 (Italia settentrionale, secon-da metà del sec. xi)6 e il prezioso frammento di NewHaven, Yale University, Beinecke Library ms. 974 re-centemente individuato da Gero Dolezalek (Italiacentrale, area romanesca, seconda metà del sec. xi),su cui si tornerà più avanti.7
Per avere un Codex più o meno completo (comple-to almeno per i primi nove libri)8 bisognerà invece ri-correre ai manoscritti prossimi alla, o anche di piena,età bolognese e dunque attribuibili, su base ovvia-mente paleografica (nessuno se ne adonti), tra gli ul-timi decenni dell’xi secolo e i primi decenni di quellosuccessivo e cioè, per quel che vedo, Montpellier, Bi-bliothèque universitaire (Section de médicine) H 82(= Krüger ms. M, Italia settentrionale);9 Berlin, Staat-sbibliothek Ms. lat. fol. 272 (Italia centrale)10 e 273 (=
Krüger ms. R, Italia centrale),11 il bifolio di guardiaposteriore di Wien, Österreichische Nationalbiblio-thek Ms. 206512 (il più tardo e evoluto della serie).13
A integrazione di un panorama già di per sé abba-stanza desolato si possono ancora annoverare, rile-vanti per antichità, ma assai poveri di testo, la cartaconservata a Bologna, Collegio di Spagna 73 (Italia set-tentrionale, sec. xiex.-xiiin.),14 le due importanti car-te di Würzburg, Universitätsbibliothek, M.p.j.f.m.215(Italia centrale, area romanesca, metà/terzo quartodel sec. xi), e il foglio dell’eccezionale frammento val-licelliano su cui sarà necessario tornare (Italia meri-dionale, seconda metà del sec. xi):16 miseri avanzi, an-che questi ultimi, dell’abbandono patito dai testigiustinianei durante i secoli dell’alto medioevo.17
Tra le testimonianze più antiche, dunque, a voltetalmente frammentarie da rendere difficile una preci-sa definizione del loro contenuto, e i primi mano-scritti medievali a noi pervenuti, alcuni dei qualiespressione di un processo di graduale riappropria-zione del testo, si osserva, a proposito della tradizio-ne diretta del Codex,18 un silenzio durato oltre tre se-coli e mezzo.
7.
È idée reçue che quel vuoto sia occupato dalle Adnota-tiones Codicum domini Iustiniani, più note col titolo diSumma Perusina, una delle opere più singolari del-
1 A. Ciaralli, Ancora sul manoscritto pistoiese del Codex (Arch. Cap.C 106). Note paleografiche e codicologiche, in «Scrittura e Civiltà» 24(2000), pp. 173-225.
2 Ciaralli, Ancora sul manoscritto cit., pp. 202-206.3 Ovviamente è impossibile, in questa sede, ripercorrere la princi-
pale letteratura intorno a questi fondamentali manoscritti, basti qui ilrinvio a Dolezalek-Mayali, Repertorium cit., 1 rispettivamente pp.379, 343 e 185 e C. M. Radding-A. Ciaralli, The Corpus Iuris Civilis inthe Middle Ages. Manuscripts and Transmission from the Sixth Century tothe Juristic Revival, Leiden-Boston 2007, ad indicem.
4 Si veda Krüger, Codex Iustinianus cit., pp. v-xxxxiiii.5 F. Patetta, Di un nuovo Codice epitomato, in «Bullettino dell’istitu-
to di storia del diritto romano» viii (1895), pp. 203-224 (ora in Id., Stu-di sulle fonti giuridiche medievali, presentazione di G. Astuti, indici acura di A. Benedetto, Torino 1967, pp. 219-240). Si veda Tort-Mar-torell, En torno a Pesaro 26 cit.
6 Con C. 4.20.12-21.11 ma senza C. 4.20.20 e C. 4.21.7, per il quale siveda Dolezalek-Mayali, Repertorium cit., 1, p. 392; Radding-Cia-ralli, The Corpus iuris civilis cit., pp. 107 e 152 e Corcoran, After Krü-ger cit., pp. 438-439.
7 Dolezalek-Ciaralli, Codicis Justiniani Epitome cit.8 Sulla tradizione degli ultimi tre libri dell’opera cfr. E. Conte, Tres
libri. La ricomparsa del testo e l’esegesi scolastica prima di Accursio, Fran-kfurt am Main 1990, ma vedi anche quello che si legge in Radding-Ciaralli, The Corpus iuris civilis cit., pp. 154-155.
9 Dolezalek-Mayali, Repertorium cit., 1, pp. 281-291; Radding,Reviving Justinian’s Corpus cit., pp. 46-49 e Radding-Ciaralli, TheCorpus iuris civilis cit., pp. 163-165.
10 Dolezalek-Mayali, Repertorium cit., 1, pp. 148-154; A. Finger-nagel, Die illuminierten lateinischen Handschriften süd-, west- und nordeuropäischer Provenienz der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kul-turbesitz (4.-12. Jahrhundert), Wiesbaden 1999, pp. 23-24; Radding-Cia-ralli, The Corpus iuris civilis cit., pp. 162-163.
11 Per i quali si veda Dolezalek-Mayali, Repertorium cit., 1, pp.154-157; Fingernagel, Die illuminierten cit., pp. 17-18; Radding, Re-viving Justinian’s Corpus cit., p. 46 e Radding-Ciaralli, The Corpus iuris civilis cit., pp. 158-162.
12 Radding-Ciaralli, The Corpus iuris civilis cit., pp. 157 e 165.13 Escludo dal conto il manoscritto Avranches, Bibliothèque Muni-
cipale 141 (più un frammento aggregato al ms. 6), un manoscritto non
italiano, impropriamente considerato epitomato da Mor e a mio pa-rere attribuibile alla prima metà del xii secolo, cfr. C. G. Mor, Il ma-noscritto del Codice giustinianeo della Biblioteca comunale di Avranches, orain Scritti di Carlo Guido Mor, Pisa 1977, pp. 63-76.
14 Il foglio di guardia con C. 7.40.1c-2.1 e C. 7.40.3 pr.-43.2. Si veda D.Maffei-E. Cortese-A. Garcia y Garcia-C. Piana-G. Rossi (edd.),I codici del Collegio di Spagna di Bologna, Milano 1992, p. 148.
15 Con C. 1.27.1.36 fi.-27.2.16 e C. 2.43.3-51.2, cfr. R. Weigand, Frag-mente des römischen Rechts in der Universitätsbibliothek Würzburg, in«Zeitschrift der Savigny Stiftung, Romanistische Abteilung» 105(1988), pp. 784-788; H. Thurn, Die Handschriften der kleinen Provenien-zen und Fragmente. Die mittelniederländischen Codices beschrieb W. Wil-liams-Krapp, Wiesbaden 1990, pp. 229-230; A. Ciaralli, Produzione ma-noscritta e trasmissione dei testi di natura giuridica fra xi e xii secolo: dueesempi, in V. Colli (hrsg.), Juristische Buchproduktion im Mittelalter,Frankfurt am Main 2002, pp. 90-92 e Corcoran, After Krüger cit., pp.432-438. Al contrario di quanto affermato da Weigand e ripetuto daThurn in forma dubitativa, il frammento, che inizia appunto con le ul-time parole del comma 36 (e non 37 secondo la bibliografia citata), nonpresenta alcuna glossa in scrittura beneventana, come già segnalato inV. Brown, A Second new List of Beneventan Manuscrips (iv), in «Medie-val Studies» 61 (1999), p. 329.
16 Roma, Biblioteca Vallicelliana, Carte vallicelliane xii.3, per lequali si veda ora S. Corcoran, New Subscripts for Old Rescripts: the Vallicelliana Fragments of Justinian Code Book vii, in «Zeitschrift der Sa-vigny Stiftung, Romanistiche Abteilung» 126 (2009), 401-422.
17 A questi occorre aggiungere l’excerptum contenuto in München,Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6375 (Germania meridionale, secoloix) con C. 3.13.2-17-1 che, copiato di seguito alla Historia ecclesiastica diEusebio, mostra con ciò una stretta dipendenza dall’antigrafo e quin-di l’occasionalità della sua trasmissione, si veda Dolezalek-Mayali,Repertorium cit., 1, p. 307 e Radding-Ciaralli, The Corpus iuris civiliscit., p. 51.
18 Per quel che riguarda la tradizione indiretta rimando a W. Kai-ser, Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelal-ter und zum byzantinischen Rechtsunterricht, Frankfurt am Main 2004,pp. 969 (Excerpte) e 970 (Verweise). Sull’importanza della scuola lon-gobardistica pavese nelle complesse vicende della medievale riemer-sione del diritto romano insiste, giustamente, Radding, Reviving Justinian’s Corpus cit., pp. 41 ss. e prima Radding, The Origins cit.
materiali per una storia del diritto in italia meridionale 51
l’esperienza giuridica medievale nonché, appunto, te-stimone sui generis della travagliata tradizione del Co-dex giustinianeo [Tav. iii].1 L’opera è tradita dal ma-noscritto n. 32 della Biblioteca dell’Archivio capitolaredi Perugia, un codice fino a tempi piuttosto recenticoncordemente ritenuto del x secolo.2 Come dimo-strato da Patetta, le Adnotationes altro non sarebberoche brevi sunti, epitomi e compendi del testo norma-tivo posti, in origine, nei margini di un manoscritto,probabilmente incompleto poiché le Adnotationes siinterrompono con C. 8.53.9, delle leggi giustinianee.Solo in un secondo momento, «sive iureconsulti sivelibrarii opera», tali compendi vennero copiati tutti diseguito, con l’omissione del testo legislativo cui si ri-ferivano, a comporre un’opera unitaria. Il CompositorSummae è il responsabile di questo passaggio, a luivanno attribuite le annotazioni che indicano i luoghiove si riscontra lacuna, nonché i frequenti errori nel-le inscriptiones e nei summaria. La redazione di questiultimi è per lo più attribuibile a un unico autore (de-nominato Breviator da Patetta), il quale mostra pocaesperienza di legge e rude conoscenza della lingua la-tina. Proprio intorno all’operare dell’epitomatore e alsuo sermo si sono concentrati gli sforzi esegetici diquanti hanno cercato di definire epoca e patria delleAdnotationes. Nessun dubbio è mai sorto in merito all’origine italiana dell’opera3 attribuita, generica-mente, a ‘territori romanistici’ come la Campania o il
Lazio.4 Per quanto riguarda l’epoca della sua compo-sizione si va dalla metà del vi secolo,5 alla prima me-tà del vii6 o anche, più genericamente, tra vii e ix.7Ma qui è opportuno distinguere tra i sommari e la lo-ro raccolta: «L’opera dovette esser messa insieme po-co prima del codice che la conserva, verso la fine delsecolo ix o al principio del x; mentre i summaria chela compongono risalgono ad un periodo notevol-mente anteriore, tra la seconda metà del secolo vii ela prima metà dell’viii».8 Si tratta di conclusioni lar-gamente accolte e fondate da un lato sulla grave cor-ruzione del dato linguistico, dall’altro sull’analisi deicapitoli contenti disposizioni di diritto pubblico e am-ministrativo e sulle erronee assimilazioni compiutedal Breviator intorno a talune figure di funzionari im-periali. Una più recente analisi paleografica ha però ri-considerato le particolarità scrittorie delle due maniche parteciparono alla copiatura del testo (una dellequali presente solo nelle carte finali), dimostrando co-me quelle caratteristiche, comunemente interpretatequali indizio di antichità, siano invece da riferire apunti di contatto con la cultura grafica propria del-l’Italia meridionale.9 La scrittura con cui sono copia-te le Adnotationes non è, in effetti, facilmente definibi-le: essa presenta alcuni caratteri che sono propri dellatradizione grafica corsiva altomedievale (e così sonostati interpretati, con la conseguente datazione piut-tosto alta) accanto a una struttura che pare franca-
1 Recentemente riprodotto in facsimile integrale: Adnotationes Codicum domini Iustiniani (Summa Perusina), Firenze, 2008, con unanota introduttiva di G. Crifò e M. Campolunghi. Accompagna lariproduzione del volume l’edizione del testo curata da Federico Pa-tetta: F. Patetta, Adnotationes codicum domini Justiniani (Summa Peru-sina), in «Bollettino dell’Istituto di storia del diritto romano» xii(1900), riedito come volume a sé stante col medesimo titolo a Romanel 1933. L’anastatica, preceduta da una nota per chi legge di Giovan-ni Diurni e Severino Caprioli, è tratta precisamente dal Bullettino.L’edizione dell’opera è preceduta da un ampio saggio introduttivo,pp. v-lxxxii, ripubblicato anastaticamente in Patetta, Studi sulle fon-ti cit., pp. 241-318.
2 Così la storiografia giuridica che ha studiato direttamente il ma-noscritto tutta reperibile in A. Ciaralli-V. Longo, Due contributi a unriesame della Summa Perusina (Perugia, Bibl. Cap. ms. 32), in «Scrittura eCiviltà» 25 (2001), pp. 1-62. Non troppo dissimile un primo orienta-mento paleografico, incline a orientarsi per la seconda metà di quel se-colo, cfr. A. Petrucci, Alfabetismo ed educazione grafica degli scribi alto-medievali (secc. vii-x), in P. Ganz (ed.),The role of the book in medievalculture. Proceedings of the Oxford International Symposium 26 September-1October 1982, i, Turnout 1986, p. 120 e P. Supino Martini, Roma e l’areagrafica romanesca (secoli x-xii), Alessandria 1987, p. 197 n. 1.
3 «Ego in Italia esse scripta arbitror», scriveva Heimbach, e poichéosservava che «Habentur enim aliquot locis ea dicendi genera, quaeGraeci sermonis propria sunt», ne concludeva che «probabile non est,hunc librum in his Italiae partibus, quae Grecorum imperio num-quam subiectae erant, confectum esse», \AӤΉÔÙ· cit., pp. xvi-xvii.Analoghe le conclusioni di Conrat: «Als Heimat der Summe wird imHinblick auf den einem vornehmlich in Italien geltenden Rechsbuchezugewendeten Inhalt die apenninische Halbinsel gelten dürfen», perpoi precisare che «Man wird dann die Heimat in dem vorzugsweisevon Römern bewohnten, nicht in dem langobardischen Italien suchenwollen», M. Conrat, Geschichte der Quellen und Literatur des römischenRechts im früheren Mittelalter, 1, Leipzig 1891, p. 186.
4 E. Besta, Fonti. Legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell’im-pero romano al secolo decimo quinto, in Storia del diritto italiano, pubbli-cata sotto la direzione di P. del Giudice, 1, 1, Milano 1923, pp. 181 e 182(giudizio confermato in Id., Fonti del diritto italiano dalla caduta del-l’impero romano sino ai tempi nostri, Milano 19502, p. 57). Ulteriori os-servazioni aveva sviluppato il Besta nel suo precedente e accuratissi-
mo studio sui contenuti giuridici delle Adnotationes, si veda Id., Il con-tenuto giuridico della Summa Perusina (Comunicazione fatta dal socioEnrico Besta nella tornata del 22 aprile 1906), in «Atti della r. Accade-mia di scienze e lettere e belle arti di Palermo» s. 3, 8 (1904-5-6-7), pp.3-95, in particolare p. 69. Da rifiutare l’opinione di Tamassia per il qua-le «la summa non è lavoro originale italiano: essa è una traduzione dalgreco di uno di quei tanti Û‡ÓÙÔÌÔÈ ÎÒ‰ÈΘ de’ quali è ricca la lette-ratura bizantina … Il lavoro non può essere stato fatto che in una pro-vincia d’Italia, ove maggiore era la conoscenza della lingua greca; va-le a dire a Ravenna» – cfr. N. Tamassia, Bologna e la scuola imperiale didiritto, in «Archivio giuridico» 40 (1888), p. 266 – secondo la confuta-zione di Patetta, Adnotationes cit., pp. xxvi-xxvii e xliv.
5 Così interpreto un’ellittica affermazione di Thomas Brown: «In alegal compilation, which appears to reflect late sixth century condi-tions, curials are allotted the duty of collecting the land tax (canon) andthe poll-tax (census)», T. Brown, Gentlemen and Officers. Imperial Admi-nistration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A.D. 554-800, Hertford1984, p. 17 e nota 31.
6 P. Krüger, Geschichte der Quellen und Literatur des RömischenRechts, München-Leipzig 19122, p. 372; Patetta, Adnotationes cit., pp.xlvii e lxv; D. Liebs, Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260-640),Berlin 1987, p. 277 (si veda anche p. 280). Mentre per Patetta la metà delvii secolo è la datazione più probabile tra l’inizio di quel medesimosecolo e la metà dell’viii che è la datazione ampia dallo studioso for-mulata per la composizione dei summaria, secondo Liebs l’opera po-trebbe collocarsi intorno al terzo decennio del secolo vii.
7 «Wahrscheinlich also in der Zeit vom 7ten bis 9ten Jahrhundertverfaßt, und ein Denkmahl des praktischen Gebrauchs der römischenRechtsbücher während dieser Jahrhunderte», B. Niebuhr, Nachrichtvon einem Breviarium des Justinianischen Codex (aus einem Schreiben anSavigny), in «Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft» 3(1817), p. 391 dove soprattutto interessante è la notazione sull’ambitod’uso.
8 G. Astuti, Tradizione dei testi del Corpus iuris nell’alto medioevo, inG. Diurni (ed.), Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea. Rac-colta di scritti, Ius nostrum, 2ª serie, 1.1, Napoli 1984, p. 194 che ripren-de l’osservazione da Patetta. Un po’ più largo Conrat che riportava lacomposizione delle Adnotationes tra la metà del vii secolo e il ix o, me-glio, gli inizi di quel secolo (Conrat., Geschichte cit., p. 187).
9 Ciaralli-Longo, Due contributi cit.
52 antonio ciaralli
mente di modello carolino. La qualità e il ductus diquei grafemi e gruppi grafici arcaici sono però, a meglio vedere, propriamente beneventani1 e ciò induce una nuova valutazione della cronologia delmanoscritto che dal x secolo è senz’altro da ricon-durre alla prima metà dell’xi, che è poi anche l’epocain cui si affollano le uniche testimonianze note intor-no alla conoscenza e all’uso delle Adnotationes. Alcu-ne tra queste sono documentarie e tramandate da attigiudiziari di area romana;2 due sono invece librarie:gli excerpta contenuti nel manoscritto di Vercelli, Bibl.Cap. 122, probabilmente originario dell’area romana,e il passo presente nella cosiddetta Lectio legum brebi-ter facta del manoscritto di Roma Bibl. Vallicelliana B32 scritto in beneventana e ritenuto originario di Veroli.3
La natura ibrida riscontrata nella scrittura del copi-sta principale della Summa impone una valutazionedei contenuti dell’educazione grafica da costui rice-vuta: si tratta di un amanuense che ha imparato a scri-vere in beneventana (dunque in una scuola dell’Italiameridionale) e che si costringe a scrivere in una mi-nuscola di ispirazione carolina, oppure di uno che,istruito a paradigmi carolini (scrittura al suo tempoormai da oltre due secoli egemone nell’Italia centro-settentrionale) forza la propria mano per adattarla almodello dominante lì dove l’operazione di riprodu-zione è in corso? A seconda di come si risolva il que-sito, si ottengono risultati assai diversi in merito alpossibile luogo di copiatura del codice perugino (o al-
la possibile sua destinazione) con conseguenze nondel tutto adiafore per la storia del Codex nell’alto e me-dio medioevo.4
8.
Nuova luce sul problema dell’epoca di composizionedei summaria e dunque sulla questione stessa dell’ori-gine delle Adnotationes potrebbe fare il lacerto dellaBeinecke Library che tramanda da C. 1.14.5.1 a C. 1.15.1(ma con l’omissione di C. 1.14.7-8 e 10-11 e la sola men-zione della constitutio Graeca di C. 1.15.2) e ancora C.1.18r e C. 1.18.2-3 [Tavv. iv e v Fig. 2].5 La singola car-ta, che si conserva piuttosto malconcia, è scritta inuna minuscola romanesca, con alcuni indizi che indi-cano contatti con usi grafici beneventani,6 attribuibi-le alla seconda metà dell’xi secolo. Ma ciò che rendeinteressante il nuovo testimone è la presenza nel mar-gine esterno del suo verso di due brevi testi scritti, inminuscola non tipizzata, da una mano diversa dallaprincipale sebbene a questa coeva. Ci si trova in cor-rispondenza della parte terminale della carta (cui pre-sumibilmente manca, per rifilatura, una certa quanti-tà di scritto) cosicché i due testi, disposti l’uno sopral’altro, si trovano a essere sfalsati rispetto alle leggi cuisi riferiscono. Non v’è dubbio, infatti, che il primo ab-bia consonanza con C. 1.18.3, mentre il secondo corri-sponda a C. 1.18.4 pr., assente per le attuali condizio-ni di conservazione dalla carta, ma probabilmenteanch’esso in origine copiatovi:7
1 Ricordo che la beneventana è una scrittura che trae la propria ori-gine proprio dalla corsiva nuova alto medievale e, contrariamente aquello che avviene nell’Europa carolingia, mantiene tale suo conno-tato ‘originario’ per molti secoli; cfr. E. A. Loew (poi Lowe), The Beneventan Script, Oxford 1914, second ed. prepared and enlarged by V.Brown, Roma 1980 e F. Newton, The scriptorium and library at MonteCassino, 1058-1105, Cambridge 1999.
2 Si tratta del breve recordationis di una disputa avvenuta nel lugliodel 996 rogato da Petrus nobilis vir scriniarius et tabellio civitatis Nepesine(si veda L. M. Hartmann (ed.), Ecclesiae S. Mariae in via Lata tabula-rium, 1, Partem vetustiorem quae complectitur chartas inde ab anno 921 usquead a. 1045, Vindobonae 1895, pp. 30-31, n. 24; il memoratorium di una con-troversia agitata innanzi al pontefice nel dicembre 999 e rogato da Pie-tro scriniarius s. R. E., I. Giorgi-U. Balzani (edd.), Il regesto di Farfacompilato da Gregorio di Catino, 3, Roma 1883, p. 151 n. 437; la notitia di unplacito del 1012 (Giorgi-Balzani, Il regesto di Farfa cit., 4, Roma 1888,pp. 56-58 n. 658) e la notitia brevis di una vertenza, di nuovo svoltasi difronte al pontefice, del 2 agosto 1014 e rogata da Benedetto scriniariuss. R. E. (Giorgi-Balzani, Il regesto di Farfa cit., 4, pp. 199-202 n. 492).
3 Edita in Patetta, Adnotationes cit., pp. 294-296, si veda anche Cia-ralli-Longo, Due contributi cit., pp. 15-16, 25, 32, 54-55.
4 Nella prima ipotesi (copista educato alla beneventana che scrivein carolina) si danno due possibilità: a) stanziato in uno scriptorium lon-
tano dagli usi grafici beneventani il copista imita la minuscola comu-ne farcendola di spontanee emersioni della a lui più familiare bene-ventana; b) il committente del codice ha esplicitamente richiesto, a uncopista attivo in un centro di copia meridionale, di realizzare un ma-noscritto in minuscola comune perché alieno alla beneventana. Nellaseconda ipotesi, a mio parere meno verosimile, il copista tenterebbedi imitare, con incostanza e con esiti alterni e assai modesti, il tipo gra-fico beneventano in uso nello scriptorium che lo ospita. Sulla compre-senza di scritture minuscole di modello carolino e benenventana aMonte Cassino si veda C. Tristano, Scrittura beneventana e scritturacarolina in manoscritti dell’Italia meridionale, in «Scrittura e civiltà» 3(1979), pp. 89-150.
5 Dolezalek-Ciaralli, Codicis Justiniani Epitome cit., p. 82.6 Si osserva infatti l’uso, accanto alla forma più tradizionale, del se-
gno abbreviativo per ur secondo il modello beneventano associato, sidirebbe, al sistema di puntuazione interrogativo tipico di quella scrit-tura, si veda, per una più dettagliata descrizione, Dolezalek-Cia-ralli, Codicis Justiniani Epitome cit., pp. 83-86.
7 Nella colonna di sinistra si leggono le annotazioni marginali, inquella di destra i corrispondenti passi del Codex: il primo trascritto dalmedesimo frammento Beinecke, il secondo tratto dall’edizione Krü-ger.
Summaria nell’Epitome Beinecke
[Bo]nor(um) possessione intra annum non petita(m) [p]os-se perimi.
[P]ost divisione [s]i testam(en)ti vicium illucesserit secun-dum it sucessiones teneri.
Epitome Beinecke e Codex ed. Krüger
Si emancipata a pat[re] int(er) annu(m) bonor(um) posses-sionem petere cessasti, p(re)tendere iuris [ignorantiamnullis rationibus potes].
Si post divisionem factam testamenti vitium in lucememerserit, ex his, quae per ignorantiam confecta sunt, pra-eiudicium tibi non comparabitur.
materiali per una storia del diritto in italia meridionale 53
Non si tratta, evidentemente, dell’integrazione di costituzioni o materiali assenti, come avviene spessonei manoscritti epitomati più antichi, ma piuttosto diesposizioni sintetiche delle due norme, di cui com-pongono delle summae – delle epitomae appunto – esono l’equivalente (comprensivo di deformazioni, incomprensioni, avvilimenti morfologico-lessicali)dei summaria confluiti in quella che oggi chiamiamoSumma Perusina. Ma sono scritte senza dubbionell’xi secolo e non nel vii: cosa vieta ai compendiconfluiti nelle Adnotationes di appartenere anch’essialla medesima epoca? Se così fosse, si verrebbe acomporre un quadro più unitario, nel quale elabora-zione dei summaria (scritti, come aveva intuito Patet-ta e come conferma ora il frammento Beinecke, nelmargine di un manoscritto), loro utilizzazione nellaprassi giudiziaria e loro trascrizione in un unico con-tenitore non sono più tre fasi distinte e poco ragio-nevolmente distribuite nel tempo (rispettivamente,secondo le correnti opinioni, secoli vii/ix, x e x/xi),ma un unico momento che vide, tra gli ultimi annidel x secolo e la prima metà del successivo, più pra-tici del diritto (giusta l’intuizione di Niebuhr), attiviin un’ampia area dell’Italia centro-meridionale, af-frontare il Codex giustinianeo muovendo i primi passi, incerti e approssimativi quanto si vuole ma co-munque eloquenti, verso una sua migliore intelli-genza. In tale contesto troverebbe più facile spiega-zione pure il fatto che un testimone così indirettodell’opera, com’è il manoscritto perugino, si mostri,per quanto concerne l’integrità del testo, solidalecon una tradizione posteriore di appena qualche de-cina di anni, o anche, ormai siamo autorizzati a pen-sarlo, pressoché coeva.
9.
La Summa Perusina e l’epitome Beinecke – la primaben più consistentemente della seconda – rivelano,come s’è detto, punti di contatto con la cultura grafi-ca propria dell’Italia meridionale. Ma entrambe – e laseconda stavolta più della prima – mostrano evidenticonnessioni con la regione che, per omogeneità di esi-ti grafici, si è soliti denominare romanesca. Quella deimanoscritti vergati in minuscola tipizzata d’area ro-mana è un’altra delle ‘tradizioni perdute’1 (meglio sa-rebbe dire ritrovate) nella storia della trasmissione deitesti giustinianei e, a giudicare da ciò che sopravvive,essa rivela contorni di sicura importanza. Ne riassu-mo qui, in ordine cronologico, i contenuti noti:2
1. Bamberg, Universitätsbibliothek Jur. 1: Institutio-nes, secolo xi prima metà [Tav. vi];
2. Vercelli, Biblioteca Capitolare ms. 122: Epitome Iu-liani, Lex Dei, secolo xi prima metà [Tav. vii];
3. Würzburg, Universitätsbibliothek, M.p.j.f.m. 2: Co-dex, metà o terzo quarto dell’xi secolo [Tav. viii];
4. New Haven, Beinecke Library ms. 974: Epitome Co-dicis, seconda metà dell’xi secolo;
5. Köln, Stadtarchiv Cod. Wallfarianus 328: Institutio-nes, prima metà del xi secolo [Tav. ix];
6. Berlin, Staatsbibliothek Lat. folio 275: Codex, metàdel xii secolo [Tav. x].
Una raccolta, come si vede, di tutto rispetto (tra l’al-tro annovera un Codex che, si deve presumere, nonaveva forma epitomata: il n. 3). A contenderle il pri-mato sia per antichità, sia per varietà, sia infine perimportanza è la sola tradizione meridionale/bene-ventana.
1 Ricordo che, oltre al titolo di un romanzo di Margherita Speronidel 1914, il sintagma è usato, nel nostro settore, in F. Troncarelli,Tradizioni perdute. La Consolatio philosophiae nell’alto Medioevo, Pa-dova 1981.
2 Aggiungerei, ma per assonanze, più che per certezze, Montecas-sino, Archivio del Monumento Nazionale 49 (= Krüger ms. C) del pie-no xii secolo.
54 antonio ciaralli
Fig. 1. Firenze, Bibl. Mediceo Laurenziana, s.n., i c. 257r, Digesta domini Iustiniani augusti.
Fig. 2. ivi, i c. 257r, Digesta domini Iustiniani augusti, particolare.
Tavola. i.
materiali per una storia del diritto in italia meridionale 55
Tavola. ii.
Fig. 2. ivi, i c. 17r: hic ap(pone).Fig. 1. ivi, i c. 17r: hic d(esine).
Fig. 4. ivi, i c. 146v: stinc.
Fig. 3. ivi, i c. 52v: usque huc.
Fig. 6. ivi, i c. 256v: stinc.Fig. 5. ivi, i c. 183v: usque huc.
Fig. 8. ivi, ii c. 474r: quide(m).Fig. 7. ivi, i c. 12r: atis.
materiali per una storia del diritto in italia meridionale 57
New Haven, Yale University, Beinecke Library ms. 974r, Codex Iustinanus epitome.
Tavola. iv.
58 antonio ciaralli
Fig. 1. Fragmenta Londiniensia.
Fig. 2. New Haven, Yale University, Beinecke Library ms. 974, particolare, Codex Iustinanus epitome.
Tavola. v.
materiali per una storia del diritto in italia meridionale 59
Bamberg, Universitätsbibliothek Jur. 1, c. 4r, Institutiones Iustiniani augusti.
Tavola. vi.
60 antonio ciaralli
Vercelli, Biblioteca Capitolare ms. 122, c. 5v, Epitome Iuliani, Lex Dei.
Tavola. vii.
materiali per una storia del diritto in italia meridionale 61
Würzburg, Universitätsbibliothek, M.p.j.f.m. 2, Codex.
Tavola. viii.