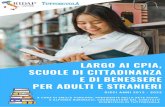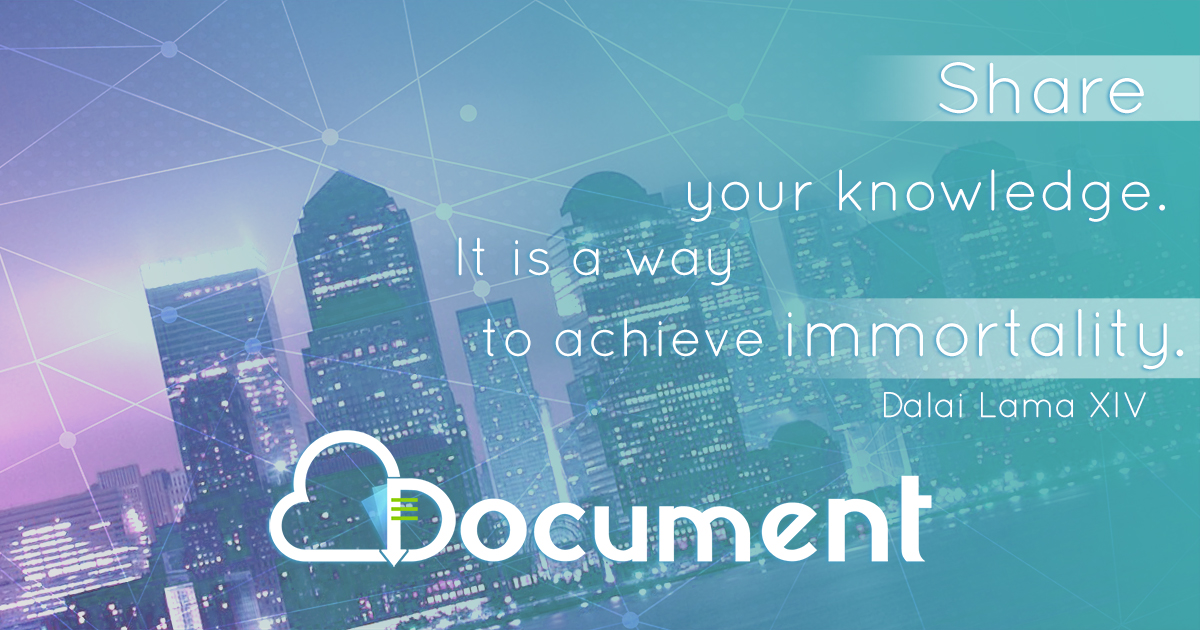Diritto e scuole dell'ebraismo di Alfredo Mordechai Rabello
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Diritto e scuole dell'ebraismo di Alfredo Mordechai Rabello
Diritto e scuole dell’ebraismo
di Alfredo Mordechai Rabello
1. Diritto ebraico e diritto israeliano - 2. Le fonti primarie - 2.1. La Bibbia - 2.2. La Mishnà e le raccolte di legge orale (70-220 ca.) - 2.3. Il Talmud di Erez Israel e quello di Babilonia - 3. Le codificazioni e i responsa - 3.1. Dal Talmud al Mishné Torah di Maimonide (HaRambam, 1138-1204)- 3.2. Dal Maimonide allo Shulchan Aruch di rabbì Josef Caro (1488-1575) - 3.3. I responsa - 4. Il diritto ebraico nel Novecento - 4.1. Introduzione - 4.2. Responsa, rispondenti e leader spirituali del XX secolo - 4.3. Il diritto ebraico nello Stato di Israele. Matrimoni e divorzi nei tribunali rabbinici dello Stato di Israele - 4.4. Cenni ad alcune problematiche sorte nei rapporti religio-ne-Stato - 4.5. Lo studio accademico del diritto ebraicoBibliografia p. 767
1. Diritto ebraico e diritto israeliano
Con il nome «diritto ebraico» (Mishpat ivrì) si intende il diritto del popolo ebrai-co, dall’epoca biblica fino ai nostri giorni; si tratta, infatti, di un diritto non relegato allo studio astratto, ma collegato alla vita giorna-liera, e ciò anche durante il lungo esilio del popolo ebraico dalla sua terra, Erez Israel, e la dispersione (diaspora). È pertanto un di-ritto che si è sviluppato continuamente, at-traverso diverse vie, col fine di apportare a chi la richiedeva la risposta della Torah, inse-gnamento ritenuto di origine divina, ma af-fidato alla interpretazione della Legge orale e dei Saggi (Chachamim). Il nome mishpat ha vari significati e accanto a quello di «dirit-to» come sistema legislativo, comprende an-che quello di fatto legale, atto di giudizio, de-cisione, giustizia, costume o uso.
La letteratura ebraica rabbinica si consi-dera divisa fra la Aggadà, avente carattere di insegnamento teologico, teosofico, storioso-fico, omiletico e la Halachà, avente caratte-re giuridico: la Halachà, dalla radice «anda-re» si propone appunto di insegnare all’uo-mo come comportarsi nei vari frangenti del-la vita e tale nome è anche usato per indica-re la decisione finale sul modo di osservare un precetto [cfr. Levitico 26,3: im bechukotai telechu, «se andrete secondo le Mie leggi»].
Secondo il sistema giuridico ebraico non vi è differenza sostanziale fra norme che riguar-dano i rapporti fra l’uomo e l’Eterno (come ad esempio la preghiera, l’osservanza del sa-bato e delle feste, il santuario ed il Beth Ha-keneset o sinagoga) e quelle che riguardano i rapporti fra l’uomo ed il proprio prossimo (come ad esempio le regole sulla compraven-dita e sulla buona fede nelle relazioni com-merciali, il matrimonio, l’omicidio, la mala lingua): entrambe sono considerate norme giuridiche; tuttavia, specialmente negli ul-timi due secoli, si è chiamato diritto ebrai-co quella parte di Halachà che corrisponde alle materie comunemente considerate giuri-diche nel mondo occidentale; si deve anche tener presente che la violazione di un dove-re verso il prossimo è considerata comunque trasgressione verso l’Eterno, che ha coman-dato anche quell’obbligo.
Il diritto ebraico ha, al tempo stesso, un carattere religioso e nazionale. Dal diritto ebraico va tenuto distinto il diritto israeliano, che è il diritto dello Stato di Israele (definito-si in alcune sue «leggi fondamentali» come «Stato ebraico e democratico»), come è stato stabilito dai suoi organi democratici, molto spesso indipendentemente dalla tradizione giuridica ebraica. Prenderemo ora in esame le fonti del diritto ebraico, pregando il let-tore di questo dizionario, che si interessa in particolare del XX secolo, di considerare che dal punto di vista religioso si tratta di fonti presenti, con valore vincolante, e non di sem-plici testi storici.
2. Le fonti primarie
2.1. La Bibbia
La fonte primaria del diritto ebraico è la Bibbia, ed in particolare i cinque libri della Torah o Pentateuco (Bereshit o Genesi, She-mot o Esodo, Vaikrà o Levitico, Bemidbar o Numeri, Devarim o Deuteronomio). La To-rah, letteralmente «insegnamento», com-prende in senso lato tutto l’insegnamento ebraico, dalla Bibbia fino ai nostri giorni.
752 A.M. Rabello
Accanto al Pentateuco abbiamo i libri dei Neviim o Profeti (Giosuè, Giudici, 1-2 Sa-muele, 1-2 Re, Isaia, Geremia, Ezechiele e i dodici profeti: Osea, Joel, Amos, Ovadia, Giona, Michà, Nachum, Chavaccuc, Zefa-nia, Chaggai, Zaccaria, Malachi) e dei Che-tuvim o Agiografi (Salmi, Proverbi, Giobbe, Meghillot – Cantico dei Cantici, Ruth, Echà o Lamentazioni, Kohelet o Ecclesiaste, Ester –, Daniele, Ezra, Nechemia, 1-2 Cronache): dalle iniziali di questi nomi la Bibbia ebraica si chiama Tanach.
Il testo biblico è accettato come testo basi-lare da cui tutto promana, come un testo uni-co senza contraddizioni, che viene assunto se-condo la interpretazione data dalla Torah she-bealpé o legge orale, legge che, secondo la tra-dizione, è stata data dall’Eterno a Mosè sul Si-nai assieme alla legge scritta.
Anche nella Bibbia abbiamo versetti di ca-rattere prettamente giuridico, assieme a mol-ti altri che non hanno tale carattere: per la tradizione ebraica nella Torah sono contenu-ti 613 precetti, positivi e negativi, che l’Ebreo è tenuto ad osservare. Secondo tale tradizio-ne nella Bibbia sono contenuti anche i set-te precetti noachidi, dati cioè dall’Eterno ad Adamo e Noè e che debbono essere osserva-ti dall’umanità intera, discendente, appun-to, da Adamo e da Noè, e cioè: 1. l’obbligo di stabilire dei tribunali che applichino il di-ritto; 2. il divieto di blasfemia; 3. il divieto d’idolatria; 4. il divieto di omicidio; 5. divie-to di furto e rapina; 6. il divieto di immora-lità sessuale; 7. il divieto di mangiare un arto tratto da un animale vivo.
2.2. La Mishnà e le raccolte di legge orale (70-220 ca.)
Accanto alla legge scritta, contenuta nella Torah e nella Bibbia in genere, esiste una leg-ge orale, tramandata e ripetuta oralmente. La distruzione del santuario (70 e.v.), la perdita dell’indipendenza ebraica (135 e.v.) e la for-mazione di una vasta diaspora, fecero sì che si sentì sempre più viva la necessità di mette-re per iscritto anche la legge orale, compren-dente tutto l’insegnamento che si era svilup-
pato fino al II secolo: l’opera fu iniziata da al-cuni dei più grandi maestri, come rabbì Aki-và (strenuo difensore di Bar Kochbà e del-la sua disperata rivolta contro Roma al tem-po di Adriano, 132-135 e.v.) che compilò una prima raccolta di leggi tradizionali, chiamata Mishnat rabbì Akivà e, come rabbì Meir, di-scendente, secondo la tradizione, dell’impe-ratore Nerone: si ritiene che la sua opera sia stata inserita integralmente nella Mishnà, in cui ogni passo anonimo dovrebbe essergli at-tribuito.
Dopo la rivolta di Bar Kochbà gli impe-ratori Antonini e le autorità ebraiche cerca-rono un modus vivendi; esso fu raggiunto sotto rabbì Jehudà, figlio di Rabban Simeon ben Gamliel, chiamato Hanassi, il Patriarca («presidente», capo del gruppo legislativo nella terza e quarta generazione dei tannaim o maestri della Mishnà); fu riconosciuto dal popolo come la maggiore autorità, Rabbi, il maestro per eccellenza; egli operò in Galilea. Nel periodo fra la seconda metà del II secolo e la prima metà del III (nell’epoca cioè in cui fiorivano in Roma le scuole dei giuristi clas-sici ed in cui il giurista romano Gaio prepa-rava le sue Institutiones) rabbì Jehudà Hanas-sì preparò la più vasta raccolta di legge orale, ordinata sistematicamente, e la chiamò tout-court Mishnà, «ripetizione», studio.
La Mishnà raccoglie una serie ingente di tradizioni, riportandole a nome dei Tannaim che le hanno riferite; sono riportate anche le opinioni di minoranza, cioè quelle opinioni che non sono state accolte come regola legale: «E perché viene ricordata l’opinione del sin-golo, accanto a quella della maggioranza, dal momento che la halachà non può essere che conforme alla maggioranza? Affinché se a un tribunale apparisse plausibile l’opinione del singolo, si possa appoggiare a quella…» [Mi-shnà, Eduyot, 1, 5]. La Mishnà, opera a carat-tere «codificatorio» del diritto ebraico, è di-visa in sei ordini, che comprendono sessanta trattati, ciascuno dei quali suddivisi in capi-toli e paragrafi; normalmente il materiale è ordinato secondo argomenti; il primo ordi-ne Zeraim o delle Semenze, contenente rego-le sulle benedizioni e la preghiera e sui pro-
753Diritto e scuole dell’ebraismo
dotti della terra di Israele, l’anno sabbatico, le offerte al tempio ecc; il secondo ordine, Mo’ed o «data stabilita», riguarda il Sabato e le altre festività; dal punto di vista stretta-mente giuridico particolare importanza han-no il terzo e quarto ordine, chiamati rispetti-vamente, Nashim («delle donne») e Nezikin («dei danni»): essi riguardano diritto pri-vato e penale, persona e famiglia, matrimo-nio e divorzio, levirato e contratti matrimo-niali; proprietà e responsabilità civile, dan-ni alle persone e alle cose, prestito, locazio-ne, diritto processuale e mezzi di prova, Si-nedrio, pena di morte e percosse; città di ri-fugio, giuramenti e testimonianze, decisio-ni ecc. un «intermezzo morale» è costitu-ito dal trattato di Avot, dei padri con mas-sime a contenuto etico, con gli aforismi che più stavano a cuore ai maestri della Mishnà, come a ribadire ancora una volta il carattere inseparabile delle norme, tutte rivolte a costi-tuire una società che aspirasse a divenire un «reame di sacerdoti, popolazione consacra-ta» (Levitico). Gli altri due ordini conten-gono nuovamente materiale più strettamen-te religioso, con Kodashim (cose sante) e Ta-horoth (cose pure), con le regole sui cibi per-messi, i sacrifici e le regole di purità.
È discusso quale fosse il carattere del-la Mishnà; vi è chi ritiene che rabbì Jehudà si limitò ad una semplice raccolta della leg-ge orale, riportando le opinioni dei diver-si saggi, mentre per altri egli desiderò crea-re un codice normativo da cui si debba de-durre la regola. La Mishnà è scritta in lin-gua ebraica, chiara e semplice; il suo metodo è prevalentemente casistico, ciò che ha per-messo, attraverso un vasto uso del distinguo, una continua interpretazione e discussione, che inizierà, subito dopo la sua fissazione, nelle Yeshivot, scuole talmudiche, e troverà poi il suo posto nel Talmud [su cui, infra]. La Mishnà è stata studiata e commentata nel corso dei secoli: fra i più famosi commenti alla Mishnà ricordiamo quello di Maimoni-de, nel XII secolo e di rabbì Ovadià Jaré di Bertinoro (in Romagna), alla fine del XV se-colo. La Mishnà si cita per trattato, capito-lo e paragrafo.
Diamo ora un esempio di una Mishnà; ac-canto alle regole sulle offerte, possiamo tro-vare importanti regole a carattere giuridico; ciò è frutto di una visione che vede l’origine di ogni regola nell’Eterno stesso, e la minu-ziosa osservanza di tale regole è vista come la via per servire l’Eterno. Così a proposito del-le offerte, leggiamo: «E come si deve inten-dere l’espressione: Tu non devi contaminar-la? Se a mò d’esempio un tale va da un luogo all’altro portando dei pani di offerta e (s’im-batte in) un idolatra (che) gli dice: Damme-ne uno che lo contamini altrimenti conta-mino tutti; rabbì Eliezher dice: Contamini tutti, ma non glie ne dia uno che contamini; rabbì Jehoshua dice: Gliene collochi uno su una pietra» [Mishnà Trumot 8,11] ed in tal modo non dà lui stesso l’oggetto da rendere impuro; infatti il problema è quello di evita-re di dare direttamente, per nostro volere sia pure in caso di costrizione (coactus, tam vo-lui), un oggetto puro perché sia contamina-to; partendo da questo caso, per somiglian-za, la Mishnà successiva tratta invece di un caso di violenza che può essere esercitato su una o più donne: «Così pure se degli idola-tri dicono a parecchie donne: Dateci una di voi che la disonoriamo, altrimenti vi violen-tiamo tutte, si lascino piuttosto violentare tutte, anziché dare loro in mano una figlia d’Israele» [Mishnà Trumot 8,12]. Le don-ne sono quindi comandate a non consegna-re una di loro, volontariamente, a chi ne fa-ceva richiesta; dal punto di vista giuridico si tratta di un caso di costrizione (ones) e quin-di anche chi avesse trasgredito al divieto non sarebbe stato punibile penalmente; è eviden-te però la gravità della richiesta di agire in un modo moralmente superiore: secondo l’in-terpretazione che verrà data dal decisore me-dievale Maimonide si tratta qui di un caso di santificazione del Nome dell’Eterno.
Accanto alla Mishnà abbiamo altre rac-colte di fonti tannaitiche, come la Toseftà, o «aggiunta», opera la cui redazione finale, dovuta a rabbì Chija e rabbì Oshaia, risale al III secolo e le baraitot, testi che non sono stati inseriti nella Mishnà né nella Toseftà. Impor-tanza del tutto particolare ha il Midrash, me-
754 A.M. Rabello
todo di interpretazione omiletica («richie-sta», cioè chiedere a un verso biblico quale sia il suo significato). Riportiamo, a mo’ di esempio il testo della Toseftà, Trattato Tru-mòt 7,20 (che tratta di un problema analogo a quello dell’omonima Mishnà, esaminata sopra): «A un gruppo di uomini dei pagani hanno detto: dateci uno di voi (a vostra scelta; questo sta a dimostrare che la richiesta è arbi-traria, non è basata cioè su una responsabilità di una determinata persona) e lo uccideremo, se no uccideremo tutti, uccidano pure tutti (si lascino pure uccidere tutti) ma non con-segnino loro una persona di Israel (appunto perché la loro richiesta è illogica, determina-ta probabilmente da antisemitismo, come di-mostrerà la storia di Israele nelle varie gene-razioni in Europa). Ma se hanno specificato, come specificarono per Scéva ben Bichrì [È stato fatto il nome di una persona che viene richiesta (il cui caso è descritto in Samuel II, cap. 20), e si può quindi pensare che tale per-sona avesse compiuto una trasgressione ver-so chi veniva ora con tale richiesta. Il parago-ne con Sceva ben Bichrì pone però anche un altro problema, dato che egli era un ribelle al regno di David, e come tale passibile di pena di morte; il problema che si pone è quindi: sarà sufficiente aver ricevuto una richiesta di consegnare una persona precisa, oppure sarà necessario che tale persona sia anche passibi-le di pena di morte secondo la Halachà ebrai-ca?], lo consegnino loro e non uccidano tutti. Disse rabbì Jehudà: A quale caso si riferisce? Quando egli è dentro (le mura di una città) e loro sono fuori (non esiste quindi lo stes-so grado di pericolo), ma quando egli è den-tro e loro sono dentro (si trovano tutti dentro le stesse mura, oppure nello stesso palazzo), siccome lui sarà ucciso e loro saranno ucci-si, lo consegnino e non uccidano tutti». Tale testo, scritto in un periodo prossimo alla dura repressione romana della rivolta di Bar Kochbà (132-135) viene a cercare una solu-zione pratica ad un problema vivamente sen-tito, la cui soluzione prende spunto dall’epi-sodio biblico riportato nel cap. 20 del II li-bro di Samuel, in cui è riportato che quando le truppe regie iniziarono l’assedio della città
in cui si era rifugiato Scéva ben Bichrì, ribel-le al re David, una donna propose nella sua saggezza – secondo le parole del testo bibli-co – al comandante Joav di consegnare il ri-belle e risparmiare così la città; sulla possibi-lità di basarsi su tale episodio, che si riferisce ad un ribelle al regno di David, per risolvere una problema con il nemico, si trovarono di-visi alcuni dei Saggi. Il testo della Toseftà sarà anch’esso alla base delle discussioni talmudi-che e sarà studiato dai decisori, assieme ad al-tri brani e mostra in modo chiaro il dilemma di fronte al quale ci si trova: in quali casi sarà possibile far causare la morte di una perso-na – purtroppo il problema è stato ben lun-gi dall’essere solo teorico – per far salvare un pubblico intero, ed in quali invece dovrà mo-rire il pubblico intero, compresa la stessa per-sona di cui era stata richiesta la consegna?
2.3. Il Talmud di Erez Israel e quello di Ba-bilonia
Dopo la redazione della Mishnà iniziò un intenso periodo di suo studio, commento e discussione, nelle Yeshivot, accademie talmu-diche di Erez Israel e Babilonia; nonostan-te la perdita dell’indipendenza i Chacha-mim stabilirono essere dovere religioso quel-lo di far decidere le cause fra ebrei da tribu-nali ebraici; il Popolo rispose a tale appello e si sviluppò, praticamente fino all’epoca della emancipazione (XVIII secolo), un sistema di autonomia giuridica ebraica, grazie appun-to anche al carattere religioso (e non solo na-zionale) del diritto ebraico. La redazione del Talmud palestinese risale all’inizio del V se-colo, periodo corrispondente alla cessazione dell’attività della scuola di Tiberiade, mentre quello babilonese venne redatto verso la metà del VI secolo (periodo corrispondente a quel-lo della redazione del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano): i maestri del Talmud si chia-mano Amoraim. Il Talmud è basato sulla di-scussione viva che si svolgeva nelle scuole, le Yeshivot, discussione alla quale segue, talvol-ta, la decisione formale. L’opera è considerata di fondamentale importanza e la fonte prin-cipale del diritto ebraico, una compilazione
755Diritto e scuole dell’ebraismo
omnicomprensiva della legge orale, sentita come vincolante. Questa opera monumenta-le, mare magnum, è fra le più studiate ed ogni decisione pratica, ogni responso rabbinico erudito, si apre con la fonte talmudica che ri-guarda il caso; la lingua usata è l’aramaico as-sieme all’ebraico. Secondo il rav Adin Stein-salz, un moderno studioso che ha contribui-to notevolmente a rendere accessibile la com-prensione del Talmud, con una edizione e commento più popolare, l’idea fondamenta-le del Talmud è di concretizzare idee astrat-te, di tradurre idee generali nella loro realiz-zazione, fino nei minimi particolari. Questa idea è senz’altro comune a tutta la letteratu-ra rabbinica, ma essa assume un carattere del tutto peculiare quando ci troviamo di fron-te a problemi di fede, cioè di relazione diretta fra l’uomo e l’Eterno e fra l’Eterno e l’uomo, vale a dire fra cosa l’Eterno chiede all’uomo e ciò che l’uomo osa chiedere all’Eterno nel-la sua preghiera, nella sua supplica: potrebbe sembrare, a prima vista, che non vi dovessero essere delle regole al riguardo e che tutto ciò dovesse costituire solo uno spontaneo moto dell’animo. Invece così non è: preghiere, be-nedizioni, lettura dello Scemà (tre brani bi-blici comprendenti la proclamazione dell’as-soluta unità dell’Eterno ed alcuni precetti, fra cui quello dell’amore e timore diell’Eter-no, tefillin o filatteri, la mezhuzhà, il talled) vengono minuziosamente regolati; le idee astratte vengono così tradotte in parole e ge-sti concreti; tuttavia i maestri sono consape-voli del rischio di giungere solo ad una for-mula arida ed esterna, che non sia il vero ri-flesso di un animo sincero, e per questo essi ammoniscono: «Non fare della tua preghie-ra una cosa fissa, ma pietà e suppliche»; è in-teressante notare che il maestro stesso si ri-ferisca innanzi tutto all’obbligo di recitare lo Scemà; il testo completo infatti dice: «R. Simeone diceva: Sta bene attento alla lettu-ra dello Shemà e delle orazioni, ed allorché preghi non fare della tua prece una faccenda consueta, ma bensì (come) un (atto di) implo-rare la clemenza e la grazia del Signore, con-forme al testo che dice: [Joel, II,13] Perocché clemente e misericordioso Egli è, lunganime
e di grande benignità e pronto a pentirsi del male…» [Mishnà, Avot, 2, 13]. I maestri per-tanto sono decisi a trovare una via per con-cretizzare le idee, per non lasciarle astratte, ma renderle con una forma propria nella vita di ogni giorno [A. Steinsaltz, Introduzione al Trattato di Berachot, Talmud Bavli, Gerusa-lemme, 1976 (in ebraico), 7 s.]. La Torah, la Mishnà ed il Talmud sono le fonti primarie, che stanno in cima della piramide delle fon-ti di cui si servirà il decisore; il Talmud for-nisce anche dei principi di legislazione, ricchi di conseguenze. Nella Novella 146 l’impera-tore Giustiniano (553) proibirà l’uso del Tal-mud e della legge orale (deuterosis).
3. Le codificazioni e i responsa
3.1. Dal Talmud al Mishné Torah di Mai-monide (HaRambam, 1138-1204)
Dopo la chiusura del Talmud incomin-cia a venir meno nell’ebraismo la presenza di una autorità centrale, riconosciuta unanima-mente, anche se non mancheranno persona-lità di eccezionale grandezza; l’attività creati-va è meno intensa; l’autorità in materia giu-ridica passa ai Gheonim, od eccellenze (capi delle accademie talmudiche di Babilonia); il Talmud viene stabilito da tali maestri come fonte autoritativa; esso deve essere studiato, discusso, ma non si può essere in disaccordo con quanto in esso stabilito come Halachà. un maestro del Talmud non può contrad-dire un maestro della Mishnà (a meno che si basi su un altro maestro della Mishnà), ed un Gaon o una autorità successiva, non può con-traddire un maestro del Talmud.
Accanto alla attività halachica, che si pro-pone di fissare il testo vincolante per la vita pratica dell’ebreo, viene sviluppata una at-tività interpretativa volta a stabilire l’esat-ta interpretazione – interpretazione secon-do il senso semplice (peshat), letterale op-pure secondo l’interpretazione tradiziona-le – dei testi vincolanti, come Bibbia e Tal-mud: è evidente che l’aver stabilito «l’esat-ta interpretazione» ha una enorme influen-
756 A.M. Rabello
za sui futuri decisori, che si rifaranno a que-ste interpretazioni, anche ogni volta che fa-ranno ricorso alle fonti prime, cioè a dire ogni volta che si farà ricorso, per esempio, ad un passo dell’Esodo si avrà presente an-che il commento di Rashi a quel determina-to passo. È questo il caso del commento alla Bibbia ed al Talmud di rabbì Schelomò ben Izchak (Francia, 1040-1105, comunemente noto con l’acronimo Rashì): il suo commen-to è stato accettato come classico ed accom-pagna ancor oggi i testi della Torah e del Tal-mud comunemente usati nel mondo ebraico; la sua interpretazione ha grande importanza come spiegazione autorevolissima del testo biblico (secondo la legge orale) e talmudico. Rashì ammette l’idea di una molteplicità di significati delle Scritture, egli cerca tuttavia di arrivare allo peshat, o significato semplice, letterale del testo, ritenendo possibile passa-re dalla Bibbia al Talmud, e viceversa, costi-tuendo essi un unico universo, Torah scritta e Torah orale.
Degno di nota il Sefer haalachot di rabbì Izchak Alfassi (1013-1073, conosciuto con l’acronimo Rif ). Il libro è ordinato secondo il Talmud, riportando solo le halachot attua-li per la sua epoca, facendo seguire ogni de-cisione di halachà da una breve discussione sul passo talmudico, citando spesso brani dal Talmud di Gerusalemme e qualche volta an-che le opinioni dei Gheonim; in caso di diver-genza fra i due talmudim, il Rif – stabilen-do il principio Hilchata kevatrei (la norma è secondo gli ultimi saggi) – decide secondo il babilonese essendo questo stato redatto qua-si due secoli dopo quello di Gerusalemme.
Il Maimonide (1138-1204) comprese che era necessario fornire al popolo non più una compilazione di testi, vicino alla lingua ori-ginale, bensì una opera nuova «categorica, razionale ed esatta dal punto di vista giuri-dico», che riportasse in buon ebraico le con-clusioni a cui si poteva arrivare dalla discus-sione talmudica, prescindendo dalla stessa; il tutto ordinato e elaborato logicamente e si-stematicamente. Maimonide ebbe al tempo stesso una enorme conoscenza e padronan-za del Talmud e della letteratura halachica
successiva, e facoltà analitiche e sintetiche, e fu in grado di offrire un’opera vasta e com-pleta, apparentemente semplice, che chiamò Mishné Torah (1170-1180), o ripetizione del-la Torah. Dei 14 «libri» (parti o trattati) del Mishné Torah contengono più propriamen-te il diritto ebraico i seguenti libri: il 4, Sefer Nashim (libro delle donne), con le regole sul-lo status personale, matrimonio e divorzio, levirato, la ragazza vergine, la donna sospetta di adulterio; il libro 5, hakedushà, sulla San-tità, contiene le regole sulle unioni sessuali proibite; il libro 11, Sefer nezikin o dei danni, contiene le regole sulla responsabilità civile e danni arrecati al patrimonio e alla persona; il 12, Sefer kinian o dell’acquisto, contiene le regole sulla compravendita, la donazione, il vicinato, il mandato, la società, gli schiavi; il 13, Sefer mishpatim o dei diritti, contiene le regole sull’affitto, il mutuo e il deposito, de-bitore e creditore, il prestito, l’eredità; infi-ne il 14 libro, Sefer shoftim o dei giudici, con-tiene le regole sul Sinedrio e le pene che gli erano affidate, regole sulla testimonianza e principi di diritto pubblico.
Il Mishné Torah ebbe un influsso enorme, ma fu anche al centro di vive polemiche: il Maimonide aveva fissato la regola basando-si certamente su una fonte di origine talmu-dica, oltre che su decisori posteriori, ma non aveva indicato su quale fonte si era basato per arrivare alla sua decisione; non avrebbe contribuito un lavoro di tal genere a rende-re, per così dire, superfluo lo studio del Tal-mud? E l’autore stesso quale scopo si era pre-fisso: di arrivare ad un’opera completamente nuova, che permettesse a chi studiava il suo libro di prescindere dal Talmud, oppure ave-va voluto fornire una guida a chi non si ritro-vava nel mare del Talmud stesso? Gli studiosi sono divisi tra di loro, e l’opera ebbe, accan-to a numerosi ammiratori, anche dei detrat-tori. Ciò che per alcuni era un pregio, per al-tri era un difetto, come ad esempio la via pre-sa da Maimonide per stabilire la regola lega-le categoricamente, senza nessun riferimento alla sua fonte o alle opinioni contrastanti. La cosa era stata segnalata dallo stesso Maimo-nide nell’Introduzione al Libro dei Precetti,
757Diritto e scuole dell’ebraismo
in cui l’autore fa espresso riferimento al Mi-shné Torah: «ho pensato che fosse anche op-portuno compilare una raccolta che abbracci tutte le regole della Torah e le azioni da essa volute fino a che non manchi nulla. Ed in quella raccolta cercherò, come son solito fare, di evitare di riportare le controversie e le opi-nioni che sono state respinte, e non vi stabi-lirò se non regole ben determinate, in modo che quella raccolta comprenda tutte le rego-le della Torah di Mosè nostro maestro – sia quelle di esse che sono necessarie in tempo di esilio sia quelle che non lo sono». Fra i più severi critici del Maimonide ricordiamo rab-bì Avraham ben David (Raavad), capo del-la Yeshivà di Posquières, autore di glosse cri-tiche al compendio del Rif ed al Codice del Maimonide.
3.2. Dal Maimonide allo Shulchan Aruch di rabbì Josef Caro (1488-1575)
La storia della codificazione del diritto ebraico prosegue con Rabbenu Jaacov ben Asher (Colonia 1270 c.a - Toledo 1343 c.a.), che compose un’opera di Halachà, Arbaa Turim (le quattro colonne): egli spiega la tra-gica situazione in cui si trova la maggior par-te del popolo ebraico dopo la distruzione del santuario, l’esilio e l’allontanamento dallo studio ed il deterioramento della pratica le-gale, notando come la proliferazione dei li-bri di Halachà renda difficile ad un comune ebreo poter arrivare alla conclusione di qua-le sia la norma legale; egli si rende conto della necessità di una codificazione che tenga con-to di tutti i risultati raggiunti. Partendo dal testo talmudico, l’autore dà una grande im-portanza al diritto civile. Da un lato la sua codificazione è anch’essa «anonima», sen-za riportare cioè il testo talmudico o la fon-te da cui ha preso la decisione; dall’altro egli non esita a riportare opinioni divergenti nel-la interpretazione del testo talmudico o nel-la fissazione della Halachà, per es. l’Alfassi, il Maimonide e suo padre, R. Asher (haRosh), tenendo conto quindi di tutta l’ampia atti-vità di Responsa che si era venuta sviluppan-do; l’opera è divisa in quattro parti, seguen-
do dal lato metodologico il Maimonide, ma con un ordinamento della materia differen-te dal suo: 1) Orach Chaim (Il cammino di vita, Salmi 16,2) contiene le regole sullo svol-gimento della vita quotidiana dell’Ebreo, con le Tefillot o preghiere, il Talled e i Tefil-lim, lo Shabbat e le Feste; 2) Joré Deà (Inse-gna saggezza, Isaia 28,9), comprendente an-che le regole del prestito ad interesse e la proi-bizione dell’usura e gli aspetti finanziari del dovere dei figli di onorare i genitori; 3) Even haezher (La pietra dell’aiuto, I Samuele 4,1) contenente il diritto di famiglia ed in parti-colare le regole sulla procreazione ed i matri-moni proibiti; gli aspetti finanziari del ma-trimonio; il divorzio; 4) Choshen Mishpat (Pettorale del giudizio, Esodo 28,29), conte-nente il diritto civile. L’opera godette anche di importanti commenti, fra cui il più famo-so è il Bet Josef di rabbì Josef Caro.
Il periodo che va dalla codificazione di Jaacov ben Asher a quella di Josef Caro è stato segnato da importanti e spesso crucia-li eventi, sia nella vita del popolo ebraico, sia nella storia generale, quali la caduta dell’im-pero romano d’Oriente (1453), la scoper-ta dell’America e la cacciata degli ebrei dal-la Spagna (1492), la Riforma di Martin Lu-tero (1483-1546) ed infine, nel XV secolo, l’invenzione della stampa; in seguito a per-secuzioni importanti comunità ebraiche in Germania furono cancellate e la geografia delle comunità ebraiche fu totalmente muta-ta, anche in seguito alla cacciata degli ebrei dalla Spagna, dal Portogallo e dalla Sicilia ed all’emigrazione in Polonia, Turchia, Erez Israel, Egitto e Nord Africa. Fu questo un pe-riodo in cui alcune autorità rabbiniche cer-carono di ripristinare la semichà (ordinazio-ne e rabbì Josef Caro fu uno dei primi ad es-sere «ordinato») per restaurare la suprema autorità in campo di Halachà, il Sinedrio. R. Joseph Caro volle attuare, con la sua at-tività codificatoria, parte del progetto. Nato a Toledo nel 1488 e morto a Safed in Gali-lea, nel 1575, Josef Caro è considerato l’auto-re del più autorevole e seguito Codice ebrai-co. Possiamo dire che tale codice sia compo-sto di due parti: una per i sapienti, il già ricor-
758 A.M. Rabello
dato Bet Josef con l’indicazione delle fonti e del metodo e con profondissime discussioni, l’altra per tutto il popolo, lo Shulchan Aruch. Nella sua introduzione al Bet Josef, il profon-do commento ai quattro Turim al quale l’au-tore dedicherà vent’anni per la sua compila-zione ed altri dodici per le annotazioni, egli fa presente la difficile situazione in cui si tro-vavano gli ebrei, anche dal punto di vista spi-rituale, e il grave pericolo della frantumazio-ne della Torah a secondo delle varie diaspo-re. Il Caro, prendendo spunto dal testo dei Turim di R. Jaacov ben Asher, sperando che questo possa essere generalmente bene accet-to, data l’origine ashkenazita del suo autore e quella sefardita del Caro, decide di presen-tare una vasta gamma di opinioni. Oltre alle fonti talmudiche, egli si serve infatti di scrit-ti di 32 fra i più importanti autori di Hala-chà, proponendosi anche lo scopo di arriva-re a stabilire quale era la regola vincolante. A tal uopo, egli fissa un metodo particolare; una volta stabilito che i tre pilastri dell’inse-gnamento sono l’Alfassi (Rif ), il Maimonide (Rambam) e Rabbenu Jaacov ben Asher, l’au-tore dei Turim, egli fissa la regola che quan-do due di loro siano d’accordo su una que-stione, la Halachà sarà secondo la loro opi-nione, fatta eccezione per pochissimi casi, in cui la maggioranza delle autorità halachiche abbia seguito una differente opinione op-pure se esista un uso contrario; quando uno dei tre taccia, e gli altri due siano divisi fra loro, ci si rivolgerà ad altre autorità (espressa-mente nominate) per stabilire la regola a se-conda della loro maggioranza; quando nes-suna delle tre autorità si sia espressa in me-rito, ci si rivolgerà ad altre ben note autorità halachike. Si noterà come Alfassi e Maimo-nide fossero sefarditi, come del resto lo stes-so Caro: non fa quindi stupore se nella sua opera c’è una preferenza per gli usi sefardi-ti, cosa questa che causò non poche difficoltà alla diffusione della sua opera, nonostante il desiderio dell’autore di risolvere anche que-sto inconveniente. R. Josef Caro non prende quindi generalmente una decisione in base al merito degli argomenti trattati, bensì segue una via tecnica, basata sulla maggioranza di
un numero di autorità prestabilito. Egli di-scute le varie opinioni ed arriva alla sua de-cisione nel Bet Josef, opera che lui stesso defi-nisce il suo opus magnum. una volta ultima-to questo enorme lavoro halachico, il Caro si accingerà a preparare un lavoro più ristretto, in cui apparirà, sempre secondo l’ordine dei Turim, soltanto la decisione finale, la regola da seguire, esposta in forma semplice e com-prensibile e senza l’apparato delle fonti; tale opera fu chiamata Shulchan Aruch (la tavola apparecchiata), con lo scopo pratico di per-mettere ad ogni Ebreo di seguirlo. Il Bet Josef, infatti, non si proponeva di essere alla porta-ta di ognuno, mentre la nuova opera aspirava ad essere conosciuta anche da comuni allie-vi, per non far dimenticare la Torah dal po-polo, scopo questo che era già stato del Mai-monide. L’opera fu compilata a Birya e Safed, in Galilea nel 1563 (più di 1350 anni dopo che, sempre in Galilea, rabbì Jehuda Hanas-sì aveva completato la Mishnà!) e fu stampa-ta a Venezia nel 1565; essa godette di diver-se ristampe già in vita del suo autore e diven-ne la base per ogni futura opera di Halachà ed ancor oggi, assieme al «completamento» ashkenazita, le glosse di rabbì Moshé Isserles, è considerata il principale libro autoritativo nel campo della Halachà. Lo Shulchan Aruch è diviso in quattro parti, come i Turim: Orah Chaim, Yoreh Deah, ’Even haezher, Choshen Mishpat: ciò per il motivo che Caro seguì per la preparazione dello Shulchan Aruch la sua stessa opera, il Bet Joseph, che è appunto un commento, articolo per articolo, ai quat-tro Turim. L’opera è divisa in sezioni, capi-toli e paragrafi. Essa omette completamente ogni fonte della norma ed ogni valutazione, essendo quindi ancor più conciso del Mishné Torah del Maimonide: è stata proprio questa opera ad essere stata considerata la codifica-zione/compilazione per eccellenza e ad esse-re ritenuta vincolante da parte del popolo e dei suoi maestri.
L’opera del Caro non avrebbe potuto ave-re il successo che ebbe, senza il complemen-to di Rabbi Moshé Isserles (1530-1572); con-trariamente ai suoi maestri, egli ritenne la codificazione un’opera meritoria e necessa-
759Diritto e scuole dell’ebraismo
ria; egli fu in corrispondenza con il Caro, dopo la pubblicazione del Bet Josef e dello Shulchan Aruch; per far sì che questo libro risultasse adatto anche al mondo ashkena-zita, egli preparò delle glosse allo Shulchan Aruch, conosciute con il nome di Mappà (tovaglia, che viene aggiunta al tavolo appa-recchiato per la Halachà). R. Caro non ave-va tenuto conto di un gran numero di auto-rità francesi, tedesche e polacche ed il Remà studiò ogni articolo del Caro aggiungendo la regola seguita dagli ashkenaziti. L’atteggia-mento di base del Remà era critico verso lo Shulchan Aruch e la forma di comando sen-za discussione, quasi che fosse Torah data di-rettamente dall’Eterno a Mosè (come spie-ga nella sua introduzione all’opera); egli tut-tavia aveva una enorme stima per rabbì Jo-sef Caro ritenendo il suo lavoro, nel suo in-sieme, eccellente. È quindi interessante nota-re che proprio la mappà del Remà permette-rà allo Shulchan Aruch la sua sopravvivenza e la sua diffusione anche nell’ambiente ashke-nazita fino a divenire il «codice definitivo e autoritativo» per tutti gli ebrei; non cessaro-no però anche le critiche, specialmente di co-loro che proseguirono a sostenere che ogni decisione andava presa secondo il Talmud, tenendo conto anche del Mishnè Torah, dei Turim e dello Shulchan Aruch. In particola-re è da segnalare l’opinione di coloro che ri-tengono la codificazione essere contrastante con il principio che «la halachà è secondo le ultime autorità». È una polemica che conti-nua, per esempio negli scritti di Jehudah Liva ben Bezalel (1520-1609); d’altro lato prose-guono anche gli autori favorevoli alla codifi-cazione, che preparano nuovi commenti allo Shulchan Aruch, nonché abbreviazioni a ca-rattere popolare i quali però, per l’autorità di chi li ha preparati, hanno assunto anch’es-si una grande popolarità e sono stati tradot-ti in varie lingue moderne. Si può vedere qui un aspetto del tutto particolare della grande discussione che divide anche il mondo giuri-dico moderno, sulla necessità di una codifi-cazione, sul suo valore rispetto alla tradizio-ne, sul suo valore per una società in continua evoluzione: nei testi del diritto ebraico non
si parla certo di Common Law e Civil Law, di Codificazione e di Decodificazione, ma un accurato esame della problematica dimostra che anche il diritto ebraico ha avuto discus-sioni non molto diverse di quelle che si sono avute e si hanno oggi nel mondo giuridico occidentale.
3.3. I responsa
Accanto alla attività che abbiamo defi-nito codificatoria, si è venuta sviluppando una fonte importantissima del diritto ebrai-co, quella delle Teshuvot cioè quel genere let-terario conosciuto dai giuristi romani con il nome di responsa prudentium e nel dirit-to musulmano con quello di fatwa. L’impor-tanza dei responsa per lo studioso è data in particolare dal fatto che la domanda e la rela-tiva risposta riflettono la realtà vissuta in un certo luogo ed in un certo periodo, entran-do nei dettagli del caso; spesso era lo stesso giudice o il rabbino del luogo che, non riu-scendo ad uscire dal dubbio o volendo essere confortato nella sua decisione, si rivolgeva ad una autorità halachica, esponendogli il caso e chiedendo il suo parere. Il fenomeno dei re-sponsa inizia già nel periodo della Mishnà e del Talmud, trovando i principali respon-sa inseriti direttamente nel testo talmudico, per quella parte che riguardava direttamen-te il problema trattato, senza costituire quin-di un genere letterario distinto; tale genere si avrà a partire dal periodo dei Gheonim. una volta creatosi un buon numero di responsa si è venuto a creare un sistema simile al case law inglese in cui Judge-made law. Lo scopo del decisore è pratico, risolvere cioè una de-terminata situazione giuridica realmente esi-stente. Anche questo fatto ha la sua impor-tanza giuridica, dovendosi – per disposizio-ne talmudica – dare la preferenza a ciò che risponde alla pratica attuale [Talmud Bavli Shabbat 21a e Bava Batra 83a]. È anche per questo motivo che, secondo alcuni autori, in caso di contrasto fra un libro «codificato-rio» ed un responsum, deve essere preferito quest’ultimo; a questo argomento viene ag-giunto che il senso di responsabilità e l’ispi-
760 A.M. Rabello
razione divina si trovano di più presso coloro che debbono prendere una decisione pratica; tuttavia altri autori danno preferenza pro-prio al testo «codificatorio», dal momen-to che generalmente un responso deve essere dato con una certa velocità, mentre chi pre-para un trattato «codificatorio» ha il tem-po di consultare tutti i testi e di ponderare le cose. Normalmente preparavano responsa le maggiori autorità, secondo un principio che era stato già stabilito in Deuteronomio [17,8-13]; vi furono centri, in Palestina e Babilo-nia, unanimente riconosciuti come l’autorità a cui si doveva obbedire; questo fatto permi-se di mantenere una certa uniformità nella giurisdizione. I responsa permisero di trovare una soluzione ad un gran numero di proble-mi che non aveva trovato pratica, diretta so-luzione nei libri «codificatori», dimostran-do così la continua vitalità del diritto ebrai-co in ogni terra della diaspora, ove esisteva una autonomia giurisdizionale ebraica alme-no sino alla Emancipazione (fine del XVIII secolo). In altri casi abbiamo, come possia-mo notare dall’esempio qui riportato, uno sviluppo di quanto abbiamo trovato nel Mi-shné Torah del Maimonide; riguardo al pro-blema del riconoscimento della legge (non ebraica) dello Stato in cui ci si trova, abbia-mo un responsum del Ramban (o Nachma-nide), riportato dal Maarik (Rabbi Josef Co-lon) nel suo libro di responsa, Sheelot utshu-vot [Venezia 1519, 61]: «Mi pare che il prin-cipio: la legge dello Stato è legge si applichi soltanto a norme stabilite in tutto il regno, che i re antecessori hanno applicato e così sono scritte sugli annali; ma ciò che il re fa al momento o un nuovo statuto che egli fa al momento per multare il popolo e che non è stato fatto dagli avi suoi, è violenza del re e non vi si applica il principio: la legge dello stato è legge». È stato sostenuto che esisto-no più di 300.000 responsa contenuti in più di tre mila libri. L’importanza della «tradi-zione orale» appare anche in questo settore: talvolta infatti l’autore del responsum, pur essendo lui già una grande autorità indipen-dente, dice espressamente, di aver consulta-to il proprio maestro. In Italia operarono al-
cuni studiosi ashkenaziti come R. Yosef Ko-lon (1420-1480), che compose numerosi re-sponsa a Mantova (Shut Maharik) (pubblica-ti a Venezia nel 1509) e R. Meir ben Izchak Katznelboghen, Maharam di Padova (1482-1565).
4. Il diritto ebraico nel Novecento
4.1. Introduzione
Tre fenomeni hanno avuto una grande influenza sulla vita ebraica moderna; da un lato la emancipazione, con l’acquisito diritto di cittadinanza ed uguaglianza, ed il caratte-re statuale del diritto fecero sì che nell’ebrai-smo occidentale vi fu un gran numero di ebrei che abbandonò il diritto ebraico, che oramai conosceva sempre di meno, per adot-tare il diritto dello Stato, anche nei rappor-ti fra ebrei: è stato un periodo di «assimila-zione», la cui influenza è viva ancor oggi, in cui il diritto ebraico cessò di vivere la sua vita normale, vita che invece proseguì, allora, nei grandi centri ebraici dell’Europa orientale e del Nord Africa. Come secondo elemento ri-cordiamo la tragedia del periodo razziale na-zifascista, che ha colpito la maggior parte del popolo ebraico, sia dal punto di vista fisico che spirituale.
Il terzo elemento è il sorgere del Sionismo che riproponeva agli ebrei un ritorno alla propria cultura, e in modo particolare un ri-torno alla propria terra (Erez Israel = la ter-ra di Israele, chiamata dai romani Palestina) ed alla propria lingua, l’ebraico. Si pose allo-ra anche il problema di quale diritto avreb-be dovuto essere adottato nel futuro Sta-to ebraico. Poco dopo la Dichiarazione Bal-four, del 17 dicembre 1918, venne fondata a Mosca la Società per il diritto ebraico, con una sua propria rivista. È interessante nota-re come il romantico parallelismo, creato dal Savigny, fra lingua e diritto («ogni popolo ha la propria lingua, ogni popolo ha il pro-prio diritto») abbia trovato strenui difensori fra i fautori della recezione del diritto ebrai-co come diritto dello Stato.
761Diritto e scuole dell’ebraismo
4.2. Responsa, rispondenti e leader spiritua-li del XX secolo
Da un punto di vista geografico nel XX secolo troviamo autori di Teshuvot o respon-sa in Europa (Galizia, Russia, Polonia, Li-tuania, Romania, Germania, Balcani, Euro-pa occidentale, in particolare dopo la Shoà), Nord Africa, Stati uniti d’America, Erez Israel e Stato di Israele.
I problemi trattati, oltre a quelli norma-li di carattere rituale, come l’osservanza del Sabato e delle feste, le preghiere e il Beth Ha-keneset (Sinagoga), riguardano in particolar modo i rapporti fra il singolo e la comunità ebraica o fra le comunità e lo Stato; proble-mi di vita e di morte nel periodo delle per-secuzioni razziali; conversioni all’ebraismo e matrimoni misti, abiure, problemi di rico-struzione di una autonomia ebraica in Pa-lestina, già al tempo del mandato britanni-co: viene istituito in questo periodo (1921) il Gran Rabbinato di Erez Israel, con due rab-bini capo (uno sefardita ed uno ashkenazi-ta) che esercitano al tempo stesso la funzione di presidenti del supremo tribunale rabbini-co: nei loro scritti troviamo l’eco della nuova epoca in Palestina, con la comunità ebraica che torna alla sua terra con numerosi proble-mi, anche in campo giuridico, da risolvere. Nei responsa più moderni troviamo affronta-ti anche i problemi di bioetica. Ricordiamo qui alcuni dei più famosi autori di responsa, la cui influenza è stata determinante nel XX secolo ed è avvertita ancor oggi:
a) Responsa Achiezer di rabbì Chaim Ozer Grodzinski (1863-1940), famosa autorità dell’ebraismo di Vilna in Lituania, assai at-tivo all’inizio del secolo; la sua morte, alla vi-gilia dell’occupazione tedesca, segnò la fine dell’ebraismo lituano. In un suo respon-so [Resp. Ahiezher, Even Haezher 26] dà una nuova interpretazione al passo talmudi-co che richiede che il candidato alla conver-sione all’ebraismo osservi le Mizvot (precet-ti): quello che il Talmud respinge, egli spie-ga, è il caso di un candidato alla conversione che dica al Tribunale rabbinico di voler con-vertirsi a condizione (matné) di essere esen-
te dall’osservanza di un determinato precet-to, sia pure di minore importanza; nessuna conversione è ammissibile a queste condizio-ni, dato che l’ebraismo deve essere accettato nel suo insieme. È differente però la situazio-ne di chi accetta di ubbidire a tutti i coman-damenti, ma sa di non riuscire ad osservar-li tutti, e questo non per principio, ma per debolezza umana: non bisogna considerare quest’ultima situazione come contraddicen-te il divieto talmudico e si potrà quindi effet-tuare la conversione di un tale candidato.
b) Responsa Melamed leho ’il del Rav D.Z. Hofmann (1843-1921), di origine ungherese, capo della Scuola rabbinica Hildessheimer a Berlino, educatore di generazioni di rabbini e leaders dell’ebraismo. Nei suoi responsa ven-gono affrontati anche molti problemi moder-ni: per es. egli ha sostenuto [Melamed leho’il, Joré Deà 48a] che il tribunale rabbinico non deve prendere in considerazione solo il candi-dato alla conversione, ma anche tutto il con-testo famigliare, dando particolare attenzio-ne ai futuri figli ed alla famiglia. Il caso esa-minato riguardava un non-ebreo sposato ad una ebrea con matrimonio civile ed in attesa di un bambino. Posto di fronte alla domanda da parte del marito di convertirsi all’ebrai-smo, il rabbino Hofmann ha preso in esame in particolare la situazione che si sarebbe ve-nuta a creare per il nascituro, figlio di madre ebrea e quindi ebreo secondo la Halachà; in una società in cui i non-ebrei sono la mag-gioranza assoluta, sarebbe stato quasi certo che il bambino avrebbe avuto una educazio-ne non-ebraica qualora fosse stata respinta la domanda del padre; che colpa ha il bambino della situazione che si è venuta a creare? Se-condo il decisore è meglio quindi converti-re il padre, nonostante i dubbi che una simile soluzione può sollevare, creando così una fa-miglia ebraica omogenea.
c) Rav Israel Meir Hakohen, noto come il Chafez Chaim (Vilna 1838- Radin 1933), fu autore di un importante commento alla prima parte dello Shulchan Aruch chiamato Mishnà Berurà e di un libro di regola morale Shemirat Halashon (Sorveglianza della lin-gua, 1873), che vuole insegnare come parlare
762 A.M. Rabello
bene santificando il nostro parlare con le pa-role della Torah, come evitare il parlar male del prossimo, la maldicenza e il pettegolezzo.
d) Rav Izchak J. Reines (Bielorussia 1839-1915) fu fra i primi fautori del movimento sionista, vedendo – come T. Herzl – in esso un movimento per la salvezza degli ebrei pri-ma ancora che per il ritorno in Eretz Israel; nel 1902 pubblica Or Chadash al Zion (una nuova luce su Sion), confutando le tesi dei rabbini antisionisti; nel 1905 fondò la prima yeshiva-liceo a Lida, dando importanza agli studi generali accanto a quelli di Torah.
e) I problemi più tragici sono, naturalmen-te, quelli affrontati durante la Shoà da ebrei che volevano, anche in quelle condizioni, ri-manere fedeli ai voleri divini; per esempio nel 1942 nel ghetto di Kovno, Lituania, le autorità tedesche decretarono che ogni don-na ebrea incinta sarebbe stata messa a morte, assieme al suo feto: rabbì Efraim Oshri stabi-lì che l’aborto era permesso, onde salvare al-meno la vita della madre, che altrimenti sa-rebbe morta assieme al feto [Responsa Mi-maamakim, o De profundis No. 20]; egli per-mise anche di consegnare i bambini ebrei del ghetto a famiglie cristiane prima dell’arrivo dei nazisti per permettere di salvarli intanto fisicamente, rimandando a dopo la guerra il salvataggio spirituale.
f) Rav Moshé Feinstein (Russia 1895-New York 1986), leader dell’ebraismo ameri-cano del XX secolo, autore della famosa col-lezione di responsa Igrot Moshé, ha affronta-to, accanto ai fondamenti della fede, anche importanti problemi moderni di tecnologia e di bioetica: è considerato una delle autori-tà halachiche.
g) Rav Josef D. Soloveitchik (Polonia 1903-Boston 1993), talmudista e filosofo, appartenente alla famiglia che influenzò la Jeshivà di Volozhin in Lituania con lo studio analitico del Talmud, essendo anche aperto agli studi generali (ricevendo nel 1931 il dot-torato dall’università di Berlino); trasferito-si in America (1932) divenne il rav di Boston, esercitando una enorme influenza sull’edu-cazione ebraica e sionistica, portando la Ha-lachà ed il suo pensiero al centro dell’atten-
zione. Fondò a Boston il Maimonides School e fu a capo della Yeshiva university a New York, propagandando l’unione fra la profon-da conoscenza della Torah e lo studio del-le scienze secolari. Altri problemi di que-sto tragico periodo sono stati affrontati dal Rav Iechiel J. Weinberg, nei suoi Shut Seri-dé Esh (Responsa resti di fuoco): fra l’altro è stato affrontato il problema se vi fosse modo di permettere lo stordimento elettrico prima della macellazione rituale, come era stato ri-chiesto dai nazisti, come uno dei primi atti quando salirono al potere, con l’intenzio-ne naturalmente di colpire gli ebrei e l’ebrai-smo; le autorità rabbiniche arrivarono ad una soluzione negativa.
h) Grande influenza ebbe il capo del mo-vimento Chabad il Rebbe del Lubavitc Me-nachem Mendel Shneerson (1902-1994), che contribuì grandemente a rinforzare l’ebrai-smo dopo la Shoà, attraverso l’invio di messi (shelichim) anche nei luoghi più dispersi.
Problemi particolari vengono affrontati in Erez Israel e nello Stato di Israele, ove ope-rano autorità religiose assai influenti, fra cui ricordiamo:
i) Rav Izchak hakohen Kook (Riga 1865-Gerusalemme 1935), il primo rabbino capo di Israele nel XX secolo, prima della nascita dello Stato; allievo del Netziv (R.N.Z. Ber-lin) alla famosa scuola talmudica (yeshivà) di Volozhin, in Lituania, fu la più importan-te guida spirituale dell’ebraismo sionista re-ligioso; egli fu pieno d’amore verso i pionie-ri (chaluzim), anche se non religiosi; è auto-re anche di opera di responsa, come Da’at Ko-hen. Ha sottolineato l’importanza del ritor-no del popolo ebraico, anche nella sua par-te non religiosa, alla sua terra come elemen-to importante del processo divino di reden-zione, costruendo un ponte di comprensione fra la leadership del Sionismo laico ed i mem-bri del Sionismo religioso. Fondò (1924) la Yeshivà Mercaz Harav a Gerusalemme, alla cui direzione succederà (1952) il figlio Rav Zvi Jehudà Kook (Lituania 1891-Gerusa-lemme 1982): essa è divenuta la Yeshivà gui-da dell’ebraismo sionista religioso, sottoline-ando la centralità di Erez Israel (Torat Erez
763Diritto e scuole dell’ebraismo
Israel) e sostenendo l’importanza dell’eser-cito israeliano ed insegnando anche pensie-ro e fede ebraica.
l) Rav Ben Zion uziel (Gerusalemme 1880-1953), primo rabbino capo sefardita di Israele nel XX secolo, prima della nasci-ta dello Stato e primo rabbino capo sefardi-ta dello Stato di Israele; il suo Piské Uziel be-sheelot hazhman è una raccolta di responsa su vari problemi contemporanei, trattati con grande umanità; fra l’altro si dichiarò favo-revole al diritto di voto alle donne. A propo-sito delle conversioni all’ebraismo, special-mente in casi di matrimoni misti, viene pro-seguita la linea tracciata dal Rav Ozer Gro-dzinski [783 a]: «Sappi ancora che nel caso di un non-ebreo che viene a convertirsi gli si fanno conoscere i principi basilari della Re-ligione, che sono l’unità di D-o e la proibi-zione dell’idolatria e ci si prolunga su que-sto punto mentre per quanto riguarda l’ac-cettazione delle Mizvot gli si fanno sapere alcuni precetti leggeri ed altri precetti gra-vi e non ci prolunga su questo [viene citato il passo di Maimonide, Mishné Torah, Hil-chot Isuré Bià 14:2, Shulchan Aruch, Joré Deà 268,2 e Shach, 8] […] da qui risulta espressa-mente che non gli viene richiesto di adempie-re alle Mizvot ed anche non è necessario che il Tribunale sappia che le osserverà […] ma gli si comunicano un po’ di Mizvot perché sap-pia cosa dovrà fare perché se vuole possa re-cedere dalla conversione e non possa dire: se lo avessi saputo non mi sarei convertito […] e questo a priori, ma a posteriori se non glie l’ha detto la cosa non ritarda la conversione [Shach, ibidem, 3]. Da tutto questo abbiamo appreso che la condizione del compimento delle Mizvot non fa ritardare la conversione, neppure a priori» [Shut Piské Uziel besheelot hazman, 65]. Fra i suoi allievi il Rav Haim David Halevi (1924-1998), rabbino capo di Tel Aviv ed importante autore di libri di Ha-lachà e responsa, tradotti anche in italiano.
m) Rav Izchak Herzog (Polonia 1888-Ge-rusalemme 1959), successe al Rav Kook nel Rabbinato di Erez Israel (1936), guida spiri-tuale nel difficile periodo della Shoà e della ricostruzione dello Stato Ebraico (trattò per
es. problemi dell’esercito e polizia ebraici): i problemi di tali epoche appaiono nei suoi responsa raccolti in Hechal Izchak. Alla As-semblea Rabbinica del 1950 furono stabili-te alcune disposizioni (takanot), su proposta del rabbino capo Herzog, riguardanti il dirit-to matrimoniale ebraico nello Stato di Israe-le, vincolante per gli ebrei residenti in Isra-ele: il matrimonio deve essere regolato solo da rabbini autorizzati ad hoc; il matrimonio deve essere celebrato solo in presenza di dieci ebrei adulti (minian); la prima parte del ma-trimonio (erusin) e la seconda (kidushin) do-vranno essere celebrati immediatamente uno dopo l’altro; l’età minima matrimoniale del-la donna è stata fissata a 16 anni; la proibi-zione della bigamia, già accolta nelle comuni-tà ashkenazite ed italiane, viene estesa a tutte le comunità; in casi eccezionalissimi un per-messo di un matrimonio con un’altra mo-glie, ammesso da un tribunale rabbinico con procedure speciali, dovrà essere approvato dai rabbini capi dello Stato di Israele.
n) Rav Ovadià Josef (Bagdad 1920), il più importante posek (decisore) sefardita oggi vi-vente, autore dei libri di responsa Yechavé Da’at e Jabia’ Omer in cui vengono affronta-ti i principali problemi dell’ebraismo ai no-stri giorni, ribadendo la centralità dell’inse-gnamento dello Shulchan Aruch. Fu rabbino capo sefardita dello Stato d’Israele e leader del movimento politico Shas.
o) Rav Eliezer Y. Waldenberg (Gerusa-lemme, 1916-2006), autore dei responsa Ziz Eliezher, si è occupato in particolare di pro-blemi di medicina ed Halachà, anche come guida rabbinica dell’ospedale Shaaré Zedek a Gerusalemme; egli ha permesso, per esem-pio, l’aborto nel primo trimestre nel caso di un feto affetto di Tay-Sachs [9:51:3]; nei suoi responsa egli fa anche uso del concetto di di-gnità umana [kevod haberiot, 6:10:3].
p) Particolare attenzione hanno destato i problemi di sussistenza e le regole giuridiche attinenti Erez Israel; Rav Zvi P. Frank (Li-tuania 1873-Gerusalemme 1960) apparten-ne al movimento del musar (morale), come allievo del Rav Salant; nei suoi responsa Har Zvì vengono affrontati problemi attuali e at-
764 A.M. Rabello
tinenti alla santità di Erez Israel. Il Rav She-lomò Goren (1917-1994) fu il primo rabbi-no capo dell’esercito israeliano, stabilendo le regole fondamentali per un esercito ebraico; fu con le truppe che liberarono il Kotel ha-maaravì (cd. «muro del pianto») nel 1967; è anche autore di commenti talmudici e di libri di pensiero ed Halachà. Il Rav Shelo-mò Zalman Auerbach (1910-1995), direttore della Yeshivà Kol Torah è stato considerato uno dei decisori di Gerusalemme più seguiti, trattando anche i nuovi problemi di bioetica e di tecnologia, come ad esempio problemi di Shabbat derivati dall’uso dell’elettricità; fu particolarmente sensibile ai problemi di mo-rale. una importanza particolare hanno avu-to i fondatori e direttori della Yeshivà (scuo-la talmudica) di Har Etzion in Alon Shvut: Rav Yehuda Amital (Transilvania 1925), re-duce da Auschwitz, ove fu deportata tutta la sua famiglia, partecipò come capitano alla guerra d’Indipendenza e fu favorevole alla partecipazione degli studenti delle Yeshivot al servizio militare, favorendo la fondazione delle cosiddette Yeshivot esder, ove è possibi-le conciliare studio di Torah e servizio mili-tare. Fondatore di Memad, Movimento per il rinnovamento del Sionismo religioso, fu mi-nistro (1995-1996), ed ha scritto libri di pen-siero ed Halachà; l’altro fondatore Rav Aha-ron Lichtenshtein, co-capo della Yeshivà di Har Etzion in Alon Shvut, genero del Rav J.D. Soloveitchik, è la più eminente persona-lità della linea Torah umadà (Torah e scien-za). Rav Shlomo Moshe Amar (Casablanca 1948), rabbino capo d’Israele dal 2003 e au-tore di responsa, si è mostrato sensibile ai pro-blemi delle ’agunot e si è dato da fare per l’av-vicinamento di gruppi dispersi come i Fa-lashà in Etiopia ed i bené Menashé in India.
q) Accanto a queste personalità rabbini-che vorremmo ricordare alcuni docenti che hanno avuto una influenza particolare nel mondo delle scienze dell’ebraismo. Il prof. Ghershom Sholem (Berlino 1897 - Gerusa-lemme 1982), studioso di Kabbalà, fu il pri-mo professore di Misticismo ebraico all’uni-versità ebraica di Gerusalemme, aprendo la via agli studi scientifici sulla Kabbalà. È au-
tore di Le grande correnti della mistica ebrai-ca [Torino 1993] e di numerose altre opere sulla mistica ebraica, su Shabbatai Zevi, il messianesimo e l’idea sionista; il prof. Shaul Lieberman (Pinsk, Bielorussia 1898-1993), grande talmudista con profonde conoscen-ze anche negli studi classici, insegnò Talmud al Jewish Theological Seminary e pubbli-cò una edizione scientifica dei primi tre or-dini della Tosefta con un ampio commen-to Tosefta kifshuta e studi critici ed edizio-ni critiche di alcuni trattati del Talmud Je-rushalmi. Studiò l’influenza della cultura el-lenistica sull’ebraismo in Palestina nel I se-colo e.v. nel suo studio Talmud shel Kesarin [1931]; fra l’altro ha sostenuto che l’ordine di Nezhikin (Danni) del Talmud Jerushalmi sia stato composto a Cesarea verso la metà del IV secolo. Il prof. Efraim Elimelech urbach (Polonia 1912 - Israele 1991), fu fra i docenti più influenti di Talmud all’università Ebrai-ca, lasciandoci studi fondamentali come The Sages. Their Concepts and Beliefs [Jerusalem 1979]; The Tossafists [Jerusalem 1980, in ebr.]; The Halacha [Jerusalem 1984, in ebr.]; The World of the Sages, Collected Studies [Je-rusalem 1988, in ebr.].
4.3. Il diritto ebraico nello Stato di Israele. Matrimoni e divorzi nei tribunali rabbi-nici dello Stato di Israele
Essendo lo Stato di Israele uno stato demo-cratico, e non teocratico, la Halachà sarà ap-plicata come diritto dello Stato solo in quan-to formalmente recepita per legge della Kene-set (parlamento). Seguendo il sistema ottoma-no, fatto proprio anche dal mandato britan-nico, una legge israeliana del 1953 sulla giu-risdizione dei tribunali rabbinici stabilisce: «1) I matrimoni e i divorzi di ebrei in Israele, cittadini o residenti dello Stato, sono di com-petenza esclusiva dei tribunali rabbinici. 2) I matrimoni e i divorzi degli ebrei si effettuano conformemente alla legge della Torah». Vie-ne qui data una norma che riguarda al tem-po stesso il diritto e il tribunale: esempio di incorporazione diretta di una branca del di-ritto ebraico, che viene studiato anche nelle
765Diritto e scuole dell’ebraismo
università come parte del diritto di famiglia; al tempo stesso vi è chi fa notare che questa incorporazione rende il diritto ebraico nor-ma statale, che viene applicato appunto come diritto dello Stato, cosa che ha causato diversi conflitti fra il Tribunale rabbinico e la Cor-te suprema (laica), che ha imposto il proprio controllo di legalità sui tribunali rabbinici statali. È questa, evidentemente, la parte del diritto ebraico più in uso nello Stato di Israe-le; le norme sui matrimoni fra ebrei, la capa-cità dei nubendi, la loro età, così come quelle sui divorzi, in quali casi concederli, ecc., sono regolate dal diritto ebraico tradizionale; dal 1948 le sentenze dei tribunali rabbinici ven-gono pubblicate e studiate, ed avvocati/avvo-catesse «laici» rappresentano le due parti in casi di conflitto. È discusso se, oltre alle fun-zioni espressamente stabilite dalla legge israe-liana, tali tribunali possano fungere da arbi-tri qualora entrambe le parti acconsentano ad affidare loro la soluzione del conflitto. La cosa è stata recentemente considerata proibi-ta dalla Corte suprema. Ciò non toglie che le parti possano decidere di comune accor-do di portare la loro controversia dinanzi a un tribunale rabbinico che giudicherà secon-do il din Torah. Si veda per es. www.dintora.org/english/English.asp (visitato l’11 giugno 2010) del Tribunale rabbinico per questioni patrimoniali presso l’Istituto Eretz Chem-dà (istituto in memoria del famoso Rav giu-dice Shaul Israeli, capo della Yeshivà Mercaz Harav e membro del Consiglio rabbinico su-periore). un altro tribunale rabbinico famo-so è quello sefardita, sotto la presidenza del Rav Ovadià Josef. Il problema degli alimen-ti può essere trattato anche dinanzi alla cor-te distrettuale. Spesso quando una parte, spe-cialmente se non religiosa, non è soddisfatta del modo di agire del tribunale rabbinico, si rivolge ai mezzi di informazione pubblica si svolge un dibattito pubblico, con pressio-ne che viene esercitata sulle autorità rabbini-che, affinché accolgano soluzioni che sembri-no più adatte; il rabbinato ha emesso specia-li disposizioni (Takanot) sul funzionamento di tali tribunali e sulla procedura da seguire in essi. Riportiamo qui le considerazioni del
Maimonide sulle regole matrimoniali ebrai-che: «il divieto delle unioni proibite, il di-vieto della prostituzione, l’obbligo della Ke-tubà e dei Kiddushim, con i quali tuttavia la donna non è permessa sempre, ma è proibi-ta nei periodi del mestruo e del puerperio, e non solo questo, ma tutte le altre limitazioni poste dai nostri maestri al fine di limitare il rapporto sessuale, vietandolo durante il gior-no, tutto questo ci è stato comandato da D-o unicamente perché ci allontanassimo gran-demente dall’estremo del desiderio sfrenato e, spostandoci così un po’ dalla medietà verso l’assenza di sensibilità ai piaceri, si rafforzas-se nella nostra anima l’inclinazione alla con-tinenza» [M. Maimonide, Gli Otto Capitoli. La dottrina etica, a cura di G. Laras, Firenze 2001, cap. IV, 72]. I maestri del Talmud han-no indicato la via per ottenere la pace della famiglia: «Chi ama la propria moglie come se stesso, la rispetta più di se stesso, conduce i propri figli e le proprie figlie sulla retta via facendo sì che esse si sposino nel tempo giu-sto (cioè nel tempo della pubertà), per queste persone è scritto: “Conoscerai che pace è nel-la tua tenda” [Giobbe 5:24 ]» [T.B. Jevamòt 62b, nella traduzione di G. Laras, I racconti del Talmud, Como 2000, 16].
Oltre al campo dei matrimoni e divorzi vi sono anche altri settori in cui il legislato-re israeliano ha tenuto conto della posizione del diritto ebraico; molte volte la terminolo-gia usata dal legislatore è quella tradiziona-le; dal punto di vista più sostantivo in alcu-ni casi il legislatore ha adottato alcune leggi per uniformarsi alle regole del diritto ebrai-co, come ad esempio norme che limitano l’al-levamento del maiale (animale notoriamen-te vietato all’alimentazione dalla Bibbia) nel-la maggior parte del territorio dello Stato e norme che limitano la circolazione dei pub-blici trasporti (aerei dell’El Al, treni ed auto-bus) nei giorni di sabato e feste.
4.4. Cenni ad alcune problematiche sorte nei rapporti religione-Stato
In questo paragrafo segnaleremo alcu-ni dei principali problemi sorti nei rapporti
766 A.M. Rabello
fra lo Stato di Israele laico e il diritto ebraico. Si prenda per esempio il caso del matrimo-nio: in Israele non esiste un matrimonio ci-vile; si suppone che ogni cittadino apparten-ga ad una determinata religione e che celebri il matrimonio nell’ambito del suo status per-sonale. Ora, a parte il fatto che vi sono per-sone che non vorrebbero vedersi collocate in una determinata religione, vi sono dei casi in cui per l’ebraismo è proibito celebrare un ma-trimonio: se normalmente la proibizione dei matrimoni fra parenti è ancor oggi comune-mente accettata, vi sono dei casi di divieti ti-pici del diritto ebraico che sono più difficili, come ad esempio:
- proibizione alla donna adultera di unirsi al marito e al complice; ora è da tener presen-te che è considerato adulterio anche l’unione di una donna che in buona fede credeva che il marito fosse morto in guerra, come era sta-to certificato in una testimonianza, che poi si è verificata errata. Al ritorno del marito la donna non potrà più essere sposa del primo e del secondo marito.
- proibizione alla vedova di risposarsi a chi vuole nel caso che il marito sia morto senza aver avuto figli e lasciando il marito un fra-tello, se non dopo aver compiuto la cerimo-nia della chalizà con cui la donna viene li-berata dal cognato dal vincolo, cerimonia che ha sostituito l’antico matrimonio di le-virato (ibbum). Ora se il fratello è minoren-ne la donna sarà obbligata ad attendere fino al raggiungimento della maggiorità religiosa (13 anni) del fratello stesso, prima di poter-si risposare.
- divieto dei «matrimoni misti», fra un ebreo e una non-ebrea o viceversa: tale pro-blema si è fatto particolarmente acuto in se-guito alla immigrazione dai paesi dell’ex unione Sovietica. Non essendo facile la pro-cedura di conversione all’ebraismo, le cop-pie miste o convivono o vanno a celebrare all’estero il loro matrimonio, facendolo poi registrare dal ministero degli interni.
- proibizione ad un figlio/a adulterino od incestuoso (mamzher) di effettuare un matri-monio ebraico. La situazione del mamzher è assai penosa ed in genere il tribunale rabbini-
co farà tutto il possibile per liberare una per-sona da tale definizione, cercando, per esem-pio, di far dichiarare nullo ab initio il primo matrimonio della madre in seguito a qualche vizio nella celebrazione, venendo ad elimina-re quindi il successivo «adulterio».
Anche nel caso dei divorzi vi sono proble-mi non facili: anche se la giurisprudenza rab-binica ha fatto notevoli sforzi per arrivare ad un divorzio consensuale, dal punto di vista strettamente giuridico il divorzio è un atto voluto dal marito che deve essere accettato dalla moglie. I problemi sorgono qualora il marito non possa concedere il divorzio, per esempio per aver perduto la capacità giuridi-ca in seguito a grave malattia mentale, o per-ché non si sa dove si trovi il marito, per esem-pio in seguito a guerra, deportazione, ciclo-ne, attacco terroristico ecc. La donna si tro-va allora nella posizione di ’agunà o ancora-ta, cioè rimane legata al marito non potendo divorziare da lui. Il diritto rabbinico ha cer-cato di sollevare le donne da questa posizio-ne facilitando la possibilità di basarsi su testi-monianze particolari, che permettano di po-ter dichiarare il marito come morto e quindi di dichiarare il vincolo matrimoniale come sciolto; si noti però che una tale sentenza sarà soltanto dichiarativa, e quindi, come abbia-mo già accennato, se il marito ritorna a casa la donna dovrà separarsi dal primo e dal se-condo marito, con il pericolo di far dichia-rare mamzherim i figli nati dal secondo ma-trimonio.
In una posizione simile si trova la moglie il cui marito si rifiuti di dare un divorzio di sua spontanea volontà e che non rientri in uno dei casi in cui il marito è obbligato a con-cedere il divorzio (mesurrevet ghet).
Organizzazioni femministe, anche reli-giose, cercano di convincere i tribunali rabbi-nici a trovare soluzioni nell’ambito della Ha-lachà, soluzioni che sarebbero possibili ma che vengono respinte a priori da vari ambien-ti ortodossi, facendo rinforzare in tal modo la richiesta che lo Stato fornisca lui stesso una soluzione con l’introduzione di matri-monio e divorzio civili. Si noti però che an-che in tal caso non verrebbero risolti i pro-
767Diritto e scuole dell’ebraismo
blemi delle persone religiose o tradizionali-ste e che si verrebbe a creare una situazione assai difficile nelle possibilità di matrimoni futuri fra religiosi e non. Inoltre, come han-no dimostrato le situazioni in paesi, come gli Stati uniti e la Francia in cui esistono comu-nità ebraiche e vi sono matrimoni civili, mol-ti sono i casi in cui almeno uno dei coniugi (e normalmente si tratta della donna) non si sente libero di agire anche dopo un divorzio civile, se il vincolo non viene sciolto anche re-ligiosamente.
4.5. Lo studio accademico del diritto ebraico
Già prima della fondazione dello Stato di Israele (1948) nella università ebraica di Ge-rusalemme venne iniziato lo studio e l’inse-gnamento del diritto ebraico, come discipli-na autonoma, che si è andata sempre più svi-luppando. Nel 1963 è stato fondato l’Istitu-to di ricerca di diritto ebraico, in seno alla fa-coltà di giurisprudenza dell’università ebrai-ca di Gerusalemme. Oggi lo studio del di-ritto ebraico fa parte dei corsi obbligatori in ognuna delle facoltà giuridiche dello Stato di Israele; inoltre corsi opzionali e seminari per-mettono di approfondire argomenti speciali, mentre in corsi opzionali il diritto ebraico viene studiato comparativamente con il di-ritto romano, il diritto musulmano, il dirit-to medievale ed il diritto israeliano moder-no. In Italia abbiamo alcune cattedre di di-ritto ebraico, per esempio alla Pontificia uni-versità lateranense, ove è docente D. Piattel-li, ed all’università statale di Milano istituita per cura della fondazione Goren-Goldstein. Altre cattedre si trovano in importanti uni-versità nel mondo (come alla Yeshiva uni-versity, Harvard university, Boston univer-sity, alla Sorbonne di Parigi). Vi sono state numerose tesi di dottorato di ricerca dedica-te all’argomento, che hanno permesso di ap-profondire temi particolari. Questo studio ha carattere scientifico e segue normalmen-te i metodi di ricerca del positivismo giuri-dico: fra tali docenti ricordiamo il prof. Me-nachem Elon (1923-), dell’università ebrai-ca di Gerusalemme, fondatore dell’Istituto
di ricerca del diritto ebraico e poi giudice e vicepresidente della Corte suprema israelia-na. La sua attività, come docente e come giu-dice, è stata svolta per favorire l’integrazione del diritto ebraico nel diritto dello Stato. È autore di quattro volumi di Jewish Law. Hi-story, Sources, Principles [1994] e di un vo-lume su Jewish Law. Cases and Materials [1999]. Nelle sue sentenze egli ha cercato di applicare il concetto ebraico di dignità uma-na. Egli da un lato è considerato il capo del-la scuola gerosolimitana, con numerosi allie-vi che ne continuano l’opera, dall’altro è sta-to anche al centro di polemiche metodologi-che (per es. con giuristi come I. Englard e B. Jackson).
Bibliografia
1. Esistono alcuni volumi di bibliografia, divi-si a seconda che riguardino studi in lingua ebraica o in lingue europee: N. Rakover, Ozar Hamishpat, A Bibliography of Jewish Law. Modern Books, monographs and articles in Hebrew, Jerusalem 1975; II, 1990; Id., The Multi-language Bibliography of Jewish Law, Jeru-salem 1980. La Enciclopedia Judaica (Jerusalem 1971, in ingl.) contiene numerose voci riguardanti il diritto ebraico; tali voci sono state anche riunite nel volume curato da M. Elon, The Principles of Jewish Law, Jeru-salem 1975. Fra i libri istituzionali: A. Gulack, Istitu-zioni di diritto Ebraico, diritto patrimoniale, 4 voll. in ebr., Tel Aviv 1967; I. Herzog, The Main Institutions of Jewish Law (The Law of Property; The Law of Obli-gations), 2 voll., London-New York 1980; per tratta-ti in generale, in inglese: M. Elon, Jewish Law. Histo-ry, Sources, Principles, Philadelphia 1994, I-IV; N.S. Hecht - B.S. Jackson - S.M. Passamaneck - D. Piattel-li - A.M. Rabello (ed.), An Introduction to the History and Sources of Jewish Law, Oxford 1996; in italiano: V. Colorni, Legge ebraica e leggi locali, Milano 1945; A.M. Rabello, Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica, Torino 2002; Id., Il matrimonio ebraico, in S. Ferrari (a cura di), Il matri-monio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commen-to alle fonti, Torino 2006. In francese sono degni di nota gli studi di A. Weingort, Intérêt et Crédit dans le Droit Talmudique, Paris 1979; Id., Responsabilité et Sanction en Droit Talmudique et Comparé, Paris 1998. Sul diritto israeliano si può consultare l’ampia biblio-grafia curata da R. Sanilevici, Bibliography of Israe-li Law in European Languages, Jerusalem 1985, segui-ta da aggiornamenti curati dalla stessa autrice e poi da H. Bonk; fra gli studi più recenti di diritto israeliano in lingua italiana segnaliamo: S. Colombo, Israele, in
768 A.M. Rabello
Digesto (IV ed. vol. X civile) 1993, 201 ss.; R. Delfino, Dall’eterogeneità delle fonti alla codificazione del diritto israeliano, in «Rivista di diritto Civile», 52 (1996), 89 ss.; L. Saporito, L’esperienza israeliana di diritto civi-le. Dal modello «misto» al nuovo Jus Commune Euro-peo, in «Rivista di diritto Civile», 54 (1998), 449 ss.; A.M. Rabello, Israele: senza «causa» e senza «consi-deration», in L. Vacca (a cura di), Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica, Torino 1997, 407 ss.; Id., La legge israeliana sulla donazione, 1968, in Studi in onore di Pietro Rescigno, Milano 1998, II.1, 729 ss.; Id., Buona fede e responsabilità precontrattuale nel diritto israeliano alla luce del diritto comparato, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 54 (2000), 471 ss., 847 ss. Sul diritto costituzionale israe-liano T. Groppi - E. Ottolenghi - A.M. Rabello (a cura di), Il sistema costituzionale dello Stato di Israele, Tori-no 2006.
2.1. Sul diritto biblico: D. Daube, Studies in Bibli-cal Law, Cambridge 1947; Z. Falk, Hebrew Law in Biblical times, Jerusalem 1964; sull’interpretazione della Bibbia secondo la Halachà cfr. A.M. Rabello, L’interpretazione del Talmud babilonese e del Talmud di Eretz Israel: il Midrash Halachà, in S.J. Sierra (a cura di), La Lettura ebraica delle Scritture, Bologna 1995, 103 ss. Sui sette precetti noachidi: Tosefta, Avoda Zhara 8:4; Talmud Babilonese, Sanhedrin 56a; E. Benamozegh, Israele e l’umanità, (trad. ital.), Geno-va 1990; A. Pallière, Il santuario sconosciuto, Roma 1953; A. Lichtenstein, The Seven Laws of Noah, New York 1981; S. Stone, Sinaitic and Noahide Law: Legal Pluralism in Jewish Law, in «Cardozo Law Review», 12 (1991), 1157 ss.; N. Rakover, Law and the Noahides. Law as Universal Value, Jerusalem 1998; R. Fontana, Sinaitica, Firenze 2006.
2.2. Sul periodo intermedio si veda in generale: Z.W. Falk, Introduction to Jewish Law of the Second Commonwealth, Leiden 1972, 2 voll.; S.J. Sierra, Le condizioni spirituali degli ebrei prima della distruzione del II santuario, in Biblische und Judaistische Studien, Fest. Paolo Sacchi, Frankfurt 1990, 252 ss. Su Murab-baat: J.T. Milik, Les Grottes de Murabbaat, Oxford 1961; L.H. Schiffmann, Sectarian Law in the Dead Sea Scrolls. Courts, Testimony and the Penal Code, Chico 1983. Sulla legge orale e la Halachà cfr. E.E. urbach, Haalachà. Its sources and development, Jerusalem 1984; S. Safrai, «Oral Tora», in Compendia Rerum Judaicarum ad Novum Testamentum, Section One, The Jewish People in the First Century (ed. by S. Safrai and M. Stern), II, Assen 1976, 35 ss.; G. Stemberger, Introduzione al Talmud e al Midrash, Roma 1995. Sulla Mishna: H. Albeck, Introduction to the Mishna, Tel Aviv 1959 (in ebr.); V. Castiglioni, Mishnaiot, traduzione italiana con note illustrative, Roma 1962; E.E. urbach, «Mishnah», in Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1971, XII, col. 93 ss.; è in corso di pubbli-cazione una nuova traduzione italiana con commento, che viene pubblicata per trattati, a cura del Rabbina-to italiano. Sulla Tosefta: M.S. Zuckermandel, Tose-
phta based on the Erfurt and Vienna Codices (1881), with «Supplement to the Tosephta» by S. Lieber-man, Jerusalem 1970; S. Lieberman, Tosefta Ki-fshu-tah. A Comprensive Commentary on the Tosefta, Jeru-salem 1962-1992; A. Goldberg, The Tosefta-Compa-nion to the Mishna, in Compendia Rerum Judaicarum ad Novum Testamentum, The Literature of the Sages (ed. Sh. Safrai), I, Assen 1987, 283 ss.
2.3. Traduzioni del Talmud: I. Epstein, The Babyloniam Talmud, Translated into English with Notes, with notes and Indices, London 1936-1948; M. Schwab, Le Talmud de Jerusalem, Paris 1871-1889. In generale si veda: Ch. Albeck, Introduction to the Talmud, Babli and Yerushalmi, Tel-Aviv 1969 (in ebr.); E.E. urbach, The Sages. Their Concepts and Beliefs, Magnes Press 1979. Al diritto talmudico ha dedica-to vari studi in ebraico Sh. Albeck, General Principles of the Law of Tort in the Talmud, Jerusalem 1965; sul diritto del lavoro: B. Lifshitz, Employee and indipen-dent contractor-acquisition and obligation in contrast, Jerusalem 1993 (in ebr.). Sul divieto giustinianeo di studiare il Talmud: A.M. Rabello, Giustiniano, ebrei e samaritani, II, Milano 1988, 814 ss.; si veda anche Id., L’interpretazione del Talmud babilonese e del Talmud di Erez Israel: il Midrash halakahà, in S.J. Sierra (a cura di), Lettura ebraica delle Scritture, Bologna 1995, 99 ss.; G. Levi, Il Talmud, in D. Di Cesare - M. Morselli (a cura di), Torah e filosofia, Firenze 1993, 29 ss.
4.2. Responsa: È possibile oggi trovare una raccol-ta di responsa, antichi e moderni, nel CD (in ebr.) dell’università Bar Ilan, Responsa Project. Nel sito www.responsa.co.il (visitato l’11 aprile 2009) si può trovare The online Judaica Responsa dell’universi-tà Bar Ilan. Quasi tutti gli autori ricordati nel nostro breve esame, figurano nella raccolta di responsa dell’università Bar Ilan (in ebr.).
4.2.a) Sull’insegnamento di rabbì Chaim Ozer Grodzinski si veda l’importante studio del Rav S.J. Zevin, Ishim veshitot. (uomini e metodi. Serie di articoli su maestri di Halacha e i loro metodi sullo studio della Torah), Gerusalemme 1952, pp. 189 ss.; sul problema trattato nel testo cfr. A.M. Rabello, Il matrimonio nel diritto ebraico, in S. Ferrari (a cura di), Il matrimonio: diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti, Torino 2006, 39 ss.
4.2.c) Per qualche cenno biografico cfr. www.torah.org/learning/halashon/ccbio.html.
4.2.d) Sul Rav Izchak J. Reines cfr. G. Bat-Jehuda, Ish hameorot (L’uomo dei lumi): rabbì Izchak Iaakov Reines, Gerusalemme 1985, con l’ultimo capitolo, a cura del Rav Shilo Refael, sul suo metodo nella hala-chà, 356 ss.
4.2.e) Si veda E. Oshry, Responsa. Dilemmi etici e religiosi nella Shoà, a cura di M. Giuliani, Brescia 2004. Sul Rav Weinberg ed il problema della shechità durante il periodo nazifascista si veda P. Lerner - A.M. Rabello, The Prohibition of Ritual Slaugtering (Kosher Shechi-ta and Halal) and Freedom of Religion of Minorities, in «Journal of Law and Religion», 22 (2006-2007), 1 ss.
769Diritto e scuole dell’ebraismo
4.2.f) «Ha cercato qual è il volere di D-o dalla nostra generazione» per usare l’espressione del Rav S. Rapoport, Ricordate la Torah di Mosè, Mio servo. Sulla via seguita dal Rav Feinstein nel fissure la Halachà per i problemi del nostro tempo, in Reame di sacerdoti e nazio-ne consacrata, Gerusalemme 1989, 366 ss. (in ebr.); S. Finkelman - N. Sherman, Reb Moshe:The Life and Ideals of Hagaon Rabbi Moshe Feinstein, Brooklyn 1986.
4.2.g-h) Si veda B. Carucci Viterbi, Rav Elihau Eliezher Dessler, rav Josef Dov Halevi Soloveitchik, rabbi Menachem Mendel Shneerson. Tre declinazio-ni del Rabbinato moderno, in M. Colafato (a cura di), Maestri. Leadership spirituali: vie, modelli, meto-di, Roma 2006, 75 ss.; si veda, in italiano, J.B. Solo-veitchik, Riflessioni sull’ebraismo, a cura di A.M. Somekh, Firenze s.d.; Id., Halakhik man, Philadel-phia 1983; Id., On Repentence, Jerusalem 1980; si veda anche http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_B._Solo-veitchik; http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbi_Mena-chem_Mendel_Schneerson.
4.2.i) http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Isaac_Kook; http://muse.jhu.edu/journals/shofar/toc/sho25.3.html.
4.2.l) Si veda M.D. Angel, Loving Truth and Peace: The Grand Religious Worldview of Rabbi Ben Zion uziel, Northwale 1999: http://en.wikipedia.org/wiki/Ben-Zion_Meir_Hai_uziel; http://en.wikipedia.org/wiki/Hayim_David_HaLevi.
4.2.m) Si veda B.S. Jackson (ed.), The Halakhic Thought of R. Isaac Herzog, Atlanta 1991; http://en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Herzog.
4.2.n) Si veda B. Lau, Da Maran a Maran: l’inse-gnamento halachico del Rav Ovadià Josef, Tel Aviv 2005; http://en.wikipedia.org/wiki/Ovadia_Yosef.
4.2.p) Si veda ad es. S. Goren, Torat Harefuà, Geru-salemme 2001. Y. Amital, Hama’alot mimaamakim (Gradini de profundis), Gerusalemme 1974; Id., E ha dato la terra agli uomini, Alon Shvut 2005; Id., Resisé tal, Alon Shvut, 2005.
4.3. M. Silberg, Talmudic Law and the Modern
State, New York 1973; C. Klein, Stato, ebraismo e confessioni religiose in Israele, in A. Riccardi (a cura di), Il Mediterraneo nel Novecento. Religioni e stati, Mila-no 1994, 110 ss. In generale si veda A.M. Rabello, Il Rabbinato centrale di Erez Israel, in «Daimon», 3 (2003), 115 ss. Sul diritto matrimoniale: E. Bulz, Le Divorce en Droit Rabbinique dans ses rapports avec le droit laique moderne, La Chaux-de-Fonds 1954, in part. 83; P. Shifman, Israel, in «Juris Classeur de Droit Comparé», 8 (1988). Si veda anche il IV volu-me del The Jewish Law Annual, Leiden 1981, dedica-to al problema del divorzio nel diritto ebraico, ed in particolare sul diritto della donna al divorzio; Brei-towitz, Between Civil and Religious Law: the Plight of the Agunah in American Society, Connecticut 1993; J. Kohn, La protection juridique des agounoth par la justice française, in «Kountrass», 13 (1998), 34 ss.; T. Einhorn, Jewish divorce in the Intermational Arena, in Private Law in the International Arena. Liber Amico-rum Kurt Siehr, ed. by J. Basedow et al., The Hague 2000, 135 ss.; G. Atlan, Les Juifs et le Divorce. Droit, histoire et sociologie du divorce religieux, Bern 2002.
4.4 Accanto a varie riviste in cui sono trattati, di volta in volta, problemi giuridici alla luce del diritto ebraico, si possono segnalare le principali riviste scien-tifiche dedicate esclusivamente al diritto ebraico: in lingua inglese «The Jewish Law Annual»; in appen-dice ad ogni volume viene pubblicata una bibliogra-fia, con un brevissimo riassunto dello studio, in lingua inglese; tale rivista ha dedicato nel 1980 un supple-mento al «Modern Research in Jewish Law». In ingle-se ed in ebraico abbiamo «Dine Israel. An Annual of Jewish Law and Israeli Family Law» dell’università di Tel Aviv (si noterà che i problemi di diritto famigliare abbiano diretta attinenza sia con il diritto ebraico che con il diritto israeliano). In lingua ebraica «Shenaton ha-mishpat ha-ivri = Annual of the Institute for Re- search in Jewish Law». Cfr. anche supra 1). Ai proble-mi di bioetica e diritto ebraico è dedicata la rivista «Assia» diretta da M. Halperin.