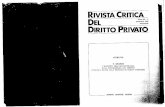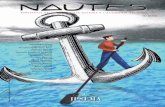Rom e Sinti come Minoranza. Profili di diritto italiano e comparato e di diritto internazionale
Diritto dei Consumatori
Transcript of Diritto dei Consumatori
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Diritto dei Consumatori
Introduzione
Il “Consumerism” origini ed evoluzione
Il consumatore dal linguaggio economico e sociale allinguaggio giuridico
La figura del consumatore, s’inquadra in diversi settori: giuridico,sociologico ed economico.
La dimensione del consumatore e del mondo dei consumi è penetrata moltotardi nel linguaggio dei giuristi.
Il fenomeno sociale del consumerismo nasce negli Stati Uniti d'America allafine del 19° secolo, ed è il frutto di una vasta protesta degli strati piùpoveri del proletariato americano, già allora vessato dai grandi monopolistied oligopolisti che imponevano alti prezzi e qualità scadente suigeneri,di,prima,necessità. Il successo delle proteste portò all’approvazionedi leggi federali che imposero un livello minimo di genuinità negli alimentie nei medicinali.
Negli anni ’70 del Novecento, il Movimento dei consumatori si estende anchenell’Europa Continentale: sorgono associazioni private. I consumatoridivengono oggetto di attenzione non solo da parte delle istituzioni ma ancheda parte di studiosi di economia, sociologia e di diritto. Sono introdottele prime leggi che si preoccupano di tutelare i consumatori dalle frodi,dalla pubblicità ingannevole.
Nel 1975, la Comunità Europea, dopo un lungo dibattito interno, intervieneal fine di armonizzare le regole del “mercato interno” e riordina in modoorganico tutte le iniziative in materia di tutela del consumatore e precisaquali saranno gli obiettivi del suo intervento:
1. La protezione contro i rischi e per la salute del consumatore2. La protezione degli interessi economici del consumatore;3. La predisposizione di consulenza e assistenza per il
risarcimento dei danni; 4. L'informazione e l'educazione del consumatore;5. La consultazione e la rappresentanza dei consumatori nella
predisposizione delle decisioni che li riguardano;
1
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Fasi della ricostruzione e dell’evoluzione del fenomeno associativo inEuropa:
I) 1973: Commissione C.E. istituisce un Comitato consultivo dei consumatori,che esprime pareri in ordine all’armonizzazione delle discipline delsettore;
II) 1975: emanata risoluzione sulla tutela dei diritti e degli interessi deiconsumatori;
III) 1989: il Comitato assume la denominazione di Consiglio, composto da 33membri, eletti per un triennio, esprime orientamenti attraverso il Serviziopolitico dei consumatori.
Anche le associazioni, sempre negli anni ’70, iniziano ad assumere un ruoloimportante sia a livello istituzionale sia per la promozione dei diritti edegli interessi dei consumatori. Nel nostro Paese l’associazionismo nelsettore è fenomeno piuttosto recente. Tra le più importanti associazioniitaliane ricordiamo: la Federconsumatori, l’Adoc, il Codacons; l’Adiconsum,il Movimento consumatori.
Particolarità che connota l’esperienza italiana è data dal movimentocooperativo che si preoccupa di tutelare gli interessi dei consumatoricoinvolgendoli nel mondo della produzione e della distribuzione, con lecooperative del consumo; qui il consumatore assume quindi un duplice ruolo,del soggetto che crea e del soggetto che consuma, potendo contenere i prezzie controllando la qualità di beni e servizi.
Il consumatore dal punto di vista economico e sociologico
Tra il 1960 ed il 1970 è stato esaminato a fondo il comportamento delconsumatore, e si ebbe allora la consapevolezza che le scelte deiconsumatori rispondono a due tipi di esigenze: materiali e psicologiche.Successivamente, l’intervento della sociologia portò una ventata di novità,e consentì agli economisti ed alle imprese di identificare con precisione lecaratteristiche del consumatore. E’ nato così il marketing e tutte quelleattività, come la pubblicità subliminale, che ogni giorno ci spingono adacquistare non ciò che è utile per noi ma ciò che la catena produttiva desidera. Il marketingcrea ogni giorno nuovi bisogni, necessità che non esistevano fino ad unattimo prima e che non ci portano verso alcun benessere, e poi ci spiegacome placare questi nuovi bisogni spendendo soldi e facendo debiti. L’UnioneEuropea ha ritenuto la pubblicità talmente pericolosa per i consumatori davarare una Direttiva ad hoc già nel 1984 (Direttiva 84/450/CEE sullapubblicità ingannevole, recepita in Italia solo nel 1992 dal D.Lgd.74/1992), e successivamente, nel 1997 la Direttiva è stata nuovamentemodificata per regolare il fenomeno della pubblicità comparativa (Direttiva97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicitàingannevole e comparativa, recepita in Italia dal D.Lgs. 67/2000).
Perché tutelare il consumatore?
2
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Le risposte sono varie:
a) Chi ritiene che ciò sia il risultato di una nuova ripartizione in classisociali adeguata alla nuova realtà sociale;
b) Chi vi ha visto una frammentazione della persona;c) O degli interessi protetti dall’ordinamento;
d) Chi il risultato delle convergenti direttive normative provenienti dafonti formali diversificate.
Gli interrogativi sulle ragioni che sorreggono la politica e gli interventicomunitari rivolti alla tutela del consumatore, così come la legislazione ela giurisprudenza degli Stati membri dell’Unione, si sono rinnovati nelmomento in cui le definizioni legislative di <<consumatore>> hanno fattoingresso nei codici civili.
Attualmente si può dire che la nozione di consumatore ha assunto contorni diuna formula neutra, priva di connotati ideologici. Se si dovesse accoglierela definizione che sottolinea aspetti sociali del diritto privato,bisognerebbe frammentare in altrettanti aspetti di volta in volta connessicon l’età, il sesso e le condizioni economiche e sociali.
I consumatori nel mercato globalizzato
Globalizzazione e rivoluzione digitale
Globalizzazione Rivoluzione digitale
Riguarda la dimensione planetaria dei Si riferisce alle nuove tecniche di rapporti economici, la produzione di comunicazione, scrittura, raccolta ebeni e servizi destinati ai mercati distribuzione di informazioni, multinazionali, la circolazione di ottenute mediante l’applicazionecapitali, investimenti senza delle 3 grandi frontieretecnologiche:frontiere. Implica mercati mondiali - hardware;per la finanza, diffusione di bio- - software;tecnologie, nuovo rapporto tra - internet. produzione agricola e alimenta- E’ il mondo dell’informazione e dellazione. realtà virtuale.
Nel momento in cui questi due fenomeni si sono integrati è avvenutaquell’implosione che ha portato alla new economy: cioè a un altro modo diprodurre, consumare, lavorare e di vivere dentro e fuori al mercato.
Forme di tutela del consumatore
Nel mercato globalizzato si possono distinguere 3 livelli di rapporto traconsumatore e professionista:
1. Livello locale;2. Livello comunitario;
3
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
3. Livello internazionale o globale.
Il primo appartiene al diritto interno e richiede la soluzione di problemiquali la disciplina dell’e- commerce, firma digitale, conclusione delcontratto mediante tecnologie informatiche.
Il secondo implica interventi di armonizzazione sia ad hoc, alcuni giàeffettuati con direttive.
Il terzo è il più problematico, atteso che non si sono ancora raggiuntiaccordi internazionali per l’uso delle tecnologie informatiche e quindi ilconsumatore è esposto alla disciplina impostagli dal professionista.
CapitoloPrimo
Il diritto dei consumatori
Le fasi del processo di tutela
La cronistoria della tutela del consumatore si snoda secondo un processoeconomico, sociologico e giuridico che si può scandire in fasi.
Prima fase:
Si colloca in Italia tra l'inizio degli anni '70 e l'inizio degli anni '80; essa è connotata da unafondamentale esigenza: individuare la figura del consumatore come controparte, non solo economica,dell'impresa, e sviluppare il tentativo di identificarne i diritti, che assolvono anche alla funzione di limitealla libera attività imprenditoriale. Nella prima fase si è assistito quindi all'individuazione dei diritti incapo agli individui considerati come consumatori.
Seconda fase:
Collocata tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90: intervento legislativo e giurisprudenziale neisingoli settori in cui si può articolare il consumo (ad es. pubblicità, credito, risarcimento in caso didanni derivanti da vizi e difetti di prodotti e servizi).
Terza fase:
Si colloca nell'ultimo decennio, in cui si è accreditato lo status di consumatore e si sono introdotti primiprovvedimenti di tutela. Si discute se sia opportuno o no elaborare un quadro normativo organico diprotezione del consumatore, sia nella dimensione individuale che in quella collettiva, si discute sulle
4
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
modalità di intervento se quest'ultimo si debba mantenere a livello statuale o anche regionale, se sidebba lasciare spazio all'autonomia privata o debba essere frutto della mediazione dell'interventopubblico.
In ambito comunitario si può dire che il settore della tutela dei dirittidei consumatori è uno dei settori in cui gli organi comunitari hannoritenuto di non applicare in modo esteso il principio di sussidiarietà, cioèdi non affidare interamente agli Stati membri il compito di tradurre inregole gli indirizzi di protezione del pubblico considerato nella dimensionedel consumo, dell'utenza e del risparmio, ma piuttosto di mantenere costantee vivo l'impulso all'armonizzazione degli ordinamenti nazionali.
In ambito europeo si sono moltiplicate le occasioni d'incontro tra giuristie operatori dei diversi paesi membri dell'unione e del consiglio d'Europa,questa tecnica di comunicazione e discussione viene avviata medianteconvegni, cicli di conferenze e seminari ed ha la finalità di illustrare imodelli nazionali e agevolarne il trapianto e la circolazione.
Nel nostro paese si ricorda l'approvazione della recante la "disciplina dei dirittidei consumatori e degli utenti" (L.281/98), tale legge da ingresso ad alcunidiritti che non avevano ancora ricevuto il riconoscimento generale. In piùassicura una tutela collettiva dei consumatori attraverso il riconoscimentogenerale della legittimazione ad agire delle loro associazioni.
Dalla fine del 1998 alla primavera del 2002 il diritto dei consumatori aregistrato novità in ambito comunitario e nell'esperienza il nostro paese darichiedere un vero e proprio ripensamento dell'intera materia.
In ambito comunitario l'apice della trasformazione è rappresentato dal"quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori 1999-2003", dal libro verde sulla "protezione dei consumatori nell'unioneeuropea", da alcune direttive di portata generale quali: la direttiva n.99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni diconsumo.
Nel diritto interno, oltre all'attuazione delle direttive comunitarie,emerge l'esigenza di coordinare tutta la disciplina in un testo unico.Questo disegno che portava a compimento con il D.Lgs n. 206/2500 che haintrodotto il codice del consumo.
Altri grandi novità riguarda l'autentica rivoluzione che si attuata nelsistema delle fonti del diritto interno, in cui per effetto della L. Cost.3/2001 si è riscritto l'art.117 Cost. e si sono modellati i poteri normatividello Stato e delle regioni, a quest'ultima spetta la potestà legislativa inriferimento ad ogni materia non strettamente riservata alla legislazionedello Stato. Tra le materie riservate allo Stato non compare una dizioneconcernente i consumatori, ma compaiono materie che investono il diritto diconsumatori, come la moneta, la tutela del risparmio, i mercati finanziari,la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile e penale, la visitaamministrativa, la giurisdizione e le norme processuali; mentre la tuteladella salute e l'alimentazione sono materie di legislazione concorrente.
5
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Costituito da fonti di diversa natura, il settore dei consumi da luogo ad unvero e proprio corpus normativo, aggregando istituti, singole discipline,problematiche che si possano tutte riferire ai consumatori, al rapporto diconsumo e così via.
Le fonti del diritto dei consumatori
Il diritto comunitario
Il diritto comunitario è stato il vero motore per la realizzazione di undiritto dei consumatori negli ordinamenti nazionali. Per il nostro paese èstato determinante, anzi si può dire che solo l'adesione dell'Italia alMercato comune ha consentito di decollare a questa branca del diritto; percontro il diritto comunitario si è esteso in modo straordinario, pervadendoambiti un tempo considerati inattingibili perché riservati al legislatorestatuale, comunque alle prerogative degli Stati membri. Superato il primodecennio, dagli anni 70 agli anni 80 del novecento, i due percorsi,comunitario e interno, si sono intrecciati.
Il diritto interno. La costituzione e il ruolo dello Statoe delle Regioni
Nel linguaggio dei costituenti le categorie economiche contemplateriflettevano una storia classica del mercato, senza particolareconsiderazione della libertà di concorrenza e delle dimensioni dei consumi.Il ruolo di consumatore si può pertanto costruire tenendo conto delledisposizioni che riguardano la persona, per godere dei consumatori, cometutela della persona (art.2 Cost.), diviene un limite interno all'iniziativaeconomica privata, che non deve offendere la dignità, la sicurezza e lasalute della persona e della conformarsi alla utilità sociale (art.42, c.2,Cost.).
Nella distribuzione della potestà legislativa tra Stato e regioni, con lamodificazione dell’art. 117 Cost. per effetto della L. Cost. 3/2001, loStato si è riservato alcune materie, altre le ha condivise con le regioni eper tutto resta affidata la legislazione alle regioni. Tra le materieriservate allo Stato non compare una legislazione sul consumo, ma compaionomaterie che investono il diritto di consumatori, come la moneta, la tuteladel risparmio, i mercati finanziari, la tutela della concorrenza,l'ordinamento civile e penale, la visita amministrativa, la giurisdizione ele norme processuali; mentre la tutela della salute e l'alimentazione sonomaterie di legislazione concorrente.
La legge ordinaria e gli atti ad essa equiparati
Molte sono le disposizioni del codice civile che trattano materie cheinteressano i consumatori; da considerare con attenzione è il settore delcredito, che non si può circoscrivere solo alla disciplina del credito al
6
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
consumo, ma abbraccia tutti rapporti contrattuali tra le banche, gliintermediari finanziari, le società finanziarie e i consumatori.
Con ritardo rispetto alle iniziative legislative assunte in altri paesieuropei, nel luglio 1998 è stata approvata la legge che riconosce dirittifondamentali dei consumatori e degli utenti delle loro associazioni.
Anche gli statuti regionali talvolta tengono conto degli interessi deiconsumatori, così pure gli statuti comunali, provinciali e delle cittàmetropolitane.
Il codice del consumo (d.lgs. 206/2005) ha incorporato gran parte delledisposizioni contenute in leggi speciali e le disposizioni del codice civilein esso inserite in attuazione delle direttive comunitarie.
Le leggi regionali
Gran parte delle questioni giuridiche che investono i consumatori appartieneall’ordinamento civile, la cui disciplina è riservate allo Stato. In unasentenza della corte costituzionale si chiariva che le regioni possono averecompetenza legislativa in quelle materie del diritto privato che nonincidono sugli istituti
fondamentali, quali ad es. i modi di acquisto e di estinzione dellaproprietà, le obbligazioni, la famiglia, la responsabilità civile, isoggetti. Poiché anche le regioni possono attuare direttive comunitarie,sarà di volta in volta necessario capire a quale livello si debba attestarel'attuazione delle direttive e quali differenze tra provvedimenti possonoessere consentite.
Comuni e province
Nei comuni e nelle province sono stati istituiti uffici per la tutela delconsumatore, per l'informazione e l’educazione, oppure per i controlli dellapolizia annonaria; si può quindi individuare una sotto branca della materiaraccolta di diritto amministrativo di consumi.
Provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti
L'antitrust, l'Isvap (Istituto sulla vigilanza delle assicurazioni private),la Consob (commissione di vigilanza sulle società e sulla borsa), il Garantedei dati personali, l'autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni,l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, hanno potere normativo sub-primario, e adottano provvedimenti che concernono la tutela degli interessidei consumatori nei settori di loro competenza.
Autodisciplina e codici di condotta
7
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
La formazione negoziale del diritto come fattoreunificante dei fenomeni in esame
Autonomia privata, codici deontologici, accesso alla giustizia sono fenomenicollegati tra loro che hanno come minimo comune denominatore: la formazionenegoziale del diritto. La formazione negoziale del diritto è un connotatoessenziale della stessa positività dell'ordinamento giuridico, in quanto èlo stesso ordinamento che consente la creazione di norme giuridiche al difuori delle fonti istituzionali: si tratta della creazione di regole e dellaistituzione di diritti soggettivi che non proviene dall'altro, cioèdall'imposizione con legge o con provvedimento amministrativo avente naturadi normazione sub-primaria, ma proviene dalle formule organizzatorie dellasocietà civile. La creazione negoziale non può farsi strumento diprevaricazione del più forte sul più debole, né strumento di contrasto conl'ordinamento, né strumento di elusione delle regole dell'ordinamento; cosìcome l'autonomia privata non può sconfinare nell'arbitrio e nellasopraffazione, essa deve consistere in un agire positivo e non può sottrarsial limite controlli.
Autonomia e controlli: due prospettive di analisi inconflitto e quattro modelli possibili di classificazione
Ogni settore dell'economia ha alimentato la polemica tra liberisti einterventisti, tra sostenitori del mercato libero da limitazioni,prescrizioni e controlli, e sostenitori del mercato libero nel rispettodelle regole di correttezza, buona fede, tutela degli interessi deboli edegli interessi socialmente rilevanti.
Le due posizioni appaiono antitetiche più per gli assunti ideologicamenteopposti da cui muovono che non per gli effetti pratici che ne conseguono:anche il mercato più libero non sfugge a limitazioni e controlli; gli stessicontrolli non possono essere fino al punto di inceppare l'eserciziodell'attività economica.
Individuata la scelta di campo da parte del legislatore e dell'interprete,si possono individuare diversi modelli di rapporto tra autonomie econtrolli, cioè tra le creazioni di regole e il controllo sulla loroosservanza da parte dei loro destinatari possono ascriversi a 4 diversimodelli:
1. autonomia e autocontrollo;
2. autonomia ed eterocontrollo;
3. eteronormazione e autocontrollo;
4. eteronormazione ed etero controllo.
8
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
I soggetti e gli interessi investiti
Un'analisi rivela che la categoria degli status non è stata superata nésoppressa dalla codificazione del 1942, dalla legislazione speciale e dagliorientamenti giurisprudenziali. Convivono status di privilegio e status diprotezione: quando i primi basta menzionare le regole protettive chegovernano le professioni liberali, per i secondi le regole di protezione cheper l'adesione dell'Italia al Trattato CE, il legislatore statuale è tenutoad introdurre. Mentre nella nostra esperienza si distinguono iprofessionisti dagli imprenditori, non sono state ben definite quelle delconsumatore, risparmiatore ed utente. Gli interessi sono: individuali,diffusi, collettivi; ma nei diversi settori indagati ha rilievo l'interessepubblico, che non si può considerare soddisfatto dal reciproco o concorrentesoddisfacimento degli interessi privati in gioco.
Coordinamento delle fonti normative
Il quadro normativo in esame presenta lacune e difetti di coordinamento; ciòdipende dalla diversa origine, il diverso grado e il diverso operare dellefonti normative. Quanto al diritto comunitario, è assente la distinzione traprofessionisti liberali e imprenditori, tutti unificati con la terminologiadi "professionisti". Quanto alla normativa costituzionale si pone al centrodi questo diverso l’art. 41, da coordinare con gli artt. 2,3 Cost. Quantoalla legislazione speciale e ordinaria, si richiamano le osservazioni fattesulle leggi istitutive degli ordini. Quanto agli atti normativi sub-primarisi segnalano i regolamenti Consob sul comportamento delle SIM (società diintermediazione mobiliare), e la ricerca presso l'Autorità antitrust sullalegittimità degli Albi professionali. Quanto alla prassi legittimata subspecie di consuetudine dalla identificazione normativa delle fonti elegittimata dalla giurisprudenza, si pongono problemi analoghi a quelliinerenti all'autonomia negoziale. Quanto alle regole deontologiche, sipongono alcuni fondamentali problemi: la loro natura, la loro formulazione,il loro ambito, la loro finalità, il loro contenuto, il loro ruolo.
Elaborazione di clausole contrattuali e la tutela dellaconcorrenza
Gli organismi che regolano il comportamento degli aderenti, mediante codicidi condotta si propongono spesso anche di regolare i loro rapporti negozialiinterni e quelli con i terzi.
Con la L. n. 580/1993 è stato affidato alle Camere di commercio, il compitodi agevolare la redazione di moduli o formulari per la disciplinaconvenzionale dei rapporti tra imprese e dei rapporti tra imprese econsumatori.
9
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Vi sono fenomeni assai diversi e complessi: Le associazioni di categoria,gli organismi di controllo della deontologia, spesso si propongono diuniformare e di sistemare le regole negoziali che i singoli aderentiistituiscono con i terzi; si pone un problema grave e delicato se questeregole possano ostacolare la libera concorrenza. I contratti standard,contengono "condizioni economiche" concernenti, prezzi, tariffe,corrispettivi e clausole che incidono sugli aspetti economici, quali quellerelative a limitazioni esclusioni della responsabilità, decadenze, recessiecc.
La predisposizione di moduli uniformi alle imprese di un settore è spessoincoraggiato dalle associazioni di categoria, per il settore assicurativol’ANIA, per il settore bancario l’ABI; il problema è stato sottoposto
alla Commissione per la tutela della concorrenza e del mercato (c.d.Autorità antitrust), la quale ha ritenuto che le direttive delleassociazioni di categoria rivolte ad impegnare le imprese iscritte adattenersi ai modelli o alle regole elaborate dalle medesime associazionicontrastino con l’art.2, c.2, della L. 287/1990, perché le direttive delleassociazioni possono considerare o come cartelli veri è propri oppure comeintese che falsano la concorrenza.
Per il settore assicurativo, l'Autorità ha irrogato sanzioni a carico di unaventina di società assicuratrici per aver posto in essere intese aventi adoggetto la determinazione delle tariffe e degli scoperti delle polizzerelative al ramo "rischi diversi" e per essersi scambiate informazionifinalizzate alla determinazione comune degli elementi contrattuali, per averuniformato le franchigie delle polizze al ramo "infortuni" e al ramo"malattia" ed ad altri rami.
Per il settore bancario, la Banca d'Italia occupata di controllare se laredazione di clausole uniformi relative ai contratti bancari da partedell’ABI (c.d. Norme bancarie uniformi, NBU) potesse esporre l’ABI e leimprese aderenti alla sanzione dell’Autorità antitrust, che con unprovvedimento ha sottolineato che l’ABI è un'associazione senza scopo dilucro alla quale aderiscono la quasi totalità delle banche e degli istitutifinanziari, avendo lo scopo di cooperare con le istituzioni, di informaregli aderenti (cioè le banche e gli istituti iscritti all'associazione)promuovere studi, ricerche e scambi di informazioni; le c.d. NBU in quantodeliberazioni di un'associazione di imprese rientrano nelle fattispeciedell’art. 2, c.2, legge antitrust; poiché le intese riguardano laformulazione di norme bancarie uniformi che l’ABI invita o suggerisce diadottare. La Banca d'Italia recepito il parere dell'Autorità antitrust hacon proprio provvedimento, precisato che: 1. il carattere non strettamente miracolante delle intese non trae al vaglio della concorrenza;
10
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
2. devono essere modificate le condizioni contrattuali che riservano alla banca la potestà di modificareunilateralmente il contratto, escludere gli interessi di diritto e così via.
In ottemperanza a questo provvedimento l'ABI ha modificato le NBU ed haelaborato un codice di condotta concernente i rapporti con i clienti.
Il Codice del Consumo (Cc)
Il codice del consumo (D.lgs. 206/2005) entrato in vigore il 23 ottobre del2005, si compone di 146 articoli (diventati 171 dopo le modifiche del 2007);tale codice si apre con una enunciazione di carattere generale che richiamala normativa dell'U.E. e definisce i propri scopi intesi nel senso diarmonizzare e riordinare le normative concernenti i processi di acquisto econsumo, al fine di assicurare la tutela dei consumatori e degli utenti.
L'art. 3 include il testo della L. 281/1998, identificando i diritti deiconsumatori e le necessarie definizioni relative al consumatore/utente ealle associazioni di consumatori e utenti.
L'elenco dei diritti dei consumatori corrisponde all'elenco di dirittiprevisti dalla risoluzione CEE del 1975, con qualche formulazioneinnovativa. Oltre alla salute e alla sicurezza, si considera la qualità deiprodotti e dei servizi; per quanto concerne il diritto all'informazione,quest'ultima deve essere adeguata non solo sufficiente a consentire alconsumatore di effettuare le sue scelte, ma anche completa, comprensibile enon fuorviante, deve essere corretta.
Gli interessi economici devono confermarsi a <<correttezza>> (essa esprimeun principio generale riguardante l'intera materia delle obbligazioni e laclausola generale di buona fede), <<trasparenza>> (si deve verificare se ilcontratto è chiaro,inintelligibile, e se il consumatore è statoadeguatamente informato prima della sua istallazione e durante l'esecuzionedel rapporto) ed <<equità>> (è la più complessa e può implicare sia paritàdi trattamento, sia congruità del prezzo, sia considerazione dellasituazione concreta e specifica del consumatore).
Il diritto all'educazione intricata un impegno da parte delle istituzioni ainformare il consumatore e a formare la sua capacità di scelta, di giudizioe di consapevolezza dei propri diritti.
Natura dei diritti elencati Questi sono riconosciuti e garantiti dalla legge statuale e dalla stessaCostituzione, come il diritto alla salute (art.32), il diritto allasicurezza (art.41, c.2), il diritto di azione (art.24), garantiti a ciascunoin quanto persona. La categoria giuridica dei consumatori non ha trovatoesplicito riconoscimento nel testo originario della Costituzione; in ognicaso alcune situazioni si pongono come veri e propri diritti soggettivi cheoggi potremmo qualificare come tradizionali.
La qualificazione di <<diritti fondamentali>> può essere intesa:
11
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
a) in senso proprio -come posizioni soggettivi inviolabili, insopprimibili,immodificabili come ribadito dall'art. 143 del Cc (codice del consumo);b) in senso traslato - cioè come posizioni soggettive che costituiscono lostatus giuridico del consumatore e sono da considerarsi particolarmenterilevanti.
Questi diritti <<fondamentali>> dei diritti dei consumatori a cui potrannoaggiungersi altri diritti; un elenco dunque non a numero chiuso ma tale dacostituire i diritti basilari che non possono essere lesi nell'esercizio diattività economiche.
I diritti delle associazioni di consumatori e utenti
Artt. 136ss, riguardano i diritti delle associazioni dei consumatori, il cuiscopo primario è quello di tutelare il consumatore tramite l'esercizio diattività giudiziale alla quale si l'attività di informazione, educazione,assistenza, di promozione dei loro interessi, di negoziazione con le impresee di risoluzione dei conflitti.
Diritto di azione consiste:
1. nell'esercizio dell'azione inibitoria (di atti e comportamenti lesividegli interessi dei consumatori e degli utenti);2. nell'esercizio di azioni cautelari rivolte a correggere o eliminare glieffetti dannosi delle violazioni accertate;3. Nell'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in forma specifica,limitatamente alla richiesta di pubblicazione del procedimento ottenuto.
Si tratta di azioni proposte in via autonoma o nel procedimento promosso dalsingolo consumatore o utente.
Alle medesime associazioni si riconosce il diritto di promuovere laprocedura conciliativa, la quale può essere promossa anche dai singoliinteressati, la procedura si può concludere con la conciliazione verbaledichiarato esecutivo dal pretore.
La rappresentatività si fonda su alcuni requisiti di base:
I. costituzione in forma scritta e un ordinamento a base democratica,II. uno scopo esclusivo di tutela dei consumatori e degli utenti senza
fini di lucro,III. un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della
popolazione nazionale,IV. la presenza in almeno 5 regioni o province autonome,V. un bilancio conforme alle prescrizioni dettate per le associazioni
non riconosciute,VI. svolgimento di attività continuativa,VII. immunità da condanne dei rappresentanti.
Novità del codice del consumo12
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Si segnalano:
- disposizioni sull'educazione del consumatore (art.4) orientata a favorirela consapevolezza dei suoi diritti;
- gli artt. 33 e ss. incorporano le regole del codice civile sulle clausolevessatorie nei contratti dei consumatori senza correzioni di sorta. Vi sono2 disposizioni che collegano il Cc con il codice civile:
art.38 che qualificando indirettamente queste disposizioni come speciali, farinvio alle norme del codice civile per quanto non previsto dal Cc el'art.142 che modifica il testo del codice civile da inserire nella Cc,ribadendo l'applicazione del codice civile laddove non siano applicabili lenorme del Cc o altre norme più favorevoli al consumatore.-art.39 chiarisce che le pratiche commerciali sono improntate ai principi dibuona fede, correttezza e lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenzedi protezione delle categorie di consumatori;- artt. 40-43 trattano il credito al consumo, fanno sostanzialmente rinvioal testo unico bancario, viene inserita una disposizione (art.42)sull'inadempimento del fornitore di beni e servizi secondo la quale "ilconsumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora hadiritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, acondizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatorel'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. Laresponsabilità si estende anche il terzo al quale il finanziatore abbiaceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito".-disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (artt.47ss.), dei contratti a distanza (artt. 50 ss.) e la disciplina del recessoche è comune (artt. 64 ss.);-il commercio elettronico è oggetto di una disposizione di rinvio (art.68),-regole sulla multiproprietà (artt.69 ss.)-regole sui viaggi (artt.82).-carte dei servizi, il Cc si occupa dei servizi pubblici (art.101);-disciplina della sicurezza dei prodotti (artt. 102 e ss.);-responsabilità per danno da prodotti difettosi (artt.114 ss.);-nella vendita di beni di consumo (artt.128 ss.);-azioni inibitorie e accesso alla giustizia.
Con l’introduzione dell’art. 140-bis, il Codice si è arricchito dell’ “azionedi classe”, cioè della procedura dinanzi al Tribunale finalizzataall’ottenimento del risarcimento del danno in capo a ciascun componente delgruppo di consumatori danneggiati da un medesimo fatto.
Modifiche al Codice del Consumo
Nel corso del 2007 il Codice del consumo è stato oggetto di alcuni rilevantiinterventi normativi a testimonianza del fatto che non fossesufficientemente esaustivo ai fini della tutela a tutto tondodeiconsumatori. Nonostante le modifiche apportate e pur non mancando
13
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
apprezzabili sforzi ricostruttivi, manca ancora un coerenteimpiantosistematico. Ad esempio, la solenne enunciazione dei dirittifondamentali dei consumatori di cui all’art. 2 comma 2 del Codice: ildiritto alla tutela della salute, il diritto alla sicurezza ed alla qualitàdei prodotti, il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed all’equitànei rapporti contrattuali ed ancora il diritto all’erogazione di servizipubblici secondo standard di qualità ed efficienza, si palesa come priva diun reale contenuto precettivo, esaurendosi nella riaffermazione, peraltrocon norma di rango inferiore, di diritti già formulati nella CartaCostituzionale e già tutti indubbiamente spettanti ad ogni cittadino inquanto tale, indipendentemente dalla posizione ricoperta nella circolazionedi beni e servizi, cioè dalla sua qualifica di imprenditore o consumatore.Si è recepita la direttiva 2005/29/CE in materia di “Pratiche commerciali sleali traimprese e consumatori” (ad opera del d.lg. n. 146/2007), quindi, l’attuazionedelle “Disposizioni correttive ed integrative a norma dell’art. 7 della legge n. 229/2003” (ad operadel d.lg. n. 221/2007) per mezzo del quale si provvede anche a far rifluireall’interno del Codice la disciplina riguardante la “Commercializzazione a distanzadi servizi finanziari ai consumatori” (dettata dal d.lg. n. 190/2005 in attuazionedella Direttiva 2002/65/CE).Con questi poderosi interventi, gli articoli del Codice passano daglioriginari 146 agli attuali 171, rilevanti sia per dimensioni che percontenuti. La regolamentazione in materia di pratiche commerciali, inparticolare, è destinata ad influenzare in modo complessivo il grado ditutela riconosciuto ai consumatori, trattandosi di un intervento che,ponendosi l’ambizioso obiettivo di contrastare in modo trasversale lecondotte scorrette adottate dai soggetti professionali (nella pubblicità enella promozione dei prodotti, al momento della vendita come sul versantedelle garanzie) impatta in modo consistente sull’impianto del Codice.Le disposizioni correttive ed integrative (d.lg. n. 221/2007) rispondono,invece, all’esigenza di completare il quadro dell’ordinamento di consumo. Diparticolare rilievo, come detto, l’intervento in materia di pratichecommerciali tra professionisti e consumatori che, dal punto di vistasistematico, ha il merito di mettere ordine nella disciplina dellapubblicità realizzando una chiara separazione tra le norme a tutela deiprofessionisti concorrenti (oggi poste al di fuori del Codice di settore) equelle a tutela dei consumatori che oggi si trovano proprio nei nuovi artt.da 18 a 27-quater. Si osservi, infine che le norme sulle pratichecommerciali scorrette operano anche altri interventi di coordinamento: ild.lg. n. 146/2007 riforma anche l’art. 57 del Codice riguardante la “fornituranon richiesta” (art. 2) ed incide altresì (art. 5) sulla legge n. 173/2005,recante la disciplina della vendita diretta a domicilio e delle venditepiramidali stabilendo l’abrogazione, nella parte in cui riguardano forme divendita tra consumatori e professionisti, dell’art. 5, 1° e 7° comma. Dopotanto tempo di legislazione speciale, sull’onda di una evidente esigenza disemplificazione della normativa, è tornato in auge l’ operazione dicodificazione per risistemare la materia oggetto del Codice, con uno sforzoche va riconosciuto.
14
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Inutile aggiungere il valore simbolico e politico di una siffatta operazioneper i consociati che possono trovare in un unico corpus tutta (o quasi) ladisciplina che riguarda un certo ambito, contribuendo a quella conoscibilitàdella legislazione, in grado, secondo i precetti costituzionali, dirimuovere gli ostacoli alla uguaglianza sostanziale tra i consociati.
Capitolo secondo
I diritti dei consumatori in ambito europeo e la loro attuazione nel diritto interno
Tutela del consumatore in ambito europeo: La Carta europea dei consumatori del 1973
La Carta europea è stata approvata dall'assemblea consultiva del Consigliod'Europa con la risoluzione n. 543/1973, in essa vengono elencati i"diritti" che avrebbe potuto essere garantiti ai consumatori nei singolipaesi aderenti. Principi ispiratori sono espressi nel preambolo ove siprecisa che i paesi membri avvertono l'esigenza "di favorire il progressoeconomico sociale" attraverso una più stretta unione che trova formeconcrete nella definizione di regole uniformi in materia di consumerism.
Definizione di consumatore: inteso come “ogni persona, fisica o morale, allaquale siano venduti beni o forniti servizi per uso privato”.
La Carta individua 4 diritti fondamentali:
1) Diritto alla protezione e all’assistenza, con particolare alla difesadei diritti in giudizio;
2) Diritto al risarcimento del danno, per la circolazione di prodottidifettosi, o per la diffusione di messaggi mentonieri, erronei;
3) Diritto all’informazione e all’educazione;
4) Diritto alla rappresentanza.
La Carta dei consumatori si chiude con l’invito alle associazioni difabbricanti e commercianti, a elaborare propri codici ed a instaurare prassicommerciali, che dovrebbero promuovere l’osservanza più rigorosa di norme,sottoposte all’approvazione degli organismi internazionali dei consumatori.
Risoluzione del 1975 e i programmi iniziali della CEE
15
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
La risoluzione sui diritti dei consumatori, approvata nel 1975 ha comeobiettivo non solo la difesa dei valori
della salute e degli interessi economici dei consumatori, ma anchel’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, per prevenirecontrasti ed evoluzioni troppo differenti. Il mercato interno esige che lacircolazione di beni e di servizi non sia ostacolata da legislazioninazionali, il Trattato CEE nell’ambito delle politiche comunitarie perseguecome obiettivo primario “il miglioramento delle condizioni di vita e dioccupazione, tramite la promozione di uno sviluppo armonioso delle attivitàeconomiche, una espansione continua ed equilibrata , volta a migliorare iltenore di vita”.
Fondamentali obiettivi della risoluzione del 1975 sulla tutela delconsumatore:
a) Efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessieconomici dei consumatori;
b) Efficace protezione contro rischi per la salute e sicurezza delconsumatore;
c) Predisposizione di mezzi di assistenza, consulenza e risarcimento deidanni;
d) Informazione ed educazione del consumatore;
e) Consultazione ed rappresentanza dei consumatori nella preparazione didecisioni che li riguardano.
I punti fondamentali di questo programma collimano con l’elencazione dei“diritti dei consumatori” elaborati dal Consiglio d’Europa nella Carta del1973.
Politiche comunitarie e interventi frammentati
A partire dalla fine degli anni ’70 e soprattutto negli anni ’80 la Comunitàdà l’avvio ad un intenso programma di intervento, che riguarda l’attuazionedelle linee programmatiche tracciate nella risoluzione del 1975. Sonoinvestiti pian piano tutti i settori che riguardano i rapporti traconsumatore e professionista es. pubblicità commerciale, conclusione delcontratto, credito al consumo, clausole abusive, viaggi, multiproprietà.Con il Trattato di Amsterdam del 1997 alla tecnica di intervento frammentatosi affianca quella di coordinamento.L’intervento è giustificato dalle finalità di armonizzazione dellediscipline nazionali. Armonizzazione si differenzia dalla uniformazione, odalla applicazione identica di un complesso di disposizioni a tutti i
16
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
cittadini della Comunità; l’armonizzazione implica coordinamento,avvicinamento ma non sovrapposizione né identità.
Thomas Wilhelmsson distingue diversi livelli di armonizzazione:
1. Livello GIURIDICO-TECNICO: ha lo scopo di eliminare i costitransattivi, la scelta della legge applicabile, le difformità tra idiversi ordinamenti nazionali;
2. Livello REGOLAMENTARE: implica l’introduzione di regole non derogabilicon cui si vogliono tradurre le istanze che la Comunità consideraprioritarie;
3. Livello IDEOLOGICO: persegue lo scopo di creare un’identità comuneagli ordinamenti nazionali.
Atto Unico, Trattato di Maastricht e nuovi programmicomunitari
Trattato di Roma (1957): non contemplava norme ad hoc sui diritti deiconsumatori e sulla loro tutela, in quanto le finalità di tale trattatoerano circoscritte all’instaurazione di uno spazio economico libero tra iPaesi aderenti.
Atto unico europeo (1986) con cui si è integrato e modificato il Trattatodi Roma, ha rafforzato il ruolo del Comitato economico e sociale, in materiadi protezione dei consumatori.
Trattato di Maastricht (1992) ha trasformato la CE nell’U.E., ed haprevisto un apposito titolo dedicato alla “protezione dei consumatori”, l’U.E. hacompetenze specifiche volte a tutelare il consumatore
attraverso apposite misure. Le misure comunitarie non impediscono aisingoli Stati membri di assumere iniziative di tutela più rigorose.
L’armonizzazione passa anche attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia,la quale a fronte di una situazione in cui molti paesi non si peritavano diattuare le direttive nei tempi prescritti, ha inaugurato quell’indirizzointerpretativo secondo il quale le direttive che sono dettagliate e cheistituiscono diritti in capo ai singoli, sono immediatamente operanti,sicché le norme interne in contrasto con esse non sono applicabili dalgiudice chiamato a risolvere controversie. L’applicabilità diretta funzionasolo verticalmente (efficacia verticale) nei rapporti tra singolo e Stato, enon orizzontalmente (efficacia orizzontale) nei rapporti tra privati. In
17
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
caso di lesione di diritti soggettivi garantiti dalle direttive, al singolocittadino è riconosciuto il diritto di azione nei confronti dello Statoinadempiente al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Quanto alla politica di interessi comunitari dei consumatori, la Comunità haproseguito in modo sistematico a elaborare programmi di durata triennale,volti a dare attuazione ai 5 diritti disegnati nella risoluzione del 1975.
“Acquis” comunitario nel diritto dei consumi
L’esperienza normativa acquisita si denomina acquis, quella in materia diconsumatori oltre alle disposizioni contenute nei Trattati, nellagiurisprudenza delle sentenze della Corte di Giustizia, proviene anche dalledirettive.
Tra le più importanti direttive si rinvengono:
- Direttiva n.84/450/CEE sulla PUBBLICITA’ INGANNEVOLE;
- Direttiva n. 85/374/CEE in materia di RESPONSABILITA’ PER DANNO DAPRODOTTI DIFETTOSI, successivamente modificata da una direttiva del1999;
- Direttiva n. 85/577/CEE per la TUTELA DEI CONSUMATORI, IN CASO DICONTRATTI NEGOZIATI AL DI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI;
- Direttiva n.87/102/CEE in materia di CREDITO AL CONSUMO;
- Direttiva n.88/378/CEE in materia di SICUREZZA DEI GIOCATTOLI;
- Direttiva n.90/314/CEE in materia di VIAGGI.
Seguono poi quelle in materia di sicurezza generale dei prodotti, di servizidi investimento nel settore dei valori mobiliari, di trattamento dei datipersonali, di contratti a distanza; firme elettroniche; commercializzazionea distanza dei servizi finanziari, pratiche commerciali sleali,e in materiadi assicurazione.
La svolta del Trattato di Amsterdam
Art.153 del Trattato di Amsterdam (del 1997 entrato in vigore nel 1999),implica una svolta di straordinaria importanza nell’organizzazione degliobiettivi dell’U.E. e nella definizione di “cittadinanza europea”. Il primocomma si propone di promuovere l'interesse dei consumatori e ad assicurarlodall'elevato di protezione, la disposizione di apertura enuncia anche che laComunità ritiene proprio
compito istituzionale contribuire a tutelare alcuni diritti e interessi deiconsumatori. La tutela riguarda il diritto alla salute, alla sicurezza edegli interessi economici. La promozione riguarda il diritto
18
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardiadei propri interessi.
Differenze tra:
- Risoluzione del 1975: primo programma di iniziative assunte per laprotezione di interessi nuovi;
- Trattato di Maastricht: la protezione dei consumatori guadagna untitolo apposito (XI) e un'articolazione normativa nella disciplina dibase della Comunità, concentrata sul conseguimento di un elevatolivello di protezione dei consumatori;
- Trattato di Amsterdam: individuazione di diritti che sono oggetto didisposizioni non più di natura programmatica, ma di natura percettiva.
I diritti e gli interessi dei consumatori
I diritti individuati dall'art.153 sono ascrivibili ai tre diversecategorie:
1. Diritti soggettivi perfetti, riconosciuti e garantiti non solodall'individuo come <<consumatore>>, ma ad ogni individuo come <<persona>>in alcune Costituzioni scritte dei paesi membri, quali la salute lasicurezza (Cost.It. artt. 32, 42, c.2);2. Interessi economici;3. Diritti soggettivi che implicano una considerazione non solo individualema anche collettiva, come l'informazione, l'educazione e l'organizzazione(che comprende sia la libertà di associazione, sia la presenza istituzionaledei gruppi).
Per la seconda categoria emergono una serie di dubbi, che devono esseresciolti tenendo conto delle prassi interpretative delle norme comunitarie edegli scopi del trattato di Amsterdam(in particolar modo si fa riferimentoall'art.153). I diritti in capo ai consumatori nei rapporti economici sonomolteplici, questi si connotano per il loro contenuto economico e pur nonavendo eguale "durezza" rispetto a quelli inerenti la salute e la sicurezza;tuttavia sono diritti fondamentali in quanto riconosciuti e garantiti dallalegge di base dell'Unione.Un altro aspetto rilevante dell'articolo 153, riguarda il c.2 con il qualesi dispone che "nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche oattività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti allaprotezione dei consumatori". L'espressione "politica" indica i valori, gliobiettivi, gli indirizzi dell'Unione, la quale si fa carico di considerarein ogni caso la politica dei consumatori come una delle proprie politicheistituzionali. L'esigenza di consumatori costituiscono dunque un punto diriferimento obbligato, nel senso che non sarà sufficiente prenderli inconsiderazione, ma sarà necessario mediare gli interessi con esse
19
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
conflittuali, per assicurare un livello di protezione elevato degliinteressi dei consumatori.
Convenzione europea sulla legge applicabile in materia diobbligazioni contrattuali
L’art.5 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazionicontrattuali entrata in vigore nel 1991, prevede norme relative alla sceltadella legge da applicarsi al contratto concluso dai consumatori. Il comma 1recita che tale articolo si applica ai contratti aventi per oggetto lafornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, ilconsumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attivitàprofessionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura.
L’Art.3 recita:
1) il contratto è regolato dalla legge scelta delle parti; la scelta deveessere espressa o risultare in modo certo dalle disposizioni delcontratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la leggeapplicabile a tutto il contratto o a una parte di esso;
2) Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre ilcontratto a una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza.Qualsiasi modifica intervenuta posteriormente alla
3) conclusione del contratto, non inficia la validità formale delcontratto e non pregiudica i diritti di terzi;
4) la scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata onon dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento dellascelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano ad un unico paese,non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di talepaese non consente di derogare per contratto.
Nel caso in cui le parti non scelgano la legge applicabile (a normadell’art.3), l’art.4 dispone che il contratto è regolato dalla legge delpaese con il quale presenta il collegamento più stretto.
La prima deroga prevista dell’art. 5 stabilisce che la scelta ad opera delleparti della legge applicabile, non può avere per risultato di privare ilconsumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperativedella legge del paese nel quale risiede abitualmente:
a) se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da unaproposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiutonello stesso paese gli atti necessari per la conclusione delcontratto;
20
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
b) se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine delconsumatore nel paese di residenza;
c) se il contratto rappresenta una vendita di merci e se consumatori si èrecato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulatol'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dalvenditore per incitare il consumatore ha concludere una vendita.
La seconda deroga dell'art. 5 prevede che, in mancanza di scelta effettuataa norma dell'art. 3, tali contratti siano sottoposti alla legge del paesenel quale il consumatore ha la sua residenza abituale, sempre che ricorranole condizioni previste al par.2 del medesimo articolo.
La ratio dell'art.5 è chiara ed è quella di offrire protezione alla parteconsiderata "più debole" nel rapporto di consumo cioè l'utente.
Per quanto attiene gli aspetti formali, alcune delle questioni aperte dallanorma riguardano:
1) definizione di consumatore;2) settori di tutela;3) identificazione della controparte del consumatore;4) gli effetti della normativa.
Osservazioni sui profili formali di applicazione della norma:
La norma non da la definizione di "consumatore", quella di consumatore èespressione recente e non definitivamente decodificata.
La norma sembra poi considerare solo i rapporti di consumo che hanno origineda un negozio concluso in forma scritta e sulla base di una trattativa o unacontrattazione individuale, mentre nella quasi totalità dei casi i rapportidi consumo si concludono oralmente o se in forma scritta, sulla base dicondizioni generali di contratto predisposte dall'impresa e imposte alconsumatore. La scelta della legge quindi o non si compie affatto, o secompiuta è unilaterale e perciò imposta al consumatore.
Inoltre non è possibile definire il consumatore senza definire lacontroparte, dalla norma non si intende se controparte è semplicemente ilproduttore (del bene o servizio), l'importatore, il rivenditore (venditorifinali). Occorrerebbe visto che l'art.5 non da la definizione di consumatoredi integrarla con la definizione delle singole leggi nazionali.
Anche i settori di tutela non sono tutti considerati dall'art.5, in altritermini i riferimenti alle leggi che riguardano il consumatore sonoincompleti.
"Contratto con i consumatori", è ogni pattuizione a base individuale o di"massa", che abbia come destinatario un consumatore, quindi sono inclusi siai patti, non contenuti in un contratto completo, sia le offerte, sia lecertificazioni delle promesse e anche le descrizioni della qualità deiprodotti di servizi o le indicazioni sulle modalità d'uso che abbianorilevanza negoziale.
21
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Osservazioni sui profili sostanziali, di affettività, di opportunità dellanorma:
Qualche perplessità può sorgere dal fatto che l'assunto da cui sembramuovere il sistema della convenzione è che le legge di residenza delconsumatore sia più favorevole al consumatore che non all'impresa; taleassunto può essere apprezzabile negli ordinamenti nei quali il consumatore ègarantire protetto, non lo è invece per gli ordinamenti che attendono quellemisure di protezione, o in cui le misure non siano di livello elevato comequelle per i paesi più evoluti.
La tutela del consumatore nei principi generali deldiritto comunitario e nella giurisprudenza della Corte diGiustizia dell'Unione Europea
Il complesso delle regole di diritto comunitario comprende anche i principigenerali, che secondo l'orientamento della dottrina delle fonti del diritto,sono norme di secondo grado, in quanto ricavati in via induttiva dallesingole disposizioni che si applicano in particolari settori.
Tra i principi generali si annoverano: il principio di sussidiarietà, ilprincipio di proporzionalità, i principi di tutela dell'affidamento.
Sul piano delle effettività si è accertato che gli stessi organi dell'U.E. ela corte di giustizia hanno più volte menzionato questi principi e li hannosalvati nella loro azione.
Nel 1976 la corte di giustizia ha elevato al rango di principi generali,idiritti fondamentali dell'uomo e sono stati inclusi anche quelle aventinatura economica. Nella giurisprudenza della corte di giustizia si registral'applicazione di principi che riguardano indirettamente o direttamente laposizione giuridica ed economica dei consumatori.
In primo luogo si è considerata la violazione da parte degli stati membridell'obbligo di recepire nell'ordinamento interno, le direttive comunitarieconcernenti il settore dei rapporti di consumo. Si è pertanto affermato ilprincipio generale di responsabilità dello Stato e delle istituzioni interneper violazione del diritto comunitario.
In secondo luogo, il principio della tutela del consumatore si è venutoformando nell'applicazione delle disposizioni del trattato di Romariguardanti la libera circolazione delle merci, le restrizioni in materiapreviste dagli ordinamenti degli stati membri non possono violare i dirittie le forme di difesa dei consumatori.
Occorre segnalare una significativa pronuncia della corte di giustizia cheprende posizione sulla definizione di consumatore:
Sentenza del 1998, concerneva la sottoscrizione di una fideiussionesottoscritta dal figlio, Dietzinger, a favore del padre, commerciante, che
22
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
aveva contratto un mutuo con una banca; ci si chiedeva se il contratto difideiussione potesse considerarsi sottoscritto da un consumatore e quindiassoggettato alla disciplina dei contratti negoziati fuori dai localicommerciali, oppure ne fosse estraneo. La corte ha svolto ragionamento sullabase del quale il contratto di fideiussione è di natura accessoria rispettoal contratto principale, e che in linea generale non si possa escluderedalla sfera di applicazione dei consumatori un contratto a favore di terziper il solo motivo che i beni o servizi acquistati siano da esso destinatiall'uso di una persona estranea al rapporto contrattuale in questione.Tuttavia, poiché il contratto principale era stato concluso non da unconsumatore ma da un commerciante, cioè un professionista, la corte haritenuto che l'art.2 della direttiva sulla conclusione di contratti fuoridai locali commerciali debba essere interpretato "nel senso che un contrattodi fideiussione stipulato da una persona fisica, la quale non agiscanell'ambito di un'attività professionale, è escluso dalla sfera diapplicazione della direttiva quando essa garantisca il rimborso di un debitocontratto da un'altra persona la quale agisce, per quanto la concernenell'ambito della propria attività professionale".
La corte di giustizia in più occasioni ha ritenuto che la nozione diconsumatore, qualunque sia la sua definizione, non può che riguardare unapersona fisica. Ciò non significa che in fase di attuazione delle direttive,gli Stati membri siano vincolati, potendo invece estendere la tutela allepersone giuridiche che operino al di fuori dell'attività commerciale svolta.
Nuove politiche di tutela del consumatore nell'U.E.
Nuovi programmi di politica dei consumatori
Nella sua relazione sul "Piano violazione in materia di politica dei consumatori 1999-2001" e sul "Quadro generale per le attività comunitarie a favore deiconsumatori", la Commissione ha sottolineato l'aiuto e il sostegnofinanziario e logistico assicurato alle associazioni, l'obiettivo diistituire " euro-sportelli" per meglio servire i consumatori, l'obiettivo diagevolare il dialogo tra consumatori e aziende.
La relazione evidenzia ancora lacune in materia di educazione deiconsumatori e descrive invece i risultati ottenuti sul piano della sicurezzadei prodotti, si preoccupa inoltre di migliorare la tutela degli interessieconomici dei consumatori con particolare riguardo ai servizi finanziari,all'accesso ai conti bancari, all'uso della moneta elettronica ed aifenomeni di indebitamento eccessivo.
La Commissione si propone poi di semplificare il quadro normativo e dimigliorare l'integrazione delle misure dirette a tutelare gli interessieconomici di consumatori con le altre politiche dell'unione, inoltre haelaborato un articolato programma di interventi volti a raggiungere unmigliore livello di armonizzazione in quei settori in cui consumatori devonoessere protetti indipendentemente dalle informazioni acquisite (ad es., in
23
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
materia di tutela della salute fisica e di sicurezza). Elementi chiave dellanuova strategia sono: l'unione monetaria ottenuta mediante l'introduzionedell'euro, l'uso di Internet, lo sviluppo del commercio elettronico,l'affinamento dei modelli di consumo.
Il Libro verde ha una funzione rilevante, perché in primo luogo espone ilquadro complessivo degli interventi già effettuati nel settore; in secondoluogo si preoccupa di capire quale potrebbe essere il futuro di questosettore, se cioè sia necessario affidare al mercato la soluzione deiproblemi di tutela del consumatore (ad es. attraverso codici diautodisciplina, attraverso le negoziazioni tra professionisti e le loroassociazioni con le associazioni dei consumatori) oppure se sia necessarioun nuovo intervento del legislatore comunitario al fine di coordinare ladisciplina esistente. Gli esempi evocati riguardano le pratiche commercialileali, le pratiche ingannevoli, l'informazione, la cooperazione tra soggettiportatori di interessi tra loro conflittuali e da contemperare.In contrasto con questa linea -le politiche comunitarie spesso confliggonocon le politiche concernenti il mercato interno e la concorrenza-lacommissione ha elaborato una comunicazione sulla promozione delle venditenel mercato interno.
I 10 principi di base
I principi sono formulati con una terminologia accessibile a tutti edescrivono il " livello minimo di tutela" che tutti gli stati membridovrebbero garantire ai consumatori:
1) COMPRARE CIO' CHE SI VUOLE,DOVE SI VUOLEl'ordinamento comunitario garantisce la libertà di acquisto e di trasportodi beni e servizi all'interno dell'unione, consente cioè ai consumatori dicomprare ciò che vogliono in qualsiasi paese dell'unione, senza doversiaccollare dazi doganali o imposte supplementari (oltre all'Iva prevista);può essere effettuato in via diretta, a distanza, per corrispondenza, pertelefono o per Internet;
2) RESTITUIRE CIO' CHE NON FUNZIONAl'ordinamento comunitario ha introdotto regole relative alle garanzie nellevendite, che consentono di esperire rimedi diversi quali la riparazione, lasostituzione o la restituzione, nei casi previsti;
3) NORME DI SICUREZZA ELEVATE PER ALIMENTI ED ALTRI BENI DI CONSUMOl'ordinamento comunitario prevede regole di controllo sull'intera catenaalimentare per garantire la sicurezza degli alimenti;
4) INFORMARSI SU CIO' CHE SI MANGIAl'ordinamento comunitario prevede regole concernenti le informazioni daindicare sulle confezioni di prodotti, l'etichettatura ripercorre ilprocesso produttivo evidenziando tutti i dati utili, compresa lacomposizione, la provenienza, le allergie;
5) CONTRATTI EQUI NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI
24
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
questo principio si riferisce al divieto delle clausole abusive;
6) A VOLTE I CONSUMATORI POSSONO CAMBIARE IDEAè il principio che consente chi abbia fatto acquisti di beni o servizi inluoghi diversi dai locali commerciali, o mediante tecniche a distanza, disciogliersi dal vincolo contrattuale esercitando il diritto di recesso (c.d.diritto di ripensamento) entro un determinato periodo di tempo e senzapenali;
7) CONFRONTARE I PREZZI DEVE ESSERE PIU' FACILEper potersi orientare il consumatore deve scegliere i prodotti anche conriguardo alla loro commisurazione, oltre che con riguardo alla loro qualità;di qui l'obbligo imposto ai supermercati di indicare il prezzo unitario delprodotto, al di là delle quantità contenute nelle confezioni in vendita.Regole più complesse, ma efficaci, riguardano i prezzi dei servizifinanziari, che sono resi più trasparenti dalla comunicazione del tassoannuo effettivo globale (TAEG);
8) I CONSUMATORI NON VANNO INGANNATI si fa riferimento alla pubblicità ingannevole, alle informazioni daconferire ai consumatori in caso di vendite televisive e per corrispondenza,alle informazioni che riguardano i prodotti finanziari;
9) LA TUTELA DEI CONSUMATORI DURANTE LE VACANZEè un principio che si riferisce sia agli obblighi degli operatori turistici,sia ai carriers per far sì che quanto dichiarato nell'opuscolo informativoconsegnato al cliente corrisponda alla prestazione effettiva. Esso siriferisce anche all'acquisto del diritto connesso al godimento parziale diimmobili (c.d. Multiproprietà) e si riferisce anche alla circolazione dianimali domestici che siano provvisti di passaporto;
10) MEZZI DI RICORSO EFFICACI PER LE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE poiché i consumatori sono "agenti economici e responsabili del mercatointerno", non solo essi ricevono garanzie per fare acquisti sicuri in tuttii paesi dell'unione, ma anche l'opportunità di cercare i migliori affariovunque in Europa. La rete ECC-Net informa i consumatori sui loro diritti ecomunica le informazioni necessarie per attirare i rimedi relativi quandol'acquisto è transfrontaliero.
Nuove prospettive comunitarie in materia di tutela deiconsumatori
Il Parlamento europeo e il consiglio con la decisione n.20 del 2004, hannodefinito un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitariea sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007.
I settori di azioni riguardano: la salute e la sicurezza dei consumatori in relazione ai servizi e aiprodotti non alimentari; la tutela degli interessi economici e giuridici deiconsumatori; la promozione dell'informazione e dell'educazione deiconsumatori.
25
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Le azioni riguardano obiettivi di natura prioritaria:elevato livello comune di tutela, attraverso la definizione di norme epratiche comuni; l'applicazione efficace delle norme che tutelano iconsumatori attraverso la sorveglianza del mercato; meccanismi dirisoluzione stragiudiziale delle controversie, coinvolgimento delleassociazioni dei consumatori nello sviluppo delle relative politichecomunitarie.
Con la comunicazione del 2005 la commissione ha proposto al Parlamento diadottare una decisione relativa al programma di tutela della salute e deiconsumatori per il periodo 2007-2013, si tratta di un testo assai ampio incui si prende atto delle attuali disuguaglianze di trattamento deiconsumatori in ambito europeo, con particolare riguardo alle fasce debolicostituiti dagli anziani e dai minori. Per il futuro la commissione siimpegna a rafforzare la sorveglianza e il controllo dei rischi cheminacciano la salute, a rafforzare le misure di prevenzione, a realizzaresinergie tra sistemi sanitari nazionali. Per le misure concernenti irapporti giuridico-economici la commissione si propone di effettuare larevisione delle direttive vigenti e di realizzare un quadro comune diriferimenti per il diritto contrattuale europeo; sostenere le associazioni;migliorare l'applicazione della normativa e le forme di tutela; migliorarel'informazione e l'educazione dei consumatori.
La Carta di Nizza e la Costituzione europea, accenni sulTrattato di Lisbona
L'U.E. ha approvato la Carta dei diritti fondamentali; essa quattro principidi natura generale:
1) dignità;2) libertà;3) solidarietà;4) cittadinanza;5) giustizia.
I diritti della persona si confondono con i diritti dei consumatori dalmomento che il diritto la salute è incluso nel diritto all'integrità personale,il diritto alla sicurezza e nel diritto sull'accesso alla prevenzionesanitaria e alle cure mediche; il diritto di associarsi è previsto dall'art.12; ildiritto di esprimersi e di essere informati è previsto dall'art.11; il diritto alla tutela degliinteressi economici è frazionato nella disposizione che assicura l'accesso aiservizi di interesse economico generale, nella tutela dell'ambiente e ingenerale nella garanzia di un elevato livello di protezione deiconsumatori,art.38.Queste disposizioni si riflettono nella Costituzione europea, il cuiprocesso di ratifica è stato interrotto da parte di alcuni Stati membri etutte le attenzioni si sono spostate sul Trattato di Lisbona (2007) entratoin vigore nel dicembre del 2009, che ha apportato profonde modifiche altrattato istitutivo dell'U.E.
26
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Attuazione delle direttive comunitarie nel diritto interno
Le direttive comunitarie sono state attuate con leggi speciali o mediantemodificazioni al codice civile:
Esempi:
- quella in materia di pubblicità ingannevole è stata attuata con D.L. 74/1992;-la direttiva per la tutela dei consumatori il caso di contratti negoziati fuori dei localicommerciali, è stata attuata con D.Lgs 50/1992;-la direttiva concernenti i viaggi, vacanze e circuiti <<tutto compreso>> è stataattuata con D.lgs 111/1995.
L'ordinamento è stato poi completato con l'introduzione di una legge generale suidiritti dei consumatori, la L.281/1998 ora inglobata nel c.d. CODICE DEL CONSUMO,che è stato concepito come un contenitore aperto a tutte le innovazionilegislative.
Capitolo terzo
La disciplina della concorrenza ela Correttezza nell’attività commerciale
La Legge Antitrust
La L.287/1990 concerne la tutela della concorrenza e del mercato.
Terminologia: Ci si è soffermati sul significato di concorrenza e mercato,si tratta di due fenomeni differenti e contrapposti fra loro: mentre vi puòessere mercato senza concorrenza (c.d. mercato monopolistico ooligopolistico), non vi può essere concorrenza senza mercato. Aggiungendo "emercato" si è voluto avvertire che lo spettro degli interessi incisi è piùampio a quello a cui di solito ci si riferisce quando si parla diconcorrenza (cioè agli interessi degli imprenditori concorrenti, nel c.d.libero mercato).La nozione giuridica di mercato: rimane vaga essendo il mercato una figuraideale dell’incontro di domanda e offerta, che varia a seconda dei beni edei servizi, delle regioni, dei sistemi politici e quindi dei sistemieconomici.
La nozione di concorrenza: varia con riguardo alla concorrenza sleale, aiconsorzi, ai patti di non concorrenza, ecc.
Inoltre i riferimenti ai principi di diritto comunitario amplia l’aerea diintervento dell’interprete, inoltre nel testo della legge il termine“consumatore” ricorre a più riprese in particolare: in tema di abuso diposizione dominante, a danno dei consumatori; in materia di deroghe al
27
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
divieto di intese restrittive della libertà della concorrenza, si ritengonolecite tali intese, autorizzate dall’agenzia amministrativa, diano luoghi amiglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiamoeffetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori.
Disciplina del mercato e tutela diretta dei consumatori
La disciplina della concorrenza e del mercato, investe in modo diretto gliinteressi dei consumatori, ciò perché nel mercato operano anche questi,riguardo agli interessi dei consumatori la L.287 riserva un’attenzionemodesta: dal testo si ricava che l’interesse dei consumatori è preso inconsiderazione solo come punto di riferimento, come metro di valutazionedell’anticoncorrenzialità di un atto o di una pratica, cioè come mezzo,piuttosto che come fine.
Tecniche di tutela del consumatore e disciplina dellaconcorrenza
La strumentazione tecnica con cui provvedere alla tutela dei consumatorinell’ambito della disciplina del mercato e della concorrenza, proponeiniziative molteplici, ma in particolare se ne segnalano 2:
1) La rappresentanza (c.d. diritto di essere ascoltati e il diritto dipartecipare agli uffici o organi che amministrano gli interessi deiconsumatori);
2) L’azionabilità degli interessi incisi.
Né l’una né l’altra tecnica sono contemplate nella disciplina antitruststatuale. La prima perché i consumatori non sono rappresentati nellaindividuazione dei componenti dell’Autorità di controllo. L’obiettivo delLegislatore in questo provvedimento, come negli altri che riguardano ilmercato, non è quello di tutelare
i consumatori, ma gli interessi dei consumatori insieme con gli interessidegli imprenditori. Ma l’equilibro da questi tipi di interessi è apparante,in quanto gli interessi degli imprenditori sono solidi e sono presenti nelladisciplina legislativa, per contro, gli interessi dei consumatori non sonointeressi di categoria, sono deboli, essendo affidati alle associazioni esono da poco tempo presenti nei testi legislativi.
Neppure la seconda tecnica è contemplata nella disciplina antitrust perchéle azioni a difesa degli interessi dei consumatori nella disciplina ditutela della concorrenza e del mercato sono considerate in modo marginale,alle associazioni si riserva solo la facoltà di informare l’Autorità, cioè
28
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
di portare alla sua attenzione i fenomeni anticoncorrenziali che si devonoreprimere. Quanto alla legittimazione ad agire in materia di risarcimentodel danno, le associazioni sono ignorate,essendo tutta al più possibileun’azione individuale. La dottrina si è concentrata sulla natura e l’entitàdel danno; ma in materia di illecito aquiliano derivante da violazione delladisciplina antitrust il problema più delicato è dato dal nesso causale.
Solo con l’ammissione della legittimazione ad agire delle associazionirappresentative, cioè con la class action , si sarebbe potuta assicurareuna efficace tutela dei consumatori.
La Corte di Cassazione ha ritenuto di competenza del giudice ordinario,provvedere al risarcimento del danno subìto dal consumatore, in caso diviolazione della disciplina comunitaria da parte di imprenditori cheavessero alterato la concorrenza. Il caso in esame riguarda le società diassicurazione che avevano concordato le tariffe per le RC Auto, che sonostate condannate dall’Autorità antitrust con apposito provvedimento,confermato dal Tar del Lazio e dal Consiglio di Stato.
La circolazione delle merci e dei servizi
Recente interpretazione attinente agli artt. 81,82, ex 85, 86 del Trattatodi Roma in ordine alla circolazione delle merci, alle restrizioni introdottedagli Stati membri e alla protezione degli interessi del consumatore.
Una ormai nutrita giurisprudenza della Corte di Giustizia documenta questoindirizzo innovativo. Essa non riguarda solo le restrizioni allacircolazione ma anche la denominazione e l’etichettaggio dei prodotti e cosìvia.
Il caso più importante (Cassis de Dijon, del 1979) ha dato l’avvio ad una nuovaprassi; si discuteva se fosse legittima la restrizione all’importazione inGermania di questo liquore, restrizione dettata dalla legislazione tedescache vieta la commercializzazione di liquori di frutta a bassa gradazionealcolica, la Corte ha precisato che le disparità tra le singole legislazioninazionali causano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ma questiostacoli vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi comenecessarie per rispondere a esigenze imperative attinenti in particolareall’efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica,alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori. Essa haaccolto la richiesta dell’importatore francese, escludendo che la leggetedesca fosse rivolta a tutelare questo specifico interesse.
29
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
La Comunità ha approvato diversi provvedimenti concernenti i prezzi; tra glialtri la direttiva n.88/314/CEE, approvata su D.Lgs 78/1992 dispone che iprezzi dei prodotti non alimentari siano precisati in modo chiaro, anche suriferimento a peso, misura, quantità, per la migliore informazione delconsumatore.
La correttezza commerciale e i nuovi progetti diintervento a favore dei consumatori
Nel Libro verde sulla tutela del consumatore, la Commissione europea, chiedese sia utile predisporre un testo unitario preceduto da alcune regolegenerali sulla correttezza nell’attività commerciale (fair trading).
Il problema volto a determinare le modalità di prevenzione deicomportamenti scorretti nei confronti dei consumatori, che ha portato laComunità ad intervenire per tutelare i consumatori, avrebbe facile soluzionese ogni paese fosse dotato di regole di fair trading.
In ambito europeo ben 13 Stati prevedono nel loro ordinamento una clausolagenerale di correttezza, ciò avviene sulla base di diversi modelli quellodelle pratiche commerciali corrette, all’illiceità o alla colpa; laterminologia è varia ma ogni formula appare legata ad una clausola generale.
Il contrasto più grande non sta nelle formule, ma nella contrapposizione traordinamenti dell’Europa continentale e ordinamenti dell’Europa insulare,cioè di common law.
Le regole generali sulle quali si fonda il mercato integrato comunitariodevono coordinare cioè rendere compatibili 3 principi: la concorrenza, lacorrettezza nell’attività commerciale, la protezione del consumatore.
Prima dell’Atto unico solo la concorrenza insieme con le 4 libertà (dicircolazione delle persone, dei capitali, dei beni e dei servizi),costituiva l’ossatura del diritto comunitario, gli interessi dei consumatorierano protetti solo in via mediata, dopo l’Atto unico e soprattutto dopo ilTrattato di Amsterdam la protezione dei diritti e degli interessi deiconsumatori è divenuta una degli obiettivi primari dell’Unione.
In ogni ordinamento i 3 principi sono variamente combinati, nel nostro Paesesono tra loro separati ed hanno peso diverso, il più forte è quello chegarantisce la libertà di concorrenza, la sua nuova veste giuridicaconsolidata con la legge antitrust del 1990, ha fatto sì che potesse essereconsiderato come inclusivo il principio di tutela del consumatore.
Questa linea evolutiva, che costituisce al tempo stesso una possibilesoluzione alla frammentazione dell’ordinamento comunitario e alcoordinamento dei 3 principi, vi sono diversi livelli di armonizzazione aseconda delle materie delle singole direttive, a seconda dell’epoca e della
30
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
congiuntura in cui la direttiva è approvata, a seconda degli obiettivi chele direttive intendono raggiungere.
Le pratiche commerciali scorrette
Trattasi di una delle forme più aggressive di vendita, perché il contattocon il consumatore non è effettuato da un dipendente del distributore ma daun soggetto che agisce per conto del distributore e può presentarsi sottole spoglie di un vicino, di un amico, di un conoscente; è difficile persinodistinguere in questo caso tra proposta di vendita e semplice consiglioall’acquisto. Vi sono poi le ipotesi di pubblicità occulta, e altreinformazioni che sono oggetto della disciplina di tutela dei dati personali(L. 675/1996 e successive modifiche).
Le vendite piramidali
L. 173/2005 ha colmato la prima lacuna, la legge prevede una definizionedelle vendite dirette a domicilio, intese come le vendite al dettaglioeffettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domiciliodel consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova.L’attività è assoggetta alla disciplina della vendita al dettaglio, di cuialla riforma della disciplina del commercio prevista dal D.Lgs 114/1998, inparticolare si prevede che chi svolge attività di promozione della venditasi identifichi, in modo da non sorprendere o ingannare il consumatore sullesue effettive intenzioni commerciali; l’incaricato deve esibire il relativotesserino. Il termine "piramidale" deriva dalla struttura formale in cuiviene organizzata la vendita: la persona in cima alla piramide è la prima avendere un bene o un servizio a un numero limitato di persone, le quali siincaricano di introdurre altre persone nella "piramide" a un livellosuccessivo, con l'obiettivo di formare una nuova piramide sotto di sé e diottenere i guadagni corrispondenti ai volumi di vendite prodotti dallapropria struttura.
La legge in esame disciplina anche il rapporto tra incaricato eimprenditore che esercita l’attività di vendita diretta, e fa divieto aquest’ultima di imporre all’incaricato l’obbligo dell’acquisto di minimiquantitativi di merci o servizi offerti. Si fa l’obbligo all’incaricato diapplicare le disposizioni contrattuali stabilite dall’impresa, salva la suaresponsabilità. Si prevede il suo compenso mediante provvigione.
La legge vieta la promozione e realizzazione di attività e strutture divendita fondate sul reclutamento di altri rivenditori: il divieto non ègenerale, perché è subordinato al fatto che il reclutamento sia l’incentivoprimario dei componenti della struttura di vendita; vieta altresì le c.d.catene di Sant’Antonio e i giochi ad esse collegati (che configurano lapossibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre
31
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinto previo ilpagamento di un corrispettivo). Per accertare la sussistenza di un rapportopiramidale la legge prevede alcuni indici presuntivi inerenti il contenutodegli accordi tra impresa e incaricato della vendita.
La direttiva sulle pratiche commerciali sleali(Direttiva 2005/29/CE)
Per pratiche commerciali sleali, si intendono le pratiche ingannevoli eaggressive, come ad esempio la vendita forzata. L'Unione europea (UE)garantisce lo stesso grado di protezione a tutti i consumatoriindipendentemente dal luogo di acquisto o di vendita nell'UE. Essa proteggequindi anche i consumatori più vulnerabili, come i bambini, nei confrontidella pubblicità che li esorta direttamente ad acquistare.
Campo d'applicazione:La direttiva quadro si applica a tutte le transazionidelle imprese con il consumatore nei casi in cui questo viene influenzato dauna pratica commerciale sleale avente un'incidenza sulle sue decisioni, comequella di acquistare o meno un prodotto, sulla libera scelta in caso diacquisto e sulle decisioni riguardanti l'esercizio o meno di un dirittocontrattuale. Essa non si applica alle transazioni fra imprese. Essa nonaffronta neppure le questioni relative al buon gusto o all'educazione, allasalute e alla sicurezza ovvero alla normativa che regola i contratti. Ladirettiva armonizza interamente la normativa vigente in questo settoreistituendo un divieto di ordine generale. Gli Stati membri non avranno lapossibilità di utilizzare le clausole minime previste da altre direttive perimporre prescrizioni supplementari nel settore coordinato dalla presentedirettiva.
Inoltre, questa direttiva completa le disposizioni relative alle transazionifra impresa e consumatore di cui alla direttiva sulla pubblicitàingannevole.
Il consumatore di riferimento è il consumatore medio, così come definitodalla Corte di giustizia. Questo criterio è modulato allorquando una praticacommerciale riguarda in maniera specifica un gruppo particolare (ad esempio,i bambini); in questo caso il membro medio di tale gruppo diviene il puntodi riferimento.
Essa modifica la direttiva 84/450/CEE riguardante la pubblicitàingannevole (abrogata dalla direttiva 2006/114/CE), ladirettiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia dicontratti a distanza, la direttiva 98/27/CE riguardante le azioni inibitoriee la direttiva 2002/65/CE riguardante la commercializzazione a distanza deiservizi finanziari.
Criteri generali: La direttiva definisce i criteri generali per determinarese una pratica commerciale sia sleale al fine di stabilire un ventagliolimitato di pratiche disoneste vietate in tutta l'UE. Tali criteri
32
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
considerano se la pratica sia contraria alle esigenze della diligenzaprofessionale e se alteri o possa alterare sostanzialmente il comportamentodel consumatore medio. Inoltre, essa stabilisce la differenza fra lepratiche ingannevoli e le pratiche aggressive precisando i criteri perindividuarle.
Pratiche ingannevoli: Una pratica commerciale può ingannare sia tramiteun'azione, sia tramite un'omissione. Una pratica è ingannevole per omissionese non fornisce le informazioni minime o le informazioni di cui ilconsumatore medio ha bisogno prima di acquistare. La direttiva stabiliscequindi un elenco di informazioni essenziali di cui il consumatore ha bisognoprima dell'acquisto; ad esempio, le caratteristiche principali del prodotto,il prezzo (tasse comprese), le spese di consegna (ove necessario) e ildiritto di recesso. Una pratica commerciale è ingannevole per azione secontiene informazioni false ovvero se induce o può indurre in errore ilconsumatore medio, anche se le informazioni presentate sono oggettivamentecorrette.
Pratiche aggressive: D'altra parte, la direttiva definisce i criteri perstabilire se una pratica commerciale sia o meno aggressiva: se cioè questautilizza molestie, costrizioni o influenza ingiustificata.
«Lista nera» di pratiche vietate: Essa stabilisce, nell'allegato I, l'elencocompleto dei comportamenti commerciali sleali vietati in tutta l'UE in ognicircostanza; una specie di « lista nera » delle pratiche commerciali sleali.Ad esempio, i sistemi piramidali di vendita, la fornitura non richiestaovvero l'utilizzazione della pubblicità-esca (quando il prodottopubblicizzato ad un buon prezzo non è disponibile) ovvero l'utilizzazione difinte interviste pubbliche. Questa lista può essere modificata solo tramiterevisione della direttiva.
Gruppi «sensibili» di consumatori:Gruppi di consumatori considerati «sensibili » sono protetti in maniera particolare. Ad esempio, i bambini sonoprotetti contro la pubblicità che li esorta direttamente ad acquistare. Ilcriterio di consumatore medio è modulato quando una pratica commercialeriguarda in materia specifica un gruppo particolare (ad esempio, i bambini),in questo caso il membro medio di tale gruppo diviene il punto diriferimento.
Contesto:La presente direttiva quadro fa seguito al libro verde del 2001sulla protezione dei consumatori ed al Libro verde (Libri verdi sono documenti diriflessione su un tema politico specifico pubblicati dalla Commissione. Sono prima di tutto documentidestinati a tutti coloro - sia organismi che privati - che partecipano al processo di consultazione e didibattito) pubblicato nel 2002. Oltre alle garanzie che essa fornisce alconsumatore, la direttiva permette uno sviluppo migliore del commerciotransfrontaliero nel mercato interno.
Capitolo quarto
33
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Informazione del consumatore e pubblicità commerciale
Forme e ruolo della pubblicità
Fra tutti i fenomeni del mondo dei consumi, quello della pubblicità èl’emblema delle società moderne.
Origini: In Italia negli anni ‘60 si registra l'emergere di questo fenomenoin modo sempre più decisivo, ma le origini della pubblicità commerciale sidevono collocare alla metà dell'ottocento, in quel periodo la pubblicitàintensa ad informare il consumatore era circoscritta alla fase dell'acquistoe coinvolgeva esclusivamente il dettagliante e l'acquirente del prodotto.Essa era legata al ruolo determinante svolto dal rivenditore nel processo diproduzione e distribuzione della merce, si creava una sorta di vincolopersonale di fiducia tra acquirente e venditore.
Oggi: la pubblicità si è trasformata da strumento di informazione del pubblicoin strumento di persuasione. La funzione attuale della pubblicità è quella nondi informare, ma di orientare i consumi, stimolare bisogni, promuoverel'assorbimento della domanda. La pubblicità è l'anima del commercio ma èanche l'arma principale della lotta concorrenziale:
a) la pubblicità è oggi un fenomeno di distorsione dell'apparato produttivo,perché mezzo di persuasione ma non di informazione;b) la pubblicità è strumento di lotta concorrenziale privo di qualunqueriferimento ai contenuti e agli oggetti;c) la pubblicità, in quanto strumento di orientamento dei consumi, è ilsettore cui sono indirizzate prevalentemente le ricerche di mercato leazioni delle imprese.
Essa è un fenomeno ineliminabile dalla società moderna, infatti il problemanon è quello della sua eliminazione ma quello del suo contenimento (quando essarisulta assorbire capitali troppo ingenti, dal cui investimento in attivitàproduttive si potrebbero ricavare vantaggi superiori per l'interacollettività) e del suo controllo al fine di evitare che i messaggipubblicitari siano strumento di distorsione delle scelte dei consumatori.
L'esperienza italiana poggiava originariamente su 2 pilastri:
1- disciplina del codice civile, circoscritta alla repressione dellaconcorrenza sleale;
2- autodisciplina affidata al Giurì.
Successivamente per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia, siè introdotta una regolamentazione con leggi speciali e si è affidato ilcompito del controllo dei messaggi all'Autorità di vigilanza dellaconcorrenza e del mercato.
Autodisciplina
34
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Alla fine dell'ottocento si collocano iniziative di autodisciplinapubblicitaria: 1890 il primo "codice", proprio dell'esperienza inglese,mentre in Italia il primo "codice" etico degli utenti della pubblicità èelaborato dall'UPA (utenti pubblicità associati) nel 1951, cui fa seguitouna raccolta di direttive della Fip (federazione italiana di pubblicità) cheaccoglie le richieste delle categorie professionali. Nel 1966 si compila ilCodice di lealtà pubblicitaria; da ultimo viene emanato il Codice di autodisciplinapubblicitaria (1975).
I caratteri della pubblicità: deve essere onesta, veritiera, corretta e nonlesiva dell'onore delle agenzie delle imprese che la praticano, il "codice"stabilisce il divieto di pubblicità ingannevole (la pubblicità deve evitareogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore iconsumatori).
Altre disposizioni riguardano la paternità del messaggio e la veridicità deisuoi contenuti; disposizioni particolari sono previste per il controllo deimessaggi che sfruttino la superstizione, la credulità, la paura
dei destinatari, si facciano vincolo di violenza, volgarità, indecenza,offendano le convinzioni morali o religiose, o risultino dannose per bambinie adolescenti.Per prevenire danni ai consumatori dei prodotti, di stabilisce che quando sitratta di prodotti suscettibili di presentare pericoli la pubblicità deveindicarli con chiarezza.
In ordine alla concorrenza sleale: la pubblicità non deve essere imitativa, non deve creareconfusione o sfruttamento del marchio, del nome, della notorietà altrui, non deve essere denigratoria ocomparativa.
Profili organizzatori- accanto al Giurì operano il comitato di accertamentoe la segreteria:
- Giurì = composto da un minimo di 9 membri nominati dalla confederazionegenerale italiana della pubblicità, tale organo esamina la pubblicità cheviene sottoposta e pronuncia su di essa seguendo il codice diautodisciplina;- Comitato di accertamento = composto di 7 membri scelti con i medesimicriteri, sottopone al giurì la pubblicità difforme dalle disposizioni delcodice, esprime pareri consultivi.
Procedimento: ha inizio per effetto di chiunque si senta leso da messaggipubblicitari difformi dalle disposizioni del “codice”, o per iniziativa delComitato; il Giurì nomina un relatore, che invita le parti a presentar entroun certo termine le rispettive deduzioni; si avvia la discussione e vieneemessa la “decisione”.
Qualora si accerti l’infrazione il Giurì invita le parti interessate chehanno aderito al “codice” a desistere dalla pubblicità riprovata; lasanzione può consistere anche nella pubblicazione della decisione sugli
35
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
organi di informazione, qualora la parte che ha violato il codice non siattenga alle decisioni del Giurì.
Le disposizioni del codice sono giuridicamente vincolanti?
È chiaro che il vincolo deriva dall’adesione al “codice” ha natura moltoparticolare perché non può considerarsi un vincolo giuridico. Sullagiuridicità del vincolo si è espresso il Tribunale di Milano, cherichiamando la th degli ordinamenti giuridici privati, ha ritenuto di poterdi riconoscere del codice di autodisciplina , un corpo di regole destinate avincolare tutti gli aderenti e tutti coloro che pur non avendo aderitodirettamente alla associazione abbiamo accettato le clausole inserite neicontratti pubblicitari in base alle quali si fa obbligo agli utenti dirispettare le norme del codice di autodisciplina.
Pubblicità televisiva
Prima direttiva comunitaria sulla pubblicità risale al 1984, il legislatoreha ritardato ad attuarla, infatti nel nostro ordinamento è entrata prima invigore una disciplina di controllo della pubblicità televisiva.
L'art. 8 L. 223/1990 dispone che la pubblicità radiofonica e televisiva nondeve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazionidi razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose eideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, lasicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizi morale o fisico aminorenni e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.
La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come taleed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici dievidente percezione.
La normativa contenuta nell'art.8 è circoscritta a messaggi pubblicitari chevengono diffusi attraverso radio e televisione; negli altri settori comequello editoriale, della stampa, della telematica e quello delle tecnichedel contatto video-televisivo o porta a porta, si attendono norme dicarattere generale.
Con la riforma del settore e l'istituzione dell'Autorità garante delletelecomunicazioni avvenuta con L.249/1997, si sono ampliate le competenzeche riguardano anche la tutela degli utenti e si è conservato l'organismorappresentativo delle loro associazioni.
Direttiva comunitaria sulla pubblicità ingannevole e la sua attuazione
Direttiva 1984/450/CEE, attuata con il D.lgs 74/1992, la pubblicitàingannevole è quel tipo di pubblicità che trae in inganno il pubblico o che
36
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
crea confusione tra i prodotti e danneggia i concorrenti. È ragionevoleritenere ingannevole anche la pubblicità che non informa ma suggestiona(c.d. Pubblicità suggestiva).
Contenuti:
1. Trasparenza della pubblicità;2. L'identificazione della pubblicità;3. Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza deiconsumatori;4. Sicurezza;5. Bambini e adolescenti.
Le disposizioni del d.p.r. 224/1988, sulla responsabilità del produttore: ilproduttore che usa messaggi ingannevoli può essere considerato responsabile,anche se il prodotto di per sé non presentava difetti, ma richiedeva daparte dell'utente l'impiego di regole di prudenza e vigilanza che l'utentenon abbia osservato perché a ciò indotto dal modo di presentare il prodotto.
Con l'emanazione del codice del consumo, queste disposizioni sono stateinserite nel contesto più ampio dei rapporti di consumo.
Il controllo della pubblicità è divenuto uno dei settori di maggior lavorodell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Gli interventi diquesta hanno riguardato:
1. Il settore finanziario;2. Le telecomunicazioni;3. I prodotti alimentari;4. I prodotti parafarmaceutici e i cosmetici,5. I servizi di distribuzione commerciale;6. Le vendite a distanza;7. Il settore turistico;8. La pubblicità occulta.
L'Autorità garante non è vincolata dalla prassi consolidatasi nel controlloprivatistico dei messaggi pubblicitari operati dal giurì di autodisciplina.L'orientamento del giudice amministrativo competente ha tracciato i confinitra i due organi, pubblico e privato, ed è nel senso della prevalenza delcontrollo pubblico: il giurì di autodisciplina pubblicitaria ha unfondamento convenzionale e i suoi pronunciamenti vincolano soli soggetti cheabbiano accettato e sottoscritto il relativo codice, mentre l'autoritàgarante della del mercato ha affondamento pubblicistico a tutela diinteressi collettivi di particolare spessore sociale: ne consegue che i dueorgani operano su piani diversi e le relative decisioni in materiapubblicitaria possono essere discordanti.
Il principio che assiste l'autorità nel controllo del messaggio è dato dallasua idoneità a consentire al consumatore di operare scelte consapevoli; leinformazione devono essere chiare ed esaurienti.
37
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
In ordine alla pubblicità occulta, l'autorità ha ritenuto chel'ingannevolezza del messaggio prescinde dalla veridicità delleaffermazioni, in quanto la pubblicità deve essere riconoscibile di per sé;particolare attenzione è posta ai messaggi destinati ai minori, specie seidonei a minacciarne la sicurezza fisica o psichica l'interesse che si favalere dinanzi all'autorità garante, non è quello proprio del ricorrente, mapiuttosto un interesse pubblico, infatti si agisce per la promozione non diun interesse proprio ma collettivo (creando indirettamente un vantaggio afavore del singolo consumatore, dell'associazione dei consumatori e delprofessionista che ne trae vantaggio attraverso la censura del messaggio,elimina un mezzo pericoloso di concorrenza sleale da parte di altrioperatori).
Nozione di pubblicità ingannevole
L'Autorità antitrust ha precisato che agli effetti dell'applicazione deld.lgs 74/1992, la violazione del principio di correttezza non rivesteautonoma rilevanza nella valutazione della liceità del messaggio,l'eventuale scorrettezza potendo rilevare solo in quanto contribuisca arendere la comunicazione ingannevole.
La violazione della correttezza, secondo l'autorità, non implica violazionedella disciplina della pubblicità ingannevole se non realizza l'effetto chequella disciplina vuole prevenire, cioè la lesione degli interessi deiconsumatori.
Nell'accertamento dei profili di ingannevolezza del messaggio pubblicitario,non rilevano gli eventuali comportamenti abusivi o lesivi della concorrenza,in quanto il messaggio pubblicitario va valutato da un punto di vistaoggettivo.
Esempi:
1. Costituisce pubblicità ingannevole l'uso pubblicitario di unadenominazione simile a quella di altra impresa operante da molto più tempo;2. Costituiscono pubblicità ingannevole i medesimi messaggi pubblicitari chereclamizzano corsi a pagamento, utilizzando le apparenze di un'offerta dilavoro;3. Costituisce pubblicità ingannevole il messaggio pubblicitario diffuso amezzo posta consistente nella comunicazione dell'assegnazione gratuita aldestinatario e alla sua famiglia di una vacanza-soggiorno e tale danascondere un'offerta nella quale rimangono in realtà a carico deipartecipanti le spese del viaggio e i pasti.
Occorre tener conto degli effetti del messaggio, di qui il rilievo datoall'età del pubblico dei destinatari. Se si tratta di minori, il vagliocritico del messaggio si attenua da parte del destinatario e quindi piùsevero deve essere il controllo.
Pubblicità comparativa
38
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità compartiva, è stata emendata con ladirettiva 97/55/CE ed approvata dal Parlamento e dal Consiglio nel 1997.
Definizione:
viene intesa come pubblicità comparativa, qualsiasi pubblicità che individuiin modo esplicito o implicito un concorrente o i beni o i servizi diidentica natura offerti da un concorrente.
Modo esplicito: si ha quando si cita la denominazione del prodotto, dellamarca, della casa produttrice ecc;
Modo implicito: quando il prodotto è rappresentato attraverso segni allusiviche lo richiamano alla mente del consumatore (esempio: la formainconfondibile della bottiglietta di coca cola).
La pubblicità comparativa non è libera, i criteri di controllo del messaggiocomparativo sono:
1. Il confronto dei prodotti e dei servizi deve essere obiettivo;2. Il confronto deve avvenire su caratteristiche essenziali, pertinenti,verificabili e scelte lealmente;3. I beni e i servizi confrontati devono essere concorrenziali, appartenerecioè allo stesso mercato, allo stesso genere;4. La pubblicità non deve essere ingannevole;5. La pubblicità non deve generare confusione sul mercato tra l'utente dellapubblicità e un concorrente, ovvero tra marchi, denominazioni commerciali,occorrerà che nella relazione tecnica del messaggio sia accuratamenteeffettuata la distinzione tra prodotti e servizi comparati;6. La pubblicità comparativa non deve essere sleale, non deve cioè causarediscredito, denigrazione o disprezzo di un concorrente;7. La pubblicità comparativa non può essere utilizzata per trarre vantaggiodalla notorietà di marchi di denominazioni commerciali di un concorrente.
Per reprimere la pubblicità comparativa non conforme alle prescrizioni siprevedono i medesimi mezzi già introdotti dalla direttiva sulla pubblicitàingannevole (azione giudiziaria, controllo di autorità amministrative,azioni inibitorie, pubblicazione delle sanzioni e dichiarazionirettificative).
Il trattamento della pubblicità comparativa emergente dalla disciplinadiverge da quello considerato nel codice di autodisciplina:
Il codice - reprime la pubblicità comparativa che è rivolta al conseguimentodi un ingiustificato profitto, reprime la comparazione diretta in quantodenigratoria,ammette la comparazione indiretta, ma solo se rivolta aillustrare, le caratteristiche e i vantaggi reali dell'attività e delprodotto utilizzato.
L'autorità ha pubblicato una piccola guida per la cura del consumatore, incui vengono illustrati i profili tecnici, economici e giuridici della
39
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
pubblicità, spiega come agisce l'autorità, come se non del procedimento dicontrollo e come si possono segnalare casi di violazione della disciplina.
Capitoloquinto
Il credito al consumoe il sovra indebitamento
Il credito al consumo
Con credito al consumo si intendono tutte quelle attività di finanziamentodelle persone fisiche e delle famiglie che hanno lo scopo di sostenerei consumi o di rimandare o rateizzare i pagamenti. Il credito al consumo sicaratterizza per il fatto che non serve per sostenere investimenti, ma soloper finanziare la spesa corrente delle famiglie.Dal punto di vista del consumatore: consente l’acquisizione immediata delbene o del servizio;Dal punto di vista del venditore: il credito al consumo è strumento diassorbimento della merce, mediante agevolazione nel rimborso del prezzo checomportano un aumento del prezzo secondo percentuali stabilite;Dal punti di vista del finanziatore: è un’operazione che consente diconseguire un profitto attraverso operazioni di prestito, che nelle formedel credito al consumo sono strettamente collegate all’acquisto di beni oservizi presso rivenditori e imprese autorizzate dall’istituto. In Italia, gli unici soggetti autorizzati a concedere il credito al consumosono le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositiregistri.Gli strumenti finanziari che sono utilizzati per accedere al credito alconsumo sono:
Carte di credito Pagamenti posticipati o rateizzati Prestiti personali Cessione del quinto dello stipendio Consolidamento del debito
Non rientrano invece nel credito al consumo i mutui ipotecari per l'acquistodi immobili in quanto si tratta di un investimento e il debito risultacoperto dal valore dell'immobile stesso.Gli strumenti per accedere al credito al consumo possono essere suddivisiin finanziamenti finalizzati, quali la rateizzazione dell'acquisto diun'automobile o il pagamento degli acquisti tramite carta di credito. Sonoinvece finanziamenti non finalizzati i prestiti personali e ilconsolidamento del debito delle famiglie.
40
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Garanzie e tassi di interesse
Le garanzie che vengono chieste al consumatore per accedere al credito alconsumo sono abbastanza limitate, tipicamente è sufficiente che ilrichiedente abbia un reddito, meglio se da lavoro a tempoindeterminato o nella pubblica amministrazione, un conto corrente e nonsia iscritto nella lista dei cattivi pagatori.
Il tasso di interesse applicato a queste tipologie di prestiti è molto piùelevato rispetto a quello applicato ai mutui. Questo perché il rischiodi insolvenza del debito è più elevato e non ci sono garanzie a frontedel prestito se non il reddito del contraente. Inoltre il fatto che gliimporti non sono elevati e la decisione di contrarre un debito diquesto tipo non viene ponderata dai consumatori, permettono alleistituzioni che concedono il credito di farsi pagare uno spread piùelevato. Quando invece il prestito ha il solo scopo di incentivarel'acquisto invogliando il consumatore ad affrontare una spesa chealtrimenti non sarebbe in grado di sostenere, è possibile che vengaapplicato un tasso molto ridotto (prestiti a tasso zero). In questicasi è possibile pensare il prestito come ad una forma di sconto, èinfatti il venditore che si accolla l'onere del finanziamento versol'istituto che concede il credito.
Disciplina comunitaria
Obiettivi della direttiva 87/102/CEE:
1. Si da attenzione alla formazione del tasso annuo delle spese cioè delcosto totale del credito espresso in percentuale annua. Esso comprende ilcosto del contratto di ogni operazione necessaria per escutere il credito,di ogni altro rapporto di garanzia connesso, degli altri obblighi derivantidalla legge;2. Tra le informazioni da assicurare al consumatore deve essere inclusoanche il tasso annuo globale effettivo (T.A.E.G.);3. In caso di offerta non sollecitata dal consumatore, ad es. vendite portaa porta, sia riconosciuta al consumatore la possibilità di recedere dalcontratto entro un termine prefissato (almeno 7 giorni);4. L'operazione deve essere fatta per iscritto e deve contenere una serie diinformazioni.
Esigenze prese in considerazione della comunità sono 2:
I. informazione del consumatore;II. Il consumatore possa eccepire al finanziatore l'esistenza di viziconcernenti l'acquisto.
Infine si prevedono misure nel caso in cui l'operazione creditizia sia stataportata a termine e il fornitore di rientri in possesso del bene alienato;in questo caso il trasferimento della proprietà non è consentito se non invia giudiziale quando è stato versato almeno un terzo del prezzo. Nel casodi rimborso anticipato, il consumatore ha diritto ad una riduzione dei costicomplessivi.
41
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Attuazione delle direttive:
la prima direttiva comunitaria sul credito al consumo ricevuto attuazionenella legge comunitaria n. 142/1992 e successivamente la disciplina diquesta è stata inserita nel t.u. Bancario; il legislatore italiano si èlimitato a riprodurre il testo comunitario senza ampliare la tutela delconsumatore.
Contenuti:
Art.121 del t.u. Contiene due definizioni:
Quella di consumatore -inteso come "la persona fisica che agisce per scopiestranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmentesvolta".Circoscrivendo la definizione alle persone fisiche, non si sonoricompresi nell'ambito di tutela specifica: le associazioni, gli istituti diassistenza e beneficenza, in quanto queste non possono qualificarsi comepersone fisiche.
Quella di credito al consumo -inteso come "la concessione, nell'esercizio diun'attività commerciale o professionale, di credito sottoforma di dilazionedi pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziariaa favore del consumatore. Il credito deve essere contratto a fini nonprofessionali o imprenditoriali, restano escluse le operazioni delconsumatore concluda per uso misto.
Ambito di applicazione
Nell'ambito del credito al consumo sono esclusi:
-contratti concernenti l'acquisto o la conservazione di un diritto diproprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare,l'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;- contratti di locazione (vi rientrano invece per contro i contratti dileasing, perché l'esclusione contempla i contratti che non prevedano inalcun momento il trasferimento della proprietà della cosa locata);- la direttiva esclude anche i contratti di apertura di conto corrente,diversi dai conti coperti da una carta di credito.
Il t.u. dispone un regime speciale disciplina per l'apertura di un contocorrente non connesso con l'uso della carta di credito, prevede che ilcontratto indichi, a pena di nullità, il massimale e l'eventuale scadenzadel credito, il tasso d'interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneriapplicabili dal momento di conclusione del contratto, le condizionidell'esercizio del ius variandi, le modalità di recesso dal contratto.
Quanto agli importi, la direttiva prevede l'esclusione dei contratti conimporti inferiori a 200 ECU (unità di conto europea) e superiori a 20.000ECU.
42
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Modalità di finanziamento: è la direttiva che il t.u. Escludono i crediticoncessi senza remunerazione di interessi o di altri oneri; la direttivaprecisa che la disciplina non si applica ai crediti in cui non si impone lacorresponsione di alcun interesse, a condizioni che il consumatore accettidi rimborsare il credito con un pagamento unico; il t.u. Amplia l'eccezione,portando a 18 mesi il termine del rimborso.
La direttiva prevede altresì, la possibile esenzione dei contratti dicredito che siano stipulati in forma di atto pubblico e i contratti in cuisi preveda la corresponsione di interessi a un tasso oggettivo globaleinferiore a quelli prevalenti sul mercato oppure che non siano offerti alpubblico in genere; di tale esclusione non si è avvalso il legislatoreitaliano.
Spese e il tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Disciplina del TAEG è assai articolata. La prima direttiva indicava alcunicriteri di determinazione, rinviando alla disciplina dei singoli statimembri; introduceva per alcuni principi:
a) la comunicazione al consumatore dell'ammontare del TAEG, espresso inpercentuale, alla della conclusione del contratto, in quanto questo è unodegli elementi essenziali del contratto scritto;
b) in caso di impossibilità di calcolo all'atto della conclusione delcontratto, la comunicazione delle informazioni utili al consumatore inordine alla sua determinazione;
c) ovvero in mancanza di tale possibilità, la precisazione del costo totaledel credito;
d) libertà da parte del finanziatore di modificare il taeg sulla base dellecondizioni previste in contrasto;
e) la tempestiva informazione del consumatore di ogni modificazioneeffettuata a mezzo di estratto conto o di altri mezzi ritenuti accettabiliper gli stati membri;
f) e ciò anche in caso di accettazione tacita degli scoperti.
La seconda direttiva ispirata al principio secondo il quale il TAEG e ilcosto totale del credito devono essere calcolati in modo uniforme in tuttigli Stati membri:
I- il costo totale del credito comprende tutti i costi del creditocompresi gli interessi e le altre spese che il consumatore devepagare per il credito;
II- il TAEG e le spese devono essere calcolate secondo formule allegatealla direttiva;
III- Le formule diverse applicate nei diversi Stati possono essereutilizzati fino al 1995.
43
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Il T.u. Ha disposto che il TAEG sia calcolato secondo le formule stabilitedal CICR, e che in essa sia ricompreso il costo dell'interposizione, se ilfinanziamento è avvenuto con interposizione di un terzo.
Pubblicità
fatte salve le disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e di quellesleale, la prima direttiva ha stabilito che i messaggi pubblicitari relativiai finanziamenti, qualora indichino il tasso di interesse o altre cifreriguardanti il costo del credito, contengano anche il TAEG, eventualmentecon esempi tipici.
Oggetto, forma, modalità di conclusione del contratto
La prima direttiva ha precisato che:
a) i contratti di credito devono essere conclusi per iscritto ed unesemplare deve essere lasciato al consumatore;b) e si debbono contenere: l'indicazione del TAEG, le condizioni a cuiquesto può essere modificato, gli altri elementi essenziali del contratto -il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto dicredito, l'importo del racconto e delle rate, le garanzie richieste.
Il t.u. Ha ripreso queste indicazioni precisando che devono essere contenutenei contratti a pena di nullità. In caso di difetto di nullità di questeclausole che a sostituzione automatica con: a) il TAEG equivale al tassonominale minimo dei BOT annuali o di titoli similari; b) la scadenza delcredito è a 30 mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa èriconosciuta a favore del finanziatore. In tema di nullità le disposizionisono derogabili solo se in senso più favorevole al cliente. In conformitàalla prima direttiva il t.u. Ha consentito l'adempimento in via anticipatadegli obblighi derivanti dal contratto, non ha previsto alcunché in ordinealla possibilità da parte del consumatore di pagare con titoli cambiari,compresi i vaglia.
Quanto alla cessione del credito, la prima direttiva stabilisce che ilconsumatore ha la facoltà di far valere nei confronti del terzo le eccezionie i mezzi di difesa che poteva valere nei confronti del creditoreoriginario, compreso il diritto alla compensazione.
Il t.u. si uniforma alla direttiva, non precisa se la cessione avvenga conle medesime garanzie di tutela anche in caso di cessione del contratto e nonprecisa neppure se sia ammissibile la pattuizione, prevedibile al momentodella conclusione del contratto, dell'anticipato consenso del debitoreceduto alla cessione del contratto.
Inadempimento del fornitore
44
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
L'inadempimento del fornitore e la persistente obbligazione del consumatorea effettuare i versamenti a favore del finanziatore costituiscono da sempreil tema cruciale del credito al consumo.
Per prima direttiva distingue due ipotesi:
1. Gli interessi del consumatore siano pregiudicati dall'inadempimento delfornitore, per omessa fornitura, o per difetto di conformità dei beni o deiservizi alle pattuizioni contrattuali;2. Vi sia un accordo pregresso tra finanziatore e fornitore in base al qualeil credito sia messo a disposizione esclusivamente dei clienti delfornitore, ove il consumatore abbia agito nei confronti del fornitoreinadempiente senza soddisfazione, la direttiva prevede che egli abbiadiritto di procedere contro il fornitore.
Il t.u. prevede solo la II ipotesi aggiungendo che la responsabilitàprevista si estende al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto idiritti derivanti dal contratto di cessione del credito; il che significache:
a) in caso di cessione del credito dal fornitore al terzo, i diritti delconsumatore nei confronti del fornitore e quindi del finanziatore rimangonosalvi, ma sono tali solo ove vi sia il previo accordo di credito esclusivodel finanziatore nei confronti dei clienti del fornitore;
b) in assenza di tale patto di esclusiva, non si precisa se il consumatoreabbia salvi i propri diritti nei confronti del fornitore; tale eventualitàove non prevista per legge, non è data al consumatore, in quanto si escludeda parte della dottrina maggioritaria sia la natura trilaterale del rapportotra finanziatore, fornitore e consumatore, sia che il consumatore abbiaazione diretta nei confronti del fornitore, non è egli avendo posto inessere alcun contatto direttamente con il fornitore.
Non si vede quindi come possano essere tutelati i diritti del consumatorenei confronti del fornitore, dal momento che il consumatore è obbligato amantenere il rapporto istituito col finanziatore e non ha la facoltà disospendere versamenti o i ratei, né di proporre eccezione al finanziatorederivanti da vizi non conformità o altri inadempimenti del fornitore.
La giurisprudenza in materia è pressoché inesistente.
Si segnala:
- una pronuncia della corte di appello di Cagliari che ha ritenuto nonretroattiva la disciplina della L. 142/1992, ai rapporti in corso; perciò ilfinanziatore non assume alcun obbligo in relazione all'inadempimento delfornitore.
- il pretore di Bologna nel 1998 ha stabilito che in caso di inadempimentodi un contratto di credito al consumo, una società finanziaria non puòpretendere il pagamento degli interessi moratori sugli interessi
45
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
corrispettivi non versati, se non dal giorno della domanda giudiziale esempre che questi ultimi siano dovuti da oltre sei mesi.
La corte di giustizia ha precisato che contratto di finanziamento econtratto di fornitura del bene del servizio deve essere previstospecificamente dalla disciplina di attuazione introdotta dallo stato membro.
Il codice del consumo prende in considerazione il credito al consumo soloper gli aspetti di raccordo tra la compilazione e il t.u. Bancario. Richiamai poteri del CICR in ordine alla definizione dei criteri di calcolo del TAEGe inserisce la disposizione sul inadempimento del fornitore.
Tra le novità è il processo di modificazione che ha investito la direttivasul credito al consumo, nel 2005 la commissione europea ha adottato unaproposta modificata di direttiva che eleva il livello di diritti dei dirittidei consumatori; tra le innovazioni si segnalano:
- separazione della disciplina del credito ipotecario dal creditoal consumo;
- il diritto di recesso da esercitare entro 14 giorni;
- il diritto di risolvere il rapporto che il contratto a cui esso èriferito è stato risolto.
Sovrindebitamento del consumatore
Il fenomeno del sovrindebitamento inteso nel senso dell'impossibilità di farfronte ai propri impegni debitorii per ragioni di vita familiare da parte dipersone fisiche o di famiglie-queste progetto di rilevazione di mercato,analisi economiche sociologiche e di normazione e nell'esperienza francese,nella nostra esperienza è stata esaminata solo di sfuggita.
Nell'esperienza francese è stato approvato un provvedimento volto aprevenire e a disciplinare le difficoltà collegate al sovrindebitamento deiprivati e delle famiglie. In sintesi si introduce una procedura diripianamento e ripianamento della situazione debitoria che si può articolarein due fasi:
1. " Amichevole ", cioè convenzionale e concordata all'istanza del debitore;
2. Giudiziale, con cui si possono assumere provvedimenti per protrarre lascadenza dei rimborsi, consolidare i debiti, ridurre gli interessi ecc.
Le finalità sociali dell'intervento sono evidenti, in altri terminil'intervento legislativo è consapevole:
a) delle diverse categorie di debitori (vittime, cicale, ingenui,calcolatori);b) dei diversi tipi di indebitamento (bisogni essenziali di alimentazione esopravvivenza); alle esigenze di stabilità (es. l'acquisto della casa di
46
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
abitazione) o di conforto (elettrodomestici; vetture) o ancora spese menopressanti o addirittura futili (case per vacanze, arredi ecc).
Capitolo sesto
I contratti di massa Le condizioni generali del contratto
La negoziale delle condizioni generali di contratto, dell'uso di moduli oformulari, dell'impiego di modelli contrattuali uniformi o standard è tipicadelle società a capitalismo maturo, ma non soltanto di esse.
I <<contratti di massa>> sono definiti così per sottolinearne l'ampiadiffusione, il collegamento con la distribuzione di prodotti e serviziessenziali, le uguaglianza delle condizioni praticate agli utenti, ciascunodei quali si confonde nella massa.
Il ricorso a questi strumenti negoziali è universale, la prassi negozialeattuata mediante condizioni generali consente di:
a) praticare a tutti consumatori uguali condizioni;
b) trasferire sui consumatori rischi e oneri non negoziabili;
c) accentrare i procedimenti giudiziali eventualmente sorti dallaacquisizione di beni e servizi in un unico foro, che coincide con quellodove ha sede l'impresa.
Ciò che preme sottolineare è il fatto che nella prospettiva che riguardadiritti dei consumatori si possono collocare solo le condizioni generalipraticate dall'impresa nell'amministrazione dei suoi rapporti con iconsumatori.
Il modello originario di controllo previsto dal codice civile
Il codice civile dedica alcune norme alle condizioni generali di contratto.Il modello normativo si articola in alcune disposizioni che riguardanol'efficacia delle clausole predisposte e gli oneri formali per il loroimpiego (artt. 1341, 1342 cod. civ.). Si ricordano inoltre le clausole diesonero da responsabilità e delle prassi negoziale di impresa sonofrequenti, che spesso la problematica delle clausole di esonero si confondecon quella delle condizioni generali (artt. 1228, 1229).
Art. 1341 cod. civ.:
a) comma 1, impone al consumatore un onere di conoscenza o conoscibilitàdelle condizioni generali di contratto che ne aggrava la posizione (comeavverte Gorla, il cliente non ha tempo di leggere il lungo tratto dellastampa anche da sola davanti ai suoi occhi, nello stesso tempo si favoriscechi può impedire le formulari clausole poco leggibili e di scarsacomprensione), in questo modo la sottoscrizione e le clausole vale a sancire
47
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
il potere normativo dell'impresa di cui il consumatore deve subire, suomalgrado, gli effetti;
b)comma 2, esclude l'efficacia delle clausole vessatorie, qualora esse nonsiano partitamente sottoscritte; il fatto della semplice sottoscrizione, sevale a rendere avvertito il consumatore degli impegni che sta assumendo,nello stesso tempo garantisce all'impresa la possibilità di introdurre nelcontratto clausole di ogni tipo, non negoziabili e non modificabili da partedell'aderente.Il c.2 dell'art. 1341, legittima l'uso delle clausole vessatorie, in altritermini non ne circoscrive l'impiego, ne impedisce all'impresa diutilizzarle, indica solo in modo nel quale tale clausole si devonoutilizzare: un modo che si esaurisce nell'adempimento di semplici oneriformali (la sottoscrizione).
Art. 1342: le clausole aggiunte, ancorché prevalenti su quelle a stampa nonpossono modificare toto il piano economico predisposto dall'impresa.
Art. 1370: con esso si fa riferimento alle clausole oscure e ne rendeevanescente il ruolo di tutela dell'aderente.
Il sistema normativo del codici civile legittima l'impiego delle condizionigenerali di contratto anche a danno del consumatore e quindi ledisposizioni, devono leggersi come direttive a sostegno dell'impresa cuigarantisce il più ampio campo d'azione e immunità da qualsiasi controlloesterno. Questa
valutazione viene rafforzata dall'esame della disciplina delle clausole diesonero da responsabilità, con la quale il codice civile predispone alcunimeccanismi di controllo delle pattuizioni che tendono a trasferire ilrischio da una parte e l'altra (art.1229).
Direttiva sulle clausole abusive e la sua attuazione
Direttiva 93/13/CEE: vengono in evidenza:
a) principi generali;
b) questioni aperte dalla esegesi del testo;
c) le novità o le somiglianze rispetto agli ordinamenti stranieri;
d) novità rispetto all’esperienza italiana.
Nel nostro Paese il recepimento non è avvenuto in modo lineare, in quantonel redigere e approvare il testo il Parlamento, secondo la Commissioneaveva violato la direttiva. Sicché con la L. 526/1999 si è provveduto amodificare il testo del codice civile:
1. soppresse le parole che specificavano il contenuto del contratto delconsumatore all’art. 1469- bis, c.1;
48
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
2. si è aggiunto il c.3 all’art. 1469 quater, in modo da specificare chel’interpretazione più favorevole al consumatore non esclude il ricorsoall’azione inibitoria;
3. art.1469-quinquies, con la specificazione che è inefficace ogniclausola contrattuale che abbia l’effetto di privare il consumatoredella protezione assicurativa.
La Commissione ha convenuto l’Italia dinanzi la Corte di Giustizia, inquanto non si era provveduto ad apportare tutte le modifiche richieste, laquale ha ritenuto il nostro paese inadempiente agli obblighi comunitari el’ha condannato ai sensi dell’art.69, n.3, della procedura regolante ilcontenzioso dinanzi alla Corte.
È stato attivato un osservatorio per accertare quali clausole sianodichiarate abusive negli ordinamenti dei Paesi membri.
Contratti dei consumatori
Per contratti dei consumatori, s’intendono quel tipo di contratti, neiquali, una delle parti è il consumatore, in modo specifico quelli posti inessere tra consumatore e professionista.
Quanto al tipo contrattuale si fa riferimento ad una categoria variegata dicontratti, perché ricomprende i contratti di credito al consumo, i contrattidi viaggio, i contratti di acquisto di beni e servizi, alcuni contrattibancari, ecc.
Il codice civile riportava nell’intitolazione del capo XIV- bisl’espressione “contratti del consumatore” ed aveva ad oggetto regole di portatagenerale.
La direttiva prevedeva che gli Stati dovessero uniformarsi entro il 31dicembre del 1994, l’attuazione da parte dell’Italia è avvenuta solo nel1996 a seguito di un lungo e travagliato iter e da molteplici interventi eemendamenti.
Le disposizioni già inserite nel codice civile sono state ora incluse nelcodice del consumo (artt.33-38 Cc).
Aspetti generali
a) Ambito di applicazione
Per i contratti conclusi anteriormente all’approvazione della direttiva,poiché essa non è retroattiva si applica la disciplina prevista dagli artt.1341,1342,1370.
49
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Per i contratti conclusi successivamente al termine di scadenza dellamoratoria concessa agli Stati per il recepimento (31.12.1994) si discute sela direttiva sia immediatamente applicabile, in quanto sufficientementedettagliata (si avrebbe applicabilità verticale).
Per il periodo successivo all’entrata in vigore, sono assoggettati allanuova disciplina, sia i contratti conclusi dopo il 25 febbraio 1996 sia icontratti a tempo indeterminato, conclusi precedentemente a tale data edestinati ad esaurire i loro effetti ed i contratti rinnovati o prorogatisia anteriormente che posteriormente a tale data.
La disciplina di recepimento non si applica, in ogni caso, a:
1. Clausole che riproducano disposizioni di legge (art.1469 –ter, c.3 oraart.33 Cc);
2. Clausole che riproducano disposizioni o siano attuative di principicontenuti in convenzioni internazionali di cui siano parti contraentigli Stati membri dell’U.E. o la stessa U.E.
La disciplina di recepimento si applica a:
1. Clausole previste da essa, sia testualmente sia in via interpretativa;sia a quelle non previste purché presentino i caratteri divessatorietà previsti dall’art.33 Cc;
2. Clausole non predisposte direttamente dal professionista ma da terzi eda questo utilizzate; sia clausole di altro contratto, come leclausole di rinvio o per relationem richiamate o assoggettate aregolamenti predisposti dal professionista o dalla P.A.
3. Si applica ai contratti conclusi per atto pubblico, con l’assistenzadi notaio.
b) Collocazione nel titolo II (<< dei contratti in generale>>)
La disciplina di recepimento aveva scelto di collocare la nuova disciplinanel codice civile; con la nuova collocazione nel Codice del consumo, le cosenon sono cambiate, in caso di dubbio questa deve essere interpretata allaluce della direttiva comunitaria; dei principi del diritto comunitario edelle regole contenute nel codice civile grazie ai rinvii contenutinell’art.38 e negli artt.142 ss. del Cc.
c) Coordinamento con altre disposizioni
Nel codice civile e nelle leggi speciali sono numerose le disposizioni chesi occupano di contratti che abbiano come parte il consumatore. Il lorocoordinamento in assenza di regola ad hoc introdotte dalla nuova disciplina
50
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
deve essere effettuato sulla base di criteri ordinari di interpretazionedella legge e nel rispetto del d.comunitario.
Con riguardo:- Alla disciplina delle condizioni generali di contratto (artt.
1341,1342,137 cod.civ.), si ritiene che la nuova disciplina non siasostitutiva ma integrativa. In altri termini gli articoli pocanzicitati si applicano comunque ai contratti tra imprese;
- All’art. 1229 cod.civ. (clausole di esonero o di limitazione dellaresponsabilità); la sanzione di tale art. è più grave, in quantoconsiste nella nullità, anziché nell’efficacia; essa prevale perchépiù protettiva per il consumatore;
- Alla disciplina prevista dalle regole di recepimento di altredirettive (es. multiproprietà, viaggi), si applicano solo le clausoledi tenore generale, ma non quelle che concorrono singole clausole,perché tali discipline sono da considerarsi speciali, anche seanteriori al recepimento di tale direttiva.
d) Terminologia
Nel testo della nuova disciplina di usa a volte l’espressione clausole“abusive” a volte “vessatorie”, l’espressione “abusive” è data dall’inesattaversione del testo italiano della direttiva; esse devono intendersiomologhe.
Principi generali
1. Autonomia della volontà delle parti; il professionista è limitatonella sua libertà contrattuale perché se inserisce clausolevessatorie, queste (se ne viene accertata l’esistenza) non sonoefficaci. Restano salve le clausole che si riferiscono all’oggetto delcontratto o al corrispettivo di beni o servizi e le clausole o glielementi di clausole che siano stati oggetto di trattativa. La formadei contratti del consumatore è libera, salvo i casi di quei contrattiper i quali in cui si prevedano forme vincolate;
2. Principio della chiarezza e comprensibilità delle clausole redatte periscritto, nel dubbio prevale l’interpretazione più favorevole alconsumatore. Le clausole oscure o incomprensibili, non sono di per séinefficaci, ma sono intese in modo favorevole alla parte più debole.
Ci si chiede se:
a) Il principio valga anche per i contratti conclusiverbalmente o per fatti concludenti;
51
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
b) Il giudice possa tener conto delle circostanze delcaso (es. il contratto è sottoscritto da unanalfabeta , che sa fare solo la proprio firma);
in entrambi i casi soccorre il principio generale dibuona fede oggettiva. Si discute se la buona fede sia requisitoaggiuntivo al requisito dello squilibrio giuridico tra leprestazioni, siccome il significato di squilibrio è ipotesicontraria alla buona fede, non è necessario effettuare un doppiocontrollo, ad es. nell’accertamento di clausole vessatorie,essendo sufficiente l’accertamento del significato di squilibrio.
Altre regole
La nuova disciplina contiene regole di carattere generale che riguardano lavalutazione di vessorietà, gli effetti della declaratoria, le tecniche dicontrollo e la legittimazione ad agire:
Disciplina sulla vessatorietà prevede 3 diversi livelli:
1. Clausole dichiarate inefficaci, si tratta di quelle clausole diesclusione o limitazione delle azioni del consumatore nei confrontidel professionista, quelle che escludono o limitano la responsabilitàdel professionista in caso di morte o danno alla persona delconsumatore, risultante da un fatto o omissione del professionista; diinadempimento inesatto del professionista, ecc.
2. Clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria;
3. Clausole non contenute nell’elenco (ved. Art. 33 Cc).
La vessatorietà deve essere valutata tenendo conto di 2 elementi:
I. Contrarietà contro la buona fede oggettiva;
II. Squilibrio degli obblghi e diritti derivanti dal contratto.
Il primo è collegato al secondo, poiché in presenza di squilibrio, si puòdeterminare la violazione della buona fede, inoltre questo consentel’inefficacia della clausola, cosa che la violazione oggettiva di per sé nonha.
Lo squilibrio presenta 2 caratteri:
1. Deve essere significativo e deve riguardare i diritti e gli obblighidelle parti, deve avere cioè natura giuridica e non economica; ilgiudice non può valutare la adeguatezza economica del corrispettivo,del prezzo, ecc solo se:
52
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
a) La singola clausola arrechi unosvantaggio al consumatore, ma non siasimmetrica ad altra clausola che arrechisvantaggio al professionista;
b) La singola clausola sia collocata in uncontesto che non giustifichi lo svantaggioimposto al consumatore;
c) La singola clausola arrechi unosvantaggio che appaia significativo, taleda squilibrare il rapporto tra laposizione del consumatore e quella delprofessionista.
Si tratta di 3 diverse operazioni interpretative che il giudice è chiamato acompiere tenendo conto della natura del bene o del servizio, dellecircostanze e delle altre clausole (art.33 Cc). Nella prima il giudice devericavare dal testo la convinzione oggettiva che la clausola sia svantaggiosaper il consumatore; la seconda è più complessa perché questa deve essereconsiderata alla luce delle altre e coordinata con esse; la terza èestremamente difficile in quanto il giudice deve raffrontare il contratto inconcreto esaminato con un modello di contratto “equilibrato”, in sostanzadeve valutare l’equilibrio delle posizioni giuridiche previste dal contrattoin modo complessivo.
Regole speciali
L’art.. 33 Cc elenca clausole che si presumono vessatorie fino a provacontraria, si tratta di una rassegna di clausole utilizzate di frequente neicontratti predisposti dall’impresa, dirette a trasferire i rischi alconsumatore, a limitare gli impegni assunti a chi produce o fornisceprodotti e servizi, a incidere sulla durata del rapporto a consentireall’impresa di recedere o di variare il contenuto del rapporto.
Là dove la nuova disciplina colpisca clausole che nel nostro ordinamentoriproducono disposizioni di legge, questa rimangono efficaci, in quanto ladirettiva e quindi la disciplina di recepimento fa salve le clausoleriproduttive di norme.
Gran parte delle clausole contenute nell’elenco corrispondo a quelle che lagiurisprudenza aveva già classificato come vessatorie, la cui efficacia èsubordinata alla specifica sottoscrizione ex art. 1341, c.2; la clausola èefficace se sottoscritta; nell’art.34 Cc si presume vessatoria e quindiinefficace fino a prova contraria.
Tipi di controllo
53
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
La disciplina di recepimento affida al giudice ordinario la competenza inmateria di azioni inibitorie e di azioni dirette a far dichiarare inefficacile clausole vessatorie. Il controllo delle clausole vessatorie è di tipogiudiziale, nel senso che spetta al singolo consumatore contraentepromuovere l’azione per la declaratoria e alle associazioni dei consumatori.La legge non prevede l’intervento delle associazioni o delle Camere diCommercio, nel procedimento intentato dal singolo consumatore, ma non èescluso che in via giudiziale tale intervento possa essere ammesso. Ladisciplina di recepimento deve essere osservata oltre che dallo Stato equindi dalla P.A. anche dalle c.d. agenzie indipendenti (Banca d’Italia,CONSOB, ISVAP, Autorità antitrust), quando queste dovessero emanareregolamenti afferenti clausole praticate nei confronti dei consumatori, essenon potranno ignorare la nuova disciplina, ma anzi uniformarsi ad essa erenderla applicabile.
La sanzione
La sanzione della clausola vessatoria riconosciuta come tale èl’INEFFICACIA, si tratta di una figura speciale di inefficacia, perchépresenta caratteriste peculiari:
- è INEFFICACIA RELATIVA: in quanto opera solo a vantaggio delconsumatore (art.36 Cc);
- è RILEVABILE D’UFFICIO DAL GIUDICE;
- è PARZIALE: in quanto il contratto rimane efficace per il resto.
La sanzione riguarda solo il contratto preso in esame dal giudice: nonriguarda tutti i contratti esistenti sul mercato contenenti identicaclausola dichiarata inefficace. Di qui l’utilità di assicurare, oltre cheuna tutela individuale,anche una tutela collettiva, mediante lalegittimazione ad agire per inibitoria concessa ad associazioni e alleCamera di Commercio.
Applicazione giurisprudenziale degli artt. 1469-BIS-SEXIES Cod.Civ.(ora artt. 33-38 Cc)
Numerose sono le pronunce che si sono raccolte negli ultimi decenni sugliartt. 1341,1342, 1370 del Cod.Civ. riguardanti le condizioni generali dicontratto.
Nella grande varietà di modelli contrattuali utilizzati solo pochi sono isettori investiti dalla problematica, quali i contratti di assicurazione, icontratti bancari, i contratti di viaggio, di acquisto di autoveicoli,mentre sono rimasti indenni in contratti delle agenzie immobiliari per lacompravendita di immobili, i contratti per l’erogazione dei servizi pubbliciessenziali ecc.
54
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Per quanto riguarda i procedimenti inibitori, si è delineato un contrastotra le prime ordinanze, con cui si è ritenuto non sussistente il presuppostodell’urgenza e quelle successive, con cui altri tribunali hanno accoltoazioni inibitorie. Il contrasto sembra ora quasi in fase di superamento conuna interpretazione estensiva delle disposizioni di natura processuale.
I professionisti, le loro associazioni, le Camere di Commercio
Alcune associazioni di categoria (ABI, per i contratti bancari – ANIA per icontratti assicurativi) hanno segnalato solo alcune delle clausole che piùvistosamente appaiono lesive degli interessi dei consumatori. Da questopunto di vista si ricorda il parere del Comitato economico e sociale dellaC.E. che ha segnalato per tutti i Paesi dell’Unione più di 40 clausoleabusive inserite nei contratti di assicurazione e produttive di effettilesivi degli interessi dei consumatori.
Le Autorità amministrative indipendenti e l’applicazione delladirettiva
Nel nostro ordinamento le Autorità di vigilanza, come la Banca d’Italia perle imprese bancarie, la CONSOB per le imprese di investimento mobiliare,l’ISVAP per i contratti di assicurazione, l’Autorità sulletelecomunicazioni, l’Autorità di vigilanza sulla concorrenza esull’integrità dei mercati hanno conservato poteri sui professionisti deisingoli settori in ordine alla redazione e conclusione di contratti conclusicon i consumatori.
L.580/1993 ha disposto il riordino delle Camere di commercio, industria,agricoltura, artigianato, e sono state attribuite a queste nuove funzioni ecompetenze .
Le Camere di commercio possono:
1. promuovere la costituzione di commissioni arbitrali o conciliativeper le controversie, sia fra imprese, sia fra imprese e consumatori eutenti;
2. predisporre e promuovere contratti tipo tra imprese, loro associazionie associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degliutenti;
3. promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole iniqueinserite nei contratti;
4. costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti control’economia pubblica, l’industria, il commercio e promuovere azioni perla repressione della concorrenza sleale.
Particolarmente significativa è la funzione generale di controllo.L’attuazione di tali competenze, compresa la facoltà di promuovere la
55
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzionedelle controversie, non solo tra imprese, ma soprattutto fra imprese econsumatore, consente alle Camere di promuovere la tutela del consumatore.
Capitolo settimo
Le vendite e gli altri contratti rilevanti per i consumatori
Vendite al consumatore
Premessa
La diffusione sul mercato di prodotti e servizi ha conosciuto negli ultimianni un'evoluzione straordinaria, dettata dalle moderne tecniche dipubblicità, di contatto con il consumatore, di tecniche sofisticate didistribuzione, alla concentrazione nei grandi centri commerciali, all'usodel leasing, del franchising, del merchandinsing e all'impiego di tecnologieinformatiche.
Viene modificato anche lo stesso citato tradizionale di "garanzia", che nonsi identifica solo nel rischio economico connesso con la circolazione diprodotti affetti da vizi, ma si amplia a ricomprendere anche gli obblighi diprotezione connessi con la potenziale lesione di interessi primari delcompratore, quali la salute e l'integrità fisica.
La moderna disciplina della vendita sembrerebbe destinata ad un ritorno alpassato, nella misura in cui trova nuova formazione la distinzione travendite operate tra commercianti e vendite operate ai consumatori.Nell'ottocento la distinzione tra vendite civili e vendite commerciali,tendeva alla realizzazione degli interessi del ceto mercantile,nell'esperienza attuale la distinzione persegue la finalità di assegnarealle vendite ai consumatori una disciplina che mira a tutelare l'interessedel contraente più debole.
In alcuni casi particolari le circostanze nelle quali opera il contratto divendita hanno richiesto l'intervento diretto del legislatore; nel nostroordinamento hanno ricevuto esplicita normazione le vendite a rate, percorrispondenza e quelle straordinarie e di liquidazione.
In materia di vendita uno dei principi è dato dalla libertà contrattuale deiprivati nella definizione delle modalità di conclusione del contratto, delcontenuto, della forma e nella scelta del contraente. Negli ordinamenti deipaesi membri dell'unione la materia è ritagliata tra le fonti: dei codicicivili, di commercio, delle leggi speciali, e dei modelli giurisprudenziali.
56
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Oggi si assiste ad un fenomeno della c.d. permeabilizzazione del dirittocivile e commerciale da parte dei principi del diritto comunitario anche inquei settori in cui la comunità non ha competenza. L'espansione dei principidel diritto comunitario tende così a realizzare non solo la convergenzadegli ordinamenti in settori speciali, ma anche nella struttura di base diprincipi generali.
La direttiva su taluni aspetti della vendita e delle garanzie diconsumo e la sua attuazione
La disciplina di attuazione della direttiva n. 99/44/CE è avvenuta con ild.lgs. 24/2002; la nuova disciplina novellava il codice civile, essendo lesue disposizioni inserite agli artt. 1519 - bis-nonies; attualmente, questesono contenute nel codice del consumo agli artt. 128-135. L’inserimento nel cod.civ. era particolarmente significativo in quanto da unlato lasciava intendere che la nuova disciplina, non essendo confinata inuna legge speciale aveva valenza generale e dall'altro confermava che leregole previste imprimono all'intero ordinamento una catterizzazione modernaconforme al diritto comunitario e tendente all'armonizzazione con le regoleche si stanno radicando in tutti gli ordinamenti dell'unione europea.
La nuova disciplina prevista dal Cc si aggiunge, ma non sostituisce ladisciplina vigente, semmai la modifica laddove necessario; si possonoindividuare 3 regimi di vendite:
1. Vendite tra imprenditori e le vendite tra privati regolate dagli artt. 1470 ss. cod.civ.;2. Vendite speciali, regolate dalla legislazione interna, domestica o di derivazione comunitaria;3. Vendite internazionali, regolate dalle convenzioni internazionali.
Ambito di applicazione:
esso comprende i contratti di vendita, di permuta, di appalto, disomministrazione, di opera e tutti gli altri contratti diretti allafornitura di beni di consumo da fabbricato da produrre (art. 128 Cc).
Le vendite e gli altri contratti ad esse equiparati sono assoggettati alladisciplina in quanto una delle parti sia definita consumatore.
Il consumatore: la definizione di consumatore corrisponde a quella dettatadall'art. 2 della L. 281/1998, cioè "la persona fisica che agisce per scopiestranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta-art. 3 Cc.
Il venditore: è quel tale persona fisica o giuridica, pubblica o privatache, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale,utilizza i contratti di cui sopra.
57
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Il produttore: comprende i soggetti contemplati dal d.p.r. n. 224/1988 sulleresponsabilità del fabbricante per difetti insiti nei prodotti immessi sulmercato.
I beni: oggetto di contratti considerati sono beni di consumo, anche daassemblare e anche usati, sono esclusi esclusione i beni oggetto di venditaforzata e di procedure di vendita giudiziaria, l'acqua e il gas, l'energiaelettrica.I beni sono conformi se:
- idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; - corrispondono alla descrizione fatta dal venditore e dal modellopresentato da questo;- presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stessotipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
La conformità: per valutare la conformità si tiene conto altresì delledichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche dei beni fatte non solo dalvenditore amata dal produttore e nella pubblicità commerciale onell'etichettatura.
Non vi è difetto di conformità se il consumatore era a conoscenza deldifetto al momento della conclusione del contratto o non poteva ignorarlocon l'ordinaria diligenza e se il prodotto è stato fabbricato con istruzionio materiali forniti dal consumatore. Al difetto di conformità è equiparatoil difetto di istallazione del bene.
Il venditore può generarsi dalla garanzia se non era a conoscenza delledichiarazioni degli altri soggetti della catena distributiva, o se ladichiarazione è stata adeguatamente corretta prima della conclusione delcontratto, in modo conoscibile al consumatore o se la decisione di acquistonon è stata incisa banda dichiarazione.
Il venditore (art. 129 Cc) è responsabile solo dei difetti esistenti almomento della consegna e quando il difetto di conformità si sia manifestatoentro due anni dalla consegna del bene.
I rimedi assicurati all'acquirente divergono da quelli stabiliti dalladisciplina ordinaria, perché gli consentono di chiedere:
1. Il ripristino senza spese della conformità mediante riparazione osostituzione, a sua scelta, sempre che il rimedio richiesto non siaoggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro; leriparazioni o le sostituzioni sono onerose secondo alcuni specifici criteriindicati alle lett. a,b,c; in ogni caso le riparazioni devono essereeffettuate entro un congruo termine dalla richiesta;
2. La riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto solo se ricorronoalcune condizioni: se la riparazione o la sostituzione sono impossibili, sequeste non sono state effettuate entro un congruo termine, se hanno arrecatoinconvenienti.
58
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Il consumatore decade dai diritti previsti se non denuncia al venditore ildifetto di conformità entro il termine di 2 mesi dalla data di scoperta incui ha scoperto il difetto.
L'azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.
A sua volta il venditore ha diritto di regresso nei confronti del soggetto odei soggetti responsabili facenti capo alla catena distributiva.
Anche la garanzia convenzionale (cioè la c.d. Garanzia commerciale) èoggetto di disciplina; per quanto riguarda i contenuti obbligatori (idiritti di cui è titolare il consumatore, l'oggetto della garanzia, glielementi per farla valere, la lingua italiana), per quanto riguarda lavalidità in ogni caso della garanzia anche se non rispondente al disposto dilegge.
Tutte queste disposizioni sono imperative, questa la novità introdotta dalladirettiva: ogni patto anteriore alla comunicazione al venditore del difettodi conformità, volto a escludere o limitare anche in modo indiretto didiritti riconosciuti in capo al consumatore della disciplina è nullo, lanullità è relativa in quanto può essere fatta valere solo dal consumatore epuò essere rilevata d'ufficio dal giudice.
La vendita fuori dei locali commerciali
Profittando della casualità delle scelte dei consumatori e della lorodiffusa disinformazione, l'impresa è in grado di proporre acquisti, inapparenza vantaggiosi per i clienti, che si rivelano invece, concluso ilcontratto, sorprendentemente vantaggiosi per il venditore (ciò ad es. siverifica nelle vendite porta a porta). In questi casi il consumatore versain una situazione particolarmente debole, in quanto non avendo lapossibilità di provare il prodotto, di conoscere in anticipo le qualità, dipoter riscontrare l'esistenza delle qualità promesse e non può fare ricorsoall'intervallo di tempo che intercorre tra il momento della scelta scelta eil momento dell'acquisto. Si giustificano così le misure preventive adottatein Gran Bretagna e la dettagliata normazione francese, che è stata presacome modello dalla commissione CEE. I principi sui quali si fonda la leggefrancese (del 1972) sono quelli di evitare l'acquisto a sorpresa e pocomediato, concedendo al consumatore un periodo di riflessione, attribuendogliun diritto di recesso (da esercitarsi entro 7 gg); si tratta di un dirittoindisponibile e irrinunciabile.
Le vendite fuori dei locali commerciali in ambito comunitario
La disciplina è stata introdotta dalla comunità con la direttiva n.85/577/CEE: questa si apre con le definizioni stipulative in ordine allequali l'ambito di applicazione è circoscritto ai c.d. Contratti a domicilio.Proprio perché rivolta a tutelare il consumatore dalle vendite aggressive,la direttiva non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'acquisto siapreceduto da una trattativa iniziata spontaneamente dal consumatore, ovverosia stata attuata attraverso reciproci e duraturi contatti condotti periscritto: l'effetto sorpresa, in questi casi non può avere alcun rilievo ben
59
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
potendo calcolare il consumatore i rischi che si sarebbe accollato e avendoil tempo e la disponibilità di controllo sull'economica che intendevaintraprendere. Occorre puntualizzare che la richiesta di cataloghi, campionie simili, l'invito del consumatore rivolto al commerciante perché gli rendavisita o compia una dimostrazione domicilio, non sono da considerarsiiniziative in questo senso. In tal modo si sottolinea che la disciplina siapplica comunque a tutte le ipotesi di vendita a domicilio, siano esseeseguite con le tecniche dell'offerta fatta porta a porta, o telefonicamenteo mediante l'invio di campioni, di cataloghi e anche le vendite impostericadono in questa direttiva. Il solo fatto del mutamento del luogo dellavendita operata dai locali dell'impresa al domicilio del consumatorecostituisce presupposto sufficiente per assoggettare tutte le vendite alladisciplina progettata.
Gli aspetti rilevanti della direttiva sono 3:
1. Oneri formali per la stipulazione di contratti a domicilio (nascedall'esigenza di difendere gli interessi economici dei consumatoriconsentendo di acquisire tutte le informazioni necessarie per scegliereliberamente di concludere il contratto o di rifiutare l'offerta);2. La fissazione di un periodo di ripensamento nel quale l'acquirente puòesercitare il diritto di recesso;3. La distribuzione del rischio in modo equo tra le parti.
I contratti a domicilio devono essere stipulati per iscritto, a pena dinullità e la medesima sanzione si prevede se il contratto non contienealcune esplicite menzioni o non sia stato sottoscritto di proprio pugnodall'acquirente o non sia stata consegnata copia al consumatore.
Il contratto a domicilio deve contenere:
- nome e indirizzo delle parti contraenti;- prezzo;- modalità di pagamento;- informazioni sul diritto di recesso.
S'intende così evitare la serie di abusi con i quali le imprese cercano disottrarsi alle disposizioni di diritto comune relative all'inadempimentoalla garanzia, privando il consumatore delle necessarie indicazioni relativeai diritti e agli obblighi.
Il diritto di recesso consente di prevenire gli effetti a sorpresadell'operazione economica e quindi di sfuggire a impegni vincolanti cherisultano eccessivamente onerosi per l'acquirente. Si prevede che il periododi riflessione accordato al consumatore dopo la conclusione dell'accordoabbia durata di sette giorni ed entro tale termine deve essere data notiziaal commerciante.
60
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Particolare rilievo acquista la disposizione che esclude qualsiasi marginedi trattativa in ordine al recesso, ad esempio quando il consumatore virinuncia dietro riduzione del prezzo del prodotto; ciò in quanto si trattidi un diritto indisponibile ed irrinunciabile.
Il diritto di recesso dei paganti ulteriormente stabilendo che sarannocolpite a nullità tutte le clausole contrattuali e impongono al consumatoreil pagamento di un indennizzo per l'esercizio delle recesso, il qualeeffettuato entro i termini previsti, non prevede alcun obbligo di pagamento.Il consumatore non è tenuto a pagare un corrispettivo per il normale usodella merce nel periodo di ripensamento.
La corte di giustizia CEE con la sentenza del 1993 ha enunciato 2 importanti principi, il caso riguardavauna consumatrice che uscita dalla stazione di Milano centrale era stata convinta a sottoscrivere unmodulo contrattuale, qualche giorno dopo l'acquisto la consumatrice se ne era pentita ed hacomunicato la volontà di recedere dal contratto, rifiutandosi di non versare le rate del prezzo; nelfrattempo l'impresa aveva ceduto il credito ad una società di factoring e questa ricevuta lacomunicazione con cui la debitrice manifestava l'intenzione di non voler pagare aveva adito il giudiceper soddisfare il proprio credito. Nel corso del giudizio di opposizione al credito ingiuntivo, l'acquirenteaveva richiamato l'applicazione della direttiva comunitaria 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori incaso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali; si deve segnalare che tale direttiva non eraancora stata attuata dal legislatore italiano, sicché il giudice competente aveva richiesto, su richiestadell'opponente una pronuncia pregiudiziale alla corte di giustizia riguardo due aspetti: se la direttivafosse sufficientemente dettagliata, e che dovesse applicarsi solo nei rapporti tra singoli e lo Statoitaliano o anche nei rapporti dei singoli tra loro. La corte ha confermato che tale direttiva èsufficientemente dettagliata e precisa e quindi direttamente applicabile inoltre ha precisato chel'applicazione della direttiva è solo verticale (cioè si applica ai rapporti tra singolo e stato) e nonorizzontale (cioè ai rapporti tra singoli). Perciò ove il giudice non avesse potuto adattare l'ordinamentointerno alla direttiva dando un'interpretazione della legge nazionale, l'unico rimedio che rimaneval'acquirente da quello di promuovere un'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Statoitaliano, ma non quello di sospendere pagamenti.
Lo Stato italiano, al momento era inadempiente (ecco perché si poteva arichiesta di risarcimento del danno allo Stato italiano).
Attuazione della direttiva
La direttiva è stata attuata con il d.lgs. 50/1992, la normativa riprendesostanzialmente il testo della direttiva.
In breve:
- il consumatore deve essere informato sul diritto di recedere, diritto chedeve essere riportato per iscritto sul modulo predisposto dal venditore;- il diritto di recesso è irrinunciabile, e ogni pattuizione in contrastocon la disciplina in esame è nulla,
61
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
- l'esercizio del recesso deve avvenire mediante comunicazione trasmessaentro 7 gg all'operatore commerciale, il termine decorre dallasottoscrizione della nota d'ordine o dal momento in cui consumatore aconoscenza del diritto di certo o dalla data di ricezione della merce. Incaso di mancata informazione il termine è prorogato a 60 giorni;- condizione dell'esercizio è l'integrità della merce;- le controversie sono assoggettate alla competenza territorialeinderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio delconsumatore, se ubicati nel territorio italiano.
La giurisprudenza ha cominciato ad applicare la disciplina di recepimentodella direttiva sui contratti conclusi fuori dei locali commerciali conparticolare rilievo alla fattispecie del recesso. Il tribunale di Romadovendo giudicare un fatto anteriore al recepimento della direttiva, hasostenuto che il giudice nazionale, nell'interpretare l'art. 1372 cod. civ.concernente la vincolatività del contratto, può ravvisare, fra le cause discioglimento del contratto, una facoltà di recesso derivante dal principigenerali di tutela del contraente più debole.
Queste disposizioni relative sono contenute nel codice del consumo agliartt. 45-49.
Le vendite a distanza
La direttiva sulla "protezione dei consumatori in materia di contratti adistanza" è stata approvata nel luglio del 1997. I principi di libertàcontrattuale è salvaguardato per tre aspetti fondamentali:
1. L'INFORMAZIONE;2. IL RECESSO;3. L'IMPIEGO DI TECNOLOGIA CHE OPERANO A DISTANZA.
L'informazione del consumatore:
a) vi sono informazioni preliminari alla conclusione del contratto inerentiall'identità e all'indirizzo (o sede) del fornitore, le caratteristicheessenziali del bene o del servizio (essenziale dovrebbe riguardare laqualità), il prezzo e le eventuali spese di consegna, le modalità dipagamento, consegna o esecuzione, il diritto di recesso, il costo dellautilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, la durata dellavalidità dell'offerta e (e la immodificabilità) del prezzo, la durata minimadel contratto se esso sia ad esecuzione continuata o periodica.
Tra tutte queste informazioni la direttiva seleziona quelle che devonoessere confermate per iscritto in tempo utile: si tratta delle condizioni edelle modalità di esercizio della ricetta, dell'indirizzo del fornitore, deiservizi di assistenza e di garanzia, del recesso in caso di contratti didurata indeterminata o superiore a 1 anno.
b) vi sono informazioni da trasmettere nel corso dell'esecuzione delcontratto. Si tratta delle informazioni riguardanti la mancata disponibilità
62
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
del bene o del servizio richiesto, la possibilità di sostituzione del bene odel servizio, le spese di rinvio o sostituzione conseguente all'eserciziodel recesso.
c) vi sono informazioni che non spettano al fornitore bensì agli Statimembri, perché i consumatori possano conoscere la disciplina di recepimento,e alle organizzazioni professionali, perché consumatori possano conoscere iloro codici di autodisciplina.
Modalità di conclusione e di esecuzione del contratto
Il contratto per l'acquisizione di un bene o di un servizio con tecniche dicomunicazione effettuate a distanza ( ad es. posta, messaggiopubblicitario,fax, telefono, posta elettronica, televisione, internet) nondebba avere forma scritta, né al consumatore, una volta avvenuta la suaconclusione, deve essere trasmesso un supporto cartaceo; la forma scritta èrichiesta solo per talune informazioni preliminari.
È previsto il diritto di recesso successivo alla conclusione del contratto,da effettuarsi entro 7 gg. lavorativi, senza penalità e senza spese, salvequelle di restituzione.
Il termine decorre:
1. Per i beni: dal ricevimento, se il fornitore a trasmesso le informazionipreliminari; in caso contrario il termine prolungato a 3 mesi dalricevimento del bene;2. Per i servizi: dalla conclusione del contratto, se il fornitore hatrasmesso le informazioni preliminari; in caso contrario è prolungato di 3mesi dalla conclusione del contratto.
Se le informazioni sono trasmessi entro tre mesi, e il periodo del recessotorna ad essere contenuto in 7gg.
Esecuzione:
la fornitura deve essere eseguita entro 30 gg. e in caso di inadempimento siprevede il rimborso del consumatore.
Il pagamento può avvenire o mediante il ricorso al credito al consumo e inquesto caso l'esercizio del recesso comporta la risoluzione di diritto delcontratto di credito; o mediante carta di pagamento, in caso di usofraudolento della carta il consumatore può annullare il pagamento.
Modalità di vendita:
la direttiva prevede: per le forniture non richieste, il loro divieto, sesiano corredate da richiesta di pagamento; l'esonero del consumatore daprestazioni corrispettive, se la fornitura non richiesta non sia accettata;
63
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
l'irrilevanza del silenzio, in caso di mancata risposta; il consensopreventivo del consumatore, in caso di uso del dispositivo automatico dichiamata o di fax.
Garanzie ulteriori
La direttiva prevede ulteriori garanzie a tutela del consumatore; ledisposizioni inerenti i diritti riconosciuti in capo a questo devono essereconsiderate imperative e quindi non rinunciabili neppure dall'interessato.La direttiva assicura una tutela minimale e consente agli Stati membri diintrodurre disposizioni più severe; inoltre si preoccupa dell'accesso deiconsumatori alla giustizia, sia con riguarda all'onere della prova, sia conriguardo al ricorso alle ADR.
Attuazione della direttiva sulle vendite a distanza
Con il d.lgs. 185/1999 è stata data alla direttiva 97/7/CE.
Il contratto a distanza è definito come il contratto "avente per oggetto beni oservizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazionedi servizi a distanza organizzato dal fornitore, e che per tale contratto, impiega esclusivamente una opiù tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusionedel contratto stesso".
L'espressione a distanza riguarda lo spazio fisico esistente tra fornitore econsumatore e quindi specifica una categoria di contratti porta a porta; latecnica di comunicazione a distanza riguarda qualunque mezzo che, senza lapresenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possaimpiegarsi per la conclusione del contratto tra le parti.
La disciplina non si applica: ai contratti a distanza concernenti i servizifinanziari, ai contratti conclusi mediante distributori automatici o localicommerciali automatizzati, contratti conclusi con gli operatori delletelecomunicazioni impiegando telefoni pubblici; a contratti concernenti beniimmobili (ad eccezione delle locazioni), ai contratti conclusi in occasionedi una vendita all'asta.
Le finalità della disciplina, sono quelle di difendere il consumatore daimetodi aggressivi di vendita perseguiti con le nuove tecnologie e ditutelarlo in quanto parte contrattualmente più debole del rapporto adistanza. Per realizzare le finalità indicate il legislatore ha concentratola sua attenzione sulle informazioni e consumatore di ottenere prima dellaconclusione del contratto.
Le informazioni devono essere inequivoche e fornite in modo chiaro ecomprensibile. L'omissione delle informazioni obbligatorie comporta dalpunto di vista civilistico una dilazione dei termini entro cui ilconsumatore può recedere dal contratto oltre che sanzioni penali eamministrative.
64
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
L'esercizio del recesso avviene senza alcuna penalità e senza che sianecessario specificarne il motivo, il termine per l'esercizio del recessofissato in 10 gg. (o in 3 mesi, se le informazioni non sono state fornitesecondo le modalità previste) e decorre per i beni dal momento del lororicevimento, e per i servizi dalla conclusione del contratto.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio di una comunicazione scrittaalla sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso diricevimento.
Effetti del recesso:
il recesso comporta la restituzione della cosa consegnata secondo lemodalità e tempi brevi in contratto; il termine per la riconsegna non puòpiù inferiore ai 10 gg. dalla data di ricevimento del bene; le speseaccollate al consumatore possono riguardare solo la restituzione e in talcaso devono essere previste in contratto. Per parte sua il fornitore tenutoa rimborsare le somme versate dal consumatore, gratuitamente e nel minortempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data in cui egli è venuto aconoscenza dell'esercizio del recesso.
Il contratto di credito al consumo che il consumatore abbia concluso con ilfornitore, o con il terzo che abbia concluso l'accordo con il fornitore, èrisolto di diritto senza penalità o del consumatore eserciti diritto secondoquanto stabilito. Il fornitore deve comunicare al terzo concedente ilcredito, l'avvenuto esercizio del diritto di accesso. Le somme versate dalterzo che ha concesso il credito sono rimborsate dal fornitore, senza alcunapenalità, ma con l'addizione degli interessi legali maturati.
Esecuzione del contratto:
il fornitore deve eseguire l'ordine entro 30 gg. che decorrono dal giornosuccessivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordine alfornitore. In caso di indisponibilità del bene o del servizio, il fornitoreinforma il consumatore e gli rimborsa le somme che siano già state da questocorrisposte. Il fornitore, se sia stato autorizzato dal consumatore, nellafase anteriore alla conclusione o all'atto della conclusione del contratto,può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita; se non èautorizzato non può sostituire la fornitura, anche se di valore e qualitàequivalenti o superiori.
Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta; l'istituto diemissione della carta di pagamento è tenuto a accreditare al consumatore ipagamenti eccedenti il prezzo pattuito o derivanti dall'uso fraudolentodella carta da parte del fornitore o di un terzo, l'istituto ha diritto diaddebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Le vendite aggressive sono scoraggiate, in quanto introdotto il divieto difornitura di beni asserviti al consumatore senza ordine, nel caso in cui lafornitura comporti la richiesta di pagamento. I diritti riconosciuti in capo
65
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
al consumatore dalla normativa sono irrinunciabili ed è nulla ognipattuizione contraria.
Tutte queste disposizioni sono raccolte nel codice del consumo agli artt.50-67.
I contratti relativi alla multiproprietà
La direttiva comunitaria in tema di multiproprietà (94/47/CE)
Nella maggior parte dei casi la multiproprietà è utilizzata a finituristici, da qui l'opportunità di intervenire da parte della comunità perassicurare agli acquirenti una tutela minima concernente le informazioni dacomunicare nella fase precontrattuale e al momento della conclusione delcontratto e le regole riguardanti il credito e il contenuto del contratto.
L'art.2 della direttiva definisce il contratto di multiproprietà "comel'accordo, concluso per un periodo di almeno tre anni, con il quale, direttamente o indirettamente,dietro corrispettivo di una certa somma globale, un diritto reale o un altro diritto vertente sulgodimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato determinabile dell'anno anteriorealla settimana, è costituito o forma oggetto di un trasferimento o di un impegno di trasferimento".
Si prevede che il venditore debba garantire al compratore:
1. La costruzione a regola d'arte dell'immobile;2. Il trasferimento del diritto libero da ogni vincolo o assoggettato aivincoli esplicitati in contratto;3. La concessione di garanzie sufficienti in caso di ritardi o di danni;4. L'eventuale partecipazione all'amministrazione.
Si prevede la redazione e la consegna l'acquirente -prima della conclusionedel contratto - di un documento informativo che fa parte integrante delcontratto; eventuali modifiche possono essere apportate solo se determinateda circostanze indipendenti dalla volontà del venditore.
Forma del contratto: è prevista la forma scritta, di cui si indicano inallegato gli elementi essenziali e la redazione della lingua chel'acquirente dichiari di conoscere.
Elementi minimi del contratto:
1. Identità, il domicilio del venditore e la sua posizione giuridica almomento della conclusione del contratto;2. La natura del diritto oggetto del contratto;3. La descrizione dell'immobile, ove esistente o se esso sia in corso dicostruzione; lo stato di avanzamento, la previsione di ultimazione, la datadi consegna;4. Le informazioni sul diritto di recesso;5. La data, il luogo e la sottoscrizione.
Il diritto di recesso deve essere esercitato dall'acquirente entro 10 gg.dalla sottoscrizione del contratto (definitivo o preliminare). Il contratto
66
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
non conteneva le informazioni indicate nell'allegato i termini che decorreda quando dette informazioni mancanti sono inserite nel contratto, sempreche ciò sia avvenuto entro tre mesi. Il recesso si esercita concomunicazione che costituisce mezzo di prova.
La disciplina prevista dalla direttiva è minimale, le ragioni di questascelta sono esplicitate nel secondo "considerando" di questa, ove si precisache lo scopo cui è rivolta consiste nel creare una base minima di norme chegarantiscano il buon funzionamento del mercato interno e in tal modo latutela degli acquirenti; infatti il profilo dei beni in gioco èesclusivamente contrattuale ma sono previsti anche confini di interventorelativi: alle informazioni sugli elementi costitutivi del contratto, allemodalità di trasmissione di tali informazioni e alle procedure e modalità dirisoluzione e di recesso.
L'attuazione della direttiva comunitaria
La direttiva 94/47/CE è stata attuata con d.lgs. 427/1998, il testo nonpresenta particolari novità rispetto alla direttiva medesima; attualmente ledisposizioni di attuazione sono raccolte nel codice del consumo, agli artt.69-81.
- art. 1 del d.lgs. dà la definizione d'uso;- art. 2 " " " dispone i contenuti del documento informativo che ilvenditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazionisul bene immobile;- art. 3 " " " prescrive alcuni requisiti del contratto: la forma scrittaa pena di nullità, la lingua dell'acquirente, i contenuti e l'identità e ildomicilio dell'acquirente, il periodo di esercizio del diritto oggetto delcontratto, l'esclusione di altri oneri e spese per l'acquirente oltre quellievidenziati, lo scambio dei diritti di godimento, data e luogo dellasottoscrizione;- art. 4 " " " impone al venditore di usare il termine multiproprietà solose l'oggetto del contratto è un diritto reale;- art. 5 " " "disciplina il diritto di recesso, da esercitarsi entro 10giorni dalla conclusione del contratto, ma il termine si allunga chel'acquirente non ha ottenuto le informazioni prescritte;- art. 6 " " " fa divieto al venditore di richiedere acconti;- art. 7 " " " si occupa della fideiussione bancaria o assicurativa che ilvenditore è obbligato a rilasciare all'acquirente per l'adempimento delcontratto; - art. 8 " " " prevede la risoluzione del contratto di concessione dicredito che l'acquirente abbia chiesto per l'acquisto del diritto oggettodel contratto in caso di esercizio del recesso;
- art. 9 " " " prevede che le clausole contrattuali o i patti aggiunti dirinuncia dell'acquirente ai diritti previsti nel decreto o di limitazionedella responsabilità del venditore siano nulli.
I contratti di viaggi vacanze
Disciplina dei contratti di viaggi e vacanze
67
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
In un primo tempo, il contratto di viaggio turistico è stato oggetto dellaconvenzione sul contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles nel 1970 erecepita dallo stato italiano con la L. 1084/1997, limitatamente ai viaggiinternazionali.
Punti salienti della convenzione:
- diritto del viaggiatore di promuovere l'azione di responsabilitàcontrattuale per danni derivanti dalla prestazione inesatta, non solo neiconfronti del vettore o del fornitore del servizio singolo, ma anchedell'organizzatore del viaggio, il quale risponde anche per gli altrisoggetti che hanno partecipato con le rispettive prestazioniall'effettuazione del servizio.
Questa disciplina è marginale rispetto quella dedicata alla tutela delconsumatore, recata dalla direttiva 85/577/CEE recepita con D.lgs. 111/1995.Ora le disposizioni sono raccolte nel codice del consumo, agli artt. 82 -100.
La tutela del consumatore nei rapporti inerenti viaggi, vacanzecircuiti "tutto compreso"
l'ambito della direttiva della sua disciplina di ricevimento riguarda i c.d.Pacchetti turistici, con tale espressione l'art. 69 del Cc allude airapporti che presentano almeno due tra i seguenti oggetti:
Trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto eall'alloggio. Controparte del consumatore in questi rapporti può esserel'organizzatore (tour operator) o un'associazione senza scopo di lucro.
Per il contratto si prescrivono alcuni requisiti:
1. La forma, che deve essere scritta;2. La redazione, che deve essere espressa in termini chiari e precisi;3. La documentazione, in quanto il consumatore che deve consegnare copia delcontratto.
Altresì il contratto di vendita di pacchetti turistici deve fornireinformazioni relative a:
a) alla destinazione, alla durata e alle date di inizio e di conclusione delviaggio; all'identità dell'organizzatore;b) al prezzo del pacchetto turistico; alle modalità di pagamento, conriguardo ad acconti (non superiore al 25%);c) alla caparra, che non può essere trattenuta dal organizzatore se ilrecesso dipende da fatti non imputabili al consumatore;d) alla copertura assicurativa; all'intervento del fondo di garanzia.
Il contratto deve indicare le caratteristiche della sistemazionealberghiera; i contenuti dei servizi turistici, gli accordi sulle modalitàdi viaggio, nonché i termini entro i quali il consumatore deve essereinformato sull'annullamento del viaggio, può presentare reclami, può
68
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
inoltrare le sue determinazioni per le modificazioni dei contenuti delviaggio; infine le spese per la cessione del contratto a terzi. Una curaparticolare è posta sull'informazione del consumatore sia con riguardo aidati che devono essere forniti sia con riguardo ai documenti contrattuali(opuscoli).
Il contratto può essere ceduto dal consumatore.Il prezzo è suscettibile di revisione, purché le parti l'abbianoconsensualmente convenuta, ma l'aumento del prezzo non può superare illimite del 10%.Il contratto può essere modificato unilateralmente dall'organizzatore, ma ilconsumatore ha diritto di recedere senza pagamento di penale, primadell'inizio del viaggio. Se la modificazione è successiva, l'organizzatoredeve provvedere al consumatore alternative adeguate, salvo il risarcimentodel danno.La prestazione sostitutiva, sempre rimanendo salvo il diritto alrisarcimento del danno, è prevista anche in caso di annullamento delviaggio.
Regime di responsabilità:
alla regola ordinaria che impone all'organizzatore l'onere della prova cheil mancato o inesatto adempimento è dipeso da impossibilità dellaprestazione a lui non imputabile e alla regola che rende responsabile ildebitore del fatto illecito dei suoi ausiliari, si affianca la regola inbase alla quale l'organizzatore risponde salvo rivalsa, del danno inferto alconsumatore dagli altri prestatori di servizi che hanno cooperato con lui.Quanto alla responsabilità extracontrattuale, essa è prevista nei limitidelle convenzioni internazionali, con prescrizione triennale, essendoperaltro nulli gli accordi che modifichino la disciplina dellaresponsabilità previste dalle convenzioni.
Per i danni a cose, si fanno salve sono le convenzioni, che sianoammissibili ai sensi delle convenzioni internazionali, con prescrizione diun anno del diritto al risarcimento, decorrente dalla data del rientro delconsumatore.Ulteriore vantaggio per il consumatore è dato dalla prescrizionedell'assicurazione obbligatoria della responsabilità per il risarcimento deidanni alla persona e alle cose e dalla istituzione di un fondo di garanziaper il caso di insolvenza dell'organizzatore.
Uno dei problemi più interessanti della materia, riguarda la natura deldanno risentito dal turista in caso di "vacanza rovinata". Si può ritenereche, si sia in presenza di danno morale contrattuale; ma la giurisprudenzapreferisce qualificarlo come danno biologico o come danno morale oesistenziale, oppure come semplice conseguenza dell'inadempimentodell'organizzatore.
Tribunale di Torino:
il danno da vacanza rovinata, a prescindere dalla sua natura patrimoniale onon patrimoniale, è danno risarcibile.
69
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Tribunale di Milano:
il minore godimento della vacanza e i disagi sopportati dal turista a causadell'inadempimento dell'agenzia di viaggi e/o del tour operator, siestrinsecano in un danno non patrimoniale la cui risarcibilità è ammessa inbase alla revisione dell'art. 13 CCV.In caso di overbooking ha precisato che: il risarcimento del danno daoverbooking nell'albergo prenotato dall'organizzatore di viaggi comprende,nel caso di riprotezione presso l'albergo di categoria inferiore o comunquenon dotato dei servizi e delle caratteristiche propri dell'albergooriginariamente prenotato, non solo la differenza tra il prezzoeffettivamente sborsato dai viaggiatori ed il prezzo che questi avrebberodovuto corrispondere qualora la prenotazione avesse avuto originariamentead oggetto il servizio successivamente offerto, ma anche il risarcimento deldanno da vacanza rovinata, che trova il suo fondamento negli artt. 13 e 15CCV, a mente dei quali l'organizzatore di viaggi dispone di qualunquepregiudizio causato al viaggiatore. Rimane così superata l'obiezione circail carattere non patrimoniale del danno predetto,
Vertendosi in ipotesi di pregiudizio la cui liquidazione è prevista dallalegge, secondo il disposto dell'art. 2059 cod. civ. il risarcimento deldanno può essere effettivamente effettuato in misura pari alla metà delprezzo del servizio equitativamente effettuato in misura pari alla metà delprezzo del servizio effettivamente fruito dai viaggiatori.
La corte di giustizia ha inoltre precisato che nell'ambito della disciplinadei viaggi rientrano anche i "viaggi su misura" definiti dai consumatori almomento della prenotazione.
I contratti relativi ai servizi di pubblica utilità
Quadro normativo
Tra i programmi di protezione dei consumatori si è segnalata l'esigenza diun intervento di coordinamento e di promozione delle legislazioni degliStati membri in questo settore.
Dal punto di vista delle fonti, si distinguono 4 livelli:
1. LIVELLO COMUNITARIO: oltre alle direttive, concernenti la tutela delconsumatore in materia di pubblicità commerciale, di credito al consumo, divendite effettuate al di fuori dei locali commerciali, di viaggi e turismo,di responsabilità del produttore di beni difettosi, si riscontrano dueiniziative che incidono direttamente sui rapporti dei consumatori con glienti erogatori di servizi:
70
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
- la direttiva sulle clausole abusive contenute nei contratti deiconsumatori;- il progetto di direttiva sulla responsabilità del prestatore di servizi(quest'ultima è ancora all'esame degli organi comunitari ed ha un futuroincerto).
2. LIVELLO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE: in cui si fa riferimento ai diversiprovvedimenti presi dal nostro paese per tutelare i diritti dei consumatori,come ad es. la nuova disciplina delle clausole abusive.
3. LIVELLO DEI PROVVEDIMENTI DI NORMAZIONE SUB-PRIMARIA O REGOLAMENTARE EIL LIVELLO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E AI REGOLAMENTI EMANATI DALL'AUTORITA'INDIPENDENTI DEI DIVERSI SETTORI DEI SERVIZI;
4. LIVELLO DELL'AUTONOMIA PRIVATA: in cui gli erogatori di servizi sonotenuti ad elaborare una propria carta inerente alla qualità del servizio eai rapporti con gli utenti, nonché il rapporto contrattuale con essiistituito.
I servizi e i consumatori
La definizione del significato di: erogatore, utilizzatore, servizio; non sirinvengono né in ambito normativo comunitario né in ambito normativointerno. Tuttavia una direttiva precisa che i soggetti erogatori sono sia lepubbliche amministrazioni, sia i soggetti privati concessionari, ai quali iprincipi non si applicano direttamente ma indirettamente.
Gli utenti di volta in volta denominati anche consumatori, sono variamentedefiniti.
In ambito comunitario: il consumatore viene definito come la persona fisicache opera al di fuori della sua attività professionale; la direttiva tendead accreditare la nozione di consumatore-persona fisica, in quanto sipreoccupa della tutela della salute, dell'assistenza e previdenza sociale,della libertà di comunicazione, della libertà e sicurezza, della libertà dicircolazione, nonché del rispetto del principio di uguaglianza, percontrastare discriminazioni fondate su sesso, razza, lingua, religione eopinioni politiche degli utenti, e si preoccupa delle esigenze degli utentiportatori di handicap.
In ambito nazionale: la L. 481/1995, fa riferimento a consumatori e utentiin generale e si preoccupa di tutelare gli utenti deboli, quali anziani edisabili.
I servizi sono qualificati come “pubblici” dalla direttiva e di “pubblicautilità” dalla L. 481.
La L. 481/1995
Con tale legge si è introdotta un'articolata disciplina dei contrattirelativi ai servizi di pubblica utilità. L'impianto normativo riguarda ingenerale la concorrenza, l'efficienza, la diffusione e la regolazione dei
71
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
servizi di pubblica utilità, nonché l'istituzione delle autorità diregolazione dei servizi.
Tra le finalità si contempla la promozione della tutela degli interessi diutenti e consumatori, con riguardo alla qualità dei servizi. Queste finalitàsono state realizzate mediante diverse tecniche:
1. Si istituiscono autorità amministrative indipendenti con il compito dicontrollare le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercentiservizi siano attuate nel rispetto dei principi tali da assicurare unservizio: concorrenziale, cioè non esercitato in regime di monopolio legaleo di fatto; corretto, cioè non esercitato in modo che se ne possonoconoscere e controllare i costi, le componenti, le condizioni; egalitario,al fine di evitare discriminazioni tra utenti; satisfattivo, in modo chesiano soddisfatte le esigenze ragionevoli degli utenti, ivi comprese quelledegli anziani e dei disabili; socialmente non dannoso al fine di evitare leesternalità a carico dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e dellasalute degli addetti; equilibrato, nel senso che il prezzo onnicomprensivosia
commisurato all'andamento del mercato e conforme alle finalità sopraindicate; trasparente, perché i costi delle singole prestazioni offertesiano evidenziati disaggregandone le componenti, e siano resi pubblici,corretto, in modo che l'autorità possa determinare i casi di indennizzoautomatico; qualificativamente congruo, cioè corrispondente ai livelli diqualità ripartiti per settori e tipi di prestazioni, e definiti conl'ausilio dei rappresentanti degli utenti e dei consumatori; informato,perché i consumatori possano avere accesso agli uffici, avere sollecitarisposta ai reclami, istanze, segnalazioni.
2. Per raggiungere tali obiettivi, si assegnano alle autorità prepostepoteri di: richiesta di informazioni e documenti agli esercenti delservizio; controllo dell'esecuzione del servizio; irrogazione di sanzioni;inibizione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, con l'obbligodi corresponsione di un indennizzo; audizioni periodiche delle associazionidi consumatori e utenti, di associazioni ambientaliste sindacali; conduzionedi procedure di conciliazione e arbitrato in seconda istanza, rispetto alprimo grado svoltosi presso le camere arbitrali istituite presso le cameredi commercio; adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantirel'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorrettofunzionamento, nell'ambito delle procedure di conciliazione arbitrato.
3. La nuova disciplina interviene in una serie di settori ma non esauriscetutti i settori dei servizi pubblici. Essa non è coordinata con ladisciplina delle clausole abusive né con le situazioni che si dovrannooccupare delle controllo di quest'ultime; agevola la partecipazione deiconsumatori e degli utenti, che però al di là del diritto di interpello e diinformazione non posso interferire nelle scelte gestionali e nellaformulazione delle clausole contrattuali. Assicura il pronto ristoro deidanni, mediante la determinazione di un indennizzo che non potràcorrispondere al risarcimento del pieno danno risentito, ma vale, se leprocedure di conciliazione e di arbitrato saranno efficienti, a migliorare
72
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
la tutela dei diritti degli utenti e a decongestionare il caricodell'amministrazione della giustizia.
Problemi applicativi
Tra i numerosi problemi afferenti l'interpretazione e l'applicazione dellaL. 481/1995 e il suo coordinamento con le discipline di confine ointerferenti con essa, la dottrina ha segnalato alcune questioni:
- ci si chiede se le autorità di regolazione abbiano poteri di intervento inmateria di clausolazione dei contratti di utenza; certamente il testocontrattuale è oggetto di applicazione dei principi di trasparenza e diqualità del servizio; poiché si cerca di offrire protezione all'utente inordine alla continuità e regolarità del servizio;
-sempre nell'ambito dell'attività dell'autorità, sono da coltivare glispunti offerti da queste sue disciplina in ordine ai contatti, ancheinformali tra questa e le associazioni dei consumatori anche al fine diconcordare, suggerire o rischiare l'attenzione delle autorità su linee delsuo intervento.
- quanto alla determinazione dell'indennizzo automatico si deve chiarire sesi tratti di un intervento definito di parametri generali o dideterminazione caso per caso e se si tratti di indennizzo definitivo o sesia possibile all'utente richiedere anche risarcimento del danno ulteriore,ove debitamente provato.
Nel codice del consumo è contenuta una sola norma di rinvio alla disciplinaspeciale (art.101).
Capitolo ottavo
I servizi finanziari
Quadro normativo europeo. Ritardi e difficoltà delle strategie didifesa del risparmiatore
A parte l'ambito del credito al consumo, le misure di tutela del consumatorenel settore dei servizi finanziari si sono affacciate nei programmi diprotezione del consumatore elaborati in sede comunitaria solo da alcunianni.
Le difficoltà dell'intervento sono dovute a una molteplicità di ragioni:
1. SUBSTRATO GIURIDICO = nella gran parte dei sistemi giuridici dei paesiaderenti all'unione, gli interessi dei consumatori in materia dei servizifinanziari, sono considerati marginali:
73
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
a) o perché la normativa è contenuta in codice di commercio o in leggi speciali che nascono con finalitàdiverse rispetto a quella primaria di tutela del consumatore;
b) o perché i consumatori sono considerati, in quanto clienti, alla stregua di una controparte e quindisu un piano fittiziamente paritetico.
2. SUBSTRATO ECONOMICO = le esigenze del libero mercato sonoistituzionalizzate al punto da far ritenere che ogni settore obbedisca alleproprie regole economiche e non sopporti limitazioni o controlli diversi daquelli finalizzati alla stabilità del mercato e all'affidamento dei suoioperatori.
3. FATTORE TECNOLOGICO = i servizi finanziari attualmente richiedonol'impiego di tecnologie sofisticate, che rivoluzionano i metoditradizionali, anche nel segmento finale del rapporto istituito con ilconsumatore.
Il quadro del diritto comunitario in materia è complesso, le direttive piùrilevanti al riguardo sono:
- settore bancario: direttive in materia oltre a quelle sul credito alconsumo, sono la n. 77/780 del 1985, la direttiva n. 89/346, coordinate oranella direttiva 2000/12/CE.
- intermediazione finanziaria: direttiva sugli organismi di investimentocollettivo, quella sui servizi di investimento nei settori dei valorimobiliari, la direttiva relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori,quella sull'esercizio di attività bancaria, la direttiva sullacommercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
- materia assicurativa: direttiva sull'assicurazione diretta sulla vita e ladirettiva sulla sicurezza diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
I legislatori nazionali hanno seguito l'orientamento comunitario senzapreoccuparsi di integrare i programmi con la tutela specifica degliinvestitori non professionali.
Aspettative fondamentali dei consumatori:
1. Per i RAPPORTI BANCARI = stabilità dell'istituto di credito, larestituzione delle somme investite, la qualità dei servizi, un giusto prezzodelle operazioni richieste, possibilmente un profitto dall'investimento;2. Per i RAPPORTI ASSICURATIVI = la copertura dei rischi, il giusto prezzodei premi, la restituzione dei capitali e un margine di profitto per iprodotti assicurativi a contenuto finanziario;3. Per i RAPPORTI DI INVESTIMENTO FINANZIARIO = una corretta e fruttuosagestione dei capitali;4. Per i RAPPORTI PENSIONISTICI = affidabilità dell'operatore e puntualeriscossione delle rate pensionistiche.
Testo unico sull'intermediazione finanziaria
74
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
T.u. approvato con D.Lgs. 58/1998, recante norme sui mercati finanziari esulla c.d. corporate governance. Si tratta di una disciplina che asserisce aldiritto pubblico dell'economia, ma contiene anche regole che si possonoascrivere al diritto privato.Non sono mai nominati i "consumatori"; il risparmiatore non professionale èperò considerato come consumatore di prodotti e servizi finanziari.
Art. 5 t.u. = si pone la tutela degli investitori, insieme con la stabilità,la competitività, il buon funzionamento del sistema finanziario, eraassicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana eprudente gestione dei soggetti abilitati.
Art. 3 del Trattato, come modificato a Maastricht, considera obiettivofondamentale comunitario il rafforzamento della protezione dei consumatori;in questo senso si fa riferimento anche alla direttiva 97/9/CE, sullacostituzione da parte degli Stati membri di sistemi di indennizzo cui leimprese di investimento sono tenuti a partecipare, da cui si ricavano duemodelli di lettura:
-indirizzo commercialistico-bancario;-indirizzo privatistico (che cura gli interessi dei risparmiatori).
Il primo modello prevale ancora sul secondo e pur avendo qualche punto dicontatto con questo si propone come unico o principale.
a) Conflitti di interesse
Art. 10 direttiva 93/22/CEE dispone che l'impresa di investimento "sia strutturata ed organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischioche gli interessi dei clienti siano lesi dai conflitti di interessi traimpresa e i suoi clienti e tra i singoli clienti";
il testo unico le propone il testo del decreto di recepimento (D.lgs415/1996) della direttiva e ignora il testo di quest'ultima.
T.u. Si preoccupa della "esigenza di ridurre al minimo i conflitti diinteressi".
b) Documentazione contrattuale
Art. 23 t.u. Prevede un obbligo di consegna cliente di un esemplare delcontratto; lo scopo della disposizione consiste nel consegnare al cliente iltesto dei diritti e degli obblighi insorti con la conclusione del contratto;ma il cliente ha interesse a conoscere il documento anteriormente allaconclusione. Non si può considerare assolto l'obbligo di consegna del testosottoscritto dal cliente e non ancora approvato dall'intermediario.
c) Ius poenitendi (diritto di recesso)
Incertezza interpretativa del t.u. : art. 30, c.6, dispone che l'efficaciadei contratti è sospesa per la durata di 7 gg. decorrenti dalla data disottoscrizione da parte dell'investitore. La sottoscrizione dell'investitore
75
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
non coincide necessariamente con la conclusione del contratto; se non c'èconclusione non ci può essere recesso, allora o si tratta di revoca dellaproposta, ma in tal caso il testo si pone in contrasto con la direttivacomunitaria, oppure si tratta di recesso, e allora il termine sottoscrizionedeve essere sostituito con il termine conclusione.
d) Collocamento a distanza
Art. 32 t.u. Rinvia al regolamento della CONSOB, la disciplina delcollocamento a distanza dei servizi di investimento e degli strumentifinanziari.
e) Responsabilità del revisore
Tale regime di responsabilità è stato introdotto nel nostro ordinamento conl. delega 216/1974, anticipata dal d.l. 95/1974. Con il d.p.r. 316/1975,concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci dellesocietà per azioni quotate in borsa, si prevedeva all'art.12 unadisposizione riguardante la responsabilità civile e delle persone che hannosottoscritto la relazione di certificazione e dei dipendenti che abbiano
effettuato operazioni di controllo contabile; tali soggetti eranoconsiderati responsabili in solido con la società di revisione per i danniconseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti dellasocietà assoggettata a revisione e dei terzi.
Successivamente l'VIII direttiva (1984) in materia di società, relativaall'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge deidocumenti contabili, prevedeva all'art.23, una disposizione secondo la qualegli Stati membri prescrivono che le persone abilitate ad effettuare ilcontrollo dei documenti, svolgano tali controlli con diligenzaprofessionale.Il tessuto normativo sia completato con l'art. 164 del t.u. sui Mercatifinanziari (D.lgs 58/1998), il quale prevede che "alla società di revisionesi applicano le disposizioni dell'art. 2407, c.1, cod.civ. i responsabilidella revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisionecontabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per idanni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confrontidella società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzidanneggiati".
Il nuovo t.u. Non ha tenuto conto del disposto dell'art. 23 della direttiva,questa disposizione ha eletto quale criterio di valutazione delcomportamento del revisore lo standard della diligenza professionale, mentrel'art. 164, facendo rinvio all'articolo 2407, c.1, cod.civ., assume astandard la diligenza del mandatario, che secondo l'art. 1710 è quella delbuon padre di famiglia. Si tratta di un regime di favore ancora piùalleviato dagli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza secondo iquali l'osservanza dei principi contabili, redatti dalle stesse società direvisione, può essere considerata un comportamento in sé per sé corretto.
76
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
L'art. 12 del d.p.r. 316/1975 ha aggiunto ulteriori problemi applicativi,per l'improprietà dei termini usati si segnala che la disposizione nonprecisa se la responsabilità operi solo in caso di revisione legale o ancheper la revisione volontaria, non precisa se l'attività di revisione debbaconsiderarsi attività intellettuale o un servizio, né della responsabilitàper fatto illecito dei lidi semplicemente dalla colpa (cioè dalla violazionedella diligenza del buon padre di famiglia) o, versandosi in materia diresponsabilità extra contrattuale si possa far capo alla responsabilitàoggettiva; e inoltre che i soggetti ivi considerati (c.d. Responsabili e idipendenti) siano responsabili in solido solo per dolo o per colpa grave oper colpa pura e semplice.
In sede comunitaria l'attività della società di revisione, come quella diqualsiasi società che svolge attività intellettuale, è considerata unservizio, nel diritto interno si può fare riferimento al criterio dellaresponsabilità oggettiva, in ogni caso non si potrà valutare ilcomportamento della società di revisione solo su una base della diligenzaordinaria, tale criterio riguarda il rapporto negoziale istituito sulla basedi revisione volontaria, ma non incide sui criteri di imputazione dellaresponsabilità per fatto illecito della società di revisione, al dolo e allacolpa dovrà far riferimento per i c.d. Responsabili e che i dipendentitenuti in solido con la società di revisione.
Sulla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale del revisore,i giudici distinguono la responsabilità contrattuale del revisore neiconfronti della società assoggettata a revisione, dalla responsabilitàextracontrattuale nei confronti dei terzi estranei al rapporto negoziale; ehanno ritenuta la sussistenza della responsabilità della società direvisione che abbia cagionato un danno a terzi in conseguenza del negligenterilascio di una redazione di certificazioni di bilancio quando la cattivainformazione si ponga quale condicio sine qua non dell'altrui lesionepatrimoniale.
Caso di specie
I giudici di Torino avevano accertato che la società di revisione non aveva adempiuto diligentemente alproprio compito, rilasciando la certificazione pur avendo rilevato gravi irregolarità e non informandodi esse gli organi competenti; l'azione era stata proposta dal commissario della liquidazione coattaamministrativa di una società fiduciaria. La questione collegata con la responsabilità da prospetto: lasocietà di revisione aveva rilevato la mancata comunicazione ai fiducianti, come richiesto dal prospetto,della individuazione e della tipologia delle cessioni di credito pro soluto relative ad operazioni disollecitazione del pubblico risparmio, omettendo nel contempo di accertare in concreto l'inadempienza,e di attivarsi, indirettamente, tramite il collegio sindacale è direttamente per far cessare, mediantel'intervento della Consob, il comportamento abusivo della società fiduciaria a danno dei risparmiatori.
f) Responsabilità dei soggetti abilitati allo svolgimento dei servizi diinvestimento
77
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Il t.u. sui mercati finanziari porta 2 disposizioni in materia diresponsabilità per i danni dei risentiti dai clienti o da terzi nellosvolgimento di servizi di investimento:
1. art. 23, c.6, sui contratti "nei giudizi di risarcimento dei dannicagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e diquelli accessori, spetta ai sogg. Abilitati l'onere della prova di averagito con la specifica diligenza richiesta";
2. art. 31, c.3, sui promotori finanziari " il soggetto abilitato checonferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzidal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti aresponsabilità accertata in sede penale".
Entrambe le disposizioni sono riconducibili alla direttiva 93/22/CEE.
Quanto alla disciplina della responsabilità delle imprese di investimento,non si precisa se si tratti di responsabilità contrattuale oextracontrattuale.La disposizione (art.23) prevede solo l'inversionedell'onere della prova, quanto allo standard applicabile si fa riferimentoalla diligenza specifica richiesta, poiché l'art. 21 non precisa il grado didiligenza richiesta, menzionando la diligenza insieme con la correttezza ela trasparenza, si può precisare che le diligenze richieste quellaprofessionale, non la semplice diligenza ordinaria, ma con riguarda laresponsabilità del fatto illecito si può teorizzare la responsabilitàoggettiva dell'impresa.
Allo stesso modo per l'art.31, c.6, che proprio perché non dice nulla conriguardo ai criteri di imputazione della responsabilità, lascia intendereche le imprese di investimento rispondono in via oggettiva di dannirisentiti dai clienti ad opera dei promotori finanziari incaricati; è utilela precisazione con cui si stabilisce che la responsabilità solidalesussiste anche per i fatti penalmente rilevanti, ciò a evitarel'irresponsabilità della impresa per dolo del dipendente o dell'incaricato.
g) Responsabilità da annunci pubblicitari e da prospetto
queste fattispecie di responsabilità sono previste esplicitamente dal t.u.sui mercati finanziari, ma possono essere anche ricostruite sulla base dellaviolazione di disposizioni che prevedano determinati comportamenti nonosservati dai soggetti regolamentati e quindi atti a cagionare danni aterzi. In particolare le disposizioni che vengono in considerazione sonogli:
artt. 101 (sugli annunci pubblicitari), 94 (sugli obblighi degli offerenti)contenuti sempre nel t.u. nell'ambito della disciplina della sollecitazioneall'investimento. Queste disposizioni sono collegate con il dispostodell'art. 143, c.1, in ordine alla inidoneità delle informazioni diffuse nelcorso della sollecitazione, implicando la responsabilità del committente edei rappresentanti delle associazioni degli azionisti, e c.2, secondo il
78
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
quale l'intermediario è responsabile della completezza delle informazioni;il c.3, inverte l'onere della prova, che consiste nel dimostrare di averagito con la diligenza richiesta.
In giurisprudenza (riguardo alla natura della responsabilità da prospetto lanatura della responsabilità da annunci pubblicitari illegali o ingannevoli,al nesso causale e al danno risarcibile) si è formato un orientamentoarticolato. Si è precisato che la società fiduciaria incaricata di emetterecertificati rappresentativi di quote s.r.l. Di cui disponga fiduciariamente,deve predisporre un prospetto informativo che rifletta l'organizzazione, lasituazione economica e finanziaria e l'evoluzione dell'attività fiduciariastessa, destinatari del prospetto informativo è il pubblico deirisparmiatori e non la Consob; i poteri di controllo della commissione sulprospetto non si limitano al riscontro della conformità della bozza diprospetto allo schema-tipo, ma riguardano la veridicità dei dati e dellenotizie forniti; l'approvazione del prospetto informativo da parte dellaConsob non esclude la responsabilità dei proponenti in ordine alla veritàdelle notizie contenute nel prospetto. In appello, la pronuncia è statariformata sul punto della legittimazione attiva, ritenendosi che prospettosia destinato solo alla Consob.
In un'altra vicenda si è precisato che l'intermediario bancario, incaricatodel collocamento di valori mobiliari presso il pubblico dei risparmiatori,risponde verso questi ultimi per le inesatte informazioni fornitesull'emittente dei titoli, a meno che provi che neppure una attentarevisione delle notizie trasmesse dall'emittente avrebbe potuto palesare ivizi del prospetto informativo. L'origine di questa responsabilità è
ritenuta nella lesione dell'affidamento suscitato dalla campagnapromozionale nei sottoscrittori circa la veridicità delle informazionicontenute nel prospetto, poi rivelatesi inveritiere; sia è qualificata comecolpa di
natura contrattuale attinente alla fase precontrattuale; il danno limitatoall'interesse negativo, si è detto consistere nella perdita del capitaleinvestito e nel lucro cessante, rappresentato dalla utilità chel'investitore avrebbe tratto da investimenti alternativi. La pronuncia èstata confermata l'appello, dove si è precisato che la responsabilità daprospetto ha natura precontrattuale e grava sugli emittenti, suisottoscrittori del prospetto e sulla banca che provvede al collocamento deivalori mobiliari.
h) Caso Parmalat
79
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Il caso Parmalat viene studiato come fenomeno per prevenire quanto piùpossibile i rischi degli investimenti finanziari. Con riguardo ai titolirelativi al gruppo Parmalat, i risparmiatori si possono distinguere inalmeno in 3 diverse categorie, a seconda della situazione in cui versavanoal momento del crack:
1. Coloro che avevano acquistato titoli Parmalat molto prima che sidiffondessero notizie sulle difficoltà economiche in cui cominciava atrovarsi il gruppo;
2. Coloro che hanno acquistato dopo la diffusione di queste notizie e chequindi hanno voluto speculare sul titolo;
3. Coloro che non hanno acquistato volontariamente, ma hanno trovato sulproprio conto l'acquisto di titoli Parmalat, in virtù di operazionieffettuate dalla banca o dalla società di investimenti di cui erano clienti.
Ciascuna di queste categorie ricevono tutela differenziata, a seconda che sipossa dimostrare il grado di conoscenza della situazione in cui versava iltitolo e l'intenzionalità del suo acquisto.A loro volta gli operatori finanziari hanno provveduto con a collocare ititoli Parmalat per tutto il periodo in cui sul titolo non si erano ancoradiffuse notizie allarmanti; qualche operatore però ha continuato adattaccare il titolo anche nel periodo successivo, acquistandolo per iclienti, previo loro ordine o senza ordine, perché la mediazione eravantaggiosa, o peggio, vendendo ai clienti titoli del proprio patrimonio,al fine di sottrarsi alla perdita di valore del titolo scaricandolo sulpatrimonio altrui. Anche per gli intermediari dunque occorre faredistinzioni in ordine alla loro responsabilità. Ciò per quanto riguarda ilrapporto tra il risparmiatore e l'intermediario.
Ovviamente vi sono rapporti che stanno a "monte" e a "valle" di questi. A<<monte>> sta il labirinto delle finanziarie di Collecchio, il sole 24 ore,ha pubblicato un organigramma del gruppo al momento del crollo finanziario,in cui campeggiano le società off shore. In collegamento con il gruppo sidevono poi segnalare le banche finanziatrici, italiane e straniere, dellequali si sta indagando il grado di colpevolezza della stabilità del gruppo,e le società di revisione che si sono succedute nel controllo delle societàdel gruppo.
A <<valle>> si collocano:
- le vicende giudiziarie di natura penale, a carico degli amministratori delgruppo, dei revisori e delle banche finanziatrici, in cui si sono costituiticome parte civile i risparmiatori danneggiati e le loro associazioni;- le vicende giudiziarie che riguardano il gruppo in sé, assoggettato ladisciplina del risanamento delle grandi imprese in crisi, affidata ad uncommissario straordinario;- il fallimento di alcune società operative del gruppo e l'insinuazione nelpassivo dei creditori;- la sorte dei dipendenti;
80
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
- la sorte dei titoli della nuova Parmalat, la società costituita comerisultato del risanamento del gruppo;- la responsabilità civile delle banche finanziatrici del gruppo, italiane estraniere;- l'eventuale responsabilità della Consob;- l'autorità amministrativa di vigilanza del mercato finanziario, per omessocontrollo dei bilanci e dei prospetti del gruppo;- la sorte dei procedimenti pendenti negli USA, trovarsi in forma di classaction, da parte degli investitori colà residenti;- la sorte delle altre società del gruppo sparse in altri continenti.
Commercio elettronico e Protezione del Consumatore
Direttiva 2000/31/CE sul Commercio elettronico
Campo d'applicazione: Essa riguarda in particolare i seguenti settori eattività on-line: giornali, banche dati, servizi finanziari, serviziprofessionali (di avvocati, medici, contabili, agenti immobiliari), serviziricreativi (ad esempio, video a richiesta), commercializzazione e pubblicitàdirette e servizi d'accesso a Internet. La direttiva si applica unicamenteai fornitori di servizi che abbiano sede nell'U.E. Tuttavia, per nonostacolare il commercio elettronico mondiale, la direttiva prestaparticolare attenzione ad evitare incompatibilità con l'evoluzione giuridicain atto in altre parti del mondo.
Applicazione della legislazione dello Stato dove è stabilito il prestatore - La direttiva definisceil luogo di stabilimento del prestatore come il luogo in cui un operatoreesercita effettivamente e a tempo indeterminato un'attività economicamediante un'installazione stabile. Tale norma del paese d'originecostituisce l'elemento fondamentale della direttiva poiché crea la chiarezzae la certezza del diritto necessarie per permettere ai prestatori diservizio di proporre i propri servizi in tutta l'Unione.
Principio dell'assenza di autorizzazione preventiva: La direttiva vieta agliStati membri di imporre ai servizi della società dell'informazione regimi diautorizzazione speciali che non si applicherebbero a servizi analoghiforniti con altri mezzi. Ad esempio, sarebbe contrario alla direttivaassoggettare l'apertura di un sito web ad un procedimento di autorizzazione.Un sito potrà essere però subordinato ad autorizzazione se l'attivitàcontemplata è un'attività regolamentata (ad esempio, servizi bancari efinanziari on-line)
Trasparenza: Gli Stati membri devono prevedere nella loro legislazione che iprestatori di servizi della società dell'informazione rendano facilmenteaccessibili in modo diretto e permanente ai loro destinatari * e alleautorità competenti le informazioni di base sulle loro attività: nome,indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di immatricolazione alregistro del commercio, titolo professionale e iscrizione ad associazioniprofessionali, numero della partita IVA.
81
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Comunicazioni commerciali e spamming: Le comunicazioni commerciali devonoessere chiaramente identificabili e inequivocabili (art. 6) in modo darafforzare la fiducia del consumatore e garantire pratiche commercialileali. Inoltre, le comunicazioni commerciali attraverso messaggi elettronicidevono essere chiaramente identificate fin dal momento in cui ildestinatario le riceve. Inoltre, gli Stati devono adottare i provvedimentinecessari per far sì che i prestatori che inviano per posta elettronicacomunicazioni commerciali non sollecitate consultino regolarmente erispettino i registri negativi ("opt out") * in cui possono iscriversi lepersone fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali.Tuttavia, la direttiva non vieta agli Stati membri di scegliere il sistemacosiddetto dell'"opt in * " .
Contratti on-line: La direttiva obbliga gli Stati membri a eliminarequalsiasi divieto o restrizione concernente l'utilizzazione dei contrattielettronici. Inoltre, essa garantisce la certezza del diritto imponendoalcuni obblighi d'informazione per la conclusione dei contratti elettronici.Tali disposizioni completano la direttiva del 1999 relativa alle firmeelettroniche.
Responsabilità degli intermediari: La questione della responsabilità degliintermediari, in particolare dei fornitori di "hosting", è fra le piùdelicate. Infatti, si tratta di stabilire in che misura tali intermediaritecnici possono esser ritenuti responsabili dei contenuti illeciti e dannosipubblicati sulla loro rete o sul loro server.
Per eliminare le incertezze giuridiche esistenti, la direttiva esonera daqualsiasi responsabilità gli intermediari che hanno un ruolo passivo, nellamisura in cui provvedono semplicemente al "trasporto" di informazioniprovenienti da terzi. Inoltre, essa limita la responsabilità dei prestatoridi servizi per altre attività intermediarie come l'archiviazione delleinformazioni. In altri termini, i fornitori d'infrastruttura e i fornitorid'accesso non potranno essere ritenuti responsabili delle informazionitrasmesse, purché non diano origine alla trasmissione e non selezionino ildestinatario della trasmissione o le informazioni trasmesse.
Tuttavia, la direttiva precisa che gli Stati membri possono stabilire chegli operatori del sito Web siano tenuti ad informare non appena possibile leautorità pubbliche competenti di presunte attività illecite esercitate dautenti Internet. Allo stesso modo, gli Stati membri possono prevederel'obbligo per i fornitori di "hosting" di comunicare alle autoritàcompetenti le informazioni che permettono di identificare i proprietaridelle pagine ospitate.
Applicazione della direttiva: Gli Stati membri e la Commissione incoraggianol'elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali,di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all'efficaceapplicazione della direttiva. Tuttavia, la Commissione garantirà laconformità di questi codici ai principi del diritto comunitario e la lorotrasparenza a livello comunitario. Le associazioni dei consumatori devono
82
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
essere coinvolte nel processo di elaborazione e di applicazione dei codicidi condotta (art. 16).
Gli Stati membri provvedono affinché la loro legislazione consenta, in casodi dissenso tra prestatore e destinatario di un servizio della societàdell'informazione, l'uso efficace, anche per vie elettroniche adeguate,di strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie. Gli Statimembri provvedono affinché gli organi di composizione extragiudiziale dellecontroversie applichino, nel rispetto del diritto comunitario, principi diindipendenza, di trasparenza, del contraddittorio, di efficacia delprocedimento, di legalità della decisione, di libertà per le parti e dirappresentanza (art. 17).
Gli Stati membri provvedono a che le attività dei servizi della societàdell'informazione possano essere oggetto di ricorsi giurisdizionaliefficaci che consentano di prendere provvedimenti atti a porre fine alleviolazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa (art. 18).
Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti dispongano diadeguati poteri di controllo e di indagine ai fini dell'efficaceapplicazione della direttiva. Essi provvedono anche a che le rispettiveautorità collaborino con le autorità nazionali degli altri Stati membri. Atal fine essi designano un punto di contatto, di cui comunicano gli estremiagli altri Stati membri e alla Commissione (art. 19).
Deroghe
La direttiva prevede tre tipi di deroghe:
alcune attività sono escluse dal campo d'applicazione (allegato 1), comele attività notarili o di rappresentanza in giudizio;
l'articolo 3 (clausola del "paese d'origine") non si applica ad alcunisettori particolari (ad esempio per i diritti d'autore o le obbligazionicontrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori);
gli Stati membri possono prendere misure che limitano la liberacircolazione dei servizi provenienti da un altro Stato membro (deroghecaso per caso) adottate per motivi specifici (ad esempio inerenti allatutela dei minori, alla salute o alla protezione del consumatore).
Sul commercio elettronico il codice del consumo contiene solo una norma dirinvio all’art. 68.
Vendita a distanza di prodotti finanziari
Direttiva n. 2002/65/CE (relativa alla commercializzazione di servizi finanziari aiconsumatori) attuata con il D.lgs 190/2005.
Campo d'applicazione: La direttiva si applica ai servizi finanziari aldettaglio (i servizi bancari, d'assicurazione, di pagamento e diinvestimento, compresi i fondi pensione, negoziati a distanza (ad esempio
83
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
per telefono, fax o Internet), ossia mediante qualunque mezzo utile senza lafisica e simultanea presenza delle parti al contratto.
La direttiva e la sua disciplina di attuazione riguardano solo il talivisite al consumatore (dove non professionale) è il fornitore, cioè ilsoggetto viene a contatto telematico con il consumatore.Le disposizioni riguardano solo l'accordo iniziale di servizio vale a direl'accordo di base dal quale possono derivare operazioni distinte (ad es. sesi tratta di ordini, o altro atto collegato all'accordo di base si procederàsecondo quanto stabilito dalla disciplina attuale, dei regolamenti delleautorità indipendenti e della disciplina pattizia).
La disciplina non riguarda direttamente i contratti conclusi con iconsumatori, a differenza delle regole previste per i contratti a distanzain cui si dettano regole sulla conferma delle informazioni ricevute esull'esecuzione del contratto. Le uniche regole che incidono sul contratto trattano del recesso e dellemodalità di pagamento. Per colmare queste lacune si fa ricorso non tanto alla disciplina deicontratti a distanza ma piuttosto alla disciplina dell'e-commerce e aldiritto comune. La nuova normativa riguarda invece le informazioni chedevono essere trasmessi ai consumatori prima della conclusione del contrattoprima del consumatore sia vincolato anche da una semplice offerta.
Si tratta di informazioni riguardanti i fornitori, il servizio finanziario,il contratto medesimo, il ricorso (cioè ai mezzi di tutela stragiudiziale ealla utilizzazione del fondo di garanzia). Le informazioni devono esserefornite in modo chiaro e comprensibile in osservanza delle regole sullacorrettezza e buona fede nella fase precontrattuale e sulla protezione degliincapaci di agire e di minori.
In particolare:
- per il contratto = si prevede che il consumatore debba conoscerne inanticipo alcuni aspetti del contenuto, quali l'esistenza o meno deldiritto di recesso, la durata minima, la disdetta, le clausole penali,le modalità di recesso, la legge applicabile, lingua disponibile.Analoghe informazioni non essere fornite se si usa la telefoniavocale. La comunicazione può avvenire anche con modalità diverse dallaconsegna del testo scritto, ma il consumatore ha diritto a suarichiesta di ricevere con vicini contrattuali supporto cartaceo,sempre che ciò sia compatibile con il contratto concluso o con lanatura del servizio finanziario prestato. Queste informazioni sonodistinte dalle clausole contrattuali che devono essere comunicate alconsumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da uncontratto di istanza o da un'offerta.
- Il diritto di recesso = può essere esercitato entro 14 gg. :
a) dalla data di conclusione del contratto;
84
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizionicontrattuali e le informazioni sulle condizioni contrattuali, setale data è posteriore alla conclusione del contratto.
Durante il periodo in cui si può esercitare il diritto di ripensamentol'efficacia dei contratti è sospesa. Non sono consentiti i servizicomunicazione non richiesti.
Il pagamento dei servizi può avvenire o in concomitanza con l'esercizio deldiritto di recesso o se il recesso non è esercitato con i mezzi usuali(carte di credito e di debito) e usando la firma elettronica.
L'onere della prova riguardante l'adempimento degli obblighi di informazioneal consumatore, la prestazione del consenso alla conclusione del contratto,l'esecuzione del contratto, la responsabilità per l'inadempimento diobbligazioni derivanti dal contratto, grava sul fornitore. Le clausole diinversione o di modifica dell'onere della prova sono abusive, i dirittiriconosciuti ai consumatori del decreto sono irrinunciabili e ognipattuizione è affetta da nullità relativa a favore del consumatore. Leassociazioni consumatori hanno legittimazione ad agire per la tutela degliinteressi collettivi e possono fare reclamo per l'accertamento di violazionedelle disposizioni del decreto.
Nel caso in cui il fornitore ostacoli l'esercizio di recesso da parte delconsumatore, o non rimborsi le somme pagate e violi di regolesull'informazione precontrattuale in modo da alterare significativamente larappresentazione delle sue caratteristiche.Il testo riprende i contenuti della direttiva; si potrebbe osservare chetrattandosi di una disciplina diretta a tutelare gli consumatori, avrebbepotuto essere inserita nel codice del consumo; sarebbe stato utile precisareil momento nel quale il contratto si intende concluso o comunque inseriretra le informazioni obbligatorie anche questo punto, si sarebbe anche potutoprecisare meglio come funziona il sistema di reclami. È apprezzabile e sianoprecisate le conseguenze della omissione di informazioni che consistononella nullità del contratto. Non si intende tuttavia perché il recessoostacolato dal fornitore è un diritto del contraente anziché delconsumatore, né s'intende perché il testo faccia riferimento al codicecivile per la disciplina delle clausole vessatorie dal momento che questedisposizioni sono confluite nel codice del consumo.
Il codice delle assicurazioni
Nell'ambito del diritto assicurativo la disciplina è molto complessa, illegislatore comunitario ha tentato, con una serie di direttive, diliberalizzare il mercato, di semplificare, uniformare la disciplina ditutelare il cliente, quando, non essendo un professionista ma un consumatoreabbisogna di una particolare considerazione.L'approvazione del codice delle assicurazioni private era quindi moltaattesa, ma occorreva adeguare la disciplina, riformulato in modo cheematico, alla normativa europea. Il diritto assicurativo è per sua natura un
85
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
complesso di regole che dovrebbe essere compatibile con quelleinternazionalmente accreditate, ed è pur vero che le prassi costituisconouna fonte di diritto non scritta e flessibile, in cui si riflette il dirittomite. Ma è anche vero che ad es., la disciplina della riassicurazione èpressoché estranea al codice civile e alla legislazione speciale, così nelnuovo codice è limitata ad alcune disposizioni (artt. 57 ss). Eppure lariassicurazione è una tecnica di copertura così largamente praticata, chealcune compagnie e molte per alcuni rami assicurativi, ribaltano quasil'intero rischio assunto sulle imprese di riassicurazione. Altro puntorilevante, è la disciplina dell'oggetto sociale che la normativa vigente nonaveva considerato in dettaglio, così pure la disciplina delle clausole dellepolizze assicurative che potrebbero essere talmente limitative dei dirittidel cliente e irte di decadenze e di adempimenti, da rendere quasiimpossibile il pagamento dell'indennizzo. Per contro, il codice harappresentato l'occasione per dare attuazione alla direttiva sugliintermediari assicurativi, afferma la responsabilità solidale dell'impresaassicuratrice con i "produttori diretti" per i danni anche volontari da essiarrecati, prevede poi obblighi di informazione precontrattuale e regole dicomportamento. Ma tuttavia non precisa le conseguenze del loro inadempimentodal punto di vista civilistico, nessuna connessione è stata poi tentata conil codice del consumo.
Novità rilevanti
Disciplina del contratto: ad es. il contratto deve essere redatto in modochiaro ed esauriente (art. 166); se ne deduce che deve essere fatto in formascritta e che la sua redazione deve essere completa e intelligibile.Riguarda la completezza e l'intelligibilità si fa riferimento alla notainformativa (artt. 185 ss) si tratta di un documento di cui il cliente devedisporre prima della conclusione del contratto e unitamente alle condizionidi assicurazione, in modo da poter vagliare adeguatamente tutti gli aspettidell'opera economica (tale documento è stato utilizzato anche nell'ambitodella trasparenza bancaria). Anche in tale caso non sono state chiarite leconseguenze dell'inadempimento dell'assicuratore, non è pensabile comeproposto dall'ISVAP,che il rimedio sia quello della responsabilitàprecontrattuale.Trasparenza del contratto implica la correttezza dei comportamenti, ilcodice prevede opportune regole sulla prevenzione dei conflitti d'interesse,si tratta di disposizioni molto elastiche che non includono l'equità deirapporti né la pariteticità del trattamento dei clienti, ma in ogni casopongono questi ultimi al riparo da ogni pregiudizio che dal conflitto possaderivare.
Sul danno patrimoniale e sul danno biologico, sono riprese le regole giàvigenti, che rendono questa voce di danno indifferente al reddito prodotto,e si prevedono tabelle uniformi aggiornate annualmente sia per le lesioni isuperiori sia per quelle inferiori al 9%. Il fatto di consentire al giudicedi aumentare l'importo, nel primo caso fino al 30% e nel secondo fino a 1/5della somma liquidata, dovrebbe suggerire ai danneggiati di mediare prima diaccettare le somme loro offerte.
86
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Capitolo nono
La sicurezza dei prodotti, i difetti e la responsabilità del fabbricante
Nella società moderna è fenomeno consueto il propagarsi di danni connessicon il processo produttivo. In ogni ordinamento, prima che fosserointrodotte leggi speciali o regole ad hoc, la circolazione di prodottidifettosi è stata assoggettata alla disciplina prevista in materia divendita o di responsabilità civile dai codici e dalle regole consolidatedalla tradizione.
Oggi la garanzia è regolata dal D.lgs 24/2002, ora artt. 128 ss. Cc.
Responsabilità extracontrattuale. Il principio della colpa
La circolazione di prodotti difettosi provoca danni che possono essereconsiderati presupposti di un atto illecito. Il danno risentito delconsumatore è causato, nell'ipotesi più frequenti, dalla fabbricazionenegligente, un prodotto alimentare sigillato contiene corpi estranei, uncapo di vestiario che è facilmente infiammabile, una macchina tagliacarteche non ha schermi di protezione per gli operai, sono esempi di prodotti dinegligente costruzione o progettazione. In tutte le ipotesi considerate e inmolte altre, è possibile identificare dunque una colpa a carico delproduttore.
Danno, nesso di causalità, colpa sono gli elementi fondamentali dell'attoillecito extracontrattuale. Le norme applicabili sono quindi quelle diresponsabilità civile e in particolare la clausola generale dell'art. 2043del cod. civ.
Il principio "nessuna responsabilità senza colpa", opera anche in materia diresponsabilità del produttore; l'esperienza italiana sintomaticadell'arretratezza dei modelli codicistici e della giurisprudenza, ha sempreseguito il principio nessuna responsabilità senza colpa. In un primo tempo,in verità, si è tentato di escludere la responsabilità diretta delproduttore, successivamente la colpa del produttore comporta responsabilitàaquiliana a suo carico. Inoltre si risale alla responsabilità delfabbricante anche in un caso nel quale non vi erano prove evidenti della suacolpa: una bottiglietta di coca cola estratta da un refrigeratore esplodenon appena posata sul banco di mescita, ferendo la venditrice; l'improvvisae insolita esplosione viene considerata circostanza sufficiente a fondareuna colpa dell'imbottigliatore per aver posto in circolazione un contenitoredifettoso.
Particolare rilievo hanno della suprema corte in materia di danni daprodotti:
87
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
1. La prima ricorrere ancora al principio di responsabilità per colpa -inassenza di prove evidenti della negligenza del fabbricante-ritiene che laresponsabilità che porta egualmente affermare quando, da un'attentavalutazione delle circostanze, la colpa può essere presunta.
2. La seconda ritiene che la responsabilità oggettiva del conducentedell'autoveicolo per danni dovuti a vizi di costruzione non esclude laresponsabilità per colpa del costruttore.
Nozione di difetto = intesa non solo nell'accezione di meccanica assenza diparti o ingredienti necessari, o di presenza di corpi estranei del prodotto,o di ridotto uso del prodotto, ma anche nel senso di mancanza di adeguateinformazioni nell'uso.
Confini della responsabilità = tutti i soggetti danneggiati dal prodottodevono essere risarciti, ma le loro richieste non possono rivolgersi agliintermediari o ai rivenditori, i quali di solito non hanno colpa nellaproduzione del danno. Quanto ai soggetti che sono legittimati passivi delrisarcimento, la dottrina ritiene sia possibile affermare la responsabilitàsolidale del produttore di singole parti del prodotto e del produttore delprodotto finale.
Nell'ambito della prova, ci si chiede se occorre dare la prova dellanegligenza del fabbricante, il linea astratta, la risposta deve esserepositiva; sì che nell'eventualità che il consumatore non riesca ad addurreprove convincenti, non sarà possibile affermare la responsabilitàdell'impresa.
Importante è segnalare il fatto che il concorso di colpa del danneggiato nonesclude, a priori, la responsabilità dell'impresa: la presenza di un difettodel prodotto è sempre un evento che incide sul processo causale del danno.In alcuni casi, tuttavia la giurisprudenza ha deciso in senso contrario,escludendo la responsabilità del produttore in presenza di atti negligentidel danneggiato.
Il rischio d'impresa
La tesi che fa riferimento all’art. 2043 cod. civ. al fine di fondare unaresponsabilità per colpa del fabbricante è certamente la più fedele al datoletterale del codice civile e ha incontrato non solo il favore dellagiurisprudenza ma anche quello di parte della dottrina.
Ad ogni costruzione dottrinale che elegga ha proprio fondamento il principiodella responsabilità per colpa (anche presunta) nella individuazione delledirettive da applicarsi alle fattispecie di danni derivanti dall'eserciziodi attività imprenditoriali si è infatti obiettato che:
a) ogni sistema fondato sulla colpa è viziato da veri e propripregiudizi di natura storica e di natura ideologica;
88
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
b) il ricorso a tecniche di presunta colpa è frutto diun'anacronistica fictio iuris, e comporta un errore logico nellainterpretazione delle norme giuridiche;
c) il sistema fondato sulla colpa esclude ogni tentativo diassicurare una razionale distribuzione del rischio;
d) il sistema fondato sulla colpa ha un costo sociale molto piùalto del costo dei sistemi fondati su altri criteri diimputazione, in particolare dei sistemi informati alprincipio del rischio d'impresa (responsabilità oggettiva).
Il consolidarsi di regole di responsabilità svincolato dal presuppostosoggettivo della colpa e l'imputazione al produttore di responsabilità(oggettiva) per rischio d'impresa si collocano nell'ambito dellaresponsabilità civile.
È corrente opinione, che sui principi di responsabilità oggettiva sifondi l’art. 2049 cod. civ., in tema di responsabilità dei padroni ecommittenti per danni cagionati dai dipendenti e preposti; e che acriteri di natura oggettiva sia ispirata alla responsabilitàdell'esercente di attività pericolose ( art. 2050), del custode dicose e di animali (artt. 2051, 2052), dei proprietario di edifici(art. 2053) e di autoveicoli (art. 2054).
In materia di circolazione di prodotti difettosi, alcuni autoriritengono che la responsabilità oggettiva debba colpire solo leimprese di grandi dimensioni, mentre per quelli di ridotte dimensioni,per le imprese artigianali e così via siano più adeguati i criterifondati sulla colpa. Altri propongono di applicare il criterio delrischio d'impresa solo nell'ipotesi di danni derivati da difetti diproduzione o per omessa informazione, ma non nei casi di difetti diprogettazione, perché riscontrandosi questi tipi di difetti, non in unarticolo isolato ma in tutti gli articoli della serie, l'onereaccollato all'impresa risulterebbe troppo gravoso. Altri infineescludono l'operatività del criterio della colpa e propongonoun'applicazione indifferenziata del criterio del rischio d'impresa,ricavandolo dall'art. 2049 che non disciplina solo le attività svoltedai dipendenti, ma può inteso in un senso più generale, come regola diresponsabilità di tutte le attività svolte in forma imprenditoriale.
Nell'esperienza statunitense la definitiva affermazione della colpadel fabbricante è stata fermata nel caso Greenman, dove si afferma cheil "produttore è oggettivamente responsabile, se diffondendo unprodotto sul mercato, con la consapevolezza che esso sarà usato senzaalcun controllo preventivo, il prodotto risulta pericoloso per lasalute umana.
89
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
In realtà, il ricorso alla disciplina contrattuale, la costruzione digaranzie implicite al contratto di vendita, l'affermazione dellaresponsabilità oggettiva del venditore, sono tecniche impiegate dallecorti per pervenire a un risultato preciso: l'imputazione oggettivadel rischio d'impresa, a vantaggio del consumatore.
L'orientamento delle Corti americane viene registrato nella raccoltadei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità per attoillecito. Il secondo Restatement of Torts, dal 1965 reca un paragrafoaggiunto la sezione 402 A, nel quale trova ampio spazio la regola diresponsabilità oggettiva dell'impresa per la fabbricazione deiprodotti difettosi:
1. Chi vende un prodotto in condizioni difettose e pericolose inmodo irragionevole per l'utente o il consumatore, o per le coseche a loro appartengono, è responsabile del danno fisico in talmodo cagionato al consumatore o all'utente o alle loro cose, se:
a) il venditore svolge attività di vendita di quel prodotto,
b) e ci si può aspettare che il loro prodotto pervenga all'utente oal consumatore nelle stesse condizioni nelle quali è statovenduto.
2. Le regole di cui al comma 1 si applica anche se:
a) il venditore ha esercitato tutta la diligenza possibile nellafabbricazione e nella vendita del prodotto,
b) l'utente o il consumatore non hanno acquistato direttamente da onon hanno instaurato rapporti contrattuali diretti con ilvenditore.
Questa linea di tendenza è stata accolta con favore dalla dottrina,anche se non mancate critiche ai risarcimenti eccessivamente generosi.
La direttiva sulla responsabilità del produttore e la suaattuazione
Direttiva n. 374/1985, si apre con il principi generale in virtù del quale"il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suoprodotto".
Per prodotto si intende "ogni bene mobile", ivi compresa l'elettricità aesclusione dei prodotti agricoli naturali;
90
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Per produttore si intende "il fabbricante di un prodotto finito, ilproduttore di una materia prima o il fabbricante della materia componente "nonché "ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segnodistintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso ".
Quando si applica il principio generale della responsabilità del produttore?
La direttiva introduce una vera e propria responsabilità oggettiva, perchéprescinde dall'accertamento della colpa; il danneggiato deve provare ildanno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno. L'attenzionesi concentra quindi non sul criterio di imputazione della responsabilità,che anche se non menzionato può identificarsi nel rischio o se si preferiscenella emissione medesima del prodotto nel mercato, ma piuttosto sullanozione di difetto del prodotto, che è difettoso quando non offre lasicurezza che si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte lecircostanze (quelle relative la presentazione del prodotto, l'uso cui ilprodotto è ragionevolmente destinato, il momento della messa incircolazione).
Regola generale di responsabilità oggettiva del produttore
Il provvedimento di attuazione della direttiva è stato incorporato nelcodice del consumo agli artt. 114 ss.Si apre con un’enunciazione di carattere generale che recita: “ il produttore èresponsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” .
La norma produce una vera e propria ipotesi tipica di responsabilità senzacolpa, in quanto circoscrive nell'ambito della responsabilità in terminisoggettivi alla figura del produttore, in termini oggettivi ai soli danniderivanti da difetti dei prodotti.
La norma è formulata con l'impiego di espressioni che seguono il tenoredegli artt. 2048, 2049, 2052, 2053 cod. civ., a differenza di quantoprevisto dall'art. 2048 non c'è una semplice presenza di colpa; a differenzadi quanto previsto negli artt. 2052, 2053, non si fa riferimento al casofortuito come causa di esclusione della responsabilità. La colpa delproduttore non è mai menzionata, e le prove di aver diligentemente fabbricadel prodotto, o di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nonsono ammesse, ed è quindi chiaro che si è in presenza di una responsabilitàoggettiva.
Rimane aperta la questione della sopravvivenza del fortuito: ma se il dannocagionato da difetti derivanti da causa ignota, il produttore non può inalcun modo esonerarsi da responsabilità. Se il danno invece è causato da uncaso fortuito, tale circostanza deve considerarsi fattore esonerativo dellaresponsabilità del produttore, sempre che si tratti di un evento che dadietro il rischio sotto dall'imprenditore.
91
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
A questa concezione sembra ora allinearsi la stessa suprema corte.
L'onere della prova
Art. 120 del codice del consumo dispone:
1. Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causaletra difetto e danno;2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere laresponsabilità, ai fini dell'esclusione della responsabilità è sufficientedimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difettonon esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo incircolazione;3. Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un difetto delprodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnicasiano anticipate dal produttore.
Esclusione della responsabilità
Il testo italiano, all'art. 116 riprende quasi letteralmente il dispostodella direttiva.Il c.1, lett. e, ove dopo la esclusione della responsabilitàdel produttore per il c.d. rischio dello sviluppo, precisava: "se ilproduttore, dopo la messa in circolo del prodotto, abbia conosciuto oavrebbe dovuto conoscere la sua pericolosità, è responsabile secondo lenorme del codice civile e se omette di adottare le misure idonee a evitareil danno, quali informazioni del pubblico, l'offerta del richiamo perrevisione o l'offerta del ritiro del prodotto". Si ignorano le ragioni dellasoppressione di questo comma del testo approvato.
La definizione di prodotto
L'art. 115 Cc definisce il prodotto:
1. Prodotto, è ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro benemobile o immobile;2. Si considera prodotto anche l'elettricità.
Rispetto al testo della direttiva, si è aggiunta la definizione delprodotto, si è esclusa invece l'applicazione della direttiva ai prodottiagricoli del suolo e a quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia;occorre precisare che la direttiva lasciava liberi gli Stati membri diincludere anche queste fattispecie.
La definizione di produttore
Art. 103 enuncia le definizioni di produttore:
1. Produttore è il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità oqualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sulprodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo ocolui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se
92
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
quest'ultimo non è stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto, glialtri operatori professionali della catena di commercializzazione nellamisura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche disicurezza dei prodotti;
2. È distributore qualsiasi operatore professionale della catena dicommercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche disicurezza dei prodotti;
3. Art. 116 dispone che sia sottoposto alla stessa responsabilità delproduttore, il fornitore che abbia distribuito il prodotto omettendo dicomunicare al danneggiato l'identità del produttore.
La definizione di difetto
Art. 117 enuncia i criteri con i quali identificare il prodotto difettoso.Si considerano ipotesi più frequenti di responsabilità: l'errataprogettazione, l'errata fabbricazione e l'errata confezione del prodotto;anche le omissioni o gli errori dell'informazione costituiscono fondamentodi responsabilità oggettiva del fabbricante e, ove necessario,dell'importatore e degli altri soggetti considerati responsabili.
Intervento di un terzo e colpa del danneggiato
L'intervento del terzo non esclude la responsabilità del produttore (art. 8c.1), la colpa concorrente danneggiato può comportare la riduzione o lasoppressione della responsabilità del produttore (art.8 c.2).
Il testo italiano non riproduce il testo dell'art. 8, c.1, trattandosi di unprincipio ovvio è costantemente applicato in giurisprudenza, quest'ultimatende a equiparare l'intervento del terzo al caso fortuito, e quindi aesonerare il danneggiante. Tale principio potrà convincere il giudice dellaopportunità di affermare la responsabilità del produttore anche se vi siaintervento del terzo; si tratterà di accertare, secondo le circostanze, inche misura tale intervento abbia inciso sul processo causale del danno.
Prescrizione, decadenza, requisiti di proponibilità dell'azione dirisarcimento del danno
Le regole previste nel testo italiano non comporta particolari novità èstata quella della direttiva. Una sola annotazione vale la pena di fare:l'introduzione nel decreto italiano del requisito di proponibilitàdell'azione per il danno a cose, e il fatto che non si è previsto unmassimale per i danni da difetti di serie. La giurisprudenza esclude ilrisarcimento del danno morale, posto che la responsabilità prevista deld.p.r. 224/1988 ha natura sostanzialmente obiettiva, il produttore che siaritenuto responsabile ai sensi di tale normativa non può essere condannatoal risarcimento del danno morale.
La giurisprudenza
93
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
A differenza di quanto accaduto in altri paesi dell'U.E., la giurisprudenzain materia di responsabilità del fabbricante nel primo decennio diapplicazione del d.p.r. 224/1988 non è stata copiosa, anzi le pronunce sicontano in un numero esiguo.
In ordine agli aspetti processuali, alla Corte di Cassazione ha precisatoche la domanda diretta a far valere la responsabilità aquiliana delproduttore per i danni conseguenti ai difetti di costruzione della cosa èfondata su presupposti diversi da quelli dell'azione di rivalsa rivolta alcostruttore chiamato a rispondere dei vizi dell'opera eseguita con materialedifettoso contro il fornitore del materiale e pertanto non può essereproposta per la prima volta in appello.
L'onere della prova che grava sul produttore in ordine alla messa incommercio di un prodotto esente da difetti è assolto quando sia provata talecircostanza, sicché il produttore non risponde del danno risentito dallavittima se questa non sia in grado di provare l'esistenza del difettosuccessivamente alla sua messa in commercio.
Sulla destinazione prevedibile del prodotto all'uso, una sentenza delTribunale di Monza ha precisato che il fabbricante di una mountain-bike èresponsabile del danno provocato all'utente dalla rottura della forcella edal distacco di una ruota mentre l'utente percorreva un sentiero dicampagna. Quando tuttavia l'uso non sia prevedibile da parte delfabbricante, questi è esente da responsabilità: la corte di cassazione hacosì statuito a proposito di un'altalena collocata nei giardini comunali,sulla quale era salito minore, anziché prendere posto sul sedile il minoreera salito sul bracciolo, perdendo l'equilibrio e amputandosi un pollice.
Il difetto può riguardare anche le modalità di fabbricazione del bene e chesiano casualmente collegati con il danno derivante dal suo contenitore,sicché è stata affermata la responsabilità del produttore di una bottiglia
di succo il cui atto si era improvvisamente staccato colpendo ilconsumatore, per effetto della fermentazione del liquido nonsufficientemente pastorizzato.
In un caso nel quale aveva trovato la morte per ustioni una neonata perchéla coperta termica, non provvista di dispositivo termostatico, la cassazionepenale ha sottolineato che proprio l'assenza di normativa ad hoc, dallaquale deriva l'obbligo del fabbricante di inserire tale dispositivo,implicava il dispiego di maggiori cautele e attenzione da parte delfabbricante.
Sulla responsabilità solidale del produttore di parti staccate e delvenditore che le abbia assemblate si registra una pronuncia del tribunale diMilano, ciò perché il prodotto non presentava le necessarie condizioni disicurezza e perché il montaggio avrebbe dovuto essere eseguito a regolad'arte.
94
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Qualche incertezza si riscontra sul coordinamento tra disciplina dellegaranzie contrattuali e disciplina della responsabilità civile. In un casoin cui un trattore aveva causato danni al conducente, il tribunale di Pesaroha escluso la responsabilità extracontrattuale del fabbricante, e ha ammessola responsabilità contrattuale del venditore-concessionario, ma solo per idifetti del veicolo.
Il settore nel quale si registra il maggior numero di pronunce concernel'esercizio di attività pericolose; si tratta ad es. dello scoppio dibombole a gas, fattispecie ben nota e frequente; a questo proposito lasuprema corte ha precisato che nell'ipotesi in cui non sia fornita la provadella causa dello scoppio, possono operare cumulativamente la presunzione diresponsabilità a carico del produttore-distributore, quale esercenteattività pericolosa, e quella a carico dell'utente, quale custode,riferendosi a due omissioni differenti.
Problemi attuali
Uno dei problemi più spinosi riguarda il rischio dello sviluppo, cioè laproduzione e la distribuzione di beni ormai obsoleti rispetto ai nuovitraguardi della scienza e della tecnica.
La Corte di giustizia ha precisato che per potersi liberare dallaresponsabilità, il produttore di un prodotto difettoso deve dimostrare chelo stato oggettivo delle conoscenze tecniche e scientifiche al momento dellamessa in commercio del prodotto, non consentiva di scoprire i difetti diquest'ultimo.
La Suprema Corte ha precisato che è da ritenere esercente attivitàpericolosa, colui che produce una sostanza potenzialmente lesiva dautilizzare per comporre un farmaco destinato ad essere ineattatonell'organismo umano, pertanto ai sensi dell'articolo 2055 del cod. civ.egli è responsabile in solido con il produttore finale dei danni derivantidall'uso del medicinale, salvo che e provi di aver impiegato ogni cura emisura secondo le conoscenze tecniche e scientifiche esistenti, atte aimpedirlo.
Altro esempio emblematico è dato dalla responsabilità del fabbricante diprodotti da fumo, cui opera il principe di accettazione del rischio in baseal quale il consumatore che non può ignorare il danno derivante fumo etuttavia si accolla volontariamente il rischio, non può chiedere ilrisarcimento. Tuttavia sono in corso altri procedimenti che potrebbero avereesito diverso, ciò perché le case produttrici di prodotti da fumo nonavrebbero informato i consumatori dei risultati di ricerche da essecommissionati concernenti sia l'assuefazioni al prodotto, sia la suanocività effettiva.
Monitoraggio della Commissione europea e le modificazioni alladirettiva.
95
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
La direttiva n. 85/374/CEE aveva realizzato un'armonizzazione solo parziale,una prima relazione è stata presentata nel 1995, dove era stata posta inluce il necessario adeguamento progressivo degli ordinamenti alle nuoveregole e la scarna giurisprudenza che nei primi anni di applicazione si eravenuta formando in materia.
Il Parlamento europeo ha approvato la modificazione direttiva, a seguitodell'epidemia della mucca pazza, in base alla quale prodotti agricoli nontrasformati e prodotti della caccia sono stati esclusi nell'area dellaresponsabilità del produttore.
Nel luglio del 1999 la Commissione ha pubblicato un libro verde sullaresponsabilità civile per danno da prodotti difettosi per accertare se sidovessero introdurre ulteriori modificazioni.
In attuazione della direttiva 99/34/CE, il d.lgs. 25/2001 ha modificato ladisciplina del d.p.r. 224/1988 sopprimendo l'esenzione dei prodottiagricoli.
La corte di giustizia europea ha affrontato il problema dell'attuazionedella direttiva 85/374/CEE con riguardo al rapporto tra le regole da essarecate e la disciplina preesistente negli ordinamenti nazionali, secondo lapronuncia, la disciplina prevista in sede comunitaria non può esserederogata per offrire al consumatore una tutela maggiore. La sentenza apparedel tutto arbitraria, dal momento che le direttive offrono una tutelaminimale, si attende pertanto di sapere se questa pronuncia sarà confermatada altre successive.
La sicurezza dei prodotti
La direttiva più recente 2001/95/CE, è stata attuata con d.lgs. 172/2004,ora incorporato nel Cc, agli artt. 102 ss.
Art. 103 Cc definisce prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che in condizionidi uso normali o ragionevolmente prevedibili, conclusa la durata e la messain servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcune rischiooppure presenti rischi minimi considerati accettabili nell'osservanza di unlivello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone infunzione in particolare dei seguenti elementi: caratteristiche del prodotto,il suo effetto su altri prodotti, la presentazione del prodotto, la suaetichettatura, la categoria di consumatori esposte ai rischi diutilizzazione, in particolare i minori e gli anziani. È prodotto pericolosoqualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro.
Art. 104 Cc il produttore deve informare il consumatore su tutti i datiutili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'usonormale o ragionevolmente prevedibile del prodotto e alla prevenzione deirischi. Il distributore deve agire con diligenza per contribuire a garantirel'immissione sul mercato di prodotti sicuri. L'uso dell'espressione implica
96
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
che al distributore si possa solo imputare una colpa, ma non unaresponsabilità oggettiva, salvo il caso in cui non sia identificabile ilproduttore.
Art. 105 Cc c'è una presunzione di sicurezza derivante dalla conformità delprodotto alla normativa comunitaria e nazionale, tale presunzione non esimeproduttore, il fornitore o il distributore dalle loro rispettiveresponsabilità.
Artt.107 ss. prevedono misure di controllo dell'Amministrazione e degliorgani comunitari per effettuare le verifiche, per acquisire leinformazioni, per vietare la distribuzione di prodotti pericolosi, perprevederne il ritiro dalla circolazione.
Art. 108 Cc consente agli interessati di partecipare alla fase delprocedimento amministrativo, agli accertamenti e di depositare memorie edocumenti. Oltre agli elementi di responsabilità civile, derivanti daldiritto comune, il codice del consumo prevede sanzioni di natura penale perla violazione di queste disposizioni.
La responsabilità del prestatore di servizi
Il progetto di direttiva sulla responsabilità del prestatore di servizipotenzialmenti dannosi per la salute umana, segue il modello della direttivasulla responsabilità del fabbricante per i prodotti difettosi. A differenzadi questo, il progetto risulta più articolato nelle regole definitorie,oltre a offrire la nozione di servizio (corrispondente a cura di prodotto) edi prestatore (corrispondente a cura di produttore e importatore, siaggiunge nella disciplina attrattiva quella di fornitore), dà pure lanozione di consumatore.
Definizioni:
- Consumatore: persona fisica che è destinataria o fornitrice di un servizio scopo eminentementeprivato (si sottolinea la destinazione delle direttiva alle persone fisicheproprio perché lo scopo di questa consiste nel tutelare la persona fisicadel consumatore pertanto deve trattarsi di consumo privato e non effettuatoa scopo commerciale).
Il rapporto produttore-consumatore è costituito da un contatto sociale, in quantonon vi è una relazione contrattuale diretta tra i due soggetti: ilconsumatore intreccia i suoi rapporti direttamente con l'intermediario.Nel caso dei servizi, l'utente invece ha un rapporto contrattuale direttocon l'erogatore del servizio: si ricorre perciò a una finzione e siconsidera anche un questo rapporto extracontrattuale. La soluzione è dinatura necessitata per il fatto che gli ordinamenti dei singoli stati membriprevedono, al di là della legislazione
97
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
speciale, figure assai diverse tra loro, quali gli obblighi di sicurezzaintegrativi del contratto, o il concorso di responsabilità contrattuale edextracontrattuale.
- Servizio: ricomprende ogni prestazione effettuata a titolo professionale onell'ambito dell'utenza pubblica, a titolo oneroso o gratuito, che non abbiaper oggetto diretto ed esclusivo la fabbricazione di beni mobili, iltrasferimento o la cessione di diritti reali o intellettuali e siarealizzata a beneficio di un consumatore. I servizi possono essere anchemateriali o immateriali. Non sono considerati servizi gli atti non idonei aprovocare un danno fisico al consumatore o ai suoi beni, i trasportiinternazionali e i servizi sanitari.Le esclusioni dell'area semantico-normativa di servizio sono dettate daragioni diverse: per esempio per la fabbricazione di beni mobili esiste giàuna direttiva riguardo, per il trasferimento o la cessione di diritti realie di diritti d'autore si tratta di settori che nei paesi comunitari hannogià una disciplina specifica; per i servizi sanitari perché implicanol'intervento su soggetti già affetti da malattie, anomalie o comunque giàcompromessi nella loro salute, mentre la direttiva progettata riguarda lelesioni che possono derivare da sinistri.
Sono invece ricompresi tutti servizi che si aggregano intorno all'appalto,al contratto d'opera, anche professionale, al trasporto non internazionale,al mandato, all'agenzia.
- Prestatore di servizio: è il fornitore che abbia sede all'interno dellaCEE, se esterno è considerato tale l'importatore del servizio. Ai soggettiche appartengono alla categoria di prestatore di servizi era dapprimaimputata la responsabilità oggettiva per il difetti di sicurezza delservizio prestato. Tale responsabilità era fondata sul rischio creato e sulprofitto che se ne trae. Si capovolgeva quindi il tradizionale criterio diimpostazione della responsabilità fondata sulla colpa nell'esercizio diprofessioni liberali e dei destini di. La responsabilità oggettiva non eraillimitata. Si trattava come nel caso della fabbricazione di prodotti, diuna responsabilità oggettiva attenuata; infatti il prestatore rispondeva deldifetto di sicurezza del servizio, intendendosi per tale la lesione dellalegittima aspettativa dell'utente in ordine alla salute, alla propriaintegrità fisica e alla integrità dei propri beni.
Per contro, il prestatore si poteva esonerare dimostrando l'intervento dicause non derivante dalla propria volontà (forza maggiore avente natura dicausa imprevedibile, irreversibile ed estranea) oppure che il servizio erastato prestato nell'osservanza delle leggi comunitarie o statuale aventenatura imperativa o di regole imperative emanate dall'Autoritàamministrativa.
Quanto all'onere della prova il danneggiato doveva dimostrare l'esistenzadel danno e il difetto di sicurezza del servizio, non era richiesta la provadel nesso di causalità, ma sono la dimostrazione dell'esistenza di elementisuscettibili di stabilire la verosimiglianza del nesso di causalità.
98
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
Il modello è stato successivamente modificato e si è attestato allapresunzione di colpa.
La responsabilità non può essere ridotta per l'intervento del terzo ma se viè concorso di colpa della vittima. Non è consentito ricorrere a limitazionio esclusioni convenzionali della responsabilità. Si tratta di norme cheriprendono la disciplina comunitaria della responsabilità del fabbricante. La prescrizione dell'azione si compie in 18 mesi.
Qualche novità ulteriore si registra nella definizione del danno, perchéoltre al danno fisico alla persona, si prevede il risarcimento del dannoalle cose, senza le limitazioni ammesse dalla direttiva sulla responsabilitàdel fabbricante; in più si considera risarcibile il danno morale, ignoratoda quella, e pure il c.d. danno finanziario e il lucro cessante collegaticon il danno fisico o alle cose. Non è risarcibile invece il mero dannoeconomico.
Ora diventa facile compiere il traslato dal servizio all'attività, quindiconsiderare assoggettabili alla disciplina solo le attività pericolose in sée non a qualsiasi attività di prestazioni di servizi potenzialmente dannosa.
Una grave lacuna si registra ove non si precisa che la normativa previstaper la sicurezza deve essere imperativa. Il progetto non è stata maiapprovato, ora alcune sue previsioni sono incluse nel progetto di direttivasui servizi generali in corso di approvazione.
Capitolo decimo
I rimedi e l’accesso alla giustizia
I rimedi
I rimedi di cui si può avvalere il consumatore:
in primo luogo, l'INFORMAZIONE, che può essere acquisita presso gli"sportelli dei consumatori" istituiti in molti comuni, presso leassociazioni dei consumatori e dei professionisti, le stesse imprese, nonchépresso i consulenti e gli avvocati specializzati in questo settore e pressole autorità amministrative indipendenti.
Nel settore del mercato finanziario si annoverano numerosi codicideontologici: il codice di autodisciplina dell'associazione bancariaitaliana, il codice di comportamento dell'associazione intermediarimobiliari, il codice deontologico di autodisciplina dei promotorifinanziari.
Accanto ai codici si devono considerare i protocolli d'intesa con cui leassociazioni di categoria di professionisti le associazioni dei consumatoriconcordano regole di comportamento, anche afferenti la conclusione èl'oggetto dei contratti di professionisti con i consumatori. Per quest'anno
99
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
particolare rilievo i contratti bancari e i contratti assicurativi.Importante ricordare inoltre le procedure di conciliazione.
In secondo luogo, il RECESSO, inteso come diritto di ripensamento opentimento, che deve avvenire nei termini stabiliti senza alcuna spesa openalità.
In terzo luogo, i RIMEDI TIPICI, relativi al risarcimento del danno,psicofisico, patrimoniale non patrimoniale.
La LEGITTIMAZIONE AD AGIRE, compete sia al consumatore sia alle associazionidi consumatori o di professionisti, e ad altri organismi, come le camere dicommercio. Le regole previste dalla legge generale sui diritti fondamentalidei consumatori (L. 281/1998), emendato dal d.lgs. 224/2001, e ora contenutenel Cc agli artt. 139 ss, dispongono che le associazioni inseritenell'elenco tenuto presso il ministero delle attività produttive, possanoagire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi al fine diinibire gli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori edegli utenti, per chiedere l'adozione delle misure donne a correggere oeliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, per far ordinarela pubblicazione del provvedimento giudiziale.
Accesso alla giustizia
La protezione del consumatore trova rilevanti ostacoli non solo nello strumentariogiuridico di matrice privatistica dei diversi settori del processo diproduzione e distribuzione della merce, ma anche in altri fattori di cuioccorre tener conto nella formulazione delle valutazioni complessive dellediverse esperienze. Tali fattori sono molteplici e di varia natura tra i piùrilevanti si possa indicare: l'ignoranza della legge, l'insufficienza deimeccanismi di gratuito patrocinio, l'estensione del rischio processuale, ifattori psicologici che inibiscono ai danneggiati il ricorso ai tribunali,la passività del giudice.
L'informazione e l'educazione del consumatore non consistono primieramentenell'educazione e nella informazione finalizzata alla scelta dei prodotti,ma piuttosto nell'acquisizione della consapevolezza dei propri diritti; iproblemi psicologici che agiscono come deterrente della richiesta di tutelada parte del consumatore presentano varie cause (scarsa fiducia nella legge,ignoranza della legge, sfiducia nella magistratura, modeste entità del dannosubito, convincimento erroneo di nulla poter pretendere dall'impresa, timoredi affrontare spese processuali con scarse probabilità di successo e cosìvia) e si possono superare solo mediante un'intensa azione educativa e conrimedi processuali ad hoc, la questione della passività dei giudicirichiederebbe poi un approfondito esame delle cause che inducono lamagistratura ad essere scarsamente sensibile ai problemi di tutela delconsumatore e delicatissima è poi la problematica dei rapporti tralitigiosità e ricchezza.
Tutte queste questioni si possono ricondurre a 3 fondamentali aspetti dellatutela processuale del consumatore:
100
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
1. Azioni di entità modesta, patrocinio gratuito o semi-gratuito eistituzione di sezioni speciali nei tribunali ordinari come punti diimmersione della problematica dell'accesso alla giustizia;
2. La tutela sostanziale degli interessi diffusi e gli strumenti processualiad hoc come nuovo fenomeno di protezione di interessi dei consumatori che edorbitano l'area degli interessi tradizionalmente protetti;
3. L'istituzione di organismi di natura amministrativa pubblica per latutela di interessi dei consumatori che si identificano con l'interessegenerale della collettività.
Organismi esistenti
Nei paesi della comunità si sono ampiamente discussi progetti di difesadegli interessi deboli e si sono attuati tali progetti creando organismi adhoc.
Ci si riferisce ad esempio:
a) alle procedure arbitrali che si stavano presso le camere di commercio;b) alle procedure espletate dalle associazioni di piccoli proprietari e diinquilini (es. ANIA);c) alla conciliazione per i danni agli autoveicoli e al ruolo che potrebbeassicurare l'ACI:d) all'uso delle procedure arbitrali per controversie minori tra clienti esocietà di assicurazione o istituti di credito;e) Al giurì di autodisciplina pubblicitaria;f) all'istituzione del giurì dell'informazione;g) alle iniziative della consulta nazionale degli utenti e consumatori conla confcommercio e la Telecom, per la soluzione arbitrale dellecontroversie;h) all'istituzione di procedure arbitrali tra utenti dell'informatica eproduttori di hardware e software;i) all'istituzione delle camere di conciliazione presso le corti d'appello,di cui esempio rilevante è quella istituita a Roma.
Resta alcuna autorità amministrative, quali la Consob e l'ISVAP, si sonoistituiti uffici ad hoc (denominati uffici reclami o uffici per gliesposti), a cui si possono rivolgere consumatori per esporre doglianzeconcernenti gli interessi che sono assoggettata al controllo di taliagenzie: per la Consob, le doglianze riguardano l'operato delle Sim e deipromotori finanziari, per l'ISVAP l'operato delle società di assicurazione edegli agenti di assicurazione.
Particolare rilevanza in questo contesto assume l'iniziativa promossadall'associazione bancaria italiana, la quale ha elaborato un regolamentodell'ufficio reclami degli enti creditizi e dell'Ombudsman bancario, in cuisi prevede che presso gli istituti creditizi aderenti alla proposta èistituito un ufficio reclami, a cui possa rivolgersi la clientela perqualunque questione derivanti da rapporti intrattenuti con l'entecreditizio, avente ad oggetto rilievi circa il modo in cui l'ente stesso
101
RIASSUNTO -Introduzione al diritto dei consumatori – Guido Alpa- Ed. Laterza – 2006
abbia gestito operazioni o servizi. Si prescrive che i reclami sono inviatiall'ente creditizio in forma scritta; il reclamo deve essere esaminato edevaso nei successivi 60 giorni e, ove accolto, l'ente deve indicare i tempientro i quali la vertenza sarà risolta. Qualora il cliente non siasoddisfatto dell'esito del reclamo si può rivolger all'ufficio prepostoaffinché la questione sia nuovamente delibata. Non possono fruire di taleprocedura di seconda istanza, i clienti che non rivestano lo status diconsumatori, cioè coloro che abbiano intrapreso
rapporti contrattuali con l'ente creditizio per ragioni inerentiall'esercizio della professione o di attività imprenditoriali.
L'Ombudsman è costituito dal presidente, nominato dal governatore dellaBanca d'Italia, da 2 membri nominati dal presidente dell'ABI, 1 membronominato dal presidente del consiglio nazionale forense e uno nominato dalpresidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
C'è poi la procedura conciliativa concertate tra l'ANIA e le associazionidei consumatori.
Si può anche ricorrere a veri e propri arbitri. Ma a questo propositooccorre verificare se una iniziativa di questo tipo sia compatibile con ladisciplina delle clausole abusive.
Sono in corso progetti più estensivi a cura dell'unione delle camere dicommercio, dell'ISDACI e dell'associazione italiana per l'arbitrato (AIA).
102