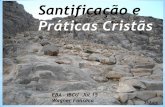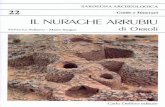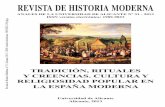La scriminante sfigurata. Il diritto soggettivo come fonte di incriminazione? Il caso dei reati...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La scriminante sfigurata. Il diritto soggettivo come fonte di incriminazione? Il caso dei reati...
79
RIV
ISTA
TR
IMES
TRA
LE D
I DIR
ITTO
PEN
ALE
DEL
L’EC
ON
OM
IA
12014
€ 42,00
9!BMMCF>:RSR
QOO!ISBN 978-88-13-34320-0
5!;EE;;F:SXV
STR!00149745
ANNO XXVII - N. 1 GENNAIO-MARZO 2014 ISSN 1121-1725
RIVISTA TRIMESTRALE DI
DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA
diretta daGIUSEPPE ZUCCALÀ
ALBERTO ALESSANDRI, PAOLO BERNASCONI Lugano, CHRISTIAN BERTEL Innsbruck, GUIDO CASAROLI, IVO CARACCIOLI, PHILIPPE CONTE Bordeaux,
MIREILLE DELMAS-MARTY Parigi, ANTONIO FIORELLA, GIOVANNI MARIA FLICK, GIOVANNI FLORA, FRANK HÖPFEL Vienna, ALESSIO LANZI, VINCENZO MILITELLO,
CARLO ENRICO PALIERO, ANTONIO PAGLIARO, PAOLO PATRONO, SALVATORE PROSDOCIMI, GIOVANNI SCHIAVANO, KLAUS TIEDEMANN Friburgo i. Br.
Tari
ffa
R.O
.C.:
Po
ste
Ital
iane
S.p
.a. -
Sp
ed. i
n ab
b. p
ost
. - D
.L. 3
53/2
003
(co
nv. i
n L.
27/
02/2
004
n° 4
6) a
rt. 1
, co
mm
a 1,
DC
B M
ilano
www.edicolaprofessionale.com/RTDPE
D O T T R I N A
A R T I C O L I
Federico Consulich
ricercatore di diritto penale nell’Università di Genova
LA SCRIMINANTE SFIGURATAIl diritto soggettivo come fonte di incriminazione?
Il caso dei reati fiscali
Sommario: 1. Ambientamento del discorso: il diritto penale da ultima a prima ratio. - 2. Per-cezione sociale e controllo penale della devianza in ambito fiscale. - 3. L’indeterminatez-za della scriminante come «volano» della criminalizzazione: il caso dell’abuso del diritto.- 3.1. In particolare: il caso paradigmatico dell’abuso del diritto in campo tributario. -3.2. Dalla semantica all’esegesi delle norme penali tributarie: elusione, evasione e abuso. -3.2.1. Il leading case della sentenza «Dolce & Gabbana» e la prevedibilità della normapenale tributaria. - 4. L’integrazione della norma penale tributaria. L’art. 37 bis d.p.r.600/1973 e l’analogia esplicita indotta nella fattispecie incriminatrice. - 4.1. La fonte del-l’analogia in malam partem: il parametro di valutazione implicito nell’art. 37 bis. - 5. Glieffetti interpretativi del canone dell’abuso del diritto: la trasmutazione del fatto tipicodel delitto di dichiarazione infedele. - 5.1. I riflessi dell’impiego dell’abuso del diritto sulcoefficiente soggettivo del reato. - 6. Qui iure suo utitur neminem laedit. L’abuso del di-ritto e l’impotenza delle garanzie penalistiche. - 7. La teoria dell’abuso del diritto allaprova della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. - 8. Sintesi. Nullumcrimen nazionale e nullum crimen convenzionale. Il sistema delle garanzie e il topos «abu-so del diritto»: cumulatività vs alternatività.
1. – Nel corso di un convegno svoltosi a Milano nel luglio del 1989 ilprof. Alessandri definiva l’elusione fiscale come un comportamento perfet-tamente regolare da un punto di vista formale, la cui maliziosità si esprime-va nell’assenza di valide ragioni commerciali (1) e concludeva poi nel sensodi ritenere che i principi di determinatezza e tassatività, nonché il principiodi offensività, ostassero alla rilevanza penale dell’elusione fiscale. L’assenzadi qualsiasi capacità decettiva della condotta elusiva, in considerazione del-l’esatta conoscibilità della propria situazione offerta dal contribuente al-l’amministrazione finanziaria, non era collocabile all’interno della crimino-dinamica tra dichiarazione siffatta del privato e danno agli interessi pubbli-ci. A ritenere diversamente, osservava l’Autore, si sarebbe finito per sacri-ficare in nome di emergenze fiscali i principi fondamentali del diritto pe-nale (2).
(1) Così Alessandri, L’elusione fiscale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1075.(2) Alessandri, L’elusione fiscale, cit., 1081.
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
La situazione spirituale attuale del diritto penale smentisce questa con-statazione, pur formalmente tuttora ineccepibile e rimanda invece l’imma-gine del diritto penale tributario come una sorta di «campo di battaglia» incui progressivamente le norme incriminatrici si stanno, più o meno lenta-mente, riposizionando nella «campagna» contro i comportamenti di infe-deltà fiscale in senso lato. Pur identica nella lettera è l’interpretazione dellanorma a mutare, orientata com’è sempre più all’effettività della tutela pena-le quale che sia, piuttosto che alla garanzia del destinatario del precetto.
2. – La strategia penalistica, per continuare nell’impiego del lessico«militaresco», è grandemente condizionata dalla rappresentazione mediati-ca della devianza economica, di tipo fiscale in particolare, in un contesto dicrisi del debito sovrano che primeggia nell’agenda setting della politica na-zionale e internazionale (3).
La trasformazione ermeneutica del tipo penale in campo tributario ri-sponde, oggi, ad un marcato bisogno di pena. È indubbio che la conforma-zione di alcune fattispecie del d. lgs. 74/2000, per come interpretate dallaCassazione, rispondono ad una logica funzionale, che rende le norme incri-minatrici molto duttili per le agenzie del controllo penale, intendendo pertali sia la Procura della Repubblica, che la Polizia giudiziaria specializzata,che l’Agenzia delle Entrate.
La concezione funzionale dell’illecito penale si esprime essenzialmentenell’impiego della norma punitiva non più solo come strumento reattivo al-l’illecito, ma anche proattivo rispetto all’implementazione di direttrici piùampie di politica del diritto. È, infatti, l’accentuazione in sede applicativa deiprofili più general-preventivi del sistema penale tributario, di tono quasi«moralizzante» (4), a colpire l’attenzione, tanto che ci si è posti il quesito seil diritto penale tributario, al pari di quello in materia di terrorismo e ordinepubblico, non corrisponda sempre più ad una sorta di diritto penale del ne-mico, quel fenomeno politico-criminale che ha occupato le riflessioni delladottrina internazionale nei primi anni dello scorso decennio (5); certo la ge-
(3) Sul tema dei rapporti reciproci tra diritto penale e media, Forti-Bertolino (a curadi), La televisione del crimine, Milano, 2005; Paliero, La maschera e il volto (percezione socia-le ed «effetti penali» dei media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 490 ss.; Bianchetti, Mass me-dia, insicurezza sociale e recenti orientamenti di politica penale, Milano, 2012, passim.
(4) Sulla funzionalizzazione dello strumento penale a campagne di moralizzazione dellasocietà, quando la matrice autoritaria del diritto penale (più antica) prevale su quella demo-cratica (più moderna) Paliero, L’agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto pena-le?, in Criminalia, 2012, 101.
(5) Su cui per tutti Jakobs, di cui in lingua italiana si veda Jakobs, Diritto penale del nemi-co, in Donini-Papa (a cura di), Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, Milano,
2 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
stione giurisprudenziale dei reati fiscali è più pacata «nelle forme» rispettoa quella dei reati di terrorismo e criminalità organizzata, ma disvela comun-que alcune continuità contenutistiche, incentrata com’è sull’autore più chesul fatto, sui profili soggettivi dell’agente più che su quelli effettuali dellacondotta.
D’altra parte l’evoluzione giurisprudenziale dei reati tributari ha avutoanche una traduzione legislativa, come testimoniato da precetti emblemati-ci, sia per la scarsa qualità tecnica che per l’attentato alle garanzie fonda-mentali del cittadino a cui possono prestarsi (si spera solo per insipienza dellegislatore): si pensi, ad esempio, alla criminalizzazione delle «false risposteall’amministrazione finanziaria», tra le cui pieghe si nasconde una lesionedel principio del nemo tenetur se detegere (6).
Ed è in questo contesto operativo che si trova ad agire la norma penale,che si espande e trasforma i propri connotati, in una tensione alla crimina-lizzazione di forme di devianza economica – come l’elusione fiscale – primasolo lambite, mai afferrate dalle indagini penali ed oggi invece trasportate,manu militari, dai «margini» al «nucleo» del diritto penale tributario.
5 ss.; nel panorama italiano, a mero titolo esemplificativo, si segnalano Donini, Il diritto pe-nale di fronte al nemico, in Cass. pen., 2006, 772; Id., Il volto attuale dell’illecito penale. La de-mocrazia penale fra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, 53 ss.; Palazzo, Contrastoal terrorismo, diritto penale del nemico e diritti fondamentali, in Questione giustizia, 2006, 667ss.; Pulitanò, Lo sfaldamento del sistema penale e l’ottica amico-nemico, in Questione giusti-zia, 2006, 743. Inoltre si vedano i contributi di Donini, Diritto penale di lotta v. diritto penaledel nemico, e Pulitanò, Il problema del diritto penale del nemico, fra descrizione e ideologia,entrambi in Gamberini-Orlandi (a cura di), Delitto politico e diritto penale del nemico.Nuovo revisionismo penale, Bologna, 2007, rispettivamente 131 e 233; Bonini, Lotta alla cri-minalità organizzata e terroristica, garanzia dell’individuo, garanzia della collettività: riflessionisistematiche, in Cass. pen., 2009, 2216; si veda poi, a livello monografico, Bartoli, Lotta alterrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annienta-mento del nemico assoluto, Torino, 2008, 10, con particolare riferimento all’attenuazione del-le garanzie processuali.
(6) Ci si riferisce all’art. 11 comma 1 l. 22 dicembre 2011, n. 214, che recita: «Chiunque, aseguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi intutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell’artico-lo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione dicui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solose a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decre-to legislativo 10 marzo 2000, n. 74». In questo senso si vedano i dubbi manifestati da Flora,
Le recenti modifiche in materia penale tributaria: nuove sperimentazioni del «diritto penale delnemico»?, in Dir. pen. proc., 2012, 15 ss., che evidenzia in particolare la lesione al principiodel nemo tenetur se detegere (22). Per una critica alla piega soggettivistica ed emergenziale chepare aver preso il diritto penale tributario, si veda anche Aldrovandi, La nozione di «fattureo altri documenti per operazioni inesistenti» nel «diritto vivente» ed il «nuovo volto» del dirittopenale tributario, in Ind. pen., 2012, 230 ss.
FEDERICO CONSULICH 3
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
3. – L’abuso del diritto è il paradigma contemporaneo di quanto ora det-to.
È una nozione intimamente correlata al diritto civile, perciò difficil-mente importabile nel diritto penale, se non con esiti deprecabili. L’abusodel diritto «sta e cade», infatti, con la nozione di causa del negozio giuridi-co, costituendone una deviazione dalla «funzione economico-giuridica» (7),una difformità funzionale tra atto concreto e titolo formale (8).
Si tratta di uno strumento interpretativo che consente di attribuire, inconcreto, la qualifica di illiceità ad una condotta in sé astrattamente lecita, sesoggettivamente volta al perseguimento di finalità diverse da quelle ricono-sciute dall’ordinamento come congrue.
Vi è una correlazione tra abuso del diritto e limiti al diritto. Perché sipossa abusare di un diritto è, infatti, necessario che questo sia ristretto in unperimetro, il cui superamento costituisca una manifestazione dell’illecito.
Può darsi un abuso di tutti i diritti che contemplino delle prerogative diagire, che attribuiscono cioè la possibilità di tenere condotte commissive,necessariamente confliggenti con interessi contrapposti; si escludono i meri«diritti negativi», il cui contenuto consiste cioè nel dovere in capo ai terzi diastenersi dal compiere azioni lesive del titolare del diritto (9).
Si abusa dunque solitamente di diritti di tipo potestativo (il campo tipi-co, oltre al caso del diritto tributario, è il diritto di difesa nel processo), rea-lizzando una frode alla loro funzione (10).
(7) Questa è, infatti, la nota definizione di causa del negozio giuridico fornita da Betti,
Causa del negozio giuridico (voce), in Nov. Dig. it. III, Torino, 1959, 32; si vedano anche Mes-
sineo, Il contratto in genere, in Cicu-Messineo (diretto da), Trattato di diritto civile e com-merciale, Milano, 1972, 111; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, 231.
(8) È la posizione di Orlandi, Abuso del diritto e teoria della fonte, in Velluzzi (a curadi), L’abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari, Pisa, 2012, 135.
(9) Si consideri, ad esempio, il caso del diritto a non essere sottoposto a tortura: nonavendo tale diritto alcun limite, esso si presenta strutturalmente incompatibile con un abusopoiché viene esercitato in modo passivo, omissivo tanto dal punto di vista del titolare del di-ritto, quanto da parte dei terzi, che devono limitarsi ad astenersi da azioni lesive. Il diritto disciopero attribuisce, invece, al titolare la prerogativa di compiere attività positive; si trattacioè di un diritto che si esercita con condotte incidenti sulla sfera giuridica altrui. Evidenziacome il diritto a non essere torturato non possa essere sottoposto a relativizzazione di sortaBartoli, «Chiaro e oscuro» dei diritti umani alla luce del processo di giurisdizionalizzazionedel diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 805, con richiami alla letteratura propensa, invece,ad ammettere limitazioni a tale divieto fondamentale.
(10) Il punto è focalizzato in relazione al diritto di difesa nel processo penale da Cass., sez.un., 10 gennaio 2012, n. 155, in Cass. pen., 2012, 2444 ss., con nota di Caprioli, Abuso del di-ritto di difesa e nullità inoffensive. Sul tema dell’abuso del processo si vedano le perspicue os-servazioni di Padovani, A.d.r. sul c.d. abuso del processo, e Palazzo, L’abuso del processo e isuoi rimedi tra legalità processuale e legalità sostanziale, entrambi in Cass. pen., 2012, rispetti-vamente, 3605 ss. e 3609 ss.
4 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
L’abuso del diritto appare una forma di «illecito generale» dell’ordina-mento, una nozione interdisciplinare che progressivamente sta espanden-dosi anche nel settore del diritto penale in cui sembrava non potesse avereospitalità per una semplice ragione: l’atipicità della sua fattispecie costituti-va (11).
Esso si presenta, infatti, come la violazione non di una regola, ovvero diuna disposizione normativa tassativa, ma di un principio, ovvero di una pro-posizione normativa sovraordinata alla regola, caratterizzata da una dimen-sione programmatica e generale (pur potendo avere un contenuto imperati-vo) (12).
L’abuso è dunque una peculiare forma di illecito, se non addirittura undiverso genus di infrazione normativa (13): non si tratta, infatti, di un contra-sto con un specifico divieto normativo, ma della frustrazione rispetto al va-lore sotteso alla norma che riconosce il diritto.
In quanto tale, l’abuso comporta l’inapplicabilità della norma attributi-va della prerogativa; posto che però il diritto di agire – in campo penale – ri-leva in quanto possa scriminare un comportamento illecito, non applicareuna norma attributiva del diritto significa consegnare la condotta alla quali-fica di illiceità penalmente rilevante.
Sicché, ambientato in territorio penalistico, l’abuso del diritto potrebbecondurre ad esiti perniciosi; riletto con gli strumenti ermeneutici del pena-lista, si sostanzia in un abuso della scriminante e comporta l’inapplicabilitàdella stessa, per contrasto della condotta concreta con la ratio della normadi liceità (14).
(11) Più precisamente è possibile affermare che l’abuso del diritto sia il risultato aberran-te dell’applicazione del criterio della gerarchia tra valori in gioco, nell’ambito di un contrastonormativo tra incriminazione e giustificazione. La notazione è di Atienza-Manero, Abusodel diritto e diritti fondamentali, in Velluzzi (a cura di), L’abuso del diritto. Teoria, storia eambiti disciplinari, cit., 47.
(12) Per una compiuta analisi degli illeciti atipici cfr. Atienza-Ruiz Manero, IlÍcitosatÍpicos. Sobre el abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación de poder, Madrid, 2006, 27;per una critica serrata alla teorica di questi ultimi, in particolare sottolineando come spinga igiudici a decidere basandosi su credenze personali e intuizioni morali, Comanducci, Abusodel diritto e interpretazione giuridica, in Velluzzi (a cura di), L’abuso del diritto. Teoria, sto-ria e ambiti disciplinari, cit., 30.
(13) In questo senso ad esempio, Giorgianni, L’abuso del diritto nella teoria della normagiuridica, Milano, 1963, 109; Breccia, L’abuso del diritto, in Diritto privato, Padova, 1998, 5ss.
(14) Sull’abuso della causa di giustificazione v. Mucciarelli, Abuso del diritto, elusionefiscale e fattispecie incriminatrici, in Maisto (a cura di), Elusione e abuso del diritto tributario,Milano, 2009, 433, che evidenzia come l’inapplicabilità della scriminante non significa di persé la rilevanza penale dell’abuso del diritto, dovendo la condotta non scriminabile essere al-tresì tipica ai sensi di una norma incriminatrice per poter essere punita.
FEDERICO CONSULICH 5
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
3.1. – Il tema dell’abuso del diritto costituisce un topos del diritto tribu-tario attuale ed esprime efficacemente tutte le contraddizioni insite in unaconcezione della giustificazione non contenuta entro gli argini delle garan-zie penalistiche.
L’effetto di incriminazione che discende dall’abuso del diritto, comeformula concettuale, dipende dalla natura che la giustificazione riveste ri-spetto ad alcuni delitti tributari; il diritto di compiere una certa operazionenegoziale «dotata di impatto fiscale» integra il tipo legale di alcuni reatiprevisti dal d. lgs. 74/2000, dal concetto di fittizietà di cui agli artt. 2 e 4, aquello di mezzi fraudolenti o artifici di cui all’art. 3, nonché l’obbligo di pre-sentazione delle dichiarazioni fiscali per quanto riguarda l’art. 5 (15).
Sono tutte ipotesi in cui le norme che prevedono un diritto d’agire incampo fiscale non si limitano a scriminare, ma altresì integrano il tipo, in ne-gativo, attraverso la definizione delle condizioni d’uso di un certo elementonormativo della fattispecie penale: nel caso dell’art. 4 del d. lgs. 74/2000 sitratta del concetto di elementi attivi inferiori a quelli effettivi e quello di ele-menti passivi fittizi.
In breve: per conoscere se esiste una sottovalutazione dell’attivo oun’ipervalutazione del passivo (gli elementi normativi del tipo penale) oc-corre guardare se sia stata correttamente esercitata da parte del contribuen-te la propria libera autonomia negoziale (il diritto scriminante). Di fatto pe-rò la giurisprudenza, per verificare tale ultimo elemento, impiega un ap-proccio ermeneutico assai problematico: tramite il concetto di abuso del di-ritto si rifà, infatti, alle finalità antifiscali del privato al momento in cui com-pie negozi giuridici in sé leciti.
Il divieto di abuso del diritto è, come detto, un principio attinente al-l’interpretazione della norma (16), come tale di per sé privo di risvolti san-zionatori di alcun tipo, ma via via la giurisprudenza domestica ne ha fattodiscendere, in materia penale tributaria, l’inflizione di sanzioni ora ammini-strative (17) e, più tardi, criminali.
Il punto cruciale risulta il seguente. Esiste nell’ordinamento, quanto
(15) L’art. 5 invece, essendo un reato omissivo proprio, costituisce l’inadempimento di unobbligo di agire che viene attualizzato al ricorrere del presupposto di un’imposta dovuta, cfr.Cadoppi, Sub art. 5, in Caraccioli-Giarda-Lanzi (a cura di), Diritto e procedura penale tri-butaria, Padova, 2001, 220.
(16) Come evidenziato da Perini, La tipicità inafferrabile, ovvero elusione fiscale «abusodel diritto» e norme penali, in questa Rivista, 2012, 732.
(17) Cass., V, 18 maggio 2011, n. 21782, in Riv. dir. trib., 2012, 347 ss., con nota di S. LaRosa, Ancora sugli incerti confini tra abuso del diritto, elusione ed illecito fiscale; Cass., 30 no-vembre 2011, n. 25537, in Dir. prat. trib., 2012, 763 ss., con nota di Corrado, Elusione e san-zioni: una dicotomia insanabile.
6 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
meno a parere delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (18), sullascia delle note sentenze della Corte di Giustizia di Lussemburgo Halifax ePart service un generale principio antielusivo, confermato e specificato dasingole norme scritte che si contrappongano, sanzionandole, a condotte fi-scalmente elusive. Tale principio preclude al contribuente il conseguimen-to di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto di strumenti giuridicipur idonei in astratto ad ottenere un’agevolazione o risparmio di imposta.L’uso può dirsi «malevolo» nel caso in cui non si possano riscontrare nel-l’operazione negoziale valide ragioni economiche, apprezzabili da parte diun osservatore terzo, che la giustifichino prima ed a prescindere dal conse-guimento dei benefici fiscali stessi.
La ragione economica può anche essere differita nel tempo e non im-mediatamente apprezzabile in termini finanziari, potendo ad esempio deri-vare da un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda (19), pur tut-tavia tale miglioramento deve esistere e avere una natura extrafiscale.
Difficile affermare che la violazione di questo principio possa avereconseguenze penali, se è vero che molte sentenze hanno escluso non solo larilevanza penale intrinseca del fenomeno, ma anche la sua spendibilità pro-batoria a sostegno di imputazioni più complesse, in cui l’abuso del dirittopoteva fungere cioè da escamotage per introdurre in sede penale presunzio-ni tipiche del diritto tributario. È invece più recente, come vedremo infra,la tesi per cui l’ambito di applicazione di molte delle fattispecie di cui al d.lgs. 74/2000 possa coinvolgere il comportamento elusivo (20).
L’incriminazione delle condotte elusive passa per lo più attraverso l’art.
(18) Cass., sez. un. civ., nn. 30055, 30056, 30057 del 23 dicembre 2008, in Corr. trib.,2009, 411, nonché Cass., 21 gennaio 2009, in Fisco 1, 2009, 729; Cass., 8 aprile 2009, in Fisco1, 2757. Il tema ovviamente ha conosciuto anche una declinazione comunitaria, da parte dellaCorte di Giustizia, in tema di imposte armonizzate (iva), cfr. CGCE, 21 febbraio 2006,C-255/02 (cd. sentenza Halifax), in www.ilfisco.it/fisconline, seguita da Cgce, 21 febbraio2008, C-425/06 (cd. sentenza Part service). Si evidenzi però che la nota sentenza Halifax, puredificando il principio dell’abuso del diritto, ne ha al contempo limitato l’operatività al-l’omesso riconoscimento del beneficio fiscale avuto di mira, sancendo l’impossibilità che aduna condotta così atipica potesse conseguire una sanzione. Cfr. sul punto Lanzi, I riflessi pe-nali dell’elusione fiscale, il trasfer pricing e il CFC, in Ind. pen., 2012, 7 ss.; Mucciarelli,
Abuso del diritto, elusione fiscale e fattispecie incriminatrici, cit., 437.(19) In questi termini Cass. Trib., V, n. 1372 del 21 febbraio 2011, Rv. 616371. In dottri-
na, estremamente critico sui concetti di ragionevolezza economica e antieconomicità qualicriteri interpretativi vaghi e indeterminati per decifrare il concetto di elusione fiscale, Terra-cina, Riflessi penali dell’evasione fiscale, Roma, 2012, 55.
(20) Si evidenzia in dottrina che l’incriminazione su cui più può incidere in termini di am-pliamento del penalmente rilevante l’elusione fiscale è quello di dichiarazione infedele ai sen-si dell’art. 4 d. lgs. 74/2000, poiché rappresenta quella a spettro più ampio, cfr. Mangione,
La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesisten-ti, in Musco (a cura di), Diritto penale tributario, Milano, 2002, 128 ss.
FEDERICO CONSULICH 7
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
4, in particolare attraverso l’elemento normativo dell’«indicazione di ele-menti passivi fittizi», laddove la fittizietà può essere intesa come inesistenzain rerum natura, secondo una concezione tutta penalistica del concetto, op-pure quale indeducibilità e inopponibilità all’amministrazione fiscale, que-sta volta quindi in un’accezione tributaristica (21).
Vi può anche essere una rilevanza ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 74/2000, lad-dove attraverso l’abuso del diritto di stabilimento, previsto agli artt. 49 e ss.del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si ponga al di là deiconfini nazionali (comunque in uno Stato comunitario) la sede di un ente,la cui attività economica però solo fittiziamente si svolga all’estero: in tale si-tuazione di fatto sarebbe illecita la mancata presentazione della dichiarazio-ne fiscale in Italia (22).
Nota è l’origine della tesi secondo cui l’elusione fiscale e quindi l’abusodel diritto può avere una cittadinanza penale.
Chi sostiene questa impostazione (Franco Gallo) (23), afferma la punibilità dell’elu-sione fiscale e alla luce della nozione ampia di imposta evasa contenuta all’art. 1 lett. f)del d. lgs. 74/2000, nonché degli art. 7 e 16 del medesimo decreto (24).
Quest’ultima norma, nel sancire l’irrilevanza penale delle condotte elusive sottopo-ste al giudizio del Ministero delle Finanze e del comitato antielusivo, ammetterebbe im-plicitamente la rilevanza di tutte quelle, di medesima natura e struttura, non sottoposteal parere o comunque che non abbiano ottenuto l’assenso dell’organo amministrativostesso.
L’art. 7 invece dichiarerebbe fittizi i costi non deducibili anche nelle ipotesi in cuiqueste condotte non siano punibili perché, proprio in base all’art. 7, rispettose di meto-di costanti di impostazione contabile o comunque di criteri esplicitati nel bilancio.
(21) Seguono la tesi sanzionatoria del diritto penale rispetto alle nozioni degli elementicostitutivi dei reati tributari, oltre a Gallo, Rilevanza penale dell’elusione, in Rass. trib.,2001, 321 ss.; Di Amato, La dichiarazione infedele, in Di Amato-Pisano (a cura di), Trattatodi diritto penale dell’impresa, VII, I reati tributari, Padova, 2002, 556 ss.; Bersani, I reati di di-chiarazione infedele e di omessa dichiarazione, Padova, 2003, 16 ss.; nel senso di un’accezioneautonomistica dei concetti di fittizietà e imposta evasa Mangione, La dichiarazione fraudo-lenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, cit., 77; Dassano, Ladichiarazione fraudolenta tra autonomia di disciplina e regole di contesto, in La riforma del di-ritto penale tributario, Torino, 2000, 43.
(22) L’abuso del diritto di stabilimento è stato tematizzato dalla Corte di Giustizia, in par-ticolare della sentenza Cadbury Schweppes, in cui i giudici comunitari hanno stabilito che glieffetti fiscali favorevoli conseguenti all’esercizio del diritto di stabilimento in un Paese terzopotevano essere disconosciuti solo in caso di creazione di una struttura puramente artificiosa,cfr. CGCE, Cadbury Schweppes, 12 settembre 2006, C.196/04.
(23) Gallo, Rilevanza penale dell’elusione, cit., 321 ss.(24) Sulla base della definizione di imposta evasa considera penalmente rilevante anche
l’imposta elusa, come risultato della differenza tra imposta dovuta e quella autoliquidata a se-guito dell’operazione elusiva, Martini, Reati in materia di finanze e tributi, in Grosso-Pa-
dovani-Pagliaro (a cura di), Trattato di diritto penale. P.te speciale, XVII, Milano, 2010,392 ss., in particolare 402.
8 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
3.2. – Per quanto siano assai labili e a tratti confusi i connotati di evasio-ne, elusione e abuso del diritto, la Cassazione penale non è giunta a sancirel’equazione per cui l’elusione fiscale corrisponda tout court ad un illecito pe-nale, ma certo crea la commistione tra tre differenti tipologie di condotte(appunto tra quelle elusive, evasive (25) e abusive (26)).
Presto detto in cosa consista il concetto di evasione fiscale: la violazione delle normedel sistema penale tributario (27).
Alla luce del principio consacrato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazio-ne, la condotta abusiva di un diritto consisterebbe, invece, nell’utilizzo di norme fiscalidi favore per fini diversi da quelli per cui sono state introdotte nell’ordinamento.
Secondo alcuni Autori l’elusione sarebbe un fenomeno intermedio tra il lecito rispar-mio di imposta e la conclamata frode fiscale (28). Ciò si tradurrebbe nell’irrilevanza pena-le della condotta, anche per simmetria di sistema: se in sede extrapenale l’unica conse-guenza prevista dal diritto tributario per il negozio elusivo è la semplice parziale ineffi-cacia, non può essere punito penalmente ciò che non è sanzionato fiscalmente.
L’elusione fiscale rappresenta dunque l’intersezione di procedimenti leciti che evi-tano il sorgere del debito fiscale o ne fanno sorgere uno più lieve (si tratta di una prassinota come tax avoidance (29)). Tra abuso del diritto e elusione fiscale dovrebbe intercor-
(25) Per evasione deve intendersi qualsiasi condotta riconducibile alle fattispecie di cui ald. lgs. 74/2000 secondo Terracina, Riflessi penali dell’evasione fiscale, cit., 187. L’elusione sidistinguerebbe dall’evasione in quanto quest’ultima presuppone una valida pretesa tributariache colpevolmente non viene adempiuta dal contribuente, mentre l’elusione rappresenta unacondotta che impedisce, ancora prima di inadempierla, la formazione della pretesa tributaria,aggirando le norme che la regolerebbero, cfr. la classifica definizione di Hensel, Diritto tri-butario, Milano, 1956, 146. La difficoltà di definire i tre concetti (evasione, elusione ed abu-so) ben si percepisce anche in sede comunitaria, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia,come evidenziato da Piantavigna, Abuso del diritto fiscale nell’ordinamento europeo, Tori-no, 2011, 85.
(26) Sostiene come non si debba individuare la rilevanza penale di una condotta a partiredalla sua natura elusiva, bensì occorra prendere le mosse direttamente dalla norma penale,scontando l’indifferenza penalistica della qualifica evasiva o abusiva della condotta dal puntodi vista tributario Giacometti, La problematica distinzione tra evasione, elusione fiscale eabuso del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 453; in precedenza Veneziani, Elusione fisca-le, «esterovestizione» e dichiarazione infedele, in Dir. pen. proc., 2012, 865. Per una recente ri-flessione sul «confine conteso» evasione ed elusione e, in generale, sulla rilevanza penale del-l’abuso del diritto cfr. Salcuni, Abuso del diritto ed elusione fiscale tra offensività e determi-natezza, in questa Rivista, 2013, 113 ss.
(27) Così Mucciarelli, Abuso del diritto, elusione fiscale e fattispecie incriminatrici, cit.,440.
(28) Perini, La tipicità inafferrabile, ovvero elusione fiscale, «abuso del diritto» e normepenali, cit., 734 ss. L’elusione fiscale viene definita da Tesauro, Istituzioni di diritto tributa-rio, P.te Gen., Torino, 2009, 240: «una forma di “risparmio fiscale” che è conforme alla lettera,ma non alla ratio delle norme tributarie: il contribuente che elude evita di applicare la tassazio-ne più onerosa seguendo un percorso anomalo, abusivo».
(29) Sul concetto di tax avoidance in termini di elusione, che si contrappone all’evasione,in quanto con la prima si definisce l’uso di legittime forme giuridiche per evitare il sorgere delpresupposto di un tributo v. già Lovisolo, Evasione ed elusione tributaria (voce), in Enc.
FEDERICO CONSULICH 9
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
rere, secondo alcuni Autori, un rapporto di specialità (30): il divieto di abuso del dirittoesprimerebbe un vero e proprio principio dell’ordinamento, mentre l’elusione fiscalesarebbe da intendere come la violazione di una norma che specifica, in riferimento al di-ritto tributario, il divieto dell’abuso di una prerogativa legittima del cittadino, al pari diquanto fa l’art. 833 c.c. in relazione al diritto civile (31).
L’elusione fiscale non rappresenta un concetto legislativo, essendo stata la dottrinadi settore a delinearlo, definendola come un aggiramento della normativa fiscale, carat-terizzata dal rispetto delle forme normative, ma dal tradimento della ratio che le ispira(32). Si tratta insomma non di una violazione di un divieto normativo, ma dei valori che lenorme, pur non violate, mirano a tutelare. È un illecito «per violazione di principi gene-rali» (33).
Conclusivamente, ferma restando l’eterogeneità del concetto di evasio-ne fiscale, quelli di elusione ed abuso del diritto ci paiono concetti quasi so-vrapponibili, che da punti di vista differenti, l’effetto conseguito (l’elusione)o la condotta tenuta (l’abuso), denotano un medesimo fenomeno: l’eserciziodi un diritto in modo incoerente rispetto alla ratio della norma che lo preve-de.
Abuso o elusione (che dir si voglia) segnano la creazione ermeneutica
giur., XIV, 1989, 2 ss. Nello stesso senso Napoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penaletributario, Milano, 2000, 234 ss.
(30) In questi termini Musco-Ardito, Diritto penale tributario, Bologna, 2012, 178, nt.35, nonché Mucciarelli, Abuso del diritto, elusione fiscale e fattispecie incriminatrici, cit.,425 ss. Evidenzia come l’art. 37 bis d.P.R. 600/1973, nel tipizzare varie ipotesi di elusione fi-scale, finisca per attribuire a queste gli stessi caratteri costitutivi dell’abuso del diritto (naturafiscale esclusiva ed uso distorto degli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento) Perini,La tipicità inafferrabile, ovvero elusione fiscale, «abuso del diritto» e norme penali, cit., 737.Nella dottrina non penalistica ritiene che l’elusione fiscale vada ricondotta al fenomeno del-l’abuso del diritto Tabellini, L’elusione fiscale, Milano, 1988, 128 ss.
(31) Mucciarelli, Abuso del diritto, elusione fiscale e fattispecie incriminatrici, cit., 423 ss.(32) Per una panoramica della nozione cfr. Falsitta, Manuale di diritto tributario, P.te
gen., Padova, 2011, 213; Marongiu-Marcheselli, Lezioni di diritto tributario, Torino,2009, 25.
(33) Sull’incompatibilità tra elusione fiscale e illecito penale cfr. Musco-Ardito, Dirittopenale tributario, cit., 178 ss.; Mucciarelli, Abuso del diritto, elusione fiscale e fattispecie in-criminatrici, cit., 402; più di recente, segnala l’irrimediabile contrasto tra il concetto di elusio-ne fiscale ed il principio di tipicità dell’illecito penale Flora, Perché l’«elusione fiscale» nonpuò costituire reato (a proposito del «caso Dolce & Gabbana»), in questa Rivista, 2011, 869;Lanzi, I riflessi penali dell’elusione fiscale, il transfer pricing e il CFC, cit., 7 ss.; Di Amato, inDi Amato-Pisano, I reati tributari, in Trattato di diritto penale dell’impresa, VII, Padova,2002, 249 ss.; Flick, Abuso del potere ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, in Giur.comm., 2011, 483 ss., nonché anche Perini, La tipicità inafferrabile, ovvero elusione fiscale,«abuso del diritto» e norme penali, cit., 737, che evidenzia come l’attribuzione di rilevanza pe-nale all’abuso del diritto porrebbe problemi, prima ancora che di determinatezza, di riservadi legge, stante il fulcro comunitario della rilevanza giuridica di tale istituto. Già da tempo co-munque la dottrina aveva sostenuto che il concetto di elusione fosse di difficile inquadramen-to concettuale in rapporto al diritto penale italiano Alessandri, L’elusione fiscale, cit., 1075ss.
10 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
da parte della giurisprudenza di uno strumento nato, in prima battuta, perprivare di effetti una condotta ritenuta non meritevole di tutela e, in secon-da battuta, per poterla sottoporre a sanzione (34).
Di seguito quindi impiegheremo, dunque, i due termini come se fosserosinonimi.
3.2.1. – Il tema dell’abuso del diritto è stato posto all’attenzione dei pe-nalisti solo in tempi relativamente recenti.
Come detto, i reati tributari, in particolare l’art. 4 d. lgs. 74/2000, pre-sentano fattispecie dai confini evanescenti che ben si prestano ad interpre-tazioni espansive: non appena il contesto politico economico si è presentatofavorevole, prontamente è sopraggiunta un’esegesi estensiva dei limiti dipunibilità.
Pare di questo tipo quella che «aggancia» la norma penale tributaria al-le disposizioni antielusive come fa la Cassazione nel caso «Dolce e Gabba-na» (35).
Recentemente la Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di interveniresul tema dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale con una sentenza ormainota riferita alla coppia di famosi stilisti. In sintesi si è ritenuto che non qua-lunque condotta elusiva ai fini fiscali assuma rilevanza penale, ma solo quel-la che corrisponda ad una specifica ipotesi di elusione prevista dalla legge(36) e proprio entro questo limite la persecuzione penale di una fattispecieconcreta, che pure costituisce la mera distorsione soggettiva di un diritto diagire, non contrasterebbe con il principio di legalità (37).
(34) In questo senso già Giacometti, La problematica distinzione tra evasione, elusionefiscale e abuso del diritto, cit., 460 s., che segnala come i due concetti si differenzino dal puntodi vista del tipo di accertamento che è a loro sotteso, ovvero l’applicazione di norme positive(l’elusione), cui si contrappone un accertamento sintetico e semplificato a favore dell’ammi-nistrazione (l’abuso).
(35) Cass., II, 22 novembre 2011 Cc.(dep. 28 febbraio 2012), n. 7739, Rv. 252019, in Riv.it. dir. proc. pen., 2013, 451, con nota di Giacometti, La problematica distinzione tra evasio-ne, elusione fiscale e abuso del diritto e in Dir. pen. proc., 2012, 858, con nota di Veneziani,
Elusione fiscale, «esterovestizione» e dichiarazione infedele.(36) Il paradigma è costituito dall’art. 37 bis d.P.R. 600/1973, introdotto dal d. lgs. 358/
1997, che stabilisce che siano inopponibili all’Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e inegozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obbli-ghi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsialtrimenti indebiti. Si tratta a ben vedere di una disposizione assolutamente generale, la cuicarenza di tassatività risulta di fatto intollerabile per il sistema penale.
(37) La sentenza resa sul «caso Dolce e Gabbana» è stata più di recente confermata daCass., III, 6 marzo 2013 (dep. 3 maggio 2013), n. 19100 in www.penalecontemporaneo.it (9dicembre 2013), con nota di Giacometti, La Cassazione torna sulla rilevanza penale dell’elu-sione fiscale; in Dir. pen. proc., 2014, con nota di A. Dell’Osso, L’elusione fiscale al banco di
FEDERICO CONSULICH 11
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
Breve: la rilevanza penale delle condotte elusive non deve contrastaresolo con il generale principio di divieto di abuso del diritto, ma con una del-le sue concretizzazioni normative specifiche, la principale delle quali è certa-mente l’art. 37 bis del d.p.r. 600/1973: ciò garantirebbe la ragionevole pre-vedibilità dell’incriminazione.
Procedendo con ordine.La nota vicenda prende le mosse dalla scelta dei due stilisti di cedere i
marchi della loro griffe di moda ad una holding lussemburghese. Nellaprospettazione accusatoria ciò sarebbe avvenuto con fissazione di unprezzo di cessione inferiore a quello che sarebbe derivato in una liberacontrattazione tra parti indipendenti, al fine di sottrarre al fisco una plu-svalenza.
La contestazione si collocava in un più ampio contesto di esterovestizio-ne, se è vero che le società lussemburghesi coinvolte nell’operazione sareb-bero state tali solo formalmente, in quanto poi controllate da una holdingitaliana, con duplice vantaggio fiscale: gli utili derivanti dalle royalties, cherappresentavano il prezzo per la licenza dei marchi concessa alla società ita-liana da quella lussemburghese, sarebbero stati tassati secondo la più bene-vola legislazione lussemburghese e al contempo avrebbero rappresentatoun costo deducibile dalla società italiana.
L’incertezza applicativa è bene rappresentata dalla successione delledecisioni in ordine alla vicenda, poiché alla pronuncia di primo grado cheha sancito la irrilevanza penale del fenomeno (38), ha fatto seguito una sen-tenza della Cassazione di segno opposto, che ha invece sostenuto, comedetto, che il comportamento elusivo non possa essere considerato tout courtpenalmente neutro, e che la rilevanza penale poteva condurre all’applica-zione tanto dell’art. 4, quanto dell’art. 5 del d. lgs. 74/2000, a condizioneche si tratti di condotte che rientrino in una specifica condotta antielusiva,che descriva in modo determinato la fattispecie (39).
Il caso «Dolce & Gabbana», per quanto si tratta della sentenza più notain tema, si inscrive in un filone interpretativo di natura evolutiva che risale
prova della legalità penale, 81 ss. e in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, con nota di Troyer-Ingras-sia, La rilevanza penale dell’elusione, il caso Bova e il triangolo di Penrose, 2081 ss. Questi ulti-mi AA., tornando alla sentenza resa sul caso «Dolce e Gabbana», ne rilevano tutti i profili difrizione con i principi di garanzia penalistici (precisione, tassatività, irretroattività, materiali-tà, determinatezza e sussidiarietà).
(38) Per una compiuta analisi della sentenza del Gup di Milano, 29 aprile 2011 n. 828/2011 cfr. Troyer-Ingrassia, Esclusa nuovamente la tipicità penale dell’elusione. A margine diun noto caso di presunta esterovestizione tra divieto di presunzioni legali nel processo penale elibertà di stabilimento, in Riv. dott. comm., 451 ss.
(39) Si tratta della sentenza Cass., II, 28 febbraio 2012 (22 novembre 2011), n. 7739, cit.
12 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
alla sentenza 26723 del 2011 della Cassazione (40), tanto che l’Ufficio delMassimario del Supremo Collegio, nella relazione sulla giurisprudenza del2011, segnala proprio quest’ultima decisione «in quanto espressiva di un ri-levante mutamento giurisprudenziale» nella misura in cui «ha ritenuto con-figurabile il reato di dichiarazione infedele [...] anche in presenza di unacondotta elusiva rientrante tra quelle previste dall’art. 37 bis del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600» (41).
L’impostazione generale delle relazioni tra elusione e fattispecie penal-tributarie propugnata dalla sentenza della Cassazione nel caso degli stilistimilanesi è stata poi seguita da un ancor più recente arresto della SupremaCorte in un caso relativo alla legittimità di una misura cautelare reale, anco-ra una volta peraltro riferibile ad un personaggio del mondo dello spettaco-lo.
Come nel caso «Dolce e Gabbana», infatti, anche nel caso «Bova» (42) laCassazione ha attestato, dunque, sull’art. 37 bis d.P.R. 600/1973 la linea delpenalmente rilevante, comprendendo nel territorio penalistico anche con-dotte elusive.
Per la verità, come segnalato da attenta dottrina (43), l’ultima sentenzanon si limita ad adeguarsi al dictum della sentenza «Dolce & Gabbana», macompie un ulteriore ampliamento del tipo penale: ammettendo la possibili-tà di ricondurre nell’art. 37 bis atti, fatti o negozi estranei a quelli elencatida quest’ultima norma, ma comunque assimilabili ad essi, si è aperta in viamediata la fattispecie incriminatrice al generale principio di divieto di abu-so del diritto, evocando il «delitto di elusione fiscale» (44), reato a forma libe-ra soggettivisticamente orientato.
Sul piano giudiziario esce di scena il disvalore d’evento, vale a dire l’eva-sione, inteso come accadimento economico-giuridico costituito dalla diffe-renza tra due fatti storici – l’imponibile dichiarato e l’imponibile esistente(45) – a favore del disvalore d’intenzione sotto forma di omessa giustificazio-
(40) Cass., III, n. 26723 del 18 marzo 2011, in Corr. Trib., 2011, 2937, con nota di Corso,Abuso del diritto in materia penale verso il tramonto del principio di legalità?
(41) Così la Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, Lagiurisprudenza delle Sezioni Unite e le principali linee di tendenza della Corte di Cassazione.Giurisprudenza penale, Tomo II, 57, leggibile sul sito della Corte al seguente indirizzo http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Rassegna%20Penale%202011.pdf.000.
(42) Cass., III, 6 marzo 2013 (dep. 3 maggio 2013), n. 19100, cit.(43) Troyer-Ingrassia, La rilevanza penale dell’elusione. Il caso Bova e il triangolo di
Penrose, cit., 2092.(44) Flora, Perché l’«elusione fiscale», cit., 869.(45) Sul significato delle soglie di cui all’art. 4 d. lgs. 74/2000, cfr. Ramponi, «Transfer
pricing» e categorie penalistiche. La selettività dell’illecito penale tributario tra disvalore d’azio-ne e disvalore d’evento, in questa Rivista, 2009, 231.
FEDERICO CONSULICH 13
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
ne (o che dir si voglia: di assenza di giustificato motivo), tipico di ben altreincriminazioni: l’assenza di valide ragioni economiche a supporto di condottein sé comunque lecite.
Compendiando il discorso fin qui sviluppato, per ricondurre anche lapronuncia sul cd. «Caso Bova» ad un minimo comune denominatore conquella che l’ha preceduta, si può osservare l’applicazione dell’art. 37 bis inmodo da smentire qualsiasi insegnamento in tema di efficacia oggettiva euniversale delle cause di giustificazione.
Per quanto recentemente contraddetta da un «obiter dictum» in unasentenza della Suprema Corte depositata nel settembre 2013 (46), si tratta diuna tendenza assai problematica per «la sistematica del diritto» oltre che, çava sans dire, per il tasso di garanzia complessivo del sistema penale.
Condotte lecite civilmente, in quanto espressione della libertà negozialeprivata, protetta costituzionalmente dall’art. 41 Cost., nonché dalle normedel codice civile che riconoscono, disciplinano e quindi garantiscono il liberoimpiego di determinati negozi giuridici, vengono disconosciute dal dirittotributario quanto agli effetti prodotti, definiti inopponibili rispetto al Fisco,e, infine, punite dal diritto penale.
Una sola condotta, tre differenti qualificazioni giuridiche: il dogma del-l’unità dell’ordinamento giuridico, che non tollererebbe diverse valutazioninormative di una medesima fattispecie, pare «polverizzato».
4. – Ai fini della responsabilità penale è decisivo, oggi, l’art. 37 bisd.P.R. 600 del 1973 (47). Introdotta con l’art. 7 del d. lgs. 358/1997 e intito-lato disposizioni antielusive, tale previsione è stata interessata poi da plurimiinterventi di interpolazione ispirati alla logica, reattiva, di frapporre un ar-gine rispetto alle variopinte operazioni e meccanismi escogitati dalla prassiper determinare un risparmio di imposta.
La disposizione «impone all’amministrazione una interpretazione ana-logica, vale a dire la estensione a fattispecie fiscalmente atipiche o “innomi-nate” del regime fiscale (più oneroso) previsto dalla legge per atti o negozi orelativi collegamenti tipici o “nominati” purché le due serie producano ri-
(46) Ci si riferisce a Cass., Sez. V, 16 gennaio 2013, n. 36859, Pres. Zecchi, Rel. Micheli, inwww.dirittopenalecontemponaneo.it (20 gennaio 2014) con nota di Cavallini-Troyer, Elu-sione, progressione criminosa e specialità: due passi avanti e uno «a lato» su tre topoi in materiapenaltributaria, che ha appunto affermato incidentalmente come debbano essere consideratepenalmente lecite quelle condotte elusive che non siano oggetto di specifica sanzione penale,unico segnale inequivoco di una volontà di penalizzazione da parte del legislatore.
(47) Sulla tipizzazione adottata ex post da parte del legislatore con riferimento all’art. 37bis cfr. Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, cit., 465 ss.
14 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
sultati simili» (48). In altre parole, l’art. 37 bis consente l’applicazione di undeterminato trattamento tributario ad ipotesi di atti, fatti o negozi, anchecollegati tra loro, che non rientrano nella sfera applicativa dalla norma chedisciplina a quali condizioni ricorre l’imposta. Di fatto, un elenco di negozigiuridici, in se stessi leciti, vengono qualificati come inopponibili al Fisco inbase a considerazioni soggettive, al disegno elusivo che anima l’agente (49).
L’interazione tra l’art. 37 bis e qualsivoglia norma penale, quindi anchequella di cui all’art. 4 che è la fattispecie «predestinata» a questo connubiocosì problematico con la norma tributaria in analisi, non determina soloun’integrazione del precetto penale, ma comporta la trasformazione in sensoanalogico della struttura della norma penale, di per sé incompatibile con ilprincipio di tassatività (50).
A dire il vero non è incontroversa l’interpretazione della norma anti-elusione (51).Accanto alla tesi della natura procedimentale dell’art. 37 bis, che qualifica tale disposi-zione come un criterio di accertamento implicante un mero obbligo di disconoscimentodegli effetti fiscali a posteriori (52), vi è chi ha sostenuto che l’articolo in parola potrebbecostituire una disposizione sanzionatoria e avere quindi natura sostanziale.
In quest’ultimo caso la conseguenza è chiara: se fosse un illecito amministrativo,questo escluderebbe, in base al principio di specialità di cui all’art. 9 della l. 689/1981,l’illecito penale di dichiarazione infedele (53); seguendo la prima interpretazione, ben
(48) Falsitta, Natura delle disposizioni contenenti «norme per l’interpretazione di norme»e l’art. 37 bis sull’interpretazione analogica o antielusiva, in Riv. dir. trib., 2010, 519 ss., 543.
(49) Recita il primo comma della norma: «Sono inopponibili all’amministrazione finanzia-ria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti adaggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposteo rimborsi, altrimenti indebiti».
(50) In questi termini, Perini, La tipicità inafferrabile, cit., 742. In senso conforme Gia-
cometti, La problematica distinzione, cit., 466.(51) A livello costituzionale il riferimento per l’ampliamento dell’applicabilità dell’art. 37
bis fino a farlo diventare la concretizzazione normativa di un più generale principio antielusi-vo sono gli artt. 2 e 53, comma 1 Cost. (Principio di capacità contributiva) e 53 comma 2Cost. (principio di progressività dell’imposizione). Il ragionamento è stato sviluppato daCass., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30055, successivo alle già esplicite sentenze Cass., sez.trib. n. 10257/2008 e 25374/2008.
(52) Nel senso della natura sostanziale della norma si esprime ad esempio Gallo, Rile-vanza penale dell’elusione, cit., 327; in senso assai problematico espone gli argomenti a soste-gno della natura sostanziale e procedimentale dell’art. 37 bis, Marcheselli, Elusione, buonafede e principi del diritto tributario, in Rass. trib., 2009, 414 ss. Sul tema si veda anche Cass.,sez. trib., 8 aprile 2009, n. 8487, che afferma, nella propria motivazione, come l’art. 37 bis sia«In definitiva, la norma di contrasto all’elusione non ha come finalità quella di penalizzare ilcontribuente che non ha commesso nessuna violazione, bensì quella di garantire l’uguaglianzadel trattamento fiscale. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, tende soltanto a riportare sotto ilregime della disciplina fiscale comune una operazione che a tale regime è stata sottratta senza ra-gione».
(53) Si tratta della tesi di Corso, Commento a Cass. pen., V, 18 maggio 2006, n. 34780, inCorr. Trib., 2006, 3049.
FEDERICO CONSULICH 15
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
più diffusa, si deve però ammettere che risulterebbe comunque illogico che un fatto le-cito per il diritto tributario, in quanto non sanzionato in alcun modo, sia punito penal-mente in un settore in cui si dovrebbe manifestare in massimo grado la funzione latusensu accessoria del diritto penale, quale ultima ratio dell’ordinamento (54).
Peraltro è stata la stessa Suprema Corte, consapevole delle frizioni già con il princi-pio di riserva di legge in materia tributaria, ad affermare che il principio antielusivo nondovrebbe essere sanzionatorio, ma ripristinatorio, comportando il mero disconoscimen-to degli effetti dei negozi posti in essere con intento abusivo (Cass., 8772/2008), comeperaltro enunciato nella ben nota e citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea nel caso Halifax (55).
Se prevalesse la tesi, che pare più corretta anche in considerazione delsistema di norme in cui si inserisce (nel titolo IV del d.p.r. 600/1973, dedi-cato all’accertamento e ai controlli da parte dell’amministrazione), per cuil’art. 37 bis determina la mera inopponibilità del negozio e dei suoi risultatieconomici all’amministrazione fiscale, la disposizione avrebbe natura dinorma-valutazione (norma di giudizio), con la funzione di supportare, expost, l’accertatore o il giudice rispetto al fatto da scrutinare. Non si tratte-rebbe di una norma-comando, poiché non opererebbe cioè come criterio dideterminazione del comportamento del consociato al momento in cui agi-sce (56).
In sostanza, non pare corretto impiegare ai fini penali l’art. 37 bis deld.P.R. 600/1973, per un duplice motivo, riguardante funzione e strutturadelle norme che si vorrebbe chiamare a cooperare.
i) Evidente la peculiarità funzionale della norma tributaria. Integrando-la con quella penale, attraverso il concetto di elemento passivo fittizio o atti-vo inferiore a quello effettivo, se ne tradirebbe la natura: si torcerebbe la ra-tio dell’art. 37 bis per punire la distorsione di una ratio di una norma (postoche in ciò si sostanzia l’elusione). Ad abuso del diritto del contribuente si ri-sponderebbe con un abuso del diritto istituzionale impiegando una normapreposta ad operare in una fase di controllo da parte del Fisco, per fondarein capo al contribuente obblighi di condotta a contenuto dichiarativo, pe-nalmente sanzionati.
(54) L’argomento è sviluppato da Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale. Quale rile-vanza penale?, cit., 465 ss.
(55) Cgce, 21 giugno 2006, proc. n. C-155/02, § 93, secondo cui «la constatazione del-l’esistenza di un comportamento antiabusivo non deve condurre ad una sanzione, per la qua-le sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro e univoco, bensì semplicemente a unobbligo di rimborso»; su cui si veda anche Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale: qualisanzioni tributarie?, in Giur. Comm., 2012, 177 ss.
(56) Utile richiamare, al fine di distinguere le regole di condotta dalle regole di giudizioDan-Cohen, Decision Rules and Conduct Rules: On Acoustic Separetion in Criminal Law, in97 Harv. L. Rev., 625 s. (1984).
16 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
ii) Altrettanto lampante è il vincolo strutturale della norma penale inquanto tale. Non pare possibile che il diritto penale, per la sua connaturataesigenza tipologica, cioè la necessità di procedere per categorie di condotteunitariamente e dettagliatamente descritte, dotate del medesimo disvalore(57), possa essere privato delle proprie radici. L’abuso del diritto, infatti, im-plica un sindacato opinabile dell’autorità pubblica sulla tollerabilità socialedell’esercizio di un diritto da parte del privato, sui costi collettivi derivantidalle sue scelte negoziali (58).
4.1. – La peculiare funzione della norma tributaria ben emerge non ap-pena si guardi al criterio di valutazione su cui si sostiene.
Come in tutte le norme incentrate su concetti normo-valutativi, il pro-blema essenziale è la determinazione del criterio di giudizio che deve seguirel’interprete nella applicazione della norma. L’art. 37 bis rende, infatti, inop-ponibili all’Amministrazione fiscale i costi derivanti da negozi privi di vali-de ragioni economiche (elemento normovalutativo), con conseguente colla-zione al reddito del contribuente del quantum indebitamente risparmiatoall’imposizione, con rischio di conseguente incriminazione penale ove sianosuperate le soglie di punibilità.
Il punto dolente è la criteriologia dell’accertamento della mancanza divalide ragioni economiche dell’operazione negoziale.
Accanto ai consueti «casi facili», occorre, infatti, predeterminare unaprocedura interpretativa per gestire quelle ipotesi in cui la mera razionalitàeconomica non è evidente: è noto che il giudice penale fatica a districarsi infattispecie ad altissimo tasso di complessità tecnica. Alla consueta mancan-za di leggi scientifiche «di copertura» spendibili in questo ambito, si posso-no sommare motivazioni personali: come valutare, ad esempio, il caso dellarinuncia del contribuente ad un diritto nell’ambito di una successione te-stamentaria (59)?
Se accettiamo l’assunto che un negozio intrapreso per mere finalità fi-scali sia penalmente rilevante, risulta difficile giustificare perché, ad esem-pio, non costituisca un abuso del diritto l’insediamento di stabilimenti in-dustriali nelle regioni meridionali del Paese (60), per fruire di incentivazioni
(57) Sul concetto di tipo, nella dottrina italiana, si veda per tutti, Palazzo, Il principio dideterminatezza nel diritto penale, Padova, 1979, 356 ss.
(58) Sulle esigenze ordinamentali sottese al concetto dell’abuso del diritto si vedano le ri-flessioni di Spena, Diritti e responsabilità penale, Milano, 2008, 139.
(59) Non a caso anche nella dottrina tributaria si riconosce come i risultati dell’operazionenon siano affatto sicuri, cfr. Mastroiacovo, L’economicità delle valide ragioni (note minime amargine della recente evoluzione del principio dell’abuso del diritto), in Rass. trib., 2010, 449 ss.
(60) Art. 37 d.l. 179/2012 convertito con l. n. 221/2012.
FEDERICO CONSULICH 17
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
fiscali oppure l’assunzione di un disoccupato di età inferiore a trenta anniin luogo di uno più anziano (61): si tratta, infatti, di ipotesi in cui la logica delrisparmio fiscale è esclusiva eppure fomentate dal legislatore (62).
Quello dell’impiego ai fini penali del concetto di equivalenza funzionale tra una dataprocedura negoziale civilistica ed un’altra, corretta agli occhi dell’amministrazione, è untema ormai frequente nel diritto tributario con una possibile ricaduta penale. Si tratta,in effetti, dello stesso modus procedendi che si registra rispetto al transfer pricing, allor-ché si assista ad una determinazione accentrata del prezzo di trasferimento di beni e ser-vizi nell’ambito di transazioni tra società di un medesimo gruppo aventi sedi in Stati dif-ferenti (63). Al valore effettivamente attribuito ad un bene o a un servizio nell’ambito delgruppo se ne sostituisce un altro, giudicato corretto dall’amministrazione fiscale, perevitare l’attuazione di politiche di tax plannig, in cui il prezzo, più elevato o più basso diquello tra società indipendenti, porti con sé la riduzione o l’incremento di reddito per lesocietà del gruppo, a seconda delle convenienze fiscali. Tale prassi è contrastata in Italiacon una norma antielusiva, oggi rappresentata dall’art. 110 comma 7 d. lgs. 344/2003(tuir), disposizione che sostanzialmente rilegge le operazioni infragruppo sostituendoai corrispettivi effettivi il cd. valore normale del bene o servizio acquistato o ceduto, defi-nito ai sensi dei criteri di cui all’art. 9 tuir, il cui principio ispiratore è quello della liberaconcorrenza sulla base delle indicazioni dell’ocse (64). La valutazione si conclude conun’integrazione del prezzo e quindi in definitiva in una rettifica dei componenti del red-dito d’impresa.
La locuzione della mancanza di valide ragioni economiche impingequindi ardue valutazioni in fatto e altrettanto difficili oneri motivazionali,che comportano un elevato margine di discrezionalità applicativa e inevita-bilmente conducono ad estendere in via analogica la norma penale.
Inserendo, in via interpretativa, l’art. 37 bis nel contesto dell’art. 4 deld. lgs. 74/2000, si finisce per punire la discrasia tra quanto il contribuenteavrebbe dovuto percepire o corrispondere a terzi durante l’anno fiscale equanto indicato effettivamente in dichiarazione. Non più solo la differenza
(61) Si veda l’incentivo, di cui all’art. 1 del d.l. 76/2013 (convertito con modificazioni dal-la l. 99/2013).
(62) Gli esempi si potrebbero moltiplicare ad libitum. In generale si può dire che se èl’equivalenza funzionale il reale criterio identificativo dell’abuso del diritto è consequenzialeche il diritto penale finisca per dipendere da ragionamenti analogici. Per queste considerazio-ni, anche alla luce di un’articolata esemplificazione tra cui ricade anche l’esempio del trasferi-mento d’azienda ai sensi dell’art. 176 tuir, Perini, La tipicità inafferrabile, cit., 743 ss.
(63) Per una tassonomia dei diversi tipi di transfer pricing e per una definizione del feno-meno cfr. Alonzo-Committeri-Pallaria-Scifoni, Transfer pricing e paradisi fiscali, Mila-no, 2008, 50 ss.
(64) Sui criteri per il riferimento del valore normale di un bene o di un servizio cfr. Gay, Il«valore normale» nelle transazioni infragruppo: recenti sviluppi e prospettive, in Riv. int. trib.int., 2005, 219 ss.; per una prospettiva tipicamente penalistica del tema, Ramponi, «TransferPricing» e categorie penalistiche, cit., 193 ss.; in precedenza Troyer, Il transfer pricing traelusione ed evasione, in Riv. dott. comm., 2006, 1279 ss.
18 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
tra quanto percepito e ciò che invece è stato dichiarato: la deontologia fiscaleassume rilievo penale e si estende ad un caso simile a quello previsto espres-samente dalla legge il medesimo trattamento punitivo (65).
In tal modo, quindi, una divergenza interpretativa tra contribuente eamministrazione fiscale assume un rilievo penale grazie all’abuso del dirit-to, che funge da «trasformatore permanente» dell’esercizio del diritto incompimento di un delitto (66).
Se si ritiene che il paradigma interpretativo tipologico sia quello che l’in-terprete deve adottare, in cui nessuno spazio hanno concetti come equiva-lenza funzionale tra negozio elusivo e negozio corretto o tra valore effettivodel bene o del servizio e valore normale, ecco che il tema dell’abuso del di-ritto perde subito di consistenza in termini di garanzia.
Risultano sotto altra luce anche le disposizioni del d. lgs. 74/2000 chesolitamente fungono da perno dell’interpretazione favorevole alla rilevanzapenale dell’abuso del diritto: la definizione di cui alla lett. f) dell’art. 1 el’art. 16 forniscono al più un indizio sulla rilevanza della elusione, ma nonne definiscono in alcun modo le condizioni di tipicità. Quanto alla primadisposizione, nella definizione di imposta evasa non rientrerebbe l’impostaelusa, perché quest’ultima non è imposta dovuta dal contribuente, ma sem-plicemente pretesa ex post facto dall’amministrazione; così pure l’art. 16,che costituisce una norma di favore idonea ad escludere il dolo dell’illecitoin caso di richiesta di parere e non a fondarlo in caso di omessa richiesta.
Per completezza anche l’art. 7 del d. lgs. 74/2000 è una disposizione chedepone nel senso dell’irrilevanza dell’elusione fiscale, poiché nel sancire la
(65) Secondo Veneziani, Elusione fiscale, «esterovestizione» e dichiarazione infedele, cit.,865, la giurisprudenza manifesta nei suoi ultimi pronunciamenti una inversione ermeneutica,procedendo dal tipo fiscale, l’art. 37 bis, al tipo penale, le norme incriminatrici del d. lgs.74/2000. Per comprendere i rapporti tra evasione penalmente rilevante ed elusione fiscale lagiurisprudenza parrebbe aver adottato il procedimento di previa qualificazione in termini dirilevanza fiscale alla luce delle norme antielusive della condotta concreta per poi qualificarleai sensi di una delle disposizioni incriminatrici del d. lgs. 74/2000. Si tratta di un modello ete-rodosso di qualificazione penalistica, poiché inserisce nell’ordinario procedimento di sussun-zione una fase intermedia per nulla necessaria: ciò che va confrontato, anche di fronte a que-ste vicende fiscali, è se la condotta concreta sia tipica alla luce della sola fattispecie penale.
(66) Insomma, l’interpretazione secondo cui l’abuso del diritto ha cittadinanza nel dirittopenale viola il dovere del giudice di interpretare le norme penali orientandosi alla garanziadell’imputato: i diritti dell’accusato in sede penale sono, infatti, costituzionalmente prevalentirispetto a quelli della vittima (individuale o collettiva che sia, come nel caso dei delitti tributa-ri). I diritti di quest’ultima sono, infatti, già contemplati e protetti attraverso la legalità cheimpone la formalizzazione della loro tutela in una norma di legge. Per questa tesi, in generalee non con riferimento all’elusione fiscale, si veda Velluzzi, Due (brevi) note sul giudice pena-le e l’interpretazione, in Criminalia, 2012, 310; in argomento cfr. Donini, Disposizione e nor-ma nell’ermeneutica penale, in Biscotti-Borsellino-Pocar-Pulitanò (a cura di), La fab-brica delle interpretazioni, Milano, 2012, 90.
FEDERICO CONSULICH 19
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
non punibilità delle valutazioni discendenti da criteri esplicitati, evidente-mente a fortiori non può punire condotte elusive che per definizione sonomostrate in bella evidenza all’amministrazione (67).
La fittizietà, in questo quadro non può esaurirsi in una mera irregolaritànell’esposizione di un costo esistente in rerum natura; per divenire fittizia insenso penalistico, la posta indicata nella dichiarazione fiscale deve possede-re una capacità falsificatrice (68).
5. – Presto dette le conseguenze dell’impiego dell’abuso del diritto conparticolare riferimento alla fattispecie di dichiarazione infedele, la più espo-sta al ricorso a tale canone ermeneutico.
Le incriminazioni formalizzate nel d. lgs. 74/2000, come noto, hannocostituito il paradigma del diritto penale d’evento, attraverso fattispecie in-criminatrici a forma vincolata, in reazione ad una situazione previgente dicriminalizzazione del pericolo presunto attraverso cd. delitti ostacolo.
Un diritto penale razionale, quello in materia tributaria, che però, concrescente velocità a partire dalla fine dello scorso decennio, ha subito unatorsione con riferimento alle «maglie» più deboli dell’impianto del decretolegislativo, costituito dalle disposizioni in tema di dichiarazione infedele eomessa dichiarazione.
Incentrate su concetti normativi, vere e proprie clausole generali, tali
(67) In questo senso Marcheselli, Elusione, buona fede e principi del diritto tributario,cit., 410 e Ramponi, «Transfer pricing» e categorie penalistiche, cit., 224 ss.
(68) In assenza di una definizione legale di elusione fiscale ed evasione fiscale, nonché diuna casistica tassativa delle norme antielusive rilevanti per il diritto penale, l’unico riferimen-to deve essere la norma incriminatrice: dovrà sempre optarsi per l’irrilevanza ai fini penalidella mera indeducibilità fiscale in assenza di una norma pensata ad hoc per il diritto penale,che integri i termini della fattispecie incriminatrice in relazione a questa ipotesi. Se valesse in-vece la tesi secondo cui si deve tenere conto anche delle componenti di costo indeducibile perl’applicazione dell’art. 4 e se la conseguenza dell’elusione fosse la non deducibilità delle com-ponenti negative del reddito scaturenti dai fatti elusivi, ecco che si potrebbe chiudere il sillo-gismo attribuendo così a cascata rilevanza penale ai fatti elusivi. Ovviamente lo stesso varreb-be, specularmente, per gli elementi attivi effettivi non dichiarati in conseguenza di un fattoelusivo. Sul punto cfr. Perini, La tipicità inafferrabile, cit., 736. L’atipicità penale deriva dal-l’assenza di rischio tipico, pur essendo irregolare sotto il profilo contabile e fiscale, dell’attri-buzione della competenza di esercizio ad un certo costo allorché l’erronea rappresentazioneconsegua ad un criterio costante di redazione della contabilità ai sensi dell’art. 7 d. lgs.74/2000; lo stesso qualora siano esposti i criteri delle valutazioni nonostante siano irregolari,ancora una volta in base all’art. 7. Quel che manca in questi casi è la capacità decettiva. Nellostesso senso del testo già Ramponi, «Transfer pricing» e categorie penalistiche, cit., 241;Mangione, La dichiarazione infedele, cit., 140; Dassano, La dichiarazione fraudolenta tra au-tonomia di disciplina e regole di contesto, cit., 144. Ritiene invece che l’art. 4 sia in grado di ri-comprendere, oltre ai costi inesistenti, anche i costi non di competenza e quelli privi di ine-renza eppure conteggiati nella dichiarazione fiscale Perini, Il delitto di dichiarazione infedeleex art. 4 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in Dir. pen. proc., 2000, 1259 ss.
20 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
fattispecie criminose si sono rivelate ben presto assai malleabili e cedevoliad interpretazioni estensive: quando se ne è presentata l’occasione, l’art. 4e, in parte, l’art. 5 del d. lgs. 74/2000 si sono mostrati come fattispecie incri-minatrici di tipo aperto (69).
Il tipo penale dell’art. 4 si presenta come un illecito di modalità di lesio-ne, poiché l’evasione, l’evento (70), deve conseguire ad una condotta decet-tiva, apprezzabile in termini di falsità (71). Il collegamento deve avere naturacausale, nel senso che rileverà solo l’evasione che consegua alla falsità e nonad altre (o anche ad altre, per sommatoria) condotte, ad esempio di naturaelusiva. Il delitto di dichiarazione infedele costituisce un’ipotesi di falsitàideologica del privato, qualificato dall’oggetto materiale della condotta, dalveicolo della falsità, costituito dalla dichiarazione dei redditi o dell’iva (72).
Il tipo legale della dichiarazione infedele è, nell’interpretazione più re-cente della Suprema Corte già richiamata è del tutto differente. Ormai il pa-radigma del reato fiscale a forma libera, il cui rapporto con la dimensioneeffettuale dell’illecito è solo apparentemente garantito dal superamentodelle soglie di punibilità previste dalla disposizione, tanto che si è parlato aquesto proposito di un illecito aquiliano a fronte di un danno all’erario chesuperi le soglie previste dalla legge (73), ad indicare un delitto ormai disinca-gliato dalla tipicità.
A ciò si aggiunga che la fattispecie di dichiarazione infedele può essereletta come un reato di mera condotta; si può infatti parafrasare la norma co-me la redazione di una dichiarazione fiscale falsa per «ipoindicazione» del-l’attivo reddituale o «ipermanifestazione» del passivo: l’effetto di evasione èdunque così sincopato rispetto alla condotta da essere più apparente chereale.
Se valesse quanto ora detto ed il processo interpretativo della giurispru-denza fosse condotto alle sue coerenti conseguenze, la dichiarazione infe-dele si scolorirebbe in un reato di mera condotta a forma libera (sic!), accom-pagnata dal superamento della soglia quantitativa: nulla di più indetermina-to dunque.
(69) Nel caso di cui all’art. 5 del d. lgs. 74/2000, l’elemento che si presta ad interpretazio-ni attraverso il criterio dell’abuso del diritto è costituito dal presupposto implicito della con-dotta, il dovere di presentare le dichiarazioni fiscali, qualora si intenda come penalmente rile-vante l’elusione di tale dovere attraverso negozi giuridici pensati in chiave antifiscale.
(70) Definiscono l’offesa di questa fattispecie come un evento di danno rappresentatodall’evasione di imposta, nella misura minima indicata dalla soglia di punibilità, Musco-Ar-
dito, Diritto Penale tributario, cit., 166.(71) Sul punto Ramponi, «Transfer pricing» e categorie penalistiche, cit., 235.(72) Veneziani, Sub art. 3, in Caraccioli-Giarda-Lanzi (a cura di), Diritto e procedura
penale tributaria, cit., 141.(73) Veneziani, Elusione fiscale, «esterovestizione» e dichiarazione infedele, cit., 867.
FEDERICO CONSULICH 21
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
5.1. – Non ci si deve però arrestare al piano della tipicità del reato, poi-ché è possibile scorgere anche importanti conseguenze in tema di dolo.
Il defedamento del tipo oggettivo (e quindi del suo disvalore) implical’attribuzione di un primario ruolo per l’intenzione (sotto forma di finalitàd’evasione), chiamata a compensare l’assenza del disvalore dell’azione: puresordendo come elemento soggettivo, tale finalità si riverbera, in un circolocostitutivo della tipicità, sulla condotta, determinandola.
Non è più il dolo a essere «specchio del fatto», come usualmente si inse-gna, ma il fatto a riflettere il dolo. Quest’ultimo è però un criterio normativodi imputazione dell’illecito definito in modo incompiuto dall’art. 43 comma1 c.p.; le vicissitudini interpretative e la perenne incertezza in ordine allanatura, alla struttura e all’ampiezza del dolo eventuale dimostrano l’incom-pletezza della formalizzazione legale (74).
Il dolo, proprio perché sfugge ad un’esaustiva definizione normativa, sipresta ad una rilettura e ad una precomprensione ermeneutica da parte del-l’interprete che ne ricrea, al momento dell’applicazione della norma penale,il contenuto, plasmandolo inevitabilmente con categorie pregiuridiche, an-che di carattere etico, e con valutazioni assiologiche sul significato di queltipo di condotte cristallizzate nella legge penale (75).
La capacità tipizzante del dolo è ben studiata e, in definitiva, utile senon ineliminabile (76); non altrettanto indagati sono forse i limiti di tollera-bilità, le «dosi massime» dell’induzione della tipizzazione in sede penalemediante elementi soggettivi. In altro modo: vi è un limite oltre cui la fisio-logia dell’intervento del dolo nel tipo si tramuta in patologia, ma non èchiaro quale sia tale soglia.
Nel campo del diritto penale economico il dolo è oggi ubiquitario: dalpunto di vista processuale, la sua prova trasuda da segni equivoci (la teorica
(74) Su cui si veda Pagliaro, Il reato, Milano, 2007, 96 e più di recente Pulitanò, I con-fini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 25.È stata la stessa Cassazione a Sezioni Unite a dirci dopo tutto che «il dolo eventuale è una figu-ra di costruzione giurisprudenziale e dottrinale, non forma oggetto di una testuale previsione le-gislativa, la sua costruzione è rimessa all’interprete» (così Cass., sez. un., 26 novembre 2009, n.12433 in Cass. pen, 2010, con nota di Donini, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricetta-zione. Le Sezioni Unite riscoprono l’elemento soggettivo.
(75) Si vedano in tema le osservazioni di Pulitanò, I confini del dolo, cit., 25.(76) Sul ruolo del dolo già a livello oggettivo, a mero titolo di esempio, Donini, Illecito e
colpevolezza nell’imputazione del reato, Milano, 1991, 70 ss., che evidenzia ad esempio (80)come abbia rilevanza generale ed oggettiva, prima dell’accertamento della rappresentazioneeffettiva, la valutazione sulla rappresentabilità del rischio che ha dato causa all’evento lesivo;successivamente Id., Illecito umanistico e colpevolezza personale, in Id., Il volto attuale dell’il-lecito penale, Milano, 2004, 197 ss. ove l’A. evidenzia (205) che «occorre concepire il dolo e lacolpa “come” azione, oltre che “come” colpevolezza».
22 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
dei segnali d’allarme) ed esso viene finanche «dato per scontato» e quindiaccantonato come tema di indagine attraverso il ricorso a formule presunti-ve (id est: l’imputato non poteva non sapere) (77); in campo sostanziale, inve-ce, il dolo pervade a volte l’intera incriminazione, non limitandosi a com-pensare il deficit di materialità del fatto con un surplus di disvalore di inten-zione, ma rischiando di giungere ad esaurire il disvalore del reato: è proprioil caso dell’abuso del diritto applicato ai reati tributari (78).
Con essa si segna un’ardita sintesi tra dolo generale, inteso come generi-co antagonismo soggettivo all’ordinamento, e atipicità oggettiva della con-dotta, che anzi è addirittura lecita se non usualmente protetta dalla legge.
Ed ecco qui lo schema a cui si giunge in un pericoloso corto circuito trafatto e dolo, poiché l’esercizio di un diritto – punto di vista oggettivo – assu-me rilevanza penale qualora sia guidato da un’intenzione antifiscale, dalpunto di vista soggettivo.
Una simile chimera normativa, in cui fatto e dolo si fondono pur andan-do «in direzioni opposte», non pone solo un problema di condizioni di uti-lizzo del dolo per la costruzione del tipo penale, ma altresì, ancora una volta,il tema della garanzia per il corretto impiego della scriminante dell’eserciziodel diritto (79).
6. – La figura dell’abuso del diritto ben si colloca nel contesto, semprepiù «di lotta» (80), del diritto penale tributario, con particolare riferimentoproprio al tema dell’evasione fiscale.
(77) Sul punto Iacovello, Processo di parti e prova del dolo, in Criminalia, 2010, 499 ss.;sia consentito anche il rinvio a Consulich, Nolo cognoscere. Il diritto penale dell’economiatra nuovi responsabili e antiche forme di responsabilità «paracolpevole»: spunti a partire dalnuovo art. 236 bis l.f., in questa Rivista, 2012, 613 ss.
(78) L’abuso del diritto è un concetto elaborato dalla dottrina civilistica per consentire algiudice il sindacato sull’autonomia negoziale dei privati. Sottende, per la definizione del pro-prio ambito operativo, una valutazione comparativa di interessi contrapposti. Sul punto si ve-da Perlingieri, Profili civilistici dell’abuso tributario. L’inopponibilità delle condotte elusive,Napoli, 2012, 15.
(79) Il risultato tipico di tale comparazione è la restrizione del perimetro del giuridica-mente consentito e protetto, sulla base di una lacuna assiologica percepita dal giudice. Incisi-va in questi termini la riflessione di Giacometti, La problematica distinzione tra evasione,elusione fiscale e abuso del diritto, cit., 462.
(80) Per una definizione del diritto penale di lotta come concetto normativo distillato dal-le direttive di politica del diritto esplicitate nei preamboli degli atti comunitari (si veda la de-cisione quadro 2004/757/GAI del 25 ottobre 2004) e delle convenzioni internazionali (ad es.la Convenzione della Nazioni unite contro il crimine organizzato transnazionale) cfr. Doni-
ni, Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico, in Gamberini-Orlandi (a cura di),Delitto politico e diritto penale del nemico, cit., 132 ss. Evidenzia come anche nelle dichiara-zioni dei politici, in particolare del Presidente del Consiglio Monti nell’agosto del 2012, simanifesti la convinzione che l’ordinamento sia in guerra contro l’evasione fiscale Perini, Latipicità inafferrabile, cit., 750.
FEDERICO CONSULICH 23
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
Con l’abuso del diritto, si rimprovera al contribuente lo sfruttamentodel «disallineamento» della lettera della legge rispetto alla propria ratio (81).Ciò equivale a pretendere dal contribuente, sotto minaccia di pena, di ren-dersi una sorta di guardiano dello spirito della legge tradito dal legislatorestorico.
Anche per il diritto penale la costatazione generale formulata con riferi-mento al rapporto tra abuso del diritto e illecito civile, secondo cui «il giu-dizio funzionale della condotta implica una presa di posizione della fonte in-torno agli scopi ammessi e non ammessi. Tutta la moderna teoria dell’abusoruota [...] intorno alla rilevanza dello scopo ed alla eventuale eccedenza dellacondotta rispetto allo scopo ammesso dall’ordinamento» (82).
Si impone insomma un limite «interiore» alla volontà del cittadino, chepoco si concilia con la natura stessa del diritto soggettivo se lo si concepiscealla luce della will theory o choice theory, in base a cui un diritto è tale inquanto l’ordinamento riconosce e rispetta la scelta dell’individuo in ordinea come impiegarlo (afferma Hart: «one who has a right has a choice respectedby the law» (83)).
Presupposto di ammissibilità del vaglio sul corretto esercizio di unaprerogativa giuridicamente tutelata, foriero anche della sua punibilità, è in-vece l’adesione ad una diversa concezione, orientata al pensiero di Bentham,ovvero la interest theory (o benefit theory): un soggetto è titolare di un dirit-to, e quindi beneficiario di una condotta obbligatoria da parte di terzi, inquanto «lo meriti», cioè lo eserciti responsabilmente, nell’interesse genera-le. Il presupposto è dunque che esista un parametro oggettivo di valutazio-ne delle scelte del cittadino sui propri diritti (84).
La riconversione di un diritto scriminante in una condotta punibile de-riva proprio dalla valutazione della dannosità sociale della condotta in sé le-cita.
Nel concetto di abuso del diritto sono impliciti criteri teleologici atti-nenti alla valutazione della funzione sociale della condotta in relazione allaratio legis della disposizione da cui scaturisce il diritto soggettivo (85).
(81) Così Marcheselli, Elusione, buona fede e principi del diritto tributario, cit., 418. Evi-denzia come l’individuazione della ratio di una norma è caratterizzata da un’elevata discrezio-nalitàVelluzzi, Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale, Torino, 2002, 125 ss.
(82) In questi termini Orlandi, Abuso del diritto e teoria della fonte, cit., 126.(83) In questo senso Hart, Legal Rights, (1973), ried. In Hart, Essays on Bentham, Stu-
dies in Jurisprudence and Political Theory, Oxford, 1982, 188.(84) Per la distinzione tra will theory e la contrapposta teoria della interest theory cfr. Ce-
lano, I diritti nella juurisprudence anglosassone contemporanea. Da Hart a Raz, in Coman-
ducci-Guastini (a cura di), Analisi e diritto 2001, Torino, 2002, 20 ss.(85) Per un’analisi storica dei criteri impiegati dalla giurisprudenza italiana per distingue-
24 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
Non a caso quindi, l’elemento centrale della definizione dell’abuso deldiritto è la dimensione assiologica del concetto, la lettura di norme di leggeordinarie alla luce di principi che conferiscono una nuova veste giuridica aduna condotta in precedenza astrattamente lecita (86); attorno a questo pro-cedimento di «rilettura» della norma alla luce di un principio extralegaleruota il concetto di abuso del diritto. Quest’ultimo è uno strumento di ade-guamento indebito di norme giuridiche attributive di un diritto rispetto adesigenze di politica criminale.
Nella manifestazione penalistica del fenomeno, però, la nozione di abu-so del diritto entra immediatamente in frizione con tutti i corollari della le-galità. Non si tratta solo del principio di determinatezza delle fattispecie in-criminatrici, ma anche di quello di materialità. L’elusione patisce, infatti,una carenza di percepibilità empirica del fatto illecito: l’artificiosità dellacondotta può apprezzarsi in termini esclusivamente normativi. In questi ca-si i dati oggetto di dichiarazione fiscale sono rappresentati correttamentedal contribuente al Fisco, né vi è alcuna alterazione della realtà per il trami-te di condotte simulatorie, che presentano cioè una divergenza tra il volutoed il dichiarato; il contribuente sfrutta margini di scelta, lasciati dalla for-mulazione letterale della norma, per diminuire o escludere un debito tribu-tario (87).
Viene eroso anche il principio di tipicità, per il tasso di soggettivizzazio-ne insito nel concetto di abuso e per lo slabbramento della fattispecie chene deriva.
Queste garanzie penalistiche hanno però un vizio genetico che depo-
re tra uso legittimo e abuso di un diritto Pino, L’abuso del diritto tra teoria e dogmatica (pre-cauzioni per l’uso), in Maniaci (a cura di), Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica, Mila-no, 2006, 145 s.
(86) Si vedano Atienza-Manero, Abuso del diritto e diritti fondamentali, cit., 33, che in-dicano come elementi costitutivi della nozione di abuso del diritto i) la presenza di una regolache consenta una data condotta, ii) la presenza di un danno a terzi della condotta consentita,iii) la finalità illecita o orientata al danno altrui come movente dell’azione del titolare del dirit-to e, infine, iv) il fatto che la condotta in concreto esorbiti dal perimetro del principio che giu-stificava la regola permissiva.
(87) In questo senso, Musco-Ardito, Diritto penale tributario, cit., 179. Per una declina-zione del problema della rilevanza penale dell’elusione fiscale in chiave di transfert pricing,Lanzi, I riflessi penali dell’elusione fiscale, il transfer pricing e il CFC, cit., 14 ss. Il transfer pri-cing rappresenta il fenomeno economico per cui le transazioni commerciali tra più società re-sidenti fiscalmente in Paesi diversi e appartenenti ad un medesimo gruppo sono sottopostealla determinazione di un medesimo prezzo, definito in modo accentrato dalla capo-gruppo,con evidenti ricadute in termini di quantificazione del reddito imponibile di ciascuna, chepuò risultare differente da quello che ogni società avrebbe conseguito ove non fosse stata par-te di un gruppo. Per un’analisi del fenomeno del transfer pricing in chiave penalistica si vedaRamponi, «Transfer pricing» e categorie penalistiche, cit., 193 ss.
FEDERICO CONSULICH 25
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
tenzia grandemente la loro portata e impedisce che possano svolgere la fun-zione di limite del diritto penale rispetto all’abuso del diritto.
Quest’ultimo è, infatti, una distorsione di una scriminante, di un diritto odi una libertà, non di un’incriminazione. La vaghezza del diritto scriminante,così come la soggettivizzazione dello stesso, non sono arginabili da principidi garanzia validi tradizionalmente solo per il fatto tipico; occorre dunqueelaborare principi di tutela validi specificatamente per la giustificazione.
Si noti, infatti, che la categoria dell’antigiuridicità è l’unica delle trecomponenti del reato ad essere priva di principi penalistici assiologicamen-te connotati che ne guidino l’applicazione (quali sono ad esempio, per il fat-to, il principio di precisione, di tipicità o di materialità e, per la colpevolez-za, il principio di cui all’art. 27 comma 1 Cost.).
Eppure anche dal fronte dell’antigiuridicità possono provenire profon-di vulnera alle garanzie del destinatario del precetto penale, se è vero che latrasformazione del lecito in delitto, dell’esercizio di un diritto in un abusopenalmente rilevante depriva di prevedibilità il complessivo ordinamentopenale, impedendo di prevedere i confini delle scriminanti usualmente ap-plicabili in contesto economico.
La questione di fondo è dunque l’individuazione di un principio giusti-ziabile e specifico che presieda alla interpretazione e all’evoluzione, norma-tiva e giurisprudenziale, dei diritti allorché si pongano come scriminanti,cioè quando interagiscono con l’incriminazione.
7. – L’abuso del diritto, come criterio ermeneutico, risulta quindi pro-blematico per il diritto penale costituzionalmente orientato (88).
Il richiamo alla legalità del reato non è stato però finora sufficiente acontenere la metamorfosi interpretativa del fatto di reato, posto che la rilet-tura delle fattispecie tributarie alla luce della teoria dell’abuso del dirittocostituisce un fenomeno evidente nella prassi.
Non è detto che la legalità nazionale sia l’unico argine contro simili de-rive interpretative; vi è, infatti, un diverso paradigma di legalità rispetto alquale la rilevanza penale dell’abuso del diritto può apparire illegittima.
L’ordinamento italiano, tradizionalmente incentrato sul monopoliodella disposizione legale nella definizione del campo di responsabilità pena-le, sta scoprendo progressivamente la forza cogente del precedente giudi-ziale delle giurisdizioni superiori.
Si tratta di un processo sotterraneo ormai emerso non solo entro i confi-ni nazionali, ma tematizzato anche a livello continentale, in quegli ordina-
(88) Cfr. Flora, Perché l’«elusione fiscale», cit., 869.
26 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
menti, quale quello francese, in cui il ruolo creativo del giudice non è unamanifestazione ortodossa e consueta della vita del sistema normativo (89).
Tra le giurisdizioni sovranazionali più attente alla definizione di una li-nea di tutela nei confronti del diritto penale giurisprudenziale, figura certa-mente la Corte europea dei Diritti dell’Uomo che nella seconda metà delloscorso decennio ha guadagnato un rango di primissimo piano dal punto divista operativo, consacrato poi grazie a due note sentenze di un’altra giurisdi-zione superiore, questa volta nazionale, ovvero della Corte costituzionale (90).
Come noto, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è antiformali-
(89) Si evidenziano in particolare le riflessioni della letteratura francese, Allard-Gara-
pon, Les juges dans la mondialisation. La nouvelle révolution du droit, Paris, 2005, 84; Del-
mas Marty, Mondializzazione e ascesa al potere dei giudici, in Vogliotti (a cura di), Il tra-monto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, Torino, 2008, 127 ss. Nell’indi-viduazione di uno statuto penale delle incriminazioni e delle giustificazioni, occorre ammet-tere che la cifra caratterizzante del diritto penale contemporaneo sia la dimensione qualitati-vamente e quantitativamente crescente del ruolo creativo del giudice. Che il dato sia un’evo-luzione o un’involuzione per le garanzie penalistiche è ampiamente discusso nel dibattitoscientifico. Si vedano, per rimanere alle più recenti, le riflessioni, assai articolate e complesse,di Fiandaca, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età delprotagonismo giurisdizionale, in Criminalia, 2011, 79 ss.; Palazzo, Testo, contesto e sistemanell’interpretazione penalistica, in Dolcini-Paliero (a cura di), Studi in onore di Marinucci,I, Milano, 2006, 515 ss.; Mazzacuva, A proposito della «interpretazione creativa» in materiapenale: nuova garanzia o rinnovata violazione di principi fondamentali?, in Dolcini-Paliero
(a cura di), Studi in onore di Marinucci, I, cit., 437 ss.; Pulitanò, Sull’interpretazione e gli in-terpreti della legge penale, in Dolcini-Paliero (a cura di), Studi in onore di Marinucci, I, cit.,657; da ultimo Manes, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fontisovranazionali, Roma, 2012, 22 ss.
(90) In forza delle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 (Sui riflessi penalistici di queste duedecisioni Abbadessa, Il nuovo rango sub-costituzionale della Cedu: riflessi sul diritto e sul pro-cesso penale domestico, in [email protected], 2008, 399 ss.), seguite poi dalla sentenza 311/2009e 317/2009, che ne hanno sostanzialmente confermato l’impianto, le norme della Cedu costi-tuiscono parametro interposto di legittimità costituzionale, il cui tassello normativo costituzio-nale è rappresentato dall’art. 117 Cost. È bene sottolineare che il parametro interposto di le-gittimità costituzionale non è costituito dalla mera lettera della Convenzione, ma dall’inter-pretazione che ne viene fornita dalla giurisprudenza della Corte che ne costituisce organo ap-plicativo. Il paradigma operativo è quello della judicial law making, in cui l’evoluzione, purnell’ambito di una sorta di vincolo del precedente, è possibile attraverso distinguishing ooverruling, oppure attraverso il riconoscimento da parte della Corte di un’evoluzione degliordinamenti partecipanti al sistema convenzionale, qualora questi facciano emergere unanuova garanzia o una nuova declinazione di una garanzia preesistente, che in precedenza nonerano emerse. Quest’ultimo ad esempio è stato il modello in cui è possibile incardinare il notopronunciamento sul cd. «caso Scoppola», cfr. Corte Edu, 17 settembre 2009, Scoppola vs. Ita-lia, che ha sancito il principio dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole al reo,nell’ambito dell’art. 7 Cedu. Ritiene che la sentenza si giustifichi alla luce della percezione daparte dei Giudici di Strasburgo della formazione di un nuovo consenso europeo sul principiodella retroattività della lex mitior Manes, La lunga marcia della Convenzione europea ed i«nuovi» vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in Manes-Zagrebelsky (acura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Mila-no, 2011, 21.
FEDERICO CONSULICH 27
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
stica e sincretistica, fondendo gli orizzonti tra civil law e common law sulpiano della definizione delle fonti della responsabilità penale e delle relativegaranzie. E così il principio del nullum crimine sine lege finisce per adattarsialla norma incriminatrice reale, quale risulta forgiata dalla giurisprudenza,e non più alla sola disposizione astratta.
Il principio di legalità ed irretroattività delle norme penali incriminatri-ci o aggravatrici del trattamento sanzionatorio (salvo, in base al paragrafo 2dell’art. 7 Cedu, per i fatti che, già al momento della commissione, doveva-no considerarsi come criminali in base ai principi generali del diritto rico-nosciuti dalle nazioni civili (91)) si inscrive nel nucleo fondativo della Cedu(92), come tale insopprimibile e incomprimibile (93), anzi dotato di forzaespansiva primordiale, grazie al collegamento operativo con il concetto dimateria penale, quale presupposto della garanzia (94).
Il principio di legalità, nell’accezione convenzionale, si sostanzia non inun criterio di ripartizione delle fonti abilitate all’incriminazione, ma in unparametro di qualità della normazione, ben sintetizzato nel brocardo nul-lum crimen sine lege clara (in accezione anglofona: no punishment without
(91) La Corte di Strasburgo si è riferita a tale norma in casi di condotte risalenti al se-condo conflitto mondiale e all’immediato dopoguerra, cfr., Harris-O’Boyle-Bates-Buck-
ley, Article 7: Freedom from Retroactive Criminal Offences and Punishment, in Harris-
O’Boyle-Warbrick (Eds.), Law of the European Convention on Human Rights, Oxford,2009, 339.
(92) Secondo attenta dottrina, la legalità per come interpretata dalla Corte di Strasburgonon è ormai molto differente dalla dimensione in action della legalità domestica. In questosenso v. Di Giovine, Il principio di legalità tra diritto nazionale e diritto convenzionale, in Stu-di in onore di Mario Romano, IV, Napoli, 2011, 2236. Sarebbe in corso una contaminazionepositiva tra le giurisprudenze nazionali, sovranazionali e internazionali. Per una riflessione intal senso Manes, I principi penalistici nel network multilivello: trapianto, palingenesi, cross-fertilization, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 846. Per una analisi dei rapporti tra Corte di Giu-stizia dell’Unione Europea e Corte europea di Diritti dell’Uomo, nell’ambito della tutelamultilivello dei diritti dell’uomo, Andolina, Nuovi scenari nella tutela penale dei diritti fon-damentali in Europa, in Dir. pen. proc., 2012, 764 ss.; Manacorda, Carta dei diritti fondamen-tali e CEDU: una nuova topografia delle garanzie penalistiche in Europa?, in Studi in onore diMario Romano, IV, Napoli, 2011, 2373 ss.
(93) Anche di recente si veda l’affermazione del principio come «an essential element ofthe rule of law», in Corte EDU, Liivik vs Estonia, 25 giugno 2009, § 92, in cui la Corte ha rico-nosciuto che l’applicazione del delitto di abuso d’ufficio previsto dall’art. 161 del c.p. estonenon fosse corrispondente ai requisiti di chiarezza e prevedibilità della legge penale, poichémentre la norma si riferiva a condotte effettivamente dannose, la condotta concreta era risul-tata meramente rischiosa per il patrimonio dello Stato. Su tale pronuncia si veda Abbadessa,
Una nuova violazione dell’art. 7 Cedu: la sentenza Liivik contro Estonia e i significati della lega-lità penale convenzionale, in Ius17@unibo, 2009, 347 ss.
(94) Per la definizione dei molteplici criteri che presiedono all’individuazione del con-cetto di materia penale, si veda Manes, sub art. 7, in Bartole-De Sena-Zagrebelsky (di-retto da), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012,259.
28 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
predictability). Il diritto è tale anche se di fonte giurisprudenziale: ciò cheimporta è che il destinatario sappia in anticipo se una condotta costituiscereato. In questo quadro poco conta come sia ripartito il carico di lavoro tralegislatore e giudice nella precisazione dei contorni dell’illecito, fatto salvol’impiego di uno schema di riferimento nitido a livello legale, prima dell’in-tervento del giudice (95).
Si noti, infatti, come la Corte di Strasburgo ammetta che l’attività inter-pretativa del giudice possa rimediare, limitandola, alla genericità della nor-ma penale, ma ciò è ammissibile solo a condizione che sia riscontrata unacontinuità storica dell’interpretazione adottata sulla base della pregressa giu-risprudenza o delle condizioni storico-sociali di riferimento (96).
La tassatività dell’incriminazione, nell’ottica convenzionale, si trasfigu-ra nella possibilità del cittadino di conoscere, in base alla disposizione nor-mativa rilevante e all’interpretazione che nel tempo ne è stata data dalla giu-risprudenza, quali siano gli atti e le omissioni che facciano scaturire la pro-spettiva di una pena, anche alla luce dell’applicabilità di eventuali norme di
(95) Schermers, General Course on the European Convention on Human Rights, in Col-lected Courses of the Academy of European Law, VII, 2, The Protection of Human Rights inEurope, The Hague-Boston-London, 1996, 1 ss. Si tratta, per quel che ci pare di comprende-re, di un paradigma fortemente indeterminato e perciò variabile in base al tipo di incrimina-zione. Sull’indeterminatezza del concetto di prevedibilità dell’interpretazione della legge pe-nale Rolland, Sub art. 7, in Pettiti-Decaux-Imbert (cur.), La Convention européenne desdroits de l’homme. Commentaire article par article, Paris, 1999, 293 ss. Men che meno la Cortedi Strasburgo ha chiarito i parametri di riferimento del giudizio di prevedibilità e accessibilitàdella norma penale. La Corte ha affrontato in un numero di casi limitati il tema della accessi-bilità della norma penale, dichiarando in una sola occasione, peraltro in tempi relativamenterecenti, la violazione del principio di cui all’art. 7 comma 1 Cedu. Si tratta del ben noto casoPessina vs. Francia, in cui la Corte ha sancito che il mutamento di interpretazione della leggein materia edilizia da parte della Corte di Cassazione francese fosse imprevedibile e sfavore-vole al reo in quanto di segno opposto all’insegnamento della giurisprudenza consolidata, co-stante nel senso dell’irrilevanza penale della condotta. Si potrebbero anche citare le decisioniCorte EDU, Liivik vs Estonia, 25 giugno 2009 e Dragotoniu e Militaru-Pidhorni vs Romania,24 maggio 2007, ma si tratta in realtà di sentenze che non si incentrano sul principio di irre-troattività, bensì di tassatività. Posto che la Corte ha inteso l’accessibilità della norma comeagevole disponibilità di informazioni sufficienti per determinarsi in libere scelte di condotta, èfondamentale il ruolo giocato dalla pubblicità della norma incriminatrice. In questo sensol’accessibilità viene intesa in Corte EDU, Sunday Times VS U.K., 26 aprile 1979, § 49. Sull’im-portanza della pubblicità delle norme ai fini della loro sufficiente accessibilità Corte EDU,Chappel vs U.K., 30 marzo 1989, § 56.
(96) Oltre alla nota Corte EDU, S. W. vs Regno Unito, 22 novembre 1995, § 34 in tema dimarital immunity per i delitti sessuali commessi dal marito nei confronti della moglie, cfr.Commissione Edu, X vs Austria, 22 luglio 1970 rispetto alla punibilità di atti omosessuali sul-la base dell’incriminazione della metà dell’Ottocento in tema di «indecenze innaturali». Direcente si veda Corte EDU, Kononov vs. Lettonia, 17 maggio 2012, 185, che sottolinea comesia essenziale il ruolo della giurisprudenza nell’adeguamento della norma al contesto socialedi riferimento.
FEDERICO CONSULICH 29
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
favore (97), tra cui evidentemente sono ricomprese anche quelle che nel no-stro orizzonte dogmatico vanno sotto il nome di scriminanti. Ne conseguel’irretroattività della nuova interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole,che non può inverarsi a scapito del concreto imputato, a meno che non siada questi prevedibile (98).
Occorre però guardarsi dalla trasformazione della legalità convenziona-le, per come elaborata dalla Corte di Strasburgo, in un moderno idolo pe-nalistico.
Vi sono, infatti, noti precedenti in cui la Corte europea dei diritti del-l’uomo ha ritenuto prevedibile e accessibile il mutamento interpretativodella giurisprudenza in ordine al fatto di reato oppure alle esimenti (termi-ne da impiegare in accezione volutamente generica) che ne limitano il cam-po applicativo alla condizione che tale evoluzione esegetica sia «ancorata» al-la coscienza sociale.
La Corte ha, infatti, legittimato la punizione di due cittadini inglesi per il reato ses-suale di rape, per la precisione attempt of rape, disapplicando in via interpretativa unaesimente di natura consuetudinaria che il common law inglese accordava al marito (cd.marital immunity) rispetto ad alcune condotte lesive della integrità psicofisica e delle di-gnità della moglie e che era senza dubbio vigente al momento dei fatti, come ammessodalla stessa Corte europea nel caso C.R. vs Regno Unito (§ 35) (99). Il criterio decisivoper la Corte è stato rappresentato dal riferimento ad una «comune percezione», a livellosociale, dei rapporti tra coniugi, che ha esentato i giudici dall’esaminare se il caso con-creto ricadesse nelle eccezioni alla causa di non punibilità che erano già state elaboratein giurisprudenza in data antecedente ai fatti (100). La logica che muove la Corte pare es-sere l’implementazione della tutela di alcuni diritti consacrati dalla Convenzione euro-pea dei diritti dell’uomo. La Corte sostiene, infatti, letteralmente: «the abandonment ofthe unacceptable idea of a husband being immune against prosecution for rape of his wife
(97) Si veda, nella giurisprudenza della Corte EDU, Kokkinakis vs Grecia, 25 maggio1993, § 52; Corte EDU, Gurguchiani vs Spagna, 15 dicembre 2009, § 29.
(98) Il corollario fondamentale di tale impostazione è l’applicazione dell’irretroattività an-che al diritto giurisprudenziale, specie nei casi di mutamento in malam partem imprevedibile(cd. Overruling). In argomento cfr. Manes, Sub art. 7, cit., 274, nonché Zagrebelsky, Laconvenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, in v.Manes-Zagrebelsky (a cura di), La convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordina-mento penale italiano, cit., 101 e ss. Importante sul punto la decisione già citata Pessino c.Francia (Corte edu, Pessino c. Francia, 10 ottobre 2006).
(99) Corte EDU, CR. vs Regno Unito, cit. e, in pari data (22 novembre 1995) S.W. vs Re-gno Unito. In particolare si veda il ragionamento della Corte nel primo dei due casi, al § 35.
(100) In questi casi la Corte ha ritenuto prevedibile la disapplicazione, e quindi l’interpre-tazione sfavorevole per il reo, sulla base dell’evoluzione normativa subita nel tempo dall’ordi-namento inglese in materia di reati sessuali: la Corte per giungere a tale conclusione ha con-dotto un’analisi approfondita dell’ordinamento britannico, comprensiva anche delle propo-ste di legge avanzate in argomento, nonché, ovviamente, della giurisprudenza in materia siaprecedente che successiva al fatto commesso dal ricorrente.
30 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
was in conformity not only with a civilised concept of marriage but also, and above all,with the fundamental objectives of the Convention, the very essence of which is respect forhuman dignity and human freedom» (101). Si badi bene che la Corte Europea non ha par-lato mai di applicazione retroattiva della legge penale, che avrebbe comportato l’applica-zione della deroga al principio di irretroattività espressa all’art. 7 comma 2 della Con-venzione (102), ma semplicemente di evoluzione interpretativa prevedibile e quindi ricon-ducibile comunque all’art. 7 comma 1 (103).
Quello della marital immunity non è però stato l’unico pronunciamento della Cortein ordine a cause di giustificazione. Nel caso A. vs. Regno Unito., la Corte europea haanalizzato una defense di common law, il reasonable chastiment, prevista nell’ordinamen-to nazionale e che aveva consentito la non punibilità dell’autore del fatto, consistito nel-l’inflizione di ripetute percosse con un bastone nel proprio giardino ad un minore da
(101) A questo proposito si è qualificato il parametro impiegato dalla Corte per decideredella prevedibilità della sanzione per un dato comportamento come criterio sociale di prevedi-bilità, cfr. Zagrebelsky, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalitànella materia penale, in [email protected], 2009, 57 ss.
(102) Si noti che la stessa eccezione al divieto di retroattività favorevole prevista al secon-do comma dell’art. 7 della Cedu, conferma l’esistenza del principio di prevedibilità, poiché lapunizione di un fatto che per il diritto nazionale non era un illecito punibile al momento incui è stato commesso è ammissibile solo qualora la condotta, a livello internazionale, ricadaentro il concetto di crimine in base ai principi generali di diritto delle nazioni civili. Si trattaall’evidenza di ipotesi criminose per definizione accessibili anche per coloro che appartenga-no ad uno Stato che in quel momento storico, non li riconosce come tali. Sui non semplicirapporti tra il diritto internazionale di cui al primo comma e i principi generali di diritto dellenazioni civili, di cui al secondo, cfr. Valentini, Diritto penale intertemporale. Logiche conti-nentali ed ermeneutica europea, Milano, 2012, 108 ss. L’espressione di cui al secondo commaricalca, come noto, la «formula di Norimberga», che ha consentito di punire fatti criminosi diguerra e contro l’umanità commessi nel periodo della seconda guerra mondiale, indipenden-temente dalla disciplina normativa che quegli stessi fatti ricevevano nell’ordinamento nazio-nale tedesco. La formula mira a governare, più in generale, fenomeni di transizione giudizialetra regimi giuridici incompatibili; sul tema, con riferimento all’ordinamento tedesco, si vedaVassalli, Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei delitti di Stato nellaGermania postnazista e nella Germania postcomunista, Milano, 2001, passim.
(103) Corte EDU, CR vs Regno Unito, cit., §§ 39-42. Si tratta di uno schema argomentati-vo assolutamente sovrapponibile a quello che ha permesso di punire i funzionari di frontierae le alte cariche del regime comunista della DDR coinvolte nel caso oggetto della nota deci-sione del 2001 della stessa Corte EDU (cfr. Corte EDU, GC, Streletz, Kessler, Krenz e K.H.W.vs Germania, 22 marzo 2001). La violazione del principio di irretroattività non è stata affer-mata nel caso dei cd. mauershutzen responsabili di aver assassinato o ferito coloro che cerca-vano di attraversare il confine tra le due Germanie all’epoca della guerra fredda. Anche inquesta occasione, seppure non implicante la disapplicazione di scriminanti, la Corte di Stra-sburgo ha, nei fatti, ritenuto applicabili retroattivamente disposizioni non vigenti all’epocadei fatti. La Corte ha affermato la legittimità della punizione per funzionari di frontiera dellaDDR, sulla base di una reinterpretazione delle norme del codice penale dello Stato comuni-sta senza ricorrere alle eccezioni al principio di irretroattività della legge penale consentitedall’art. 7 comma 2 Cedu. Sulla logica che ha guidato la giurisprudenza tedesca, che ha intesoevitare che gli imputati potessero spendere processualmente una defense ingiusta e sleale, cfr.Fletcher, The Grammar of Criminal Law: American, Comparative and International. Foun-dation, Oxford, 2007, 147.
FEDERICO CONSULICH 31
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
parte del patrigno. In questo caso la Corte ha invece ritenuto tale interpretazione con-traria al principio di cui all’art. 3 Cedu, nell’angolazione prospettica del diritto a non su-bire trattamenti inumani e degradanti (104).
In breve, per trarre un comune denominatore dalle vicende ora riassun-te in modo alquanto sommario, è possibile affermare che la nozione di pre-vedibilità della responsabilità penale della Corte di Strasburgo si presentacome un dispositivo giuridico a due velocità: una ordinaria, in cui le garanzieper il reo sono espanse nel massimo grado, ed una eccezionale, in cui le stes-se garanzie vengono rimodulate a tutto vantaggio della vittima, allorché ildelitto contestato sia offensivo di diritti fondamentali di quest’ultima (105).Quando la condotta offende in modo intollerabile diritti fondamentali san-citi dalla Convenzione – nei casi accennati: incolumità personale, dignità elibertà sessuale – la legalità penale può soccombere ed un overruling puòessere considerato non solo legittimo, ma ancora prima, del tutto inesisten-te, poiché la condotta in questione si presenta già carica di un disvalore so-ciale, seppur non ancora normativo (106).
(104) Si tratta della sentenza A. vs U.K. (ric. n. 100/1997/664/1096), 23 settembre 1998.Dopo aver ricordato, al § 14, che «Parents or other persons in loco parentis are protected by thelaw if they administer punishment which is moderate and reasonable in the circumstances. Theconcept of “reasonableness” permits the courts to apply standards prevailing in contemporary so-ciety with regard to the physical punishment of children. Corporal punishment of a child by ateacher cannot be justified if the punishment is inhuman or degrading. In determining whetherpunishment is inhuman or degrading, regard is to be had to “all the circumstances of the case, in-cluding the reason for giving it, how soon after the event it is given, its nature, the manner andcircumstances in which it is given, the persons involved and its mental and physical effects” (sec-tion 47(1)(a) and (b) of the Education (no. 2) Act 1986, as amended by section 293 of the Educa-tion Act 1993)», la Corte ha quindi stabilito, al § 24, che «In the Court’s view, the law did notprovide adequate protection to the applicant against treatment or punishment contrary to Arti-cle 3. Indeed, the Government have accepted that this law currently fails to provide adequateprotection to children and should be amended. In the circumstances of the present case, the fai-lure to provide adequate protection constitutes a violation of Article 3 of the Convention».
(105) In questo caso ci si imbatte in veri e propri «delitti convenzionali», atti lesivi dei di-ritti fondamentali della persona, che prescindono dalla tipizzazione nazionale e rispetto a cuile scriminanti paiono avere una portata normativa depotenziata ed un grado di resistenza epermanenza nel tempo inferiore. L’impostazione vittimocentrica della giurisprudenza dellaCorte di Strasburgo, notata anche di recente in dottrina, potrebbe comportare la restrizionedell’area della liceità con correlativa espansione dell’ambito del penalmente rilevante, proprioattraverso una progressiva contrazione dell’ambito di applicazione di alcune scriminanti. Laviolazione dell’obbligo convenzionale di tutela della vita umana, di cui all’art. 2 della Cedu oaltri diritti fondamentali (come la libertà e integrità sessuale) viene riconosciuta dalla Corterispetto a discipline nazionali che prevedano le norme di liceità, che limitano indebitamente,nell’ottica della Convenzione, l’ambito applicativo di una incriminazione a tutela di tale bene.Si veda Corte EDU (Grande Chambre), Markaratzis vs Grecia, 20 dicembre 2004, § 57; ancheCorte EDU, Natchova e al. vs Bulgaria, 20 febbraio 2004, § 109 e Corte EDU, 4 novembre2008, Oktem vs Turchia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 334 ss.
(106) Fondamentali nell’attribuire rilevanza alla prevedibilità dell’applicazione della nor-
32 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
La causa può essere forse identificata in un approccio «funzionalista»della Corte nella propria attività interpretativa, tutta orientata a garantire lamassima effettività possibile agli scopi di tutela della Convenzione, attra-verso l’implementazione dei diritti qualificati come fondamentali nel testodel 1950 (107).
All’esito di questa considerazione, di fronte a un tale paradigma di lega-lità, pare segnata la sorte della teorica dell’abuso del diritto in campo tribu-tario, exemplum di un diritto penale tutto sommato «non problematico», inquanto composto da delitti non offensivi di diritti fondamentali dell’uomo:dovrebbe valere per tali reati la dimensione ordinaria della legalità conven-zionale, a tutto vantaggio del reo.
Dati questi presupposti, per potersi attribuire rilevanza penale all’abu-so del diritto occorre il sostegno da una giurisprudenza costante e, ove que-sta manchi per la «novità» dell’interpretazione, da segnali sociali congruenticon l’interpretazione evolutiva della norma penale.
Nulla di tutto questo pare, oggi, predicabile dell’abuso del diritto; sonoinequivoche le due sentenze della Suprema Corte rese nei casi «Dolce &Gabbana» e «Bova» (108), ma già contrastate dall’importante obiter dictumsuccessivo di una sentenza della Cassazione del settembre 2013 (109). Talesituazione giurisprudenziale non pare in grado di fornire la struttura con-cettuale e normativa grazie alla quale i contribuenti possano prendere libe-re scelte d’azione nella gestione dei propri rapporti con l’amministrazionefiscale.
Le sentenze della Cassazione che hanno aperto la strada verso la rile-vanza dell’abuso del diritto si rivelano allora, ad un’analisi integrata dellalegalità, doppiamente illegittime:
i) perché indebitamente estensive del tipo legale, in violazione deiprincipi nazionali di riserva di legge e determinatezza;
ma alla luce dei mutati contesti sociali di riferimento Corte EDU, Cantoni vs Francia, 15 no-vembre 1996 in materia di esercizio abusivo di farmacia e Corte EDU, G. vs Repubblica Fede-rale Tedesca (ric. 13079/1987), in materia di estensibilità del reato di coercizione fisica ancheal caso di partecipazione a sit-in di protesta, entrambe riportate da Nicosia, Convenzione eu-ropea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006, 79 ss.
(107) Nello stesso senso, comprende nel diritto di cui accertare la prevedibilità anche leprassi conformi agli scopi della Convenzione Esposito, Il diritto penale «flessibile». Quandoi diritti umani incontrano i sistemi penali, Torino, 2008, 343 ss.; 380.
(108) Alcuni riconoscimenti della rilevanza penale dell’elusione fiscale anche in alcunesentenze precedenti, si veda infra nota 112. Sul tema delle prevedibilità della repressione pe-nale dell’elusione fiscale, si vedano le ampie riflessioni di A. Dell’Osso, L’elusione fiscale,cit., 90 ss.
(109) Ci si riferisce alla già citata Cass., sez. V, 16 gennaio 2013 (dep. 6 settembre 2013), n.36859, Pres. Zecchi, Rel. Micheli.
FEDERICO CONSULICH 33
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
ii) perché imprevedibili per il reo nel momento in cui sono state pro-nunciate, essendo espressive di un principio di diritto non anticipato da unapregressa giurisprudenza, né ambientandosi in un contesto socio-culturaledi riferimento favorevole alla criminalizzazione di siffatte categorie di con-dotte (110).
8. – Il principio di legalità, nell’accezione convenzionale, è come detto,nullum crimen sine lege clara (in accezione anglofona: no punishmentwithout predictability).
Si tratta di un principio «machiavellico», che in nome del fine (la chia-rezza del diritto) giustifica i mezzi: è in altro modo «agnostico» sugli stru-menti con cui garantire l’accessibilità della legge penale. Per la Corte euro-pea dei diritti dell’uomo, la certezza può derivare o dalla chiarezza della lit-tera legis in sé o, in via mediata, da una giurisprudenza costante costituita daprecedenti coerenti tra loro (111).
La legalità convenzionale non deve essere eretta a modello esclusivo digaranzia del diritto penale moderno. Nell’ottica Cedu, infatti, i principalicorollari della legalità nazionale rischiano di essere «fagocitati» dal princi-pio onnicomprensivo dell’accessibilità e prevedibilità della norma penale.
Breve: se vale quanto finora esposto, un’interpretazione evolutiva, an-che se analogica in malam partem, può rispettare la legalità convenzionaleove sorretta da una giurisprudenza costante. Declinando il discorso sul pia-no oggetto del presente lavoro, è possibile affermare che se oggi la rilevanzapenale dell’elusione fiscale è un epilogo ex ante imprevedibile di un proces-so penale, ciò non esclude che, domani, la giurisprudenza si consolidi nel ri-conoscimento della punibilità dell’abuso del diritto e quindi simile inter-pretazione non violi più l’art. 7 Cedu.
(110) È ovvio però che tale nozione va intesa diversamente al variare del destinatario tipi-co della norma penale, in considerazione del settore in cui questa stessa si trova ad operare.Una norma è accessibile quando sussiste un nesso di adeguatezza culturale tra norma e conte-sto di riferimento: la pubblicità deve infatti essere conformata sulle caratteristiche del desti-natario tipico della norma di condotta, cfr. Corte EDU, Groppera Radio AG e a. vs Svizzera,28 marzo 1990, § 68. Si veda anche Corte EDU, Flinkkila e a. vs Finlandia, 16 aprile 2010, §67, che sancisce la prevedibilità della incriminazione in relazione alla professione dei ricor-renti (giornalisti); ancora cfr. Corte EDU, Kuolelis, Bartosevicius e Burokevicius vs Lituania,19 febbraio 2008, § 120, nonché Corte EDU, Custers, Deveaux e Turk vs Danimarca, 3 mag-gio 2007, § 94 ss., in relazione a membri di un’organizzazione ambientalista rispetto all’incri-minazione di accesso abusivo a sito militare rilevabile solo tramite mappe non ufficiali.
(111) Per una declinazione del tema della rilevanza penale dell’elusione fiscale alla lucedell’art. 7 Cedu, nel senso che la giurisprudenza in tema di elusione mini l’accessibilità delprecetto penale, cfr. già Troyer-Ingrassia, La rilevanza penale dell’elusione. Il caso Bova e iltriangolo di Penrose, cit., 2087.
34 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
Si tratta di un epilogo ben possibile. Se, infatti, fino alla più volte citatasentenza della Cassazione sul caso «Dolce & Gabbana», la giurisprudenzadi merito si era orientata nel senso dell’atipicità delle condotte elusive (112),non si può negare che la Suprema Corte abbia oggi a più riprese, e con sta-tuizioni alquanto «visibili» anche grazie al tipo di imputato, stabilito la pos-sibile rilevanza dell’elusione fiscale.
Quand’anche si consolidasse, divenendo prevedibile, tale opzione er-meneutica, nondimeno si tratterebbe di un epilogo interpretativo inaccetta-bile per la legalità nazionale, il cui portato garantista non può essere sosti-tuito dall’art. 7 Cedu, ma semmai deve essere con esso integrato, in un’otti-ca cumulativa, con il risultato di arricchire e modernizzare le garanzie pena-listiche del nostro ordinamento.
La previsione dell’art. 7 Cedu, per come vivificata dalla giurisprudenzadella Corte di Strasburgo può dunque costituire, solo se corretta e imple-mentata in senso garantista per il destinatario del precetto attraverso una
(112) Si rimanda ai decreti di archiviazione GIP Bergamo, 13 maggio 2010; GIP Treviso,21 febbraio 2011 e 20 maggio 2011; GIP Milano 9 ottobre 2009 e 3 dicembre 2009 e GIP Ro-ma 8 novembre 2011, tutti citati da Corso, L’operazione elusiva non è inesistente né costitui-sce reato, in Corr. trib., 2012, 419, nt. 5. Si vedano, inoltre i decreti di archiviazione GIP Mon-za, 19 maggio 2010; GIP Milano, 18 agosto 2010; GIP Milano, 3 novembre 2011, citati daMereu, Abuso del diritto ed elusione fiscale: rilevanza penale o mera mancanza di una explica-tio terminorum? Alcune riflessioni a margine del caso «Dolce & Gabbana», in Dir. prat. Trib.,2012, nt. 48, 49, 55, tutti inediti. Inoltre anche GIP Pinerolo, 21 aprile 2004, n. 788 e GIP.Milano 20 novembre 2002, in Riv. dott. comm., 2006, 1277, con nota di Troyer, Il transferpricing tra elusione ed evasione. Inoltre Catania, 11 novembre 2009, n. 2741/2009, in Riv.dott. comm., 2010, 881 e ss., con nota di Troyer-Ingrassia. Si richiamano infine le sentenze dinon luogo a procedere, allo stato inedite, indicate da Troyer-Ingrassia, La rilevanza penaledell’elusione. Il caso Bova e il triangolo di Penrose, cit., 2084, nt. 15, ovvero GIP Milano, 26gennaio 2012 – Dott. Tutinelli; GIP Milano 30 gennaio 2012 – Dott. Meyer; GIP Milano, 19maggio 2011, – Dott.ssa Mannocci. La stessa Cassazione aveva avuto modo di chiarire:«l’operazione che è dedotta nell’attuale vicenda, (...) per quanto articolata in passaggi complessie, per quanto possa lasciare il convincimento di artificiosità, non è assolutamente censurabile intermini di simulazione. Al più potrebbe ritenersi strutturata come negozio indiretto in frode allalegge fiscale (...) condotta che esula dalla contestazione e che non assume (trattandosi di elusio-ne) interesse a fine penale». Si tratta di Cass. pen., sez. V, 7 luglio 2006, n. 34780, in Corr.trib., 2006, 3045 ss., con il commento di Corso, Secondo la Corte di Cassazione l’elusione nonintegra un’evasione penalmente rilevante. Sempre nella giurisprudenza di merito, si veda an-che, tra le altre, C. App. Bologna, 21 aprile 2004, n. 788 in Riv. dott. comm., 2006, 1278; Trib.Catania, 29 maggio 2010, n. 2741, in www.ilfisco.it/fisconline; GIP Milano, 1 aprile 2011, inRiv. pen., 2012, 99. Nella giurisprudenza di legittimità, negatrici della rilevanza penale del-l’abuso del diritto sono state Cass., V, n. 23730 del 18 maggio 2006, Romanazzi; Cass., III, n.14486, 26 novembre 2008, Rv. 244071. Favorevoli alla rilevanza penale del fenomeno a con-dizione che la condotta elusiva conduca alla presentazione di una dichiarazione infedele perla mancata esposizione di una parte degli elementi attivi, Cass., III, n. 26723, 18 marzo 2011,Rv. 250958; la stessa rilevanza è stata sancita, in tema di omessa presentazione della dichiara-zione relativa all’iva, ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 74/2000, da Cass., III, n. 29724 del 26 maggio2010, Rv., 248109.
FEDERICO CONSULICH 35
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
sintesi con il principio di legalità nazionale, il volano per modernizzare ilprincipio di legalità su nuove basi, non solo formali, ma anche sostanziali epragmatiche.
Presto detto lo spunto che si può trarre da questo breve excursus sullalegalità convenzionale in tema di rilevanza penale dell’elusione fiscale. Lateorica dell’abuso del diritto è senz’altro un tentativo di «scardinare» il prin-cipio di tipicità del fatto di reato, ma al contempo modifica le «coordinatenormative» del giudizio di antigiuridicità, di cui veicola una rilettura sogget-tivistica.
Più che attestarsi sulla difesa del principio di riserva di legge, dell’irre-troattività o del divieto di analogia in malam partem, occorre forse sfruttarel’occasione per riflettere se non sia il caso di valutare se esista (e quali formeabbia) uno statuto di garanzia tipico per le scriminanti (nel caso di specie:l’esercizio del diritto), che ne assicuri un’applicazione prevedibile e certa efughi le tentazioni di interpretazioni restrittive o abolitrici di un diritto o diuna libertà negoziale, con immediati effetti estensivi del penalmente rile-vante (113).
La sfida per il diritto penale di domani, anche alla luce di una fecondainterazione tra diritto nazionale e convenzionale, potrebbe essere l’edifica-zione di un complesso di vincoli di garanzia che non rappresentino la meratraslazione alla norme di liceità dei principi di tutela validi per l’incrimina-zione, ma un autonomo complesso di presidi, volti ad attribuire prevedibili-tà e controllabilità alla giustificazione.
La sollecitazione proveniente dal topos dall’abuso del diritto riguarda ilfondamento assiologico del punire i reati economici: rispetto a simile tema,la difesa della legalità del fatto pare un fronte di battaglia troppo arretrato.Ad essere in gioco, rispetto a norme che sembrerebbero così specifiche,ipersettoriali, tutto sommato non particolarmente cruente dal punto di vi-sta della loro applicazione (114) è una questione di moralità del diritto pena-
(113) A sgomberare il campo dalla possibilità di impiegare in sede penale il concetto dielusione fiscale, può essere la constatazione che prima di rendere casuale la responsabilità pe-nale, esso riduce in modo inaccettabile il grado di certezza dell’attività economica, rispetto acui il diritto penale è «latu sensu» sanzionatorio. Segnala, infatti, come la questione dell’abu-so del diritto, stretta tra i principi qui iure suo utitur neminem laedit e summum ius summainiuria, sia perenne e quindi insolubile Palazzo, L’abuso del processo e i suoi rimedi tra legali-tà sostanziale e legalità processuale, cit., 3609, concludendo nel senso della refrattarietà del-l’abuso del diritto alla tipizzazione (3615). L’importanza della precisione della legge penale inmateria economica è ricordata da Tiedemann, Cesare Beccaria e i reati economici, in Riv. it.dir. proc. pen., 2013, 1383, poiché l’A. afferma «formule dai contorni troppo estesi recano consé l’innato pericolo di abusi e di utilizzi arbitrari, asserviti all’ideologia del governo o dei giudici,invece che posti al servizio di una giustizia moderata».
(114) Solitamente le pene irrogabili per i delitti fiscali, ove non si inneschino contestazioni
36 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
le, chiamato com’è al rispetto di principi di uguaglianza e di razionalità pri-ma ancora che di legalità.
A ben guardare, infatti, l’abuso del diritto, in generale e non solo con ri-ferimento ai delitti tributari, pone il tema dell’assenza di una garanzia dicertezza sui diritti e sulle modalità prevedibili di un loro corretto esercizio,rispetto a cui la ricaduta penale, per quanto distorta, è un esito obbligato e,quindi, tragically predictable.
Zusammenfassung
Das Strafrecht, und dort insbesondere das Steuerstrafrecht, befaßt sich im-mer öfter mit dem Thema des Rechtsmißbrauches und seiner Strafbarkeit.Der Mißbrauch bewirkt die Unanwendbarkeit der Norm, die die Rechtferti-gung vorsieht, und somit die Rückführung der Handlung auf die jeweils inBetracht kommende Straftat.
Der Verweis auf das Legalitätsprinzip im Strafrecht war bisher nicht ent-scheidend, um ein Umlesen der Steuerstraftaten im Licht der Rechtsmiß-brauchstheorie von seiten der Rechtsprechung zu zügeln, auch nicht unter Be-zugnahme auf den Art. 7 des Europäischen Menschenrechtsabkommens.
Besser, als auf einer Verteidigung der Prinzipien des Vorbehalts des Ge-setzes, des Rückwirkungsverbotes oder des Verbotes der Analogie in malampartem zu beharren, wird es daher wohl sein, sich den Umstand der anwach-senden Bedeutung des Rechtsmißbrauches zu Nutze zu machen, um über dasVorhandensein eines typischen Garantiestatuts für die Rechtfertigungs-gründe (im vorliegenden Fall: die Ausübung des Rechts) zu reflektieren, waseine vorhersehbare und sichere Anwendung der Strafnorm in ihrer Gesamt-heit, als Synthese von Strafverfolgung und Rechtfertigung, sichern würde.
Abstract
Criminal law, especially criminal tax law, is increasingly facing the issueof the abuse of law and its criminalising relevance. The abuse entails the non-applicability of the norm that attributes the justifying right and, therefore, theframing of the concrete behaviour within the relevant criminal offence.
di riciclaggio o associazione per delinquere, consentono il ricorso a strumenti sanzionatori al-ternativi (sanzioni sostitutive, misure alternative alla detenzione) o sono comunque sospendi-bili, essendo dirette a soggetti integrati socialmente.
FEDERICO CONSULICH 37
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014
Until now, recalling the principle of legality of the crime has not beenenough for the courts to refrain from reading criminal tax offences in the lightof the theory of the abuse of law, not even in the perspective of art. 7 of theEuropean Convention on Human Rights.
More than insisting on defending the principles of strict legality (reserva-tion of statutory law: «riserva di legge»), of non-retroactivity of criminal lawor of the prohibition of analogy in malam partem, perhaps we need to takeadvantage of the occasion of the growing applicative relevance of the abuse oflaw to reflect on the existence of a statute of guarantee typical for the causesof justification (especially, the exercise of a right), which grants a predictableand certain application of the criminal norm as a whole, as a synthesis ofcriminalisation and justification.
38 ARTICOLI
Riv. trim. dir. pen. econ. 1/2014