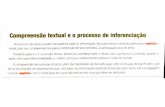Schiavitu’ e redenzione dei “cattivi”, tra processo secolare e diritto musulmano
Transcript of Schiavitu’ e redenzione dei “cattivi”, tra processo secolare e diritto musulmano
B I M E S T R A L E D E L L ' I P S E M A S U L L A C U L T U R A E L ' E C O N O M I A D E L M A R EB I M E S T R A L E D E L L ' I P S E M A S U L L A C U L T U R A E L ' E C O N O M I A D E L M A R E
4/2006
Pos
te It
alia
ne S
.p.A
.- S
ped.
in a
bb.p
ost.
- 70
% -
DC
B R
oma
Alessandro ArcaiAlessio Claroni
Annamaria Barbato RicciAntonio ParlatoClaudio Natale
Daniela Squarcia Matticoli Domenico Repetto
Domenico RiccioGerardo Picardo
Luigi MauriMaria Monicelli
Raffaella MorianiRoberta Bencini
Roberta StopponiRosa Pascale
Tommaso VisoneValentino GuidiVasco Fronzoni
L’attività dell’Istituto si svolge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infor-tuni sul lavoro e le malattie professionali e di prestazioni previdenziali di malattia ematernità del personale della navigazione marittima, aerea e della pesca marittima.
PRESTAZIONIL’IPSEMA eroga ai propri assicurati prestazioni previdenziali obbligatorie e integrative,nonché prestazioni obbligatorie per conto dell’INPS.
L E P R E S TA Z I O N I I S T I T U Z I O N A L I A S S I C U R AT E S O N O :- un’indennità giornaliera temporanea, per inabilità totale al lavoro derivante da infor-tunio sul lavoro o malattia professionale;
- un’indennità giornaliera per temporanea inidoneità agli specifici servizi della naviga-zione;
- una rendita o una somma capitale “una tantum” per inabilità permanente totale oparziale al lavoro conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- una rendita e un assegno “una tantum” ai superstiti in caso di morte per infortu-nio sul lavoro o malattia professionale;
- altre prestazioni di carattere accessorio (fornitura di protesi, rimborso spese diviaggio, assegno per assistenza personale continuativa);
- certificazione ai fini pensionistici dell’eventuale esposizione dei marittimi alle fibre diamianto.
L E P R E S TA Z I O N I I N T E G R AT I V E , P R E V I S T E D A I C O N T R AT T I C O L L E T T I V I , S O N O :- un’indennità giornaliera temporanea per periodi non coperti dall’assicurazione dilegge;
- un’indennità “una tantum” per inabilità permanente da malattia contratta per causadi servizio;
- un’indennità “una tantum” per morte conseguente a infortunio o malattia contrattaper causa di servizio.
L E P R E S TA Z I O N I E R O G AT E P E R C O N T O D E L L’ I N P S S O N O :- un’indennità giornaliera temporanea per i periodi di malattia previsti dalla legge;- le prestazioni economiche previste dalle leggi sulla maternità;- rimborsi per i donatori di sangue.
Le prestazioni economiche a tutela della maternità sono corrisposte al personaledella navigazione marittima, al personale amministrativo delle Società di navigazionedi preminente interesse nazionale ed al personale di volo.
I SERVIZI DELL’IPSEMA
n. 4/2006Settembre - Dicembre
NAUTESNAUTESB I M E S T R A L E D E L L’ I P S E M A S U L L A C U LT U R A E L’ E C O N O M I A D E L M A R E
L’EDITORIALE
LE ARTIE IL MARE
IDOCUMENTII PORTI ITALIANI
L’Ipsema riduce il costo del lavoro Antonio Parlato 7
Una nuova missioneper l’EnteRaffaella Moriani 11
Cagliari, il marericonquista la città Rosa Pascale 15
Occorre ridurre il gap dei porti italianiLuigi Mauri 23
Il canale di Suez,artificiale e necessarioAnnamaria Barbato Ricci 27
Il collocamento della gente di mareDomenico Repetto 35
Igiene e sicurezzadei lavoratori marittimiClaudio Natale, Roberta Stopponi 45
Si pesca sempre di piùma servono regoleAlessandro Arcai 59
Ormeggio, dunque sono,ma se mi rubano la barca?Alessio Claroni 67
La funzione paradigmatica e pionieristica del diritto marittimoDomenico Riccio 75
Schiavitu’ e redenzionedei “cattivi”, tra processosecolare e diritto musulmanoVasco Fronzoni 89
Riaffiora l’antichitàdalle acque del SudLorenzo Ferragamo 107
Comunicazione,ruolo e pubblica utilitàValentino Guidi 111
L’attività assicurativa dell’Ipsemaper la nautica da diportoRoberta Bencini 127
LE ONDE RACCONTANOLe onde raccontanoA cura di Mimmo Della Corte 135
I LIBRIConrad, London o Tobino?Mursia lancia una nuovacollana di libri di mareGerardo Picardo 139
Il velaio? Un sartoingegnere che ama il mareGerardo Picardo 143
Le norme sulla nautica da diporto, per tuttiMaria Monicelli 145
LA STORIALa battaglia di Lepanto, genesi di un mitoTommaso Visone 147
I FONDALI PREZIOSIRavenna e il suo centroportuale, classeDaniela Squarcia Matticoli 151
INCONTRI 155
DirettoreAntonio Parlato
Comitato di DirezioneAntonio Parlato, Giancarlo Fontanelli
Palmira Petrocelli, Fausta Savone
Direttore ResponsabileFausta Savone
Hanno collaboratoAlessandro Arcai, Annamaria Barbato Ricci, Roberta Bencini,
Alessio Claroni, Lorenzo Ferragamo, Vasco Fronzoni, Valentino Guidi, Luigi Mauri, Maria Monicelli, Raffaella Moriani,
Claudio Natale, Antonio Parlato, Rosa Pascale,Gerardo Picardo, Domenico Repetto, Domenico Riccio,
Daniela Squarcia Matticoli, Roberta Stopponi, Tommaso Visone
RedazioneLorenzo Ferragamo
Direzione e redazione00187 Roma - Via S. Nicola da Tolentino, 5
Tel. 06 47877263 - Fax 06 4871265
EditoreSTILGRAFICA srl
Via I. Pettinengo, 31/33 - 00159 RomaTel. 06 43588200 - Fax 06 4385693
[email protected] - www.stilgrafica.com
N. 4/2006 Settembre-Dicembre – Reg. Trib. Roma n. 616/2002
Illustrazione di copertina: © “Images.com” / Steve DininnoLe immagini di questo fascicolo sono state tratte da:
“Yachting ’600-’800” - Edito da Gribaudo
NAUTESNAUTESB I M E S T R A L E D E L L’ I P S E M A S U L L A C U LT U R A E L’ E C O N O M I A D E L M A R E
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEPresidente: Antonio Parlato
Consiglieri: Fabrizio Bianchi Schierholz, Angelo Cima,Domenico Lo Jucco
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZAPresidente: Giancarlo FontanelliVice Presidente: Gennaro Fiore
Consiglieri: Ervio Dobosz, Beniamino Leone, Giuseppe Lombardi,Giovanni Montanari, Tommaso Pacchelli, Franco Paganini,
Giovanni Rizzo, Deodato Russo, Roberto Scotti, Enrico Tonghini
COLLEGIO DEI SINDACIPresidente: Saverio Parlato
Vice Presidente: Vincenzo SuppaSindaci: Anna Concetta Curtilli, Alfredo Roccella
Direttore Generale: Palmira Petrocelli
DIREZIONI CENTRALIOrganizzazione e Personale: Angela Razzino
Finanza e Patrimonio: Daniele LeoneAssicurazione e Prestazioni: Agatino Cariola
Vigilanza e Prevenzione: Sante Perticaro
Sede centrale
ROMA - Via San Nicola da Tolentino, 5 - Cap 00187Tel. +39.06.478.771 - Fax. +39.06.48.71.265
Centri operativi
MAZARA DEL VALLO - Piazzetta S.N. Regale, 6 - Cap. 91026Tel. +39.0923.907.440 - Fax [email protected]
MESSINA - Via Calabria 38/40 - 98122 Tel. +39.090.601.56.02 Fax. +39.090.601.56.09
MOLFETTA - Via B. Maranta, 14 - Cap. 70056Tel. +39.080.39.73.777 - Fax. +39.080.39.73.557
Sedi Compartimentali
GENOVA - Via Serra, 8 - Cap 16122Tel. +39. 010.547.111 - Fax +39.010.547.1121
NAPOLI - Via S. Nicola alla Dogana, 9 - Cap. 80133Tel. +39.081.760.500.1 - Fax +39.081.55.11.820
TRIESTE - Via Galatti, 1 - Cap. 34132Tel. +39.040.37.801 - Fax [email protected]
PALERMO - Via Onorato, 5 - Cap. 90139Tel. +39.091.74.39.211 - Fax +39.091.320.283
7
L’IPSEMA RIDUCE IL COSTO DEL LAVORO
Antonio Parlato
La delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ipsema, relativaal taglio del costo del lavoro delle imprese marittime attraverso lariduzione del carico delle aliquote contributive non è certo cosa dapoco. Lo dimostrano i consensi giunti dalle istituzioni e dalle cate-gorie a seguito di una manovra tariffaria a lungo attesa se la pre-cedente fu decisa nel lontano 2000. Per giungere a questa deci-sione il Consiglio ha voluto attendere il conto consuntivo del 2005allo scopo di verificare se il buon andamento della gestione, rile-vato con il consuntivo del 2004 e confermato dal bilancio tecnico,trovasse conferma. Quel bilancio aveva già evidenziato, rispettoall’aliquota media di equilibrio, un avanzo tecnico dello 0,84% manel 2005 il dato è ancora migliorato. Come accade in questi casiper un istituto assicuratore, base della manovra è stato uno studiotecnico attuariale che ha tenuto conto dei rischi rilevati e delle ri-sultanze dei consuntivi e da questo ha preso il via il nuovo pianotariffario. Anche nella consapevolezza da parte dell’Ipsema di po-ter e dover dare un contributo alla riduzione del costo del lavoroin un momento nel quale emergono difficoltà per la crescita dellosviluppo nel quadro economico-finanziario che è dinanzi a tutti.A questo punto “distribuire” la riduzione delle aliquote, decisanella misura di 7 milioni di euro, non avrebbe potuto non tenerconto dei “contribuenti”. Che non sono solo gli armatori che as-sicurano con l’Istituto gli equipaggi delle loro navi contro il ri-schio di infortuni e di malattie professionali ma anche lo Stato: alfine di garantire la competitività della flotta nazionale sullo sce-nario mondiale, questi concorre alla copertura di una parte spes-so rilevante dei contributi dovuti per alcune delle categorie di na-
L’ EDITORIA
LE
NAUTES
viglio. Fatte dunque le debite proporzioni tra il peso contributivoassolto rispettivamente dallo Stato e dagli Armatori, il Consiglioha ritenuto che fosse giusto distribuire le riduzioni tra l’uno e glialtri: così che i 7 milioni di euro sono stati, per effetto della ma-novra, divisi in 4 milioni e 500mila euro per alleviare gli oneri dicui lo Stato si è caricato per sostenere la competitività di varie ti-pologie di navi e in 2 milioni, 500mila euro agli Armatori, per ri-durre il peso contributivo residuo che sostengono al netto deicontributi dello Stato.I 7 milioni di euro da pagare in meno consentono di ridurre com-plessivamente del 10% le aliquote, espresse in percentuale sul-l’ammontare delle retribuzione lorda imponibile: una contrazionedi costi per le imprese davvero significativa nel panorama degli en-ti previdenziali. Mentre, avuto riguardo alle classi di rischio, diver-se in ciascuna delle varie tipologie, è stato possibile, in coerenzacon la legislazione vigente, utilizzare le risorse disponibili, sempregarantendo l’equilibrio gestionale, in favore tra l’altro del traspor-to passeggeri, del traffico merci nazionale (e quindi delle “auto-strade del mare”) come indicato dal Consiglio di Indirizzo e Vigi-lanza dell’Istituto, dei rimorchiatori e della pesca costiera.Spiccano tra le riduzioni quelle relative alle navi da diporto, allagrande nautica che cresce in misura rilevante con i superyacht dilunghezza f.t. oltre i 24 metri, pur senza che gli equipaggi iscrittiall’Ipsema crescano nella stessa misura. Qui la manovra si fa dun-que più strategica: ridurre le aliquote dinanzi all’andamento dei ri-schi ma al contempo incoraggiare quegli armatori della grandenautica che ricorrono a “equipaggi-ombra” a rientrare nella legali-tà ora che non possono esserci più alibi, essendo stata ridotta l’ali-quota dal 9,1% al 4,50%. Sotto questo aspetto, anche i porticciolituristici e il turismo nautico riceveranno indirettamente benefici.Questo mentre l’Istituto, non solo per il lavoro sommerso presentedel diporto, va attivando intese e protocolli con il Comando gene-rale delle Capitanerie di porto, con l’Arma dei Carabinieri, con laGuardia di finanza e la Polizia di Stato, a fronte di una strategia diattenzione per far emergere il lavoro nero.Va anche detto che la delibera del Cda ha confermato la aliquotaaggiuntiva obbligatoria del 5% per i maggiori rischi dei palombari
8
9
e dei sommozzatori in vista di una auspicata legislazione che rego-lamenti meglio queste categorie di lavoratori dipendenti, che sonosicuramente in espansione, e per le quali, si vedano le proposte dilegge esistenti, si ipotizza la istituzione di uno specifico ruolo infunzione dell’interesse per la archeologia sommersa. In verità se-guendo l’iniziativa della Sicilia, unica regione italiana sinora a isti-tuire una Soprintendenza Archeologica per i beni sottomarini.Il Consiglio ha anche deliberato di istituire, nell’attuale quadropolitico internazionale, l’aliquota aggiuntiva obbligatoria nellamisura del 5% per i maggiori rischi corsi dagli equipaggi delle im-barcazioni che svolgono nelle zone di guerra le attività delle classidi rischio trasporto passeggeri, trasporto merci internazionali eausiliarie.Infine la dinamica degli eventi infortunistici, la fluttuazione diversi-ficata tra le varie categorie di navi, l’incremento della attività diprevenzione, l’emergenza di nuovi rischi in taluni comparti, ha
L’IPSEMA RIDUCE IL COSTO DEL LAVORO
suggerito all’Ipsema di tenere d’ora in poi sotto continua, e nonpiù periodica, sorveglianza l’andamento degli infortuni e delle ma-lattie professionali nelle varie tipologie di navi. Per essere pronti aintervenire sugli aumenti o sulle riduzioni tariffarie che si manife-steranno necessarie.Una manovra forte e al contempo complessa se il confronto delConsiglio di amministrazione, per giungere a queste scelte, con ilConsiglio di Indirizzo e Vigilanza, la Direzione generale, i Dirigenticentrali alla Finanza e alle Prestazioni, l’Attuario, è stato moltolungo ed ha richiesto numerosi incontri dedicati all’esame dellasussistenza dei presupposti per assumere una iniziativa che, senzafalse modestie, giudico tra le più significative di questa consiliatu-ra, incidendo direttamente sui minori costi delle imprese e delloStato che le sostiene. E così qualificando ancor di più la missionedell’Ipsema nei confronti dello Stato e della Comunità nazionale.
10
11
UNA NUOVA MISSIONE PER L’ENTE
Raffaella Moriani
L’ente previdenziale dei marittimi ottiene il via libera al finanziamentodal ministero del Lavoro per tre progetti di studio sulle condizioni divita della gente di mare e sulle cause più frequenti di infortunio. Sicandida a diventare nuovo soggetto istituzionale di ricerca e ilprossimo obiettivo è iscriversi alla Anagrafe nazionale delle ricerche
L’Ipsema amplia la propria missione istituzionale e investe sulla ri-cerca. Oltre a interessarsi della tutela assicurativa della gente dimare, infatti, l’Ente previdenziale si arricchisce di una nuova estrategica competenza, quella relativa alla ricerca. Dopo i successiottenuti nei suoi dieci anni di attività istituzionale, tutti concentra-ti sul fronte della tutela della gente di mare, l’Ipsema si proiettanel futuro allargando gli orizzonti e cercando nuovi traguardi.L’istituto previdenziale guidato da Antonio Parlato è riuscito pro-prio nelle scorse settimane a ottenere il via libera al finanziamen-to per tre specifici studi di ricerca. In questo modo l’Ipsema inter-cetta specifici contributi messi a disposizione dal ministero del La-voro per analisi e progetti di studio. Un risultato più che lusin-ghiero che pone l’Ipsema tra gli enti più avanzati sul fronte dellaricerca.Più nel dettaglio, i progetti curati dall’Ente previdenziale e finan-ziati dal governo sono tre: a) le cadute dall’alto per l’attività dilavoro marittimo: studio della casistica nosologica ed ipotesi diinterventi preventivi; b) analisi del fattore anagrafico sull’anda-mento generale del fenomeno infortunistico nel settore maritti-mo; c) analisi dei rischi da esposizione ad agenti fisici, con parti-
NAUTES
colare riferimento alle vibrazioni meccaniche e alle radiazioni ot-tiche. Si tratta di tre progetti molto complessi e ambiziosi che una volta,realizzati consentiranno di raggiungere un livello molto avanzatodelle conoscenze sul comparto marittimo con particolare riguardoa fattori e cause che incidono sulle malattie e gli infortuni dellagente di mare. Con questi tre progetti finanziati, il cui ammontare complessivostanziato è di 160mila euro, l’Ipsema sarà in grado di fornire det-tagli tecnici decisivi sulle condizioni di lavoro a bordo delle navi.Per l’ente previdenziale dei marittimi i prossimi saranno anni impe-gnativi che rappresenteranno un banco di prova decisivo per leaspirazioni dell’Ipsema.L’obiettivo a medio termine per l’ente è quello di iscriversi all’Ana-grafe nazionale delle ricerche, in modo da divenire soggetto istitu-zionale stabile sul fronte del settore ricerca. Tra i tre progetti elaborati dall’ente previdenziale marittimo il piùdelicato è sicuramente il primo (le cadute dall’alto per l’attività dilavoro marittimo – contributo di 60mila euro), visto che con que-sto studio si punta a esaminare i casi di infortunio derivanti dal-l’ambiente di lavoro e dovuti alle cadute. L’Ipsema allo stato attua-le registra che le cadute costituiscono almeno la metà del fenome-no degli infortuni marittimi. La durata prevista del progetto è didue anni. Nella prima fase si punterà ad acquisire e classificare ledenunce di infortunio, a individuare le categorie di marittimi piùesposti al rischio cadute, a studiare la normativa vigente in mododa individuare eventuali vuoti legislativi. Sempre nella prima partedel progetto poi si acquisiranno informazioni sugli infortuni dallebanche dati ufficiali delle Capitanerie di Porto, dell’Inail e di Con-fitarma.In questo modo sarà successivamente possibile elaborare delle sta-tistiche sugli infortuni mirate a rimarcare l’incidenza delle cadutesull’attività lavorativa dei marittimi. La seconda e ultima parte delprogetto, invece, sarà caratterizzata dallo studio di come incenti-vare alla prevenzione, dalla ideazione di corsi di formazione pro-fessionale per i lavoratori alla formulazione di suggerimenti tecnici
12
13
da proporre alla cantieristica navale in modo da aumentare la so-glia di salvaguardia dei lavoratori. Il secondo progetto finanziato all’Ipsema (Analisi del fattore ana-grafico sull’andamento generale del fenomeno infortunistico nelsettore marittimo – contributo 40mila) vuole focalizzare l’attenzio-ne sulla articolazioni del lavoro marittimo. In particolare, si inten-dono segnalare le particolari condizioni di lavoro marittimo chenel tempo producono cambiamenti fisiologici ed ergonomici per lagente di mare che sono tali da rappresentare una sorgente di pro-gressivo affaticamento psico-fisico legato all’aumento dell’età edalla diminuzione della vigilanza. Con questo studio l’Ipsema inten-de presentare una analisi comparata sul “fattore età” e su comequesto incide sulla fenomenologia infortunistica nel comparto ma-rittimo.Il terzo e ultimo progetto finanziato dal governo (Analisi dei rischida esposizione ad agenti fisici – contributo 60mila euro) punta a
UNA NUOVA MISSIONE PER L’ENTE
tracciare una precisa definizione delle condizioni fisiche in cui lagente di mare lavora. Questo passaggio è strategico per delinearei tassi di esposizione al rischio per il corpo umano e del carico sudi esso che derivano dalle vibrazioni meccaniche che l’ambiente divita e di lavoro genera. La durata prevista dello studio è di diciottomesi ed esso si articola in tre fasi: la prima si basa sulla acquisizio-ne delle denunce di infortunio, l’elaborazione di una serie di ipo-tesi strutturali navali che siano in grado di mitigare il rischio daesposizione ad agenti fisici, l’individuazione delle tipologie di ser-vizio marittimo che più espongono al rischio il lavoratore.La seconda fase si caratterizzerà sulla acquisizione di notizie e sta-tistiche di infortuni registrate nelle banche dati di Capitanerie,Inail e Confitarma. La terza e ultima fase del progetto infine saràcostituita dalla elaborazione di un progetto mirato per incentivarela prevenzione, dalla ideazione di proposte volte a integrare lanormativa vigente in materia, dalla formulazione di suggerimentitecnici su come costruire in futuro le navi e tutelare al meglio i la-voratori. 14
15
CAGLIARI, IL MARERICONQUISTA LA CITTÀ
Rosa Pascale
Un porto che in pochi anni cambia volto e si apre agli sguardi dellacittà. Che dopo decenni di distacco si lascia vivere offrendo occasionidi svago, spazi di cultura e opportunità lavorative
Dopo anni di “separazione in casa” la città di Cagliari e il suo por-to tornano a dialogare, anzi a essere l’una lo specchio dell’altro.Ed ecco che via Roma diventa una piazza sul mare destinata alpasseggio, il “Museo mediterraneo dell’arte nuragica e dell’artecontemporanea” presto sarà il riferimento per la ricerca artisticadell’area mediterranea e si esplorano opportunità di sviluppo.Il nuovo sistema portuale sembra pensato per riportare la città diCagliari al centro degli scambi del mediterraneo e per diventaremotore dell’economia e degli scambi. Niente di nuovo a ben guar-dare. Infatti è proprio a partire dalla fondazione del porto che len-tamente prese forma la città, fondata da marinai che approfittaro-no dell’ampio golfo per trovare riparo. L’origine di Cagliari sembra legata ai Fenici. Il nome stesso dellacittà pare derivi dal termine Karel, che significava “città di Dio”.Inizialmente formata da insediamenti discontinui, grazie alla domi-nazione Cartaginese acquistò una struttura urbana e presto diven-ne lo scalo più importante della Sardegna. La città fu un impor-tante scalo commerciale per il traffico delle merci che giungevanodall’oriente e per i prodotti dell’economia isolana, soprattutto ce-reali, minerali, formaggio e lana. La dominazione cartaginese duròall’incirca tre secoli, fino a quando i romani, nel 238 a.C., esteseroil loro dominio alla regione. I sette secoli di governo romano ac-
NAUTES
crebbero la bellezza e l’importanza della città tanto che Cagliaridivenne uno dei centri più importanti dell’isola e incrementò lasua vocazione commerciale pur mantenendo intatte tradizioni ecostituzione politica. Il centro cittadino si espanse e crebbe il numero degli abitanti finoa sfiorare le ventimila unità; aumentò anche il prestigio quandoCesare le attribuì lo statuto di Municipium Italicum come premioper la fedeltà dimostratagli durante la guerra civile con Pompeo.La fonte principale della sua ricchezza era, come sempre, costitui-ta dal porto e dai commerci che in esso si svolgevano. Successiva-mente, durante la dominazione vandalica, Cagliari fu luogo diconfino come molte altre località sarde. Tornata all’impero bizanti-no beneficiò di un periodo di pace ma anche di una cattiva ammi-nistrazione dovuta alla distanza e al disinteresse dell’impero chegravò i cittadini con ingenti tasse. Per questi motivi, e per le inces-santi incursioni arabe, nel 1015 la città si staccò dal giudicato bi-zantino e si affidò all’amministrazione di giudici locali. In questoperiodo furono fiorenti i traffici con Marsiglia e alcuni porti pro-venzali e, più tardi, con Genova e Pisa.Cagliari rimase indipendente fino al 1258, anno in cui venne oc-cupata militarmente da Pisa che riportò il suo centro vitale sullacosta e ampliò il vecchio porto. Il centro urbano fu dotato di forti-
16
ficazioni e mura intorno al Castello, la popolazione aumentò e ilporto divenne uno dei più importanti del Tirreno.Il declino di Pisa in terra ferma portò all’infeudazione dell’isola daparte di Papa Bonifacio VIII al re Giacomo II d’Aragona. La città di-venne la capitale dell’isola e del regno; mantenne la sua vocazionedi centro commerciale grazie anche alla costruzione di una nuovadarsena che migliorò la ricettività del porto.Dopo quattro secoli di dominazione spagnola Cagliari passò al-l’Austria nel 1708 ma fu presto ceduta, insieme al resto dell’isola,a Vittorio Amedeo II. I Savoia governarono la Sardegna con meto-di autoritari fino a quando i piemontesi che vi risiedevano furonocacciati e costretti a imbarcarsi verso il continente. Ottenuti alcuniprivilegi i moti antipiemontesi si sopirono per poi risvegliarsi cicli-camente. Intanto la città stava cambiando fisionomia: illuminazione pubbli-ca, manutenzione delle strade, nuove opere portuali e l‘inizio diattività industriali le confermarono il ruolo di centro più importan-te dell’isola. Grazie alla costruzione di nuove strade e, soprattutto,della ferrovia, si valorizzò il porto dando nuovo impulso al com-mercio. Lo sviluppo delle infrastrutture continuò fino alla Seconda guerramondiale, quando Cagliari fu tragicamente bombardata a causadell’importanza strategica dell’avioscalo di Elmas e del porto. In-signita della medaglia al valore militare fu ricostruita e ampliatae, dal 1949, è il capoluogo della Regione Autonoma della Sarde-gna.Cagliari è sempre stata al centro dei grandi cambiamenti politici,economici, culturali e tecnici che hanno interessato la sorte dei ba-cini mediterranei. Nell’ultimo secolo, però, il porto non è riuscitoad adeguarsi ai nuovi bisogni della marineria, ed è rimasto comeincompiuto e fermo. Negli ultimi anni, invece, qualcosa sta cam-biando grazie all’impegno dell’Autorità portuale in sinergia con legiunte di comune, provincia e regione. La città si è riappropriatadel suo water-front grazie all’abbattimento del muro che tagliavain due il molo di Ichnusa e impediva la vista della sponda di levan-te. Inoltre, il porto cittadino e quello della marina militare, non piùdistinti, danno una visione unitaria del capoluogo. Via Roma diven-terà un’isola pedonale, si potrà passeggiare dall’ingresso della città
18
19
L’ INTERVISTA
CAGLIARI, IL MARE RICONQUISTA LA CITTÀ
fino al molo di Su Sicco e l’intera area storica sarà restituita al ca-poluogo riqualificato e ripensato per lo svago e il turismo.La banchina Ichnusa sarà destinata al traffico crocieristico. Il nuo-vo terminal consentirà al porto cagliaritano di essere inserito nellerotte turistiche delle grandi navi da crociera e di raddoppiare iltraffico delle navi da turismo offrendo attrattive che oggi manca-no. Il fondale passerà dagli attuali sette metri a nove e sono giàstate eliminate le antiestetiche gru e il pannello di Levante. Inoltreè stato spostato alla Scafa il porto pescherecci che potrà ospitarecirca ottanta posti barca. Il cuore del progetto, però, è la tensostruttura che accoglierà i tu-risti: 2.500 metri quadrati, di cui metà coperti a forma di veliero incristallo, acciaio e pietra calcarea di Orosei, con veri e propri pen-noni: vicina allo sbarco, permetterà il rapido inserimento dei turistinella città. Ci saranno spazi destinati ai croceristi, alle compagniee ai tour operator oltre che bar, ristoranti, uffici, centro congressie sale adibite a esposizioni di vario genere. Il porto turistico vero eproprio sorgerà a Su Sicco con una disponibilità superiore agli at-tuali 800 posti barca. Tra qualche anno sarà possibile inoltre per-
20
correre il lungomare fino a Marina Piccola: un lungo itinerario ren-derà comunicanti i moli di via Roma con quelli della Plaja, il moloIchnusa, il pennello di Bonaria, il canale di San Bartolomeo e ilmolo di Sant’Elmo. Una splendida passeggiata per i turisti e i ca-gliaritani.Altri progetti sono in fase di conclusione sull’area occidentale delbacino cagliaritano, occupata dal porto canale recentemente adi-bito al transhipment.Sul lato di ponente saranno sistemati su 500 metri di piazzali ebanchine gli impianti logistici, che arriveranno quasi a costeggiarela strada per Pula. La banchina sarà arretrata di circa 50 metri peraumentare lo spazio di manovra delle imbarcazioni e la profonditàdel bacino verrà portata da 14 a 16 metri. Aumenterà sostanziosa-mente il traffico di container e navi che ogni settimana raggiungo-no l’approdo e la nuova profondità permetterà di accogliere mezzidi maggiore stazza accrescendo l’importanza dello scalo commer-ciale anche perché Cagliari, trovandosi lungo l’asse Suez-Gibilter-ra, attira l’interesse degli armatori.Nella zona industriale sorgerà anche un centro tecnico per soddi-sfare la domanda della nautica da diporto che potrebbe diventarestanziale. Per ultimo si stanno studiando soluzioni per ravviare lazona franca, che non è mai riuscita a decollare. Si pensa di sfrut-tarla per lavorare e assemblare merci che arrivano da mercati ex-tracomunitari e ripartono per altri mercati extracomunitari. Il pro-
21
L’ INTERVISTA
CAGLIARI, IL MARE RICONQUISTA LA CITTÀ
getto include lo sviluppo di attività locali, con dipendenti sardi,che lavorino merci destinate ad altri mercati.
“Vorrei un porto più vissuto”
Il regista, e primo sostenitore, del nuovo assetto dell’area portualecagliaritana è Antonio Granara, presidente dell’Autorità portuale.Nautes gli ha rivolto alcuni interrogativi.
Presidente Granara, il porto di Cagliari è stato stravolto da unaserie di interventi che ne hanno ridefinito le funzionalità. Leispesso ha parlato di “sistema portuale perfetto”. Ci spiega cosaintende?Vuol dire che ogni singola scelta non può prescindere da una vi-sione d’insieme complessiva perché ogni intervento produce effet-ti sull’insieme. Per farle un esempio: abbiamo deciso di spostare itraghetti a via Riva di Ponente non solo per sgombrare il fronte divia Roma ma anche per le strade che confluiscono sul lato di po-nente. In questo modo è più facile per i passeggeri che scendonodalle navi con le loro vetture raggiungere le strade che portano aPula, Campidano e al nord. Chi scende a piedi, invece, si trova vi-cino alla stazione degli autobus Arst e alla ferrovia. Nel piano re-golatore tutto ha una logica funzionale ispirata alla massima frui-bilità dell’area portuale: solo in questo modo possiamo esserecompetitivi.
Sarà presto operativo il nuovo terminal crocieristico. Quali van-taggi prevede per la città e in che modo cambierà la vivibilitàdell’area portuale?La nuova stazione crocieristica permetterà l’approdo ai turisti di-rettamente nel centro della città. I vantaggi per Cagliari potrebbe-ro essere enormi ma tutto dipenderà da come sapremo sfruttarequesta opportunità. È essenziale che gli enti e gli operatori abbia-no una programmazione comune: vanno creati itinerari per nondirottare i turisti verso altri siti, bisogna favorire l’apertura di atti-vità commerciali e fornire nuove occasioni di svago. Insomma dob-biamo soddisfare il crocerista e, contemporaneamente, creare
22
nuove opportunità di lavoro per i cittadini. Mi auguro che il Co-mune, la Provincia, gli operatori turistici e le varie categorie sap-piano trovare le giuste sinergie per operare al meglio e per la sod-disfazione di tutti.
Lei che tipo di attività vorrebbe vedere svolte nell’area portuale?Vorrei un porto vissuto intensamente. Immagino visite guidate delporto storico, manifestazioni culturali con grossa partecipazione,una marina che diventi punto d’incontro per i cagliaritani e attra-zione per i turisti. E poi il museo, i congressi e le esposizioni, i ne-gozi e le attività commerciali.Un porto come sarà quello di Cagliari è pensato anche per influiresullo sviluppo e le potenzialità della città. È una marcia in più che imiei concittadini sapranno senz’altro utilizzare al meglio.
23
NAUTES
OCCORRE RIDURRE IL GAP DEI PORTI ITALIANI
Luigi Mauri
Il mondo del trasporto marittimo mondiale va verso una crescita piùche esponenziale ma non tutti gli scali sono pronti a farvi fronte.Un’indagine sui porti europei ha rilevato come il divario tra Nord eSud si allargherà sempre di più e l’Italia sembra il fanalino di coda
Un recente studio dell’Ocean shipping consultants (Osc), “Marke-ting of Container Terminals”, ha messo in evidenza che il businessdel traffico container nei porti è cresciuto di oltre il 10% annual-mente negli ultimi 15 anni e, grazie alla globalizzazione dell’eco-nomia mondiale, tale andamento continuerà a essere inarrestabi-le. Le previsioni dello studio indicano che la domanda dei portiraddoppierà entro il 2015, con circa 650 milioni di teu movimen-tati in tutto il mondo. Ocean shipping consultants sostiene inoltreche il processo non si basa semplicemente sulle previsioni di nuovie migliori terminal, ma si sofferma sull’importanza di profitti mas-simizzati in virtù dei massicci investimenti effettuati durante glianni, sottolineando che i porti in grado di crescere prima e megliodal punto di vista infrastrutturale, saranno coloro che potrannobeneficiare dell’incremento dei traffici.Tenendo in considerazione le condizioni economiche, la domandamondiale del traffico container prevede un aumento del 60% (pari a495 milioni nel 2010) e di un ulteriore 32% (pari a 647 milioni di teunel 2015). Per quanto concerne la domanda dei porti asiatici è previ-sta un’espansione della movimentazione del 63% dal 2003 al 2010fino a 240 milioni di teu, mentre in quelli americani la crescita è atte-sa intorno al 55% (pari a 91 milioni di teu nel 2010). Lo studio pre-vede anche per gli scali dei Caraibi e per quelli latini trend positivi.
I PORTI ITALIA
NI
24
E qui si apre il discorso sullo stato dei porti. Ed è ancora una voltaun’analisi di Osc che ci aiuta a comprendere una situazione che,va detto subito, presenta non pochi dati negativi per il nostro pae-se. Un confronto con gli altri scali europei, infatti, mette in lucecome il gap a nostro scapito sia non solo già profondo ma anchedestinato a crescere sempre di più nel tempo. I porti con cui cistiamo confrontando hanno strutture più dinamiche, dispongonodi maggiori capacità finanziarie e possono contare sull’appoggiodelle istituzioni nazionali che da sempre, e sempre di più, operanoconcretamente per assicurare e sviluppare il ruolo primario dellaportualità nel loro sistema economico.E’ anche per questo motivo, se non addirittura soprattutto, che iporti del Nord Europa continuano a viaggiare a velocità doppia ri-spetto a quelli del Sud. Se, poi, il confronto è fra colossi del cali-bro di Rotterdam e Anversa e i porti italiani, allora l’esito è diquelli da punteggio tennistico, ovviamente a nostro sfavore. Nonc’è nemmeno una pagina, un grafico o una tabella in cui il raf-fronto non metta spietatamente in luce quanto il mondo del tra-sporto marittimo viaggi su una linea che si allontana costante-mente dalle analisi e dagli interventi che, in maniera sempre piùspesso raffazzonata, il nostro sistema elabora e cerca di mettere inatto.Stando al rapporto redatto dai più grandi esperti dello shipping in-ternazionale (che basano il loro studio su ogni intervento già pro-grammato, approvato e finanziato), i numeri e le statistiche diffusihanno un’evidenza tale da non richiedere ulteriori commenti. Iporti del Nord Europa, che nel 2003 avevano una capacità globaledi movimentazione pari a 47,6 milioni di teu, arriveranno nel 2015a quota 110 milioni. Il tasso di crescita sarà pari al 91% nel perio-do 2004-2010 e del 19% nei successivi 5 anni. Fra i singoli porti,si segnalano i livelli d’eccellenza di Rotterdam (da 8,37 milioni diteu del 2003 ai 20,02 del 2015), Anversa (da 6,15 a 15,98 milio-ni), Amburgo (da 6,95 a 14 milioni) e Harwich Haven (da 3,25 a7,47 milioni). Di tutto rilievo anche il dato dei porti russi del marBaltico, la cui capacità passerà da 0,85 a 5,57 milioni di teu. Ma ilprogresso più rimarchevole sarà quello del sistema portuale tede-sco, che fra il 2004 e il 2010 vedrà la propria capacità aumentaredel 95%.
25
I PORTI ITALIA
NI
OCCORRE RIDURRE IL GAP DEI PORTI ITALIANI
Scendendo al Sud del continente, l’analisi di Ocean shipping con-sultants si fa sempre più ricca di luci e ombre. Allo sviluppo fortedei porti spagnoli, infatti, corrisponde la desolante prospettiva de-gli scali italiani che, solo in rarissimi casi, si segnalano positiva-mente. Nell’Europa meridionale atlantica il miglior risultato previ-sto è quello del porto di Las Palmas, nelle isole Canarie, che nel2015 avrà una capacità di 3,34 milioni di teu. Passando al Medi-terraneo occidentale, spuntano subito i risultati più significativi:Algeciras (da 2,90 a 9,10 milioni), Valencia (da 2,30 a 6,15), Bar-cellona (da 1,90 a 6). Il governo spagnolo, del resto, in questi annisi è contraddistinto più di tutti per i suoi importanti investimenti inporti e logistica.Quanto all’Italia, i tassi di crescita – con l’eccezione di Gioia Tau-ro, destinata a superare quota 8 milioni di container – diventanominimi. Genova, fino a tre anni faporto leader nel Mediterraneo, nel 2003 aveva una capacità di1,75 milioni di teu: nel 2015, ovvero dopo la realizzazione di unaparte degli interventi previstinel vecchio Piano regolatore,passerà a 3,55 milioni (vale adire poco più della metà diBarcellona). Sviluppo frena-to anche per La Spezia (da1,20 a 1,90 mi l ioni d iteu), Livorno (da 0,95 a1,05), Taranto (da 1,20a 2,00) e Tr ieste (da0,40 a 0,60).
26
Ma lo studio di Ocean shipping non si limita a prendere in consi-derazione il trend di crescita delle capacità dei porti. Si spinge, in-fatti, a ipotizzare quale potrà essere, neiprossimi anni, la risposta del mercato agli investimenti program-mati dalle varie Authority. Si scopre, così, che i porti italiani nel2015 potranno movimentare 24,95 milioni di teu, mentre la do-manda del mercato andrà da un minimo di 16,80 a un massimo di19,84 milioni di teu. Nella migliore delle ipotesi, insomma, il siste-ma portuale italiano potrà saturarsi al 79,5% della sua possibilitàreale.
27
NAUTES
IL CANALE DI SUEZ,ARTIFICIALE E NECESSARIO
Annamaria Barbato Ricci
A circa centoquaranta anni dalla sua inaugurazione, il canalemarittimo artificiale più lungo al mondo dimostra la sua indispensa-bilità. Rappresenta tuttora un punto nevralgico per il trasportocommerciale. Il movimento di navigazione si prevede cresca del 3%nel 2007. Il futuro è East Port Said
Nell’occhio del ciclone, in tutti i sensi. Il Canale di Suez, collega-mento principe fra Mediterraneo e Mar Rosso, rappresenta sindalla sua inaugurazione nel 1869, dopo dieci anni di lavori, il pun-to nevralgico per il commercio e per gli equilibri geopolitici. Conla sua realizzazione, la navigazione marittima ha vissuto una rivo-luzione copernicana, abbattendo i costi e riducendo drasticamen-te i tempi. Secondo i calcoli recentemente resi noti dall’Autoritàche governa il Canale di Suez, grazie a esso si riduce dell’86% ladistanza fra il Mediterraneo orientale e l’Arabia Saudita e del 23%quella fra l’Olanda e il Giappone.La galoppante espansione dell’economia internazionale, l’esisten-za di navi mercantili che hanno un pescaggio massimo di 62 piedie una stazza fino a 220mila tonnellate hanno richiesto un resty-ling del Canale, per adeguarne la profondità. L’esigenza di un am-pliamento della recettività portuale di Porto Said ha suggerito lacreazione di un nuovo insediamento, denominato East Port Said,sfida infrastrutturale per il governo egiziano che conta di attrarreinvestimenti e aziende su un’area di 35 chilometri quadrati. Questo è il futuro. Ma ogni vicenda va vista nella sua interezza,per cui è imprescindibile un salto all’indietro, a cominciare da piùo meno 40 secoli fa. In Egitto governavano i Faraoni e Sinoserte
28
III, nel 1874 a. C., diede il via al primo progetto in assoluto perrealizzare un canale di collegamento fra il Nilo e il Mar Rosso,prodromo del Canale di Suez. Con lo sgranarsi dei secoli, nume-rosi sovrani succedutisi sul trono egiziano posero mano al nuovoscavo del canale, contrastando l’accumulo dei detriti trasportatidal Nilo. Nel 1310 a. C. l’opera fu promossa da Siti I, nel 610 a.C.fu la volta di Nekhao e cent’anni dopo di Dara I, fino al 285 a.C.,allorché lo scavo entrò nel “programma di governo” di Tolomeo.
29
IL CANALE DI SUEZ, ARTIFICIALE E NECESSARIO
Passando il testimone della sovranità all’Impero romano, nel 117a.C. l’opera fu replicata dall’imperatore Traiano. Nell’era cristiana(640 d.C.) il canale fu riscavato da Omar ben Abdelaziz, il cosid-detto Principe dei Fedeli, sultano dell’epoca. Poi tutto si fermòper oltre 1.200 anni, ossia fino al Canale di Suez così come furealizzato grazie a Ferdinand de Lesseps. M quella è storia nota econtroversa insieme. Questa è la genesi del canale marittimo artificiale più lungo almondo (190 chilometri da Porto Tawfik a Porto Said), largo 280metri, di cui 195 navigabili, che si naviga a una velocità massimaper le navi cariche a 8 nodi, sia di giorno sia di notte con altissimilivelli di sicurezza, grazie a sofisticati sistemi di controllo.Nel suoi 137 anni di storia il Canale, nazionalizzato da Nasser nel1956 e affidato a un’apposita Autorità, è stato chiuso per sei vol-te, la più lunga delle quali è stata dal 4 giugno 1967 al 5 giugno1975, in conseguenza del conflitto fra Egitto e Israele denominato“Guerra dei Sei Giorni”. Un danno considerevole al commerciomondiale, costretto a ritornare alla circumnavigazione del Capo diBuona Speranza. Circumnavigato metaforicamente il Capo dellaBuona Volontà che ha consentito la riapertura del Canale, malgra-do le situazioni spesso fibrillanti dell’area mediorientale, il Canaledi Suez macina utili su utili. Lo ha confermato nel corso della ceri-monia celebrativa del cinquantenario della nazionalizzazione delCanale, lo stesso presidente dell’Autorità del Canale, MahmoudAbdel Fahad, annunciando che nell’esercizio finanziario chiusosi al30 giugno scorso l’Ente ha raggiunto il più alto ricavo della suastoria, incassando 3 miliardi e 564 milioni USD.Nel frattempo, grazie a una manodopera specializzata tutta egi-ziana, sono in corso alacri lavori per migliorare la navigabilità delcanale e all’inizio del 2007 la profondità si attesterà sui 66 piedi(+4 piedi rispetto all’attuale). Solo poche petroliere e navi bulkcon pescaggio superiore a 64 piedi non potranno fruire della co-moda scorciatoia rappresentata da Suez. Intanto, nel primo semestre 2006, hanno attraversato il Canale diSuez 788 petroliere, per un totale di 120 milioni di tonnellate dicarburante. Nel 2005 hanno attraversato il canale 3.568 petroliere(+9,5% rispetto all’anno precedente), trasportando 147.785 mi-lioni di tonnellate di greggio (+4,1%).
30
Sull’avveniristica ipotesi di un nuovo Canale parallelo in Paesi vici-ni, Fahad ha escluso la sua realizzabilità, in quanto il budget ne-cessario superebbe i 60 miliardi di USD, ovvero mancherebbe uncorretto equilibrio costi/benefici, oltre a essere un’opera troppoonerosa per qualsiasi governo (l’equivalente dello stanziamentonecessario per costruire oltre una diecina di Ponti di Messina).Quella che si svilupperà, quindi, è l’opera che già da 137 anni svol-ge il ruolo cardine di bypass fra Asia, Africa ed Europa e che per-metterà il passaggio anche delle cosiddette superpetroliere, con-sentendo il transito del 64% dell’intera flotta mondiale delle petro-liere (attualmente può accedervi il 60%). Le petroliere sono il19,6% del totale delle navi che attraversano il Canale, raggiungen-do anche gli Usa; grazie ai lavori attuali, si prevede che il movimen-to di navigazione, entro il 2007, dovrebbe incrementarsi del 3%.«L’Ente Canale di Suez – afferma il presidente – continua a conce-dere sconti alle petroliere ed alle metaniere che vanno dai Paesidel Golfo Persico verso l’Europa e l’America. Si giunge a prevederesconti pari al 35% del pedaggio; ulteriori aggiustamenti delle ta-riffe riguardano quantità che superino le 500mila tonnellate.I pedaggi saranno aumentati nel marzo 2007. Tale incremento èstato deciso dopo uno studio approfondito dei nuovi movimentidel commercio mondiale e delle varie merci trasportate fra i mer-cati dell’Est e dell’Ovest ed i costi dei passaggi marittimi concor-renti del Canale di Suez. Inoltre, l’aumento dipende anche dai co-sti dei lavori effettuati (per un ammontare di 1,2 mld di lire egizia-ne). Saremo quindi in grado di consentire il passaggio di superpe-troliere e delle avanzatissime navi oggi in costruzione, a doppioscafo e con stazza fino a 360mila tonnellate».Anche le portacontainer hanno avuto un ruolo importante nellosviluppo del traffico del Canale. «Sono le nostre prime clienti –sottolinea il presidente – Nei primi 9 mesi di quest’anno sono pas-sate 1.691 portacontainer (+ 9% rispetto all’anno precedente),con peso netto di merce trasportata di 82.276 tonnellate (+11%circa). Per quel che riguarda le ricorrenti voci di attacchi terroristicicontro il Canale, ci sono procedure e restrizioni severissime per te-nere sotto controllo la navigazione al suo interno e proteggeretutte le navi nel loro passaggio. Tali crimini sono previsti in tutto il
31
IL CANALE DI SUEZ, ARTIFICIALE E NECESSARIO
mondo, ma i codici di sicurezza del traffico marittimo internazio-nale aggiornati recentemente hanno vieppiù innalzato il livello disicurezza».
* Uomo politico e patriota messinese, autore di uno studio stati-stico sul Canale di Suez commissionatogli da Ferdinand de Les-seps, promotore della costruzione dell’opera
Il futuro: East Port SaidIl governo egiziano punta molto su un rafforzamento di PortoSaid, grazie anche a East Port Said, che ne amplia grandemente larecettività. Il porto è situato in un’area distinta, a est dell’entratasettentrionale del Canale di Suez, nel punto d’incontro di tre con-tinenti, nel luogo in cui s’incrociano Oriente e Occidente. A set-tentrione c’è il Mar Mediterraneo, a Sud sorge la zona industriale,
32
mentre a est lambisce il Lago Malaha e a ovest s’affaccia sul Cana-le di Suez, nell’ambito dell’area di competenza del Governatoratodi Porto Said.L’obiettivo oggi è, grazie a un piano d’intervento in corso di pre-parazione, quello di attrarre investimenti stranieri (in particolarenordeuropei, italiani e spagnoli, oltre che delle più forti multina-zionali) in questa nuova realtà portuale, con la costruzione di unaserie d’infrastrutture e di servizi che lo rendano leader nel Medi-terraneo, visto che il Canale di Suez dà a quest’area potenzialitàche vanno strategicamente sfruttate. Una realtà portuale tanto allettante che la danese Maersk, vero eproprio colosso, vi si è già insediata dal 2004. In particolare, i 4chilometri di banchine di East Port Said possono dare grande ossi-geno a quest’insediamento portuale, con prospettive reali per chivorrà effettuare investimenti su larga scala, contribuendo alla suacrescita.Vi è un vasto territorio, alle spalle del previsto terminal container,che può essere utilizzato per il magazzinaggio dei cargo in trans-
33
IL CANALE DI SUEZ, ARTIFICIALE E NECESSARIO
ito, di costruzioni e riparazioni navali o per il disallestimento di na-vi; all’interno del porto, poi, è possibile insediare una fabbrica perl’assemblaggio di componentistica elettronica. Inoltre, in una zonadi 87 chilometri quadrati, di cui è competente la provincia e nonl’Autorità del Canale è possibile avviare progetti industriali per lacostruzione e la riparazione di container e lo smantellamento dellenavi. Altra opportunità imprenditoriale interessante che sarebbepossibile radicare in quest’area concerne progetti di logistica inte-grata riguardanti l’industria automobilistica per importare, assem-blare, distribuire e riesportare auto. Altrettanto promettente po-trebbe essere la realizzazione di progetti logistici per la raccolta, lapreparazione, l’impacchettamento e il magazzinaggio di prodottiagricoli, sia frutta che ortaggi.
In prospettiva: Medmar South 2007Si svolgerà a Porto Said, fra il 17 ed il 19 aprile 2007, la secondaedizione di Medmar South 2007, una convention d’ampio respirorivolta al mondo marittimo del Mediterraneo, giacché il Mare no-strum aspira a diventare l’Hub del mondo. Organizzato dalla italiana Ies (International exhibition services) di-retta da Piero Zipoli, forte del know how acquisito realizzando daben otto edizioni l’Omc (Offshore Mediterranean Conference &Exhibition), Medmar South 2007 si rivolge al mondo del mare intutte le sue declinazioni: Autorità portuali, Operatori terminalisti,Aziende specializzate nella costruzione di porti e nella fornitura diattrezzature portuali; imprese per la movimentazione di cargo;Cantieri per la costruzione e la riparazione di navi; Società d’inge-gneria navale; Società di dragaggio; Associazioni imprenditoriali,sindacati e commerciali.Chi ha interesse a visitare Medmar South 2007? Sicuramente gliarmatori, i dirigenti dei porti e dei terminali, specialisti in ingegne-ria navale e portuale; progettisti di strutture portuali. Potrannotrovare numerosi motivi d’interesse nel meeting expo anche con-sulenti in campo ambientale; operatori nel campo della logistica;banche e associazioni professionali.Gli argomenti in carnet nella tre giorni d’aprile a Porto Said sonodi grande appeal: si va dalle opportunità offerte dallo sviluppo del
progetto di Port Said East alle interessante prospettive rappresen-tate dalla creazione di joint ventures pubblico/private nella gestio-ne dei porti; dall’utilizzo di nuove tecnologie nella costruzione deiporti e nelle attività di dragaggio fino alla sicurezza dei terminali;dalle proposte di partenariato nell’ambito del Programma Euro-med all’automazione nei porti e nei terminali fino alla formazione,alla pianificazione dei porti in una prospettiva territoriale a piùampio raggio per giungere a un aspetto di scottante attualità qua-le è la sicurezza ambientale.Per informazioni: www.medmarsouth.com; Ies srl: 0761/527976
34
35
NAUTES
IL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE
Domenico Repetto*
La disciplina del collocamento della gente di mare, le finalità el’ambito di applicazione del decreto che disciplina l’assunzione deimarittimi che supera il sistema obbligatorio di collocamento validoper tutti i lavoratori. Il ruolo delle Agenzie per il lavoro e l’anagrafeper la gente di mare
Il 28 luglio 2006 sono entrate in vigore le disposizioni del D.P.R.n. 231 del 18 aprile 2006, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen. 161/2006), riguardanti la disciplina in materia di collocamentodella gente di mare. Il decreto attua la previsione del Decreto Le-gislativo n. 297/2002 secondo cui, con un regolamento emanatosu proposta del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, diconcerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, devedisciplinare il collocamento della gente di mare, prevedendo il su-peramento del sistema di collocamento obbligatorio. L’articolo 1indica le finalità e il campo di applicazione del regolamento: assi-curare una disciplina del collocamento dei lavoratori marittimi im-prontata alla razionalizzazione delle procedure e al miglioramentodell’incontro tra domanda e offerta di lavoro riguardante la gentedi mare disponibile a prestare servizio a bordo di navi italiane perconto di un armatore o società di armamento. Il regolamento nonsi applica al personale delle imprese di appalto pur essendo sog-gette alla gerarchia di bordo. Per i lavoratori marittimi extracomu-nitari continua ad applicarsi la legislazione speciale.
* Dipartimento per le Politiche fiscali – Ufficio Comunicazione istituzionale – Mini-stero del Lavoro
36
Dopo l’elencazione delle definizioni dei soggetti ai quali sono ri-volte le disposizioni contenute nel regolamento (articolo 2), l’arti-colo 3 elenca i principi generali su cui si basa la disciplina del col-locamento dei marittimi:• istituzione dell’anagrafe nazionale della gente di mare;• costituzione della Banca nazionale del lavoro marittimo;• assunzione diretta dei lavoratori con obbligo di comunicazionecontestuale al servizio di collocamento marittimo, salvo le eccezio-ni stabilite;• abolizione del regime di collocamento obbligatorio e fissazionedei principi per l’individuazione di operatori privati abilitati a forni-re servizi di intermediazione nel settore marittimo;• revisione del sistema sanzionatorio secondo gli articoli 18 e 19del Decreto leg.vo n. 276/2003;• abrogazione di disposizioni previgenti incompatibili con la nuovaregolamentazione.
Le funzioni di indirizzo e coordinamento (articolo 4) sono attribui-te al ministero del Lavoro, che le esercita d’intesa con le Regioni ele Province autonome, sentito il Comitato Centrale per il coordina-mento in materia di collocamento delle gente di mare. Per quantoconcerne i Servizi del collocamento (articolo 5), gli Uffici di collo-camento, istituiti ai sensi dell’art. 2 del Regio Decreto Legge n.1031 del 24 maggio 1925, dalla data di entrata in vigore del rego-lamento vengono posti alle dipendenze funzionali del ministerodel Lavoro. Entro 60 giorni con apposito DPR saranno definite lastruttura e l’organizzazione degli Uffici stessi, che restano ubicatipresso le autorità marittime, nonché le modalità del loro funziona-mento.
Entrano in gioco gli Enti bilaterali e le Agenzie peril lavoroIl regolamento prevede che, per lo svolgimento di attività d’inter-mediazione nei riguardi dei propri associati il ministero del Lavoropotrà autorizzare mediante convenzione gli Enti bilaterali del lavo-ro marittimo, che pertanto restano abilitati a realizzare tutti gliadempimenti e le certificazioni degli Uffici di collocamento dellagente di mare, a condizione che tali attività siano eseguite senzafinalità di lucro e ferma restando l’interconnessione obbligatoriacon la Borsa del lavoro marittimo.Il decreto introduce una rilevante novità: le attività di collocamentopotranno essere esercitate anche dalle Agenzie per il lavoro di cuiall’art. 4 del Decreto legislativo n. 276/2003 che saranno munite dispecifica autorizzazione del ministero del Lavoro, alla luce dei re-quisiti e in base alle modalità che saranno fissate con decreto delministero del Lavoro di concerto con quello delle Infrastrutture.
Funzioni e compiti dei nuovo Uffici di collocamentoL’articolo 6 del regolamento disciplina le funzioni e le competenzedegli Uffici di collocamento della gente di mare ubicati presso leCapitanerie di porto e gestite pariteticamente da armatori e marit-timi, concernenti:• la gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori; • la gestione delle schede professionali;
38
39
IL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE
• l’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e dis-ponibilità al lavoro marittimo; • la preselezione all’incontro domanda-offerta di lavoro; • la registrazione delle comunicazioni obbligatorie degli armatoriin materia di arruolamento; • il monitoraggio statistico della consistenza e dei flussi di lavoromarittimi.
L’anagrafe della gente di mareL’articolo 7 contiene le disposizioni per le procedure del colloca-mento, a cominciare dall’anagrafe della gente di mare: i cittadiniitaliani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni, che abbia-no adempiuto al diritto – dovere all’istruzione e alla formazionein base alle disposizioni del Decreto legislativo n. 76/2005 e chesiano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 119 del Codice del-la Navigazione, se intendono avvalersi dei servizi di collocamentoper l’arruolamento della gente di mare, si iscrivono negli Uffici dicollocamento dei marittimi del rispettivo domicilio e inseriti in unasezione speciale dell’Elenco anagrafico dei lavoratori di cui agli ar-ticoli 4 e 7 del DPR n. 442/2000.
40
In tale elenco possono essere iscritti altresì gli allievi degli Istitutitecnici marittimi e degli Istituti professionali a indirizzo marittimo.L’iscrizione presso l’Ufficio di collocamento del domicilio dei lavo-ratori interessati modifica la precedente normativa, che la consen-tiva presso un qualsiasi Ufficio, indipendentemente dal domicilio,residenza abituale o compartimento di immatricolazione.Resta invece immutato il divieto d’iscrizione presso più uffici dicollocamento. Gli aspiranti all’iscrizione con meno di 18 anni de-vono essere muniti del consenso di chi esercita la patria potestàgenitoriale o la tutela.
La dichiarazione di disponibilitàCome per la generalità dei lavoratori, anche per la gente di marel’articolo 9 disciplina la dichiarazione di disponibilità da parte dellavoratore marittimo e la relativa registrazione nell’elenco anagra-fico. Se il lavoratore è privo di lavoro e immediatamente disponibi-le all’imbarco, consegna o invia un’apposita comunicazione, nellaquale devono essere attestati i precedenti lavorativi, la qualificaprofessionale con la quale intende imbarcarsi, nonché l’immediatadisponibilità a svolgere attività marittima. Ricevuta la suddetta di-chiarazione di disponibilità, gli Uffici di collocamento marittimoprovvedono a darne diffusione in ambito nazionale, avvalendosidella Borsa continua (disciplinata dal successivo articolo 10). GliUffici provvedono alla verifica della permanenza nella condizionedi disponibilità mediante periodici colloqui da attivarsi entro 3 me-si dall’iniziale dichiarazione e a seguito delle comunicazioni daparte degli armatori con le assunzioni dirette effettuate.
L’assunzioneIn base all’articolo 11, la disciplina dell’assunzione della gente dimare è così regolata:• gli armatori e le società di armamento sono tenuti, in caso di ar-ruolamento di marittimi con assunzione diretta, a darne comuni-cazione contestuale (ossia entro la stessa giornata) agli Uffici dicollocamento operanti nel territorio nel cui ambito si verifica l’im-barco; • la comunicazione deve contenere, oltre alle generalità dell’arma-tore e della società di armamento, le informazioni e le indicazioni
41
IL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE
previste dalla lettera b) alla lettera l) dell’articolo 11 comma 2 delregolamento.Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indetermi-nato, è previsto l’obbligo di comunicazione della stessa ai predettiUffici entro 5 giorni.
Le sanzioniIn materia di sanzioni, l’articolo 12 del regolamento prevede cherestano ferme le disposizioni sanzionatorie contenute negli articoli18 comma 1 e 19 commi 3 e 5 del Decreto legislativo n. 276/03(vedi tabella).
42
Il regime sanzionatorio
Disposizioni transitorieI lavoratori marittimi, iscritti nelle matricole della gente di mareche alla data di entrata in vigore del regolamento non sono in ser-
Arresto fino a sei mesi e am-menda da 1.500 a 7.500 euro
E’ possibile pagare la sanzioneminima ridotta della metà se l’a-dempimento della comunicazio-ne è effettuato spontaneamen-te entro il termine di cinquegiorni decorrenti dalla data diinizio dell’omissione
Esercizio non autorizzato del-l’attività di intermediazione
Mancata comunicazione di as-sunzione agli uffici di colloca-mento Sanzione amministrati-va pecuniaria da 100 a 500 europer ogni lavoratore interessato
43
vizio di navigazione (articolo 14), sono tenuti a presentarsi pressol’Ufficio di Collocamento competente per territorio entro 180giorni, a far data dal 28 luglio 2006, per rendere la dichiarazionedi disponibilità di cui all’articolo 9, comportante la registrazionenell’elenco anagrafico e la compilazione della scheda professiona-le. La mancata presentazione senza giustificato motivo comportaa carico del lavoratore marittimo l’obbligo di riacquisire i certificatidi formazione necessari per l’imbarco prima di poter richiedere laregistrazione nell’elenco anagrafico.
Prossimi sviluppi: modalità di comunicazione equalifiche professionaliCon successivo provvedimento del ministro del Lavoro, di concertocon quello delle Infrastrutture, Innovazione tecnologica, nonchéd’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,Regioni e Province autonome, sarà definito il modello di comuni-cazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazionedei dati contenuti nell’elenco anagrafico della gente di mare, non-ché le modalità di collegamento con le matricole della gente dimare, di cui all’articolo 118 del codice di navigazione, al quale oc-corre iscriversi per la stipula e la permanenza in vita del contrattodi arruolamento.Alle qualifiche professionali del personale marittimo e ai relativi re-quisiti minimi provvede l’articolo 8 del Regolamento, stabilendoche entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso si provvede-rà al riguardo con apposito decreto del ministro delle Infrastrutturedi concerto con i ministri del Lavoro, dell’Istruzione e della Ricerca. In via transitoria si farà riferimento a quanto riportato nell’Allega-to al regolamento, che concerne le seguenti posizioni lavorative:personale di coperta, personale di macchina, personale polivalen-te, personale sanitario, personale di camera, personale di cucina efamiglia, personale addetto ai servizi vari, allievi sottufficiali, sezio-ne servizi vari, allievi comuni alberghieri.
IL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE
45
NAUTES
IGIENE E SICUREZZADEI LAVORATORI MARITTIMI
Claudio Natale*Roberta Stopponi**
Possono contare sul sostegno di una legislazione sempre più organicama sono ancora molte le situazioni in cui manca un’operativitàeffettiva delle normative. Una situazione critica specie per il contrastodegli eventi infortunistici e delle malattie professionali
La normativa vigente di settore introduce a carico delle imprese dipesca un’articolata serie di adempimenti quali la valutazione delrischio, la redazione del piano di sicurezza, la nomina del respon-sabile aziendale per la sicurezza e la sorveglianza sanitaria. Neltentativo di favorire una lettura chiara e completa della normativacontenente la disciplina sulla sicurezza e la salute dei lavoratorimarittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali ritenia-mo utile ripercorrere i passaggi più importanti dell’evoluzione le-gislativa e riportarne in sintesi i contenuti più salienti.Il comparto marittimo è un settore per il quale sono intervenuteanche diverse convenzioni e raccomandazioni a livello internazio-nale e, soprattutto, sono stati sviluppati aspetti riguardanti la pre-venzione, la formazione professionale e il ricorso alle tecnologie
* Ispettore tecnico della prevenzione – Ufficiale di Polizia Giudiziaria – Diparti-mento di Sanità Pubblica – Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro –Regione Emilia-Romagna – A.U.S.L. di Parma – Distretto Valli del Taro e del Ceno
** Dirigente medico – Ufficiale di Polizia Giudiziaria – Dipartimento di prevenzio-ne – Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro – Regione Marche –A.S.U.R. – Zona territoriale 8 Civitanova Marche (MC)
46
più moderne per i dispositivi di salvataggio. Una piena regolazionedel settore è giunta con il dlgs. n. 271 del 27 luglio 1999, pubbli-cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 Agosto 1999, Supple-mento ordinario n. 15, che ha adeguato la normativa derivata dal-la legge n. 485 del 31 dicembre 1998.Da un’analisi del sopracitato decreto si vede come esso rispecchiin maniera quasi speculare il dlgs. n. 626 del 19 settembre 1994(decreto di attuazione di numerose direttive comunitarie riguar-danti il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori)e sue successive integrazioni e modificazioni.Già nel primo articolo viene esplicitato lo scopo del dlgs. 271/99:adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavo-ratori alle particolari esigenze espletate sulle navi, in modo da as-sicurare in materia di sicurezza del lavoro la tutela della salute e laprevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali; determi-nare gli obblighi e le responsabilità specifiche da parte d’armatori,marittimi e altre persone interessate in relazione alla valutazionedei rischi a bordo delle navi; fissare, in materia d’igiene del lavoro,i criteri relativi alle condizioni d’igiene e abitabilità degli alloggidegli equipaggi; definire i criteri relativi all’organizzazione del si-stema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro a bordo e al-l’impiego dei dispositivi di protezione individuale; definire la dura-ta dell’orario di lavoro e del periodo di riposo del personale marit-timo; dettare le misure di sicurezza alla presenza di particolaricondizioni di rischio; assicurare l’informazione e la formazione de-gli equipaggi; prevedere i criteri per il rilascio delle certificazioni eattestazioni dell’avvenuta formazione.
47
IGIENE E SICUREZZA DEI LAVORATORI MARITTIMI
Il secondo articolo individua i soggetti delle norme, ovvero i lavo-ratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercanti-li, nuove ed esistenti, adibite alla navigazione marittima e alla pe-sca nonché alle navi o unità mercantili in regime di sospensionetemporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili.Mentre nell’articolo 4 vengono indicati i casi d’esclusione dall’ap-plicazione del decreto, il successivo articolo 5 definisce quali sonole misure da adottare per la prevenzione degli infortuni e l’igienedel lavoro dei marittimi, che ovviamente sono a carico dell’arma-tore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per ilavoratori marittimi.Gli obblighi dell’armatore e del comandante vengono definiti dal-l’articolo 6. In particolare, si stabilisce che l’armatore delle navi ounità elencate all’articolo 2, in relazione alle caratteristiche tecni-co-operative dell’unità, secondo il comma 1, deve valutare i rischiper la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predispo-nendo il piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro contenente in-formazioni sull’ambiente di lavoro stesso, sulle condizioni di igienee sicurezza a bordo e su eventuali interventi migliorativi, sulle mi-sure di prevenzione e protezione dei lavoratori attuate. Il comma 2stabilisce che la documentazione di cui al comma 1 deve essereredatta da personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all’arti-colo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativoregolamento di attuazione, e che essa deve essere inviata dall’ar-matore al ministero ai fini dell’approvazione secondo specifiche eben definite modalità.Il comma 3 stabilisce che il piano di sicurezza è integrato e aggior-nato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni abordo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33. Il comma 4 fissainvece i casi nei quali la documentazione, di cui al comma 2, pos-sa essere autocertificata da parte dell’armatore o dal proprietario,non inviata al ministero per l’approvazione ma conservata a bordoed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarnela conformità alle disposizioni del presente decreto. Nel comma 5viene definita una serie di obblighi per l’armatore e il comandantedella nave, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,fra i quali quelli di: designare il responsabile del servizio di preven-
48
zione e protezione dei lavoratori marittimi; designare il personaleaddetto al servizio di prevenzione e protezione; designare il medi-co competente.L’articolo 7 fissa, ferme restando le disposizioni previste dal codicedella navigazione e dal relativo regolamento di attuazione nonchédalle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, gliobblighi del comandante della nave relativi all’igiene, salute e si-curezza del lavoro. Per contro, l’articolo 8 definisce gli obblighi dellavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi o unità di cui alpresente decreto. Allo stesso modo, l’articolo 9 determina gli ob-blighi dei progettisti, dei costruttori, dei fornitori e degli installato-ri, fermo restando quanto già previsto dall’art. 6 del decreto legis-lativo 19 settembre 1994 e successive modificazioni e integrazio-ni. I progettisti e i costruttori di navi mercantili e da pesca nazio-nali devono rispettare i principi generali di prevenzione in materiadi tutela della salute e di sicurezza del lavoro a bordo, secondo ledisposizioni del presente decreto e di quanto stabilito, rispettiva-mente, dall’articolo 232 del codice della Navigazione e dall’artico-lo 275 del relativo regolamento di attuazione, integrato dalle dis-posizioni contenute all’articolo 20 della legge 14 giugno 1989, n.234 e nel decreto del ministro della Marina mercantile 18 febbraio1992, n. 280.L’articolo 10 stabilisce alcuni vincoli per il contratto d’appalto od’opera e gli obblighi previsti per l’armatore in caso di affidamen-to di lavori o di servizi a bordo delle navi mercantili o da pesca na-zionale, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi i quali, a lo-ro volta, devono cooperare all’attuazione delle misure di preven-zione e protezione dai rischi di incidenti sulle attività oggetto del-l’appalto o del contratto d’opera e coordinare gli interventi di pro-tezione e prevenzione dai rischi dei propri lavoratori, al fine di evi-tare interferenze con l’attività lavorativa di bordo connessa all’e-sercizio della navigazione. L’orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca vienestabilito dall’articolo 11 nel quale si definisce che per “durata dellavoro a bordo della nave” s’intende il tempo durante il quale unlavoratore marittimo è tenuto a effettuare l’attività lavorativa con-nessa all’esercizio della navigazione e precisando che rientrano
49
IGIENE E SICUREZZA DEI LAVORATORI MARITTIMI
nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navi-gazione e di porto anche gli appelli per le esercitazioni di emer-genza antincendio e abbandono della nave, le attività richieste dalcomandante inerenti alla sicurezza della navigazione, le attività diformazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, leattività di manutenzione ordinaria della nave, le attività richiestedal comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unitàmercantili o da pesca o di soccorso a persone. Viene inoltre defini-to che per “ore di riposo” s’intende il tempo non compreso nelladurata del lavoro e precisato che quest’espressione non compren-de le interruzioni di breve durata e che, fatte salve le disposizionipresenti nei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata del-l’orario di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mer-cantili e da pesca, è stabilita in otto ore giornaliere, con un giornodi riposo a settimana, oltre ai giorni di ferie. Il successivo articolo
50
12 specifica che l’armatore designa per ogni unità navale, tra ilpersonale di bordo, una o più persone che espleteranno i compitidel servizio di prevenzione e protezione, nonché il responsabiledel servizio stesso, sentito il rappresentante alla sicurezza dell’am-biente di lavoro.I compiti del Servizio di prevenzione e protezione a bordo sonoelencati nell’articolo 13 dove si precisa che il Servizio ha accesso atutte le informazioni inerenti all’igiene, la salute e la sicurezza del-l’ambiente di lavoro a bordo dell’unità ed è consultato dall’arma-tore per l’elaborazione delle metodologie di lavoro a bordo chepossono avere degli effetti sulla salute e sulla sicurezza del lavora-tore marittimo. L’articolo 14 prevede che l’armatore, tramite il Ser-vizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno unavolta l’anno, una riunione alla quale partecipano il comandantedella nave, il responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro eil rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, al fine diesaminare misure, dispositivi di protezione, piani di sicurezza edeventuali variazioni delle situazioni di esposizione del lavoratore afattori di rischio, introduzione di nuove tecnologie che potrebberocomportare riflessi sull’igiene e la sicurezza dei lavoratori. A con-clusione della riunione è redatto apposito verbale che è conserva-to tra i documenti di bordo a disposizione degli organi di vigilanzae di ispezione e una copia è affissa a bordo per opportuna cono-scenza di tutto l’equipaggio.Ferme restando le responsabilità del comandante della nave, pre-viste dal codice della Navigazione e dell’ufficiale responsabile del-la sicurezza ove previsto, l’articolo 15 stabilisce i doveri del re-sponsabile del Servizio di prevenzione e protezione il quale, nello
51
IGIENE E SICUREZZA DEI LAVORATORI MARITTIMI
svolgimento delle sue funzioni, si avvale del servizio di prevenzio-ne e protezione e della collaborazione del rappresentante alla si-curezza.Nell’articolo 16 si dichiara che a bordo di tutte le navi o unità dicui al presente decreto i lavoratori marittimi debbano eleggere ilproprio rappresentante all’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavo-ro, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali dicategoria. Si stabiliscono altresì i doveri del responsabile del Servi-zio di prevenzione e protezione per il quale si precisa che non puòsubire pregiudizio alcuno a causa della sua attività e beneficia del-le misure di tutela e libertà dei diritti sindacali, previste dalle vi-genti norme in materia di tutela dei lavoratori. Egli, inoltre, devedisporre del tempo necessario allo svolgimento del proprio incari-co senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari perl’esercizio delle funzioni connesse al compito assegnato, ha dirittoa una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza dellavoro a bordo delle navi, concernente la normativa nazionale einternazionale vigente nel settore e i rischi specifici esistenti nelproprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguatenozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei ri-schi stessi. Inoltre, l’articolo 17 prevede che nel “Manuale di ge-stione per la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo” siano ri-portati gli strumenti e le procedure utilizzate dall’armatore peradeguarsi alle disposizioni previste dal decreto e dalle norme inter-nazionali. Esso può costituire parte integrante del Safety Manage-ment Manual, redatto ai sensi di quanto previsto dal codice inter-nazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cuialla Convenzione Solas.
52
Negli articoli 18-22 si specifica che, ai fini di verificare l’applicazio-ne delle disposizioni contenute nel presente decreto, le navi sonosottoposte a visite iniziali e periodiche (la periodicità varia a secon-da di alcune e ben precise caratteristiche delle navi) disposte dal-l’Autorità marittima del compartimento di iscrizione della nave surichiesta dell’Asl competente, dell’armatore o di un suo rappresen-tante nonché, al fine di verificare il mantenimento della conformi-tà dell’ambiente di lavoro e ogni qualvolta se ne verifichi la neces-sità, una visita occasionale che può essere richiesta direttamentedai lavoratori mediante il rappresentante alla sicurezza dell’am-biente di lavoro. Le visite sono eseguite dalla Commissione territo-riale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavo-ro e i risultati sono annotati in apposito documento conforme almodello approvato dal ministero, una cui copia è conservata tra idocumenti di bordo, a disposizione degli organi di vigilanza.Viene anche precisato che dopo l’effettuazione delle visite nessuncambiamento può essere apportato se non con le procedure di cuiall’articolo 33 e il comandante ha l’obbligo di sostituire immedia-tamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterio-ramenti o deficienze tali da compromettere l’igiene e la sicurezzadell’ambiente di lavoro.L’articolo 23 elenca gli obblighi del medico competente specifican-do che, qualora egli a seguito degli accertamenti sanitari esprimaun giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavo-ratore imputabile all’esposizione a situazioni di rischio, ne informaper iscritto l’armatore e il lavoratore. Avverso il giudizio è ammes-so ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giu-dizio medesimo all’Ufficio di sanità marittima del ministero dellaSalute territorialmente competente. L’articolo 24 specifica, fra al-tre cose, che l’armatore provvede alla fornitura e al mantenimentoa bordo delle dotazioni mediche, medicinali e attrezzature sanita-rie adeguate al tipo di navigazione, alla durata della linea, nonchéal numero dei lavoratori marittimi imbarcati previsto dalla vigentenormativa. Il comandante dell’unità provvede a che il materiale sa-nitario messo a disposizione dall’armatore sia sempre disponibileed è responsabile della custodia e della gestione delle sostanzestupefacenti facenti parte di tali dotazioni. Ferma restando tale re-
53
IGIENE E SICUREZZA DEI LAVORATORI MARITTIMI
sponsabilità, il comandante della nave può delegare la custodiadel suddetto materiale sanitario a personale dell’equipaggio, com-ponente del servizio di prevenzione e protezione.In caso d’infortunio, indipendentemente dalla durata del periodod’inattività del lavoratore marittimo, l’armatore sulla base di quan-to designato dal Servizio di prevenzione e protezione segnala l’in-fortunio all’Autorità marittima e all’istituto assicuratore ai sensi diquanto previsto dalla normativa vigente, nonché all’Azienda Unitàsanitaria locale del compartimento di iscrizione della nave. Gli ele-menti significativi relativi all’infortunio a bordo sono annotati suun apposito “registro degli infortuni” conforme al modello appro-vato dal ministero. Il registro è tenuto a bordo della nave a dispo-sizione degli organi di vigilanza.L’articolo 27 elenca una serie di temi e di tempi con i quali l’arma-tore e il comandante devono provvedere affinché ciascun lavora-
54
tore marittimo imbarcato riceva un’adeguata informazione e for-mazione. Quest’ultima deve essere ripetuta periodicamente in re-lazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi ri-schi. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasportisaranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni relative al-la formazione del personale marittimo.Le attività di vigilanza sull’applicazione della normativa in materiadi tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi sonodi competenza dell’Autorità marittima, delle Asl e degli uffici disanità marittima, mentre le attività di consulenza non possono es-sere prestate da soggetti che svolgono attività di controllo e di vi-gilanza. Vengono quindi stabilite le sanzioni relative agli obblighidell’armatore e del comandante, dei lavoratori, del medico com-petente, del titolare dell’impresa appaltatrice e dell’armatore e fra
55
l’altro si definisce che qualora l’Autorità marittima riscontri che abordo dell’unità mercantile o da pesca nazionale vi siano difformi-tà rispetto al piano di sicurezza approvato e al relativo “Certificatodi sicurezza dell’ambiente di lavoro” che comportano rischi per l’i-giene e la sicurezza del lavoratore marittimo, essa provvede, aisensi dell’articolo 181 del codice della navigazione, non conce-dendo il rilascio delle spedizioni. Alla vigilanza ai fini penali e alleprescrizioni provvedono l’Autorità marittima, le Asl, gli uffici di sa-nità marittima in coordinamento tra loro.Dopo questa rapida sintesi del decreto si ricorda che esso nasceanche a fronte del crescere, in ogni attività produttiva, degli infor-tuni sul lavoro e dell’aumentata consapevolezza del rischio cuiquotidianamente va incontro il personale marittimo. Tra i lavori“pericolosi“, infatti, “l’andare per mare” presenta certamente li-velli di disagio e rischi così elevati e non facilmente prevedibili talida renderlo una delle professioni più insicure. Le dure condizionidi lavoro dei marittimi sono state storicamente caratterizzate dallaprecarietà dell’ambiente di vita a bordo delle unità, spesso non sa-lutare o poco adatto, dalla insicurezza dei mezzi rispetto alle con-dizioni meteorologiche o marine, dalla particolarità dei locali di vi-ta e di lavoro, spesso vicini a celle frigorifere nel caso della pesca oapparati motore e ancora, la coabitazione con altre lavorazioni edalle insidie proprie della navigazione come gli incendi, i naufragi,le collisioni e quant’altro.
Uno dei punti di innovazione del decreto che ha riformato l’appa-rato legislativo è proprio quello della formazione, sancita addirit-tura nel primo, che stabilisce tra l’altro l’obbligo di assicurare l’in-formazione e la formazione degli equipaggi. Tale formazione, fon-damentale in ogni luogo di lavoro, diventa ancora più importantein luoghi lontani dalle strutture sanitarie di terra, dove ogni mem-bro dell’equipaggio deve sapere che, in tantissime circostanze, lasalute e la vita del personale di bordo può dipendere dal pronto eadeguato intervento del singolo. Parlando di salute e sicurezza dei lavoratori e, nello specifico, salu-te e sicurezza dei lavoratori di marittimi a bordo delle navi mercan-tili e da pesca nazionali, non si può non ricordare il problema del
IGIENE E SICUREZZA DEI LAVORATORI MARITTIMI
rischio amianto. Si rammenta, in proposito, che l’allegato 1 del de-creto 20 agosto 1999 (Ampliamento delle normative e delle meto-dologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelliper rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, letteraf), della legge 27 marzo 1992, n. 257 (recante norme relative allacessazione dell’impiego dell’amianto) contiene le procedure daadottare negli eventuali interventi di bonifica da adottare su navi egalleggianti coibentati con amianto; le misure di sicurezza da adot-tare nel caso di eventuali interventi su materiali contenenti amiantocollegati o collegabili a qualsiasi intervento di riparazione e/o tra-sformazione navale effettuato in rada, in banchina o presso cantie-ri navali. Il decreto si applica in caso di interventi su materiali con-tenenti amianto a bordo di navi con bandiera italiana, nonché aquelle con bandiera estera che eseguono i suddetti interventi pres-so porti italiani o in cantieri navali in territorio italiano. Si ricorda altresì che l’approccio dell’attuale normativa sulla salutee la sicurezza dei lavoratori marittimi in genere, e nello specifico ildlgs 271/1999, è sì innovativa ma non facilmente attuabile anchee soprattutto in considerazione della debole cultura relativa allasalute e sicurezza presente in questo mondo “a parte”, fatto daimprenditori e lavoratori che spesso assumono atteggiamenti dieccessiva confidenza rispetto ai pericoli legati alle procedure lavo-rative. Il problema è però considerevole. Nella tabella di seguito sonoelencati i casi di infortunio avvenuti nei diversi settori dei trasportifra il 2000 e il 2003.
Nello specifico fonti Ispesl mostrano che gli infortuni, anche gravi,
56
57
si verificano spesso in condizioni di mare calmo e sono probabil-mente legati alla fatica, all’abbassamento della soglia di attenzio-ne e/o alla scarsa manutenzione delle attrezzature di lavoro. Anche l’analisi delle malattie professionali e gli stadi di sviluppoattraverso i quali queste possono manifestarsi, ci impongono dinon abbassare l’attenzione su questi temi e su questo “mondo”:tali dati ci confermano che solo un’ampia collaborazione fra diver-si organi (Asl Portuali, Dipartimenti di prevenzione, Capitanerie diporto, Sanità marittima, Istituti di ricerca, rappresentanti delle par-ti sociali) e livelli sempre più alti di integrazione e collaborazioneinteristituzionale potranno portare a una operatività effettiva dellanormativa specifica e, conseguentemente, a una riduzione deglieventi infortunistici, degli incidenti e delle malattie professionali.
IGIENE E SICUREZZA DEI LAVORATORI MARITTIMI
59
SI PESCA SEMPRE DI PIÙMA SERVONO REGOLE
Alessandro Arcai
La pesca nel bacino del Mediterraneo rappresenta un’attivitàcommerciale che ha raggiunto una rilevanza internazionale destinataa crescere ancora. Da qui la necessità di definire in ambito comunitariouna gestione adeguata delle risorse ittiche e il rispetto dell’eco-sistema
Nel Bacino del Mediterraneo produzione, consumi e scambi interna-zionali di prodotti ittici sono andati via via aumentando nell’arco degliultimi 25 anni. Questa la sintesi principale che emerge dal recenteRapporto Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare,“Verso un sistema di regole comuni per la pesca nel bacino del Medi-terraneo”. Rapporto che ha l’obiettivo di delineare un quadro dell’an-damento del settore e dare una linea di previsione dei consumi, finoal 2030, sulla base delle ultime statistiche elaborate dalla Fao, spie-gando le motivazioni all’origine dell’evoluzione dei consumi, dellecatture e dell’import ed export dei prodotti ittici. L’indagine giunge adue anni dalla pubblicazione dello studio “Dalla conflittualità al par-tenariato: il ruolo della pesca nel Bacino del Mediterraneo”, anch’es-so promosso dal ministero delle Politiche agricole e forestali, e rappre-senta in sostanza una fotografia della pesca nel bacino del Mediterra-neo, con particolare attenzione alla dimensione economica e sociale,affrontando inoltre il tema della gestione delle risorse ittiche. Il nuovorapporto mette in luce anche l’aspetto ambientale nell’area mediter-ranea, dove cresce l’esigenza di tutelare gli ecosistemi marini e di ga-rantire la sicurezza e la qualità dei prodotti.Fra i dati più salienti, il raddoppio dei consumi di pesce: la produzio-ne ittica ha raggiunto i 2,2 milioni di tonnellate pari a un consumo
NAUTES
pro capite di 16,2 kg all’anno. Mantenendo questo trend, entro il2030 si prevede un’ulteriore crescita dei consumi. In espansione an-che il commercio internazionale di prodotti ittici. Nel Mediterraneole importazioni sono pari a 13,6 miliardi di dollari, il 20% circa deltotale mondiale, mentre l’export ha registrato un giro d’affari di 5,9miliardi, passando a livello mondiale dal 6,6% al 9,2%. Aumentaanche la produzione ma, mentre cresce l’acquacoltura, sono in fles-sione le catture. Sul fronte delle importazioni, però, l’incrementopiù consistente ha determinato un peggioramento del deficit dellabilancia commerciale. Quanto alle tipologie merceologiche più ri-chieste, il pesce fresco, refrigerato e congelato è la commodity chemaggiormente incide sul livello degli scambi comunitari. Nel 2003 leesportazioni complessive di questi prodotti hanno rappresentato il
60
61
43% del totale dell’area pari, in termini di valore, al 39,8% degliesborsi monetari. Al secondo posto si sono collocati molluschi e cro-stacei che, con un livello di esportazione di 1.721 milioni di dollari eimportazioni pari a 4.813, rappresentano rispettivamente il 29,5%e il 35,5% dei totali.«Questo rapporto – ha sottolineato il presidente Ismea, Arturo Seme-rari – s’inserisce nell’attività ormai decennale del nostro Istituto nelsettore della Pesca e dell’Acquacoltura e si propone come un ulteriorestrumento per ampliare la base conoscitiva su cui articolare il confron-to tra i Paesi mediterranei che considerano la pesca un tema rilevanteper le politiche alimentari e ambientali del prossimo futuro». L’obietti-vo, dunque, è quello di fornire ulteriori contributi al dibattito sulla ne-cessità di adottare un sistema di regole comuni e condivise, attraversoil coinvolgimento attivo degli oltre venti Paesi che operano nel Medi-terraneo – di cui solo sette attualmente membri dell’Unione Europea– nell’ottica di cooperazione e nel quadro della Commissione genera-le per la pesca nel Mediterraneo (Cgpm). Questo perché l’attività del-la pesca nel bacino del Mediterraneo mostra un elevato grado dicomplessità, dove entrano in gioco più dimensioni considerato il nu-mero di Paesi che vi operano che, pur essendo tra loro eterogenei siaculturalmente che economicamente, sono fortemente omogenei siasul piano produttivo che sociale. Ciò evidenzia la necessità di adottareun sistema di regole comuni e condivise, valide per tutti i Paesi del ba-cino mediterraneo, anche alla luce della Conferenza ministeriale diVenezia del 2003.Secondo l’indagine Ismea, le catture in mare e in acque interne rag-giungono un quantitativo di 1,3 milioni di tonnellate, mentre il datodella sola acquacoltura indica una produzione complessiva di 880 mi-la tonnellate. Sono i Puem (Paesi mediterranei appartenenti alla Ue),con 5,6 milioni di tonnellate, ad assorbire la fetta maggiore dei con-sumi totali dell’area del Mediterraneo. Sulla base delle ultime proie-zioni, ipotizzando un trend di crescita dei consumi a un’intensità ana-loga a quella rilevata nel ventennio 1976-1999, entro il 2030 si rag-giungerà un incremento complessivo di circa 2 milioni di tonnellate,con un aumento nei Puem del 13,5% e nei Ptm (Paesi MediterraneiTerzi) del 68%. A livello mondiale questo si tradurrà in una crescitadel 156%, in valore assoluto pari a circa 150 milioni di tonnellate dipesce. In forte espansione, negli ultimi decenni, anche il commercio
SI PESCA SEMPRE DI PIÙ MA SERVONO REGOLE
internazionale di prodotti ittici, con un valore delle esportazioni stima-to attualmente attorno ai 65,5 miliardi di dollari. Nel bacino del Mediterraneo, in particolare, nell’arco dell’ultimo ven-tennio, gli scambi di prodotti ittici hanno registrato una forte crescita,raggiungendo i 13,6 miliardi di dollari per le importazioni (il 20% cir-ca del totale mondiale) e i 5,9 miliardi di dollari per le esportazioni (il9,2% del totale mondiale). Prendendo in esame i dati sulle catture, nel 2003, tra le aree di pescapiù battute nel Mediterraneo, ci sono le Baleari dove avviene il 27%delle catture e operano le flotte di Spagna, Marocco e Algeria. Seguel’Adriatico, con il 15,6% del pescato, e lo Ionio che incide per il 15%.Da segnalare anche l’area della Sardegna (12,3%) e quella dell’Egeocon l’11,3% delle catture. In tema di quantità pescate, infine, al pri-mo posto c’è l’Italia con un’incidenza del 29% sul totale delle catturenel Mediterraneo, seguita da Algeria (15,1%), Spagna (9,8%), Tunisia(9,5%) e Grecia (9,1%).
I consumiIl consumo di pesce nell’area mediterranea è più che raddoppiato ne-gli ultimi 25 anni, raggiungendo gli 8 milioni di tonnellate nel 2002,con un’incidenza sul totale mondiale pari al 7,3%. Un dato quest’ulti-mo che interessa sia i Puem (Paesi mediterranei appartenenti alla Ue)che i Ptm (Paesi mediterranei Terzi). Ma se si considerano singolar-mente i due raggruppamenti, all’interno del Bacino, sono i Puem con5,6 milioni di tonnellate ad assorbire la fetta maggiore dei consumitotali dell’area, con ben il 70%, mantenendo comunque, negli ultimidecenni, un trend positivo in entrambi i casi. Spagna, Francia, Italia, Egitto e Turchia sono i Paesi che assorbono imaggiori quantitativi di pesce. Il consumo pro capite di pesce per iPaesi dell’area mediterranea si attesta sui 16,2 kg/annui, in linea conil dato mondiale (16,3 kg/annui). Forti consumatori si confermano iPaesi mediterranei appartenenti all’Unione europea. Al primo postol’isola di Malta con 50,2 kg di prodotto pro capite e la Spagna (con47,5 kg) seguite da Francia e Cipro che ne mangiano ogni anno ri-spettivamente 31,3 kg e 28,5 kg a testa. Per tutti gli altri Paesi delgruppo Puem, il livello dei consumi annui di prodotti ittici si spinge ol-tre i 20 kg, superando ampiamente il valore medio mediterraneo emondiale. Il consumo di pesce nei Paesi mediterranei extra Ue, inve-
62
63
ce, è molto basso. I Ptm mangiano quantità (8,3 kg nel 2002) pari al-la metà di quelle medie mondiali.
Le previsioni a medio e lungo termine tra il 2005 eil 2030Le proiezioni Fao indicano, tra il 2005 e il 2030, nell’ipotesi di stabilitàdei consumi (determinante quindi solo la crescita demografica), unaumento del 15% nell’area mediterranea rispetto al livello rilevato nel1999, equivalente a una espansione pari a poco più di un milione ditonnellate, con crescita nulla nei Puem e del 53% nei Ptm. Nell’ipotesi, invece, di crescita dei consumi a un’intensità analoga aquella rilevata nel ventennio 1976-1999 – lo scenario ritenuto piùprobabile – entro il 2030 i consumi aumenteranno nei Puem del13,5% e nei Ptm del 68%, con un incremento complessivo di circa 2milioni di tonnellate. Mantenendo questi ritmi, i consumi mondialiaumenteranno del 156%, in valore assoluto un incremento pari a cir-ca 150 milioni di tonnellate.
SI PESCA SEMPRE DI PIÙ MA SERVONO REGOLE
La produzioneIn generale, anche la produzione ha registrato una crescita negli ulti-mi anni, con 2,2 milioni di tonnellate di pesce pari all’1,7% della pro-duzione mondiale. Nei Paesi del Mediterraneo si è stimato un quanti-tativo di 880 mila tonnellate per l’attività di acquacoltura, mentre perla pesca in mare e in acque interne si sono raggiunti 1,3 milioni ditonnellate. E’ l’acquacoltura a risultare, negli ultimi anni, l’attività pro-duttiva in ambito alimentare più in crescita a livello mondiale. Nel Me-diterraneo l’incremento ha riguardato sia le acque interne che il mare,risultando particolarmente intensa nei Paesi Terzi Mediterranei, tra iquali spiccano Marocco, Turchia e Cipro. A determinare questo svilup-po, sono state le innovazioni tecnologiche e la diversificazione deiprodotti allevati.Prendendo in esame, invece, esclusivamente l’attività di pesca in ma-re, le catture – dopo una costante crescita dal 1970 al 1994 – hannoregistrato una progressiva flessione dal 1995, fino a scendere nel2003 (ultimo dato elaborato dalla Fao) a un livello inferiore alle 940
64
65
mila tonnellate. In dettaglio, la riduzione delle catture ha interessatosoprattutto i Paesi Ue Mediterranei. Tra i Paesi Terzi Mediterranei si èinvece registrato un rallentamento della crescita dei quantitativi pe-scati solo dopo la prima metà degli anni ‘90, in forte aumento fino aquel momento.
Scambi commercialiIn forte espansione, negli ultimi decenni, anche il commercio interna-zionale di prodotti ittici, con un valore delle esportazioni mondiali, sti-mato per il 2003, attorno ai 63,5 miliardi di dollari. Nel bacino del Mediterraneo, in particolare, nell’arco dell’ultimo ven-tennio, gli scambi di prodotti ittici hanno registrato una forte crescita,raggiungendo i 13,6 miliardi di dollari per le importazioni e i 5,9 mi-liardi di dollari per le esportazioni.Sul fronte delle importazioni, però, l’incremento più consistente hadeterminato un peggioramento del deficit commerciale: si è accen-tuata, pertanto, per quanto riguarda l’approvvigionamento dei pro-dotti ittici, la dipendenza dall’estero dei Paesi mediterranei, fra cuiproprio i Puem sono tra i maggiori importatori, rappresentando il95% dell’intero import di prodotti ittici dell’area. Sono Spagna, Fran-cia e Italia a spiccare, tra i più forti importatori. Per quanto riguardainvece l’export, tra i Paesi mediterranei al primo posto c’è la Spagna(con quasi il 40% del totale dell’intera area mediterranea) seguita dal-la Francia (23%) e dal Marocco (17%).
Aspetti sociali del settoreAnche se l’incidenza delle catture nel Mediterraneo è di poco superio-re all’1% del totale mondiale, la pesca in quest’area assume rilevanzaper l’impatto sociale e occupazionale. Si tratta, in effetti, di un’attivitàdi tipo artigianale, a forte intensità di manodopera, profondamentediversa da quella praticata in altre aree, come quelle nord europee ca-ratterizzate da una produttività media molto più elevata. La dimensio-ne delle imbarcazioni dei Paesi Ue Mediterranei è pari a 10 tonnellate,mentre nel resto d’Europa raggiunge in media le 31 tonnellate distazza: in termini di produttività, le catture unitarie per singola imbar-cazione nei Puem non superano le 20 tonnellate per anno, rispettoalle 120 di un battello operante in acque europee extramediterranee.Maggiore è, invece, il valore unitario della produzione (5,88 euro per
SI PESCA SEMPRE DI PIÙ MA SERVONO REGOLE
tonnellata di stazza lorda nei Puem a fronte dei 3,81 euro nei PaesiUe extramediterranei).La pesca costituisce, inoltre, un’importante fonte di reddito in moltiPaesi: l’incidenza del valore aggiunto del comparto su quello agricoloè mediamente pari al 6,3%, con una punta massima del 27,9% inMarocco; elevata anche l’incidenza in Egitto (7,5%), in Tunisia(5,5%), in Turchia e in Algeria (3,4%). Nei Puem il peso assunto dalsettore pesca su quello agricolo oscilla tra l’1% della Slovenia e il12,5% della Spagna. Rispetto alla popolazione attiva in agricoltura, per l’intero bacino delMediterraneo gli occupati nella pesca sono pari allo 0,6%. L’incidenza èbassa nei Ptm, più elevata della media negli altri Paesi mediterranei. Tra isingoli Paesi terzi è da segnalare il Libano con il 6,3% degli occupati delsettore ittico sul settore agricolo; seguono Tunisia (il 2,3%), Israele(2,3%), Marocco e Croazia con una percentuale pari a circa l’1%. NeiPuem emerge – oltre all’incidenza superiore al 70% nell’isola di Malta –quella di Grecia e Spagna, con all’incirca il 3% degli occupati del settoreprimario impegnati nella pesca, seguiti da Francia (1,4%) e Italia (0,8%).
66
67
ORMEGGIO, DUNQUE SONO,MA SE MI RUBANO LA BARCA?
Alessio Claroni*
Non sempre lo sviluppo del turismo nautico è stato accompagnatoda un adeguato sostegno legislativo e ancora non si è data pienasoluzione alla tutela degli utenti dei porti turistici
La tutela dell’utente nell’ambito di un porto turistico rappresentaoggi un tema di notevole importanza, soprattutto se si considera ilperiodo storico in cui esso si inserisce. Come è noto il turismo, an-che nautico, in questi ultimi anni ha vissuto momenti evolutiviestremamente importanti, che ne hanno condizionato in manierasignificativa i contenuti. Basti accennare alla recente Legge 29marzo 2001, n. 135, concernente la “Riforma della legislazionenazionale del turismo”, seguita, a distanza di sette mesi, dall’ema-nazione della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, nelmodificare il titolo V della Costituzione, ha trasferito la competen-za legislativa esclusiva in materia di turismo alle Regioni.Con specifico riferimento poi al turismo nautico, nel 2003 si è as-sistito alla emanazione di una Legge che ha apportato consistentimodifiche alla prima Legge 11 febbraio 1971, n. 50. La Legge 8luglio 2003, n. 172, infatti, nell’introdurre “Disposizioni per il rior-dino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”,ha fornito importanti linee guida cui attenersi in un’ottica di po-tenziamento del settore in questione. In tale contesto l’impegnoassunto dal governo, in applicazione dell’art. 6 della legge in pa-rola, di provvedere alla elaborazione di “un decreto legislativo re-
NAUTES
* Docente di Legislazione del turismo e Diritto europeo dei trasporti, facoltà diGiurisprudenza, Università di Bologna
cante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da dipor-to” si è concretizzato nel recentissimo Decreto Legislativo 18 lu-glio 2005, n.171, che ha introdotto in Italia il Codice della Nauticada diporto.
I porti turisticiLa portualità turistica nasce e si sviluppa come conseguenza del-la nascita e dello sviluppo di un fenomeno legato al turismo erappresentato, specificamente, dalla nautica da diporto. Deve ri-levarsi come, sebbene numerosi siano stati gli interventi legislati-vi che hanno interessato il settore del turismo nautico in questiultimi anni, lo specifico tema della portualità turistica non è sta-to contemplato né nella Legge n. 172/2003 né nel D. Lgs.n. 171/2005.La carenza legislativa che ha coinvolto, e che tuttora coinvolge, laportualità turistica ha rappresentato, soprattutto in passato, un
68
69
problema di notevole gravità. La problematica principalmente av-vertita nel settore è stata quella della difficoltà di approntare nuo-ve strutture ricettive, ovvero ampliare quelle già esistenti, in modotale da rispondere adeguatamente alla crescente domanda di postibarca espressa dai diportisti nautici. È dato rilevare infatti come, a fronte di una incapacità generaledello Stato di fornire sufficienti risorse finanziarie utili per la realiz-zazione di nuove infrastrutture destinate alla navigazione da di-porto, sino al 1997 in Italia sia mancato un provvedimento legisla-tivo capace di consentire un intervento in tal senso anche da partedi soggetti privati. Detto stato di forzato immobilismo è stato par-zialmente superato solo a seguito della emanazione del D.P.R. 2dicembre 1997, n. 509 che, oltre a fornire una definizione ufficia-le di “porto turistico” (fino ad allora mancante, anche nell’ambitodella Legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riforma dei porti italiani),ha attribuito ai privati la possibilità di ottenere una concessionedemaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicatealla nautica da diporto. In realtà, non può sottacersi come l’idoneità della concessione dicui al D.P.R. n. 509/1997 a consentire esclusivamente la costruzio-ne di un porto turistico (e non anche la sua gestione) potrebbe,paradossalmente, rappresentare un ostacolo allo svolgimento del-l’iniziativa economica privata nel settore.
Alcuni aspetti del contratto di ormeggioL’incremento del fenomeno della nautica da diporto ha comporta-to la necessità di addivenire a una adeguata regolamentazione de-gli obblighi cui soggiacciono il concessionario-gestore di un portoturistico e l’utente del porto medesimo, quali parti di una fattispe-cie contrattuale comunemente conosciuta come “contratto di or-meggio”. In tale contesto, è dato preliminarmente rilevare come ilcontratto di ormeggio si manifesti sotto forma di fattispecie con-trattuale attraverso cui una parte, rappresentata dal concessiona-rio-gestore di un porto turistico assume l’obbligo di mettere a dis-posizione dell’altra, verso un corrispettivo e per un determinatoperiodo (anche alcuni decenni) una porzione di specchio acqueoper ivi permettere lo stazionamento di una specifica unità da di-porto (c.d. “posto-barca”), nonché di fornire quei servizi accessori
ORMEGGIO, DUNQUE SONO MA SE MI RUBANO LA BARCA?
previsti espressamente ex contractu, ovvero individuati dal regola-mento interno che disciplina il porto turistico medesimo.Il contratto di ormeggio, in mancanza di una disciplina legislativaa esso specificamente riferita, rappresenta una fattispecie contrat-tuale atipica. Tutto ciò premesso, senza alcuna pretesa di esausti-vità in questa sede relativamente al contenuto del contratto dequo, appare fuor di dubbio come il tema della tutela dell’utente(consumatore) in ambito portuale assuma connotati significativa-mente differenti a seconda della natura giuridica che si riconosceal contratto in parola.In effetti, a partire dagli anni Settanta, la dottrina e la giurispru-denza, nell’ottica di determinare gli obblighi incombenti sulle partidel contratto di ormeggio, hanno tentato di individuare la discipli-na di una qualche fattispecie contrattuale tipica cui ricondurre ilcontratto in esame, privilegiando le ipotesi del contratto di depo-sito e del contratto di locazione.La difficile tutela dell’utenteLa prima pronuncia giurisprudenziale ad avere inquadrato il con-tratto di ormeggio nello schema del deposito è stata la sentenzaresa dalla Corte di Appello di Venezia in data 22 novembre1977. Più recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza 21ottobre 1994, n. 8657, ha ritenuto che il contratto di ormeggionon possa “essere assunto ipso iure nella categoria del contrattodi deposito, potendo avere ad oggetto la semplice messa a dis-posizione ed utilizzazione delle strutture portuali, ovvero esten-dersi alla custodia dell’imbarcazione: nel primo caso lo stesso èassimilabile, infatti, alla locazione e solo nel secondo al deposi-to, da cui discende l’obbligo di custodire il natante e di restituir-lo nello stato in cui è consegnato”. Le due sentenze citate offro-no l’opportunità di compiere alcune riflessioni in merito alla que-stione in esame. L’orientamento favorevole a ricondurre il con-tratto di ormeggio nell’alveo del contratto di deposito consentedi affermare che, in tal caso, all’obbligazione principale del ge-store del porto turistico di fornire uno specchio acqueo idoneoall’ormeggio dell’unità da diporto, si associ quella di provvederealla custodia dell’unità medesima. Più specificamente, in applica-zione delle disposizioni previste dagli artt. 1766 ss. c.c., graveràsul gestore del porto l’obbligo di custodire l’unità da diporto del-
70
71
l’utente del posto barca usando la diligenza del buon padre difamiglia.Il depositario (in questo caso, il gestore del porto turistico) potràessere esonerato dalla responsabilità derivante da perdita della co-sa depositata solo dimostrando di avere custodito la res (l’unità dadiporto) con la diligenza del buon padre di famiglia e che, ai sensidell’art. 1780 c.c., l’inadempimento sia derivato da causa a luinon imputabile.Ciò premesso, particolare attenzione deve essere dedicata all’ipo-tesi in cui la perdita della detenzione dell’unità da diporto ormeg-giata sia dipesa da furto perpetrato ai danni della stessa. È da rite-nersi che, non potendo il furto integrare una ipotesi di evento im-prevedibile e inevitabile, esso non possa conseguentemente essereassimilato a una ipotesi di caso fortuito. In tal modo, sembrerebbedoversi constatare come il gestore di un porto turistico non possaritenersi esonerato per la perdita dell’unità da diporto ormeggiata
ORMEGGIO, DUNQUE SONO MA SE MI RUBANO LA BARCA?
qualora detta perdita sia dipesa dal furto dell’unità da diporto me-desima. Questo principio è stato confermato dal Tribunale di Tranicon sentenza resa il 7 giugno 2002. Dalle considerazioni che precedono, secondo cui il depositario –gestore del porto turistico – è responsabile per il furto dell’unitàda diporto, parrebbe doversi desumere come detta responsabilitàdebba essere estesa anche alle pertinenze dell’unità stessa (si pen-si, a titolo esemplificativo, al furto delle strumentazioni di bordo).
72
73
Per contro, l’obbligo di custodia, se non diversamente previsto dacontratto, dovrebbe essere escluso con riferimento a quei beni chesi trovino a bordo solo occasionalmente.A conseguenze differenti si perviene nella ipotesi in cui si decidadi propendere per la tesi idonea a inquadrare il contratto di or-meggio nello schema della locazione. In tal caso, infatti, par fuordi dubbio come il gestore del porto turistico soggiaccia esclusiva-mente al regime di responsabilità previsto dagli artt. 1571 ss. c.c.Per questo motivo, dovendosi escludere a carico del gestore unobbligo di custodia sull’unità da diporto, non si potrà conseguen-temente prevederne una responsabilità contrattuale per il furtodell’unità medesima.Indipendentemente dalla natura giuridica del contratto di ormeg-gio, è dato poi rilevare come, in applicazione dell’art. 1229 c.c.,siano da ritenersi nulle quelle clausole contrattuali dirette a esclu-dere o a limitare la responsabilità del gestore del porto turisticoper dolo o per colpa grave.Può essere, in conclusione, interessante notare come l’orienta-mento giurisprudenziale più recente sia teso a escludere che ilcontratto di ormeggio possa essere ricondotto allo schema di ununico contratto tipizzato. Secondo infatti la Corte di Appello diTrieste (28 luglio 1999), il contratto di ormeggio “ha ormai assun-to una sua giuridica individualità, che porta a far convivere nellasua disciplina norme confluenti da tipi legali differenti”. Più speci-ficamente, la suddetta tesi parrebbe propendere per l’individua-zione del contratto di ormeggio quale contratto atipico a causamista, in cui confluiscono le cause di differenti contratti tra cui ildeposito, la locazione e la somministrazione. Detto orientamento,che ad avviso di chi scrive appare senza dubbio condivisibile, sipone in una linea di continuità con una politica legislativa che hacercato, in questi ultimi anni, di tutelare maggiormente la figuradel consumatore nell’ambito dei processi di natura contrattuale incui può essere coinvolto. La tesi da ultimo citata, nel configurare l’ormeggio quale contrattoatipico a causa mista potenzialmente idoneo (essendo riconducibileanche alla locazione) a riconoscere all’utente del posto barca un di-ritto personale di godimento sul porto turistico, parrebbe inoltrecontemplare, a favore dell’utente del porto medesimo, l’applicazio-
ORMEGGIO, DUNQUE SONO MA SE MI RUBANO LA BARCA?
ne della normativa contenuta nel Tit. IV del recente “Codice delconsumo” emanato con dlgs. 6 settembre 2005, n. 206.In particolare, le previsioni normative accolte dal succitato Codiceintrodurrebbero nella disciplina del contratto di ormeggio principiestremamente garantisti per l’utente del posto barca, soprattuttocon riferimento ai requisiti del contratto in esame (che, in tal mo-do, dovrebbe essere concluso obbligatoriamente per iscritto), non-ché al diritto di recesso (protratto a dieci giorni lavorativi) a favoredell’utente medesimo.
74
75
LA FUNZIONE PARADIGMATICA E PIONIERISTICA DEL DIRITTO MARITTIMO
Domenico Riccio
La genesi del diritto marittimo“Navigare necesse est, vivere non est nocesse”. Il motto di Pom-peo Magno, impegnato nella lotta contro i pirati nel Mediterraneoe nel per liberare le vie di approvvigionamento del grano per Ro-ma (divenuto poi anche il motto delle città della Lega Anseatica),testimonia la consapevolezza antica dell’importanza del mare perle sorti d’Italia. Dalle Repubbliche marinare di Amalfi, Pisa, Geno-va e Venezia alle imprese di Colombo, tale presa di coscienza si èandata corroborando, diventando il fattore determinante per lanascita di fortune enormi. Invero il rapporto tra l’uomo e il mare è antico e arcano e semprefecondo. Allo stesso modo e conseguentemente il diritto maritti-mo ha avuto modo di nascere e svilupparsi già molto tempo ad-dietro e accompagnare i giuristi nelle fasi di evoluzione dellascienza giuridica.Il più antico testo legislativo in materia marittima è costituito dalleleggi di Hammurabi, re di Babilonia (2285-2242 a.C.), ma ci sonoanche tracce di leggi fenicie e di leggi greche e questo sebbene lanavigazione sia stata in ogni epoca dell’antichità regolata quasiesclusivamente dalle consuetudini. Il testo più importante del dirit-to ellenico è la Lex Rhodia (475-479 a.C.), poi incorporata dai giu-risti romani nel titolo 14.2. del Digesto nel quale sono disciplinatinumerosi istituti di diritto marittimo, anche se manca una tratta-zione organica della materia. Ma già nel libro 53 dei Basilici (IX-Xsec. d.C.) appare un saggio di codificazione del diritto marittimogreco-romano.Di poco anteriore (VIII sec. d.C.) è la prima redazione del NomosRhodion Nautikos, raccolta privata di consuetudini, che fu applica-
NAUTES
ta per vari secoli nell’Italia meridionale e in tutto l’Adriatico e checostituisce una delle più cospicue fonti del diritto marittimo me-dioevale. Quest’ultimo si riannoda, da un lato, al diritto romano,dal quale ereditò gli istituti fondamentali, plasmandoli secondo lenuove condizioni dell’economia e gli accresciuti rapporti commer-ciali; dall’altro, al diritto consuetudinario volgare, cui non fu estra-nea la corrente ellenico-orientale.In Italia assistiamo a una fioritura di statuti marittimi delle più im-portanti città dei mari Adriatico e Tirreno. Gli statuti raccoglieva-no, in gran parte, consuetudini già fissate dalle magistrature mer-cantili.In Adriatico assumono grande importanza gli statuti Veneti, cui siispirarono gli ordinamenti marittimi della Dalmazia, che esercitaro-no notevole influenza sulla legislazione dei paesi dell’Europa delnord, fra cui si segnalano i Recessi dell’Hansa (Amburgo, Brema eLubecca, sec. XIV-XV). Destinato a integrare i Róles d’Oléron è il
76
77
Guidon de la mer, composto a Rouen presumibilmente alla finedel secolo XVI e prevalentemente dedicato all’assicurazione.Il primo testo di leggi marittime, di carattere pubblico e privato,che costituisce l’inizio della moderna codificazione del diritto ma-rittimo, è l’Ordonnance de Louis XIV, donnée au mais d’aout1681, touchant la marine. Questa ordinanza ebbe un’influenzadecisiva su tutto lo svolgimento delle legislazioni successive, af-frettando la formazione di leggi nazionali in sostituzione degli usiinternazionali (Ordinanze di Bilbao del 1737; leggi prussiane del1727 e del 1766; Ordinanza svedese del 1750) ed è stata ripro-dotta, spesso testualmente, nel codice francese di commercio del1807, formandone il libro II.A questa seguono in Italia: l’Editto di marina e navigazione marit-tima Toscana, emanato dal granduca Francesco di Lorena il 10 ot-tobre 1748; il Reale editto, o sia regolamento per la navigazionede’ bastimenti mercantili de’ 18 agosto 1741 di Carlo III di Napoli,seguito dal Reale editto del 1759; l’Editto di navigazione mercan-tile austriaca, emanato da Maria Teresa d’Austria nel 1774; il Co-dice per la veneta mercantile marina, compilato dal Magistrato deicinque savi alla mercanzia e approvato dal Senato il 21 settembre1786, che è considerato il principale complesso normativo di dirit-to marittimo italiano del secolo XVIII.La conquista napoleonica impose al Regno Italico il codice di com-mercio francese in base al decreto dato a Bajona il 17 luglio 1808.Nello stesso anno il codice fu introdotto nel Granducato di Tosca-na e nel Regno di Napoli. Successivamente alla restaurazione le vi-cende della codificazione marittima in Italia furono diverse. Mapuò affermarsi che l’influsso del codice di commercio francese fudecisivo. Unificato il Regno d’Italia, con r.d. 25 giugno 1865 n.2364 fu approvato e pubblicato il codice di commercio, che dedi-cava al commercio marittimo il secondo libro. Al tempo stesso,con altro r.d. 25 giugno 1865 n. 2360, fu approvato il testo delcodice per la marina mercantile, comprendente le norme di dirittoamministrativo, internazionale, penale e processuale riguardanti lanavigazione marittima.Con la 1. 24 maggio 1877 n. 3919, il codi-ce per la marina mercantile venne modificato e poi ripubblicato intesto unico con r.d. 24 ottobre 1877 n. 4146. Con r.d. 20 novem-bre 1879 n. 5166 ne fu approvato il minuzioso regolamento. A
LA FUNZIONE PARADIGMATICA E PIONIERISTICA DEL DIRITTO MARITTIMO
sua volta, il codice di commercio del 1865 veniva abrogato conr.d. 31 ottobre 1882 n. 1062, che approvò il nuovo codice di com-mercio. Anche in questo testo il libro II era dedicato alla materiamarittima e, più esattamente, al commercio marittimo e alla navi-gazione (marittima e interna). Leggi speciali di particolare rilievosuccessive sono quelle del 14 giugno 1925 n. 938, in tenia di assi-stenza, salvataggio e urto di navi; del 31 dicembre 1928 n. 3055,sui privilegi marittimi e l’ipoteca navale; del 25 maggio 1939 n.868, sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi:tutte di adeguamento a convenzioni internazionali.
Le fonti internazionaliAppare evidente che il precipuo interesse e la cospicua produzionenormativa in questo campo ha consegnato all’interprete un’auto-noma branca del diritto, quella – appunto – del diritto marittimo.Ma non è solo l’aspetto storico che evidenzia la particolarità di ta-le materia. Vi sono, infatti, peculiarità eminentemente praticheche portano a sottolinearne necessariamente la diversità con le al-tre discipline giuridiche.In questo campo, ad esempio, assume una rilevanza ragguardevo-le la normativa internazionale uniforme, sulla scorta della conside-razione che la disciplina della navigazione tende naturalmente al-l’uniformità. In effetti, nei rapporti inerenti alla navigazione si riscontrano,con frequenza di gran lunga maggiore che in altri settori, ele-menti di estraneità, nel senso che da un lato vengono coinvoltiinteressi di soggetti appartenenti a Stati diversi, dall’altro i rap-porti si svolgono nell’ambito di operatività di diversi ordinamentistatali. Si determina, in conseguenza, l’esigenza di evitare che isuddetti rapporti ricevano una regolamentazione differente neivari Stati, in relazione alla legge statale che risulti loro riferibilein esecuzione ielle norme di diritto internazionale privato appli-cabili. Pertanto i vari governi e anche gruppi privati interessatialle operazioni marittime fin dall’inizio del secolo scorso, hannostimolato e favorito la redazione e la conclusione di convenzioniinternazionali cosiddette di diritto uniforme, miranti appunto arealizzare una regolamentazione uniforme di quei rapporti inmateria di navigazione che più frequentemente presentano ele-
78
79menti di estraneità, ottenendo nel contempo la riduzione deiconflitti di legge.A ciò si aggiunga l’opera delle organizzazioni internazionali, qualisoprattutto Comite maritime international (CMI), costituito a Bru-xelles nel 1897. Si tratta di un’organizzazione di carattere privato,costituita da operatori giuridici, economici e tecnici, fra loro rag-gruppati in associazioni nazionali, con l’obiettivo di predisporreprogetti di convenzioni internazionali di diritto uniforme da sotto-porre a una conferenza diplomatica per l’approvazione. Il Comiteha svolto tale ruolo fino al 1967, facendo approvare sedici con-venzioni internazionali. Successivamente ha continuato e continuaa operare utilmente, ma in funzione di supporto a organizzazioniinternazionali intergovernative nel frattempo costituite.Non ultimo, poi, si ricorda l’influsso comunitario sulla materia for-temente connessa alla tematica del trasporto e quindi al fine isti-tuzionale della Comunità della “libera circolazione”.
L’espansione del diritto marittimo: il diritto dellanavigazione aerea e il codice della navigazioneLa storia più recente riafferma non solo la dignità scientifica del
LA FUNZIONE PARADIGMATICA E PIONIERISTICA DEL DIRITTO MARITTIMO
diritto marittimo, ma anche la sua naturale propensione allaespansione, ovvero all’offrirsi come paradigma per la regolamen-tazione delle materie analoghe, fino a inglobarle al suo interno.Invero, con la l. 30 dicembre 1923 n. 2814 e 24 dicembre 1925n. 2260, era stata delegata al Governo la facoltà di emanare, tragli altri, nuovi codici di commercio e per la marina mercantile. Conil r.d. 3 giugno 1924 era stata nominata una commissione presie-duta dal senatore Raffaele Perla, che aveva ultimato i lavori nel1931, con la redazione di un Progetto di codice marittimo, cheperò non ebbe seguito. Il progetto pur modernizzando la disciplina, rilevava uno stato diimperfezione, sia perché mancava di una salda impostazione me-todologica, sia perché separava nettamente gli istituti pubblicisticida quelli privatistici e trascurava la navigazione interna. Questoprogetto, come si evince dalla formulazione utilizzata, prescindevadalla regolamentazione della navigazione aerea.Sulla scena giuridica così segnata dell’inizio del secolo scorso, ir-rompe la forte personalità di indubbio prestigio e grande autore-
80
81
volezza di Scialoja, il quale sin dal 1922, ma compiutamente nellaprolusione letta all’Università di Napoli il 31 gennaio 1928 (La si-stemazione scientifica del diritto marittimo), che trovò poi svolgi-mento nel Sistema del diritto della navigazione, nonché nelle pa-gine della Rivista del diritto della navigazione, fondata nel 1935dallo stesso Scialoja, sostenne non solo l’unità e l’autonomia deldiritto della navigazione, ma anche, che la materia doveva neces-sariamente comprendere accanto alla navigazione marittima an-che quella aerea. Muovendo dalla considerazione della fisionomia unitaria, alla qua-le si è accennato, e del fatto tecnico che è a base di ogni forma dinavigazione, in tale programma Scialoja segnò alla scienza e allalegislazione un preciso indirizzo, sostenendo l’unità e l’autonomiadel diritto della navigazione. Egli affermò inoltre che lo studio diquesto ramo del diritto non deve limitarsi alla navigazione maritti-ma o ai rapporti di carattere commerciale che attengono a essa,bensì a tutti gli aspetti, pubblicistici e privatistici, della navigazioneper mare, per acque interne e per aria. Questa concezione detteinfine particolare rilievo alla considerazione del diritto vivente, sianell’interpretazione della legge scritta che nella nuova sistemazio-ne legislativa della materia.Pertanto, quando alla fine del 1939 fu ripresa l’opera della revi-sione dei codici e la riforma della legislazione in materia di navi-gazione che fu affidata a un comitato presieduto da Scialoja (ilquale predispose il progetto ministeriale del codice della naviga-zione), quest’ultimo – conformemente a quanto fino allora avevasostenuto – ricomprese nel progetto non solo la materia della na-vigazione marittima, ma anche la navigazione aerea. Per Scialoja,il diritto della navigazione aerea costituisce un parziale adatta-mento di istituti del diritto marittimo: registro navale, pubblicità,diritti di garanzia, assistenza, gettito, abbandono ecc. Ne conse-gue che il “diritto della navigazione acquea”, ovvero il diritto ma-rittimo, assume la funzione di diritto generale della navigazione eintegra le lacune del diritto eccezionale aeronautico. Sempre perScialoja, le norme del diritto aeronautico si presentano per lamassima parte come semplici e limitate deviazioni o derivazioni diistituti millenari del diritto marittimo. Ed è per ciò che l’ordina-mento di questo costituisce il diritto comune applicabile alla nuo-
LA FUNZIONE PARADIGMATICA E PIONIERISTICA DEL DIRITTO MARITTIMO
va materia, in quanto non sia espressamente o implicitamentederogato.E poiché è nota l’influenza del Sistema di Scialoja nella redazionedella Relazione al codice della navigazione, in quest’ultima si leg-ge che “la disciplina della navigazione marittima si configura co-me la parte generale nella quale si innesta la disciplina della navi-gazione aerea” (§ 11). Affermazione ripresa da Dominedò, secon-do il quale, le norme di diritto marittimo si applicano alla materiaaeronautica sia per richiamo espresso sia per analogia sia, ancora,per interpretazione estensiva giustificata dal carattere di tali nor-me come “diritto comune della navigazione”.
Il diritto marittimo quale diritto speciale el’applicazione per via analogicaLa materia della navigazione viene disciplinata attraverso un com-plesso organico di norme coordinate (ordinamento della naviga-zione), che si colloca in posizione speciale rispetto alla disciplinacomune o generale. Il diritto della navigazione è, perciò, dirittospeciale rispetto al diritto generale o comune.In sostanza l’art. 1 c. nav. stabilisce che, in materia di navigazione,si applicano il codice della navigazione, le leggi, i regolamenti, lenorme corporative e gli usi a essa materia relativi e, ove questefonti non siano suscettibili di applicazione né diretta né analogica,si applica il diritto comune. Dando valore prevalente alle fonti pro-prie della materia e condizionando l’operatività del diritto comuneo generale al preventivo ricorso a tutte le fonti speciali, anche digrado gerarchico inferiore, nonché al non fruttuoso impiego delprocedimento analogico, la normativa generale o comune viene adassumere collocazione ed efficacia subordinate rispetto alla discipli-na propria della materia, che è oggetto, in linea primaria, dellefonti di qualunque grado gerarchico che particolarmente le si riferi-scono. L’integrazione normativa attraverso il diritto generale siesplica dopo l’esaurimento del ricorso a tutte le fonti interne (pro-prie) della navigazione e ai principi speciali (tramite l’analogia) cheda esse si desumono: si tratta dunque di un ordinamento autono-mo rispetto all’ordinamento generale, nel quale pure s’inserisce.Tale operazione consente pure di enucleare una serie di “principispeciali” della materia. Per Pescatore con il procedimento analogi-
82
83
co si opera un’astrazione che dalla norma (o norme) particolareconsente di risalire al principio, il quale fissa una regola più ampiadi quella espressa, comprensiva della fattispecie non regolata, cuisi intende provvedere, sorretta dalla eadem ratio. Si agisce nel-l’ambito della legge o di un complesso di leggi attinenti alla stessamateria alla quale le fattispecie (regolata e da regolare) apparten-gono. Da qui la specialità del principio fissato.Pertanto, l’esperimento del procedimento analogico svolto priori-tariamente nell’ambito della materia della navigazione permette dirisalire a principi speciali, che dalla materia marittima si espando-no a quella aeronautica. È proprio la specialità dei principi checonsente di applicare alla materia aeronautica norme regolatrici
LA FUNZIONE PARADIGMATICA E PIONIERISTICA DEL DIRITTO MARITTIMO
della navigazione marittima, prima di procedere all’applicazionediretta di norme di diritto generale.L’applicabilità analogica di norme regolanti la navigazione maritti-ma alla materia aeronautica è stata sovente richiamata in concre-to. Sono stati fatti gli esempi del rimorchio per via d’aria, cui ap-plicare la disciplina del rimorchio per acqua; della delimitazionedella navigazione da diporto aereo in base alla corrispondentenormativa marittima (art. 1, commi 2 e 4, l. 11 febbraio 1971 n.50); della possibilità di un esercizio professionale dell’aeromobilein comproprietà, cui applicare le norme sulla società di armamen-to; dei poteri del comandante di aeromobile per provvedere alladeficienza di viveri e di provviste durante il viaggio (ipotesi confi-
84
85
gurabile in caso di soste e percorsi obbligati imposti da atti di so-praffazione), desumibile, anche per effetto dell’art. 893 c. nav.,dagli art. 300 e 301, relativi al comandante di nave; dell’estensibi-lità della disciplina delle avarie comuni alla navigazione aerea, cuida un avallo normativo l’art. 11 c. nav.; ecc.
L’esplicitazione della funzione paradigmaticadel diritto marittimo attraverso l’uso dei richiamiMa non è solo l’applicazione per via analogica del diritto maritti-mo che fa concludere per la sua importanza e necessarietà, quan-to ancor di più – come ha avuto modo di evidenziare Tullio – lapresenza di frequenti “richiami” alla materia marittima da parte diregolamentazioni differenti. Come è detto nella Relazione al codi-ce della navigazione (§ 11), “i richiami alle norme marittime, con-tenuti nella parte aeronautica, acquistano il significato di esplicitaapplicazione di una regola generale”.Tanto per fare un esempio, se il legislatore ha sentito l’esigenza(con l’art. 955) di rendere espressamente applicabili al trasportoaereo di cose gli articoli che regolano il trasporto marittimo (da425 a 438 e da 451 a 456), ciò significa che è il legislatore stessoche ha individuato dei principi speciali, comuni al trasporto marit-timo e aereo, sì da estendere al secondo la disciplina del primo invia diretta e non analogica.La differenza tra il sistema dei richiami e il procedimento analogi-co sta nel fatto che, mentre l’applicazione della norma richiamataavviene in modo diretto e automatico, l’applicazione della normaper analogia presuppone un’indagine dell’interprete diretta all’in-dividuazione del principio speciale. Ciò non toglie che anche nelsistema dei richiami operino i principi speciali. Si tratta, in sostan-za, di principi speciali operanti ex lege, che non è necessario indi-viduare ai fini della ricerca della norma applicabile. Così facendo,il legislatore ha imposto e cristallizzato l’estensione sostituendosiall’interprete e sopprimendogli il compito di ravvisare, in un datomomento storico, l’eventuale identità di ratio iuris.
L’autonomia del diritto marittimoLa regolamentazione peculiare della materia ne disvela la autono-mia legislativa.
LA FUNZIONE PARADIGMATICA E PIONIERISTICA DEL DIRITTO MARITTIMO
La disciplina particolare e organica del diritto della navigazione ècontenuta, infatti, in un codice apposito, il codice della navigazio-ne, approvato con r.d. 30 marzo 1942 n. 327, che ne costituiscela fonte più cospicua.Tale autonomia legislativa si è affermata nello stesso periodo ditempo in cui il diritto commerciale l’ha perduta, per essere stata larelativa disciplina assorbita dal codice civile. Questo assorbimentoè stato giustamente connesso, da un lato alla naturale tendenzadei principi del diritto speciale a espandersi fuori del loro ambitodi applicazione, dall’altro alla tendenza del diritto generale ad as-sorbire istituti sorti originariamente sotto la spinta di particolariesigenze, rivelatisi poi capaci di una più ampia applicazione. Il di-ritto commerciale era maturo per tale assorbimento, non il dirittodella navigazione, più giovane nell’elaborazione scientifica, anchese fondato su un’antica tradizione nei suoi istituti marittimisti.Questo dà ragione dell’autonoma sistemazione legislativa realizza-ta dal codice della navigazione.Il diritto della navigazione ha, inoltre, autonomia scientifica, che èconnessa in gran parte allo studio specifico dei problemi che deri-vano dai fatti della navigazione; tale studio, essendo diretto allasistemazione di quella particolare normativa e alla sua collocazio-ne nel quadro generale dell’ordinamento, si fonda sulla particola-re, primaria rilevanza del sistema di quelle fonti.Essa viene propugnata dalla dottrina in materia che non ha man-cato di rimarcare, con Righetti, che il diritto marittimo sussisteautonomamente e abbraccia “tutte le norme che hanno una re-lazione diretta o indiretta, nei loro precetti o nei relativi presup-posti fattuali, con l’elemento primordiale ‘mare’”. Posizione che,in verità, era già stata avanzata diversi anni prima negli stessitermini da Sandiford, per il quale con l’espressione “diritto ma-rittimo” si deve intendere il complesso delle norme giuridiche,che regolano le attività, che hanno riferimento con il mare e“dal fatto che il diritto marittimo regola le attività che hannorapporto con un determinato ambiente ne deriva come conse-guenza che questo diritto è particolarista o per meglio dire auto-nomo”. Sulla stessa falsariga, poi, si pone Spasiano, per il quale– poiché il diritto delle acque interne e il diritto aereo – in altronon consistono che in un’applicazione delle regole marittimisti-
86
87che, nel diritto marittimo in particolare e non nel diritto della na-vigazione in generale, vanno ricompresi, appunto, tanto il dirittodella navigazione interna, quanto il diritto aeronautico. Per cui, ildiritto della navigazione rappresenta – secondo Spasiano – unaparte del diritto marittimo, così come del diritto delle acque in-terne e del diritto aereo.Il diritto della navigazione ha infine autonomia didattica, in quan-to forma oggetto di specifico insegnamento universitario, che haavuto riconoscimento concreto nel 1942 (r.d. 5 settembre 1942 n.1319) con la prima attribuzione della cattedra di diritto della navi-gazione nell’università di Roma ad Antonio Scialoja. A essa seguìl’inserimento di apposite cattedre nella disciplina statutaria degliinsegnamenti di tutte le università italiane.
L’importanza del diritto marittimo: attualità eprospettiveAppare evidente agli occhi dell’interprete non solo la specificitàdel diritto marittimo, quanto ancor di più la sua funzione di faro
LA FUNZIONE PARADIGMATICA E PIONIERISTICA DEL DIRITTO MARITTIMO
per le materie affini, sì da far assurgere a valenza costituzionale iprincipi speciali regolatori della materia.È il caso, infatti di sottolineare che la comunanza di principi spe-ciali può raggiungere un tale livello di incisività da condurre in al-cuni casi a ravvisare l’illegittimità costituzionale di norme di dirittoaeronautico che irragionevolmente divergano da norme di dirittomarittimo.In sostanza, può accadere che una norma di diritto aeronauticovioli l’art. 3 cost. qualora si ponga in contrasto con una norma didiritto marittimo. In tal caso, l’irragionevolezza del contrastoemerge dalla considerazione della necessità di regolazione unifor-me delle due fattispecie a confronto e scaturisce dalla individua-zione di un comune principio speciale che vincola a livello costitu-zionale all’uniformità della disciplina. Ciò significa che l’art. 3cost. può attribuire una valenza costituzionale al principio specia-le, rafforzando quindi al massimo livello l’importanza della materia(Corte cost. 26 maggio 2005 n. 199).Tali considerazioni illuminano sulla importanza attuale del dirittomarittimo per l’intera materia della navigazione e dei trasporti. Matale importanza travalica questa stessa ultima materia e, in pro-spettiva, assume contorni ancor più generali se soltanto si ponemente all’origine marittimistica di molti istituti di diritto commer-ciale (assicurazione, società, cambiale, ecc.). Ancora oggi, poi,non si possono ignorare i contributi che il diritto marittimo offrealla teoria dell’impresa e degli ausiliari, della comunione e dellasocietà, dei modi di acquisto della proprietà, dei titoli di credito,della responsabilità civile e della colpa. Vanno anche ricordati gliistituti originali (noleggio, avaria comune, limitazione di responsa-bilità), che trovano sempre più spesso applicazione al di fuori deigià ampi ambiti della materia.Appare evidente, in conclusione, che il diritto marittimo non hamai dismesso quella funzione di “pioniere del diritto” che con ar-guzia e lungimiranza gli fu attribuita da Ascarelli all’inizio del se-colo scorso, il che non solo giustifica la sua specificità scientifica epratica, ma ne consiglia l’esaltazione delle peculiarità, proprio infunzione delle positive ricadute che ciclicamente comporta a tuttigli ambiti dello scibile giuridico e della prassi dell’economia.
88
89
SCHIAVITU’ E REDENZIONEDEI “CATTIVI”, TRA PROCESSO
SECOLARE E DIRITTO MUSULMANO
Vasco Fronzoni*
A metà del 1500 nacque una confraternita laica con lo scopo diriscattare i cristiani in modo da salvarli fisicamente e moralmente.Ma non erano pochi i convertiti che abbracciavano l’Islam
Il Mediterraneo, fin dagli albori della navigazione, è sempre statoun mare insidioso, poiché nelle sue acque e lungo le sue spondeera particolarmente attiva e praticata la pirateria. Nelle Leggi Pla-tone, elaborando una città ideale, arriva addirittura a fissarne unadistanza di sicurezza dal mare, di 14 chilometri e 700 metri. Ac-canto alla pirateria, fu molto presente anche il fenomeno dellaguerra di corsa,1 che l’avvento dell’Isl–am contribuì a far nascere efiorire.
NAUTES
1 Vi è una precisa differenza tra i termini corsaro e pirata. Il corsaro era un armato-re, al servizio di un sovrano, che riceveva da questi una specifica autorizzazione(lettera o patente “di corsa”), venendo così legittimato a compiere scorrerie e adassaltare le imbarcazioni nemiche del sovrano stesso, rappresentandone quindi unaforza navale ausiliaria, in dipendenza delle alleanze o convenienze di quello. Laguerra di corsa non sollevava riprovazioni morali e al corsaro venivano forniti ap-poggi logistici e collaborazione da parte degli stati alleati. Diversamente, il pirataera colui che assaltava navi o effettuava a terra incursioni, senza autorizzazione elimitazioni alcune e senza nessuna motivazione ideologica o politica. Questa, a oc-chi moderni, può sembrare una tenue distinzione ma all’epoca cui si riferisce avevauna importanza fondamentale ed effetti ben definiti, sul piano giuridico, politicoed economico.
* Collaboratore scientifico, per l’archeologia subacquea, del Centro studi tradizioninautiche.
In particolare, a partire dall’800, con l’istituzione dell’emiratoereditario aghlabide sulla provincia dell’Ifriq–I yya – la modernaTunisia – ebbe inizio quello che viene definito il “gihad2 maritti-mo”3, una spinta espansionistica islamica, attraverso il rafforza-mento dell’attività cantieristica navale, che portò nell’827 allaconquista della Sicilia e, per lungo tempo, alla supremazia dei le-gni musulmani nel canale di Sardegna, nello stretto di Sicilia enel mar Ionio meridionale. Questa fu la premessa, assieme allosviluppo dei commerci, a che nei secoli successivi, tra Isl–am e cri-stianità, venissero effettuate nel bacino mediterraneo continuerazzie, battaglie, inseguimenti e cacce navali da un lato e, dal-l’altro, una fitta rete di rotte, scambi, commerci e osmosi cultu-rali, gli uni presupposto, causa e conseguenza degli altri e vice-versa.Fino ai tempi moderni, i trasporti marittimi erano preponderantirispetto a quelli terrestri e le coste, così ricche di isole, golfi, baiee insenature, offrivano numerosi punti di appoggio alle imbarca-zioni corsare o pirata, dando loro la possibilità di nascondersi esferrare attacchi improvvisi, ricavando bottino di merci, beni eprede umane. La guerra di corsa era addirittura uno strumento di lotta politica,di cui ad esempio si servirono le maggiori potenze europee – so-prattutto Francia e Inghilterra – nelle lunghe ostilità che le vide-ro contrapposte le une alle altre. La corsa, quindi, vantava circui-ti di scambio e di trattative ufficiali e istituzionali per convertirein profitti i beni conquistati. La sicurezza di tali transazioni com-merciali e monetarie testimonia come questa attività divenneuna vera e propria attività imprenditoriale, regolata da contrattie licenze. Analizzando il blocco occidentale in termini strettamente marina-reschi, nella contrapposizione tra potenze europee da una parte e
90
2 Il termine gihad, comunemente ed erroneamente tradotto con “guerra santa”,deriva dalla radice verbale araba _a-ha-da e vuol dire sforzarsi, nel senso di impe-gno per raggiungere un nobile fine. Sulle varie accezioni del termine si veda A.CILARDO, Il Diritto islamico ed il Sistema giuridico italiano, E.S.I., Napoli, 2002, pp67 e ss..3 C. LO JACONO, Profilo storico del mondo musulmano, I.P.O., Roma, 2002.
^
^
91Califfato e Reggenze barbaresche dall’altra,4 dal punto di vistadella costruzione navale, esso era notevolmente più evoluto. Tra il 1500 e il 1600, le imbarcazioni utilizzate dalle flotte musul-mane erano, prevalentemente, le galee. La galea aveva uno scafopiuttosto allungato (poteva arrivare fino a 55 metri), stretto (circa5 metri) ed era bassa di bordo e le sue caratteristiche ne facevanouna imbarcazione estremamente veloce; normalmente potevacontare su due alberi a vele latine, che venivano spiegate per co-prire lunghe distanze, ma la forza propulsiva era soprattutto datadai remi. Erano necessari dai 150 ai 200 vogatori, disposti di solitosu 25 panche divise in due da un corridoio. La galea mediterraneaarmava pochi pezzi d’artiglieria a bordo, per questioni di peso e dispazio. Era inoltre dotata di uno sperone a prua, in genere dibronzo, per squarciare le chiglie delle navi nemiche e, al contem-po, per immobilizzarle in modo da consentire l’abbordaggio.
SCHIAVITU’ E REDENZIONE DEI “CATTIVI”, TRA PROCESSO ...
4 Per Reggenze barbaresche si intendono quei governatorati ottomani in Barberia,il Maghreb o Nord-Africa, dai cui principali porti venivano equipaggiate e armate leimbarcazioni per la guerra di corsa. In ordine di importanza, vi erano Algeri, Tunisie Tripoli.
Anche se in minor numero, vi erano altre imbarcazioni utilizzatedalle flotte islamiche. Le galeotte erano più piccole e leggere, equindi più veloci e sfuggenti rispetto alle galee, delle quali, tutta-via, possedevano quasi tutte le altre caratteristiche. Vi erano poi lefeluche, lunghe non più di 20 metri ma più larghe delle galee edotate di diverse vele e di 8 o 12 remi, e gli sciabecchi con unoscafo grosso ma di basso pescaggio che teneva bene il mare, do-tati di remi a sostegno delle vele latine degli alberi, che armavanodiversi cannoni, e che venivano per lo più utilizzati d’inverno,quando le condizioni meteo-marine non consentivano l’utilizzodelle galee. In ogni caso la maggior parte dell’attività corsara av-veniva dalla primavera agli inizi dell’autunno.Le galee erano meno maneggevoli dei galeoni, imbarcazioni a velaquadra, maggiormente presenti nelle flotte cristiane e molto te-muti quando avevano il vantaggio del vento. La spinta propulsiva
92
93
dei remi delle galee riusciva a superare la velocità delle vele deigaleoni solo durante le bonacce, peraltro tipiche dell’estate medi-terranea. Tuttavia, le galee erano obbligate a tenersi vicine alla co-sta e a fare scalo ogni 10 giorni per rifornirsi d’acqua e, in ognicaso, imbarcavano provviste per una cinquantina di giorni di navi-gazione al massimo. Inoltre, il principio tecnico sul quale si fonda-vano le navi a vele quadre era la presenza di una grande vela ag-giuntiva, che poteva essere manovrata rapidamente variandonesia la direzione che la superficie. Ciò fu reso in parte possibile conil passaggio da vascelli a un albero solo a quelli a tre alberi e, inparte, grazie al prolungamento degli alberi stessi (di norma quellidi maestra e mezzana), ottenuto innestando gli alberi di gabbia. Intal modo, non solo si accresceva la gamma delle direzioni possibilidi vela, ma ciascuna vela poteva essere velocemente modificataper combinarsi con la rotta della nave e la direzione del vento oanche essere ammainata. L’innovazione ebbe una evidente e posi-tiva ripercussione sulla prevalenza navale delle flotte cristiane suquelle musulmane.Il periodo culminante della guerra corsara viene comunemente in-dividuato tra il XVI e il XVII secolo. Ciò in quanto le grandi rottecommerciali – e quindi le vicende politico-economiche a esse col-legate – si spostarono dal Mare Nostrum verso gli scenari indiani,del nuovo mondo e del Sud-est asiatico. Insieme a esse si spostòl’attenzione e la vigilanza delle potenti flotte da guerra delle gran-di nazioni di allora.5
Anche le coste napoletane furono sottoposte a frequenti incursio-ni da parte di barbareschi e turchi, in particolare intorno alla metàdel XVI secolo. In particolare divennero note e temute, nel Golfo,le attività corsare di Kayr ed-D–In (detto il Barbarossa e noto anchecome Ariadeno) e Drag–ut, che in più occasioni saccheggiarono Ca-pri e la costiera sorrentina.6
Conseguenza delle incursioni era la riduzione in schiavitù, che po-teva avvenire attraverso la cattura degli equipaggi e dei passeggeridelle navi oppure attraverso le razzie lungo le coste. Il fenomeno
SCHIAVITU’ E REDENZIONE DEI “CATTIVI”, TRA PROCESSO ...
5 F. BRAUDEL, La Mediterranée. L’espace et l’histoire, Milano, 1992. 6 C. MUTTI, Khair ed-D_n “Barbarossa”, corsaro o mu_ahid?, ed. Barbarossa, Sal-luzzo (CN), 1986.
assunse dimensioni veramente rilevanti. E’ stato di fatti calcolatoche nel periodo d’oro della corsa vi fossero ad Algeri circa 25.000schiavi, a Tunisi 10.000 e a Tripoli circa 4.000.7
La prigionia, tuttavia, non deve necessariamente essere vista comeuna condizione disumana e anzi alcuni schiavi uscirono dalla loroesperienza di vita con sentimenti non del tutto negativi, riuscendoa guardare alla loro prigionia con una certa obbiettività, raccon-tando un mondo diverso, non crudele. Questo è ad esempio il ca-so di Cervantes, che partecipò alla battaglia di Lepanto del 1571 eche venne catturato nel 1575 in mare, rimanendo schiavo in Alge-ri per 5 anni;. Nel Don Chischotte, infatti, egli non dipinge affattoil mondo musulmano a tinte fosche.In realtà, lo schiavo costituiva un bene molto apprezzato e assu-meva un valore economico variabile, influenzato oltre che dal nu-mero di “braccia” disponibili sul mercato, anche dalla costituzio-ne fisica e dalle conoscenze, capacità e attitudini lavorative diognuno.8
L’impiego degli schiavi era il più vario: come portuali, per la manu-tenzione delle infrastrutture cittadine, come operai nei cantieri na-vali, come artigiani, come contadini e, soprattutto, come rematorisulle galee. Più fortunati erano coloro che venivano impiegati conmansioni domestiche, in quanto spesso riuscivano a farsi apprez-zare e a inserirsi nel contesto familiare arrivando talvolta a sotto-scrivere con il padrone specifici contratti, in forza dei quali que-st’ultimo, dietro corrispettivo, consentiva allo schiavo di svolgereun mestiere o un altro lavoro, permettendogli così di accumularedanaro per provvedere al suo riscatto. Soprattutto nel mondo musulmano, infatti, oltre che per il poten-ziale lavorativo, gli schiavi costituivano una considerevole risorsain quanto rappresentavano una merce preziosa da rivendere allacristianità. Il fenomeno dei riscatti andò man mano sempre più im-plementandosi: si calcola che almeno un quarto degli schiavi pre-senti in Barberia venisse affrancato ogni anno, dando luogo a unaenorme movimentazione di danaro e a forti impulsi per l’econo-mia europea e Nord-africana. Sovente le missioni di redenzione
94
7 S. BONO, I corsari barbareschi, Torino, 1964.8 I più ricercati erano gli artigiani, i marinai e i carpentieri navali.
95costituivano l’occasione, difatti, per svolgere d’ambo i lati cospicuie fruttiferi commerci. Le prime trattative di riscatto avvennero pro-babilmente in mare o lungo le coste dei paesi cristiani, anche per-ché talvolta, data l’elevato numero di schiavi catturati, era piùconveniente non sovraccaricare le imbarcazioni e non correre il ri-schio che la “merce” deperisse. Veniva così innalzata una bandie-ra di riscatto (simbolo noto a entrambi i blocchi) nei pressi dellelocalità saccheggiate, invitando compaesani, parenti e amici deicatturati a mercanteggiarne la liberazione.9 Quando tuttavia il nu-mero delle persone catturate dai barbareschi divenne molto eleva-to, fu necessario organizzare – e poi istituzionalizzare – delle veree proprie missioni di redenzione, patrocinate da organizzazioni re-ligiose o laiche.In questo contesto si colloca l’attività della Santa Casa della Re-denzione dei “cattivi”, che nacque con il nome di Confraternita di
SCHIAVITU’ E REDENZIONE DEI “CATTIVI”, TRA PROCESSO ...
9 Spesso, infatti i corsari davano inizio immediatamente alle trattative di riscattosenza allontanarsi dalle acque del sud Italia (ridossandosi magari in qualche insena-tura), tant’è che nel 1571 fu emanato un editto che proibiva agli abitanti del Vice-regno di intraprendere direttamente le trattative di riscatto.
Santa Maria del Gesù della Redenzione dei Cattivi, formalmenteapprovata dal Vicerè di Napoli nel 1548 e da Papa Giulio III nel1550. La Confraternita, la cui documentazione è conservata pres-so l’Archivio di Stato di Napoli, è da considerarsi come la primaistituzione italiana di carattere laico sorta con lo scopo di riscatta-re i cristiani ridotti in schiavitù dai musulmani.10 Nei primi anni divita gli incontri dei confratelli avvenivano nella Chiesa di San Do-menico Maggiore. Successivamente, nel 1559, la Confraternita sitrasferì nel convento dei Celestini a S. Pietro a Majella, e iniziò lacostruzione, su un suolo adiacente, di un intero complesso conannessa chiesa, completata nel 1564, che tutt’ora si trova in via S.Sebastiano n. 1, nei pressi del Conservatorio.11 Dal 1564 l’istitu-zione fu chiamata Santa Casa della Redenzione dei Cattivi.Lo scopo prefisso dai confratelli, oltre a quello collaterale di prati-care vantaggiosi commerci, era triplice: provvedere concretamentealla salvezza fisica degli schiavi cristiani, provvedere attraverso il ri-scatto del corpo anche alla salvezza dell’anima di questi ultimi, inbilico verso l’abiura e, nel contempo, salvare la propria anima, poi-ché nel giorno del giudizio universale il Signore non avrebbe avutomisericordia di quanti non avessero avuto compassione dei fratelliche si trovavano o che si erano trovati in “cattività”.La Confraternita organizzava la raccolta dei fondi, attuata me-diante collette pubbliche12 ed elemosine personali ben definite e,cercando appoggi e protezioni, armava una imbarcazione, forma-va un equipaggio, prendeva contatti con le autorità musulmane,
96
10 G. BOCCADAMO, Prime indagini sull’origine e l’organizzazione della Confra-ternita napoletana della Redenzione dei Cattivi (1548-1588), in Campania Sacra,VIII-IX.11 La chiesa è ora nota col nome di S. Maria della Mercede e S. Alfonso de Liguorie, più che come appartenente alla Confraternita, è ricordata per il fatto che in essaS. Alfonso Maria de Liguori togliendosi la spada la depose ai piedi del quadro dellamadonna liberatrice degli schiavi e fece voto di rinunzia al foro e di farsi prete (G.BOCCADAMO, op. cit.).12 Le collette venivano effettuate nelle chiese, nelle città e nelle campagne, facen-do leva sul sentimento di chi era stato colpito dal fenomeno delle catture. Per sti-molare la generosità dei fedeli venivano anche concesse speciali indulgenze. Inol-tre, erano in uso specifici legati tra le disposizioni testamentarie, per incrementare ifondi di riscatto.
97
concordando – sommariamente – l’ammontare dei diritti di entra-ta e uscita dai porti per le navi di riscatto e del prezzo dei singoliriscatti. Si faceva inoltre consegnare un salvacondotto, che garan-tisse la circolazione nel Mediterraneo e salvaguardasse la nave e isuoi occupanti da eventuali attacchi corsari. Infine, stipulava assi-curazioni sulla nave e le merci trasportate, concludeva accordicommerciali con mercanti e banchieri che avevano emissari in Ita-lia, Francia, Spagna, e Reggenze barbaresche, per procedere alleanticipazioni e agli accrediti necessari per le spese di viaggio esoggiorno dei redentori e per le operazioni di riscatto. Poteva anche accadere che uno schiavo o un suo incaricato chie-desse un prestito alla confraternita per il proprio riscatto o che in-viasse in patria una procura con indicazioni necessarie per rendereliquido e disponibile il denaro necessario al proprio riscatto, adesempio vendendo beni, recuperando lasciti testamentari, riscuo-tendo crediti.
SCHIAVITU’ E REDENZIONE DEI “CATTIVI”, TRA PROCESSO ...
La prima imbarcazione della Confraternita per i viaggi di redenzio-ne, la Santa Maria di Pozzano, fu acquistata il 27 Maggio 1549,per 324 ducati e rimase anche l’unica. Come comandante fu scel-to un anacaprese, Iacovo Savastano, il quale dopo l’allestimento ealcune riparazioni effettuate a Capri, salpò il 5 giugno 1549 condestinazione Gerba, in Tunisia, portando a bordo svariate mercan-zie. La spedizione ebbe successo e dopo sette mesi, il 15 gennaio1550 la Santa Maria attraccò a Napoli portando con sé 50 schiaviriscattati. Dopo vari viaggi per ammortizzare le spese (trasportò uncarico di grano a Roma, imbarcò merce a Taranto), agli inizi del1551 venne organizzato un secondo viaggio al quale succedettenel 1552 un terzo, fatale, poiché la Santa Maria affondò o fu af-fondata, con tutto il suo carico ed equipaggio. La Santa Casa, dopo l’episodio, non armò più vascelli in proprio,ma noleggiò di volta in volta alcuni vascelli, ripartendo così i cari-chi e i rischi.
98
99
Le imbarcazioni che recavano i redentori, quando transitavanonelle rade antistanti i porti barbareschi, inalberavano la bandieradi riscatto e venivano raggiunte da un funzionario musulmano,che aveva l’incarico di controllare il salvacondotto, il danaro e lemerci trasportate, al fine di determinare la tassa di entrata. Le im-barcazioni entravano poi in porto e dovevano consegnare vele eattrezzature mobili, per evitare che gli schiavi potessero impadro-nirsi di una nave e tentare la fuga. I redentori, nel corso della mis-sione, venivano avvicinati da mercanti e padroni di schiavi, chetentavano di vendere le proprie mercanzie, costituite da beni epersone. Le trattative si complicavano però quando i redentoriavevano una lista precisa delle persone da riscattare, poiché i ven-ditori potevano elevare i prezzi e cominciava così una lunga tratta-tiva, motivo per cui il soggiorno dei redentori poteva protrarsi an-che per mesi. Il prezzo degli schiavi era variabile e determinato davari fattori: età, sesso, condizioni fisiche, salute, attitudini lavorati-ve, estrazione sociale nonché dalla disponibilità sul mercato chene faceva mutare offerta e domanda. In media, nel periodo a ca-vallo tra il 1500 e 1600, il prezzo di uno schiavo cristiano ammon-tava a 100 ducati.Quando non vi erano indicazioni precise su nominativi da ritrova-re, oppure avanzava del danaro, si seguiva l’ordine di scelta stabi-lito dallo statuto della Santa Casa, a scalare: i bambini molto pic-coli, quelli più grandi, le donne,13 i vecchi, gli uomini che avesse-ro lasciato in patria mogli e figli. A ogni modo bisognava dareprecedenza al riscatto di chi ne avesse più bisogno e fosse in pe-ricolo di perdere la fede. Si aveva riguardo anche per i sacerdoti.L’operazione di riscatto si concludeva con il rilascio, da parte del
SCHIAVITU’ E REDENZIONE DEI “CATTIVI”, TRA PROCESSO ...
13 Va tuttavia sottolineato come nell’Islam c’era grande richiesta di schiave, indiriz-zate soprattutto ai lavori domestici, dal momento che la destinazione agli harempresupponeva un tipo di “merce” dettagliato e specializzato. Ciò si rifletteva sulprezzo d’acquisto. Ed è proprio a causa dell’elevato importo, nonché della perditadi interesse per quella che poteva essere considerata una merce “usata” e degra-data, le donne riscattate furono certamente inferiori agli uomini. Ed esiguo fu an-che il numero di donne ridotte in schiavitù rispetto agli uomini, circostanza che ri-sulta indicativa del fatto che erano più frequenti le catture tra la gente di mare, ri-spetto a quelle avvenute a seguito di incursioni e razzie tra le popolazioni costieree rivierasche.
padrone dello schiavo, di un certificato di affrancamento nel qua-le ne venivano riportati, oltre al nome e cognome, le caratteristi-che fisiche, il luogo in cui era stato catturato, il lavoro svolto e lasomma pagata per il riscatto. Una volta rientrati in patria, gli exschiavi dovevano trascorrere, a spese dello Stato, un periodo diquarantena.La Confraternita napoletana aveva buoni rapporti con le autoritàmaghrebine e godeva di favorevoli condizioni, tant’è che l’Arci-confraternita del Gonfalone di Roma, istituzione analoga alla San-ta Casa, chiese ai barbareschi di parificare le condizioni. Anche dopo l’attività della Santa Casa, la redenzione dei “cattivi”fu, comunque, un’occupazione presente a Napoli. Difatti su richie-sta di Ferdinando IV, nel 1778 Papa Pio IV estese al Regno di Napolila “Bolla della Crociata”, avente per fine quello di procacciare fon-di per la costruzione di nuove navi onde potenziare la marina na-poletana per meglio combattere contro i corsari barbareschi e perriscattare i sudditi finiti in schiavitù. La bolla, in cambio degli oboli,consentiva ai fedeli la dispensa dal digiuno durante la quaresima.14
Poteva accadere che alcuni schiavi, a dire il vero molti, rinnegava-no la propria fede. Gli sventurati catturati, speravano nel riscattodalla schiavitù, ma quando questo non arrivava, finivano col cede-re alle sollecitazioni esercitate per abbracciare l’Isl–am e cercavanoaddirittura di inserirsi nella vita civile e produttiva del mondo mu-sulmano. Molte volta accadeva che si riuscisse a vivere meglio nel-la nuova società che in quella di origine, migliorando le propriecondizioni di vita e la propria situazione socio-economica. I rinne-gati (come venivano comunemente definiti da ambo i lati i conver-titi) cristiani, soprattutto se dotati di una qualche capacità marina-resca, venivano in ogni modo incentivati a partecipare alle spedi-zioni corsare, per mettere a frutto la loro conoscenza dei luoghi edelle abitudini occidentali.
100
14 La raccolta dei fondi consentì la fondazione dei cantieri navali di Castellammaredi Stabia (1783), ancora oggi in piena attività, che nel 1786 vararono le prime im-barcazioni: la corvetta Stabia da 24 cannoni, il vascello Partenope da 74 cannoni ela corvetta Flora da 24 cannoni. Quest’ultima venne poi autoaffondata nel 1799.Parte del relitto è ancora oggi visibile nel Porto di Napoli, su un fondale di 12 me-tri, nei pressi della Stazione Marittima.
101Statisticamente le donne abbandonavano più facilmente il cristia-nesimo, anche per i legami che si creavano con i figli nati in schia-vitù. Tra il XVI e il XVII secolo, si calcola che i “rinnegati” fosserocirca 300.000.15
I cristiani che erano stati costretti a ripudiare la loro fede, o perchéforzati da violenze fisiche e morali o per migliorare le proprie con-dizioni di vita in territori estranei e ostili, ovvero perché si trovava-no in età infantile e quindi nella impossibilità di comprendere ap-pieno le conseguenze del gesto, in patria venivano consideratiapostati a tutti gli effetti (prudenza e ragionevolezza venivano ri-tenute abiura e tradimento della fede). Quando costoro riuscivanoa rientrare nei paesi di origine, quindi, venivano sottoposti a unprocesso per sondare la possibile “riconciliazione”, subendo tal-volta pesanti condanne. Tuttavia, nel complesso, l’Inquisizione eraindulgente nei confronti di quelli che si sottoponevano al suo giu-dizio volontariamente, mostrandosi disposti a fare penitenza for-
SCHIAVITU’ E REDENZIONE DEI “CATTIVI”, TRA PROCESSO ...
15 C. MANCA, Problemi aperti sul commercio e sul riscatto degli schiavi nel Medi-terraneo dopo Lepanto, in Africa, XXIX.
male.16 I Tribunali dell’Inquisizione avevano poteri di indagine pra-ticamente illimitati, per vagliare ogni singolo comportamento ouno stile di vita passato che apparissero in contrasto con la fedecattolica. Lo svolgimento delle indagini autorizzava il braccio seco-lare a trattenere le persone contro la loro volontà per periodi inde-finiti. Per ottenere informazioni, infatti, gli inquisitori interrogava-no i sospetti per mesi, convocavano i testimoni da luoghi anchemolto remoti e intimorivano i prigionieri con ogni forma di pres-sione psicologica e costrizione fisica, non essendo raro l’uso dellatortura, al fine di scandagliare l’interno volere e l’attitudine mora-le di chi aveva abbandonato la propria fede. Il manuale di proce-dura17 in uso agli inquisitori stabiliva, di contro, che una sessionedi tortura non poteva protrarsi per più di mezz’ora e prevedevaanche una visita medica qualora vi fossero supposti impedimenti atale mezzo di (ricerca della) prova. Descrittiva della condizione dei “cattivi”, rinnegati e riconciliati èla storia di un Anacaprese, Luca D’Angelo, il quale venne cattura-to, mozzo di quattordici anni, nel canale di Malta, su di un’imbar-cazione che trasportava vino da Saragozza a Malta. Portato a Co-stantinopoli, vi restò per sei anni nel corso dei quali venne educa-to agli usi e costumi locali, venendo quindi circonciso e costretto“a bastonate”18 a rinnegare la fede. Nel 1601, con un altro com-pagno di sventure, riuscì a fuggire e, via Grecia, di tappa in tappa,a rientrare a Capri. Lì giunto si fece consegnare dal Parroco dellaChiesa di S. Sofia il suo certificato di battesimo (avvenuto il 9 apri-le 1580) e, da un componente l’equipaggio dell’imbarcazione ovefu catturato, una dichiarazione giurata descrivente le circostanzeche lo portarono alla schiavitù, per recarsi poi a Napoli, in Arcive-scovato, per farsi “riconciliare” cioè per ritornare al cristianesimoabiurando l’Isl–am. Il procedimento di “riconciliazione” fu eseguitomediante un’abiura pubblica “con una candela in mano”19 e allapresenza di quattro testimoni, tre interrogatori e si concluse con la
102
16 P. PARTNER, Corsari e crociati, Einaudi, 2003.17 Sacro Arsenale overo Pratica dell’Officio della S. Inquisitione, 1624.18 E. SERRAO-G. LACERENZA, Capri e L’Islam, La Conchiglia, Capri, 2000. 19 E. SERRAO-G. LACERENZA, op. cit.
103sentenza di riconciliazione, resa pubblica dal Vicario generale diNapoli il 7 aprile 1601. Nel mondo cristiano, contrariamente alle usanze del mondo bar-baresco, secondo le quali i “cattivi” venivano catturati prevalente-mente per richiedere un riscatto o per destinarli ai remi delle ga-lee, gli schiavi venivano impiegati per lo più come forza lavoro.Nel Regno di Napoli, nel XVII secolo, molti furono impiegati per lacostruzione della Reggia di Caserta. Livorno, insieme a Malta, fu il principale centro di commercio de-gli schiavi nel Mediterraneo. Addirittura in questa città, nel 1680,vi erano ben quattro distinti luoghi di culto per gli schiavi musul-mani. Nel mondo cristiano, sui “cattivi” non venivano esercitateparticolari pressioni affinché si convertissero e la ridottissimaquantità dei casi documentati di conversioni di schiavi musulmanial cristianesimo, sono indice della gravità del gesto, intollerabile einsuperabile per la visione islamica. Per il diritto musulmano, infatti, il reato di apostasia (ridda) è unreato punito con pena hadd (pena coranica e che quindi proviene
SCHIAVITU’ E REDENZIONE DEI “CATTIVI”, TRA PROCESSO ...
direttamente da Dio), irretrattabile per il quale è prevista la penadi morte. L’apostata (murt–add) viene esortato ad abbracciare nuo-vamente l’Isl–am. Mentre all’uomo, viene concesso un periodo di ri-pensamento di tre giorni al termine del quale, se non ci ha ripen-sato, viene condannato a morte; per la donna è prevista la carce-razione a vita, viene picchiata ogni tre giorni finché o si converte omuore. La conversione ha conseguenze sostanziali anche nel dirit-to civile in quanto l’apostata perde ogni diritto, civile, patrimonia-le e successorio e l’eventuale vincolo matrimoniale viene scioltoipso iure.20 Nel diritto musulmano inoltre, vi sono diverse previsio-ni che si occupano del riscatto dalla schiavitù e anche dei contrattidi vendita degli schiavi e delle relative garanzie.Tra le 8 categorie di beneficiari della zak –at, l’elemosina legale pre-vista dal sistema giuridico islamico, accanto a coloro i cui cuori de-vono essere riconciliati vi sono gli schiavi da riscattare, coloro iquali cioè in condizione di schiavitù si convertono all’Isl–am. Il loroaffrancamento, ritenuta azione meritoria, fu addirittura istituzio-nalizzato in una forma contrattuale (mukatabun, contratto di af-francamento) per l’esecuzione del quale, secondo la scuola Hana-fita, Sciafiita e Hanbalita, potevano essere impiegati i fondi raccol-ti con la zak–at. In tal caso, il patronato e la vocazione ereditariadel liberto passavano al bayt al-mal. Per estensione analogica, poi-ché il termine riq–ab (schiavo) veniva interpretato anche come il“cattivo” che si trovasse nella dar al-harb, era opinione comuneche lo storno dei fondi della zak–at per l’affrancamento degli schia-vi, era lecito anche per la liberazione dei musulmani prigionieri interritorio nemico.21
In tema di vendita degli schiavi, poi, il venditore, rispondeva dellamancanza delle qualità prospettate e dei difetti della cosa vendu-ta. La garanzia per vizio redibitorio, difatti, venne originariamenteconcepita soprattutto nella vendita degli schiavi, cui era estesa invia analogica quella degli animali. In tale ambito era prevista lagaranzia delle tre notti,22 durante le quali se fosso sopraggiunta
104
20 A. CILARDO, op cit.21 E. FRANCESCA, L’elemosina rituale secondo gli Ibaditi, in Studi Maghrebini, 19(1987).22 F. PELTIER, Ventes, La Maison des livres, Algeri, 1949.
105una malattia o una imperfezione nello schiavo, il contratto venivarisolto. In presenza di particolari malattie come lebbra e pazzia, lagaranzia copriva l’anno.In generale, non si ritengono possibili contratti di vendita senzaqueste garanzie, anche se si dice che Malik sul punto cambiò ideaben tre volte. Al Buhari23 ritenne attuabile anche la risoluzionedella vendita per i costumi dissoluti degli schiavi, tra i quali vieneespressamente citata l’ubriachezza abituale.Per poter essere attivata questa forma di garanzia, i vizi devonoessere antecedenti alla perfezione del contratto e, chiaramente, sesi tratta di una patologia, essa deve essere stata contratta prece-dentemente. Deve trattarsi, inoltre, di vizi che diminuiscono sensi-bilmente il valore della cosa, non essendo sufficiente che si trattidi una cicatrice sulla pelle. Se poi il venditore ha dichiarato l’esistenza di un vizio soltanto inparte, vi sono, all’interno della scuola Malichita, tre possibili orien-tamenti:
SCHIAVITU’ E REDENZIONE DEI “CATTIVI”, TRA PROCESSO ...
23 BUHARI, Kitab al-buyu.
– se il venditore ha dichiarato il vizio per la parte maggiore (ha di-chiarato che uno schiavo è fuggito per 15 gg, mentre in realtà èfuggito per 20 gg) l’acquirente avrà diritto a una proporzionale di-minuzione del prezzo. Se il vizio è dichiarato per la parte minore,il contratto è risolto;– non si distingue se la dichiarazione è stata fatta in misura mag-giore o minore, ma il compratore ha diritto a una differenza sulprezzo, in proporzione a quanto gli è stato dichiarato; – se lo schiavo perisce o si deteriora in quella parte dichiarata,l’acquirente ha diritto ad una differenza sul prezzo corrispondenteal solo vizio dichiarato; se invece perisce o si deteriora in una par-te non dichiarata, il contratto è risolto.L’azione redibitoria si estingue se il compratore, successivamentealla conoscenza del vizio, espressamente vi rinunzia, oppure se,successivamente, compie atti dispositivi sulla cosa o la utilizza inmaniera continuativa, non per necessità, integrando così una ri-nunzia tacita.Il diritto Malichita più recente riconosce anche una prescrizionedell’azione redibitoria, decorso un anno per gli immobili, sei mesiper gli schiavi, un mese per gli animali e si fonda su di una pre-sunzione di rinunzia.
106
107
RIAFFIORA L’ANTICHITÀDALLE ACQUE DEL SUD
Lorenzo Ferragamo
Straordinari rinvenimenti archeologici davanti alle coste di Campa-nia, Calabria, Basilicata e Puglia grazie al progetto “Archeomar”voluto dal ministero dell’Ambiente. Un patrimonio da utilizzareanche per la difesa dell’ambiente e per lo sviluppo del turismo
Un lavoro durato un anno e mezzo ha portato alla realizzazione diun accurato catalogo dei beni archeologici sommersi nei fondalidei mari del Sud Italia che nel corso dei secoli hanno restituitomoltissimi relitti di navi antiche, con i loro carichi di prodotti del-l’epoca ma anche capolavori assoluti dell’arte come i Bronzi di Ri-ace o il Satiro Danzante. Il programma di ricerca, denominato “Ar-cheomar”, è stato lanciato dal ministero dei Beni culturali e finan-ziato con 7,5 milioni di euro. Soldi ben spesi, a quanto pare, per-ché sono stati rinvenuti reperti di un’importanza eccezionale checontribuiranno non solo ad accrescere le nostre conoscenze scien-tifiche e storiche, ma anche a favorire nuove iniziative per la tuteladel nostro patrimonio e persino programmi di sviluppo per il turi-smo subacqueo.Le risorse sono servite non solo a sostenere i costi delle ricerche inmare – che hanno visto impegnate oltre 100 persone tra archeo-logi, biologi marini e operatori subacquei – ma anche a creare unsistema efficiente e facilmente aggiornabile di gestione delle co-noscenze sul patrimonio. Tra gli obiettivi raggiunti da ArcheoMar,anche quello di mettere a punto una metodologia di lavoro chepossa essere esportata in altri contesti, con un eventuale svilupponel campo del turismo culturale, oltre ovviamente che in quellodella tutela. Inoltre, l’impostazione metodologica della Carta Ar-
NAUTES
cheologica del Rischio Subacqueo, prevista nel progetto, si è av-valsa di un sistema informatico e cartografico all’avanguardia, de-stinato anche a fare da collettore per il recupero e la valorizzazio-ne di dati provenienti da indagini precedenti.Orientato nelle acque di Campania, Calabria, Basilicata e Puglia, ilprogetto ha portato, su oltre un migliaio di indicazioni ottenute intutte le fasi della ricerca, alla scoperta e alla documentazione diben 275 siti, di cui 96 si trovano in Calabria, 79 in Campania, 3 inBasilicata e 97 in Puglia. In particolare, durante le indagini sui fon-dali del Mediterraneo, sono stati individuati 58 relitti sommersi,con un orizzonte cronologico che spazia dai vettori commercialiromani, carichi di anfore da trasporto, alle navi medioevali, fino airelitti di navi militari della Prima e della Seconda guerra mondiale.
La tecnologiaIl progetto, che è stato affidato a otto imprese sulla base di unagara internazionale (capofila del raggruppamento è la Nautilus diVibo Valentia), ha comportato l’utilizzo delle più sofisticate attrez-zature per l’esplorazione archeologica subacquea mai usate nel108
109
Mediterraneo. Dove possibile, il sito è stato indagato anche sot-t’acqua per realizzare un’adeguata documentazione fotografica evideo.Punta di diamante dell’apparato tecnologico al servizio del proget-to ArcheoMar è stata la nave oceanografica Minibex, che ospita ilsommergibile tascabile Remora, capace di isolare in una cabina tec-nologica sul fondo del mare uno studioso, oltre al pilota, conun’autonomia di 10 ore e dotato di un mini robot filoguidato cherimanda al monitor dell’unità di appoggio, immagini in diretta dalfondo del mare. Della flotta a disposizione del ministero hanno fat-to parte anche altre due navi, la Janis e la Copernaut. Sono statiimpiegati anche i Rov (Remotely operated vehicle, cioè Veicolo acontrollo remoto), mezzi subacquei manovrati a distanza, per lopiù filoguidati. L’acqua, infatti, non consente la propagazione delleonde radio e perciò esclude la possibilità di governare il veicolo tra-mite un radiocomando. Il Rov viene quindi controllato per mezzo diun cavo (che di solito serve anche ad alimentarlo) oppure tramiteonde acustiche che, a differenza di quelle radio, si propagano inacqua piuttosto efficacemente anche se per distanze limitate. Per rendere immediatamente utilizzabili i dati risultanti dalla ricer-ca è stato previsto il loro inserimento all’interno di un sistema Gis(Sistema informativo geografico), che consentirà di integrare lefunzioni di analisi statistica, con i vantaggi della visualizzazione edell’analisi geografica forniti dagli strumenti di disegno cartografi-co. Le aree individuate sono state scandagliate con un side scansonar, che permette di rilevare la reale estensione dell’oggettosommerso. Al sonar è abbinato un magnetometro per rilevare lapresenza di metalli. La fase di rilevamenti e prospezioni dirette in mare si è stretta-mente legata alla successiva interpretazione e restituzione dei da-ti. Tutti i siti individuati sono ora posizionati con precisione grazieal rilevamento satellitare eseguito con il sistema Gps.
Le scoperteOra che Archeomar è giunto al completamento della “fase 3”(classificazione e valutazione dei reperti rinvenuti), sono state rea-lizzate centinaia di schede che contengono la cartografia di base,foto, informazioni e altri dati che finiranno in un sito web in fase
RIAFFIORA L’ANTICHITÀ DALLE ACQUE DEL SUD
di allestimento. Sarà realizzato anche un corposo atlante cartogra-fico e fotografico dei siti archeologici sottomarini scoperti. Alla fi-ne del progetto, la banca dati realizzata grazie ad Archeomar saràuno strumento efficace per la conoscenza e la tutela di un ecce-zionale patrimonio che si trova ancora nei nostri mari e sarà con-divisa con tutti gli organi deputati al controllo delle acque: Armadei Carabinieri, Guardia di finanza, Capitanerie di porto e Guardiacostiera.A illustrare i primi risultati del progetto è stato il ministro per i Be-ni e le Attività culturali, Giuliano Urbani. «Grande ricchezza di re-litti – ha spiegato il ministro – li ha offerti il mare della Puglia, maanche l’isola di Capri ha riservato straordinarie sorprese. Un talelavoro servirà non solo a scoprire la ricchezza dei nostri mari ma ariqualificare il turismo. Il ministero, nell’ambito del progetto, si im-pegna a recuperare quei relitti ritenuti eccezionali dagli stessi ar-cheologi che stanno lavorando al programma di censimento e diricerca».Come detto, i relitti individuati durante il progetto Archeomar ri-guardano tre epoche: romana, medievale e moderna. Al largo del-le isole Tremiti, in Puglia, è stato individuato ad esempio un galeo-ne veneziano del ‘500. I fondali più generosi, però, si sono dimo-strati quelli campani, in prossimità di Capri. Nelle acque che cir-condano l’isola sono stati fatti tre ritrovamenti di età romana, risa-lenti a quasi 2.000 anni fa. Il primo relitto giace un fondale sab-bioso a una profondità di 92 metri e presenta un carico di anforetripolitane riferibili al I secolo dopo Cristo.Trovato poi un giacimento archeologico che si eleva dal fondaleper oltre 3 metri a 128 metri di profondità ed è composto da al-meno cinque tipologie di anfore differenti e per la quasi totalità dicontenitori impiegati per il trasporto e il commercio della frutta.Anche questi sono databili al I secolo dopo Cristo. Al IV secolo do-po Cristo, invece, risalgono tre anfore provenienti dalle coste tuni-sine che contenevano una salsa a base di pesce, il “Garum”, uti-lizzata come condimento e salatura per i cibi. Infine, il relitto diuna imbarcazione del XVIII secolo, trovato nelle acque di Procida,chiamato “relitto dei marmi” proprio perché trasportava marmimolto antichi probabilmente provenienti da monumenti di epocaromana.
110
111
COMUNICAZIONE,RUOLO E PUBBLICA UTILITÀ
Valentino Guidi
La legge 150 del 2000 ha modificato radicalmente il rapportoburocratico e autorefenziale della Pubblica amministrazione coni cittadini utenti. Il sistema marittimo ne ha beneficiato. Per ogniorganizzazione è essenziale conoscere il livello di soddisfazionedei propri utenti, il customer satisfaction
Strategie di comunicazione del rischio e dellasicurezza: possibili applicazioni al sistema marittimoIn un settore con peculiarità specifiche, come quello di nostro in-teresse, è estremamente complesso definire modelli di comunica-zione efficaci per ciò che potremmo definire il “sistema maritti-mo”, nel quale oggi intervengono-convergono molteplici attoriistituzionali e non, deputati al governo e la regolazione del setto-re. Tale contesto è oggi estremamente mutevole alla luce d’inter-venti che vedono agire soggetti cosiddetti “sopranazionali” e altrasferimento di funzioni relative la medesima area di competen-za, per non parlare del già “frammentato” scenario di riferimento. In questo contesto, così articolato, appare difficoltoso definire oquantomeno sperimentare, un modello di riferimento di comuni-cazione pubblica relativo ai rischi applicabile al sistema marittimointeso nel suo complesso. Ma potremo evidenziare, prendendo inconsiderazione una specifica area d’interesse (quella della sicurez-za della vita sul mare), quali siano i fattori che intervengono, al fi-ne di definire la comunicazione un’attività assolutamente “neces-saria” per il miglioramento delle azioni di tutte le realtà coinvoltenel sistema.
NAUTES
In primo luogo, è opportuno rilevare che in un ambiente semprepiù mutevole (non solo per variazioni politico-istituzionali, ma an-che eventi non prevedibili come ad es. il fenomeno del terrorismo,eventi naturali ed eccezionali, ecc.), la comunicazione assume piùche in passato un ruolo rilevante, poiché attiva un flusso continuodi informazioni (intese non solo come dati aggregati) da e verso leamministrazioni interessate e costituisce il momento fondamenta-le di mediazione tra le istituzioni e i cittadini–utenti–operatori. Le azioni di “voce” sono di fondamentale importanza, poiché
consentono di cogliere le istanze prima che diventino domandaespressa e permettono la creazione di un processo dinamico diorientamento verso i bisogni finalizzato a:a) valutare se il mercato (inteso come settore di riferimento) offraalternative più efficaci alle azioni in essere; b) attivare meccanismi di valutazione che provengono dalle infor-mazioni che gli operatori danno sui servizi – prestazioni (di cui so-no destinatari);
112
113
c) assumere informazioni in modo più condiviso possibile per ilraggiungimento di obiettivi comuni (istituzioni-utenti), poichéun’informazione “condivisa” raddoppia il suo valore.A livello normativo la L. 150/2000 (legge sulla Comunicazione isti-tuzionale) ha fortemente contribuito a trasformare l’approccio bu-rocratico e autoreferenziale dell’ente pubblico in un orientamentoal mercato più attento ai bisogni dei cittadini-utenti, tramite unamaggiore “apertura” dell’amministrazione verso l’esterno. Da quil’importanza degli URP (Uffici per le Relazioni con il Pubblico) defi-niti con la L. 241/90 e rafforzati nelle funzioni con la L. 150/2000.E’ proprio da tali strutture che è utile iniziare un’analisi di come lacomunicazione diviene strumento strategico per qualsiasi policyche ha obiettivi chiari e definiti.Gli URP (art 8 L. 150/2000), insieme ad altri strumenti su cui nonci soffermeremo in questa sede (come la “carta dei servizi”, CS:“rilevazione di Customer Satisfaction” e A.I.R.: “Analisi sull’Impat-to della Regolazione”), direttamente connessi e – o derivanti dalpiù ampio concetto di comunicazione, sono divenuti indispensabili(quando correttamente utilizzati) per un’azione efficace, economi-ca ed efficiente delle pubbliche amministrazioni. L’”ascolto” è lapratica costitutiva di questi uffici (Tonetto 1998) e se utilizzato inun’ottica di “stile” di lavoro e in modo sistematico nel tempo,permette di definire una “mappatura”, non solo delle esigenze,ma anche delle carenze, al fine di attivare idonee azioni d’inter-vento e correzione delle attività dei pubblici.Gli URP, se utilizzati in modo non corretto, si riducono a meri pun-ti informativi degli apparati. Questi devono invece essere interpre-tati come uffici che svolgono attività di comunicazione a 360°,quindi comunicazione esterna ma anche interna e soprattutto “in-ter-istituzionale” come ad es. i canali d’interazione-relazione tragli URP di ministero Trasporti, ministero del Welfare, Inail, Guardiacostiera, Ipsema, ecc. Sono loro i front-office delle amministrazio-ni, le cosiddette “prime linee” che operano nel rispetto dello stru-mento “carta dei servizi”, che non devono limitarsi a “facilitare”,ma devono “garantire” l’accesso ai servizi-prestazioni delle Pubbli-che amministrazioni da parte dei cittadini, operatori, utenti.Tale premessa, contenente alcuni principi alla base della L. 150/2000,ci permette ora di approfondire alcuni aspetti della comunicazione
COMUNICAZIONE, RUOLO E PUBBLICA UTILITÀ
applicabile al sistema marittimo, e in particolar modo all’area rela-tiva il rischio e la sicurezza su cui è utile soffermarci.Una distribuzione corretta, tempestiva e capillare delle informazio-ni sui rischi e sulle misure utili a limitarli, è un aspetto fondamen-tale sia della prevenzione, sia di una gestione efficace dell’emer-genza stessa. Comunicare il rischio assume una duplice valenza:da un lato il mittente dialoga con il destinatario informandolo,dall’altro il destinatario comunica necessarie informazioni al mit-tente. Il feed back diviene quindi fondamentale al fine di delineareun quadro generale nel quale agire in modo opportuno.Per comunicazione del rischio s’intende lo scambio che si verificanel momento in cui un rischio percepito è valutato, gestito e co-municato, in un contesto nel quale gli attori principali sono le Am-ministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali, gli esperti, glioperatori, ecc. I contenuti propri di tale scambio riguardano la de-finizione del rischio e, sulla base delle conoscenze disponibili, leconseguenze dirette e indirette che questo può determinare per lasalute, ma anche le decisioni, le azioni e le politiche finalizzate allagestione di tale rischio, sia quelle in essere, sia quelle potenzial-mente utili da attivare (Covello e Allen, 1986).La comunicazione del rischio costituisce un messaggio estrema-mente delicato da gestire, a prescindere dal fatto che esistono, so-prattutto nel contesto di riferimento, molteplici rischi di natura di-versa che coinvolgono emittenti e destinatari differenti. Ogni azio-ne di comunicazione deve essere quindi accompagnata da un at-tento lavoro di valutazione che deve necessariamente prendere inconsiderazione un’analisi della “percezione” del rischio a tutti i li-velli, soprattutto dal punto di vista dei destinatari dei messaggistessi, al fine di:a) cogliere idee, spunti e suggerimenti da parte dei destinatari; b) cogliere le domande cosiddette “latenti” (inespresse); c) definire il livello di coinvolgimento e partecipazione del destina-tario all’azione;d) “dimensionare” il messaggio a misura del destinatario finale; e) creare nuove e più moderne forme di partecipazione degli uten-ti alla prestazione–servizio.Ciò su cui i modelli tradizionali si basano è una rappresentazionedel rischio che ingenuamente si affida alla trasmissione di dati e ri-
114
115
sultati scientifici, questi sono considerati sufficientemente semplicida essere compresi e accettati dai destinatari del messaggio (Stir-ling, 1998). Quel che la letteratura sull’argomento quasi mai af-fronta è l’aspetto relativo la costruzione discorsiva dei rischi chevanno comunicati, soprattutto la loro traduzione tra contesti e sog-getti coinvolti (Demaria e Todesco, 2001). Questo vale per qualsiasifase del processo che circonda e precede la comunicazione del ri-schio: il processo stesso di valutazione è influenzato da elementinon scientifici che riguardano il livello di significatività di uno speci-fico rischio e ciò che deve essere considerato come rilevante.
COMUNICAZIONE, RUOLO E PUBBLICA UTILITÀ
Se infatti da una parte troviamo gli esperti la cui percezione è so-stanziata da ricerche e dati scientifici, da un’attività cioè di riskevaluation, dall’altra troviamo i destinatari a loro volta suddivisibiliin soggetti colpiti (coloro che sentono di essere potenzialmentesoggetti al rischio) e soggetti responsabili (istituzioni competenti)coinvolti nel processo di risk management (Demaria e Todesco,2001). “Scambiare” e definire il messaggio in modo dinamico tra ivari attori permette di assumere decisioni e definire gli interventinel modo più condiviso e “partecipato” possibile.Il raggiungimento di una conoscenza ottimale delle problematicheconnesse al rischio da parte di un ente preposto alla sua gestione,può essere visto come un problema di comunicazione efficace tra idiversi attori coinvolti: comunicare un rischio significa definirlo efornire un’interpretazione, che deve essere possibilmente “persua-siva”, cioè in grado di indurre cambiamenti nelle azioni dei desti-natari. Una volta che si valuta l’esistenza del rischio e la si comuni-ca, si auspica l’adesione da parte dei destinatari del messaggio amodifiche del comportamento per la loro salvaguardia. Sfortunatamente, benché si riscontri un elevato interesse da partedei destinatari, non sempre a tale interesse corrisponde il compor-
116
117
tamento suggerito dall’istituzione (Gregory, 1995). È quindi neces-sario un tipo-modello di comunicazione che miri ad ampliare laconsapevolezza e la percezione del rischio dei destinatari, oltre auna maggiore cooperazione da parte dei diversi attori coinvolti dalrischio e dalla sua gestione.Non meno importante che comunicare l’emergenza e il rischio, ècomunicare la sicurezza. Anzi. Studi-progetti realizzati (Ipsema)confermano che il fattore della fiducia e della sicurezza sono stret-tamente connessi e intervengono nell’ambito dell’incidenza sugliinfortuni: svolgere il proprio lavoro percependo un clima di sicu-rezza influenza lo status psicologico del soggetto; al contrariostress, burn out ecc, condizionano la fiducia-insicurezza dell’indivi-duo che può essere potenzialmente più soggetto a errore umano.Comunicare sicurezza diviene necessario, specialmente in un am-biente atipico dove molteplici fattori di rischio caratterizzano l’at-tività lavorativa e anche lo stile di vita degli individui-operatori ma-rittimi. Per questo l’offerta di sicurezza deve essere comunicata at-traverso una precisa strategia che punti a far coincidere la sicurez-za percepita con la sicurezza reale (Rizzo, 2003), è il feed back diun corretto sistema comunicativo che dovrebbe caratterizzare l’a-zione delle istituzioni preposte, al fine di attivare un processo co-noscitivo dell’effettiva portata delle azioni intraprese e spingere gliindividui verso modifiche del comportamento. L’innovazione tec-nologica, poi, diviene utile supporto e moltiplicatore d’efficacia edefficienza dello strumento comunicazione, e l’utilizzo appropriatodelle NTI (Nuove Tecnologie dell’Informazione) risulta strategicoper produrre sicurezza “percepita”.Il sistema marittimo è oggi soggetto a una progressiva e continuarevisione alla luce di nuovi e molteplici fattori esterni–interni, tra iquali possiamo indicare:
Esternia) la spinta proveniente dalla realtà europea;b) le riforme istituzionali: il federalismo e le sue conseguenze sulsettore produttivo, industriale e finanziario;c) le ristrutturazioni dei vari comparti produttivi, liberalizzazioni ele inevitabili alleanze europee;d) il mercato del lavoro in continua trasformazione;
COMUNICAZIONE, RUOLO E PUBBLICA UTILITÀ
Internia) il fattore ecologico–ambientale;b) l’emergenza terrorismo;c) l problema dell’esposizione all’amianto dei lavoratori marittimi;d) l’integrazione-inclusione nel sistema lavoro di cittadini immigra-ti sempre più numerosi anche nel settore marittimo con notevoliproblematiche comunicative;e) la riduzione del gap tra chi è abilitato tecnologicamente e chi no.Questi fattori interessano direttamente-indirettamente il sistemamarittimo. In particolare quelli interni sono strettamente connessial rischio e necessitano di un’idonea attenzione vista la “sensibili-tà” dei messaggi da comunicare, poiché implicano non solo con-seguenze sociali, ma anche politiche ed economiche. Per concludere, possiamo affermare che un’idonea comunicazionedel rischio e della sicurezza si pone come utile strumento di pre-venzione per la salvaguardia della salute degli operatori, nonchéper il miglioramento delle prestazioni degli apparati, e deve farparte delle strategie di gestione di policy di prevenzione basatesull’ascolto e la partecipazione degli utenti–operatori, poiché ac-celera, promuove e diffonde quei principi di “cultura del servizio”e di “responsabilità” sui cui si basano i moderni sistemi di cittadi-nanza europea.
Il concetto di Customer Satisfactionnella Pubblica amministrazionePer ogni organizzazione che voglia migliorare la qualità dei servizierogati, è opportuno conoscere il livello di soddisfazione dei pro-pri utenti. A tal fine, uno degli strumenti più utilizzati è la rileva-zione della qualità percepita, anche denominata “indagine di cu-stomer satisfaction”. Le Amministrazioni pubbliche, oggi in particolar modo, sono chia-mate a garantire una molteplicità di servizi in settori diversi, diconseguenza necessitano d’introdurre modalità di “ascolto” siste-matico, poiché è solo tramite tale conoscenza che queste possonosvolgere in modo più efficace le proprie funzioni e comprenderemeglio i destinatari ultimi delle attività. Nelle organizzazioni che operano in regime di concorrenza e dimercato, la leva che spinge a sviluppare un sempre maggiore
118
119
orientamento verso il consumatore è la ricerca della “competitivi-tà”: l’impresa privata ha infatti bisogno di un consumatore soddi-sfatto, di un cliente fidelizzato. Alla base della relazione tra citta-dino e amministrazione vi è la necessità di rispondere in modo ap-propriato ai bisogni, la risposta a questa necessità è sentita comeun diritto da parte del cittadino e un dovere da parte dell’ammini-strazione (Tanese, Negro, Gramigna 2003).L’interesse per questo tema è da ricercarsi verso la fine degli annisessanta negli Stati Uniti, gli studi furono intrapresi allo scopo dianalizzare le performance dei mercati nel soddisfare i bisogni deiclienti–utenti, e rispondere soprattutto alla pressione esercitatadalle associazioni dei consumatori (fenomeno del consumerism).Negli anni Ottanta, poi, il concetto di qualità era riferito prevalen-temente agli aspetti “tecnici” del prodotto–servizio erogato, cioèalle dimensioni “oggettive” che interessavano prevalentemente
COMUNICAZIONE, RUOLO E PUBBLICA UTILITÀ
l’area produttiva dell’organizzazione. Tale concetto, dagli anni Ot-tanta in poi si è evoluto e arricchito di nuove dimensioni quali:a) performance funzionale; b) durata media; c) affidabilità; d) assistenza; e) qualità percepita.La realizzazione di un’indagine di CS può essere finalizzata a: a) valutare l’efficacia di specifiche politiche pubbliche; b) progettare nuovi sistemi di erogazione dei servizi; c) rappresentare – evidenziare i bisogni – attese dei cittadini;d) facilitare il superamento dei vincoli interni gli apparati;e) definire in modo strategico nuovi pacchetti di servizi o interven-ti di miglioramento su pacchetti già esistenti.Per ciò che concerne “l’impatto” della CS sull’Amministrazionepubblica, questa può costituire una leva d’accelerazione al cam-biamento degli aspetti culturali, organizzativi e tecnici se attuata
120
121
in alcune fasi della vita dell’organizzazione, quando la CS esprimemaggiormente le proprie potenzialità, vale a dire:a) quando si definiscono le zone d’intervento: nei momenti discelta e pianificazione, sentire la voce dell’utente è di fondamen-tale importanza;b) quando s’intende valutare l’impatto d’interventi di migliora-mento del servizio;c) quando s’impostano gli strumenti di valutazione e controllo.La CS è dunque uno strumento di gestione e valutazione dellestrutture, delle persone e delle competenze presenti, delle tecno-logie utilizzate, dei processi seguiti, delle risorse impiegate e, ap-punto, dei risultati prodotti. Occorre perciò che le amministrazionidiventino consapevolmente orientate a questa modalità di gestio-ne dell’organizzazione e capaci di dare valore al punto di vista delcittadino, introdotto nell’ambito dell’organizzazione come forzaspinta per un miglioramento delle modalità di funzionamento deiprocessi di lavoro.Lo svolgimento di un’indagine di CS implica un iter che si articolain quattro fasi:a) preparazione della rilevazione;b) raccolta dei dati;c) elaborazione e interpretazione delle informazioni;d) rappresentazione e utilizzo dei risultati.Questo processo permette di confrontare i risultati nel corso d’in-tervalli significativi di tempo e quindi consente di misurare la ca-pacità d’innovazione di un’amministrazione, la CS assume cosìuna duplice valenza: da un lato è una cultura e un modo di esseredell’organizzazione, dall’altro è un processo di comunicazione erelazione con gli utenti, solo queste due dimensioni assicurano lacaratteristica della policy. È importante che la rilevazione sia strutturata in modo da poterassociare le informazioni alle specifiche caratteristiche del servizio,così che ogni elemento di successo-insuccesso del servizio può es-sere rispettivamente confermato-potenziato oppure ridotto-elimi-nato (CNEL 1998). Le rilevazioni devono soddisfare in primo luogodue caratteristiche operative:a) rilevare le priorità espresse dai cittadini (qualità attesa);b) rappresentare il livello di soddisfazione dei cittadini (qualità per-cepita).
COMUNICAZIONE, RUOLO E PUBBLICA UTILITÀ
Una buona amministrazione persegue i suoi obiettivi nel rispettodei principi d’efficienza, efficacia ed economicità. L’ascolto e lapartecipazione diventano quindi elementi fondamentali poichéconsentono di costruire decisioni in modo condiviso. A decisionigià assunte, a servizi erogati, la partecipazione diventa uno stru-mento di valutazione dell’azione pubblica e quindi potenziale dimiglioramento, d’efficacia e di qualità. L’ascolto diventa il criterioper ridefinire l’amministrazione, i suoi attori e i rispettivi ruoli, lecompetenze necessarie e quelle importanti, le modalità per co-struire i processi di lavoro e i criteri per valutare i risultati. Se le indagini di CS assumono rilievo nell’ambito di apposite stra-tegie, ne consegue che la responsabilità della scelta sull’utilizzo diquesti strumenti deve spettare, in prima battuta, ai decisori: i ver-tici politici e amministrativi degli enti. La motivazione della diri-genza si riverbera sul tasso d’intervento: tanto più è alta la primatanto maggiore sarà la spinta e la profondità del secondo, intesocome il complesso delle azioni che l’organizzazione produce inconseguenza degli input ricevuti. All’amministrazione si chiede di cambiare profondamente il mododi lavorare ma anche i criteri in base ai quali giudicare i risultatiottenuti: se fino a qualche tempo fa era la conformità alle regolee a un comportamento lavorativo prescritto e consolidato a defini-re l’attività di un lavoratore pubblico, oggi l’assunzione dell’orien-tamento all’utente come criterio di valutazione dei servizi cambiale regole del gioco, impone all’amministrazione di saper affrontarei cambiamenti e l’incertezza, i nuovi bisogni e le nuove dinamichedi mercato, non sempre prevedibili. Non è un cambiamento di poco conto né un risultato che possia-mo attenderci nel breve volgere di qualche stagione. Per realizzaretutto questo occorre, certo, una strategia e una precisa aspettati-va da parte dei dirigenti capace di tradursi, però, anche in stru-menti, professionalità e servizi in grado di interpretarli e di attuarliin tutta l’organizzazione.Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Commissione europeaper lo sviluppo delle politiche sulla qualità, è stato realizzato ilprogetto ECSI (2001-2006), nato dall’esigenza di sviluppare e pro-muovere una cultura della CS. A tale iniziativa hanno aderito un-dici paesi dell’Ue e globalmente sono state effettuate 59.000 in-
122
123terviste con questionari unificati per settore merceologico (telema-tico, banche e supermercati). il Comitato tecnico internazionale,costituito da esperti della materia, ha elaborato un modello di ri-ferimento dai cui risultati è emerso un quadro differenziato in ter-mini di livello medio di soddisfazione, con posizioni eterogeneemotivate oltre che dal reale livello di soddisfazione, anche dall’in-fluenza di alcuni aspetti culturali. In una fase successiva gli obietti-vi che il progetto si propone di realizzare sono:a) creare un sistema omogeneo di rilevazione della CS in Europa;b) educare le imprese alla visione dei clienti “fidelizzati”;c) fornire indicazioni per il miglioramento della competitività;d) sollecitare la correlazione tra soddisfazione del cliente e perfor-mance economica dell’azienda;e) analizzare la relazione tra indici globali di CS e sviluppo econo-mico regionale e nazionale;Volendo tracciare un quadro, non sembra esista ancora una vera epropria “opinione pubblica europea”, e dunque occorre adattareil messaggio in funzione delle specificità del pubblico cui è indiriz-
COMUNICAZIONE, RUOLO E PUBBLICA UTILITÀ
zato. In futuro, si auspica un incremento del livello di fiducia, gliutenti sapranno quali risorse l’amministrazione mette in campo, inche modo sono utilizzate, quali risultati si conseguono; un aumen-to di fiducia sarà dovuto soprattutto al diffondersi della culturadell’e-governament. Nei prossimi anni le aree prioritarie d’inter-vento dell’amministrazione saranno:a) il sostegno alle famiglie; b) interventi finalizzati a migliorare la sicurezza delle città;c) la sanità;d) Il sostegno alla popolazione anziana sempre più bisognosa; e) l’insorgenza di problematiche legate a nuove povertà; f) l’accoglienza dei cittadini extracomunitari.Si avrà una diffusione della “digitalizzazione” dei sistemi dellaPubblica amministrazione, secondo il principio della e-democrazy,grazie al coin-volgimento ditutte le istitu-zioni centrali egli enti locali.Le attese deic i ttadini cre-sceranno spin-te da bisognisempre p iùevoluti, ma siat tenuerà i lgap tra aspet-tativa di servizie offerta effet-tiva, non saràun migl iora-mento appa-rente, ma unc o m p l e s s i v omiglioramentodella “perce-zione” del ser-vizio, dei pro-
124
125
cessi e della capacità di leggere i bisogni; le modalità di distribu-zione saranno semplificate e migliorate anche grazie alla costitu-zione di:a) punti informativi e di erogazione di servizi unificati;b) punti unici di accesso alla Pa indifferenziata;c) multicanalità;d) aggregazione di servizi accessibili con un’unica richiesta.La pianificazione e il controllo di servizi erogati faranno sì che ilruolo dell’amministrazione, e in particolare degli enti locali, si spo-sti da quello di gestore diretto di servizi a quello di responsabiledel soddisfacimento dei bisogni delle comunità amministrate.Questo consentirà di sviluppare l’applicazione effettiva del princi-pio di sussidiarietà. In sintesi le sfide che l’amministrazione dovràvincere nei prossimi anni sono:a) raggiungimento di standard di qualità e personalizzazione deiservizi;b) efficace comunicazione pubblica;c) maggiore qualità urbanistica e ambientale; d) definizione del proprio ruolo di gestione dell’interesse pubblicoall’interno dei nuovi meccanismi di partecipazione dei cittadini;e) garanzia della sicurezza dei dati personali: privacy;f) costruzione di un nuovo modello di welfare locale. Legata al raggiungimento dei suddetti obiettivi vi è la costruzionedi una “cultura orientata al servizio”: oltre alla riprogettazione dellavoro (Rovinetti 1992), deve crearsi una nuova relazione con gliutenti: si tratta di valorizzare non solo nella società, ma anche nelrapporto con l’amministrazione, “le risorse di cui sono dotati i cit-tadini”. Vuol dire istaurare un rapporto basato sulla fiducia e sulrispetto dell’autonomia di tutti i soggetti coinvolti, una culturarealmente orientata al servizio richiede istituzioni e cittadini re-sponsabili e consapevoli che il “servizio” è l’erogazione di un’atti-vità per lo più “immateriale”, prestata da persone per l’utilità-sod-disfazione di altre persone. Per concludere, possiamo affermareche oggi la vera opportunità è offerta dal riconsiderare il consu-matore in una prospettiva più completa, il concetto della Custo-mer Satisfaction evolve nella Human Satisfaction, dove il raggiun-gimento degli obiettivi è ottenuto, oltre che tramite il soddisfaci-mento di specifici bisogni, anche attraverso la creazione di una re-
COMUNICAZIONE, RUOLO E PUBBLICA UTILITÀ
lazione di fiducia con l’essere umano-cliente”. Il rapporto fra l’am-ministrazione e il proprio pubblico attuale e potenziale si evolverànella direzione di una maggiore considerazione del tessuto relazio-nale e della conseguente area della loyalty, anche perché, conside-razioni etiche a parte, le stesse amministrazioni non potranno nonrendersi conto che una nuova filosofia di “ascolto” non potrà cheportare benefici di efficienza, quale conseguenza di un rinnovatospirito di servizio. Un’amministrazione human oriented, potrà ave-re più valore di un’amministrazione customer oriented, poichél’atto di consumo rappresenta solo una porzione e non il tutto.Per approfondimenti sugli aspetti normativi:Dir. Min. Funz. Pubblica 07/02/2002 (rilevazione della qualità per-cepita)Legge 281 del 30/07/1998 (tutela dei consumatori) Legge 150 del 07/06/2000 (comunicazione istituzionale)
126
127
L’ATTIVITÀ ASSICURATIVA DELL’IPSEMA PER LA NAUTICA DA DIPORTO
Roberta Bencini
Con lo sviluppo della nautica da diporto rilevato, tra l’altro, dalministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e riportato nel “III Rapportosull’economia del mare” (edizione 2006), si rileva un incrementodell’attività assicurativa dell’Ipsema. In termini assoluti, il volumedell’attività esercitata dall’Istituto di previdenza rimane, comunque,ancora limitato, in quanto l’obbligo assicurativo riguarda i soli equipaggidotati di libretto di navigazione e arruolati
L’Ipsema è l’Ente di riferimento per l’assicurazione obbligatoria de-gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali per gli equi-paggi dotati di libretto di navigazione e arruolati sulle navi e le im-barcazioni da diporto, con qualunque mezzo di propulsione, desti-nate alla navigazione senza scopo di lucro o impiegate in attivitàdi noleggio. La distinzione tra nave e imbarcazione da diporto viene fatta sullabase della lunghezza dello scafo: per nave s’intende ogni unitàcon scafo di lunghezza superiore a 24 metri, per imbarcaziones’intende invece ogni unità con scafo di lunghezza compresa tra10 e 24 metri.Un significato più ampio viene dato all’unità da diporto, definitacome ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzodi propulsione, che comprende quindi al suo interno sia navi e im-barcazioni da diporto, che mezzi con lunghezza dello scafo infe-riore ai 10 metri, cosiddetti natanti.L’Istituto di previdenza segue con interesse lo sviluppo della nauti-ca da diporto, argomento frequentemente trattato dalla stampa, e
I DOCUMENTI
NAUTES
la recente pubblicazione del “III Rapporto sull’economia del mare”(edizione 2006), realizzato dal Censis per la Federazione del Mare,fornisce dati seppure riferiti al 2004 che confermano l’espansionedel settore, nonostante i problemi legati al numero di posti barcadisponibili, all’organizzazione dei servizi portuali e alla necessità dipotenziare il sistema di collegamento tra i porti turistici e il retro-terra. Dai dati riportati nella suddetta pubblicazione, provenienti preva-lentemente dalle rilevazioni del ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti, emerge:• una crescita media annua dei posti barca, per qualsiasi lunghez-za dello scafo, tra il 2000 e il 2004, di circa il 3,7%;• un aumento medio annuo del numero di unità da diporto iscrit-te negli Uffici marittimi, tra il 2001 e il 2004, pari allo 0,8%;• la presenza media di 8 unità da diporto ogni 1.000 abitanti, cheha permesso all’Italia di collocarsi nel 2004 al 3° posto dopo Fran-cia e Croazia tra i Paesi del Mediterraneo;• un notevole sviluppo della produzione nazionale delle unità dadiporto e dell’import destinati al mercato italiano, che complessi-vamente tra il 2003 e il 2004 hanno fatto registrare un aumentodi oltre il 30% (fonte: Ucina-Unione nazionale dei cantieri e delleindustrie nautiche e affini). Se si esaminano i dati in valore assoluto, con riferimento alle soleunità da diporto con lunghezza dello scafo superiore ai 10 metri,quindi imbarcazioni e navi, risulta che al 31/12/2004:• l’Italia disponeva di circa 30.000 posti barca per le imbarcazioni(circa 25.300 nel 2003) e oltre 4.200 per le navi (circa 2.000 nel2003);• le imbarcazioni da diporto, sia a vela che a motore, iscritte negliUffici marittimi italiani erano poco più di 30.500, le navi erano148. Passando ora ai dati dell’Ipsema, si rileva che lo sviluppo medioannuo delle unità da diporto assicurate, sia navi che imbarcazio-ni, tra il 2002 e il 2005 è risultato pari al 13%. A una crescitapercentuale interessante si accompagnano però valori assolutiparticolarmente contenuti, come si può verificare dal grafico chesegue.
128
129
Nel 2004, anno per il quale è possibile fare i confronti tra i dati del-l’Ente di previdenza e i dati sul mercato riportati nel “III Rapportosull’economia del mare”, le unità assicurate dall’Ipsema erano sol-tanto 786, pari a circa il 2,5% delle imbarcazioni e navi che, nellostesso anno, risultavano iscritte presso gli Uffici marittimi italiani.Nel passaggio dal 2004 al 2005 si è verificato un incremento di123 unità assicurate (+15,6%). Circa il 76% delle unità assicurate
I DOCUMENTI
L’ATTIVITÀ ASSICURATIVA DELL’IPSEMA PER LA NAUTICA...
GRAFICO 1
GRAFICO 2
nel 2005 faceva riferimento alla sede di Genova, il 12% a quella diNapoli, il 10% a Trieste e il rimanente 2% alla sede di Palermo.La sede compartimentale di Genova cura l’attività dell’Istituto perl’area dell’alto e medio Tirreno. La sede di Napoli gestisce l’areadell’Adriatico meridionale, dello Jonio e del Tirreno meridionale,inclusa la Sardegna. La sede di Trieste cura invece le attività del-l’Ipsema per l’alto e medio Adriatico, mentre quella di Palermo se-gue l’intera Sicilia. Le 909 unità che risultavano assicurate alla fine del 2005 eranostate per il 50% immatricolate nell’ultimo triennio (si veda tab.1), a conferma dell’interesse per il settore sorto anche in seguitoalla Legge 8 luglio 2003 n. 172 concernente le “Disposizioni peril riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nau-tico”.
Nel grafico 3, che segue, è evidente la forte concentrazione delleimmatricolazioni nell’esercizio 2003 e il confronto con il 2002conferma la ripresa di interesse per il diporto.Le immatricolazioni del 2005, pari a 133, riguardavano per il 56%unità costruite nello stesso anno, come si evince dalla tabella 2.L’anzianità media delle unità assicurate nel 2005, calcolata rispet-to all’anno di costruzione, era di poco inferiore a 11 anni.
130
TABELLA 1
Esercizio 2005
Anno di Unità Distribuzioneimmatricolazione assicurate %
Ante 2000 280 30,8%
2000 54 5,9%
2001 48 5,3%
2002 73 8,0%
2003 165 18,2%
2004 156 17,2%
2005 133 14,6%
Totale 909 100,0%
131
I DOCUMENTI
L’ATTIVITÀ ASSICURATIVA DELL’IPSEMA PER LA NAUTICA...
TABELLA 2
Esercizio 2005
Anno di Unità Distribuzionecostruzione immatricolate %
nel 2005
Ante 2000 24 18,0%
2000 3 2,3%
2001 3 2,3%
2002 2 1,5%
2003 6 4,5%
2004 20 15,0%
2005 75 56,4%
Totale 133 100,0%
GRAFICO 3
GRAFICO 4
Al valore medio dell’anzianità delle unità da diporto assicuratehanno contribuito, anche se con effetto opposto:• le unità costruite tra il 2003 e il 2004, pari a ben il 25% del to-tale assicurato (si veda tab. 3), espressione della dinamica del set-tore,• le unità costruite da oltre 25 anni, pari al 12%, che hanno spin-to verso l’alto il valore medio.
I posti di lavoro assicurati nel 2005 erano pari a 1.688 (si veda ilgrafico 5). Tra il 2002 e il 2005, i posti di lavoro sono aumentatimediamente del 10%, contro un incremento medio annuo delleunità da diporto del 13%. Tra il 2003 e il 2005 si è verificata una diminuzione del numeromedio di posti assicurati per unità da diporto, che è passato da2,07 posti a 1,86.In conclusione, la significativa crescita percentuale dell’attività as-sicurativa, rilevata nell’ultimo triennio, indica che lo sviluppo delsettore ha avuto impatto anche sull’attività dell’Ipsema, seppure ivolumi rimangono estremamente ridotti.
132
TABELLA 3
Esercizio 2005
Anno di Unitàcostruzione assicurate
Ante 1980 109
1980-1989 103
1990-1999 216
2000 65
2001 41
2002 72
2003 126
2004 102
2005 75
Totale 909
133
Rimane nelle aspettative dell’Istituto l’attesa di un ulteriore incre-mento dell’attività sul diporto, non tanto con riferimento alle im-barcazioni e navi utilizzate direttamente dal proprietario, per lequali la legge prevede che per alcuni servizi di bordo ci si possaavvalere delle persone imbarcate in qualità di ospiti, quanto perle unità impiegate in attività di noleggio e per le navi destinateesclusivamente al noleggio per finalità turistiche, la cui attività ri-sulterebbe in sviluppo e per le quali è necessario un vero equi-paggio. L’importanza dei temi legati ai rischi del lavoro ha portato l’Ipsemaa partecipare fattivamente alla battaglia contro il sommerso, perridurre la precarietà e aumentare la sicurezza in mare, assumendorecentemente l’iniziativa di ridurre sensibilmente le aliquote con-tributive sulla base delle quali i proprietari di imbarcazioni e navida diporto sono tenuti a corrispondere i contributi per l’assicura-zione contro gli infortuni e le malattie professionali.
I DOCUMENTI
L’ATTIVITÀ ASSICURATIVA DELL’IPSEMA PER LA NAUTICA...
GRAFICO 5
135
NAUTES
Il nuovo Darwin va per i mari a cercare l’albero genealogicodella vitaMedico e genetista, occhi azzurri, barba grigia da marinaio, rolexd’oro e 25 lauree honoris causa J. Craig Venter, dopo essere statoalla fine degli anni ’90 il protagonista assoluto del sequenziamen-to del Dna ha ora deciso di andare per mare. Ma non in vacanza.Anzi, a bordo dello yacht-laboratorio Mago II, da 5 milioni di dol-lari e con una spedizione da 14 milioni di dollari, ha deciso di an-dare a pesca di microrganismi marini per raccogliere e classificar-ne i genomi e completare, così, l’albero genealogico dell’evolu-zione. Si è dato quattro anni di tempo, per rivoluzionare la scien-za. Al termine di questa spedizione si propone di presentare agliscienziati un mappamondo dei geni digitale, con l’indicazioneprecisa dei luoghi dove saranno stati raccolti i singoli reperti ge-netici. Il mappamondo, così formato, servirà a colmare definitiva-mente tutte le lacune della storia dell’evoluzione, a completa-mento dell’opera di Charles Darwin. “Voglio rendere possibilel’impossibile e studiare tutte le forme di vita”, ha dichiarato sicu-ro di sé. Del resto ha già dimostrato di saper render facile, ciò chenon lo è per niente. Se è vero com’è vero che negli anni ’90, inappena tre anni, ha completato un’impresa; il sequenziamentodel Dna per la quale, secondo le più ottimistiche previsioni, ne sa-rebbero occorsi almeno 15. Per riuscirci ha ideato e brevettato unmetodo di sequenziamento veloce dei geni e su questo metodoha fondato un’impresa, Celera. Poi, dopo essere diventato ricco
LLEE AARRTTIIEE IILL MMAARREE
LE ONDE RACCONTANO
Mimmo Della Corte
LE ONDE RACCONTANO
136
con Celera, l’ha lasciata andando a fondare un istituto di ricercaal quale ha imposto il suo nome. Poi ha trasformato, facendoviinstallare due semplici serbatoi per l’acqua ed un impianto di fil-traggio, la sua imbarcazione in un laboratorio e insieme a unaciurma di gente simpatica, fra cui il microbiologo Jeff Hoffmann,è partito dalla Costa Orientale del Canada, sulla rotta di duegrandi esploratori dei secoli XVIII e XIV: il naturalista inglese Jo-seph Banks e Charles Darwin. «Con queste ricerche cambieremoil corso dell’evoluzione. Per il bene dell’umanità, eviteremo il col-lasso del pianeta. Troveremo soluzione al problema energetico»,assicura. Non si può certo dire, insomma, che non abbia fiducianei suoi mezzi e nelle proprie capacità. Del resto, perché non do-vrebbe averla? Ha già dimostrato di meritarsela appieno.
Anche gli antichi egizi andavano per mareFinora si era sempre ritenuto che gli antichi egizi non fossero soli-ti avventurarsi in crociere oceaniche e limitassero le proprie attivi-tà di navigazione a viaggi lungo il Nilo e lungo le coste del Delta.Errore. Gli egizi, erano in grado di navigare anche in mare aperto.E la scoperta è targata Napoli. La si deve, infatti, ai risultati scatu-riti dalla campagna di scavi sulla costa del mar Rosso, effettuatada esperti dell’Università Orientale di Napoli, guidata da RodolfoFattovich, insieme ad alcuni colleghi dell’Università americana diBoston. Durante le ricerche sono venuti alla luce i resti di alcuneimbarcazioni attrezzate per viaggi in mare aperto ed addiritturauna vera e propria base navale. La ricerca, inoltre, ha dato final-mente modo di collocare geograficamente la mitica “terra dipunt”, meta di una spedizione, passata alla storia perché descrit-ta su alcuni papiri, organizzata dalla regina Hatshepsut. Sarebbelocalizzata tra l’Etiopia e lo Yemen, a cavallo del tratto finale delMar Rosso. Ma le navi ritrovate sono ancora più antiche della re-gina Hatsheputs e sembra risalgano all’epoca del faraone Ame-nemhat III che regnò tra il 1807 e il 1797 e organizzò svariatespedizioni verso la terra Punt. Su queste hanno puntato la propria
LE ONDE RACCONTANO
137
attenzione gli archeologi napoletani e hanno scoperto che la baseoperativa per questi viaggi era collocata sulla costa del Mar Ros-so, nella zona oggi chiamata Marsa Gawasis, a una ventina di chi-lometri a sud di Port Safaga. Qui gli egizi scaricavano e caricava-no le loro merci. Qui trovavano tutto il necessario per riparare lenavi eventualmente danneggiate. In alcune caverne, infatti, i ri-cercatori hanno ritrovato in perfetto stato di conservazione il cor-dame indispensabile a manovrare le vele, casse per caricare e sca-ricare le stive, tessuti per le vele, vasellame, ancore e altro mate-riale.
Stop alla guerra del mare. ForseDomanda di chi sono le ricchezze disperse nei fondali marini? Fi-nora del primo che arrivava a metterci le mani sopra. Ora, peròl’Unesco ha deciso di mettere a punto un documento per evitare isaccheggi e la distruzione incontrollata dei relitti di nave e i tesoriche giacciono da almeno cento anni in fondo al mare. Una sortadi convenzione, sottoscritta recentemente a Parigi dall’Assembleagenerale dell’organismo internazionale li definisce infatti “patri-monio dell’umanità”, proprio come quelli presenti sulla terrafer-ma e dichiara, quindi, guerra a predatori. Ma centrare l’obiettivonon sarà facile perché Usa, Russia e Gran Bretagna non sonod’accordo. Eppure la messa a punto di questo documento ha ri-chiesto ben 4 anni di lavoro. Bisognava, purtroppo, fare i conticon diversi interessi in conflitto: i paesi, fa cui l’Italia, che inten-dono veder tutelati i tanti tesori sia storici che archeologici, sepol-ti in fondo ai loro mari; quelli di chi teme che, così facendo, si fi-nisca per impedire lo sfruttamento di tutti i tesori ittici e minerarie quelli di chi non intende porre alcun vincolo alla libertà di navi-gare, fra cui la Francia e i Paesi anglosassoni. E’ ovvio, però, cheper poter essere davvero efficace questa lotta deve poter contaresulla massima collaborazione di tutti, ma Stati Uniti, Gran Breta-gna, Norvergia, Russia e altri, hanno già detto di non essere d’ac-cordo e che non sottoscriveranno la convenzione. Il che rischia di
LE ONDE RACCONTANO
138
trasformare il documento di Parigi, in una di quelle tante “buoneintenzione” di cui “sono costellate le vie dell’inferno”. Ma dovesono questi tesori? Vediamolo:Mediterraneo – Un vero e proprio paradiso per gli archeologisubacquei. Il fondale è costellato di vecchi relitti. Finora è riuscitoa difendere i suoi tesori grazie alla notevole profondità, ma con lenuove tecnologie sarà possibile indagarlo fino in fondo;Mar Nero e Mar di Marmara – Nascondono relitti dall’età delbronzo fino a oggi. Relitti che certamente sono tuttora intatti,perché essendo i loro fondali privi di ossigeno non vi prosperano itarli marini; Artico, Antartide e Atlantico meridionale – Le Isole Falklandrappresentano il principale giacimento al mondo di navi ottocen-tesche. Sono i relitti delle navi dirette in California per parteciparealla corsa all’oro;Atlantico settentrionale – Nelle acque di Halifax, in inverno so-no naufragate intere flotte, quindi i suoi fondali sono ricchi di re-litti. Per il momento, ne sono stati scoperti già 65.000;I grandi laghi – Furono teatro di diverse battaglie durante laguerra Anglo-americana del 1812. Nei loro fondali sono stati ri-trovati relitti di vascelli ancora perfettamente conservarti;Caraibi – Da Colombo in poi, nei mari caraibici, vittime degli ura-gani, delle fortissime correnti che li attraversano e i molti scogliche vi affiorano, sono scomparse moltissime navi. Primeggiano, inquesta particolare classifica, i galeoni spagnoli che tornavano inpatria ricolmi di metalli prezioni. E’ il paradiso dei cercatori;Oceano Indiano – Dai vascelli portoghesi del Cinquecento allenavi dei commercianti olandesi, sulla via delle Indie sono naufra-gate nel corso dei secoli moltissime imbarcazioni.Mar Cinese Meridionale e Mar del Giappone – E’ ricco di relit-ti in grado di dare preziose informazioni sulle marinerie del Sud-est asiatico. Ma nascondono anche numerosi galeoni spagnoli enavi cariche di porcellane cinesi.
LE ONDE RACCONTANO
139
NAUTES
Meglio Conrad o Melville? London o Stevenson? E tra i contem-poranei chi è il miglior scrittore di storie di mare? Per gli appas-sionati di letteratura marinaresca è arrivato il momento di votarelo scrittore e il romanzo preferito. A lanciare il sondaggio lettera-rio-marinaresco via Internet – attraverso il sito www.mursia.com– è la Ugo Mursia di Milano, editore del più grande catalogo dilibri di mare in Italia, che ha recentemente presentato in libreria lanuova collana ‘Codice Internazionale dei segnali’. Quaranta sonole bandiere che compongono il Codice (ovvero il sistema di comu-nicazione universale adottato in mare) e quaranta saranno anchei titoli della nuova collana. “Per comporre quella che vuole esserela biblioteca del mare ideale ci è sembrato giusto consultare an-che i lettori. Ogni appassionato di mare ha il suo romanzo di rife-rimento e partecipando al nostro sondaggio avrà la possibilità divederlo pubblicato in questa collana che è, prima di tutto, unomaggio al mare raccontato dai grandi della letteratura: ci saran-no i classici ma anche opere non ancora pubblicate in Italia o ri-scoperte, come il bellissimo racconto di Mario Tobino, ‘L’angelodel Liponard’, che insieme ai romanzi di London, Stevenson eConrad inaugura questa nuova serie editoriale ”, spiegano dallacasa editrice. Entrando nel sito www.mursia.com si potranno dunque segnalareromanzi, racconti e poesie pubblicati in ogni epoca e in ogni Pae-
LLEE AARRTTIIEE IILL MMAARREE
CONRAD, LONDON O TOBINO?MURSIA LANCIA UNA NUOVA
COLLANA DI LIBRI DI MARE
Gerardo Picardo
I LIBRI
140
se. Unica condizione: che si tratti di storie di mare o di marinai.Quanto all’andamento del sondaggio, i lettori di storie di maresono un mondo a parte e part ico lare nel l ’universo deilettori. Hanno un fiuto particolare nel trovare autori interessanti esconosciuti al grande pubblico, hanno tra loro un forte passa pa-rola e sono, ovviamente, molto esigenti sulla ‘tenuta’ nautica del-le storie. Un romanzo con imprecisioni o errori nella terminologianautica o nella storia della marineria viene irrimediabilmente boc-ciato. Tra i romanzi classici più gettonati c’è ‘Martin Eden’ di JackLondon che, sicuramente, verrà pubblicato nella collana ‘CodiceInternazionale dei segnali’.Della Biblioteca del mare, il ‘navigato’ editore Mursia ci spiega:“La biblioteca del mare Mursia ha festeggiato l’anno scorso icinquant’anni di vita. In questo tempo è cambiato il modo diandare per mare e sono cambiati i lettori. Crescono i lettori checercano nel mare la grande avventura e che sognano di diventa-re vagabondi degli oceani e di seguire le rotte dei grandi navi-gatori solitari, come Slocum o Moitessier. La navigazione a velanon è più cosa per pochi privilegiati ma è ormai alla portata ditutti, anche la Biblioteca del mare con i suoi libri e suoi autori ei suoi manuali ha contribuito a diffondere la cultura del mare eanche della navigazione sicura. Ci piace pensare di aver contri-buito a cambiare il modo di pensare dei navigatori italiani: sonopiù informati, più colti, più consapevoli. Chi legge naviga me-glio”.Intanto in libreria sono arrivati i primi titoli della collana. Si co-mincia con ‘Lo specchio del mare’ di Joseph Conrad, uno dei testiforse meno conosciuti dell’autore anglo-polacco che nel 1904 ini-ziò questa serie di “bozzetti marinareschi” parallelamente allastesura di ‘Nostromo’. In questi scritti conradiani c’è lo sguardoappassionato e competente del marinaio sulle navi, sui mestieridel mare, sugli elementi meteorologici e sui capitani. Brevi storie,aneddoti, riflessioni che riprendono l’idea del mare che animatutta l’opera di Conrad: “Un banco di prova di coraggio, fedeltàe amore”.In libreria c’è anche ‘L’angelo del Liponard’ di Mario Tobino. E’ ilracconto dell’ossessione sessuale che avvolge l’equipaggio di un
I LIBRI
141
barcobestia bloccato da una bonaccia al largo di Medusa (Via-reggio). Undici uomini storditi dal silenzio del mare e immersi inun’inerzia infinita sono risucchiati in un gioco di seduzione e dimorte. C’è, in queste pagine, non solo il Tobino cantore dei se-greti dell’animo umano, ma anche un autentico poeta del mare.Da non lasciare negli scaffali anche ‘L’Isola del Tesoro’ di RobertLouis Stevenson e ‘Il lupo di mare’ di Jack London, che appar-tengono alla serie dei classici intramontabili. Il romanzo di Ste-venson ha segnato per sempre i caratteri del “pirata” mentrel’affascinante Wolf Larsen – nato dalla penna di London –, conla sua colta brutalità e la sua forza fisica, è diventato l’archetipodel comandante perfido, con poteri di vita e di morte sul suoequipaggio. Ma il ‘pacchetto’ mare comprende anche il nuovo volume di Tri-stan Jones, ‘Un marinaio da strada’. Jones è stato un navigatorestraordinario che ha solcatole rotte più incredibili. Nel suo primolibro ‘Il viaggio incredibile’, edito sempre da Mursia, ha racconta-to il suo record di navigazione dalle acque più basse del mondo,Mar Morto, a quelle più alte, Lago Titicaca. Un vero vagabondodegli oceani, nel mondo anglosassone è un cult sia per le sue im-prese nautiche sia perché, alla fine della sua vita aveva perso l’usodella gambe ma nonostante questo si è trasferito in Thailandiadove organizzava crociere con i ragazzi.‘Mare verticale’ è invece il nome della barca con la quale CeciliaCarreri, cinquantenne con un presente da magistrato, un passatoda alpinista e un futuro da regatante oceanica, ha affrontato –unica donna italiana – la regata oceanica Jacques Vabre nel2005. ‘Mare Verticale’ è anche il titolo del libro che la Carreri hapubblicato con Mursia nel quale racconta la sua singolare “con-versione” sportiva che l’ha portata dalle sfide alle vette più altedel mondo verso il Grande Blu. La storia sportiva di Cecilia Carreriè tutta all’insegna delle sfide, alla ricerca di orizzonti sempre nuo-vi per misurarsi con i propri limiti ma anche con una irreprimibilevoglia di uscire dagli schemi. Dopo anni passati a sfidare le vettepiù alte del mondo in Asia, Africa e America Latina e i deserti piùduri, Cecilia Carreri scopre, complice il ricordo di un corso di velafatto, il mare. La Carreri non è donna da mezze misure. Cerca e
I LIBRI
142
trova una barca da comperare e la sua scelta cade su un Mumm36, un’imbarcazione impegnativa nata per le regate più dure.Con questa barca, attrezzata per la navigazione d’altura, non-ostante i pareri contrari degli esperti affronta la sua prima impre-sa nautica. La sua esperienza in mare è minima, ma la grinta nonle manca. Quello che ancora non sa sulle barche e la navigazionelo impara facendo in periplo dell’Italia. L’incontro con il mare è diquelli destinati a durare e infatti lo scorso anno Cecilia ha affron-tato una delle più impegnative regate oceaniche: la Jacques Va-bre. L’avventura velica iniziata in Mediterraneo si è rapidamentetrasformata in una sfida oceanica. In queste pagine racconta conuno stile cristallino, senza retorica, l’iniziazione al mare di unadonna che quando arriva esausta in porto scrive: “Il mare avevascavato dentro la mia anima lasciandomi forte come non mai.”.Fatica fisica, paure, dolore, delusioni, incomprensioni. Cecilia silascia tutto alle spalle. In mare come in montagna si devono por-tare solo i propri sogni. Parola di un’alpinista che ha sfidato l’o-ceano.“Buon vento e buona lettura”, recita dunque il catalogo ‘Bibliote-ca del mare Mursia’. Perché le vecchie barche in legno hannosempre un’anima che raccoglie e conserva l’antico sapore dellagente di mare. Un itinerario ricco che si articola in più voci: ‘Quel-li di Capo Horn’, ‘Crociere, regate, viaggi e avventure’, ‘I sempreblu’, ma anche ‘Narrativa sul mare’, tra cui una menzione specialemerita ‘L’uomo del Cargo’ di Donatello bellomo, finalista al pre-mio ‘Sanremo libro del mare’. Un testo forte come l’impero delleonde, costruito con i ritmo delle burrasche.. E ancora ‘Manuali,tecnica e sport’, ‘Storia della marineria’ e, tra gli altri capitoli diquesto strutturato viaggio nelle acque dell’editoria ‘Uomini, navie misteri del mare’. Nella collana ‘Quelli di Capo Horn’, vanno segnalati i libri ‘GipsyMoth’ e ‘Lungo la rotta dei Clipper’. Nel primo testo si raccontacome, partito da Plymouth il 22 agosto 1966, all’età di 64 anni,Sir Francis Chichester abbia raggiunto Susney in 117 giorni. Ri-partito, in 119 giorni attraversò il Pacifico, vide terra doppiandoCapo Horn, risalì l’Atlantico e gettò l’ancora di rientro a Plymouthil 28 maggio 1967.
I LIBRI
143
Come non segnalare, poi, sempre del ‘vecchio’ e ‘profondo’ cata-logo 2005, ‘Il viaggio impossibile’ di Chay Blyth. Nel 1971, que-st’uomo compì una delle più memorabili imprese sportive nellastoria della navigazione: in 292 giorni portò a termine un ‘viaggioimpossibile’ e cioè la circumnavigazione senza scalo del globo, daest verso ovest, in senso contrario ai venti e alle correnti domi-nanti. In più, Blyth scelse di seguire una nuova rotta, sino ad allo-ra ritenuta impraticabile, tenendosi alle alte latitudini dell’emisfe-ro australe, in condizioni del tutto avverse alla navigazione. Che dire, ancora, di Willy De Roos, la cui storia viene raccontatain ‘Passaggio a Nord-Ovest’. Questo tranquillo signor di mezzaetà abbandonò il suo posto di dirigente aziendale e fece costruireun Williwaw, ovvero un Ketch in acciaio di 13 metri. Mollò gli or-meggi con l’idea di circumnavigare il mondo lungo la rotta di Ca-po Horn e al suo ritorno, non riuscendo a riadattarsi alle consue-tudini della vita cittadina, decise di ripartire intraprendendo unnuovo viaggio. Insomma, un catalogo tutto da scoprire e da leggere, nella gran-de avventura che spinge a cercare le profondità del mare e le suesfide di senso. Tenendo sempre presente l’antico adagio marina-resco: non ci sono venti favorevoli per chi non sa dove andare.
Mirò Pecorilla (Speed Sails): «Ogni vela è disegnata dopo averpreso le misure di ogni singola barca. Lavoro con risme di carta ecomputer». Randa, fiocco e, soprattutto, un grande desiderio diprendere il largo. Sono queste le caratteristiche di coloro cheamano la barca a vela. Ma dietro la gioia di prendere il vento c’èun lavoro paziente, quello del velaio, cui sono richiesti capacitàda ingegnere, estro, sartoria e un pizzico di ‘acqua salata’ che in-saporisce il lavoro quotidiano.
I LIBRIIL VELAIO? UN SARTO INGEGNERE
CHE AMA IL MARE
Gerardo Picardo
144
Un gioco ‘quasi’ da ragazzi per Mirò Pecorilla di ‘Speed Sails’, di-segnatore delle vele dell’Andromeda (comet 51), che ha vinto laRolex Cup di Capri 2005 e che ha partecipato al Salone nauticointernazionale, tenutosi a Genova fino al 15 ottobre. «Disegnovele e passo molto tempo a parlare con gli armatori – raccontaPecorilla – ma non smetto di fare regate e di uscire in barca pervedere come reagiscono le vele alle diverse andature e condizioni.Mi piacerebbe avere più tempo per viaggiare per mare, ma nonsempre è possibile. Ogni vela è disegnata dopo aver preso le mi-sure di ogni singola barca. Vado in giro per i porti con metro av-volgibile, risme di carta e pennarello indelebile anche perché conla pioggia l’inchiostro fa delle orribili sbavature». “Disegno le vele al computer – spiega ancora Mirò Pecorilla –con un software professionale. Una volta, invece, il disegno era amano libera per terra e in ginocchio. Ora si disegna la sagomadella vela suddivisa in pannelli (detti ‘ferzi’), tenendo in conside-razione la pesantezza e la resistenza del tessuto, i punti di sfrega-mento e così via. I ferzi sono tagliati da un plotter. La lavorazioneè poi eseguita da artigiani che imbastiscono e cuciono i pannellicon macchinari a braccio lungo e rifiniscono il lavoro a mano. In-somma, un sarto che va in barca con la testa nell’ingegneria aero-dinamica». «La passione per la vela – ricorda il ‘mastro velaio’ –è nata quando ero piccolo e andavo in barca con il campioneGiampiero Poggi e suo padre, ci mettevamo a prua a prendere glischizzi delle onde. La veleria è nata nel 1982 dalla passione per leregate e la velocità. Le vele più belle che ho disegnato sono quel-le di Andromeda (comet 51), di Hedimetra (X-512) che ha vintol’Arc, quelle di Gogo (comet 45) che e’ arrivata quinta alla Gira-glia, e Jala (comet 41)». E ancora «le vele latine degli antichi gozzi da pesca che ancoraregatano in Sardegna. Quello che mi ha divertito di più – ram-menta – è stato disegnare una vela per una barca in legno co-struita da papà per suo figlio. Adoro i tessuti, mi piace anche di-segnare le vele in cotone di olona per le barche d’epoca, ma nontutti riescono a capire il lavoro che c’è dietro». Nel campo delle vele vengono prevalentemente usati 10 tipi di fi-
I LIBRI
145
bre: nylon, dacron, mylar, pentex, spectra, vectran, Kevlar, Pbo (indisuso per la fragilità ai raggi solari che riducono la resistenzameccanica del tessuto fino al 70% con conseguente rottura dellevele), carbonio e cuben fiber. Comune la caratteristica di esserecomposti da una trama e un ordito. Esiste sempre un rapporto trail peso del tessuto e il suo allungamento e questo rapporto non èquasi mai proporzionale fra i vari tessuti. Ormai le vele non si co-struiscono più artigianalmente, ma con l’uso di programmi infor-matici. Software sempre più sofisticati, infatti, progettano e ta-gliano vele per poi essere lavorate su pianali lunghi decine di me-tri. Ad aiutare il velaio concorrono anche potenti macchine percucire elettro-pneumatiche a braccio lungo. L’esperienza di navi-gazione in regata del velaio rimane, comunque, un elemento fon-damentale per ottimizzare il rendimento. E prendere il vento ap-pena il mare chiama.
Il “Codice della nautica da diporto”, V. Rebuffat – E. Minnici Ro-ma 2006, edito dall’Istituto poligrafico dello Stato, vuole offrireuno strumento di documentazione normativa e giuridica comple-to e aggiornato, di facile consultazione e organizzato in modo si-stematico, in materia di nautica da diporto. Esso si rivolge – conun livello diversificato di approfondimento sia del dato giuridicoche di quello tecnico (rinvenibile fra commento, annotazioni e al-legati) – agli operatori giuridici del settore, ai funzionari delleAmministrazioni pubbliche competenti, ai responsabili delleaziende nautiche nonché dei siti di portualità turistica, ai respon-sabili di associazioni ed istituzioni nautiche che operano, a variotitolo, nel settore diportistico. Il valore aggiunto dell’opera è rap-presentato sia dal commento agli articoli che dalla ricchezza delle
I LIBRI
LE NORME SULLA NAUTICA DA DIPORTO, PER TUTTI
Maria Monicelli
146
note e del materiale di riferimento che valorizza anche le espe-rienze di normazione secondaria sia delle Capitanerie di portoche degli enti locali competenti.La realizzazione della raccolta normativa recensita appare partico-larmente opportuna a seguito dell’emanazione del D.L.vo 18 lu-glio 2005, n. 171, con cui viene adottato il codice della nauticada diporto. Il “Codice” riveste una notevole importanza, sia comecorpo unico di disposizioni sulla materia che su di un piano di fi-lologia normativa, avendo lo stesso unificato numerose leggi disettore che in trenta anni si sono succedute. Il “Codice della nau-tica da diporto” prevede anche un doppio binario di realizzazioneche attribuisce, ad atti di normazione secondaria, l’adozione diregolamenti diretti a semplificare ulteriormente alcuni aspetti del-la materia, con conseguente necessità di un raccordo sistematicodelle varie fonti che vengono così organizzate sia nell’ambito diun quadro sistematico che nell’intreccio dei richiami e dei riferi-menti.
I LIBRI
147
NAUTES
Il 7 ottobre del 1571 rappresenta una data emblematica per lastoria moderna. Quel giorno avvenne lo scontro che gli spagnoliancora chiamano “la Naval”, ovvero la pugna navale per eccel-lenza: la battaglia di Lepanto. Le acque dello stretto, su cui sispecchia la cittadina di Lepanto, che congiunge il golfo di Patras-so al golfo di Corinto, videro allora la vittoria della flotta della Le-ga Santa su quella del Sultano ottomano Selim II. Vittoria che eb-be nei Paesi cattolici un effetto paragonabile alla battaglia di Poi-tiers – avvenuta nel 732 – nell’Europa altomedioevale. Lepantocostituì allora, in Europa, il simbolo del trionfo del Bene, imperso-nificato dal Cristianesimo, sul Male, rappresentato dall’Islam, edivenne oggetto di scritti e poesie segnando nell’immaginariocollettivo dell’epoca la nascita di una nuova era. Tutto questo risulterebbe incomprensibile ai nostri giorni, se nonsi tenessero in conto le aspirazioni e il contesto dell’Europa catto-lico-mediterranea nella seconda metà del Cinquecento. Essa sisentiva oppressa e minacciata dall’avanzata dell’Impero Ottoma-no che, sin dall’inizio del secolo, colpiva con la sua potenza i pos-sedimenti cristiani via terra e via mare. La presa di Rodi (1522), labattaglia di Mohacks (1526), l’assedio di Vienna (1529), l’assediodi Malta (1565) avevano suscitato grande preoccupazione nelleCorti europee e in particolare in quella papale che, pur impegna-ta nella politica tridentina, si prodigava nella ricerca di un’allean-za rivolta non solo contro gli “eretici”, ma anche contro gli “infe-deli”.
LLEE AARRTTIIEE IILL MMAARREE
LA BATTAGLIA DI LEPANTO, GENESI DI UN MITO
Tommaso Visone
LA STORIA
148
L’operato di Pio V fu, in proposito, illuminante. Esso colse l’op-portunità storica che tra il 1570 e il 1571 favorì una parziale uni-tà di intenti tra le due più grandi potenze marinare cattoliche, ilRegno di Spagna e la Repubblica di Venezia, per creare una LegaSanta contro il pericolo turco. Infatti in quel periodo Venezia sub-iva l’attacco all’isola di Cipro, in suo possesso dalla fine del ‘400,da parte dei turchi: l’attacco ebbe termine il primo agosto 1571con la presa di Famagosta e il martirio (venne scuoiato vivo) diMarcantonio Bragadin. Mentre la Spagna vedeva crescere la pira-teria musulmana nel Mediterraneo occidentale. Le due potenze sitrovarono, quindi, concordi nel raccogliere l’invito papale a for-mare un’alleanza cristiana in funzione antiottomana, pur mante-nendo in parte una reciproca diffidenza legata alla disparità degliinteressi in campo. I negoziati furono lunghi e giunsero a compimento nel maggiodel 1571 con la creazione di una Lega, chiamata poi Santa o Cri-stiana, che univa il Regno di Spagna, la Repubblica di Venezia, loStato pontificio, le Repubbliche di Genova e Lucca, il Ducato diSavoia, i Ducati di Mantova, Urbino, Parma, Ferrara, il Granduca-to di Toscana e l’Ordine dei Cavalieri di Malta. Il comando dellaflotta venne affidato al Duca Giovanni d’Austria, fratellastro di Fi-lippo II di Spagna, uomo dal carattere bellicoso e imprudente, incerca di gloria (secondo il ritratto che ne fa Fernand Braudel). Al“bastardo” di Carlo V si affiancavano Sebastiano Venier, Marcan-tonio Colonna, Gianandrea Doria e altri principi italiani. Nel com-plesso, la flotta che si andava a concentrare a Messina nell’estatedel 1571 era una delle più imponenti che abbiano mai solcato ilMediterraneo. Al momento dello scontro con gli Ottomani le for-ze cristiane consistevano in 210 galere, più 78 tra galeoni e bri-gantini sostenuti da 6 galeazze, particolari galee dotate di duecastelli con un armamento di cannoni disposti in tre batterie (finoa 36 pezzi). La flotta turca contava, invece, 265 navi da combatti-mento tra galee e galeotte, poste sotto il comando di MehemetAlì Pascià.L’incontro tra le due armate avvenne la mattina del 7 ottobre. Es-se si disposero in direzione Nord-Sud per una lunghezza di 6-7chilometri di fronte allo stretto di Lepanto con la flotta turca che
LA STORIA
149
dava le spalle a Lepanto e quella della Lega che dava le spalle al-l’Italia.Entrambi gli schieramenti si suddivisero al loro interno in quattrosquadre: una riserva, un centro, un corno a destra e un corno asinistra. La riserva della Lega era comandata dal marchese di San-ta Cruz, il centro da Don Giovanni d’ Austria, il corno destro daGianandrea Doria e il corno sinistro da Agostino Barbarigo. I tur-chi disponevano a capo della riserva Dragut, al centro si collocaval’ammiraglio Alì, sul corno destro Mehemet Suraq e su quello si-nistro il corsaro Uluch Alì. Verso le 10.30 Mehemet Suraq mano-vrò la sua squadra per incunearsi tra l’ala sinistra cristiana e la co-sta tentando di aggirare sulla sinistra la flotta cristiana. La squa-dra veneta che teneva la sinistra reagì contrattaccando e causan-do la fuga dell’ala destra turca.Nel corso dell’azione Barbarigo venne ferito mortalmente a unocchio e Mehemet “Scirocco” fu catturato. Intorno alle 11 il cen-tro dei Turchi superò le galeazze poste di fronte allo schieramentocristiano ed entrò in contatto con il cuore della flotta della Lega,la galera “reale” con a bordo Don Giovanni d’Austria. Lo scontrotra la “Sultana” dell’ ammiraglio turco e la “Real” spagnola cau-sò un’enorme mischia che si concluse con l’abbordaggio della“Sultana” e con la decapitazione di Mehemet Alì Pascià. Durantelo svolgimento di questa mischia si ebbe una manovra centrifugadell’ala destra della Lega, che temeva probabilmente l’accerchia-mento vista la superiorità numerica della sinistra turca. Questainiziativa permise, con la creazione di un varco tra il centro cristia-no e il suo corno destro, la fuga della sinistra musulmana che te-meva a sua volta l’accerchiamento. Al termine della battaglia, co-me s’è detto in principio, la Lega ottenne una grande vittoria: laflotta turca fu annientata, con un bilancio di 110 galere cattura-te, 30 distrutte e oltre 25.000 morti.La notizia del successo generò in Italia e in Spagna una reazionefestosa che contribuì a creare un alone di leggenda attorno alloscontro: la battaglia di Lepanto diveniva mito, il mito della rinasci-ta cristiana radicato nella visione provvidenziale della storia carat-teristica di quell’epoca. Non vi è poeta della seconda metà delXVI secolo che non ricordi e commemori i celebri fatti di Lepanto
LA STORIA
150
con il tono della rivelazione e dell’annuncio della nascita di unanuova era. Basti ricordare Clelio Magno, Sebastiano Ventura, Lui-gi Grovius, Girolamo Muzio, Gabriele Fiamma, Fernando de Her-rera e Francisco de Aldana. Se l’impatto sull’immaginario collettivo europeo fu enorme, mol-to meno lo fu il risultato sul piano strategico dello schacchieremediterraneo, come evidenzia tra gli altri Fernand Braudel. Infattila Pace di Venezia con la Sublime Porta nel 1573 e la ricostruzio-ne della flotta musulmana (avvenuta in sei mesi) lasciarono ai tur-chi il ruolo di maggiore potenza militare mediterranea.Tuttavia, seguendo Pier Giovanni Donini, si può dire che gli onerifinanziari legati alla rapidissima ricostruzione della flotta e quelli,più diluiti nel tempo, per il suo mantenimento finiranno col gra-vare in maniera insostenibile sul bilancio dello Stato ottomano,dando il via a quella crisi finanziaria che nel corso del tempo si sa-rebbe rivelata come una delle principali cause della fine dell’ Im-pero Turco. Si può, dunque, concludere che la “Naval” si erge asimbolo per l’Europa cattolica della sua salvezza e della sua rina-scita, rappresentando uno di quegli episodi-cardine su cui si è for-mata la nostra cultura e che ci aiuta a comprendere la fenomeno-logia delle ideologie “identitarie” dei nostri tempi.
LA STORIA
151
NAUTES
La magnifica città di Ravenna rappresenta in Italia un raro gioiel-lo di arte bizantina ed è notissima soprattutto grazie ai suoisplendidi mosaici. Recenti studi e scavi archeologici hanno porta-to nuovamente alla ribalta la località aggiungendo altri tassellialla sua fastosa storia. Il momento culminante della crescita, incui la magnificenza della città raggiunge l’acme, è il VI secoloma la sua storia nasce in epoca preromana, quando Ravenna eraun piccolo centro urbano. Successivamente, come municipium,comincia la sua ascesa a partire dal 402, data che segna il nuovoruolo assunto quale sede imperiale trasferita da Milano e volutadall’imperatore Onorio. A partire da questo momento diventanecessario dotarsi delle infrastrutture basilari quali le mura in-nanzitutto, a causa del periodo particolarmente turbolento, maanche strade, edifici di culto che possano rivaleggiare con lamaestria del vicino Oriente. Dopo il regno di Teodorico e la suc-cessiva reggenza della figlia Amalasunta per conto di Alarico, siaprono gli anni di una guerra che vede Goti e Bizantini osteg-giarsi per concludersi con la vittoria di Belisario, generale bizanti-no di Giustiniano nel 540 circa.E mentre in Italia spiravano venti di decadimento, proprio quandosembra manifestarsi il tramonto di una grande epoca, a causadelle genti del nord che si affacciano nella nostra penisola, Ra-venna appare sempre più scintillante di colore, splendore e po-tenza. I mosaici che adornano i suoi monumenti e che rappresen-tano il tratto peculiare della sua arte, attraverso la moltitudine
LLEE AARRTTIIEE IILL MMAARREE
RAVENNA E IL SUO CENTROPORTUALE, CLASSE
Daniela Squarcia Matticoli
I FONDALI PREZIO
SI
152
delle loro tessere accendono di bagliori le magnifiche figure,creando un gioco di specchi e di rimandi che amplificano lo spa-zio che perde così ogni limite. Non un diaframma tra l’osservatoree il supporto ma una dilatazione, le forme diventano evanescentilegandosi con il mare e il cielo circostante. I luoghi per eccellenzadecorati dai mosaici sono le basiliche, i cui colori scintillanti narra-no un percorso di fede, di potere e raccontano la storia della cul-tura e delle origini di un popolo.Naturalmente vengono subito in mente quei magnifici monumen-ti come San Vitale, San Michele in Africisco e ancora Sant’Apolli-nare in Classe. Proprio in quest’ultimo, sulle pareti della navatacentrale, appare rappresentato il porto di Classe, centro di trafficie importante scalo marittimo al servizio di Ravenna. Per tale sco-po Classe venne dotata delle mura, venne ristrutturata la sua fa-scia urbana ubicata in prossimità del principale canale che attra-versava l’abitato e che rappresentava l’asse di collegamento tra ilmare e i bacini più interni e con la stessa Ravenna.Le recenti indagini archeologiche hanno confermato il ruolo com-merciale svolto da questo porto che si inseriva nell’ambito delleprincipali rotte del Mediterraneo avendo scambi principalmentecon l’Africa e con l’Oriente e quindi con l’area egea, l’Asia Mino-re e la Palestina. I commerci si svilupparono soprattutto nella se-conda metà del VI secolo, in seguito alla conquista di Ravenna daparte dell’esercito bizantino. Ben presto, però, si avvierà una fasedi declino che si protrarrà fino al VII secolo, quando il quartiereportuale perderà i suoi connotati di centro di scambi per i notimutamenti storico-politici.L’ascesa economica che contraddistinse quest’area ha la sua piùchiara e solenne manifestazione nella costruzione di due grandio-se basiliche quali Sant’Apollinare e San Severo: la prima, fortuna-tamente ancora visibile in tutta la sua smagliante bellezza; la se-conda invece è andata distrutta, tuttavia nonostante le spoliazionici rimane il suo retaggio attraverso qualche lacerto musivo. AClasse il culto cristiano si diffuse prima e più rapidamente rispettoa Ravenna e qui fu posta anche la prima sede episcopale e sepoltii primi vescovi cristiani come appunto Sant’Apollinare.Le dimensioni dei due edifici cultuali ci attestano la magnificenza
I FONDALI PREZIO
SI
153
e il potere economico raggiunto dall’area ravennate grazie ai suoiscambi commerciali e marittimi, mentre le strutture architettoni-che ci ricordano il continuo rimando all’arte orientale quale esem-pio di grandezza. A questo va sicuramente aggiunta la ricchezzadell’apparato decorativo degli interni: dai fusti delle colonne aicapitelli, dai pavimenti alla decorazione parietale. I nuovi luoghidi culto vengono concepiti quali edifici qualitativamente di altissi-mo livello per rispondere alle esigenze assunte dal ruolo di sedesregia, prima dell’imperatore d’Occidente e successivamente del redei Goti. In tale contesto la basilica diveniva luogo di aggregazio-ne, ma anche segno distintivo dell’identità culturale e politica, eancora sede delle proprie radici in quanto luogo di sepoltura delsanto locale, dei dignitari o degli esponenti più importanti dellavita ecclesiale come i vescovi. A suggellare questa folgorante stagione di grande crescita esplendore tutt’oggi Ravenna e il suo antico porto di Classe, ci ac-colgono tra i loro fastosi monumenti in attesa che questo luogoricco di storia possa avere un vero e proprio riconoscimento attra-verso la realizzazione del Museo del Parco di Classe.
I FONDALI PREZIO
SI
155
Roma, incontro del presidente Parlato, del presidente del CivFontanelli e del direttore generale Petrocelli con il ministrodella Funzione pubblica Nicolais sul futuro dell’Ente.
Roma, il ministero del Lavoro, il presidente Parlato con il diret-tore Petrocelli firmano le convenzioni per progetti di ricerca fi-nanziati dal ministero del Lavoro che riguardano a) Le cadutedall’alto per l’attività di lavoro marittimo: studio della casisticanosologica e ipotesi di interventi preventivi; b) Analisi del fat-tore anagrafico sull’andamento generale del fenomeno infor-tunistico nel settore marittimo; c) Analisi dei rischi da esposi-zione ad agenti fisici, con particolare riferimento alle vibrazio-ni meccaniche e alle radiazioni ottiche.
Roma, Federmare, partecipazione del presidente Parlato e deldirettore Petrocelli sul tema della formazione del personalemarittimo.
Roma, Sala delle Conferenze Camera dei deputati, partecipa-zione presidente Parlato al convegno “Europa Mediterraneo”organizzato dal Consorzio E.T.L. e dalla European Transportsull’idea di una politica mediterranea dei trasporti in chiaveeuropea.
Roma, Sala delle Colonne Camera dei deputati, intervento delpresidente Parlato e partecipazione del direttore generale Pal-mira Petrocelli alla presentazione del primo bilancio socialedell’Inas Cisl.
Napoli, partecipazione del presidente Parlato alla cerimoniainaugurale della linea Autostrade del Mare Napoli-Genova-Termini Imerese su iniziativa dell’Autorità portuale di Napoli.
Napoli, relazione del presidente Parlato presso il Rotary Clubdi Napoli sulle potenzialità dell’economia marittima viste at-traverso l’Ipsema.
SETTEMBRE
INCONTRI DEGLI ORGANI
156
Roma, incontro interlocutorio presso il ministero dell’Agricol-tura per la messa a punto del decreto per i fondi di assistenzaper gli eredi dei marittimi pescatori defunti.
Roma, Auditorium Conciliazione, partecipazione del diretto-re Petrocelli alla serata di premiazione di “Comunicare Roma– la cultura del fare” organizzata da Uir, Unione degli Indu-striali e delle Imprese di Roma. Premiate le idee o progettiche accrescono il prestigio di Roma e del suo “mare” nelmondo.
Roma, partecipazione del direttore Petrocelli al gruppo di la-voro nazionale sul tema del Libro Verde presso il ministero deiTrasporti.
Roma, partecipazione del direttore Petrocelli, presso il ministe-ro del Lavoro, alla riunione presieduta dal sottosegretario Sen.Montagnino in preparazione dell’incontro con la Commissio-ne europea per la valutazione della attività di Vigilanza.
Roma, partecipazione del presidente Parlato, del Civ presiden-te Fontanelli e del consigliere Civ Paganini alla presentazionedel secondo rapporto Inpdap sulla previdenza complementarenel pubblico impiego.
Firenze, intervento con relazione del presidente Parlato e deldirettore Petrocelli ai lavori del Forum europeo sugli infortunie malattie professionali presieduto da Inail.
Roma, partecipazione del direttore centrale Cariola alla tavolarotonda nell’ambito del Seminario “La riforma dei serviziispettivi delineata dal D.Lgs. 124/04” organizzata dal ministe-ro del Lavoro.
SETTEMBRE
OTTOBRE
INCONTRI DEGLI ORGANI
157
Trieste, partecipazione del team Ipsema alla storica regata ve-lica triestina “Barcolana”.
Trieste, convegno organizzato da Ipsema sul tema della nauti-ca da diporto presso la Camera di commercio di Trieste. All’in-contro hanno partecipato oltre ai vertici dell’amministrazioneanche esperti di diritto nautico e personalità rappresentativedel mondo politico ed economico della città.
Bari, partecipazione del direttore centrale Daniele Leone allacelebrazione dell’Anmil sulla “Giornata per le vittime degli in-cidenti sul lavoro”.
Roma, incontro del direttore generale Petrocelli e del consi-gliere Cima, con il sottosegretario alla Funzione pubblicaGiampiero Scanu su aspetti che riguardano il ministero e l’Isti-tuto.
Modena, partecipazione del direttore centrale Perticaro allaquarta convenzione nazionale dei responsabili dell’igiene edella sicurezza in ambienti di lavoro.
Genova, partecipazione e intervento del presidente Parlato alconvengo sulla nautica da diporto presso il Salone Nautico.Alla conferenza hanno partecipato anche il presidente Fonta-nelli, il direttore Petrocelli e il consigliere Paganini.
Roma, partecipazione del presidente Parlato del consigliereCima e del direttore Petrocelli alla assemblea degli associatiAssonave.
Roma, direzione generale della Pesca, il presidente Parlato e ildirettore Petrocelli per la firma dell’accordo con il ministerodell’Agricoltura per le misure in favore di eredi diretti dei ma-rittimi imbarcati sulle navi da pesca, deceduti per cause di ser-vizio o a seguito di affondamento delle unità da pesca.
OTTOBRE
INCONTRI DEGLI ORGANI
158
Roma, partecipazione del consigliere Cima al decennale deglienti di previdenza sul tema “Una politica previdenziale atten-ta al mondo delle professioni”.
Roma, partecipazione del presidente Parlato e del direttorePetrocelli alla assise sui porti italiani organizzata da Assoporti.
Roma, partecipazione del presidente del comitato Pari oppor-tunità Dr.ssa Iesu all’incontro presso la direzione generale Inp-dap sulla iniziativa di modifica della L.104/92.
Giulianova Marche, intervento del presidente Parlato al con-vegno organizzato da Uila Pesca “Innovazione, redditività e si-curezza delle imprese di pesca”.
OTTOBRE
INCONTRI DEGLI ORGANI
LA RETE INTERNET PER LA QUALITÀ DEL SERVIZ IO
Per avvicinare i propri servizi all’utenza, semplificando e rendendo più agevoli i rap-porti con il cittadino, l’Ente ha realizzato due nuovi servizi on-line fruibili dalle impre-se di armamento e dal personale navigante.L’IPSEMA, attraverso il proprio sito www.ipsema.gov.it e l’utilizzo della rete Internetvuole facilitare i rapporti tra il cliente e l’Istituto rendendo l’informazione disponibileal cliente stesso in ogni parte del mondo.Ai servizi possono accedere coloro che sono in possesso del nome utente e dellarelativa password, appositamente rilasciata dall’Istituto.
“A U T O L I Q U I D A Z I O N E O N - L I N E ”Le imprese di armamento già iscritte all’Istituto, attraverso il sito IPSEMA e l’utilizzodei servizi on-line, possono effettuare sia le denunce di armamento, sia l’autoliquida-zione. Il nuovo servizio evita la redazione di supporti cartacei e consente di adempie-re agli obblighi previsti dalla legge direttamente dal proprio ufficio.Gli armatori possono conoscere, inoltre, la propria posizione contributiva e assicura-tiva aggiornata in tempo reale.
“N AV I G A N D O I N R E T E ”Navigando in rete è la sezione del sito www.ipsema.gov.it dedicata a tutti coloro cuil’IPSEMA eroga le indennità per temporanea inabilità al lavoro. Tramite l’inserimentodel nome utente e della password gli aventi diritto possono interrogare on-line la pro-pria posizione nei confronti dell’IPSEMA sia per conoscere in tempo reale eventualipagamenti emessi che per il rilascio delle certificazioni.
NAVIGANDO, NAVIGANDO…IN INTERNET COME IN MARE
LA NUOVA REALTÀ DELL’IPSEMA