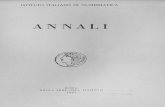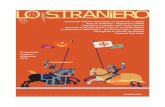LIBERO MANGIERI G. 1994, Problemi di circolazione monetaria a Nuceria Alfaterna, dall’età...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of LIBERO MANGIERI G. 1994, Problemi di circolazione monetaria a Nuceria Alfaterna, dall’età...
Nuceria Alfaterna e il suo territorio
Dslla fondazione ai Longobardi**
A cura di Antonio Pecoraroe conpresentazione di Giovanni Pugliese Carrateili
Problemi di circolazione monetaria a Nuceria AUaternadall'età classica a quella imperiale.Giuseppe Lib*o Mangieri
Età classica ed ellenistica.
Nell'aniichità greca ia polis era uno Stato vero e
proprio, che esprimeva in autonomia e libertà Iapropna polítíca dotandosi di strumenti iegislativi,sociali ed economici, che servivano a meglio esaltar-ne i'indipendenza. L'uso della moneta fu certamen-te uno dei mezzi espressivi che caratterizzarono, ne1modo più significativo, questa vocazione. Per unacittà-stato battere moneta comportava un notevolesalio di qualità. Non solo perché per allesiire unazecca occorreva un grande sforzo organízzatívo -bisognava creare un organismo di controllo, ap-prowigionarsi di scorte, ricercare incisori di talento-; ma anche perché la polis, attraverso la moneta,esprimeva - sia all'interno che all'esterno - il suoprestigio nel modo più qualificante. Le immaginiscelte per i conî rappresentavano le divinità princi-pals, dei pantheon locali, a testimonianza d'un sensoreligioso vivo e costante; esse, insieme alia leggenda
- che attestava palesemente che quelia moneta etaemessa e veniva garantita, nella sua qualità e ne1 suopeso, da una determinata città -, erano il segno piùevidente deil'autonomia e, direi anche, della fierez-za nel manifestarla. Fu per tale motivo - oltre cheper ragioni attinenti allo scambio e alle contrattazio-ni quotidiane - che quasi tutte 1e città greche sidotarono di tale fondamentale strumento, 1a mone-ta. Naturaimente, oltre alle plleis greche e magno-greche, anche Roma ed alcuni centri italici hniono,gradualmente,, per adotiarne l'uso; tra questi ultimiNuceria fu sede d'una zecca che diede vita ad unamonetazione ricca e di grande pregio artistico 1.
Nel momento in cui il fenomeno crebbe e si espan-se un po' dovunque, i commerci fra le città conob-bero un incremento significativo. I traffici ebbero,in modo partìcolare, nelle vie marittime il loromezzo preferito ed erano ampi e differenziati, conrotte che andavano dalle lontane colonie microasia-tiche fino ai porti di Massalia e delle Baleari, pas-sancio, owiamente, per la Grecia, per la MagnaGrecia e per il mondo romano.
Grazie alle tracce lasciate dalle monete oggi riuscia-mo a seguire i percorsi dei mercanti, ad htui-rel'ampiezza e l'intensità dei movimenti fra le città,le loro potenzialità economiche, i ritmi degli scambifra i centri di partenza e quelli di destinazione,situati in aree geografiche anche molto distanti fraloro; in pratica possiamo ricostruire quelia che og-gi, con un termine calzante, definiamo circolazionemonetaria2.Le notizie reiative alla circolazione moneiaria aNuceria sono, allo stato attuale, prou/isorie e su-scettibili di ulteriori approfondimenti. Ciò è dovutoalla circostanza che, nonostante la città abbia avutouna vita lunga, la ricerca archeologica non ci metteancora a disposizione una significativa documenta-zione per i primi secoli di vita, sia perché solo intempi recenti sono stati utilizzati sistemi di ricogni-zione e di conservazione più idonei, sia perché lamaggior parte de1 materiale sinora disponibile ri-sale ad epoca romana. La città più antica, pertanto,è ancora in buona parte da scoprire. In questa si-tuazione, in t'ieri, le informazioni relative alla circo-lazione monetaria sono necessariamente prolviso-rie e rare, ma proprio per questo preziose.Per il periodo classico, conosciamo una sola mone-ta straniera che circolava sicuramente in lom ed è laseguente:
ZECCA: IRNTHI.4E,340-320 ca. a.C.D. Testa giovanile laureata a d., con capelli fluenti.R. In alto IDI N [email protected] androcefalo che incede a s., con testa di pro-filo.STAZIO 1990, p. 267.g a,a1, fi 16,80, inv. 111 (inventario prowisorio).
La moneta fu rinvenut4 nel settembre del 1928, a
Nocera Superiore, sulla strada che conduce allachiesa di Sant'Antonio, e conservata quindi nei de-positi del Museo Provinciale di San Benedetto a
Salemo dove, chi scrive, la rinvenne durante il rior-
dino., 1o studio e l'esposizione del ielativo materia-le numismaiico.L'unico rinvenimento monetario d'epoca classica,sinora accertato nel territorio di Nuceria, appariie-ne ad una zecca la cui localizzazione è incerta.Sappiamo, comunque, che essa ha prodoito unaserie limitata di emissioni, riconducibili a due soligruppi. Le monete hanno in comune uno stile de-cisamente rozzo e una leggenda con caratteri misti,non riferibili ad un unico alfabeto, spia d'influssiculturali diversis. Per quanio riguarda 1a cronolo-gia, abbiamo degli elementi che ci offrono del1einformazioni, dal momento che alcune monete so-no state reperite in contesti tombali databili sicura-mente intomo al 340-320 a.C.4: sono però indica-zioni che non ci ofÉrono una cronologia assoluta; cisegnalano - dato utilissimo - che gli esemplari e-rano in circoiazione al momento in cui furono uli-lizzati come obolo di Caronte, anche se non è possi-bile stabilire da quanto. E però da sottolineare chel'emissione di sola moneta enea, in mancanza divaluta pregiata, è spia di potenzialità economichelimitate, dal momento che il bronzo, nella sua qua-lità di moneta fiduciaria, è destinato per sua nahrraad una circolazione locale e ad una durata nonprolungata. Tale circostanza fa sospettare che allespa1le di un'economia che produce solo questo tipodi monete non ci sia un'organtzzaztone sociale flo-rida, ma piuttosio una classe di contadini, di arti-giani e di piccoli commercianti. Pertanto, sebbenepossiamo affermare con certezza solo che intomoal 340-320 a.C. 1e monete erano scambiate e la zeccaera in piena attività, ritengo che f inízio delle emis-sioni di questo centro non debba essere anteriorealla metà del IV sec. a.C.5Per quel che riguarda il problema della localizza-zione, due sono i possibili centi accredllat't: Irnum,identificata col sito etrusco di Fratie di Salemo6, e
Surrentum, ubícata nei pressi dell'attuale Sorrento 7.
Per la prima ipotesi c'è da dire che, in tempi nonrecenti 8, è stato dimoshato che la parola lrnum, chesi voleva collegata alla leggenda IRNTHI, e chederiva dal nome del fiume che scone nei pressi delcentro etrusco, è di origine medievale. Non è quin-di possibile che f idronimo sia da collegare allaleggenda d'una moneta dei IV sec. a.C. e al relativopagus. Ma tale asserzione, a mio awiso, non esclu-de la possibilità di mettere in relazione le monete
- con lo stesso eenlro di Fratte; anche se-altri haava zala l'ipotesi che in esso debba essere ricono-sciuta la Marcina delle fonie.L'assegnazione delle monete in questione a Surren-tum è basata sulla circostanza che nel vicino san-luario di Athena, situato a Punta della Campanella,è stato sinora rinvenuio il maggior numero di e-
semplari di questa zeccal0. L'argomento, a mio av-viso, è lungi dall'essere determinante, perché è cir-costanza piuttosto frequente rinvenire nei santuariaccumuli di moneie derivanti da ofÍerte votive,senza che ciò si traduca, automaticamente, in unaprova dell'esistenza d'una attiviià di zecca nei pa-raggi. Va quindi osservato che non esiste un lega-me convincente, nonostante i dotti sforzi effettuati,che colleghi 1a leggenda IRNTHI a toponimi loca-liÌr. Ritengo, pertanto, che non siano emersi ancoraelementi decisivi per escludere o pone in relazionequeste monete a1l'uno o all'altro sito, per cui èopporluno lasciare, per ora, la questione aperta.Anche se non risolto, i1 problema deila locaiizza-zione risulta secondario, in questa sede, dal mo-mento che l'ipotetico sito che ha emesso le monetein esame, qualunque fosse, possedeva due carat-teristiche precise: a) aveva delle connotazioni au-toctone ben delìneate; b) era sicuramente in rap-porto con Nuceria. Ma quale fosse il tipo di rap-polto non è dato conoscere, anche perché le notiziesulla stessa Nuceria, per il periodo in esaqre, sonolimitate 12. Dalle fonti sappiamo che fu fondata dagenti sannitiche, i Sarrastil3; che nel pieno III sec.a.C. l'origine indigena dei Nucerini veniva esaltaiadagli splendidi esemplari locali con iipologia de-rivante da modelli greci, ma con leggenda in ca-ratteri oschi. Pertanto la presenza in loco d'unamoneta di un centro sicuramente non greco, esem-plare databile alla seconda metà del iV sec. a.C.,è eiemento di grande interesse, che evidenzia undialogo commerciale fta genti autoctone e si ponecome cerniera, sottolineandone la continuità, fradue periodi caralterizzali da usi e costumi pret-tamente locali e da una sostanziale autonomia cul-turale. Tale circostanza offre, a mio arwiso, ancorapiù vigore a1l'ipotesi d'una cont'edernzilne nucerina,collocabile proprio alla fine del IV sec. a.C., cuierano associate, probabilmenie, Stabia, Pompei edErcolanola, e da cui non è possibile escludere, apriori, l'appartenenza anche de1 centro che coniòla moneta in esame.Con l'avanzare della conquista romana dell'ltatameridionale le città magnogreche e quelle indigenefurono gradualmente private, ohre che della pro-pria autonomia, anche del1a possibilità d'emetteremoneta. Per la verità i Romani, fautori d'una poli-tica certamente di annessione, ma anche saggia edarticolata; adottaronomisure diverse a semn-da delgrado di solidarietà e di collaborazione espressodalle varie poleis con cui vennero in contatto o con-trasto.E attestato che, dopo la guerra annibalica, alcunicentri dell'ltalia meridionale continuarono ad e-mettere moneta, in parte consewando la propria
identità culturale, in parte impostando le nuove sospetta.re che monete veline circolassero anche inemissioni sul modello romano; essi furono caelia. quest'uìtima cina a les-tnàniar-rza d,un dialoeocanusium, Copia, Graxa, Heracrea_,_orra, paestum, àmmerciare di .,ri.onor.iu.nàio["un"#.,1"';"i:Rhegium, uxentum, Veria e Vibo Varentia. Le mo- si"ur" ".,u
;h.-ao".;;r;;;;",;"^ certa vivacità.nete di questi siti djfficiÌmente circolavano al difuori del mercato cui erano destinate, che era es_senzialmente locale. Etò japeriale,Le altre città, ormai prive deila Tóro identità cultu-rale, adottarono la moneta romana. Pertanto i-l fe- L'awento dell'lmpero romano cancellò del tuttonomeno della circolazione fu fortemente ridimen- or.i ..tiariio'.o;il;;,à?i.i"ulj fra centri non ro-sionato dal momento che, fane poche .eccpzioni, Àani che. .";;;;ì;;;iioit.uro, erano ancorauna sola fu ra moneta comune. îutavia da dué in auge durante'rri"..
".ò;,* r, h moneta, unoritrovamenri, in cenrri situari vicino Nuceria, pos- thi;:ilt*.;i;;;;. ffiffid"r der tempo, pe_siamo indireltamente ricavare delle norrzie utili'an- iò, rnun rnuno che l'lmpero amplìava i suoi confini,che. per l'argomento in esamet"ll primo è rappre- iérg.-u di raggiungere tutto il territorio sottosentato da monete di Ebusus 15 ségnarate a 'pàm- conÈolo no' póio .riui. ,ortinutu da una sorapeir6, Sarnou e probabilmente a Saierno's. iàcca; perciò altre ne vennero attivate in localitàEbusus tu una cirtà dl.grande rilievo che, in piena ittut.gi.l.,u " hú; ;;;;;ìúiÌità immediata, arespansione romana, ebbe rapporli commerciaii con traverio sigle precise, è u" .ì.rrl."to di grande ri-non pochi centri deil'Itaiia mèridionale. Le sue mo_ lievo che É."r,.it";i;;;h;; _ sopragutto neg1inete vengono rinvenute, con grande frequenza, in ultimi seóIi dei;t-f"rà :'àiiii*ri movimenti dilocalità dell'attuale camnania" centrale e'-.riéio- ilàn.t. e di merci fri località situate anche in areenale: sappiamo, infatti, clie sono presenti, oltre che geograriche molto distanti.nette località citate, a paestum e Veha,,. B;ù6;;;;ilì;;rr" p.rìàà", dai sottosuolo di Nu_La vicinanza di Nuceria ai cenfri dicui sopra, il suo !e.iu siu .rnerio matàriale in abbondanza non pos-ruolo di primo piano - non dimentichlamo che, là ,iurno, uUo,trto uttuuì* irunìin.urto, dal momen_l'allro' ebbe una monetazione autonoma fin quasi to che esso è racchiuso,'per lo piu, nei depositilo scorcio del Ill sec a'C -.e Ia sua coilocazioie-ll à"eua citta antica. ciò è doluto anche alla circostan-una posizione srrategica sula.via terrestre che, at- ,u.t.,.
"on .rìrlo;;;;;#;vi con re indica_
li'::::i:d" Ie principati.rocarirà deila campanii, zùni dei '.p".ú ;u'ì;;uii.i*in.ur.ruti, ,ugon
ii.ll:]:'3.y1 l.rso il golfo di Saterno e di ù in o..,.ui !lú op.ru n.l ,.1ì"..'Joútrig.to spesso. rraLucanÍa autorizzano a credere che Nuceria dovesse i'tril. airn.oti;, u iÀuài.r^ir. -aniche e ad effet-essere una destinazione obbligata per la moneta tuare uno scavo nello scavo. ciò porta anche aebusitana anche in considerazióne àeru suu noie- .inetter. sul modo.on *i uruno^rpesso condotti ivole capacità di penetrazione. u...'f.i ,.uii,^li 1i,jil iliffi;genza, situazioneL'altro elemento demo di rilievo è rappresentato .ià'non ,..p.. permetteva a valenti archeologi didal rinvenimento a -sarno, in ,no rt.r"i ioliàrio ioì., rirrrr.'rrt.tj .u.tu i. inat.urjàni di provenien-tombale, d,una moneta enea di Velia i"rl.rne u auà Iu";ì. g..o.r., infine, valutare le condizioni, al limi_monete romane2'. I dati cronologici dei due bronzi te della leggibiliÀ;il;'il;'";.te si presentanoromani permettono di datare la lomba, e di conse- una vorta ffi"; il ,;;;iil;ù piuttosto cono_gu enza anche il materiale di.co_rredo, fr_a lo scorcio sivo. Tutte quesre ;;gj;;'_'.óifrìntu,o.nt. u ,oo_del Ill ed iJ primo quarto del Ii sec. a.C. È int.i.r- iiu-ioni ispirate dali'opportuniià e dauo spazio -sante notare che l'esemorare verino è una moneta non (onsentono,
_in questa sede, di presentare undi.piccolo modulo, roito l.gg"ru, il ."j..;;;il q,luaro urnpio e dettagriato deua circolazione in etàcoi nominau romani è risneiri"vamenre dí i7' e 39 ii"p"ri.r., '." iù;3 ,rr;;.";r"iun.u ,.nd. pr._volte inferiore. Una monet'a dj b;o;;or; ;-;;; ,ìà!.,. pu. mrnime norizie che possiamo ricavaren,hzzata come oboro di Caronte insieme a due mo- ;.id; il;;rt ; pirr"r-* " '' ".nete romane, in un periodo storico in cui Roma Verranno, perciò, esaminati un interessante gruz-aveva praticamente conquistato l'ltalia meridiona- zolo di moireie in;;i;iiil;, già pubblicato,le, suggerisce che iì ruoro di Veria, in questo perìo- ma riconsiderato ;;;;; ii priio.,,,* che ispirado, dovesse essere di un tale ritievo.íu.ntrlo À ù;t.il;-;a.;fi;;*il:ài"una sorta-di.competizione commerciale con la città Queste ultime sono venute alla luce durante scaviegemone:r' E owio che veria doveva avere sicura- ricenriz, .ff.rt;;;;;i;;;;iiltliurotino 1.o.,t.u_mente una via ci'accesso oriviJegi_ata ai mercah del- da Ungari) e in locaiità huéti, .onl. si evince dall'agro di sarno. La vicina'nza dsr;;;ù;;;;; f; ffint. catatogo.
PnopnrprÀ FasolwoC.da lJnsarí: tríncea l, taglio VII'
Monete íinuenute il 5 ottobre 1983
ANTONINO PIO
Zecca incerta.AE.D. Tracce del busto laureato e barbato a d'R. Tracce di figura stante di ProsPetto'1. e 11,40 @ 27,80 (he 1\.
No"ta: L'esemplare è probabilmente del Il sec' d C',
forse di A. Pio.
COSTANTINO
Zecca incerta.AE, Follis.D. Testa laureata a d.
R. Tracce di figura stante di ProsPetto'2. g1.,1 @ 1s,40.
Zecca: Nicomedia.AE. 330-337 d.c.
R. M larga in monogramma indecifrabile'7. s,0,6 Q 9,00-g. "te esempla; di piccolissimo modulo, parzial-
mente leggibili o indecifrabili.
Localrra P,cngrl
Teatro: strato VIll, dell'8 aptile 1980, trincea G'
CRISPINA (mogte di Commodo)
Zecca: Roma. 180-i87 dC'AE,D. Busto femminile a d. con capelli raccolti sulla
nuca.R. Tracce di figura velata stante di prospetto'
9.99,6 Q 22,30
PROBO
Zecca: Roma.A& Antoniniano.D. IMPPRO BVSAVG.
276-282 d.C.
D. COSTANTiNOPOLLBusto di Costantinopoli elmata, laureata -e
drap-
peggiata a s., con asta riversa sopra la spalla s'
R. Vittoria dÌappeggiata stante a s., su una prua,
con scudo ed alta lràsversaie. In esergo SMM'RIC VII, p. 634, n.196; RomnrsoN Y '
p. 276' n' L5'
3.92,1. fi 18,60.
AE.D. DNA [RCADI v] sPF [AVG].Busto màschile dréppeggiato a d., con diadema
oerlinato.h/crorunno MANoR\M.L;imperatore con labaro nella mano s e prigioniero
ne[a'd.; in alto a d. /] in esergo TES.
LRBC I, 1848; GRnnsoru-vavs 62 (senza lehtera ctl
controllo).4. s.2,7 O 16,50.5. í monete incerte di piccolo modulo'
Busto maschile a d., radiato, barbato e cotazzato'
Bordo perlirato.R. ADùEMVSPROBIAVG.L'imoeratore coronato a cavallo a s., con mano Pro-tesa à sceLtro nella s.; ai piedi prigioniero ln esergo
R X. Bordo perlinato.RIC V, 2, p. 35, n. 165.
10. g3,5 @ u,30 (hg.2).
PROBO
Zecca: Roma. 276-282 d'C'
A& Antoniniano.D. PROBVS PF AVG.Busto maschjle a d., radiato, barbato e drappeg-giato.R. VICTORI AGERM.Trofeo fra due prigionieri. In esergo R A fra clava'
Bordo perlinato.RIC V, 2, p.41, n.223.11.93,3 @ 20,a0 (hg' 3).
GALERIO MASSIMIANO
ARCADIO
Zecca: Tessalonica.
MARCIANO
Zecca incerta.D. Tracce di busto a d.
383-386 d.c.
4s0-4s7 d.c.Zecca: Cizico.Zecca: CostantinoPoli.
D. Tracce di busio maschile a d. Tracce di leg- AE, Frazione di follis.D. IMPCM A MAXIMIANVS PF AVG.
BusiQ lnasch-ile radiato, barbato e drappeggJato a d'
N. CONCONOTA MI LIT\M,Il orincipe stante a d. in abito militare che riceve
,rn'a piccbla Vittoria da Giove stante a s., con scettro
neila^ s. su linea di es. In campo sotto K'RIC VI, p. 581, n. 15b.
12.92,0 @ 21,20 (hg' \.
295-296 d.c.
senda.fl.. Monogrutntnu ffi . Entro ghirlanda'
- -{s6s565
+..r5vs'1992; 503'504-
6.90,7 @ 11,s0.
AUTORITA INDECIFRABILE
IV-V sec. d.C.
COSTANZO CLORO Roma lv1. Ercuteo 312_18 d.C. 1
Zecca: Roma. zs7-zss d..c. il:il: *,^:,ji}fi, ll8Í.8. ;AE, Frazione di follis. Roma Cosranzo II 355-61 d.C. 7D. CONSTANTIVS NOBC. Roma Costanre I ttz-sa d.é. rc
ll::o ."'.*. a d. radiato, barbaro e drappeg- [:il: ;:i:l[.*" trlitilE il:3,!,
,LYot XX, in una ghirtanda; sotto H. Bordo per- i,:H l:","1",',il""" trii\]i:E frIrnato. . Siscia Valenriniano zài-is a.é. zjRIC Vf p. 360, n. 89a Tessalonica cosranre r sàz +ó J.è. 141'3. g2,8 @ 20,10 (Fig.s). Tessalonica Valente 36+67 d.C. 34Treveri Valentiniano 364-67 d.C. 17-20
Zecca: Caico.Come è possibile notare dal confronto fra i dutschemi, le monete rinvenute in proprietà Fasolinc .e in località Pareti sono da coloìarè in un ambitrcronologico più ampio rispetfo a queUe del tesoret.to, anche se i.l numéro deúe zecchà altestate è limitato.Piu articolata è l'ana[si che possiamo ricavare dal_l'esame del ripostiglio. Nonostante esso dovesseessere stato occultato, presumibilmente, intomo alQ5 d.C.r?. quasi tutti i'nominali documentano unacircolazione di IV sec. d.C.
AE. 330_335 d.C.D VRPS ROM [A]. Busto di Roma a s. elmata, conmantello imperiale.R. Lupa a s., rehospiciente, che allatta i gemelii;sopra due astri. [n eserqo SMKA.LRBC I, p. 28, M. 1247:9.1,4.92,2 @ 17,70 (Fig.6).
Riassumiamo, nei seguente schema, le zecche diprovenienza, le autorità e le relative datazioni.
Datazione N. di Cat.Costantinopoli Marciano 450-SZ d.C. 6Nicomed.ia 5
330-37 d.C. 2Tessalonica Arcadio 383-86 d.C. 4
Località pareti
Zecca Autorítà Datazione N. di Cat.
Le zecche straniere rappresentate, oltre Roma, sonoben nove, dieci se consideriamo anche gii esempla_ri provenienti dalle contrade Ungari é pareti.^ Laqual cosa desta non poca me.avi"glia in quanto èabbastanza chiaro che la loro presinza in'loco nonè da attribuire al caso. Le monete non aoDartene_vano a milizie o mercanti diretti allrove à'solo.u_sualmente fermatisi a Nuceria; questa doveva esie_re certamente una meta di rilievo, segno che nel IVsec. d.C. i movimenti di monete - e li conseguentecircolazione di beni che essi possono teslim"oniare- furono ivi certamente articolati e vivaci.
Proprieià Fasolino
Cizico Galerio Mass. 2gs_96 d,.C. 12_ . re cerramente una meta di rifievo, segno che nel IVCizico caterio Mass. 330-35 d.c. i; tg. d.c. i movimenti di monete - . li .onr.gu.nt,Roma crispina 180-87d.c. 9 circolazione di beni che essi possono teslimoniareRoma probo 267-82 d-c. i.-r - r".onó-iuì ...t.ì.ii. .ii.o"rì'u'J'i'*.tRoma c. cloro 297-gB d.c. it Oilol. ,ottotir,.are un altro elemento che mi sem_
Consideriamo ora_ ii ripostiglio citato. Esso fu rin- bra interessante e cioè che una presenza monetariavenuto nel 1966, durante i lavori di riammodema- molto simi.le 3 ggella nucerinà è registrata nellamento deila linea ferroviaria ed era formato da villa romana di Minori *, situata pocó distante, incTquecento _Pezzi circa, contenuti in un vaso, di linea d'aria, da Nuceria dove, relàdvamente al iVcui meno del 10% risultarono leggibili à. Nel ricon- set. d.C., sono state rinvenuie monete appartenentisiderare il t.t9t.jtg: partendo dii'ottica che ispira alle seguenti zecche: Alessandria, Àluiieìa, Cizico,quesia nota,.si dà di seguito lo schema con l'eleico Costanlinopolì, Roma, Siscia, Tessaloirica e Treveri.aer pezzi schedati Per zecca e relativa cronologia. Monete delle stesse zecche, come è possibile veri-
proprierà Fasolino ficare dalla comparazion_e-coi dati?ràcedenti, sonorità Datazione N ài cnt state. rinvenute anche a Nuceria. Da rilevare che iiiM""a"" t::l::L, y::,Wf, t 1!.' nominar dì ú;;;;";;;;;;lJà,i. zone deuaAntiochia Diocleziano 196 d.c. i uiXu. E interessante questJ corrispondenza di zec-Aquileia' Varenre -i67-75 d.c. ,s -Therttestata da monéte isolata a 'o."".t.
"gg.ità-àiArelate Graziano 367:71q9 iò tesaurizzazione, rinvenute in due contesti differen-!yi.o Massimiano 29s-gg d.c. i ;":;--^n J:^!^-!: L_ r,cizico ;.;;;-.- ,;íílti.E .i ri. ma. non distanti fra loro. Non credo che taleCizico Arcadio 388-92 d.C. À cllcostanza possa essere attribuita al caso, mentreCostantinopoli Costanzo II 351-55 d.c. &, deve essere considerata una chiara testimonianzaEraclea Procopio 36L67 d.c. 3; di movimenii commerciajj piu ampi ed intensi cheRoma Costartino 314 d.C. 3 ir,.ro"ri,.,"^ ";" ;r iì.^--i^i:';r.;:::1,:- ,investirono sia il litorale chè l,hintèrknd di quest,a_
rea della Campania e la cui intensitàr" nonostante idati prowisori in nosho possesso, sembra assume-re toni d'una ceÉa rilevanza.Non è possibile affermare che Nuceria ebbe unruolo di rilievo durante il periodo imperiale maritengo che la presenza in loco dt abbondanie nu-mera-rio, provefuente da località così lontane e così
distanti fta loro, sia la spia duna grande attenzionemostrata per questo cenho, a testimonianza di unsuo ruolo tutt'altro che marginale.Nel futurq quando meglio saranno c-hiariie le vi-cende di ciúà apparentemente secondarie come
Nuceria, verrà se-ni'altro offerto un contributo no-tevole alla conoscenza della storia più in generale.
BELIOGRAIIA
La bibliografia viene. segnalata in ordine alfabetico, con l,ag-giunta dell'anno d'edizione. Tuttavia, per quel che risuarda"imanuali di larga consultazione, non iroiegn'alato l'anni di edi-zione, attenendomi all'uso conune.
AvELLLNo 1836
F.M. Ave^r-rNo, Srcondo nggio di ossmnzíoni numismatithe, Hy-rium, n Opuscali diuersi, TIl, Napolì 1836.
LAMPO I916
M. Cavro, Lns monedas de Ebusus, Bascelona 1976
|-ATALLI ]9/ 2F. Carar u, Soprùúendenza archeologira d.elle pro.,ince di Salemo,Auellino e Benr,:enlo, in htnali dell'Islituta tlnliano diNumísmatica,18-19, 1971,-72, p. 309.
D'AcosrrNo 1970
B. D'AcosrrÀio, Norera Supuíore, n Enciclopedia de 'Arte Antíca,Supplen en to N7 A, pp. 547 -!A8.
Fronelu 1845
G. Fronrrrr, Monefe inedíte dell'ltnlía alfica, Napoli 1845.
Fnarrr 1990
AA.W ., Fratte, un insedíamento etrusco - campano, Modena 7990.
GrurnsoN-Mnys 1992
P. GnnnsoN - M. Mavs, Catalogue oJ late rcntn coins in lheDumbarlon Oak colleclion and in llw Whittenorc collection. FromArcadius and Honoríus t0 the accessíln of Anastasíus. Washin$on1992.
Lmpno MaNclEnr 1984
G. Lmrno M,a.Ncmnr, Ríntsenimento dí una moneta di branzo diVelía: nota sulla fne della monetazione della città, n Rítísta ltalianadi Nunísmatica, LXXXVI, 1984, pp. n3-n7.
Lmrno Mr,Ncrenr 1988
C. Lmmo M,rNcmru , La oílla romana dí Minoù il futo nunisna-tíco, in ApoI!0, Ballettino deí Musei Prwincklí del Salernitano, yI,1988, pp. 165-194.
Lmsno M,rNclenr 1990
C..Lrseno MaNrcreR.r , Soprinlendenza artlualogíca dtlle prooúrc díSalerno, Aucllino t Btnnrnto, in Annali dtll'lsìíntu atiano di Nu-mísmatica, 37, 1,990, pp.216-223.
Lmeno Marucrenr 1992
G. Lmeno MaNcreru , Spigolature nunismaticlu. Su alcune moneted'Eoca ellenistíu delk colluione Foresio, prooenientí dalle Batearí,in Atti dell'Acudenia Pontaníana, ns., XLI,1992, pp. 97-101.
LRBC IP.V. FIn-r - J.P.C. KErr, Iate rcmrn bronu coínage. paúI. TtEhonze coinage of tlu Hause oJ Constantine A.D. 324446, London1960.
RIC \," 2P.H. WEBB, TIu roman impuial uinage, Y, 2, London 1933.
RIC \TC.H. Smrenr-nrvo, Tlu roman imperial caimge,YII. From Díocle-lian's rt.form to the dulh of Maxininus. Londón 1967
RIC \,'ìI
f,M. Bnyuri-, The rotnan impeid coímge, \\,. Constantinus andlrZírias, London 1972 12 eù2.).
Rmxzzo 7937
F. R:nezzo, Ia neoopoli dí Imum (Fralte) e le sue attinenze stoim-topograficlu, n Rruista lndo-greco-ítalia, XXJ., 1937, pp. SLSB.
RonenrsoN VA.S. Ronrnr:oN, Romau mpnial caius in tlu Hunler coin ubincl,V. Oxford 1982
5OGLIANO 1YJlA. SocuaNo, Pomp eí proomana, Roma 1937, p. 15& n. 1.
SrAzro 1955
A. Sr azo, Rapponi Jra Ponpeí ed Ebusus nelle Balarí nlk luce deirinoenimenti monetari, n Annali dzll'Istítuto ltaliano di Numísma-tica, 2, 1955, pp. 33-57.
Sttzto 1990
A. Srazro, Le monete, nM. Russo, Palfn delk Campanelln. Epí-graJe rupestre osca e rcperti urí dtII'Athenaíon, a cura di P. ZancaniMon]luoro, Acudemín Nazionale dei Lincei, Monumentí Antichí, s.
miscellanea, fr, 5, Roma 1990, pp.267-272.
Tnav,rnv 199i
l. l*u^fl, Mo.re eaidenu on tfu find oJ coins oJEbusus in ltaly,n Rmue Belge de Nunilnatique d dt Sigitlographie, CXl,Xln,1991., pp. 193-197.
ZaNcaNr 1949
P. ZaNc,rNr Momt ono,Il Jiume Inríno, n Ln Parola dtt passato,
X,1.949, pp. 61-68.
Z,rNcaNi 1990
P. Z,rNcarlr Morru oto,Illnrte antiút della Canpania, nM.Ruvw, Punta della Campawlh. Epigrafe rupatrc oxn e rEeni wi dall'Ai-henaion, a cura di P. Zanani \llntuoro, kedtnin Nniowk deí Lincei,Monunnti Antíchi, s. mLutlkrca,lll, 5, Roma 19%, pp. 27L2J4.
Note
t Tmlascio questo argomento che esula i lirniti del mio conki-buto, ma che viene afftontato, in questo stesso voiume, Il tomo,da R. Cantilena, La monetmbne di Nucnía AlJaterna, pp.9-20.2 Su ta.le argomento, in generale, si rinvia ai numerosi interventisvolti al seminario Vita e slpra-Ltuipenu delb moneta antíu, tenu-tosi a Ravello nel 1990, e non ancora editi.3 Hanno cercato di dare un'interprctazione a.lla leggenda il Rt-
BEzzo 1937, ed il SocLr^No 1937. Ma essa ..atterdt anc\rc diílinguistí una conaincenle spiegazione't. Sr,tzo 1990, p.268, n. 11,.. *tzo 1990, p.269, îe dporta tutti i rirvenimenti con lerelative datazioni.
' È Ia considerazione di SrAZro 1990, p.268, che mi hova con-
corde.u V. FroneLU 1845, p. 4, seguito da altri, segnalati in Srazo1990, p.270, n. 32.
' L'ipotesi risale alì'Avelltro 183ó, pp. 109J14 e viene soste-
nuta dalia Ze,,-cex,r i949 e da STAZIo 1990.s ZeNc.q.N'r 1949., L'ipotesi diventa più complessa per cui rinvio, per il dowtoapprofondimenio, a IRAr-rE 1990 dov'è delineata un'ampia sin-tesi di tutte le proposte e dei nuovi orientamenii avanzati per iJ
centro etrusco, con bibllografia compleia.10 ZANcANT 1949 e Srazro 1990, p.270.
'! ZA^\CANÌ 1990.
'r Si rin\.ra agli hteryenii che precedono il mio, in questa siessa
sede.B Cfr. Senuo Ad Aen. \U,,738. Fntsro, però, la definiva ncilftì
deiTirreni, (Hist. Gr., fr. 41). Chiunque l'abbia fondata, il proble-ma dibase non carnbia: Nuceria era un cenho d'orgini autoctone.r.' D'Acosr!,No, 1970.r5 Isola delle Baleari, moderna hiza in Spagna. Sulla moneta-
zione di questo centro, cf. C,qvpo 1976; sulla circolazione, v.pp. 93-98 dello stesso volurne, con le iniegrazioni segnalate, inquesta sede, alle note successive.,u SrAzro 1955.r7 LmERo MANGTERT 1990, pp.207-208.
t3 LmERo MANGTEzu 1992, p.99.1, Su Velìa, v. G. LmERo MANGIERI, Velia: problemí dí circoltzio'ne monetarit, n Vita e soprnzniaenn dzlle monete antitlt, op. cit.,
Su Paestum, v. G. Lmrno MaNcmru , Ln monetazione dí Poseído-
nin-Paestum e VeIín nelb colluione Snllusto, in corso di stampa
nelle monografie del Bolltttino ài Nunísnali.r del Ministero per
i BB. CC. ed AA. Per gli alki luoghi di rinvenirnento di quesie
moneie, v. da ultimo, Tnavanvr 1991.,o V. LmERo MANGTERT i984.,r NatuÌalmente si traita d'una competizione limiiaia, di cuil'agro nocerino sembra essere, allo stato aituale, la punta piùavanzata verso settenkione., Sappiamo che Paestum ernise moneta fino all'epoca di Tibe-
rio; ma è un episodio isolato, che non hficia in nessun modo la
validità di quanto asserito.a. Capiia spesso di rinvenire monete con indicazioni di prove-
nienza urutiLizzabìli, per l'imposibilità di decodificare quella
che era una tenninologia momentanea o personale, adottata
dall'estensore di tali inrijcazioni, e ciò, talvolta, anche a causa
della scomparsa dello stesso cornpilatore.,1 RinSrazio vivamente M. Conhcello De Spagnolis per avermi
affidato lo studio del materiale in esame ed il Soprurtendente,
dott.ssa G. Tocco Sciarelli, per l'autorizzazione alla pubblicazione.r L'autorità non viene segnalata in quanto l'emissione non è
riconducibile ad un'autodtà emittente.,6 CATALU 1972 èttede una prima notizia del materiale, che fusuccessivamente edito da LEERo M,{NcIEFJ i990. Si rhvia a
quest'ultimo articolo per la descrizione e le misure dei shgolipezzi.i'La riserva è dovuta solo alla circostanza che il 90% delle
monete è illeggibile. L'esemplare più tardo appartiene ad Ono-
rio (c,1. Lmeno MaNcirru 1990, p. Tn, n. 4f, e non è stato
riportato nello schema precedente in quanto non è possibile
risalie alla zecca che l'ha emesso.?J Cf. LEERo MANcrezu 1988.