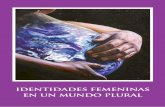Conoscenza dell’autore e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea, in V. Maraglino...
Transcript of Conoscenza dell’autore e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea, in V. Maraglino...
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 9
PAOLO MASTANDREA Università Ca’ Foscari di Venezia
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 1. Se in tema di ‘trasmissione dei classici’ noi diamo uno sguar-
do retrospettivo all’insieme, il fatto che il capolavoro di Plinio natu-ralista sopravviva nella sua integrità rappresenta una vicenda a lieto fine abbastanza rara, quasi ‘miracolosa’ per un testo di tale ampiezza: la sorte diversa toccata lungo i secoli dell’alto-medioevo a Livio e a Trogo, a Tacito e ad Ammiano – tralasciando altre gravi perdite totali da lamentare, inclusa la produzione storiografica dello stesso Plinio – dimostra quali danni potessero subire anche i maggiori monumenti della prosa letteraria latina. Furono d’aiuto alla Naturalis Historia forse l’utilità pragmatica sul piano universale, forse la presunta lati-tanza di inclinazioni ideologiche al suo interno: certo è che neppure un folto numero di adattamenti e di antologizzazioni impedirono al tratta-to di varcare illeso la strettoia dei trasferimenti da rotolo a codice, poi attraversare le membrane della rinascenza carolingia, ed ancora le carte e le stampe dell’umanesimo quattrocentesco, fino ai nostri giorni.
Concepita quando Roma «à l’apogée de l’empire» poteva dettare al mondo i propri stili di comportamento (assetti politici, regole eco-nomiche, gusti artistici, mode culturali), l’opera offriva una sistema-zione alle conoscenze scientifiche e tecnologiche correnti all’epoca, in forma di summa programmaticamente incompleta e volutamente ‘non originale’ delle cose da sapere sulla natura – cioè sulla vita de-gli uomini1. Pochi decenni appena dopo la loro composizione, quei trentasei volumina (più uno preliminare con indici di contenuti e fon-ti) costituivano un immenso deposito di materiale pronto ad ogni re-impiego: breviari e compendi – magari anonimi o pseudepigrafi; epi-tomi parziali organizzate per soggetti e argomenti disciplinari; ove necessario, rielaborazioni poetiche come il Liber medicinalis di
1 Così Plinio, con professione di modestia reclamata dalla sede incipitaria (praef., 13): Rerum natura, hoc est uita, narratur, et haec sordidissima sui parte ac plurimarum rerum aut rusticis uocabulis aut externis, immo barbaris etiam, cum honoris praefatione ponendis.
Paolo Mastandrea 10
Quinto Sereno. Salvo eccezioni (la medicina appunto, l’astronomia e la geografia, la computistica de temporum ratione), nel mentre l’attività speculativa del libero pensiero refluiva in misticismo irrazionalista e simbolismo magico-religioso, la curiosità di escertori e comuni lettori si esercitava sopra un oggetto tipico, onnipresente nelle pagine pliniane: lo studio dei mirabilia, cioè dei fenomeni che sembrano sfuggire alla norma e si tendono a definire ‘soprannaturali’2.
Non so se abbiano ragione quanti sostengono che l’interesse nei confronti dell’ignoto – ancorché materia da valutarsi alla stregua di ‘sub-science’ – favorisca pur sempre una diffusione della conoscenza, addirittura possa riuscire propedeutico alla genuina investigazione spe-rimentale3; ciò sarà forse accaduto in rapporto alle circostanze sociali e intellettuali in cui svolse i propri compiti Plinio: ma nemmeno un secolo dopo – nel clima di ansietà dove vagolavano, per esempio, le anime in-quiete di Apuleio o di Elio Aristide – già molte cose erano cambiate.
Nonostante il preambolo di fede panteistica messo dall’autore in testa all’esposizione4, e gli sguardi ironici deposti sulle assurdità del-le comuni credenze religiose5, e l’evemerismo spontaneo cosparso su
2 Sul tema fioriscono ottimi studi recenti, a partire da M. BEAGON, Roman Na-ture: The Thought of Pliny the Elder, Oxford 1992, pp. 26-54; si vedano ora le ri-sposte di Valérie Naas alla domanda «Why the mirabilia in the Naturalis Historia», in R.K. GIBSON-R. MORELLO (edd.), Pliny the Elder: Themes and Contexts, Leiden-Boston, 2011, p. 70.
3 J.F. HEALY, Pliny the Elder on Science and Technology, Oxford 2000, pp. 63-70, in particolare p. 70: «However, this interest in the inusual and sometimes bizarre may, in a sense, constitute a logical, preliminary stage on the way to genuine ‘scientific’ curiosity»; non diversamente V. NAAS, Imperialism, mirabilia and knowledge: some paradoxes in the Naturalis Historia, in GIBSON-MORELLO (edd.), Pliny the Elder cit., p. 66: «In his approach to nature Pliny does not choose between a magical conception of things and the drive to explain them. He does not even seem to be aware of a tension between these alternatives». Secondo l’autrice, solo agli occhi nostri ciò contrasta con lo scopo ‘scientifico’ dell’opera, ma al tempo di Plinio le alternative fra razionalità e paradosso non erano così marcate; e conclude, p. 67: «We must not seek in the mirabilia a proof of the decline of knowledge. They simply reflect a different kind of knowledge: one more attractive, which appeals to a larger audience and which is accessible to it. In this way, the mirabilia contribute to the diffusion of knowledge».
4 Su cui S. CITRONI MARCHETTI, Plinio il Vecchio e la tradizione del moralismo romano, Pisa 1991, pp. 21-30 e passim.
5 Tra i capitoli 14 e 18 del secondo libro, l’autore fornisce un elenco di “errori popolari degli antichi”; alla fine di questo si colloca la celebre frase (peraltro utile a esaltare l’ethos del principe Tito): Deus est mortali iuuare mortalem, et haec ad
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 11
tante narrazioni di episodi ‘miracolosi’6, divenne questo un luogo deputato all’incontro fra i continuatori della tradizione enciclopedica romana (libresca, scolastica, adiafora: insomma, neutralizzabile) e i Padri della Chiesa. Come al solito Agostino si dimostrò un autentico sovversivo: agitatore disinibito, propagandista senza eguali, nella in-cessante polemica contro la cultura classica mirava a individuarvi e colpirvi ogni minimo elemento servisse a logorarne il prestigio, in-debolirne la credibilità, dissolverne l’egemonia sulle coscienze; quando verso la conclusione del De civitate Dei (XXI, 8) dettò il fa-moso principio per cui portentum fit non contra naturam, sed contra quam est nota natura7, intendeva così rimarcare spietatamente l’insufficienza di quanti, scienziati e filosofi, avevano lavorato nei secoli per elargire risposte alle fondamentali domande dell’uomo, laddove con gli inviti continui, diretti o per interposta persona8, ad «admettre le merveilleux»9 – cioè a gonfiare senza misura la sfera aeternam gloriam uia. Hac proceres iere Romani, hac nunc caelesti passu cum liberis suis uadit maximus omnis aeui rector Vespasianus Augustus fessis rebus subueniens.
6 Talora interpretato come denuncia a-teologica; quando l’ardente diciottenne Percy Bysshe Shelley si mise a scrivere il pamphlet che gli sarebbe costato l’espulsione da Oxford (1811; riedito di recente: The Necessity of Atheism, and Other Essays, Buffa-lo NY 1993; e in italiano: La necessità dell’ateismo, Roma 2012), per l’appunto credet-te di trovare conferme alle sue teorizzazioni in materia presso vari luoghi della Natura-lis Historia. A sostegno del fatto che «the enlightened and benevolent Pliny thus pu-blicly professes himself an atheist», egli allegava tra l’altro Nat. Hist., II, 14: Quaprop-ter effigiem dei formamque quaerere inbecillitatis humanae reor. Quisquis est deus, si modo est alius, et quacumque in parte, totus est sensus, totus visus, totus auditus, to-tus animae, totus animi, totus sui eqs. Occorre aggiungere che il pubbblico anglofono conosce di solito il passo di Plinio (e in tale forma l’inciso si legge sin dai vecchi di-zionari del Webster) nella forma Quisquis est Deus – si modo est aliquis, il che suona pressappoco [ad esempio nel testo Loeb tradotto da H. RACKHAM (ed.), Pliny, Natu-ral History, I, London and Cambridge (Mass.) 1938]: «Whoever God is – provided there is a God»; il livello di scetticismo religioso normale per un autore antico risulta così notevolmente innalzato, senza scampo.
7 Le giustificazioni dottrinali offerte da Agostino, a fronte delle deroghe alle leggi di natura, sono utilmente discusse nel lavoro di F. PORSIA, Liber monstrorum, Bari 1976, pp. 27-30.
8 Si allude ai profondi ripensamenti che il Santo conosce nei suoi ultimi anni di vita in tema di guarigioni e di miracoli, ma anche al ruolo attivo che in questa “nuova propaganda” (P. BROWN, Agostino d’Ippona, tr. it. Torino 20052, p. 424) il vescovo di Ippona delegò ad alcuni suoi allievi come Orosio ed Evodio.
9 Espressioni di rara sensibilità (e genuino affetto per il protagonista del suo studio) sul nodo dei rapporti fra erudizione tradizionale, scienza e curiosità verso i
Paolo Mastandrea 12
dell’inconoscibile – egli faceva uso di mezzi occulti onde spingere le masse tra le braccia protettive di una religione nuova, però già istitu-zionalizzata rigidamente. Il cui primato non doveva essere agevole da realizzare, e lo si sarebbe visto nei secoli a venire.
Esiste oggi in letteratura un buon campionario di interventi dedi-cati alla fortuna di ‘Plinio tardoantico’, cioè alla diffusione della Naturalis Historia in fase premedievale. Senza rimontare troppo in-dietro con la bibliografia, le sintesi tracciate nell’ultimo trentennio da Angelo Roncoroni, da Guy Serbat, da Arno Borst10 offrono docu-mentati panorami sulla situazione intorno alla metà del sesto secolo – il segmento temporale da noi prescelto. Vi si cita ad esempio Vere-condo di Junca: il vescovo di questa cittadina africana (situata nella provincia Byzacena), poeta e commentatore delle Scritture11, stimò doveroso porgere ragguagli sulle dimensioni della balena che in-ghiottì il profeta Giona, invitando a leggere Physicorum historiam peri-torum, Plinii Secundi, Solini aliorumque multorum12. Poco prima mirabilia, ha seminato H.-I. MARROU, Saint Augustin et la fin de la culture anti-que, Paris 1983 (= 19584), pp. 143-157.
10 A. RONCORONI, Plinio tardoantico, in Plinio il Vecchio sotto il profilo stori-co e letterario, Atti del convegno (5-7 ottobre 1979), Como 1982, pp. 151-168; G. SERBAT, Pline l’Ancien: Etat présent des études sur sa vie, son oeuvre et son in-fluence, in ANRW, II, 32, 4, 1986, pp. 2069-2200; A. BORST, Das Buch der Natur-geschichte. Plinius und seine Leser im Zeitalter des Pergaments, Heidelberg 19952; si aggiunga C. FRUGONI, La fortuna di Plinio nel Medioevo e nel Rinascimento, nota bibliografica a Plinio Secondo, Storia naturale, I, Torino 1982, pp. LIX-LXVI, e ora la voce di F.R. BERNO, Plinius d.Ä., in Der Neue Pauly, Suppl. Bd. 7, Stuttgart 2010, coll. 697-726.
11 Il prelato cattolico compose i suoi Commentarii super cantica ecclesiastica fra il 534 e il 550 (gli estremi sono fissati da D. PANIAGUA, Solino como fuente pa-ra la exégesis bíblica de Verecundo de Junca, «Helmántica» 58, 2007, pp. 197-222: p. 201); l’edizione completa dell’opera esegetica e del carmen de satisfactione paentitentiae si deve a R. DEMEULENAERE (ed.), Verecundus Iuncensis, Commen-tarii super cantica ecclesiastica, Turnholti 1976; dopo il 548, durante le controversie fra diocesi occidentali e Giustiniano per la questione dei Tre Capitoli, si segnalò tra i collaboratori più leali del papa Vigilio di fronte a prepotenze e ingerenze del-l’imperatore, sino alla propria morte, avvenuta a Costantinopoli nel 552; a lui allude con ossequio deferente Corippo in Ioh., VII, 479-494 (su cui V. TANDOI, Note alla Io-hannis di Corippo, «Studi italiani di filologia classica» 75, 1982, pp. 47-92: pp. 80 s.).
12 Allargando al contesto la lettura del passo, si ricava l’idea di una distinzione netta tra le fonti profane e cristiane (PANIAGUA, Solino como fuente cit., p. 204): Quod si naturalis beluae huius magnitudinem velis audire, lege physicorum historias peritorum, Plinii Secundi, Solini aliorumque multorum, in nostris autem
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 13
l’enciclopedia pliniana era stata sfruttata dal monaco Dionigi il Pic-colo, a fini di computo cronologico, così come dal suo amico Cassio-doro, a proposito di geografia storica13: ma le tracce di una esplora-zione sistematica e continuativa – ciò che potrebbe offrire indizi su una disponibilità dell’opera integra – appaiono scarse o nulle. Inoltre tutti quegli scrittori, e altri contemporanei che affermano di rifarsi al-la Naturalis Historia, ovvero a riassunti del trattato, erano occidenta-li, comunque si esprimevano in latino; non conosco invece ricerche sulle forme e i modi della ricezione del testo entro gli ambienti gre-cofoni di più elevata cultura di Costantinopoli, nello specifico da par-te di un personaggio assai curioso del suo tempo: Giovanni Lido.
Si tratta di una singolare figura di filologo amatoriale, cultore di antichità latine, o perfino di quelle dottrine etrusche che all’alba della città di Romolo avevano influenzato i culti e gli apparati politico-religiosi, mantenendo sino all’ultimo un’aura di prestigio ben avver-tibile presso le classi superiori della società14. Lido era coetaneo di Giustiniano, nei cui officia svolse gran parte di una lunga e soddisfa-cente carriera; al di fuori di quanto egli si compiace di raccontare su se stesso (non poco, davvero), otteniamo utili notizie dalle pagine di
Ioannem Constantinopolitanum in libro quem de natura bestiarum scripsit. Et invenies balaenam tantae latitudinis longitudinisque corpus habere ut mensuram trium habeant et amplius iugerorum, ita ut cum fallendis nautis enatant super aquas, insulae ab ignorantibus existimentur. Ma mentre sotto il titolo De natura bestiarum si individua subito il Physiologus, talora attribuito a Giovanni Crisostomo (DEMEULENAERE, Verecundus Iuncensis, Commentarii cit., p. XI nota 2), l’unico rinvio che possa proporsi alla Historia di Plinio (Nat. Hist., IX, 4: così DEMEULENAERE, Verecundus Iuncensis, Commentarii cit., p. 169) sembra troppo vago per servire ad uno qualsiasi dei nostri scopi.
13 Utile in generale M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Enciclopedismo e sapere cristiano. Tra tardo-antico e alto Medioevo, Milano 1999, pp. 81-107; la familiarità di Cas-siodoro col testo di Plinio si dimostra col numero di diciotto loci elencati nell’indice nelle Variae dell’edizione di Å.J. FRIDH, Magni Aurelii Cassiodori, Variarum libri XII, Turnholti 1973, p. 584; riguardo alla Naturalis Historia quale probabile fonte per la geografia dei Goti, segnalo A.S. CHRISTENSEN, Cassiodo-rus, Jordanes and the History of the Goths: Studies in a Migration Myth, Copen-hagen 2002, p. 66.
14 Sull’argomento esistono indagini specifiche: per tutte, D. BRIQUEL, Chrétiens et haruspices: la religion étrusque, dernier rempart du paganisme romain, Paris 1997; forse superfluo ribadire che la quasi totalità di quei testi, antichi e antichis-simi – presenti sulla scrivania del dotto bizantino, oppure già a lui noti solo indiret-tamente – sono oggi perduti, così come i loro eventuali intermediari.
Paolo Mastandrea 14
Fozio; ecco come il futuro patriarca apre e chiude il capitolo 180 del-la sua Biblioteca15:
Ho letto di Giovanni Lido di Filadelfia, figlio di Laurenzio,
tre trattati: Sui segni divini, Sui mesi e Sulle magistrature pubbli-che. Orbene, il trattato Sui segni divini – per quanto posso giudica-re in base alla mia esperienza – non si allontana per nulla, o ben poco, dalle favole della mitologia; quello Sui mesi, sebbene con-tenga molto materiale inutile, è tuttavia di piacevole lettura e con-tribuisce non poco alla conoscenza dell’antichità; lo scritto Sulle magistrature pubbliche offre un’indagine non inaccurata agli ap-passionati di tali argomenti.
L’illustre recensore si diffonde poi – all’evidenza, senza tropppa
simpatia – sugli aspetti formali, letterari e linguistici delle opere di Lido, e conclude:
Il nostro autore trovò impiego presso la prefettura del pretorio
all’età di ventuno anni, a quaranta fu avvocato, in seguito matricu-lario; è in un periodo successivo che – egli dice – compose i tratta-ti di cui abbiamo parlato e fu nominato dignitario di corte per de-creto imperiale. Quanto poi all’epoca in cui visse, egli conobbe il regno di Anastasio e attraversò interamente quelli di Giustino e del suo successore Giustiniano. In materia di religione, Giovanni sembra essere un miscredente, poiché onora e venera le divinità pagane; tuttavia, egli si mostra devoto anche al nostro Dio, e non dà perciò modo al lettore di capire in tutta chiarezza se la sua fede in Dio sia sincera o se si tratti di una messinscena.
Le cose che Fozio leggeva ci restano, e sono appunto16: il fram-
mentario De mensibus, dedicato alla organizzazione del calendario presso vari popoli antichi; il De ostentis, estesa raccolta di responsi divinatori e previsioni meteorologiche (riferibili ai lavori agricoli, ma
15 Leggiamo la traduzione italiana del testo condotta da Claudio Bevegni in N. WILSON (ed.), Fozio, Biblioteca, Milano 1992, pp. 307-309; una motivata e persua-siva interpretazione degli atteggiamenti di Lido in ambito politico-religioso ci offre A. KALDELLIS, The Religion of Ioannes Lydos, «Phoenix» 57, 2003, pp. 300-316.
16 Si tratta di libri composti fra quinto e sesto decennio del secolo, li diamo nel-la sequenza cronologica più probabile di stesura (J. SCHAMP, introduzione a Jean le Lydien, Des magistratures de l’état romain, I/1, Paris 2006, pp. LXXIX-LXXXIV; I. DOMENICI (ed.), Giovanni Lido, Sui segni celesti, Milano 2007, p. 39).
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 15
spesso anche a grandi eventi collettivi, bellici e politici) tratte dai segni celesti; il De magistratibus populi Romani, panorama storico-descrittivo delle istituzioni dai mitici tempi di Enea sino al lunghissimo regno dell’autocrate attuale, infaticabile nell’apportare al governo quelle in-novazioni in senso assolutistico che da Lido e dal suo entourage erano regolarmente disapprovate, e più o meno apertamente criticate17.
Alcuni lavori (già ‘classici’ quelli di Tony Honoré e Giuliana Lanata su Triboniano e la formazione del Corpus iuris civilis18; ed eccellenti ora le indagini di Antony Kaldellis sulle figure di Procopio di Cesarea e dello stesso Giovanni Lido), hanno messo in luce l’esistenza di correnti di opinioni ‘repubblicane’, ostili alle direttive politico-religiose di Giustiniano. Negli anni intorno al 550 la regia civitas sul Bosforo costituiva sicuramente il principale centro di studi della romanità, ricco di biblioteche bilingui ancora intatte, frequenta-to da una classe-media di funzionari formatisi secondo gli schemi in-veterati della cultura profana; ma soprattutto, vi risiedeva una gran parte dell’aristocrazia occidentale, poiché la guerra in corso da oltre un quindicennio coi Goti aveva fatto fuggire a Costantinopoli molti espo-nenti della vecchia nobiltà laica come della moderna gerarchia cattoli-ca – a partire dal princeps senatus Cetego e dal papa Vigilio; prove-niente pure dai ranghi dell’amplissimus ordo di Roma, quest’ultimo appariva uomo di attitudini meno religiose o spirituali che politiche e
17 Sono aspetti illuminati da studi recenti (A. KALDELLIS, Identifying Dissident Circles in Sixth-Century Byzantium. The Friendship of Prokopios and Ioannes Lydos, «Florilegium» 21, 2004, pp. 1-17 e ID., Republican Theory and Political Dissidence in Ioannes Lydos, «Byzantine and Modern Greek Studies» 29, 2005, pp. 1-16); meno incline a inseguire le tracce di anticonformismo politico-religioso era M. MAAS, John Lydus and the Roman past: antiquarianism and politics in the age of Justinian, London-New York 1992: autore di una monografia apprezzabile nel complesso (se ne veda la recensione in «Paideia» 48, 1993, pp. 158-162), però portata ad interpretare l’uso della cultura classica da parte di Lido in senso nient’altro che ‘neutrale’ – se non proprio ortodosso.
18 Rispettivamente, di T. HONORÉ, Tribonian, London 1978, si rilegga il capito-lo iniziale con quel memorabile ritratto di Giustiniano (a pp. 28-30 la documenta-zione sui paralleli di ‘carattere psicopatologico’ proposti con Hitler e Stalin); di G. LANATA, Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee, Napoli 1984, soprattut-to stimolanti si rivelano le osservazioni che motivano le spinte innovative e il con-tinuo interventismo dell’imperatore-legislatore, anche in questioni di carattere reli-gioso, come conseguenza della varietà e instabilità della natura (pp. 212-213, con i rinvii alla fortuna del tema dei mirabilia in Plinio; ancora, 234-236 e passim).
Paolo Mastandrea 16
diplomatiche: lasciatosi imporre sul soglio petrino con la sopraffa-zione e gli intrighi dai Bizantini19, si trovava ormai in lotta aperta con l’imperatore; verso entrambi quei capi, come su altri esponenti dell’emigrazione quale ad esempio Cassiodoro, si concentravano in-sieme la sospettosità morbosa di Giustiniano e la curiosità intellettua-le dei circoli da cui provenivano figure cospicue di letterati quali Pie-tro Patrizio e Procopio di Cesarea, Paolo Silenziario e Agazia Scola-stico. Naturalmente la folta colonia degli italiani, coi loro amici e simpatizzanti orientali, doveva favorire la circolazione20 oltre che la stessa redazione di opere scritte in latino – di genere vario, se erano attivi il cronista Giordane e l’anonimo dell’additamentum al conte Marcellino, il poeta epico Corippo e Massimiano elegiaco; o in lingua greca, sviluppando comunque temi di antiquaria romana: storiografici e politici, giuridici e filosofici; sfidando l’intolle-ranza di ortodossie totalitarie ancorché mutevoli, e talora in osse-quio a forme di religiosità tradizionali (la disciplina Etrusca, ap-punto21, ma anche culti misterici diversi, il misticismo ermetico, la rivelazione oracolare), da loro osservate con occhi ammirati quando non proprio devoti.
19 Nel marzo del 537, ai danni del legittimo predecessore Silverio (presunto filogo-
to), che morì per la violenza patìta; artefice del misfatto, secondo la Storia segreta di Procopio, era stata l’imperatrice Teodora: la cui morte, nell’estate del 548, forse ca-sualmente coincide con il deterioramento dei rapporti tra Vigilio e Giustiniano; per un inquadramento a grandi linee dei protagonisti e dei contenuti della disputa, si veda P. MASTANDREA, “Armis et legibus”. Un motto attribuito a Iamblichus nei Romana di Iordanes, in Atti del II Convegno Il calamo della memoria (Trieste 27-28 aprile 2006), a cura di L. CRISTANTE, Trieste 2006, pp. 315-328, in particolare pp. 321-324.
20 La questione è trattata con una buona quota di originalità dallo studio di B. ROCHETTE, “Latinum est: non legitur”. Lire le latin et traduire le latin en grec en Orient, in Scrivere e leggere nell’Alto Medioevo, Atti della settimana di studio (28 aprile-4 maggio 2011), Spoleto 2012, pp. 317-348.
21 Una tale attenzione verso argomenti così peregrini si può spiegare con una strategia di appeal esercitato all’indirizzo dell’aristocrazia romana da parte del-l’omologa élite senatoria orientale: atteggiamenti esibiti o sottointesi per inciso da Procopio di Cesarea (A. KALDELLIS, Procopius of Caesarea. Tyranny, History, and Philosophy at the End of Antiquity, Philadelphia, Pa 2004, pp. 109-112; ID., Prokopios, The Secret History with Related Texts, Indianapolis-Cambridge 2010, pp. LV-LIX), e forse con maggior coerenza da Pietro Patrizio, il potente pa-trocinatore di Giovanni Lido: il quale fu trattenuto durante l’ultima delle sue amba-scerie presso il re-filosofo Theodahd e rimase confinato in Etruria per circa quattro anni, a partire dall’estate del 535.
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 17
2. Ma torniamo a Plinio: la conoscenza della cui opera emerge sin-golarmente da tutti e tre gli scritti superstiti di Giovanni Lido, e in misu-ra superiore a quanto ci mostri l’isolata coppia di menzioni esplicite rin-venibili nel De ostentis; la prima al cap. 3, e il nome sta in coda a un elenco di scrittori di cose etrusche – stilato purtroppo nel disordine cro-nologico più totale – comprendente «Capitone e Fonteio, Apuleio, Vicellio, Labeone, Figulo e Plinio il Naturalista»22. L’altra è al cap. 7, dove per alcuni episodi di massi caduti inspiegabilmente dal cielo si fa appello alla autorità di Anassagora e di Apuleio23, oltre alla te-stimonianza autoptica – l’unica che offra un preciso riscontro nel det-tato dell’opera (Nat. Hist., II, 150) – di «Πλίνιος ὁ Ῥωμαῖος».
Ad un successivo esame, si scopre appunto che una certa presen-za di notizie ricavabili dalla Naturalis Historia, e soprattutto dalla cosmologia del II libro, è diffusa lungo l’intera produzione del poli-grafo bizantino – dunque non solo nel trattato Sui segni celesti, ove pure si concentra il maggior numero dei casi; d’altra parte emergerà una stranezza: la materia pliniana pressoché mai è abbinata al suo primo autore, e come se non bastasse talora risulta attribuita ad una fonte diversa, secondaria o fittizia, comunque da noi incontrollabile, che va sotto il nome di Apuleio. Cercheremo più avanti di offrire qualche spiegazione della cosa: basterà per ora un raffronto dei luoghi che al primo sguardo consente di verificare l’ampiezza del fenomeno. Diamo a destra il testo latino costituito da Beaujeu, mentre nella colonna a sini-stra l’ordine segue quello del racconto di Giovanni Lido, sin dalla ge-nerosa «Introduzione programmatica corredata da esempi di manife-stazioni prodigiose»24: potremo così apprezzare l’agilità e la scioltez-
22 Ecco il brano di testo originale secondo C. WACHSMUTH (ed.), Iohannis Lydi, De ostentis (Περὶ Διοσημείων), Lipsiae 18972: πλὴν ἀλλ’ ὅσον μοι γέγονε δυνατόν, ἔκ τε τῶν Θούσκων ἔκ τε τῶν ἄλλων ὅσοι τούτους ἡρμήνευσαν, Καπίτωνός τέ φημι καὶ Φοντηίου, καὶ Ἀπουληίου Βικελλίου τε καὶ Λαβεῶνος καὶ Φιγούλου, Πλινίου τε τοῦ φυσικοῦ, πειράσομαι ταῦτα πρὸς ὑμᾶς διελθεῖν. Si trova risposta alle legittime curiosità nell’introduzione e nelle note di commento di DOMENICI, Giovanni Lido cit.; ivi anche l’affidabile traduzione italiana del testo a cura di Erika Maderna.
23 Argomento sviluppato attraverso una puntuale discussione delle fonti da S. CITRONI MARCHETTI, La scienza della natura per un intellettuale romano: studi su Plinio il Vecchio, Pisa 2011, pp. 125-146.
24 Il titolo italiano è dato da DOMENICI, Giovanni Lido cit., p. 51; si tratterà dunque «degli oscuramenti solari e lunari (così infatti chiamano le eclissi), delle comete e delle loro specie, dei loro tracciati, dei lampi, dei tuoni, dei fulmini e de-gli altri prodigi celesti».
Paolo Mastandrea 18
za con cui il compilatore greco si muove entro il volume pliniano, rincorrendo le proprie necessità diegetiche; ciò costituisce un indizio – questo dato si può già anticipare – a favore di una padronanza sicura, quindi della consultazione diretta, dell’originale latino.
Iohannes Lydus, De ostentis Plinius, Naturalis Historia, II
4. ἔστι γὰρ ἐκ τῆς πολυμαθεστάτης ἱστορίας λαβεῖν ὡς ἥλιοί τε πλείους κατὰ ταὐτὸν καὶ σελῆναι πεφήνασι, γινομένου ἐξ ἀνακλάσεως τούτου. Τοιγαροῦν οὐχ ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην, ἀλλ’ἐκ πλαγίου τὴν λεγομένην ἀντιδίσκωσιν θεωρεῖσθαι συμβαίνει, ἢ ἀνισχόντων αὐτῶν ἢ δυομένων. Βασιλέων δὲ τοῦτο δυνατῶν κατ’ἀλλήλων ἐπαναστάσεις σημαίνει, ὡς ἐκ τῆς Καμβύσου κατ’Αἰγυπτίων ἐφόδου λαβεῖν ἔστι, καὶ ἐπὶ τῇ Νέρωνος καταστροφῇ, καθ’ἣν ἐπὶ μὲν τῆς Ἰουδαίας διάγων Οὐεσπασιανὸς πρὸς τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἀνεφέρετο, κατὰ δὲ τὴν ἑσπέραν Βιτέλλιος, Γάλβας τε καὶ Ὄθων ἑτέρωθεν ἀντανίσταντο. Ἀπουλήιος δὲ περὶ τῶν τοιούτων γράφων καὶ ὑπὸ Κλαυδίῳ Καίσαρι τρεῖς ἡλίους ὀφθῆναί φησιν, ὁμοίως δὲ καὶ σελήνας τοσαύτας ἐπὶ Γαίου Ἀννίου καὶ <Γναίου> Δομιτίου τῶν ὑπάτων· <ᾧ> ἄντικρυς ἐδηλοῦτο Γάλλους τε καὶ Σαυρομάτας τὰ Ῥωμαίων δῃώσειν […] Πολλά[κις δὲ καὶ διάπυρος ἀστήρ, ἀσπίδος ἀπομιμούμενος τύ]πον, ἐκ τῆς ἑῴας ἐ[πὶ τὴν] δύσιν Σπ[ινθῆρας ἐκπέμπων διατρέ]χει, [τῶν] Παρθυαίων [ἔφο]δον μαν[τευόμενος. καὶ τὰ μὲν ἐκ τῶν πρω]τοτύπων κέντ[ρων], ἀνατο[λὴν λέγω καὶ δύσιν. Οὕτως ἔστ]ι λαβεῖν· ἀπὸ δέ γε ἄρ[κτου] καὶ μεσημ[βρίας, οὐκέτι ἐφόδους βαρβ]αρικὰς ταῦ[τα ἡμῖν προ]δηλοῖ, ἀ[λλὰ βιαιοτέρας
99. Et rursus soles plures simul cernuntur, nec supra ipsum nec infra, sed ex obliquo, numquam iuxta nec contra terram, nec noctu, sed aut oriente aut occidente. […] Trinos soles et antiqui saepius uidere, sicut Sp. Postumio Q. Mucio et Q. Marcio M. Porcio et M. Antonio P. Dolabella et M. Lepido L. Planco cos., et nostra aetas uidit diuo Claudio principe, consulatu eius Cornelio Orfito collega. […] Lunae quoque trinae, ut Cn. Domitio C. Fannio consulibus, apparuere. […] 100. Clipeus ardens ab occasu ad ortum scintillans transcucurrit solis occasu, L. Valerio C. Mario consulibus. […]
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 19
ἀνέμων ἐκρήξεις. Καὶ εἰ μὲν] ἐξ ἄρκτου διᾴτ[των ἐκτρέχει αὔλακάς τε πυ]ρὸς ἐπὶ τὸν ἀέρα ποιεῖ, β[ρον]τώδεις λέ[γει διοσημείας, συστρο]φὴν ἀέρος καὶ [βορρᾶν] βιαιότερον ἀν[αστήσεσθαι, ἐκ δὲ τοῦ ἐνα]ντίου φερόμενος νότον ἐπάγει.
Fieri uidentur et discursus stellarum numquam temere, ut non ex ea parte truces uenti cooriantur.
5. Ὁμοίως ἔστιν ἑτέρους ἀστέρας εὑρεῖν ποτὲ μὲν ἐν γῇ, ποτὲ δὲ ἐν θαλάττῃ τὰς ἰδίας ἐνεργείας δεικνύντας· ἐπί τε γὰρ στρατιωτικῶν ἀκοντίων πολλάκις ὤφθησαν ἐφιζάνοντες ἐπί τε τῶν ἱστῶν τῶν νεῶν, καὶ ἐν ἄλλοις δὲ μέρεσι, λιγυρόν τι σύριγμα προσηχοῦντες καὶ ὀρνέων δίκην εἰς τόπον ἐκ τόπου τῆς νεὼς μεθιστάμενοι, ὡς ἂν καταδύσωσι ταύτην. Ὅθεν καὶ τοῖς ξηροτέροις τῆς νεὼς ἐμπίπτουσι μέρεσιν, ἐξ ὧν συντομωτέραν εἰκὸς γενέσθαι τὴν ἐκπύρωσιν. Τὸ δὲ τοιοῦτον σχῆμα ἤτοι κατάστημα οἱ τὴν θάλατταν πλέοντες Ἑλένην καλοῦσιν. Ἀλλὰ κἀνταῦθα τὰ ἐξ αὑτῆς ἡ πρόνοια δείκνυσι· δύο γὰρ ἀστέρες εὐθὺς κατασκήπτουσι τῆς τοιαύτης φορᾶς, οὓς Κάστορα καὶ Πολυδεύκην καλοῦσιν, οἳ παραχρῆμα πρὸς φυγὴν τὴν λεγομένην <Ἑλένην> ἐλαύνουσι.
101. Existunt stellae et in mari terrisque: uidi nocturnis militum uigiliis inhaerere pilis pro uallo fulgorem effigie ea; et antemnis nauigantium aliisque nauium partibus ceu uocali quodam sono insistunt, ut uolucres sedem ex sede mutantes, graues, cum solitariae uenere, mergentesque nauigia et, si in carinae ima deciderint, exurentes, geminae autem salutares et prosperi cursus nuntiae, quarum aduentu fugari diram illam ac minacem appellatamque Helenam ferunt et ob id Polluci ac Castori id numen adsignant eosque in mari inuocant. Hominum quoque capita uespertinis magno praesagio circumfulgent. […]
6. Πολλάκις δὲ καὶ [σ]πινθὴρ βραχὺς ἐκ μετεώ[ρων κα]ταφ[έρεσθα]ι δόξας ἐπὶ τὴν γῆν, εἶτα ἐξ ἐπιδόσεως εἰ[ς κύκ]λ[ον τι]νὰ σελήνης ὅμοιον [ὤφθη] δισκωθείς· τοῦτο, ὅπερ ἔναγχος γέγονεν, οὐ μετρίων προδοσιῶν τε καὶ τυχῶν παρεδήλωσε κίνδυνον. Καὶ ὄμβρων δέ τινας τεραστίους διοσημείας
100. Scintillam uisam e stella cadere et augeri terrae adpropinquantem ac, postquam lunae magnitudine facta sit, inluxisse ceu nubilo die, dein cum in caelum se reciperet, lampadem factam semel umquam proditur Cn. Octauio C. Scribonio cos.; uidit id Silanus proconsul cum comitatu suo.
Paolo Mastandrea 20
ἐπὶ τῆς ἱστορίας εὑρίσκομεν. Ἐπὶ μὲν γὰρ Ἀκελίου Μάρκου25 καὶ Πορκίου τῶν ὑπάτων γάλα πρῶτον, [εἶ]τα δὲ καὶ αἷμα κατενεχθῆναί φασιν. Kαὶ κρέα δὲ παραδόξως ἀνθ’ὑετοῦ κατὰ τὴν Βολουμνίου κατέπεσεν ὑπατείαν, καὶ ἔμεινεν [οὕ]τως οὐ γὰρ ἂν θηρίον ἢ πτηνὸν ἤ τι τῶν ἐμψύχων λιμῶξαν καθάψαιτο ἐκείνου τοῦ σώματος. Κατερρύη δὲ καὶ σίδηρος ἐπὶ Λευκανίας ἀνθ’ὑετοῦ, Κράσσου τὴν ἐπὶ Πέρσας [ὁρμῶντος ἐπιστρατεί]αν. Μαρκέλλου δὲ τὴν ὕπατον ἀρχὴν διανύοντος ἔριον κατενεχθῆναί φασι περὶ Κάψαν τὸ φρούριον ἐπὶ Μίλωνος· ὃ τοῦ τὴν χώραν ἐπιτροπεύοντος ἀναίρεσιν ἐμαντεύετο. Κατηνέχθησαν δὲ πλίνθοι πολλάκις ὀπταὶ καὶ κόνις, ὥσπερ ἐπὶ Ζήνωνος τοῦ καθ’ἡμᾶς. Ὅπλων δὲ καὶ σαλπίγγων ἀπ’οὐρανοῦ γενέσθαι διαφόρως ἔδοξεν ἦχος, ὅπερ λέγεται συμβῆναι κατὰ τὴν Κίμβρων ἐπιδρομήν, καὶ ἡνίκα τοῖς ἐμφυλίοις ἐκείνοις πάθεσι τὸ Ῥωμαϊκὸν διεταράττετο.
147. Praeter haec inferiore caelo relatum in monumenta est lacte et san-guine pluisse M’. Acilio C. Porcio cos. et saepe alias, sicut carne P. Volumnio Seruio Sulpicio cos., exque ea non per-putruisse quod non diripuissent aues; item ferro in Lucanis anno ante quam M. Crassus a Parthis interemptus est omnesque cum eo Lucani milites, quo-rum magnus numerus in exercitu erat; effigies quae pluit spongiarum ferri si-milis fuit; haruspices praemonuerunt superna uolnera. L. autem Paulo C. Marcello cos. lana pluit circa castellum Compsanum, iuxta quod post annum T. Annius Milo occisus est. Eodem cau-sam dicente lateribus coctis pluisse in acta eius anni relatum est. 148. Armo-rum crepitus et tubae sonitus auditos e caelo Cimbricis bellis accepimus, cre-broque et prius et postea. Tertio uero consulatu Mari ab Amerinis et Tuderti-bus spectata arma caelestia ab ortu oc-casuque inter se concurrentia, pulsis quae ab occasu erant. Ipsum ardere cae-lum minime mirum est et saepius ui-sum, maiore igni nubibus correptis.
7. Καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν εἰ προθεωροῦσιν ἄνθρωποι τὰ ἐσόμενα, τῆς φύσεως αὐτῆς προδεικνυούσης τὰ πράγματα. Ὥς που καὶ Ἀναξαγόρας ἐπὶ τῆς ἑβδομηκοστῆς καὶ ὀγδόης ὀλυμπιάδος λίθον μέγιστον ἐκ τοῦ ἡλίου ἐκπεσεῖν ἐμαντεύσατο, ὅπερ καὶ συμβέβηκεν ὕστερον ἐπὶ Θρ[ᾴκης]·καὶ μέχρι νῦν ἔστιν ὁ λίθος, καὶ ἐξ αὐτῆς εὐθὺς τῆς θέας περιπεφλέχθαι δοκῶν.
149. Celebrant Graeci Anaxagoran Cla-zomenium Olympiadis LXXVIII se-cundo anno praedixisse, caelestium lit-terarum scientia, quibus diebus saxum casurum esset e sole, idque factum in-terdiu in Thraciae parte ad Aegos flu-men, qui lapis etiam nunc ostenditur magnitudine uehis, colore adusto, co-mete quoque illis noctibus flagrante. Quod si quis praedictum credat, simul
25 Lo scioglimento scorretto della sigla prenominale (Marco anziché Manio)
indica in maniera incontrovertibile l’uso diretto da parte di Lido di una fonte scritta in latino.
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 21
Ταὐτὸ δὲ τοῦτο κατά τε Ἄβυδον καὶ Κύζικον συμβῆναί φησιν Ἀπουλήιος ὅθεν ἔτι καὶ νῦν λίθος ἐστὶ παρ’αὐτοῖς πυρώδης μὲν τὸ χρῶμα, σιδήρῳ δὲ ἅπας κατασεσημασμένος παραδεδόσθαι γὰρ λόγος Κυζικηνοῖς ὡς συναπολέσθαι τῷ λίθῳ τὴν πόλιν ἀνάγκη. Ἵππαρχος δὲ ἑξακοσίοις ἔμπροσθεν ἐνιαυτοῖς ἡλιακὴν προκατέλαβεν ἔκλειψιν. ᾿Eπὶ δὲ τῆς φυσικῆς ἱστορίας ὁ Ῥωμαῖος Πλίνιος λίθον ἑωρακέναι φησὶν ἐν Βοκοντίῳ τῆς Ἰταλίας26 ἐξ οὐρανοῦ κατενηνεγμένον ὥστε πολλὴ κοινωνία ταῖς διοσημείαις πρὸς τὰ γήινα, κἂν τοῖς ἀπὸ τῆς στοᾶς μὴ δοκῇ.
fateatur necesse est, maioris miraculi diuinitatem Anaxagorae fuisse soluique rerum naturae intellectum et confundi omnia, si aut ipse sol lapis esse aut um-quam lapidem in eo fuisse credatur. Decidere tamen crebro non erit dubium. 150 In Abydi gymnasio ex ea causa co-litur hodieque modicus quidem, sed quem in media terrarum casurum idem Anaxagoras praedixisse narretur. Coli-tur et Cassandriae, quae Potidaea uoci-tata est, ob id deducta. Ego ipse uidi in Vocontiorum agro paulo ante delatum.
3. Nell’ultimo dei paralleli presentati qui sopra – vale a dire Ost.,
7 a fronte di Nat. Hist., II, 150 – la corrispondenza si caratterizza per un riferimento doppio, tanto esplicito al nome dell’autore quanto puntuale verso un luogo dell’opera; il fatto che Lido ripeta ed accorpi la testimonianza riguardante Anassagora sembra inoltre offrire ga-ranzia di una conoscenza diretta del libro II della Naturalis Historia, mentre resta da spiegare perché, qui come in altri luoghi precedenti o successivi (Ost., 3 = Nat. Hist., II, 99; Ost., 10b = Nat. Hist., II, 96-98; Ost., 44 = Nat. Hist., II, 137), l’erudito bizantino riproduca il te-sto di Plinio quasi parola per parola, ma dichiari – in aggiunta o in alternativa – il proprio debito verso un’altra fonte, da noi incontrolla-bile: Apuleio.
A giudicare dagli epiteti che via via gli attribuisce, Lido nutri-va una grande considerazione per l’autorità del prosatore afri-
26 L’ennesimo errore di Lido (i Vocontii erano stanziati nella Gallia Cisalpi-
na, sulla riva orientale del Rodano) si spiega con una specie di volontà di ‘at-tualizzazione’, indebita e comunque ormai sorpassata dagli avvicendamenti ge-opolitici; infatti, dal 536 la vecchia provincia della Narbonense non faceva più parte della prefettura d’Italia: il re Teodato l’aveva ceduta ai Franchi in cambio di un sostegno (o meglio, di un non-intervento) allo scoppio della guerra greco-gotica.
Paolo Mastandrea 22
cano27, e questo sebbene gli studiosi moderni tendano a credere che il presunto trattato di argomento ‘scientifico’ fosse nulla più di una silloge di estratti da Plinio28. Ad ogni modo, oggettivi e in-dubbi sono i rapporti di strettissima affinità riscontrabili fra il te-sto lidiano e la Naturalis Historia: paralleli che dopo una breve in-terruzione29 proseguono in forma anonima nel capitolo 9, dove si tratta di eclissi di sole e di luna.
27 Forse rafforzata a sua volta dalla presenza di un’altra eventuale fonte inter-
media: Cornelio Labeone (sullo specifico, P. MASTANDREA, Un neoplatonico lati-no, Cornelio Labeone, Leiden 1979, pp. 82 s.); per i testi pseudoapuleiani di argo-mento medico, variamente collegabili all’opera di Plinio ma anche a Marcello Em-pirico e alla cosiddetta Medicina Plinii, si veda la parte iniziale della monografia di G. MAGGIULLI-M.F. BUFFA GIOLITO, L’altro Apuleio: problemi aperti per una nuova edizione dell’Herbarius, Napoli 1996, pp. 11-32 (con qualche referenza su Giovanni Lido a p. 26).
28 J. BEAUJEU (ed.), Apulée, Opuscules philosophiques et fragments, Paris 1973, pp. 177-180, ha raccolto e tradotto i presunti frammenti apuleiani traditi da Gio-vanni Lido sotto il titolo Astronomica; scrive ora SCHAMP, introduction a Jean le Lydien, Des magistratures cit., p. CIV, nota 94: «L’ouvrage d’Apulée, à en juger par le contenu des fragments, ne traitait pas d’astronomie ni d’astrologie, mais il était un recueil de Mirabilia, comme l’époque en a connu beaucoup»; lo stesso BEAUJEU, Apulée, Opuscules cit., p. 177, nota 3, dubitava della paternità dei mate-riali: «en tout cas, le rédacteur a surement démarqué et résumé séchement l’Histoire naturelle de Pline».
29 Nel capitolo 8 è contenuta un’allusione che mette in rapporto i segni celesti e un evento storico recente, di importanza fatale per i contemporanei: la fallita rivol-ta del Nika (DOMENICI, Giovanni Lido cit., p. 145).
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 23
Iohannes Lydus, De ostentis Plinius, Naturalis Historia, II 9. προγνωσθῆναι δὲ τοῦτο λέγεται παρὰ μὲν Ἕλλησι πρὸς Θαλοῦ τοῦ Μιλησίου ἐπὶ τῆς ἐνάτης καὶ τεσσαρακοστῆς ὀλυμπιάδος, ἔτει ἑβδομηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ τῆς κτίσεως Ῥώμης ὕστερον, παρὰ δὲ Ῥωμαίοις ὑπὸ Σουλπικίου Γάλλου, μιᾷ πρόσθεν ἡμέρᾳ τῆς Περσέως τοῦ Μακεδόνος ἥττης. ἐπὶ δὲ Οὐεσπασιανοῦ τοῦ Καίσαρος ἐν πέντε καὶ δέκα ἡμέραις ἀμφοτέροις τοῖς φωσὶ τοῦτο συνέβη παθεῖν.
53. Et rationem quidem defectus utriusque primus Romani generis in uulgum extulit Sulpicius Gallus, qui consul cum M. Marcello fuit, sed tum tribunus militum, sollicitudine exercitu liberato, pridie quam Perses rex superatus a Paulo est, in contionem ab imperatore productus ad praedicendam eclipsim, mos et composito uolumine. Apud Graecos autem inuestigauit primus omnium Thales Milesius, Olympiadis XLVIII anno quarto praedicto solis defectu, qui Alyatte rege factus est, Vrbis conditae anno CLXX. 57. Nam ut XV diebus utrumque sidus quaereretur, et nostro aeuo accidit impe-ratoribus Vespasianis patre III. filio II. consulibus.
È poi la volta delle comete, che secondo Lido costituiscono
«l’aspetto più interessante del trattato» in virtù della loro importanza semiotica relativamente agli influssi astrali.
Iohannes Lydus, De ostentis Plinius, Naturalis Historia, II
10a. Διάφοροι δὲ αἱ τῶν κομητῶν ὄψεις, ὡς καὶ διάφορα ἄλλα. Οὐ τὰ αὐτὰ δὲ ἀποτελοῦσι· κακὰ δὲ πάντες. Ὁ μὲν γὰρ κομήτης ἐστὶ πυρώδης καὶ ταῖς κόμαις αἱματώδης· ὁ δὲ πωγωνίας ἐκ τῶν κάτωθεν δίκην πώγωνος ἔχει τὰς κόμας· ὁ δὲ ἀκοντίας ὅμοιός ἐστιν ἀκοντίῳ καὶ ὥσπερ σίδηρος κραδαίνεται (οὗ φανέντος ἡ Ἰουδαία ἑάλω, ὡς καὶ Εὐσεβίῳ τῷ Παμφίλου εἴρηται) ὁ δὲ ξιφίας βραχύτερος μὲν, ὠχρὸς δὲ καὶ ξιφήρεις ἔχων τὰς ἀκτῖνας· ὁ δὲ δισκεὺς δίσκῳ παρεμφερὴς καὶ τὸ εἶδος ὡς ἤλεκτρος·
89. Et in ipso caelo stellae repente nascuntur. Plura earum genera: cometas Graeci uocant, nostri crinitas, horrentes crine sanguineo et comarum modo in uertice hispidas. Iidem pogonias quibus inferiore ex parte in speciem barbae longae promittitur iuba. Acontiae iaculi modo uibrantur, ocissimo significatu. Haec fuit, de qua quinto consulatu suo Titus Imperator Caesar praeclaro carmine perscripsit, ad hunc diem nouissima uisa. Easdem breuiores et in mucronem fastigatas xiphias uocauere, quae sunt omnium pallidissimae et
Paolo Mastandrea 24
ὁ δὲ πίθος καπνώδους μὲν φωτὸς πλήρης, τὸ δὲ σχῆμα ὅμοιος τῇ προσηγορίᾳ μεθ’οὗ ὁ κεράστης κερατοειδεῖς ἔχων τοὺς πλοκάμους ὁ λαμπαδίας πρὸς τούτοις ὅμοιος λάμπαδι καιομένῃ ἔστι γε μὴν ὁ ἵππος, ὁ καὶ ἱππεὺς καλούμενος δίκην λοφιᾶς ἵππου διαρραίνων τὰς ἀκτῖνας, ὀξύτατος δὲ παρὰ τοὺς ἄλλους (διὸ καὶ τοιαύτης ἔτυχε τῆς προσηγορίας). Σάλπιγγος ἔτι μέμνηται ὁ Πτολεμαῖος ἐν τοῖς πρὸς Σύρον, περὶ οὗ εἰπεῖν τι οὐκ ἔχομεν· οὐδὲ γὰρ εὑρίσκομεν παρ’ἑτέρῳ τοιοῦτόν τι κατάστημα.
quodam gladii nitore ac sine ullis radiis, quos et disceus, nomini similis, colore autem electro, raros e margine emittit. 90. Pitheus doliorum cernitur figura, in concauo fumidae lucis; ceratias cornus speciem habet, qualis fuit cum Graecia apud Salamina depugnauit; lampadias ardentes imitatur faces, hippeus equinas iubas, celerrimi motus atque in orbem circa se euntes. Fit et candidus cometes, argenteo crine ita refulgens, ut uix contueri liceat, specieque humana dei effigiem in se ostendens.
10b. Γίνονται δὲ καὶ ἕτεροι κομῆται οἱ λεγόμενοι τράγοι, δίκην μαλλῶν ἢ πόκων ἐρίων νεφέλας τινὰς περικείμενοι καὶ τὴν μὲν ἀρχὴν οὕτω φαίνονται, εἰς δοράτων δὲ σχῆμα ἀποτελοῦνται. Οὗτοι δὲ πάντες οὐ πλείω ἢ ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας πεφύκασι φαίνεσθαι· ἀλλ’οὐδὲ εἰκῇ ἐφ’οἱουδήποτε κλίματος τοῦ οὐρανοῦ, περὶ δὲ μόνον τὸν γαλαξίαν κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην. Οἵ γε μὴν τυφῶνες κατὰ τὸν νότιον πόλον, σφαῖραι δ’εἰσὶν οὗτοι πυρώδεις καὶ ὡσανεὶ σύνδεσμοι πυρός οὗτοι δὲ ἐπὶ μὲν τῶν Ῥωμαϊκῶν καιρῶν οὐκ ἐφάνησαν, πρὸ δὲ αὐτῶν φανέντες ἔσεισαν τὴν Αἴγυπτον. ὅθεν αὐτοὺς Ἀριστοτέλης ἐξ ὑποκειμένης ὑγρᾶς οὐσίας ἀποτελεῖσθαι βούλεται καὶ διὰ τοῦτο ἀραιῶς ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου φαίνεσθαι διὰ τὴν ὑποκειμένην ξηρότητα. Οἱ δ’ἄλλοι πάντες ἐπὶ τὸν βορέαν, κἂν ἢ πρὸς ἀνατολὰς ἢ δύσεις ὁρῶσι. Περὶ δὲ τὸν στέφανον ἄλλος ἀναδύεται κομήτης, ὅστις ὅταν φαίνηται τὴν τῶν Περσῶν ἀπειλεῖ κίνησιν. Ἐφάνη δὲ καὶ ὅτε Νέρων τῆς μανίας ἐνήρχετο.
90. Fiunt et hirci, uillorum specie et nube aliqua circumdati. Semel adhuc iubae effigies mutata in hastam est, Olympiade CVIII, urbis anno CCCCVIII. Breuissimum quo cernerentur spatium VII dierum adnotatum est, longissimum CLXXX. 91. Mouentur autem aliae errantium modo, aliae inmobiles haerent, omnes ferme sub ipso septentrione aliqua eius parte non certa, sed maxime in candida, quae lactei circuli nomen accepit. Aristoteles tradit et simul plures cerni, nemini compertum alteri, quod equidem sciam, uentos autem ab iis graues aestusue significari. Fiunt et hibernis mensibus et in austrino polo, sed ibi citra ullum iubar. Diraque conperta Aethiopum et Aegypti populis, cui nomen aeui eius rex dedit Typhon, ignea specie ac spirae modo intorta, uisu quoque toruo, nec stella uerius quam quidam igneus modus. 92. […] Sed cometes numquam in occasura parte caeli est; terrificum magna ex parte sidus atque non leuiter piatum, ut ciuili motu Octauio consule iterumque Pompei et Caesaris bello, in nostro uero
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 25
Ἐκλάμπουσι δὲ πρὸς τούτοις καὶ λαμπάδες ἐν τῷ οὐρανῷ ἢ μᾶλλον ἐν τῷ ἀέρι (οὐδὲν γὰρ ἄστρον προσπέπηγε τῷ οὐρανῷ) καὶ φαίνονται ὅταν ἐκπίπτωσιν ὁποῖον γέγονε ἐπὶ Γερμανικοῦ Καίσαρος, ὅτε ἀγομένου θεάτρου ἐπὶ τῆς Ῥώμης τοιοῦτόν τι συμβέβηκεν, ὡς μηδένα σχεδὸν ἀγνοῆσαι τῶν τότε. Δύο δὲ σχήματα ἔστιν, ὧν τὰ μὲν λαμπάδες καλοῦνται, τὰ δὲ βολίδες. Καὶ αἱ μὲν λαμπάδες ἐπὶ τῆς ἀρχῆς διακαίονται, αἱ δὲ βολίδες δι’ὅλου πυρώδεις καταφέρονται ἕλκουσαι αὔλακα μακράν. Φαίνονται δὲ καὶ δοκοὶ καὶ οὕτως αὐτὰς οἱ Ἕλληνες καλοῦσιν. γίνεται δὲ καὶ χάσμα ἐν τῷ οὐρανῷ, οὗ συμβαίνοντος σάλοι καὶ ῥήξεις ἐξ αὐτῶν καὶ διαστάσεις τῆς γῆς γίνονται. καὶ ἕτερον δ’ ἔτι ἐμπρησμῷ παραπλήσιον πολλάκις φαίνεται ὁποῖον ἐπὶ τῆς ἱστορίας εὑρίσκεται, ὅτε Φίλιππος ὁ Ἀμύντου ἐσάλευσε τὴν Ἑλλάδα. Φαίνονται δὲ καὶ περὶ τὸν ἥλιον ἀστέρες διὰ πάσης τῆς ἡμέρας καὶ περὶ τὸν δίσκον αὐτὸν καθάπερ στέφανος καὶ ποικιλόχροοί τινες κύκλοι, ὁποῖοι ἐφάνησαν, ὅτε Αὔγουστος τοὺς ἐμφυλίους πολέμους ἐκδικῶν τὸν πατέρα ἀνανεοῦν ἔκρινεν. Oὐδὲν δὲ ἧττον φαίνεσθαι συμβαίνει, ὡς ἔφαμεν, περὶ τὸν ἥλιον ὡσανεὶ τόξον καὶ μανιάκας πυρώδεις.
aeuo circa ueneficium, quo Claudius Caesar imperium reliquit Domitio Neroni, ac deinde principatu eius adsiduum prope ac saeuum. […] 96. Emicant et faces, non nisi cum decidunt uisae, qualis Germanico Caesare gladiatorum spectaculum edente praeter ora populi meridiano transcucurrit. Duo genera earum. Lampadas uocant plane faces, alterum bolidas, quale Mutinensibus malis uisum est; distant quod faces uestigia longa faciunt priore ardente parte, bolis uero perpetua ardens longiorem trahit limitem. Emicant et trabes simili modo, quas dokous uocant, qualis cum Lacedaemonii classe uicti imperium Graeci amisere. Fit et caeli ipsius hiatus, quod uocant chasma. 97. Fit et sanguinea species et, quo nihil terribilius mortalium timori est, incen-dium ad terras cadens inde, sicut Olym-piadis CVII anno tertio, cum rex Philip-pus Graeciam quateret. 98. Cernuntur et stellae cum sole totis diebus, plerumque et circa solis orbem ceu spiceae coronae et uersicolores circuli, qualiter Augusto Caesare in prima iuuenta urbem intrante post obitum patris ad nomen ingens ca-pessendum. […] Circa solem arcus adparuit L. Opi-mio Q. Fabio, orbis C. Porcio M. Acilio, circulus rubri coloris L. Iulio P. Rutilio cos.
Paolo Mastandrea 26
4. Per quel che si capisce, stante la disastrosa incompiutezza del De mensibus, almeno sporadicamente il II libro della Naturalis Hi-storia era sfruttato dall’antiquario bizantino anche nella trattazione relativa al calendario, a proposito delle comete. Interessa notare co-me gli stessi luoghi pliniani – e dunque gli stessi materiali di docu-mentazione – conoscano impieghi diversi a seconda dei fini diversi dei due opuscoli. Se nel De ostentis (e lo si è visto poco fa, cap. 10b) gli occhi sono rivolti alle conseguenze che le apparizioni di quei fe-nomeni celesti comportano sulle vicende della storia collettiva e per-sonale, nel De mensibus ci si limita al catalogo delle varie forme, fiancheggiata da descrizioni sommarie e dagli appellativi che alle stelle comete furono dati a partire da Aristotele – al cui nome è di nuovo congiunto quello di Apuleio. Ecco dunque il testo lidiano (Mens., IV, 116), riprodotto dalla edizione di Richard Wünsch:
Ὅτι τῶν κομητῶν εἴδη κατὰ μὲν τὸν Ἀριστοτέλην ἐννέα·
κατὰ δὲ τὸν Ῥωμαῖον Ἀπουλήϊον δέκα· ἱππίας ξιφίας πωγωνίας δοκίας πίθος λαμπαδίας κομήτης δισκεὺς τυφὼν κεράστης καὶ ὁ μὲν ἱππίας ἐκ τοῦ δρόμου καὶ τῆς ὀξύτητος οὕτως ὠνομάσθη, πλαγίας δὲ καὶ ἀμυδρὰς ἀκτῖνας διαρραίνει ὁ δὲ ξιφίας δίκην ξίφους ἢ λόγχης μακρᾶς ἐκτεινόμενος φαίνεται, ὠχρὸς δὲ καὶ νεφελοειδής ὁ δὲ πωγωνίας τὴν λοφιὰν οὐ κατὰ κεφαλῆς, ἀλλ’ὑποκάτω διαρραίνει δίκην πώγωνος ὁ δὲ δοκίας ὅμοιος ἐγγύς ἐστι τῷ ξιφίᾳ, ἀλλ’οὐκ ὀξείας ἔχει, ἀμβλείας δὲ τὰς ἀρχάς· ὁ δὲ πίθος ἐκ τοῦ σχήματος ὁ δὲ λαμπαδίας πυρώδης καὶ δίκην πυρώπιδος λίθου ἢ δένδρου καιομένου πέφυκε διαλάμπειν· ὁ δὲ κομήτης πλατύς ἐστι τὸ εἶδος καὶ ὥσπερ ἱλαρὸς ἀργυροειδεῖς τινας πλοκάμους ἕλκων ὁ δὲ δισκεὺς ἐξ αὐτῆς τῆς προσαγορίας δίκην δίσκου φαίνεται οὐ λαμπρὸς οὐδὲ ἐρυθρὸς ἀλλ’ὥσπερ ἤλεκτρον· ὁ δὲ τυφὼν πυρώδης καὶ αἱματώδης φαίνεται καὶ λεπτούς τινας διαρραίνων πλοκάμους· ὁ δὲ κεράστης δίκην σελήνης κερατοειδής, ὅς, ἡνίκα Ξέρξης κατὰ τῆς Ἀττικῆς ἦλθεν, λέγεται φανῆναι. Ὁ δὲ Πτολεμαῖος ἐν τοῖς πρὸς Σύρον αὐτῷ γραφεῖσι προστίθησι καὶ ἕτερον εἶδος κομήτου καλούμενον σάλπιγγα, φαίνεται δὲ κατὰ τὸ ἀρκτῷον κλίμα. Οἱ δὲ φυσικοί φασιν, ὡς συνίστανται οἱ κομῆται ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην κόλποις ἀστρώδη τινὰ φύσιν ἐπιδεικνύμενοι· οὐ γάρ εἰσιν ἀστέρες, ἀλλὰ θρομβώσεις τινὲς ἐξ ἀναθυμιάσεως τῆς γῆς ἀποτελούμεναι, ὧν ἡ γένεσις μὲν ἐξ ἀέρος τοῦ κατὰ συναφὴν ἐγκαταλαμβανομένου τῷ αἰθέρι ὅθεν καὶ ἰσοταχεῖς αὐτῷ μέχρι διαπτώσεως
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 27
συμπεριφέρονται. Καὶ ἡνίκα μὲν τὴν ῥύσιν ἐπὶ τὸ κάτω φερομένην ἔχων ὁ αἰθὴρ περιληφθείη, πωγωνίαι τε καὶ πίθοι ἀποτελοῦνται, ἡνίκα δὲ πλαγίως, κομῆται. Τάχιον δὲ οἱ πωγωνίαι, πολὺ δὲ καὶ τούτων τάχιον πίθοι τε καὶ δοκίδες ἐκπίπτουσιν.
Poco diversamente accade per il capitolo del De ostentis in cui
Lido passa a parlare dei fulmini; a destra si danno come sempre le corrispondenze rintracciabili in Plinio.
Iohannes Lydus, De ostentis Plinius, Naturalis Historia, II
44. Διάφορος δὲ καὶ οὐ μονοειδὴς ἡ τῶν κεραυνῶν φύσις. Τοὺς μὲν γὰρ ψολόεντας ἡ παλαιότης καλεῖ, τοὺς δὲ ἀργῆτας, σκηπτούς τε καὶ πρηστῆρας. Οὐδὲ γὰρ πάντες ταὐτὸ πράττουσιν. Εἰσὶ δὲ οἳ καὶ ἀναστρέφουσι πρὸς τὰς ῥήξεις τῶν νεφῶν, ὅθεν καὶ ἐξεθλίβησαν. Καὶ οἱ μὲν διάπυροι πρηστῆρες, οἱ δὲ μὴ πυρώδεις τυφῶνες, οἱ δ’ἔτι μᾶλλον ἀνειμένοι ἐκνεφίαι. Αἰγίδες γε μὴν λέγονται οἱ ἐν συστροφῇ ἀέρος φερόμενοι. Ταύτῃ αἰγίδα Διὶ περιτίθησιν ὁ λόγος, οἱονεὶ τὸν ἀέρα καταιγίδος καὶ συσσεισμοῦ αἴτιον παραινιττόμενος. Εἰσὶ δὲ καὶ ἕτερα σχήματα κεραυνῶν· ἑλικίας αὐτοὺς τὰ βιβλία καλεῖ, ὅτι ἑλικοειδῆ γραμμὴν ἐν τῷ καταφέρεσθαι παραδεικνῦσιν. Ἔστι δὲ θαυμάσαι κἀν τούτῳ τὴν φύσιν καὶ τὸ ἄβατον τῶν ἐν αὐτῇ θεωρημάτων. Οὐδὲ γὰρ πάντες
137. Fulminum ipsorum plura genera traduntur. Quae sicca ueniunt, non adurunt, sed dissipant; quae umida, non urunt, sed infuscant. Tertium est quod clarum uocant, mirificae maximae naturae, quo dolia exhauriuntur intactis operimentis nulloque alio uestigio relicto, aurum et aes et argentum liquatur intus, sacculis ipsis nullo modo ambustis ac ne confuso quidem signo cerae. Marcia, princeps Romanarum30, icta grauida, partu exanimato, ipsa citra ullum aliud incommodum uixit. In Catilinianis prodigiis Pompeiano ex municipio M. Herennius decurio sereno die fulmine ictus est. 133. Idem ardentior accensusque, dum furit, prester uocatur, amburens contacta pariter et proterens.
30 Romanarum è lezione minoritaria dei codici, assunta da J. BEAUJEU (ed.),
Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, livre II, Paris 1950, laddove la maggioranza dei testimoni reca Romanorum. Il femminile trova forse ulteriore sostegno in una espressione di Tacito (Ann., XIII, 42) dove, per scagionare se stesso, un avversario politico si paragona a Seneca e lo accusa di aver commesso adulterio con le principesse della famiglia di Germanico: simul studiis inertibus et iuuenum imperi-tiae suetum liuere iis, qui uiuidam et incorruptam eloquentiam tuendis ciuibus exercerent. se quaestorem Germanici, illum domus eius adulterum fuisse. an gra-vius aestimandum sponte litigatoris praemium honestae operae adsequi quam cor-rumpere cubicula principum feminarum?
Paolo Mastandrea 28
(καίτοι πάντες ἐξ ἀέρος καὶ συστροφῆς νεφῶν φερόμενοι) τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις δρῶσιν. Ὁ γὰρ ἐν αὐτοῖς λεγόμενος ἀργής, ὃν καὶ λαμπρὸν ἐξαιρέτως καλοῦσιν οἱ ἀρχαῖοι, πολλάκις ἐμπεσὼν ἐπὶ πίθον ἢ ἄγγος ἁπλῶς ἢ οἴνου ἢ ὕδατος, τὸ μὲν περιέχον ἀπήμαντον τὸ δὲ ἐμπεριεχόμενον ἄφαντον ἐποίησεν. Οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ἐν σκεύεσι χρυσίον ἢ ἀργύριον φέρουσιν ἐμπεσὼν τῷ ἴσῳ τρόπῳ τὰ μὲν ἔνδον ἔτηξε, τὰ δὲ ἔξωθεν ἔσωσε. Καὶ τὸ δὴ πάντων θαυμασιώτατον ἐπὶ γυναικὸς ἐγκύμονος συμβῆναί φησιν ὁ μέγας Ἀπουλήιος, καὶ γυναικὸς οὐκ ἠγνοημένης, Μαρκίας δὴ ἐκείνης τῆς Κάτωνι τῷ τελευταίῳ συνοικησάσης. ἐμπεσὼν γὰρ αὐτῇ κεραυνὸς ὁ λεγόμενος ἀργὴς ἤτοι λαμπρὸς αὐτὴν μὲν παντελῶς ἐφύλαξεν ἀβλαβῆ, τὸ δὲ ἐν αὐτῇ διεφόρησεν οὕτως ἀνεπαισθήτως, ὡς μηδὲ αὐτὴν συνιδεῖν ὅ τι γέγονε τὸ ἐν αὐτῇ, καίτοι πρὸς ἔξοδον ἔχον. Τοιαύτην μὲν κατ’ἐξαίρετον ἐνέργειαν ἡ τοῦ ἀργῆτος εἴληχε φύσις.
Anche qui l’analogia fra il testo greco e quello latino è indubbia
sul piano letterale, ma si colgono nei due autori le differenze di approccio e di interesse verso i contenuti: se Plinio discorre celere sugli effetti pratici dei vari tipi di folgori a catalogo, Lido indugia piuttosto nel riportarne i nomi e nel descriverne le caratteristiche, allegando particolari suggestivi (ricavati dal presunto Apuleio?) che di certo innalzano il grado di ‘meraviglia’ da suscitare nel lettore.
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 29
Il confronto prosegue parallelo, i brani appaiono tra loro legati e vicini, con Lido che tende come al solito a sviluppare la base infor-mativa reperita nella più autorevole delle sue fonti latine31:
Iohannes Lydus, De ostentis Plinius, Naturalis Historia, II
45. Γενικῶς δ’εἰπεῖν, ἀβλαβῶς φυλάττεται ἀπὸ κεραυνῶν καὶ οὐδὲ βάλλεται τὴν ἀρχὴν ἐν μὲν φυτοῖς δάφνη καὶ συκῆ· καὶ γὰρ ἡλίου ταῦτα. Ὅθεν καὶ δάφνην φιλεῖν Ἀπόλλων μυθεύεται, οἷον ὁ ἥλιος·καὶ εἰς λέοντα μεταβαλλόμενος, ἀντὶ τοῦ εἰς πῦρ, οὐ φθείρει τὴν δάφνην. Ἐν δὲ πτηνοῖς ἀετός, ἐν δὲ ὑγροῖς φώκη· ὅθεν καὶ κεραυνοφόρος ὁ ἀετὸς καὶ Διὸς εἶναι νενόμισται. Ἡ δὲ φώκη ὡς ἀπήμαντος ἐπιβολῇ κεραυνοῦ, μάρτυς ἡ πεῖρα ἀποδέδωκε τῶν γὰρ νεῶν τὰ ἱστία, ἐν αἷς οἱ βασιλεῖς πλέουσι, φωκείοις εἴθισται ἀποδιφθεροῦσθαι δέρμασιν. Οὐ πλέον δὲ πέντε ποδῶν κατακρύπτεσθαι κεραυνὸς πέφυκεν εἰς γῆν, ἐξωθούμενος ἄνωθεν ὁ γὰρ ἀριθμὸς γηϊνώτατος.
146. Ex iis, quae terra gignuntur, lauri fruticem non icit, nec umquam quinque altius pedibus descendit in terra; ideo pauidi altiores specus tutissimos putant, aut tabernacula pellibus beluarum quas uitulos appellant, quoniam hoc solum animal ex marinis non percutiat, sicut nec e uolucribus aquilam, quae ob hoc armigera huius teli fingitur.
In un altro luogo del De mensibus32, con procedimento parallelo a
quello assunto a proposito delle comete (e dunque analogo, per diffe-renze di motivazione e alterazione di prospettiva, riguardo al De ostentis), si tornava del resto sulla stessa materia (Mens., IV, 175):
31 Della invulnerabilità dell’albero d’alloro, Plinio avrebbe trattato anche più avanti (Nat. Hist., XV, 134-135): spectatissima in monte Parnaso ideoque etiam grata Apollini uisa […], et quia manu satarum receptarumque in domos fulmine sola non icitur. […] Laurus quidem manifesto abdicat ignes crepitu et quadam de-testatione eqs.
32 Il passo era posto fra i materiali dubbi o spuri da R. WÜNSCH (ed.), Iohannes Lydus, De mensibus (Περὶ τῶν μηνῶν), Lipsiae 1898, p. 181, 6; corrisponde in ogni caso ai numeri di libro e paragrafo III, 52 dell’edizione di W. ROETHER, Joannis Laurentii Lydi, De Mensibus quae exstant excerpta, Lipsiae et Darmstadii 1827 e IV, 96 di Ioannes Lydus, ex recognitione Immanuelis Bekkeri, Bonnae 1837 (en-trambi riproducono la prima traduzione latina dell’opera a cura di Charles Benoit Hase, 1812).
Paolo Mastandrea 30
Τοὺς σκηπτοὺς οἱονεὶ κεραυνοὺς οἱ φιλόσοφοί φασι γενέσθαι, ὅταν ῥῆξις νεφῶν γένηται· τῆς γὰρ παρακειμένης αὐτοῖς γεώδους οὐσίας ἐξαφθείσης τὸ ἐξαφθὲν ὑπὸ τῆς ῥιπῆς ἐπὶ τὴν γῆν μετὰ ῥοίζου φέρεται. Καὶ ἐὰν μὲν ὑγρὰ τυγχάνῃ ὄντα τὰ νέφη, ἅμα τῇ καταφορᾷ σβέννυται, εἰ δὲ γεωδέστερα, πυροειδεῖς ἐκθλίβονται. Δύο δὲ εἴδη κεραυνῶν εἶναί φασιν, ὧν ὁ μὲν ὀξὺς καὶ μανὸς καὶ διάπυρος ἀργὴς ὀνομάζεται, ὁ δὲ βραδὺς καὶ καπνώδης ψολόεις καὶ ὁ μὲν διὰ τὴν λεπτότητα καὶ πρὶν ἐκπυρῶσαι φερόμενος οἴχεται διὰ τάχους, ὡς μηδὲ ἐπιφλέξαι τι τῶν ἀραιοτέρων, ὁ δὲ βραδύτερος ἱκανὸς μὲν ἐπιχρῶσαι ὡς ἀπὸ αἰθάλης καὶ καῦσαι δέ τινα τῶν ὑποπεσόντων, βολβῶν καὶ συκῆς καὶ φώκης καὶ ὑαίνης μενόντων ἀβλαβῶν, ὧν καὶ ταῖς δοραῖς περιδιφθεροῦσθαι λόγος τοὺς ἱστοὺς τῶν νεῶν διὰ τοὺς κεραυνούς. Τῶν μέντοι κεραυνοβλήτων τὰ σώματα ἄταφα κατελίμπανον οἱ πάλαι, ἀδιάφθορα μένοντα· τῆς γὰρ ἐν αὐτοῖς ὑγρότητος ἀναρπαζομένης ὑπὸ τοῦ πυρός, ὥσπερ ἀποπτηθέντα διαμένειν πέφυκε.
5. Anche il De magistratibus populi Romani, terza (e ultima ad
essere composta) delle opere di Lido giunte fino a noi, reca con sé alcuni segni di attenzione verso i libri della Naturalis Historia, su tematiche distanti tra loro. I commentatori33 segnalano analogie (benché un po’ vaghe, per la verità) fra le spiegazioni onomastiche di De magistratibus, I, 23 Σερρανὸς ὁ γεωργικὸς ἀπὸ τοῦ σπείρειν e di Nat. Hist., XVIII, 3 serentem inuenerunt dati honores Serranum, unde ei et cognomen34; e poi nell’inserto sulle qualità dello scorpione, fra De magistratibus, I, 42 στεγανοῦται, καθάπερ ὄφις τῇ μαράθῳ e parecchi luoghi pliniani35. Ma di sicuro più interessante ai nostri fini è il raffronto istituibile fra De magistratibus, III, 63 e Nat. Hist., IX, 27-29 (60-62). Si parla dello storione (acipenser sturio, ἔλοψ in greco): un pesce che, secondo Marziale (XIII, 91), era degno delle imperiali mense del Palatium, quindi rarità culinaria e prelibatezza per grandes gourmands; ec-co anzitutto la redazione lidiana della notizia, De magistratibus, III, 63:
33 Così già A.C. BANDY (ed.), Ioannes Lydus, On Powers or The Magistracies of the Roman State, Philadelphia, Pa 1983 (e di conseguenza la lista di MAAS, John Lydus and the Roman past cit., p. 133).
34 Ma SCHAMP, introduction a Jean le Lydien, Des magistratures cit., p. CCXIV il-lustra bene a quali altre fonti potesse attingere uno studioso intraprendente come Lido.
35 Si trovano ora raccolti ivi, pp. CCLVIII s.
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 31
Ὅτι δὲ τυχὸν ἔλοπος τοῦ ἰχθύος μνήμη παρῆλθεν, περὶ αὐτοῦ τὰ γνωσθέντα μοι παραθήσομαι. Ἰχθύς ἐστιν ἁπαλός, διαυγής, ὡς <ὡς> εἰ πηκτὴν καὶ κρυσταλλώδη ἀλλ’οὐ ναστὴν καὶ ἰνώδη δοκεῖν ἔχειν τὴν σάρκα· ζῳοτόκος μὲν καὶ μηρυκισμόν τινα ἀνάγων. πέφυκε δὲ τοῖς εὐτυχέσιν ἐνδιατρίβειν τόποις ὅθεν μετ’αὐλῶν καὶ κυμβάλων τοῖς Ῥωμαίοις παρετίθετο, ὥς φησιν Ἀθήναιος. Ἐν δὲ τῷ νήχεσθαι σκέπει τοὺς ὀφθαλμοὺς ταῖς παραπεφυκυίαις αὐτῷ πτέρυξιν. Καὶ ἔλοπα μὲν αὐτὸν Ἀριστοτέλης καὶ πάντες οἱ φυσικοὶ καλοῦσιν καὶ Ἀριστοφάνης δὲ ὁ Βυζάντιος ἐν τῇ Ἐπιτομῇ τῶν ἐν ἰχθύσι Φυσικῶν, οἱ δὲ Ῥωμαῖοι ἀκυιπήνσερα, δι’ἃς αὐτοὶ γεγράφασιν αἰτίας. Κορνήλιος δὲ Νέπως καὶ Λαβέριος ὁ ποιητής, ἄμφω Ῥωμαῖοι, φασὶν Ὀπτᾶτόν τινα ναύκληρον τοῦ Καρπαθίου στόλου, οἰκεῖον Κλαυδίου βασιλέως, ἐνεγκόντα ἐκ τῆς κάτω θαλάσσης ἔλοπας ἀνὰ μέσον τῆς Ὀστίας καὶ Καμπανῆς περισπεῖραι θαλάσσης.
Fu bravo intanto Jean-Dominique Fuss, uno dei primi lettori e
traduttori dell’opera in latino (1812), a notare lo sbaglio madornale – ascrivibile già a Lido ma certamente involontario – che riguarda la cronologia relativa di Optatus e degli ultimi due scrittori romani chiamati in causa36: non è proprio possibile che «Cornelio Nepote e il poeta Laberio» riferissero le gesta di un liberto di Claudio. Oggi il luogo può contare su una vasta bibliografia specifica37, trattandosi di un argomento discusso da almeno altri due enciclopedisti antichi ‘su-perstiti’ oltre a Plinio e Lido stesso, ricontrollabile perciò sulle pagi-ne di Ateneo e di Macrobio; la questione è ulteriormente complicata dal fatto che mentre nei Deipnosophistae (VII, 294f) i dati sono esposti in termini davvero essenziali, l’autore dei Saturnalia si dif-fonde molto di più sulle notizie, e con insolita consonanza formale38
36 Così Ioannes Lydus, ex recognitione Immanuelis Bekkeri cit., ad l. (p. 257): «Lydus, e Plinii loco (H.N., 9, 17) haec, ut videtur, fallente memoria petens, de Corne-lio Laberioque, ante Claudii principatum extinctis, plane aliud, de Optato idem fere atque Plinius rettulit, mutato tamen piscium nomine; in eo enim scari sunt, non acipenseres» (dunque, a parere di Fuss, Lido cita da Plinio, ma commette un errore di distrazione).
37 Ultimamente riunita nell’excursus di SCHAMP, introduction a Jean le Lydien, Des magistratures cit., pp. CCLXV-CCLXXI (ivi ogni necessaria informazione, accanto ai testi delle fonti); per gli aspetti riguardanti Sereno Sammonico, dei cui frammenti non esiste edizione moderna, si veda infra, nota 42.
38 Ma anche ideale e morale: Macrobio (sin dalla frase introduttiva nec contenta illa ingluuies fuit maris sui copiis eqs.) e Lido appaiono isolati nell’inserire
Paolo Mastandrea 32
rispetto a Lido palesa la propria fonte diretta in Sammonico Sereno, anziché in Plinio – che pure viene citato in mezzo agli altri; ecco nel-la sua piena dimensione il contesto di Sat., III, 16 (ove il personaggio di Rufio Albino sta descrivendo la raffinatezza delle mense romane al tempo di Giulio Cesare):
1 Nec acipenser, quem maria prodigis nutriunt, illius seculi
delicias euasit […] 3 […] accipite adsertore Cicerone in quo hono-re fuit hic piscis apud P. Scipionem Africanum illum et Numanti-num. Haec sunt in dialogo de fato uerba Ciceronis39: 4 Nam cum esset apud se ad Lauernium Scipio unaque Pontius, adlatus est for-te Scipioni acipenser, qui admodum raro capitur, sed est piscis, ut ferunt, in primis nobilis. Cum autem Scipio unum et alterum ex his qui eum salutatum uenerant inuitauisset, pluresque etiam inui-taturus uideretur, in aurem Pontius: ‘Scipio, inquit, uide quid agas, acipenser iste paucorum hominum est’. 5 Nec infitias eo tempori-bus Traiani hunc piscem in magno pretio non fuisse, teste Plinio Secundo qui in Naturali historia, cum de hoc pisce loqueretur, sic ait: ‘Nullo nunc in honore est, quod equidem miror, cum sit rarus inuentu’. 6 Sed non diu stetit haec parsimonia. Nam temporibus Seueri principis, qui ostentabat duritiam morum, Sammonicus Se-renus, uir saeculo suo doctus, cum ad principem suum scriberet faceretque de hoc pisce sermonem, uerba Plinii quae superius po-sui praemisit et ita subiecit: 7 ‘Plinius, ut scitis, ad usque Traiani imperatoris uenit aetatem. Nec dubium est, quod ait nullo honore hunc piscem temporibus suis fuisse, uerum ab eo dici. Apud an-tiquos autem in pretio fuisse ego testimoniis palam facio, uel eo magis quod gratiam eius uideo ad epulas quasi postliminio redisse; quippe qui, dignatione uestra cum intersum conuiuio sacro, ani-maduertam hunc piscem a coronatis ministris cum tibicine intro-ferri. Sed quod ait Plinius de acipenseris squamis, id uerum esse maximus rerum naturalium indagator Nigidius Figulus40 osten-
l’episodio in una cornice di critiche alla luxuria a tavola, e in generale agli eccessi nella spesa voluttuaria, esemplificati dai comportamenti di un praefectus classis il quale, anziché ai propri doveri di capo della flotta militare del Tirreno, si dedicava ad allevare pesci pregiati nei vivai delle coste laziali e campane.
39 W.AX-O. PLASBERG (edd.), M. Tulli Ciceronis, De divinatione, De fato, Timaeus, Berlin-New York 1987 (= Lipsiae 1938), p. 153b (De fato, frg. 4).
40 A. SWOBODA (ed.), P. Nigidii Figuli Operum Reliquiae, Amsterdam 1964 (= Vindobonae 1889), p. 131 (Libri ‘de animalibus’, frg. CXIII).
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 33
dit, in cuius libro de animalibus quarto ita positum sit ‘cur alii pi-sces squama secunda, acipenser aduersa sit’. 8 Haec Sammonicus, qui turpitudinem conuiuii principis sui laudando notat, prodens uenerationem qua piscis habebatur, ut a coronatis inferretur cum tibicinis cantu, quasi quaedam non deliciarum sed numinis pompa. 9 Sed, ut minus miremur acipenserem graui pretio taxari solitum, Asinius Celer uir consularis, ut idem Sammonicus refert, mullum unum septem milibus nummum mercatus est. In qua re luxuriam illius saeculi eo magis licet aestimare, quod Plinius Secundus tem-poribus suis negat facile mullum repertum qui duas pondo libras excederet. At nunc et maioris ponderis passim uidemus et pretia haec insana nescimus. 10 Nec contenta illa ingluuies fuit maris sui copiis. Nam Optatus praefectus classis, sciens scarum adeo Italicis litoribus ignotum ut nec nomen Latinum eius piscis habeamus, in-credibilem scarorum multitudinem uiuariis nauibus huc aduectam inter Ostiam et Campaniae litus in mare sparsit, miroque ac nouo exemplo pisces in mari tamquam in terra fruges aliquas seminauit: idemque, tamquam summa in hoc utilitatis publicae uerteretur, quinquennio dedit operam ut, si quis inter alios pisces scarum forte cepisset, incolumem confestim et inuiolatum mari redderet.
In effetti, siamo nelle condizioni di verificare almeno una delle
fonti elencate da Macrobio, cioè il passo seguente che è tratto dal li-bro nono di Plinio:
60 Apud antiquos piscium nobilissimus habitus acipenser, unus omnium squamis ad os uersis contra quam in nando meant, nullo nunc in honore est, quod equidem miror, cum sit rarus inuentu. Quidam eum elopem uocant. 61 Postea praecipuam auctoritatem fuisse lupo et asellis Nepos Cornelius et Laberius po-eta mimorum tradidere. Luporum laudatissimi qui appellantur la-nati a candore mollitiaque carnis. Asellorum duo genera, callariae minores et bacchi, qui non nisi in alto capiuntur, ideo praelati prioribus. At in lupis in amne capti praeferuntur. 62 Nunc prin-cipatus scaro datur, qui solus piscium dicitur ruminare herbisque uesci atque non aliis piscibus, Carpathio maxime mari frequens. Promunturium Troadis Lectum numquam sponte transit. Inde aduectos Tiberio Claudio principe Optatus e libertis eius prae-fectus classis inter Ostiensem et Campaniae oram sparsos disseminauit eqs.
Paolo Mastandrea 34
Si sarà notato che la notizia relativa al prefetto Optatus fa com-parsa tanto in Macrobio che in Plinio, ma solo nella Naturalis Histo-ria erano menzionati precisamente anche Cornelio Nepote e Decimo Laberio41. Osserviamo perciò questa tabella disposta su tre colonne:
Plinio, Nat. Hist., IX Macrobio, Sat., III, 16 Lido, Mag., III, 63
60 Apud antiquos piscium nobilissimus habitus acipenser, unus omnium squamis ad os uersis contra quam in nando meant, nullo nunc in honore est, quod equidem miror, cum sit rarus inuentu. Quidam eum elopem uocant. 61 Postea praecipuam auctoritatem fuisse lupo et asellis Nepos Cornelius et Laberius poeta mimorum tradidere [...] 62 Nunc principatus scaro datur, qui solus piscium dicitur ruminare herbisque uesci atque non aliis piscibus, Carpathio maxime mari frequens. Promunturium Troadis Lectum numquam sponte transit. Inde aduectos Tiberio Claudio principe Optatus e libertis eius praefectus classis inter Ostiensem et Campaniae oram sparsos disseminauit.
5 Nec infitias eo temporibus Traiani hunc piscem in magno pretio non fuisse, teste Plinio Secundo qui in Naturali historia, cum de hoc pisce loqueretur, sic ait: ‘Nullo nunc in honore est, quod equidem miror, cum sit rarus inuentu’. 6 Sed non diu stetit haec parsimonia. Nam temporibus Seueri principis, qui ostentabat duritiam morum, Sammonicus Serenus, uir saeculo suo doctus, cum ad principem suum scriberet faceretque de hoc pisce sermonem, uerba Plinii quae superius posui praemisit et ita subiecit: 7 ‘Plinius, ut scitis, ad usque Traiani imperatoris uenit aetatem. Nec dubium est, quod ait nullo honore hunc piscem temporibus suis fuisse, uerum ab eo dici. Apud antiquos autem in pretio fuisse ego
Ὅτι δὲ τυχὸν ἔλοπος τοῦ ἰχθύος μνήμη παρῆλθεν, περὶ αὐτοῦ τὰ γνωσθέντα μοι παραθήσομαι. Ἰχθύς ἐστιν ἁπαλός, διαυγής, ὡς <ὡς> εἰ πηκτὴν καὶ κρυσταλλώδη ἀλλ’οὐ ναστὴν καὶ ἰνώδη δοκεῖν ἔχειν τὴν σάρκα· ζῳοτόκος μὲν καὶ μηρυκισμόν τινα ἀνάγων. Πέφυκε δὲ τοῖς εὐτυχέσιν ἐνδιατρίβειν τόποις· ὅθεν μετ’αὐλῶν καὶ κυμβάλων τοῖς Ῥωμαίοις παρετίθετο, ὥς φησιν Ἀθήναιος. Ἐν δὲ τῷ νήχεσθαι σκέπει τοὺς ὀφθαλμοὺς ταῖς παραπεφυκυίαις αὐτῷ πτέρυξιν. Καὶ ἔλοπα μὲν αὐτὸν Ἀριστοτέλης καὶ πάντες οἱ φυσικοὶ καλοῦσιν καὶ Ἀριστοφάνης δὲ ὁ Βυζάντιος ἐν τῇ Ἐπιτομῇ τῶν ἐν ἰχθύσι Φυσικῶν, οἱ δὲ Ῥωμαῖοι ἀκυιπήνσερα, δι’ἃς αὐτοὶ γεγράφασιν αἰτίας.
41 Mentre la testimonianza relativa allo storiografo è omessa anche dall’ultima
silloge dei frammenti di Cornelio Nepote a cura di P.K. Marshall (Cornelii Nepotis Vitae cum fragmentis, Stutgardiae et Lipsiae 1991, dove col numero d’ordine 26 entra invece l’antecedente di Plin., Nat. Hist., IX, 60), si vedano a proposito della menzione di Laberio le copiose osservazioni raccolte dal suo editore più recente (C. PANAYOTAKIS, Decimus Laberius, The Fragments, Cambridge 2010, pp. 400-403).
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 35
testimoniis palam facio, uel eo magis quod gratiam eius uideo ad epulas quasi postliminio redisse; quippe qui, dignatione uestra cum intersum conuiuio sacro, animaduertam hunc piscem a coronatis ministris cum tibicine introferri᾿. Sed quod ait Plinius de acipenseris squamis, id uerum esse maximus rerum naturalium indagator Nigidius Figulus ostendit, in cuius libro De animalibus quarto ita positum sit ‘cur alii pisces squama secunda, acipenser aduersa sit’. […] 10 Nec contenta illa ingluuies fuit maris sui copiis. Nam Optatus praefectus classis, sciens scarum adeo Italicis litoribus ignotum ut nec nomen Latinum eius piscis habeamus, incredibilem scarorum multitudinem uiuariis nauibus huc aduectam inter Ostiam et Campaniae litus in mare sparsit, miroque ac nouo exemplo pisces in mari tamquam in terra fruges aliquas seminauit: idemque, tamquam summa in hoc utilitatis publicae uerteretur, quinquennio dedit operam ut, si quis inter alios pisces scarum forte cepisset, incolumem confestim et inuiolatum mari redderet.
Κορνήλιος δὲ Νέπως καὶ Λαβέριος ὁ ποιητής, ἄμφω Ῥωμαῖοι, φασὶν Ὀπτᾶτόν τινα ναύκληρον τοῦ Καρπαθίου στόλου, οἰκεῖον Κλαυδίου βασιλέως, ἐνεγκόντα ἐκ τῆς κάτω θαλάσσης ἔλοπας ἀνὰ μέσον τῆς Ὀστίας καὶ Καμπανῆς περισπεῖραι θαλάσσης.
Paolo Mastandrea 36
Sulla base del numero e della varietà di autori greci e latini chiamati in causa, distribuiti in un arco temporale di almeno cinque secoli a partire da Aristotele, non sarebbe difficile formulare ipotesi di complicati intrecci testuali, dove trovasse spicco quella che Macrobio indica esplicitamente come la fonte a lui più vicina: il po-ligrafo Sereno Sammonico e i libri rerum reconditarum che pure Lido altrove dimostra di conoscere bene42.
Gli eruditi tardoantichi, secondo un costume smascherato fin troppo bene dai gloriosi studi di Quellenforschung positivistica, in generale fanno sfoggio di citazioni di autori che dovremmo credere oggetto di consultazione accurata e diretta, laddove quasi sempre riproducono nomi e fonti di seconda o terza mano. Così, come più sopra nelle sezioni di argomento ‘cosmologico’ si poteva immagina-re fra Plinio e Lido un ruolo intermediario svolto da ‘Apuleio’ e La-beone, qui Sammonico avrebbe fatto da collettore, da filtro, quindi da rimaneggiatore maldestro dei materiali estratti dall’immensa cava della Naturalis Historia. E tuttavia, per quanto riguarda la svista cronologica cui si alludeva, è più probabile essa tragga origine da una lettura diretta – ancorché frettolosa – compiuta da Lido sul testo di Plinio: che in Nat. Hist., IX, 62 stava oramai parlando dello scarus (o sparisoma cretense), ma dell’acipenser aveva trattato solo poche ri-ghe sopra, al cap. 60 dello stesso libro.
6. In conclusione, benché il poligrafo bizantino appaia abbastan-
za smaliziato e autonomo da procurarsi di volta in volta gli elementi con cui ‘personalizzare’ le proprie pagine rispetto ai libri che com-pulsa, non va esclusa l’esistenza nell’antichità di uno scritto perduto, veramente composto da Apuleio oppure circolante sotto il suo nome, che consistesse in una silloge di testi parascientifici estratti dalla co-smologia di Plinio: fonte intermerdia donde Lido poteva aver attinto i materiali, gli esempi particolari e quant’altro egli racconta in più ri-spetto alle pagine della Naturalis Historia. Ma l’ultimo dei paralleli
42 Si tratta probabilmente di quei libri Περὶ Ποικίλων Ζητημάτων che, secondo la testimonianza lidiana (Mag., III, 32), sarebbero stati dedicati agli imperatori Diocleziano e Galerio: il che comporta un moto in avanti di un secolo circa rispetto alla cronologia che a Sammonico si assegna di solito (questione su cui sia lecito rinviare a P. MASTANDREA, Sereno Sammonico: Res reconditae e dati di fatto, «Lexis» 30, 2012, pp. 506-519).
Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea 37
istituiti qui sopra, grazie all’errore di cronologia relativa fra la coppia di fonti letterarie tardo-repubblicane coeve (Cornelio Nepote/Decimo Laberio) e il riferimento storico agli anni dell’imperatore Claudio, suggerisce l’idea che proprio Lido sia il diretto responsabile della svista, originata da un (non incomprensibile) equivoco sulla denomi-nazione dei pesci pregiati.
Per questo, e per altri minori indizi qui sopra segnalati, occorre credere che il testo di Plinio nella sua interezza circolasse ancora, a Costantinopoli, in età giustinianea; l’ultimo tempo, e forse ormai l’unico posto al mondo, ove si trovava un pubblico di lettori in grado di apprezzare edizioni di autori latini profani, anche al di fuori dei canoni della scuola.











































![[con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63209238c5de3ed8a70dc99c/con-d-bucca-per-lo-studio-delle-origini-della-paracletica-alcuni-testimoni-antiquiores.jpg)