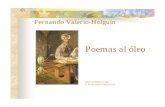Leon Battista Alberti e la Romagna umanistica. La Biblioteca Malatestiana di Cesena
Leonardo Montagna, Epigrammatum liber III, ed. by Valerio Sanzotta, Roma, Edizioni di Storia e...
Transcript of Leonardo Montagna, Epigrammatum liber III, ed. by Valerio Sanzotta, Roma, Edizioni di Storia e...
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA GRECA E LATINA
LEONARDO MONTAGNA
EPIGRAMMATUMLIBER III
a cura di
VALERIO SANZOTTA
ROMA 2010
EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA
© 2010 Dipartimento di Filologia greca e latina“Sapienza” Università di Roma
Tutti i diritti riservati
EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA00165 Roma – Via delle Fornaci, 24
Tel. 06.39.67.03.07 – Fax 06.39.67.12.50e-mail: [email protected]
www.storiaeletteratura.it
Volume pubblicato con un contributo delDipartimento di Filologia greca e latina
“Sapienza” Università di Roma
Prima edizione: settembre 2010
ISBN 978-88-6372-184-3
INDICE GENERALE
Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. XI
Abbreviazioni bibliografiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » XV
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » XXIII
1. Leonardo Montagna e la sua produzione nell’Italia del secondoQuattrocento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » XXIII
2. La raccolta poetica del Casanatense 276: descrizione delmanoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » XLIII
3. Leonardo Montagna a Viterbo e Perugia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » L
4. Note sul latino di Leonardo Montagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » LIII
5. La presente edizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » LVI
EPIGRAMMATUM LIBER III
Ad divum principem Bartholomaeum Roverellam cardinalemRavennatem Leonardi Montagnae poetae laureatiepigrammatum liber III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3
Indici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 63
Indice degli epigrammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65
Indice dei manoscritti, degli incunaboli e dei documenti d’archivio. . . » 69
Indice delle fonti e dei luoghi paralleli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 71
Indice dei nomi, luoghi e cose notevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 73
Indice delle tavole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 85
EPIGRAMMATUM LIBER IIIX
PREMESSA
Non si può dire che negli studi sull’umanesimo minore la figura di Leo-nardo Montagna sia stata del tutto trascurata e anzi non mancano su di luiimpegnati contributi, anche se per lo più egli è stato giudicato poeta diben scarso livello, spesso pedante e vanitoso. Limitando qui il discorso allasola produzione latina (ma analogamente si potrà dire di quella volgare),il Montagna non si segnala certo per eccellenza stilistica; e tuttavia la sem-plicità dei suoi versi, costruiti spesso con termini o iuncturae di un non va-stissimo bagaglio di autori classici, tra cui spiccano Ovidio e Marziale, eumanistici, sopra tutti il Panormita, non deve far velo al pregio della lorotestimonianza storica, giacché, accanto a situazioni ed episodi, certo, tal-volta minimi, del suo privato ma anche della vita pubblica, rivivono in essirapporti con uomini noti e meno noti, ma alcuni anche illustri, e viene cosìtratteggiata in modo concreto la società del tempo. Senza dire che i versidel Montagna colgono al vivo atteggiamenti e qualità variamente umanedella personalità dell’autore: così la difesa, non ovvia a quell’epoca, del ge-nere femminile nei tre capitoli dedicati a Barbara di Brandeburgo; il co-stante e devoto amore per la moglie Bartolomea e il dolore per lascomparsa di lei, come anche, nella nostra raccolta, il dolore per la mortedi un figlio e per la morte del padre; e pure, tratto comune dell’età, la cre-denza negli astri e nelle profezie.
Resta che, aperto e pronto a guardare da vicino la vita propria e quelladegli altri, il Montagna, come egli stesso candidamente scrive in un epi-gramma della raccolta che qui si pubblica, vedeva ovunque occasione dipoesia: e a confermare la letterarietà di questo atteggiamento concorre,senza dubbio, la forma epistolare che assume quasi sempre la poesia delMontagna, in ossequio al grande ruolo che riveste il genere epistolare nelQuattrocento. Insieme con quella di tanti altri umanisti minori, i quali te-stimoniano, ognuno a suo modo, le tendenze varie del nostro umanesimo,la produzione del Montagna contribuisce incisivamente al tessuto di unacultura per così dire minore, ma caratteristico di quella civiltà. Proprio
per il fatto di non poter essere inserito, se non occasionalmente e margi-nalmente, in alcun cenacolo intellettuale, il Montagna può considerarsiun caso esemplare della diffusione e della capacità di attrazione della cul-tura umanistica, anche nei confronti di uomini che non facevano profes-sione di lettere, o di semplici dilettanti, in ogni ambiente della vita civiledel Quattrocento: e non sfugga che nei suoi epigrammi si incontranospesso nomi di verseggiatori per lo più sconosciuti o poco noti, quali sono,per restare a questo libro, i viterbesi Paolo Boncambi, Domenico figliodel medico Gentile e il suo probabile cugino Altobello, e i perugini Gri-fone Baglioni e Alberto Belli. E pure capita che i versi del Montagna di-ventino occasione di osservazioni filologiche, come quella sulla caducitàdei titoli degli epigrammi, cui, secondo il suo parere, non si dovrebbe af-fidare in esclusiva la menzione del destinatario e quindi la memoria delsuo nome, da inserire invece all’interno del testo e preservarla così dal-l’oblio; e si capisce per quale motivo all’autore provochino difficoltà queinomi che, per il metro, non possono essere inseriti nell’esametro e nel pen-tametro. Piccola ossessione, certo, com’è, d’altra parte, ossessiva l’insi-stenza con cui il Montagna protesta la castità della sua vita e della suapagina, e si rifiuta di scrivere poesia lasciva, prendendo le distanze dal ce-leberrimo verso marzialiano.
Si presenta qui l’edizione critica e il commento della terza raccolta diepigrammi, dedicata al cardinale Bartolomeo Roverella, contenuta ai ff.49r-69v del ms. 276 della Biblioteca Casanatense di Roma. Come si diràmeglio più avanti, si tratta di uno dei quattro libri di epigrammi indirizzatia illustri personalità del tempo e, a partire dal secondo, contrassegnati dalMontagna con una numerazione progressiva: a papa Paolo II fu dedicatoil primo (Cesena, Biblioteca Malatestiana, S. XXIX 8), al cardinale BattistaZeno fu dedicato il secondo (Paris, Bibliothèque de l’Institut de France,806), al cardinale Ammannati il quarto (Vat. lat. 5156); si rimane incertise un quinto libro, che doveva essere dedicato all’arcivescovo LorenzoZane (peraltro già dedicatario di altri due libelli di carmina), sia stato ef-fettivamente portato a termine. Poiché il codice malatestiano non presentaal suo interno l’indicazione di liber primus, è evidente che il Montagnaconcepì l’idea di una successione di libri solo in un secondo tempo, e perònon risulta che egli li abbia alla fine riuniti né che abbia mai manifestato ilproposito di farlo: si tenga anche conto del fatto che dalla pubblicazione
EPIGRAMMATUM LIBER IIIXII
PREMESSA
del quarto liber alla morte del poeta trascorsero circa dieci anni, un temporagionevolmente sufficiente per la pubblicazione di una raccolta organica,qualora il Montagna ne avesse avuto intenzione. Sicché sembra lecito con-siderare ciascun libro come un’unità affatto autonoma, sia pure in relazioneideale con gli altri. Qui si pubblica il terzo libro in quanto, seppure par-zialmente utilizzato dagli studiosi, è forse dei quattro il meno conosciuto.
Un grande debito di riconoscenza ho contratto con Rino Avesani, Se-bastiano Gentile e Silvia Rizzo, ai quali sono grato per i suggerimenti, iconsigli, le correzioni di rotta e per la loro fiducia e vicinanza; a Rino Ave-sani e a Silvia Rizzo anche per aver accolto il lavoro nella collana da lorodiretta. Sono riconoscente ancora ad Alberto Bartòla, Concetta Bianca,Maurizio Campanelli, Paolo Cherubini, Michele Napolitano e Maria AgataPincelli, i quali hanno migliorato il testo in più punti. Sono miei eventualierrori e omissioni. Singoli problemi ho discusso utilmente con Tiziano An-zuini, Monica Berté e Luca Serianni; ringrazio particolarmente VincenzoFera per la sua disponibilità e per avermi stimolato a riflettere in manierapiù approfondita sui problemi strutturali degli Epigrammi del Montagna.Molto devo a Isabella Ceccopieri e Laura Giallombardo della BibliotecaCasanatense di Roma, e a Walter Mazzotta e Alberto Rizzo della Bibliotecadel Dipartimento di Filologia Greca e Latina dell’Università “La Sapienza”di Roma, che hanno sempre facilitato le mie ricerche. A Serena Pirrotta,cui mi lega una lunga amicizia, sono grato anche per aver agevolato, nelsettembre del 2009, il mio soggiorno di studio a Göttingen, durante il qualequesto lavoro ha assunto il suo assetto definitivo.
Roma, dicembre 2009V. S.
XIII