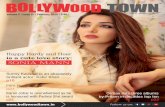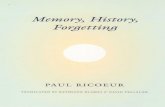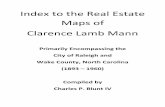El diálogo Dussel-Ricoeur: los límites de la hermenéutica del sí
La tentazione dell'eterno: Ricoeur e la "Montagna" incantata di Thomas Mann
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La tentazione dell'eterno: Ricoeur e la "Montagna" incantata di Thomas Mann
© Logoi.ph – Journal of Philosophy - ISSN 2420-9775 N. I , 2, 2015 – P. Ricoeur and the Symphony of the Languages
195
Marco Casucci La tentazione dell’eterno: Ricœur e La montagna incantata di Thomas Mann.
Peer-reviewed Article. Received: April 13, 2015; Accepted: May 08, 2015
Abstract: The aim of this contribution is to highlight the relationship between the thought of P. Ricœur and the Thomas Mann‟s novel The Magic Mountain. As it is well known, Ricœur analyses the novel in the second and in the third volume of his work Time and Narrative, in order to underline the contribution of the fictive experience of time to the phaenomenological conception of time itself. Ricœur in particular notes that in The Magic Mountain is presented a particular connection between time, death and eternity. Starting from this point, the paper wants to investigate on which philosophical basis is rooted the investigation on time in the Zauberberg in order to highlight the „temptation of the eternity‟ which works both in Mann‟s novel and in Ricœur‟s masterpiece. L‟obiettivo di questo contributo è quello di evidenziare il rapporto tra il pensiero di P. Ricoeur e il romanzo di Thomas Mann, La montagna incantata. Com‟è noto, Ricoeur analizza questo romanzo nel secondo e nel terzo volume della sua opera Tempo e racconto, al fine di sottolineare il contributo dell‟esperienza del tempo nel racconto di finzione in relazione alla concezione fenomenologica del tempo in sé. Ricoeur, in particolare, nota che ne La montagna incantata è presentata una particolare connessione tra tempo, morte ed eternità. Partendo da questo punto, questo saggio vuole cercare le basi filosofiche su cui è fondata la ricerca sul tempo in Zauberberg, al fine di evidenziare la „tentazione dell'eternità‟, presente sia nel romanzo di Mann sia nel capolavoro di Ricoeur. Keywords: Time, Eternity, Death, Narrative, Mountain. Parole chiave: Tempo, eternità, morte, narrativa, montagna
***
In un significativo passo di Tempo e racconto 1, Ricœur, affrontando il tema introduttivo delle aporie della temporalità in Agostino e Aristotele fa un‟affermazione molto forte riguardo l‟intenzione e il fine ultimo del suo studio. Dice egli infatti: «L‟interrogativo più grave che questo libro potrà sollevare resta quello di sapere fino a che punto una riflessione filosofica sulla narratività e il tempo può aiutare a pensare insieme l‟eternità e la morte»1.
Il discorso improntato da Ricœur sul tema della narratività, sulla storia così come sul romanzo, viene a toccare, con questa affermazione, una questione metafisica fondamentale che è quella del rapporto tra tempo ed eternità, attraverso il momento di negatività radicale rappresentato proprio dalla morte come punto di contatto estremo di queste due dimensioni. Questo aspetto d‟altronde si era già anticipato nella parte dedicata espressamente al problema della temporalità in Agostino; anche se, come egli stesso afferma esplicitamente esso non viene tematizzato ancora in tutta la sua radicalità, preferendo piuttosto mantenere viva l‟attenzione sulla dialettica di distensio-intentio, che costituisce uno dei punti focali dell‟opera ricœuriana. Da questo punto di vista, la dimensione dell‟eterno viene ad assumere per Ricœur un valore „negativo‟ sulla cui base leggere la problematica della temporalità in Agostino:
Trattando del tempo, Agostino fa riferimento all‟eternità solo per sottolineare più nettamente la carenza ontologica tipica del tempo umano e si misura direttamente con le aporie che segnano la concezione del tempo come tale. Per correggere un po‟ questo torto fatto al testo agostiniano, introdurrò nuovamente la
1 P. Ricœur, Tempo e racconto. Volume 1, tr. it. a cura di G. Grampa, Jaca Book, Milano, 20084, p. 138.
© Logoi.ph – Journal of Philosophy - ISSN 2420-9775 N. I , 2, 2015 – P. Ricoeur and the Symphony of the Languages
196
meditazione sull‟eternità ad uno stadio ulteriore dell‟analisi, allo scopo di trovarvi una intensificazione dell‟esperienza del tempo2.
Ricœur, così, si rende conto di „ridurre‟ in un certo senso l‟esperienza agostiniana
dell‟eternità, anticipando una ripresa di tale tema più avanti. È in questo modo quindi che possiamo fare un salto al secondo e più ancora al terzo volume di Tempo e racconto, perché è qui che la tematica dell‟eternità, anticipata nella lettura di S. Agostino, viene ripresa proprio a proposito della lettura di quelle „favole sul tempo‟ di cui lo Zauberberg di Mann rappresenta uno dei più alti esemplari.
Affrontare la lettura che Ricœur fa del romanzo di Mann ci permetterà così di penetrare questo tema del rapporto tra tempo ed eternità che rimane sottotraccia nel testo ricœuriano. Quasi come una „tentazione‟ che si annuncia ma che non viene mai del tutto esplicitata, se non per brevi accenni, tra le righe di un‟opera monumentale in cui si attraversano i molteplici e caleidoscopici meandri del tempo nel quale viviamo e ci muoviamo, ma nel quale tuttavia riluce sempre la questione fondamentale, senza di cui i molteplici colori del caleidoscopio non potrebbero essere proiettati: la questione dell‟eternità.
Questione che appunto assillò l‟opera di Mann e che anche nella sua opera si presenta come una pericolosa tentatrice, che tuttavia non può essere elusa, così come non la elusero due dei grandi „maestri‟ a cui Mann non mancò mai di riferirsi: Schopenhauer e Nietzsche, i quali pensarono proprio a partire da quella luce, pericolosamente ineludibile, come le vette che essi tentarono di raggiungere. 1) L’eternità e la morte nella lettura ricœuriana de La montagna incantata.
Ricœur reintroduce il tema dell‟eternità nei capitoli di Tempo e racconto 2 e 3 intitolati
rispettivamente La configurazione del tempo nel racconto di finzione e La finzione e le variazioni immaginative sul tempo3. In questi capitoli si tratta dell‟ambito della narrazione di finzione dopo che si è analizzata la dimensione del tempo storico. In particolare vale la pena di notare come una delle prime preoccupazioni dell‟autore sia quella di rimarcare la differenza che intercorre tra la dimensione della storia e quella del racconto di finzione. Questa differenza è la libertà in un duplice senso negativo e positivo. Se infatti da una parte «il tempo del racconto di finzione è liberato dai vincoli che esigono di trasferirlo al tempo dell‟universo», dall‟altra «la caduta dei condizionamenti del tempo cosmologico ha come contropartita positiva, l‟indipendenza delle finzione nell‟esplorazione delle risorse del tempo fenomenologico che restano non sfruttate, non dispiegate dal racconto storico»4.
A partire da questa prospettiva, quindi, è possibile per il romanzo rimodulare la questione della temporalità, in maniera tale da offrire all‟attenzione del lettore quelle variazioni immaginative sul tema che rimanevano precluse alla narrazione storica. Ma non solo. Oltre a questo infatti il romanzo permette anche di approfondire la questione del tempo fenomenologico, permettendo di accedere a tematiche che ad esso rimanevano non del tutto attingibili. Attraverso la dimensione del racconto di finzione è infatti possibile per Ricœur mettere in luce i «limiti della fenomenologia, che sono quelli del suo stile
2 Ivi, p. 20. 3 Cfr. P. Ricœur, Tempo e racconto. Volume 2. La configurazione nel racconto di finzione, tr. it. di G. Grampa, Jaca Book, Milano, 19871, pp. 187-214; Id., Tempo e racconto. Volume 3. Il tempo raccontato, tr. it. di G. Grampa, Jaca Book, Milano, 20072, pp. 193-212. Per quel che riguarda il tema qui affrontato si farà riferimento prevalentemente all‟impostazione del problema presentata da Ricœur nel terzo volume di Tempo e racconto, in cui viene inquadrato più precisamente il carattere filosofico del problema. 4 Id., Tempo e racconto. Volume 3, cit., pp. 194-195.
© Logoi.ph – Journal of Philosophy - ISSN 2420-9775 N. I , 2, 2015 – P. Ricoeur and the Symphony of the Languages
197
eidetico»5. Coi romanzi presi in esame in questa sezione è possibile una «reviviscenza del tema dell‟eternità»6. Essi infatti «forniscono all‟immaginazione un vasto campo di possibilità di eternizzazione, che hanno un solo tratto comune: quello d‟essere messi in coppia con la morte»7. In questo senso, le narrazioni sul tempo sono in grado di recuperare alla riflessione il rapporto tra tempo, morte ed eternità che nella filosofia fenomenologica husserliana e ancor di più heideggeriana, rimaneva non esplicitato.
È a partire da questa prospettiva, quindi, che Ricœur può rivolgersi alle „favole sul tempo‟ dal momento che
le esperienze-limite che, nel regno della finzione, contrappongono eternità e morte, servono al tempo stesso da rivelatore nei riguardi dei limiti della fenomenologia, che col suo metodo di riduzione porta a privilegiare l‟immanenza soggettiva, non soltanto riguardo alle trascendenze esteriori, ma anche a riguardo delle trascendenze superiori8.
È quindi in questo spirito che Ricœur si accinge a parlare del romanzo di Thomas Mann.
In esso infatti è estremamente forte l‟ambiguità di un domandare esperienziale che rifugge la tematizzazione speculativa di quell‟interrogativo sull‟eternità che tuttavia ha abitato la speculazione filosofica fino ad Hegel, lasciando poi il testimone a chi dell‟eternità fece una esperienza fondante del proprio filosofare9.
Non è un caso che da subito Ricœur presenti la questione della temporalità ne La montagna incantata sotto il segno della „perversione‟. Egli sostiene infatti che il tempo del Berghof in cui si svolgono le vicende narrate è «un tempo malsano e decadente, dove l‟erotismo stesso è segnato dalle stigmate della corruzione»10. Proprio per questo l‟antinomia tra tempo cosmologico e tempo esistenziale viene a risolversi nel tentativo di estromettere completamente il primo rispetto al secondo. Hans Castorp, protagonista del romanzo,
tenta di risolvere l‟antinomia con l‟abolizione delle misure del tempo. La posta in gioco, per conseguenza, è quella di sapere quale addestramento, quale elevazione – quale Steigerung – può risultare da una sperimentazione con il tempo, così amputato di ciò che ne fa una grandezza, una magnitudine. […] rispetto alla reiscrizione mediante la storia del tempo vissuto entro il tempo cosmico, Der Zauberberg propone una variazione immaginativa particolarmente perversa; infatti è ancora un modo di rapportarsi al tempo cosmico quello di tentare di sopprimere le tracce di tale tempo, come fa il medico astuto che offre ai suoi pazienti truffatori un termometro non graduato: è ancora nei panni della „suora muta‟ che il tempo ordinario accompagna l‟avventura spirituale dell‟eroe11.
Il gioco del tempo nelle regioni montane è quindi tale che costituisce un inganno
costante. Per quanto infatti i personaggi, e in particolare il protagonista con la sua ambigua malattia, cerchino di sfuggire al tempo ordinario, sono comunque tarlati da quel „male di vivere‟ che rende impossibile un distacco definitivo tra questi due livelli. Seppur nell‟assenza, il tempo cronologico continua a far sentire i suoi effetti, negativamente, accusando in un certo senso la dimensione del vissuto interiore per averlo estromesso dalla sua centralità, per abbandonarlo „al basso‟. „Basso‟ che drammaticamente tornerà a far
5 Ivi, p. 211. 6 Ibid. 7 Ibid. 8 Ivi, p. 212. 9 Mi riferisco a tale proposito a pensatori come Schopenhauer e Nietzsche, di cui si tratterà diffusamente più avanti, in quanto senz‟altro costituirono fonte di ispirazione per il concetto di eternità in Mann. 10 P. Ricœur, Tempo e racconto. Volume 3, cit., p. 198. 11 Ivi, pp. 198-99.
© Logoi.ph – Journal of Philosophy - ISSN 2420-9775 N. I , 2, 2015 – P. Ricoeur and the Symphony of the Languages
198
sentire la sua voce proprio alla fine del romanzo, col tuonare dei cannoni della prima guerra mondiale12.
Così, il tempo cosmico, scacciato dai personaggi del romanzo in cerca di una elevazione metafisica, si ritrova alla fine pesantemente a svolgere il suo ruolo di richiamo ad una realtà rispetto a cui l‟anelito all‟eternità costituisce l‟„incanto‟ della montagna. Ed è proprio su questa via che ci conducono le considerazioni ricœuriane, nel momento in cui il Nostro si appresta ad introdurre quello che forse può essere considerato il momento saliente che caratterizza la narrazione sul tempo dello Zauberberg, in cui cioè il fascino maligno della montagna fa sentire maggiormente i suoi effetti di irretimento sulla percezione della temporalità.
Ricœur, nel terzo volume di Tempo e racconto, introduce questo aspetto con una considerazione sul romanzo di Virginia Woolf Mrs. Dalloway a proposito del suicidio del protagonista, Septimus, che testimonia come «il tempo è un ostacolo assoluto nei confronti della visione completa dell‟unità cosmica. Noi diciamo: non è più il tempo che è mortale, è l‟eternità che dà la morte»13. Questa terribile considerazione pesa come un macigno nel momento in cui ci si accinge ad introdurre tale tema nello Zauberberg. Esso infatti è, a detta di Ricœur medesimo «la finzione più ricca di variazioni sul tema dell‟eternità e della morte»14.
Per Ricœur è infatti possibile distinguere nel romanzo di Mann quattro momenti fondamentali in cui viene esplicitato il rapporto tra tempo ed eternità in cui questo tema viene sottoposto a delle variazioni che ne mettono in luce la differente portata di significato. È così che si presenta al lettore il caso della Ewigkeitsuppe15, in cui l‟eternità viene presentata come „la solita minestra‟: un ripetersi all‟infinito del medesimo che risuona ironicamente più come una condanna che come una beatitudine. Altra cosa è, invece «l‟eternità da carnevale della Walpurgischnacht»16, in cui i partecipanti alla festa sono rapiti come in un sogno in cui continuamente si dissimulano i rapporti, e l‟eternità vi appare come una presa in giro, rispetto alla „condanna a morte‟ dinanzi alla quale sono posti tutti i partecipanti, pazienti del Berghof. Un altro aspetto che ancora viene messo in luce nel romanzo di Mann è poi quello dell‟„eternità‟ immobile della circolazione stellare, dinanzi a cui è posto il protagonista, in particolare nella contemplazione notturna della „cura a sdraio‟. E infine, l‟episodio cardine di tutto il romanzo nel capitolo intitolato Schnee in cui l‟eternità viene presentata nella sua dimensione „giubilante‟.
Queste quattro modalità di presentarsi dell‟eternità nel romanzo di Mann costituiscono il tema delle variazioni immaginative che permettono di coglierla nella sua plurilivellità a seconda del piano su cui si colloca l‟esperienza e la coscienza di colui che la compie. Tuttavia, Ricœur non tematizza esplicitamente questo aspetto, piuttosto, si rifugia dietro l‟„ironia del narratore‟, che per lo stesso Mann sarebbe lo strumento per presentare il tema del rapporto tra tempo ed eternità, senza lasciarsi troppo coinvolgere in quella tensione che a partire da una tale questione fondamentale viene a crearsi. In questo senso, l‟ironia di Mann verrebbe a costituire una sorta di schermo dietro il quale operare e manovrare le
12 Da questo punto di vista Ricœur si domanda in Tempo e racconto 2 che relazione ci sia nello Zauberberg tra la dimensione dello Zeitroman, quella del Bildungsroman l‟atmosfera di morte e di decadenza culturale all‟interno del quale si colloca la vicenda narrata. Queste dimensioni si intrecciano propriamente nella figura del personaggio principale del romanzo che diviene così il catalizzatore di queste linee di fuga intorno a cui ruota la trama del romanzo. Secondo Ricœur infatti Castorp «né vinto dall‟universo malsano, né vincitore goethiano in un trionfo grazie all‟azione, non sarebbe piuttosto una vittima la cui crescita avviene nella dimensione della lucidità, della potenza riflessiva?»: P. Ricœur, Tempo e racconto. Volume 2, cit., pp. 194-195. 13 P. Ricœur, Tempo e racconto. Volume 3, cit., p. 205. 14 Ibid. 15 Cfr. a tale proposito anche Id., Tempo e racconto. Volume 2, cit., pp. 203-204. 16 Id., Tempo e racconto. Volume 3, cit., p. 205. Cfr. a tale proposito anche Id., Tempo e racconto. Volume 2, cit., p. 205.
© Logoi.ph – Journal of Philosophy - ISSN 2420-9775 N. I , 2, 2015 – P. Ricoeur and the Symphony of the Languages
199
molteplici modalità di espressione dell‟eternità, senza il bisogno di doversi mettere in gioco, sperimentandola fino in fondo nella sua dimensione qualitativa. È quindi un po‟ come se l‟autore volesse in qualche modo invitarci a prendere parte indicandoci più vie, senza tuttavia indirizzarci esclusivamente verso l‟una, piuttosto che verso l‟altra. E tuttavia non si può certo negare che l‟eternità di Schnee costituisca un momento essenziale, senza il quale non potrebbero essere comprese „ironicamente‟ anche le altre. Tale esperienza costituisce infatti da ultimo il criterio che in qualche modo illumina tutte le altre, conferendogli senso, in una sorta di climax ascendente che costituisce uno dei punti di fuga dell‟intero romanzo17.
La lettura ricœuriana, da questo punto di vista, oscilla tra due direttrici principali, senza mai prendere espressamente partito. Da un lato infatti Ricœur continua a collocarsi nella dimensione di fascinazione propria della montagna incantata, in virtù di cui essa manifesta come sia l‟eternità a dare la morte, manifestando tutta la sua potenza negativa nei confronti della vita, una sorta di cupio dissolvi da cui tutte le dimensioni dell‟eternità presentate da Mann sarebbero pervase: «Quanto all‟affinità che può sussistere tra queste eternità disparate – afferma infatti Ricœur a tale proposito –, non è certo che essa non sia assicurata dal fascino malefico della „montagna incantata‟»18.
Così, il rapporto tra tempo ed eternità nello Zauberberg, appare inficiato, forse addirittura infettato, nella lettura ricœuriana dalla presenza ossessiva della malattia come anticipazione di quella morte che costituisce il cardine della narrazione. Si tratta tuttavia di vedere in che misura l‟intenzione manniana si orienti su questa prospettiva, cercando di cogliere le fonti che condussero Mann sulla via dell‟eterno. Su questa strada si incontrano senz‟altro Schopenhauer e Nietzsche come ispiratori, in cui la „tentazione dell‟eterno‟ fa sentire la sua voce oltre l‟atmosfera di decadenza entro cui il romanzo si colloca. 2) L’esperienza dell’eternità nello Zauberberg a partire dai saggi di Mann su Schopenhauer e Nietzsche
A Schopenhauer e Nietzsche il „mago‟ di Lubecca dedicò due vibranti saggi19, che a mio parere possono costituire la chiave di accesso filosofica al tema del rapporto tra tempo ed eternità che si presenta nel capolavoro qui preso in considerazione20.
Occorre quindi innanzitutto sgombrare il campo da un possibile fraintendimento che potrebbe occorrere con l‟impostazione di un simile problema. Si tratta dell‟idea inveterata in virtù di cui Schopenhauer e Nietzsche sarebbero „pensatori della volontà‟: più specificamente della „volontà di vivere‟, l‟uno, e della „volontà di potenza‟, l‟altro. In questo ovviamente contrapposti l‟uno all‟altro in una affermazione/distruzione degli ideali ascetici che costituirebbero il campo di contesa tra i due. In realtà, per quanto lo stesso Mann nei suoi saggi non riesca del tutto ad evitare di cadere in questa diatriba – inaugurata dallo stesso Nietzsche allo scopo di occultare il suo più profondo legame col maestro – ciò che si vuole qui adottare come pregiudizio produttivo è piuttosto l‟idea in virtù di cui i due pensatori siano accomunati da un profondo senso per l‟eternità nella sua relazione col
17 Dice Ricœur a tale proposito: «Da tutti questi avvenimenti emerge un episodio – Schnee, „Neve‟ – che solo merita di essere inscritto nella successione degli istanti di sogno e dei sogni d‟amore evocati nelle ultime righe del romanzo, „istanti‟ (Augenblicke) che restano delle cime discontinue dove il tempo raccontato e l‟esperienza del tempo trovano insieme il loro culmine» (Tempo e racconto. Volume 2, cit., p. 206). 18 Id., Tempo e racconto. Volume 3, cit., p. 205. 19 Th. Mann, Schopenhauer, in Nobiltà dello spirito e altri saggi, cit., pp. 1235-292, e Id., La filosofia di Nietzsche alla luce della nostra esperienza, in Ivi, pp. 1298-338. 20 Nel suo saggio Thomas Mann e il tempo (Jouvence, Roma, 1980) Silvia Ferretti, prendendo in considerazione il tema all‟interno de La montagna incantata, cerca la radice di tale questione nella filosofia bergsoniana, mediante un paragone con la Recherche di Proust. Viene tuttavia tralasciata una tale radice schopenhaueriana e nietzscheana, che del rapporto tra tempo ed eternità fecero uno degli elementi centrali del loro pensiero.
© Logoi.ph – Journal of Philosophy - ISSN 2420-9775 N. I , 2, 2015 – P. Ricoeur and the Symphony of the Languages
200
tempo, di volta in volta colta su livelli e da punti di vista differenti, ma che comunque rimane a fondamento della loro esperienza filosofica.
La sensibilità di Mann non manca di riconoscere questo aspetto, sottolineando in più punti dei suoi saggi il convenire dei due pensatori su questo tema essenziale. Mann, così, coglie l‟attenzione schopenhaueriana nei confronti dell‟eternità prendendo in considerazione la fonte ispiratrice principale di una tale sapienza, ovvero Platone. La radice platonica in Schopenhauer è infatti quanto mai forte ed è proprio a partire da questa che il filosofo di Danzica poté affermare con forza il legame del suo pensiero col fondamento eterno ed imperituro dell‟essere nel suo distaccarsi dal divenire temporale. Ed è proprio in questa atmosfera che Mann colloca la sua lettura dello schopenhauerismo:
Ognuno sente che questa elevazione dell‟ideale a unica realtà, superiore al fenomeno nella sua molteplicità peritura, ha in sé qualcosa di profondamente morale: la svalutazione del mondo dei sensi a favore di quello dello spirito, del temporale a favore dell‟eterno, esattamente nello spirito che sarà del tardo cristianesimo; in questo modo, infatti, il fenomeno perituro e l‟attaccamento dei sensi a esso vengono posti in uno stato di peccato: la salvezza, la verità, la trova soltanto chi si rivolge all‟eterno. Osservata da questo punto, la filosofia di Platone mostra l‟affinità e il legame tra scienza e morale ascetica21.
Alla luce di questo platonismo di fondo, così, Mann interpreta il pensiero di
Schopenhauer, collocandolo in quell‟orizzonte di eternità in cui da sempre il platonismo stesso si riconosce nei suoi tratti essenziali. Il senso schopenhaueriano per l‟eternità risuona nel breve saggio di Mann nella tensione polare tra la vita e la morte. Ed è ancor più significativo che nell‟affermare tale relazione si faccia riferimento esplicitamente allo Zauberberg:
„Chi si interessa della vita‟ ho scritto nella Montagna incantata, „si interessa in realtà della morte‟. In queste parole è ben visibile l‟orma di Schopenhauer, profondamente impressa e persistente in tutta la mia vita. E anche sarebbe stato schopenhaueriano se avessi aggiunto: „Chi si interessa della morte, cerca in essa la vita‟ 22.
È ovvio che con una tale affermazione, allo stesso tempo, Mann si pone in continuità e
in rottura con il pensiero schopenhaueriano, aprendo a considerazioni ulteriori che vogliono piuttosto penetrare lo „spirito‟ piuttosto che la lettera dell‟eremita di Francoforte. Come infatti sarebbe stato possibile mettere simili parole sulle labbra di un filosofo che aveva fatto della negazione del mondo e della vita il significato ultimo del suo sistema? Non si tratta quindi tanto di riferire con correttezza la dottrina di un pensatore, quanto piuttosto di penetrarne il non-detto attraverso il detto, ovvero di «mostrare che noi possiamo pensare nello spirito di un filosofo senza minimamente pensare secondo quello spirito»23.
È in questo senso che quindi è possibile riunire la triade di vita, morte, eternità perché è in essa che si sostanzia lo „spirito‟ della filosofia schopenhaueriana e della poetica manniana. Perché il conflitto di vita e morte non avrebbe senso se esso non si sostanziasse della dialettica di tempo ed eterno, che costituisce proprio la soglia su cui vita e morte mutano il proprio scontro in un dialogo fecondo, rendendo l‟umanità degna e libera nella sua più profonda essenza.
Senza questo accesso alla visione delle regioni superiori dell‟essere non sarebbe possibile quella coniugazione di «pessimismo e umanità»24 che costituisce per Mann uno dei punti più alti della lettura di Schopenahuer. Lettura che in questo senso permette
21 Th. Mann, Schopenhauer, cit., p. 1241. 22 Ivi, p. 1269. 23 Ivi, p. 1271. 24 Ivi, p. 1282.
© Logoi.ph – Journal of Philosophy - ISSN 2420-9775 N. I , 2, 2015 – P. Ricoeur and the Symphony of the Languages
201
ancora a Mann di mettere in strettissima relazione l‟eremita di Francoforte con l‟asceta di Sils-Maria. È solo la possibilità di vedere il mondo giustificato nella sua dimensione estetica, e quindi platonicamente eterna, ideale, che consente a Nietzsche di sopportare il pessimismo o, meglio, di riaffermarlo nella sua potenza disvelativa. In questo, secondo Mann – e a ragione, aggiungerei – «Nietzsche restò schopenhaueriano», «anche al tempo dell‟apostasia»25.
Per quanto tuttavia Mann colga una forte continuità tra i due pensatori, risulta più difficile ritrovare, nelle parole da lui scritte su Nietzsche, la traccia dell‟eternità come elemento di congiunzione delle disparate e disperate tendenze del pensiero di quest‟ultimo. Nietzsche rimane per Mann un enigma, esattamente come la folle figura di Amleto a cui significativamente viene paragonato il filosofo di Röcken nell‟introduzione del saggio a lui dedicato26. Ed è altrettanto fuori di dubbio che con questi due saggi in qualche modo Mann voglia cercare di moderare la tendenza schopenhaueriana con quella nietzscheana e viceversa, quasi a cercare un punto di mediazione umanistico tra colui che invitò l‟umanità alla negazione totale di sé e colui che al contrario fece del superuomo la massima figura del potenziamento possibile per una umanità a venire. Questo aspetto, a ben vedere, si riverbera, seppur con mutati termini, nei personaggi di Naphta e Settembrini nello Zauberberg, entrambi prototipi di uno „schopenhauerismo‟ e di un „nietzscheanismo‟ antitetici e discordanti fino al ridicolo27, rispetto a cui si pone l‟autentica figura sperimentale del giovane Castorp, ricercatore di quel senso in grado di superare le astratte posizioni dei due „maestri‟ che languono nella „lettera‟ ideologica di una sapienza che, invece, chiede di essere interrogata nel suo „spirito‟.
Risulta più difficile rintracciare nella lettura che Mann fa di Nietzsche il tema del rapporto tra tempo ed eternità come elemento fondamentale del suo pensiero. A discapito di questa trattazione sta senz‟altro la svalutazione da parte di Mann dell‟opera capitale di Nietzsche, lo Zarathustra, a favore del polemista e dello psicologo crocifisso al legno della sua malattia28.
A parere di Mann Nietzsche si è spinto troppo in là rispetto a ciò che è concesso ad un mortale, perdendosi inevitabilmente in quelle altezze che aveva tentato di afferrare29. Tuttavia in questa lettura che si propone di analizzare la „decadenza di un pensiero‟, rimangono comunque delle tracce che, riconnettendolo alla tradizione precedentemente
25 Ivi, p. 1283. 26 Cfr. Th. Mann, La filosofia di Nietzsche alla luce della nostra esperienza, cit., p. 1298. 27 A parziale conferma di questo argomento è possibile ricordare come nello Zauberberg più volte il personaggio di Settembrini venga pateticamente indicato come «suonatore d‟organetto», lo stesso termine che Nietzsche aveva utilizzato nello Zarathustra per apostrofare i suoi animali che, non comprendendo il significato della sua visione dell‟eterno ritorno, ripetevano vanamente il suo pensiero, senza riuscire a penetrarne l‟enigma (Cfr. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, a cura di G. Colli e M. Montinari, Milano, Adelphi, 1996, pp. 255-256). Allo stesso modo, il superomismo progressista di Settembrini, non è altro che una caricatura, un „pagliaccio di Zarathustra‟, per riprendere la pregnante e sinistra figura del Prologo. 28 Cfr. Th. Mann, La filosofia alla luce della nostra esperienza, cit., p. 1306. Ad equilibrare questo sin troppo ingiusto ritratto di Zarathustra mi permetto di ricordare un saggio di tutt‟altra impostazione di E. Mirri, Considerazioni sulla figura del superuomo (in Id., Pensare il medesimo, a cura di F. Valori e M. Moschini, Napoli, ESI, 2006, pp. 319-36), che già nel titolo può ben far comprendere l‟altissimo significato filosofico della „figura‟ di Zarathustra, forse troppo rapidamente liquidata da Mann nella sua considerazione „letteraria‟ e affatto filosofica. 29 Dice a tale proposito Mann nel suo saggio su Nietzsche: «L‟immagine che ci si presenta è quella di una nobile normalità fornita di meravigliose doti, cui sembra destinata una carriera regolare e di alto livello. E invece, pur muovendo da questi principi, quale tormentoso errare per vie senza meta! Quale smarrirsi salendo troppo in alto, verso vette mortali! L‟espressione sich versteigen [smarrirsi salendo troppo in alto], che ormai sta ad indicare un giudizio morale e intellettuale, deriva dal linguaggio degli alpinisti e denota la situazione per cui, nella scalata, l‟alpinista non riesce più ad andare né avanti né indietro, ed è perduto» (Th. Mann, La filosofia di Nietzsche alla luce della nostra esperienza, cit., p. 1301).
© Logoi.ph – Journal of Philosophy - ISSN 2420-9775 N. I , 2, 2015 – P. Ricoeur and the Symphony of the Languages
202
additata nel suo precursore e maestro, permettono di scorgere degli elementi in grado di condurci nella direzione di quelle vette da Nietzsche ricercate:
Nietzsche – afferma a tale proposito Mann –, in maniera molto nobile e bella, vuole il sovrastorico, quello che distoglie il nostro sguardo dal divenire elevandolo a ciò che dà all‟esistenza carattere di eternità e di immutabilità, ossia all‟arte e alla religione. Il nemico è la scienza, poiché essa vede e conosce la storia e il divenire, non l‟immutabile, l‟eterno30.
Mann vede così nel desiderio nietzscheano di eternità quel punto di intersezione in cui si
congiungono la giustificazione estetica della vita e del mondo, la dottrina del superuomo e la difficile relazione col suo maestro Schopenhauer. Solo nell‟idea che l‟umanità si salva nei suoi più alti rappresentanti, nella dimensione del genio, anticipata da Schopenhauer e che poi diventerà normativa per il delinearsi del superuomo31, è possibile trovare un punto di sutura tra questi elementi, i quali si sostanziano tutti di una eternità che ne costituisce il sugello qualitativo supremo ed apicale, senza di cui non sarebbe possibile giustificare eternamente il mondo, e il superuomo sarebbe solo un pagliaccio che salta su una corda offendendo il periglioso cammino dell‟uomo teso tra la bestia e il superuomo. Solo così, la Steigerung compiuta da Castorp nello Zauberberg può collocarsi nella sua cornice essenziale, inscrivendosi in quell‟orizzonte filosofico che aveva fatto dell‟eternità il suo punto di riferimento: pensiero in cerca di una elevazione radicale cui il romanzo manniano tenterà di dare una narrazione, una sorta di incarnazione poetica nella viva esperienza del suo protagonista. 3) Ricœur, Mann e la ‘tentazione’ dell’eterno
L‟approccio di Mann ai due pensatori precedentemente presi in considerazione rende possibile ripensare filosoficamente il senso profondo del rapporto tra tempo ed eternità all‟interno de La montagna incantata.
Per fare questo è necessario aggiungere un elemento ulteriore che accomuna l‟opera schopenhaueriana, quella nietzscheana con lo Zauberberg di Mann, ovvero l‟ambientazione montana. Tanto la filosofia di Schopenhauer che quella di Nietzsche, infatti, sorsero sotto la possente ispirazione delle „alte vette‟ del Monte Bianco e del Pitz Bernina, così come i monti di Davos costituirono la cornice del romanzo di Mann. E questo aspetto non deve essere sottovalutato in direzione di una Steigerung, di una ascesi che sa allo stesso tempo di „askesis‟ e di „ascensus‟, che costituisce il nucleo del pensiero e della poetica tanto di Schopenhauer che di Nietzsche, quanto di Mann, per poi essere riconsiderato dallo stesso Ricœur come orizzonte di comprensione imprescindibile32. L‟ambiente montano è quindi ciò che rende possibile proprio questo movimento dello spirito nella possibilità di fornire un distacco trasumanante in cui l‟io è chiamato a fare i conti con se stesso, col limite potenziale della propria mortalità, in direzione di una meta che lo trascende e che allo stesso tempo lo richiama e lo accoglie, seppur minacciandolo. La montagna costituisce così un luogo duplice, composto di una potenziale ambiguità che tuttavia si lascia accompagnare verso la possibilità di una elevazione che ne possa afferrare la dimensione criteriante.
30 Ivi, p. 1313. 31 Su questo punto, particolarmente evidente a patire dalla connessione della II Inattuale con la dottrina dell‟eterno ritorno, si veda il già citato saggio di E. Mirri, Considerazioni sulla figura del superuomo, cit., pp. 326-27. 32 Sotto questo punto di vista va tuttavia fatto notare come per Ricœur rimanga preclusa la possibilità di un autentico inquadramento della dimensione montana nella sua qualità „ascetica‟. Dalla lettura che Ricœur dà della „montagna‟ trapela piuttosto un carattere di „fuga‟ che per il „filosofo militante‟ rimane un‟aberrazione. Al contrario tanto per Schopenhauer che per Nietzsche fu solo in quelle altezze per loro possibile concepire la loro filosofia a «6000 piedi al di là dell‟uomo e del tempo».
© Logoi.ph – Journal of Philosophy - ISSN 2420-9775 N. I , 2, 2015 – P. Ricoeur and the Symphony of the Languages
203
Ricœur ha forse troppo insistito sul carattere di ambiguità di cui sarebbe portatore un testo come La montagna incantata, ma bisogna sottolineare come essa sia generata da un‟operazione ironica. Mann riesce infatti ad ottenere un tale effetto trasportando l‟umanità malata nelle altitudini della montagna, ottenendone così una sorta di visione sub specie aeterni in cui l‟uomo „di laggiù‟, privato delle sue occupazioni abituali che si consumano nel tempo ordinario, evidenzia ancora di più la vacua inanità delle sue passioni e dei suoi „flirt‟. Da questo punto di vista, mi permetto quindi di rimarcare una differenza sostanziale rispetto alla lettura Ricœuriana. Per il pensatore francese, infatti, la „malattia‟ che aleggia, anticipatrice di morte, in tutto il romanzo è un effetto dell‟incanto della montagna su coloro che ne abitano le pendici33. Ma se fosse vero il contrario? Non è piuttosto la grande salute della montagna a mettere a nudo la malattia dell‟uomo che vive „in basso‟, che è malato di morte, pur non sapendo di esserlo? Il senza-tempo della montagna rappresenterebbe il criterio che manifesta la „malattia‟ del tempo che inconsapevolmente scorre nel mondo „mondano‟. L‟esperienza di Castorp, così, non sarebbe altro che la messa in luce di questo limite, attraverso una critica che attinge nel senso di eternità della montagna il suo criterio.
È così che abbiamo le tre fondamentali esperienze dell‟eternità del romanzo che culminano nell‟episodio Neve che costituisce il punto cardine verso cui tende tutta la narrazione. Non è un caso che al polo opposto di un tale episodio si collochi proprio quello iniziale e banale della Ewigkeitsuppe, in cui l‟eternità, vista dal punto di vista del tempo e delle sue occupazioni “ordinarie” viene colto come un vano ripetersi del medesimo, ovvero come quel temporis sine fine aut principio successio che Schopenhauer contrapponeva all‟eternità del nunc stans e che possiamo ritrovare sotto mentite spoglie nella lettura che il Nano dà dell‟eterno ritorno ne La visione e l’enigma. Il vuoto circolare del tempo su se stesso è in effetti l‟idea più immediata che l‟uomo „impegnato‟ nel calcolo del proprio vivere quotidiano si fa dell‟eternità: una noia mortale, appunto, da riempire eventualmente con una riproduzione astratta di una ordinarietà di cui non ci si libera neanche dinanzi alla morte34.
Sul secondo livello di esperienza dell‟eterno troviamo poi la dimensione sognante della Walpurgischnacht, così come già evidenziata da Ricœur. A questa esperienza è legata un‟atmosfera di fuga nelle lontananze di un esotico ricordo, legato ancora ad un erotismo che, seppur malato, si affaccia sull‟eternità come risposta possibile alla morte che nell‟erotismo stesso si annuncia. D‟altronde, il fatto che il dialogo tra Castorp e la straniera dagli occhi chirghisi si svolga in francese, lingua dell‟erotismo par excellance, tende a trascinare l‟intera visione dell‟eterno in un sogno erotico35.
L‟eternità sperimentata nell‟episodio della Walpurgischnacht risponde propriamente a questo lato dell‟esperienza dell‟eterno. Sarà necessario che Castorp raggiunga i limiti della sua esistenza possibile per elevarsi ad una contemplazione dell‟eterno il più autentica e autenticante possibile.
È così che Castorp si presenta al cospetto della montagna, in quel «mondo libero e grandioso»36. che fino a quel momento lo aveva atteso al di là delle miserie del Berghof e delle dispute rabbiose tra Naphta e Settembrini. Con questo gesto quindi «Castorp si portava in alto»37 alla ricerca di una „sfida‟38 che allo stesso tempo suonava come un
33 «La magia, la stregoneria della montagna incantata, è l‟esser stregati dalla malattia, dalla pulsione di morte. Anche l‟amore è prigioniero di questo fascino. Al Berghof sensualità e marciume camminano insieme» (P. Ricœur, Tempo e racconto. Volume 2, cit., p. 191). 34 Sono ben noti a tale proposito gli strali schopenhaueriani contro questa visione dell‟eterno come il „paese della cuccagna‟ che da sempre viene reiterato come modello di un „paradiso‟ in cui l‟uomo, avendo esaurito tutti i dolori per l‟inferno, non ha saputo mettervi altro che la noia. 35 Cfr. Th. Mann, La montagna incantata, (tr. it. di E. Pocar, Milano), Corbaccio, 1992, pp. 313 sgg. 36 Ivi, p. 447. 37 Ivi, p. 446.
© Logoi.ph – Journal of Philosophy - ISSN 2420-9775 N. I , 2, 2015 – P. Ricoeur and the Symphony of the Languages
204
radicale messa in discussione delle sue pregresse certezze ed un confronto a viso aperto con quell‟ambiente maestosamente ostile che, dall‟alto delle vette dei monti, rendeva tutto il resto drammaticamente piccolo e insignificante, chiedendo così al viandante di mettersi in cammino. Il percorso stesso che viene compiuto in questa „sfida‟ assume quindi le caratteristiche di un tentativo continuo di superare le negatività che si presentano, fino ad ottenere in cambio una visione veritativa in grado di coronare la ricerca medesima con la sua apicalità.
La montagna si mostra inizialmente nel suo aspetto annichilente, favorendo col dissolvimento delle forme abituali di cui un paesaggio innevato è capace, quella caligo mistica che costituisce il presupposto di ogni autentica visione. Il paesaggio si presenta come un «deserto invernale»39 che sempre di più accentua, nel biancore abbagliante della neve, l‟annullamento dell‟ordinario che prepara l‟avvento dello straordinario: «Era il nulla, il bianco nulla vorticoso che gli si affacciava, quando tentava di guardare»40.
Castorp, così, si abbandona alla sua visione in cui gli si fa presente l‟idea una umanità riscoperta nella sua bellezza „nonostante‟ il sacrificio dell‟innocente che si consuma tragicamente nella cella del tempio41. Ed è qui forse che a Mann si fa palese nel senso più alto quella dimensione dionisiaca che aveva colto in Nietzsche, ma che in lui egli vedeva incompiuta da una veemenza carica di follia che non permetteva di accoglierla in tutta la sua portata. Dioniso: il dio lacerato e ricomposto da Apollo è in effetti quello spirito che aleggia silenziosamente nella visione mediterranea di Castorp.
Questa volta, occorre precisarlo, non si tratta di una visione ambigua. La felicità e la pace che albergano nel paesaggio mediterraneo in cui si muovono le figure di una umanità compiuta non è frutto di un compromesso con le potenze infere che nella cella del tempio immolano l‟innocente. Si tratta piuttosto di una visione sobriamente chiara e consapevole, seppur terribile, esattamente come Nietzsche la dipinse nel suo capolavoro giovanile42 e la elaborò nella visione dell‟„eterno ritorno‟.
È esattamente il gesto compiuto da Castorp, nella consapevolezza che per alcuni momenti attraversa la sua mente una volta risvegliatosi dalla visione. È in questo contesto che egli fa un‟affermazione essenziale per comprendere il grado di persuasione qualitativa raggiunta in quegli attimi di assenza/presenza a se stesso. Venendo per un attimo di nuovo assalito dalle dispute tra il conservatorismo di Naphta e il progressismo di Settembrini, il „pupillo della vita‟, con gesto semplice quanto essenziale, si trova ad affermare l‟unica prospettiva autenticamente sapienziale derivante dalla visione ricevuta: «No, non sono problemi»! In questa negazione si condensa l‟esito della Steigerung a cui Mann consegna il suo protagonista: la visione dell‟eterno nelle altezze della montagna restituisce al suo detentore la capacità di assolversi da quella litigiosa conflittualità43.
38 Ivi, p. 449. 39 Ibid. 40 Ivi, p. 451. 41 Cfr. Ivi, pp. 460-461. Utilizzo qui volutamente la congiunzione „nonostante‟ nello stesso senso in cui Ricœur la utilizza nel suo saggio Il male. Una sfida alla filosofia e alla teologia, (a cura di I. Bertoletti), Brescia, Morcelliana, 2003, p. 54. 42 Mi riferisco a tale proposito a La nascita della tragedia, in cui Nietzsche propone la sua visione estetica del mondo in cui il fondo terribile della sapienza dionisiaca si lascia cantare dall‟ordine e dall‟equilibrio apollineo secondo una sorta di „fratellanza fra le due divinità‟ (F. Nietzsche, La nascita della tragedia, a cura di G. Colli, Milano, Adelphi, 1995, p. 145). 43 «Amore e morte: ecco una rima mal riuscita, insulsa, sbagliata. L‟amore è opposto alla morte, esso solo, non la ragione, è più forte di essa. Esso solo, non la ragione, suggerisce pensieri di bontà. (…) Voglio restare fedele alla morte dentro al mio cuore, ma rammentare con chiarezza che la fedeltà alla morte e al passato è soltanto cattiveria e tetra voluttà e misantropia, se determina il nostro pensare e governare. Per rispetto alla bontà e all’amore l’uomo ha l’obbligo di non concedere alla morte il dominio sui propri pensieri» (Th. Mann, La montagna incantata, cit., p. 464). Rileggendo queste righe mi piace sempre pensare al Cantico dei cantici, laddove lapidariamente si afferma con forza che «forte come la morte è l‟amore» (Cc, 8:6). Solo
© Logoi.ph – Journal of Philosophy - ISSN 2420-9775 N. I , 2, 2015 – P. Ricoeur and the Symphony of the Languages
205
È qui che, propriamente, si compie la „tentazione dell‟eterno‟ nella lettura dello Zauberberg. È da qui che essa attinge il suo valore e il suo significato, così come la assunse per Schopenhauer e per Nietzsche sulle alte vette del pensare da loro frequentate. Questo perché l‟eterno tenta, ma non inganna. Chi eventualmente si inganna è l‟uomo in quanto tale, nella sua fallibilità ed è questo un „mistero‟ destinato a rimanere tale.
In questo senso è possibile quindi anche rileggere l‟interpretazione ricœuriana, tentando di capovolgere la prospettiva entro cui Ricœur stesso legge il romanzo. Per il pensatore francese, infatti, l‟atmosfera generale entro la quale si colloca il romanzo è quella di un generale senso di decadenza in cui l‟incanto della montagna è generato dalla manifesta corruzione che alberga nel sanatorio, rispetto a cui la stessa esperienza dell‟eterno che lì si realizza sarebbe inficiata dall‟impossibilità di tradursi in una efficace „guarigione‟ o „salvezza‟ per il protagonista. Rimane uno iato incolmabile tra il tempo e l‟eterno, secondo Ricœur, in virtù di cui quest‟ultimo sarà sempre condizione negativa del primo, anche quando, si sarà annullato ogni tempo ordinario e fatto spazio per la temporalità pura del vissuto interiore – esattamente come egli spiega nell‟introduzione del tema agostiniano dominante in Tempo e racconto.
Tuttavia, rimane una domanda che forse è possibile ancora rivolgere ad un romanzo come La montagna incantata, ovvero se l‟„incanto‟ di cui in essa si parla non nasconda in sé un significato duplice, che può sconfinare nell‟ambiguità e nell‟ironia parodistica solo se considerato da „un‟ angolo visuale che è quello appunto della „malattia‟ e della „morte‟. A partire da questi due elementi, certamente predominanti nella narrazione, l‟eternità non può che apparire come un sinistro scherzo, una presa in giro che conduce sull‟orlo di un baratro da cui non si fa più ritorno. Questo sarebbe vero solo se non vi fosse la narrazione di Neve, che non a caso viene considerata tanto da Mann quanto da Ricœur stesso il nucleo essenziale di tutta la narrazione. In questa visione, anticipata dal richiamo che Castorp sente provenire dalla montagna, è l‟eterno nella sua translucidità a mostrarsi „al di là del bene e del male‟.
È la „tentazione dell‟eterno‟, di cui si vuole mostrare il lato tanto soggettivo che oggettivo del genitivo. Certo, se da un lato Castorp è tentato dall‟eterno, lo è nella misura in cui vi è condotto da un distacco generato dalla morte e dalla malattia. Sono infatti esse a condurlo sulla soglia potenzialmente annichilente di un mondo pervertito dall‟assentarsi degli standard di funzionalità tipici del mondo umano comune. Tuttavia, non sembra che Ricœur prenda in considerazione la seconda possibilità, in virtù di cui la tentazione dell‟eterno possa risuonare secondo una modalità per cui è l‟eterno a tentare Castorp, ad avocarlo a sé in una aproblematicità che costituisce la condizione preliminare di ogni disvelamento veritativo. Da questo punto di vista, la „sfida‟ con cui il protagonista si avventura nel cuore della montagna non è tanto una provocazione soggettiva quanto piuttosto l‟accoglimento di un richiamo che proviene dal profondo di se stesso, da quell‟altezza che costituisce il criterio non ulteriormente sondabile in virtù di cui il tempo si mostra per quel che è: un non-problema. Questo è il presupposto della testimonianza e della profezia, ovvero di quello spirito che rende una storia degna di essere raccontata.
Come recita Geremia (20,7): «Tu mi hai sedotto o signore, e io mi sono lasciato sedurre». È questo in fondo il rapporto che Castorp intrattiene con l‟„incanto‟ della montagna, oltre la malattia e la morte. È questa la tentazione dell‟eterno che qui si è tentato di mettere in evidenza sulla scia della lettura ricœuriana44. Castorp attraversa la
questa affermazione, in effetti, rende il poema erotico contenuto nella Bibbia carico di un messaggio che supera l‟erotismo e dischiude ad una dimensione più alta, agapica. 44 È inevitabile a tale proposito un riferimento all‟altra „tentazione‟ che Ricœur tenterà in ogni modo di scongiurare. Si tratta della „tentazione hegeliana‟ di una sintesi assoluta di tempo ed eternità nell‟assoluto (Cfr. P. Ricœur, Tempo e racconto. Volume 3, cit., pp. 298-316). Se quindi è necessario per il francese „rinunciare a Hegel‟, tuttavia ciò non vuol dire „rinunciare all‟eternità‟, che rimane come tentatrice/seduttrice nel senso del profeta Geremia oltre i limiti del „soggetto padrone del senso‟.
© Logoi.ph – Journal of Philosophy - ISSN 2420-9775 N. I , 2, 2015 – P. Ricoeur and the Symphony of the Languages
206
seduzione della malattia e della morte, ma non vi soccombe perché ciò a cui tende è anche ciò che lo attende: la visione „giubilante‟ nella neve in cui si mostra l‟amore come risorsa perenne per chiunque si metta in cerca di se stesso. Alla seduzione della morte si sostituisce la seduzione dell‟eterno.
In questo senso bisogna quindi lasciar risuonare le ultime, interrogative, parole del romanzo: «Chi sa se anche da questa mondiale sagra della morte, anche dalla febbre maligna che incendia tutt‟intorno il cielo piovoso di questa sera, sorgerà un giorno l‟amore?»45. Una parola di speranza, sulla soglia dell‟eternità in cui la fallibilità umana può sempre trasfigurarsi, anche se solo per un attimo, raro.
Un tale superamento della funzione negativa della montagna, si accenna d‟altronde anche in Ricœur, quando lo Zauberberg viene associato alla Recherche di Proust. «È affascinante – dice infatti Ricœur – porre accanto le variazioni sull‟eternità di Der Zauberberg e quelle di Alla Ricerca»46. Tale accoppiamento permette infatti di rileggere il tema dell‟eternità al di là del “fascino malefico” della montagna incantata.
La combinazione di queste due letture permette infatti a Ricœur di cogliere quel quid che consente di rivalutare l‟esperienza apicale dell‟eternità, oltre l‟ironia dissimulatrice che troppo spesso finisce per sconfinare nel cinismo:
L‟accesso al regno „extra-temporale‟ delle essenze estetiche, nella grande meditazione del Tempo ritrovato, sarebbe ugualmente sorgente di delusione e di illusione quanto l‟estasi di Hans Castorp nell‟episodo Schnee, se la decisione di „fare un‟opera d‟arte‟ non venisse a fissare la fuggevole illuminazione conferendole la riconquista del tempo perduto. Non occorre allora che la storia venga a interrompere una vana esperienza di eternità: sigillando una vocazione di scrittore, l‟eternità si è mutata da sortilegio in dono; essa conferisce di „ritrovare i giorni antichi‟47.
In questo passo viene presentata l‟alternativa rifiutata per la Montagna incantata di
Mann, ma che tuttavia permane e si riafferma proprio sull‟apparente sfondo negativo dell‟incanto-perversione. È infatti fuori di dubbio che l‟episodio Schnee sia fonte di „delusione‟ per Hans Castorp, la cui figura ironica di ingegnere che si affaccia sui temi della trascendenza, del tempo e della morte non può che fallire dinanzi al „Graal‟48 dell‟eternità che gli si presenta nella visione durante la tormenta di neve. Appena tornato al Berghof, una volta scampata la morte per assideramento, infatti, si dice che egli „mangiò come un lupo‟ dimenticando poco alla volta la visione dell‟eternità „giubilante‟ ricevuta in dono tra le braccia della montagna. Tuttavia, se per un attimo è possibile sospendere l‟ironia del narratore per farsi trascinare nella dimensione propria, qualitativamente fondativa degli attimi vissuti da Hans Castorp lassù, in mezzo alla neve, si potrà constatare come il bisogno profondo che spinge Mann a narrare un simile episodio-chiave per tutto il romanzo non è che lo stesso di quello esplicitato da Proust ne La recherche. La „decisione
45 Th. Mann, La montagna incantata, cit., p. 676. Vale la pena di ricordare a tale proposito anche la parole con cui lo scrittore di Lubecca concludeva la sua conferenza sullo Zauberberg all‟università di Princeton: «Castorp cercatore del Graal: non credo che Loro ci abbiano pensato, leggendo la mia storia, e se io stesso lo pensai, fu più e meno che un pensiero. Rileggano il libro sotto questo angolo visuale: forse troveranno che cosa sia il Graal, il sapere, l‟iniziazione, quel „supremo‟ che non solo l‟ingenuo protagonista, ma anche il libro stesso va cercando. Lo troveranno soprattutto nel capitolo intitolato „Neve‟, dove Castorp, smarrito in altitudini mortali, sogna la sua poetica visione dell‟uomo. Il Graal che egli, anche se non lo trova, intuisce nel suo sogno quasi mortale prima di essere trascinato dalla sua altezza nella catastrofe europea, è l‟idea dell‟uomo, la concezione di una umanità futura, passata attraverso la più profonda conoscenza della malattia e della morte. Il Graal è un mistero, ma tale è anche l‟umanità: poiché l‟uomo stesso è un mistero, e ogni umanità è fondata sul rispetto del mistero umano». (Th. Mann, Introduzione alla ‘Montagna incantata’ per gli studenti dell’Università di Princeton, in La nobiltà dello spirito e altri saggi, a cura di A. Landolfi, Milano, Mondadori, 1997, p. 1521). 46 P. Ricœur, Tempo e racconto. Volume 3, cit., p. 205. 47 Ibid. 48 Cfr. Th. Mann, Introduzione alla ‘Montagna incantata’ per gli studenti dell’Università di Princeton, cit., p. 1521.
© Logoi.ph – Journal of Philosophy - ISSN 2420-9775 N. I , 2, 2015 – P. Ricoeur and the Symphony of the Languages
207
di fare un‟opera d‟arte‟ costituisce sempre al fondo il desiderio di fissare una esperienza di eternità, che nel suo darsi qualitativo non è mai „vana‟. L‟eternità costituisce sempre un „dono‟ e per questo chiede di essere poetata. Anche se filtrata attraverso le maglie di una visione apparentemente ironica e distaccata di una narrazione che tende a proporre delle alternative, piuttosto che „imporre‟ delle prospettive, la potenza della visione permane in tutta la sua portata poetica, perché in essa è pur sempre la „vetta‟ del monte che tenta il narratore e chiede di essere raccontata.
Così lo Zauberberg, l‟incanto di cui esso racconta, può essere letto sulla base di una plurilivellità di esperienze in virtù di cui l‟apparente ambiguità che si costituisce nella polarità del termine „incanto‟, possa essere superata in direzione di una qualità ulteriore di cui proprio l‟episodio Schnee è la più alta, seppur rara, testimonianza.