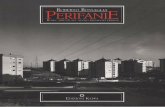[con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores...
Transcript of [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores...
FRANCESCO D’AIUTO - DONATELLA BUCCA
PER LO STUDIO DELLE ORIGINI DELLA PARACLETICA:ALCUNI TESTIMONI ANTIQUIORES D’AMBITO ORIENTALE E ITALIOTA*
Questo intervento muove dalla constatazione di una carenza all’interno di unospecifico settore della bizantinistica, quello degli studi di innografia e musico-logia. È trascorso, infatti, ormai quasi un secolo e mezzo dall’inizio degli studicritici di innografia bizantina, che hanno preso le mosse dalla riscoperta, nel1859, delle leggi ritmiche dell’innografia bizantina ad opera del benedettinoJean-Baptiste Pitra (1812-1889)1; eppure, dopo tanti studi fondamentali e tanteeccellenti edizioni di testi, si deve purtroppo ammettere che ancor oggi benpoco si sa dell’evoluzione nel tempo dei libri innografico-liturgici della Chiesabizantina, quali il Triodio, il Pentecostario, l’Ottoeco-Paracletica, i Menei, l’Ir-mologio, e così via. Si ignora quasi tutto, in particolare, della struttura stessadei più antichi codici superstiti di ciascuna collezione innografica.
In effetti, nonostante tali venerandi testimoni manoscritti custodiscano unaproduzione letteraria ricchissima, spesso pregevole, e in parte tuttora viva evitale nella tradizione di canto della Chiesa greca, essi per lo più continuano agiacere ignorati, o quasi, nelle biblioteche che li conservano; e con essi restanonell’ombra, sotto molti punti di vista, i primi secoli della storia dell’innografiabizantina, in particolare per quanto attiene ad alcuni aspetti dell’evoluzionedei generi innografici e alla questione della costituzione e sistemazione delleraccolte di inni.
Gli stessi importanti lavori di edizione critica a carattere erudito dei testiinnografici antichi non hanno potuto finora poggiare, nella gran parte dei casi,su un’accettabile euristica dei manoscritti, per via dello stato di arretratezza
73
* Il presente studio rientra nell’ambito del Progetto di ricerca d’interesse nazionale (PRIN2007) dal titolo “Per un corpus dei manoscritti innografici antiquiores” (sul quale cfr. infra, n. 7).Siamo grati agli organizzatori del Congresso Niliano di Catania del novembre 2007, e in specialmodo alla professoressa Maria Dora Spadaro, per l’invito a partecipare con un intervento suquesto tema. In questa stesura per la stampa, a Francesco D’Aiuto si devono le pp. 73-77,83-86, a Donatella Bucca le pp. 77-82, 87-92.
1 Per una recente sintesi sulla scoperta – o, più precisamente, riscoperta – delle leggi del-l’innografia bizantina ci permettiamo di rinviare a F. D’Aiuto, L’innografia, in Lo spazio letterariodel Medioevo, III: Le culture circostanti, dir. M. Capaldo [et al.], 1: La cultura bizantina, a cura di G.Cavallo, Roma 2004, pp. 257-300: 262-268.
della catalografia speciale dedicata ai codici innografico-musicali2; e lo scavonelle collezioni manoscritte insegna che tanti sono ancora i testi inediti, anchemolto antichi e di grande interesse, che aspettano di essere segnalati, censiti eportati alla luce in edizioni principes3, e che inoltre numerosi sono i manoscrittidi grande antichità che non sono stati mai utilizzati per pubblicarne testi in-nografici che sono già editi a stampa solo sulla base di recentiores. Inoltre, un’in-dagine più sistematica condotta anche su vetusti testimoni frammentari,compresi quelli papiracei, e sui membra disiecta da recuperi codicologici o con-servatisi in fogli palinsesti, potrebbe contribuire non poco a gettare luce sucerte primitive forme innografiche – come anche un contributo recente fa in-tuire4 –, o sull’originaria struttura dei libri liturgico-innografici5, o, ancora, supeculiari tipi di notazione musicale, o di “quasi-notation”, come talune arcaicheforme di notazione sono state meglio definite6.
74
2 Prescindendo dalle edizioni di singoli autori o inni, fra le edizioni erudite di specifici librio collezioni di testi segnaliamo almeno: l’edizione parziale del Theotokarion in S. Eustratiades,Qeotok£rion, I, Chennevières-sur-Marne 1931 (ma per il Theotokarion si veda anche l’edi-zione di Enrica Follieri citata infra, n. 32); quella dei testi dell’Irmologio in Id., EƒrmolÒgion,Chennevières-sur-Marne 1932; quella d’una ricca serie di inni dei Menei trasmessi principal-mente da codici dell’Italia meridionale, nella serie Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiaeinferioris, I. Schirò consilio et ductu edita, I-XIII, Roma 1966-1983; l’edizione, infine, di alcuniinni inediti da Triodi manoscritti italogreci in E.I. Tomadakes, ”Aismata toà TriJd…ou ™ra-nisqšnta ™k kwd…kwn tÁj K£tw ’Ital…aj, I-II, ™n ’Aq»naij 1995-2004.
3 A titolo d’esempio, basti consultare il repertorio di canoni inediti dei Menei pubblicatodi recente in helene Papaeliopulu-Photopulu, Tame‹on ¢nekdÒtwn Buzantinîn ¢ÄsmatikînkanÒnwn, seu Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Orientis christiani, I: KanÒnej Mhna…wn,’AqÁnai 1996, con le osservazioni, correzioni e aggiunte contenute in D. Strategopulos,’Anškdotoi buzantinoˆ ¢Äsmatikoˆ kanÒnej. Diorqèseij kaˆ prosqÁkej, Buzantin£ 20, 1999,pp. 253-266, oppure scorrere l’inventario dei nuovi frammenti sinaitici scoperti nel 1975,buona parte dei quali a carattere innografico, in `Ier¦ Mon¾ kaˆ ’Arciepiskop¾ toà Sin©. T¦nša eØr»mata toà Sin©, [a cura di P. Nikolopulos et al.], ’AqÁnai 1998, con le correzioni eprecisazioni contenute in P. Géhin - S. Frøyshov, Nouvelles découvertes sinaïtiques: à propos de laparution de l’inventaire des manuscrits grecs, REB 58, 2000, pp. 167-184.
4 F. D’Aiuto, Un antico inno per la Resurrezione (con nuove testimonianze di «scrittura mista» d’areaorientale), RSBN, n.s. 45, 2008, pp. 3-135, con XII tavv. f.t. Sull’inno ivi edito, prime notizie giàin Id., Per la storia dei libri liturgico-innografici bizantini: un progetto di catalogazione dei manoscritti piùantichi, BollGrott, ser. III, 3, 2006, pp. 53-66: 63-66.
5 Cfr. P. Jeffery, A window on the formation of the medieval chant repertories: the Greek palimpsestfragments in Princeton University MS Garrett 24, in The Past in the Present. Papers Read at the IMSVisegrád 2000, II, Budapest 2003, pp. 1-22; D’Aiuto, Per la storia dei libri liturgico-innografici bi-zantini, pp. 59-65.
6 Cfr. J. Raasted, The Princeton Heirmologion Palimpsest, CIMAGL 62, 1992, pp. 219-232; Id.,Zur Erforschung der Paläobyzantinischen Musikquellen, in J. Raasted - C. Troelsgaard (eds.), Palaeobyzan-
In questa sede tenteremo, allora, di fare almeno un piccolo passo in avanti inquesta direzione, rendendo noti i primi risultati parziali di un progetto di ricercache prevede la collaborazione fra studiosi di diverse Università: un progetto chemira a offrire da un lato un censimento, dall’altro nuove descrizioni analitichedei più antichi manoscritti innografici pervenutici, in special modo quelli datatio databili all’incirca entro l’anno Mille (ma con alcuni sconfinamenti cronologicimirati)7. Il fine è quello di creare un vero e proprio corpus destinato a contenere,col tempo, centinaia di descrizioni dei “Codices hymnographici Byzantini anti-quiores”, e che potrà costituire un punto di partenza e uno strumento di lavoroper ricostruire le diverse facies primitive di ogni differente libro innografico dellaChiesa bizantina, chiarendo le dinamiche evolutive interne a ciascuna collezione.
Per questa comunicazione, in particolare, al fine di dare un primo saggio,abbiamo voluto concentrarci sullo studio delle origini di un fondamentale librodell’ufficiatura bizantina, la Paracletica, o Grande Ottoeco8. A tal fine ci siamoserviti, per compiere i nostri sondaggi iniziali, di un certo numero di testimonisia orientali sia italogreci, dei quali diremo più avanti. Ma sarà bene, prelimi-narmente, dire qualche parola sul libro innografico di cui ci occuperemo. Comeè noto, l’Ottoeco, in quella che è considerata la sua forma più semplice, costi-tuisce l’ufficiatura per un ciclo mobile, di otto domeniche consecutive, che siripete più volte durante l’anno. Tale ufficiatura è, dal punto di vista tematico,
75
tine Notations. A Reconsideration of the Source Material, hernen 1995, pp. 1-10 (con segnalazionedella bibliografia precedente); J. Raasted, Theta Notation and Some Related Notational Types, ibid.,pp. 57-62; I. Papathanasiou - N. Boukas, Early Diastematic Notation in Greek Christian HymnographicTexts of Coptic Origin. A Reconsideration of the Sources Material, in Palaeobyzantine Notations, III: Actaof the Congress held at hernen Castle, The Netherlands, in March 2001, ed. by Gerda Wolfram(Eastern Christian Studies 4), Leuven-Paris-Dudley, MA 2004, pp. 1-25.
7 Il progetto ha ricevuto, di recente, un finanziamento da parte del Ministero dell’Universitàe della Ricerca (MIUR) in qualità di Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2007):“Per un corpus dei manoscritti innografici antiquiores” (coordinatore nazionale: FrancescoD’Aiuto). Le unità di ricerca in esso impegnate appartengono alle Università di Messina (An-tonio Labate [coord.], Alessia A. Aletta, Giorgio Barone Adesi, Donatella Bucca), di Roma“La Sapienza” (Andrea Luzzi [coord.], Angela Armati, Marco Cerasoli, Elena Paroli) e diRoma “Tor Vergata” (Francesco D’Aiuto [coord.], Luigi D’Amelia, Santo Lucà). Un’esposi-zione delle finalità del progetto e della sua struttura in D’Aiuto, Per la storia dei libri liturgico-in-nografici bizantini, ove è pubblicato il testo dell’intervento presentato al Congresso internazionale“The Current State of Byzantine Musical Studies after 75 years of Monumenta Musicae By-zantinae” (Copenhagen, 16-17 giugno 2006).
8 Schematiche definizioni dei termini qui impiegati si trovano in h. husmann, Hymnus undTroparion. Studien zur Geschichte der musikalischen Gattungen von Horologion und Tropologion, Jahrbuchdes Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer kulturbesitz, 1971, pp. 7-86: 31.
focalizzata sull’evento centrale della Resurrezione di Cristo, strettamente con-nesso con la festività domenicale. L’ufficiatura dell’Ottoeco è, inoltre, intima-mente legata alla struttura stessa della musica ecclesiastica, che è fondata sullaripartizione dei motivi melodici in otto modi musicali: un modo musicale, dun-que, per ciascuna domenica9.
La sistemazione dell’Ottoeco è attribuita, tradizionalmente, a Giovanni Da-masceno (ca. 675-749 o 754) e Cosma di Maiuma (ca. 675-ca. 752), sebbenenon siano mancate contestazioni di questo ruolo organizzativo dei due inno-grafi palestinesi, che, in effetti, richiede di essere verificato sul banco di provadella tradizione manoscritta10. In ogni caso, il contenuto di questo primitivoOttoeco domenicale sarà il nucleo intorno al quale si costituirà, più tardi, il librodella Paracletica, o Grande Ottoeco, che contiene l’ufficiatura non più per lesole otto domeniche, ma per un ciclo di otto intere settimane, inclusi i giorniferiali. Abbiamo detto che questo avverrà “più tardi”, con un’espressione vo-lutamente generica: ma precisamente quando, per opera di chi, e attraversoquali tappe intermedie? In effetti, tra queste due facies principali, l’Ottoeco da
76
9 Per una bibliografia di riferimento cfr. R.F. Taft - Nancy P. Ševcenko, Oktoechos, in ODB,III, p. 1520; Jeffery, Oktoechos, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. by S. Sadie,XVIII, London 20012, pp. 370-373. Fra gli studi più specifici relativi alla storia e alla strutturadi questa importante collezione innografica si segnalano in particolare: Ch. hannick, Le textede l’Oktoéchos, in Dimanche. Office selon les huit tons. ’Oktèhcoj, Chevetogne 1972, pp. 37-60; A.Cody, The Early History of the Octoechos in Syria, in Nina G. Garsoïan - Th.F. Mathews - R.W.Thomson (eds.), East of Byzantium: Syria and Armenia in the Formative Period (Dumbarton OaksSymposium 1980), Washington, D.C. 1982, pp. 89-113; P. Jeffery, The Earliest Oktoechoi: the Roleof Jerusalem and Palestine in the Beginnings of Modal Ordering, in The Study of Medieval Chant. Pathsand Bridges, East and West. In honor of kenneth Levy, ed. by P. Jeffery, Cambridge 2001, pp.147-209. Si vedano, infine, i recentissimi e documentati contributi di S.S.R. Frøyshov, The EarlyDevelopment of the Liturgical Eight-mode System in Jerusalem, St Vladimir’s Theological Quarterly51/2-3, 2007, pp. 139-178; D. Getov - Maria yovcheva, The Unedited Oktoechos Canons for Prophetsand Martyrs in the Byzantine and Slavonic Tradition, BSl 66, 2008, pp. 139-166: 139-141; Ch. Troels -gård, A New Source for the Early Octoechos? Papyrus Vindobonensis G 19.934 and its musical impli-cations, in Byzantine Musical Culture (Proceedings of the First International Conference of theAmerican Society of Byzantine Music and hymnology [ASBMh], Paiania, September 2007),Paeanea 2009, pp. 668-679, con 3 ill. (http://www.asbmh.pitt.edu/page12/Troelsgard.pdf) (diquesti tre ultimi lavori, conosciuti al momento di licenziare il presente contributo per la stampa,non si è potuto tenere pienamente conto).
10 Ai due grandi innografi palestinesi, Giovanni Damasceno e Cosma di Maiuma, sonoattribuite dalla tradizione le due serie di canoni incluse nell’Ottoeco domenicale, ovvero ilciclo completo dei canoni anastasimi, nucleo storico di inni domenicali per la Resurrezione,e il ciclo dei canoni stauroanastasimi, cfr. ad esempio hannick, Le texte de l’Oktoéchos, p. 48.Tuttavia, secondo Christian hannick, «Jean Damascène ne peut être en aucun cas considerécomme l’auteur du recueil “Oktoechos” qui n’existait pas à son époque», ibid., pp. 55-56.
un lato, il Grande Ottoeco o Paracletica dall’altro, se ne sono sviluppate – comevedremo nel procedere di questo intervento – anche altre, che non rappresen-tano necessariamente fasi di transizione all’interno di un modello evolutivo li-neare, e che comprendono repertori di inni cui si attingerà variamente per lacreazione del Grande Ottoeco.
Ma partiamo dai testimoni che sono stati da noi esaminati, per poi giungere,sulla base della loro analisi, a una prima individuazione delle “tipologie” di que-ste facies intermedie dell’evoluzione della Paracletica, avvertendo sin d’ora cheil quadro che andremo a delineare potrebbe essere col tempo reso più com-plesso, e venire integrato, grazie a ulteriori dati ricavati da testimoni cui finoranon abbiamo avuto accesso. Sono stati fatti sinora oggetto di analisi dettagliataun certo numero di manoscritti, in parte italogreci, datati o databili tra la finedel X secolo e il XII, e conservati nella Biblioteca della Badia greca di Grotta-ferrata e nella Biblioteca Regionale Universitaria di Messina, in parte – in misuraminore – orientali, di cui uno, il più antico del gruppo, custodito presso il mo-nastero di S. Caterina del Sinai e databile al IX-X secolo, un altro, il più recente,conservato nella Biblioteca Regionale Universitaria di Messina, e databile allafine del XII secolo. La scelta è stata ovviamente condizionata, in questa primafase, dall’accessibilità dei manoscritti stessi o dalla disponibilità di loro riprodu-zioni integrali; fra l’altro, ha giocato a sfavore anche la recente, inattesa chiusuraal pubblico della Biblioteca Vaticana per lavori di ristrutturazione, dal luglio2007 fino al 2010. I risultati che presentiamo qui saranno, dunque, da rivisitarsie verificarsi alla fine del progetto, quando si avranno, sperabilmente, un pano-rama esaustivo e descrizioni analitiche di tutti i manoscritti antiquiores dell’Ot-toeco-Paracletica giuntici. Il quadro in nostro possesso, tuttavia, permette sind’ora di individuare alcune linee portanti, e di intravedere, per l’età mediobi-zantina, un’unitarietà di fondo nell’evoluzione dell’Ottoeco – al di là delle ovviepeculiarità locali – anche in ambiti regionali molto distanti tra di loro, ovverofra l’area siro-palestinese e cipriota da un lato, e l’Italia meridionale dall’altro.
* * *
Iniziamo dunque con il testimone più antico da noi analizzato, il Sin. gr. 824(tav. 1). Si tratta, stando ai dati finora disponibili, di uno fra i più antichi mano-scritti pervenutici dell’Ottoeco. Sulla base dell’analisi paleografica, testuale e(solo parzialmente) codicologica lo si può collocare in un periodo compresotra gli ultimi decenni del IX secolo e, al più tardi, i primi del X11. Al di là della
77
11 Il codice, di ff. 228, misura mm 140 × 90. Per quest’antico testimone sinaitico e per
sua sede di conservazione attuale, tutta una serie di elementi depongono a fa-vore di un’origine sinaitico-palestinese del codice. In particolare:
a) l’utilizzazione di quella caratteristica minuscola primitiva d’area palestineseche Enrica Follieri definì “minuscola agiopolita”12;
b) l’uso di un inchiostro nero scuro, anziché bruno;c) l’impiego precoce della carta anziché della pergamena, tipico delle zone sot-
toposte alla dominazione araba;d) la fascicolazione per quinioni, come in altri manoscritti antichi, sia greci
che arabi, di queste zone.
Elementi di caratterizzazione aggiuntivi sono:
e) il formato “tascabile”, che ritroviamo, di frequente, in codici coevi d’ana-loga provenienza;
f) la grande densità della pagina13.
Quanto al contenuto, il Sin. gr. 824 rispecchia la struttura di base dell’Ottoeco,così come questa si riscontra in altri testimoni più antichi che sono stati fatti si-nora oggetto di analisi14. In questo manoscritto sinaitico, infatti, gli inni non sonoancora raggruppati e ordinati secondo la loro utilizzazione nell’ufficiatura, masi presentano suddivisi in base al genere innografico, con una prima parte, checontrassegneremo con la lettera A, contenente la sezione degli sticheri e quelladei càtismi, e una seconda parte, da noi indicata con B, comprendente i canoni.Entrambe le sezioni sono ordinate, al loro interno, secondo gli otto modi.
Nella sezione dei canoni, ovvero B, il numero delle composizioni previsteper ciascun modo musicale varia, così come varia il carattere e la destinazione
78
una sua descrizione analitica rinviamo al recente contributo di Donatella Bucca, Un antico ma-noscritto innografico di origine orientale: il Sin. gr. 824, RSBN, n.s. 43, 2006 (= Ricordo di LidiaPerria, II), pp. 87-136, con segnalazione della bibliografia precedente.
12 Enrica Follieri, Tommaso di Damasco e l’antica minuscola libraria greca, Rendiconti [dell’]Ac-cademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, ser. VIII, 29,1974, pp. 145-163 (rist. in Ead., Byzantina et Italograeca. Studi di filologia e di paleografia, a cura diAugusta Acconcia Longo, Lidia Perria, A. Luzzi [Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi195], Roma 1997, pp. 163-185).
13 Per più diffuse considerazioni sugli aspetti grafico-codicologici, rinviamo ancora a Bucca,Un antico manoscritto innografico, pp. 91-104.
14 Cfr. ibid., pp. 104-130, contributo di cui in questa sede saranno richiamati in breve sol-tanto i dati funzionali a quest’intervento.
dell’inno, ad eccezione del fatto che il primo canone della serie dedicata a cia-scun modo è sempre quello anastasimos comunemente attribuito a GiovanniDamasceno, definito però stauroanastasimos nel codice15.
Dopo la sezione dei canoni segue un’integrazione, che indichiamo con C,costituita da una serie ordinata di sticheri e successivamente di canoni da ese-guirsi durante i giorni feriali della settimana, nella misura di un canone per cia-scun giorno, dal lunedì al sabato. Si tratta di una serie di aggiunte destinate agiorni che, all’interno dello schema proposto nelle due precedenti sezioni,erano restate privi di inni16. Dal punto di vista musicale, quindi, i canoni si sus-seguono senza un chiaro ordine tonale.
Conclude il manoscritto un ulteriore gruppo di canoni e sticheri, da noiindicato con D, da intendersi, evidentemente, come possibile ulteriore inte-grazione; i canoni e gli sticheri si avvicendano, qui, senza rispettare né l’ordinetonale né la sequenza infrasettimanale17.
Ricapitolando, da quello che abbiamo riscontrato sin qui possiamo parlaredi un manoscritto ordinato per blocchi:
A-B) un Ottoeco domenicale completo – e feriale soltanto parziale – per gliotto modi, suddiviso in due sezioni: prima (A) sticheri e càtismi, poi (B)canoni;
79
15 Precisamente, troviamo per il I modo autentico tre canoni, il secondo catanittico e ilterzo per la Theotokos; per il II modo autentico tre canoni, di cui il secondo per gli apostolie il terzo per i defunti; per il III modo autentico due canoni, di cui il secondo per la Theotokos;per il IV modo autentico quattro canoni, il secondo per gli angeli, il terzo catanittico e il quartoper gli apostoli. Per il I modo plagale sono trascritti quattro canoni, il secondo per s. GiovanniProdromo, il terzo per la Theotokos e il quarto per i defunti; per il II modo plagale tre canoni,di cui il secondo staurosimos e il terzo per i defunti; per il III modo plagale tre canoni, il secondoper s. Giovanni Prodromo e il terzo per la Theotokos; infine, per il IV modo plagale cinquecanoni, rispettivamente per gli angeli, catanittico, per la Theotokos e staurosimos. Alcuni diquesti canoni, con ogni probabilità, sono tacitamente intesi nel codice come da cantarsi neidiversi giorni della settimana: per gli angeli il lunedì, catanittici il lunedì o il martedì, per s.Giovanni Prodromo il martedì, staurosimoi il mercoledì o il venerdì, per la Theotokos il mer-coledì, per gli apostoli il giovedì, per i defunti il sabato.
16 La successione è la seguente: per il lunedì un canone dedicato agli angeli, per il martedìa s. Giovanni Prodromo, per il mercoledì alla Theotokos, per il giovedì agli apostoli, per il ve-nerdì staurosimos, per il sabato anapausimos (per i defunti). Anche la serie degli sticheri che pre-cede immediatamente quella dei canoni presenta uguale destinazione con l’aggiunta, alla fine,di un gruppo di tre sticheri alla Theotokos da cantarsi durante i vespri del sabato.
17 Si tratta di un canone catanittico seguito da uno staurosimos e da due canoni per la Theo-tokos; tre sticheri theotokia; un canone per la Theotokos seguito da tre sticheri theotokia.
C-D) due successivi cicli di integrazioni con inni per giorni feriali rimasti “sco-perti”: il primo ciclo (C) ordinato secondo il giorno della settimana, ilsecondo (D) privo di ordine.
Un confronto con la tradizione manoscritta orientale poco più antica ecoeva fa emergere qualche differenza che riguarda l’ordine, il numero, e la pre-senza o assenza di alcune tipologie di inni soprattutto all’interno della sezionedi sticheri e càtismi18: ci riferiamo in particolare a manoscritti d’origine orientaleche non ci è stato ancora possibile analizzare personalmente in dettaglio, mache sono noti almeno nelle loro linee strutturali dalla bibliografia, ovvero ilSin. gr. 1593, dell’VIII-IX secolo19, e il Sin. gr. 779, del X secolo20. Si tratta didivergenze che testimoniano di uno stato di evidente fluidità della tradizione,che si esplica nella variabilità di scelta delle singole composizioni innografiche,pur nella sostanziale comparabilità dello schema strutturale di fondo21.
Evidenti sono le differenze rispetto a Ottoechi e Paracletiche orientali te-stimoni di una tradizione più recente, come ad esempio il Sin. gr. 79522, del
80
18 Per quanto riguarda la sezione dei canoni, l’esame della struttura di alcuni dei manoscrittisinaitici da noi considerati mostra in essi una strutturazione meno omogenea che, tuttavia,non siamo in grado di descrivere adeguatamente in mancanza di un’analisi dettagliata dellesingole composizioni innografiche.
19 Una sommaria descrizione in V. Beneševic, Catalogus codicum manuscriptorum Sinaiticorum,III/1, hildesheim 1965, p. 73. Il codice, pergamenaceo, di ff. 97, misura mm 180 × 115; i fa-scicoli sono numerati sul recto del primo foglio, con lettere dell’alfabeto greco (margine supe-riore esterno) e lettere dell’alfabeto georgiano (margine superiore interno). Il testo è vergatoin maiuscola ogivale inclinata. Questo prezioso cimelio, insieme al Sin. gr. 776 e al Lond. B.L.Add. 26.113, fa parte di un unico codice che oltretutto, allo stato attuale, pare rappresentareuno dei più antichi manoscritti pervenutici dell’Ottoeco, e tra i pochi in maiuscola, cfr. ancheinfra, n. 28. – Il lettore è qui avvertito che per i manoscritti ricordati in questo contributo sifornisce una bibliografia selettiva, per lo più limitata ai cataloghi, e soltanto funzionale alle te-matiche discusse.
20 Il codice, pergamenaceo, di ff. 294, misura mm 240 × 190; cfr. V. Gardthausen, Cataloguscodicum Graecorum Sinaiticorum, Oxonii 1886, p. 167; M. kamil, Catalogue of all manuscripts in theMonastery of St. Catherine on Mount Sinai, Wiesbaden 1970, p. 103 nr. 1065.
21 A tal proposito si confronti la descrizione sommaria del contenuto dei due Ottoechi si-naitici fornita da husmann, Hymnus und Troparion, pp. 33, 34-35, 41-42, con le tabelle contenutein Bucca, Un antico manoscritto innografico, pp. 107-108 figg. III-V, che sintetizzano la strutturadel Sin. gr. 824.
22 Il codice, pergamenaceo, di ff. 161, misura mm 210 × 150; cfr. Gardthausen, Cataloguscodicum, p. 171; kamil, Catalogue of all manuscripts, p. 104 nr. 1081; husmann, Hymnus und Tro-parion, pp. 40-41, 42. I fascicoli sono numerati, sulla prima e sull’ultima pagina, con letteredell’alfabeto greco (margine superiore esterno) e dell’alfabeto georgiano (margine centrale ri-
XII-XIII secolo, e il Messan. gr. 5123, codice d’area cipro-palestinese, attribuibilealla fine del XII secolo. In tali testimoni si evidenzia, infatti, un’evoluzione giàpienamente in atto, che porterà alla struttura che sarà poi alla base della Para-cletica a stampa, così come essa viene man mano cristallizzandosi a partiredalle edizioni cinquecentesche, e come è testimoniata, alla fine del processo,ad esempio dall’edizione romana della Paracletica di Propaganda Fide, del188524. Si tratta di un modello di Paracletica in cui il ciclo dell’ufficiatura èormai rifuso insieme e unico: non più separazione fra repertorio degli sticheri-càtismi e repertorio dei canoni come nel Sin. gr. 824, né distinzione – comevedremo più avanti in relazione ad alcuni manoscritti criptensi – fra ciclo do-menicale da una parte e uno o più eventuali cicli feriali dall’altra, ma un unicociclo settimanale, dalla domenica al sabato successivo, comprendente insieme,secondo la sequenza dell’ufficiatura, gli inni di tutte le tipologie, per otto set-timane ordinate secondo gli altrettanti modi musicali.
Tornando al Sin. gr. 824, la maggior parte del materiale tràdito nel mano-scritto è già quella che confluirà poi nelle edizioni a stampa; si segnala, tuttavia,qualche differenza:
1) una collocazione di determinati inni in giorni diversi25;2) la mancanza di importanti gruppi di inni26;3) una variazione del loro numero sia fra i diversi modi all’interno del mano-
scritto, sia in relazione agli altri testimoni utilizzati per il confronto.
Tale variabilità del contenuto dell’Ottoeco è riscontrabile anche in ulteriorimanoscritti antiquiores, che quindi documentano, verosimilmente, le fasi più an-tiche di un processo di assestamento della tradizione innografica che fu moltograduale, e non esente dal permanere, sulla lunga durata, di differenze d’ambitolocale anche vistose, all’interno di quella generale tendenza alla stabilizzazioneche alla fine si realizzerà nel repertorio, più o meno universalmente condivisofra le diverse edizioni, della moderna Paracletica a stampa.
81
spettivamente superiore e inferiore). In questo manoscritto gli sticheri anatolikà e alphabetikàe gli anabathmòi sono accompagnati dalla notazione musicale mediobizantina.
23 Sul manoscritto messinese cfr. infra, p. 89.24 Paraklhtik», ½toi ’Oktèhcoj ¹ Meg£lh […], ™n `RèmV 1885.25 Tali differenze sono indicate in dettaglio in Bucca, Un antico manoscritto innografico, pp. 117-
130.26 Basti qui segnalare l’assenza di composizioni facenti parte del repertorio più “tradizionale”
dell’Ottoeco, quali gli sticheri anatolikà e alphabetikà e gli anabathmòi, cfr. ibid., pp. 111-112.
Nel Sin. gr. 824, oltre al repertorio tipico dell’Ottoeco, sono presenti, comesi è visto, un ciclo ordinato di sticheri e di canoni per i giorni feriali (la sezioneC) e un altro gruppo non ordinato di canoni e sticheri (la sezione D)27. Unasimile struttura del manoscritto pone alcuni problemi di ordine terminologicoche, al momento, non è possibile risolvere data la scarsa conoscenza comples-siva che abbiamo di questi antichi manoscritti innografici. Manca infatti, atutt’oggi, una terminologia specifica che ci aiuti a esprimere sinteticamenteciascuna delle diverse facies, delle differenti forme strutturali con le quali l’Ot-toeco-Paracletica si presenta nei manoscritti medievali.
Effettivamente, nel Sin. gr. 824 riscontriamo già per alcuni aspetti l’appariredei connotati di fondo di una Paracletica, anche se in uno stato embrionale,dal momento che il repertorio per i giorni feriali è incompleto, nonostante leparziali integrazioni successive28. Il Sin. gr. 824 documenta bene, dunque, unafase di transizione da un Ottoeco solo domenicale (significativamente, l’unicociclo completo nel manoscritto) a una Paracletica vera e propria.
Un altro aspetto da non sottovalutare, nel codice sinaitico – che è un ma-noscritto, lo ripetiamo, degli ultimi decenni del IX secolo o dei primi del X –,è il fatto che in esso è attestata una diffusione rapidissima, nella regione sinai-tico-palestinese, di canoni attribuiti a innografi vissuti in età quasi coeva al co-dice e operanti a Costantinopoli fin nella seconda metà del IX secolo, qualiGiorgio di Nicomedia e Giuseppe l’Innografo29. Si tratta di un’ulteriore con-ferma della persistenza di stretti rapporti fra le due aree, in un fecondo scambioche, del resto, nei secoli fra l’VIII e il X sappiamo essersi realizzato a vari livelli– letterario, teologico, liturgico, e non solo –, e che comportò certamente un’in-tensa circolazione di libri fra l’area sinaitico-palestinese e Costantinopoli30.
* * *
82
27 Cfr. supra, pp. 79-80.28 La tradizione manoscritta sembra documentare l’esistenza di forme intermedie nello svi-
luppo della Paracletica, ma non esiste ancora uno studio esteso e approfondito che permettala ricostruzione storica delle sue fasi evolutive. Christian hannick ha definito “Paracletice si-naitica antiqua” quello che sembra essere il più antico Ottoeco di cui ci sia pervenuta una parteapprezzabile del contenuto (il già citato Sin. gr. 776 + Sin. gr. 1593 + Lond. B.L. Add. 26.113);ma le caratteristiche distintive di questo testimone non sono state ancora ben definite, cfr. han-nick, Le texte de l’Oktoéchos, p. 48; cfr. anche supra, n. 19.
29 Cfr. Bucca, Un antico manoscritto innografico, pp. 114, 125-130 passim.30 In questa sede ci permettiamo di rinviare soltanto, per queste problematiche, alla sintesi
e soprattutto all’ampia bibliografia raccolta in Lidia Perria - Vera von Falkenhausen - F. D’Aiuto,Introduzione, in Tra Oriente e Occidente. Scritture e libri greci fra le regioni orientali di Bisanzio e l’Italia, acura di Lidia Perria (Testi e studi bizantino-neoellenici 14), Roma 2003, pp. IX-XLVI.
Se ci volgiamo ora a Occidente, all’Italia meridionale, le testimonianze disimili scambi ci fanno pensare a una non meno vivace circolazione dei testi, edelle “innovazioni” strutturali in campo innografico-liturgico, anche fra centroe periferie occidentali. I manoscritti di origine italogreca da noi presi in esamesono, come si è anticipato, conservati a Grottaferrata e a Messina, e sono datatio databili tra il X e il XII secolo. Ecco un elenco delle loro segnature, ordinatosecondo la cronologia dei testimoni:
D. g. XII: an. 969/970D. g. XI: sec. X, seconda metàD. g. XIV: sec. XI, seconda metàD. g. I: sec. XI, seconda metàD. g. IV: sec. XI-XIID. g. VI: sec. XII, prima metàMessan. gr. 121 (ff. 211r-217v): sec. XII, prima metàMessan. gr. 109: sec. XII, seconda metà
In questi manoscritti troviamo attestati, accanto all’Ottoeco domenicale,altri differenti cicli innografici che, variamente combinati, costituiscono i ma-teriali cui si attingerà in quel lungo percorso di standardizzazione della strutturae del contenuto del libro innografico che dall’antico Ottoeco solo domenicaleconduce alla Paracletica “evoluta”.
Questi cicli aggiuntivi sono:1) la “Piccola Paracletica” (ovvero una Paracletica feriale detta anche, nei ma-
noscritti, “Piccola acolutia”), che contiene solo canoni dei giorni feriali dellasettimana, attinti a più autori;
2) il cosiddetto “Nuovo Ottoeco” (Nša ’Okt£hcoj) di Giuseppe l’Innografo,ovvero una Paracletica feriale appositamente creata dall’Innografo nell’am-bizione di soddisfare all’esigenza del canto paracletico dei giorni feriali conmateriale stilisticamente unitario; un ciclo, dunque, comprendente soltantocanoni di Giuseppe31;
3) il “Theotokarion”, ossia una serie di canoni alla Theotokos per un ciclo diotto settimane, ordinati secondo gli otto modi musicali32.
83
31 La successione dei canoni è la seguente: per il lunedì e per il martedì un canone cata-nittico, per il mercoledì e il venerdì un canone staurosimos, per il giovedì un canone per gli apo-stoli, per il sabato un canone per martiri, gerarchi, santi e defunti. Per la biografia e l’operadi Giuseppe l’Innografo si veda soprattutto la monografia di E. Tomadakes, ’Iws¾f Ð`Umnogr£foj. B…oj kaˆ �rgon, ™n ’Aq»naij 1971; cfr. anche D. Stiernon, La vie et l’œuvre de s.Joseph l’Hymnographe. À propos d’une publication récente, REB 31, 1973, pp. 243-266.
32 I testimoni manoscritti sembrano attestare la circolazione di tradizioni diverse di Theo-
Questi diversi cicli sono stati probabilmente tramandati dapprima comeentità distinte e a sé stanti, ma noi li troviamo di norma in vario modo com-presenti e disposti uno di seguito all’altro nei manoscritti mediobizantini, chene contengono più di uno. In seguito, nei codici i materiali innografici di cia-scun ciclo cominceranno a essere variamente rifusi, e alternati o mescolati traloro così da creare un ciclo unico, ordinato stavolta non per genere e tipologia,ma secondo la sequenza di esecuzione di ciascun inno nell’ufficiatura giorna-liera, e dunque secondo criteri rispondenti a fini di praticità, risultando talestruttura più funzionale al canto dell’ufficio.
Passiamo in rapida rassegna i testimoni esaminati, che custodiscono princi-palmente il repertorio dei canoni. Il più antico fra questi codici, il Crypt. D. g.XII33, è un manoscritto calabro-niliano, ed è sottoscritto e datato: fu esemplatonell’anno 969/970, verosimilmente in Calabria, da Cirillo presbitero, che nellasua sottoscrizione definisce il libro genericamente come un “Tropologio” (tav.2). Nonostante un’ampia mutilazione centrale, si riconosce agevolmente che ilcodice è in realtà una Paracletica feriale, seguita dal Nuovo Ottoeco di Giuseppe34.Il titolo posto all’inizio del codice (›teroi kanÒnej sÝn qeù katanuktiko……)fa presumere che il contenuto feriale di questo codice rappresentasse, anche peril copista, un’aggiunta rispetto al ciclo, più antico, dell’Ottoeco solo domenicale35.
84
tokaria, che si distinguono per la variabilità sia nel numero sia nella scelta dei canoni; la stessamolteplicità di scelta, come vedremo più avanti, caratterizza anche la selezione dei canonidella “Piccola Paracletica”. Oltre all’edizione del Theotokarion ad opera di S. Eustratiadescitata supra, n. 2, si può rinviare alla descrizione di un Theotokarion della Biblioteca Marcianadi Venezia, con l’edizione di tredici canoni inediti, disponibile in Enrica Follieri, Un Theotocarionmarciano del sec. XIV (cod. Marciano cl. I,6), Archivio italiano per la storia della pietà 3, 1962, pp.37-227; si vedano anche le descrizioni, rispettivamente del manoscritto Oxford, Bodleian Li-brary, Lyell 94 e di un codice vaticano, ad opera di S. Winkley, A Bodleian Theotokarion, REB31, 1973, pp. 267-273, e di P. Canart, Le Vaticanus gr. 1072 (+ Vat. gr. 2296, ff. 1-8). Un theoto-karion daté de 1301, BollGrott, n.s. 47, 1993, pp. 5-39.
33 Il codice, pergamenaceo, di ff. 65, misura mm 187 × 135. Sul manoscritto cfr. almenoA. Rocchi, Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae in Tusculano digesti et illustrati, Tusculani1883, p. 372; S. Lucà, Su origine e datazione del Crypt. B.b.VI (ff. 1-9). Appunti sulla collezione ma-noscritta greca di Grottaferrata, in Tra Oriente e Occidente, pp. 145-224: 146 e n. 1, 164, 188 n. 164,189, 199. Uno specimen in k. and Silva Lake, Dated Greek Minuscule Manuscripts to the Year 1200,X, Boston 1939, nr. 377 e pl. 711, dove il manoscritto è datato all’anno 970.
34 È presente nel codice una prima serie di canoni, uno per ciascun giorno dal lunedì alsabato (catanittico, per gli angeli, per la Theotokos, per gli apostoli, per la Theotokos, per idefunti), che termina mutila con il canone del lunedì del I modo plagale; dopo un’ampialacuna segue la parte finale del Nuovo Ottoeco di Giuseppe, a partire dal canone, acefalo, delgiovedì del IV modo plagale, dedicato agli apostoli. Si tratta della più antica attestazione delNuovo Ottoeco di Giuseppe presente nei manoscritti da noi finora esaminati.
35 È probabile, d’altra parte, che il codice di Grottaferrata, che allo stato attuale, pur con
Appartengono alla stessa tipologia di Paracletica feriale due manoscritti diorigine calabro-lucana, provenienti da Carbone: il Crypt. D. g. XI36 (tav. 3), dellaseconda metà del X secolo, e il Crypt. D. g. XIV37 (tav. 4), della seconda metàdell’XI secolo. Il primo contiene, come il codice precedente ma in ordine in-vertito, il Nuovo Ottoeco di Giuseppe seguito dalla Piccola acolutia feriale,ovvero due cicli separati di canoni per i giorni feriali, in ragione di un canoneper ciascun giorno, dal lunedì al sabato38. Il secondo manoscritto, acefalo emutilo in fine, tramanda allo stato attuale solo il Nuovo Ottoeco di Giuseppe39,ma si può ipotizzare che contenesse forse anche altro materiale innografico,probabilmente la Piccola acolutia.
Questo tipo di Paracletica feriale o Piccola acolutia sembra attestato con-temporaneamente, per le poche informazioni che ne abbiamo, anche in am-bito orientale: si vedano ad esempio il Sin. gr. 79340, un “Parakletikòn” deisecoli X-XI contenente solo canoni, uno per ciascun giorno feriale41, e il Sin.
85
lacune, presenta solo 65 fogli, facesse parte di una collezione più ampia comprendente anchel’Ottoeco domenicale stesso, poi smembrata e in parte andata perduta. Di recente Santo Lucàha riconosciuto il f. 19 del Crypt. D. g. XXXV, n. II, come appartenente alla nostra Paracletica,cfr. S. Lucà, Teodoro sacerdote, copista del Reg. gr. Pii II 35. Appunti su scribi e committenti di manoscrittigreci, BollGrott, n.s. 55, 2001, pp. 127-163: 155, affermazione poi ripresa in Id., Su origine e da-tazione, p. 164. Ancora da chiarire è il significato della prosecuzione dello stesso titolo inizialecitato sopra, secondo il quale il ciclo di canoni che lì prende avvio è po…hma ’Iws¾f monacoà:in esso si annoverano, infatti, composizioni ascrivibili per la maggior parte a Giuseppe l’In-nografo, ma anche ad altri innografi, fra le quali la serie di canoni di Teofane Grapto per i de-funti, prescritti per il sabato (cfr. infra, n. 56).
36 Il codice, pergamenaceo, di ff. 136, misura mm 202 × 152. Sul manoscritto cfr. Rocchi,Codices Cryptenses, pp. 371-372; Maria Giuseppina Malatesta zilembo, Gli amanuensi di Grotta-ferrata [IV], BollGrott, n.s. 29, 1975, pp. 3-54: 28, 33 (con datazione al sec. XI-XII); Lucà, Suorigine e datazione, pp. 146 e n. 1, 188, 199 e tav. 17.
37 Il codice, pergamenaceo, di ff. 133, misura mm 200 × 155. Sul manoscritto cfr. Rocchi,Codices Cryptenses, p. 373; Malatesta zilembo, Gli amanuensi di Grottaferrata [IV], pp. 24, 26, 31;Lucà, Su origine e datazione, pp. 188, 199 e tav. 18.
38 La Piccola acolutia comprende la seguente serie di canoni: catanittico, per gli angeli, pers. Giovanni Prodromo, per gli apostoli, per s. Nicola, anapausimos (per i defunti). Nel codice,essa termina mutila con il canone del lunedì del II modo autentico.
39 Allo stato attuale il manoscritto inizia con il secondo tropario dell’ode I del canone stau-rosimos per il mercoledì del I modo autentico, e termina con il secondo tropario dell’ode Vdel canone per gli apostoli per il giovedì del IV modo plagale.
40 Il codice, pergamenaceo, di ff. 233, misura mm 150 × 115; cfr. Gardthausen, Cataloguscodicum, p. 171; kamil, Catalogue of all manuscripts, p. 103 nr. 1079.
41 La sequenza è: agli angeli, catanittico, staurosimos, agli apostoli, staurosimos, koinòs (ovveroCommune-Kanon, cioè un canone che contiene tropari di vario genere: ai martiri, ai gerarchi, aisanti, ai defunti, alla Theotokos), cfr. husmann, Hymnus und Troparion, pp. 40, 42. Interessantela rubrica iniziale che recita KanÒnej sÝn qeù toà paraklhtikoà, cfr. ibid., p. 40.
gr. 77742, “Tropologio” dell’XI secolo contenente anch’esso solo canoni, unoper ciascun giorno, ad eccezione del mercoledì e del venerdì, che hanno duecanoni43. Più nutrito è il contenuto della Paracletica feriale del Sin. gr. 78344
(XI secolo), nel quale troviamo due canoni per ciascun giorno45. Non dispo-nendo al momento di descrizioni dettagliate del contenuto dei tre manoscrittisinaitici, è impossibile, però, precisare di fronte a quale delle diverse facies dellaParacletica feriale ci troviamo.
Del resto, anche il Nuovo Ottoeco di Giuseppe l’Innografo, o almeno lacircolazione di canoni appartenenti a questa raccolta, è ben attestato in areaorientale nello stesso periodo: significativo è il caso del Sin. gr. 781+782 (XIsecolo)46, per il quale non disponiamo ancora di una descrizione analitica, madel quale sappiamo che mostra già la struttura, rifusa in un ciclo unico, dellamoderna Paracletica47. Il manoscritto presenta come ultimo inno del IV modoplagale il canone di Giuseppe recante l’acrostico TÁj ’Okta»cou tÁj nšaj
qe‹on tšloj: pÒnoi d� ’Iws»f («Del Nuovo Ottoeco <dono> di Dio è la fine,le fatiche sono di Giuseppe»)48, nel quale l’Innografo sembra rivendicare or-gogliosamente la paternità di questa collezione di suoi inni, “nuova”, eviden-temente, rispetto a una raccolta innografica più antica alla quale intendevaaffiancarsi, forse l’Ottoeco domenicale, o forse una qualche insoddisfacenteforma di Piccola acolutia feriale, che con il suo Nuovo Ottoeco Giuseppe in-tendeva abolire e sostituire.
* * *
86
42 Il codice, pergamenaceo, di ff. 160, misura mm 222 × 190; cfr. Gardthausen, Cataloguscodicum, p. 167; kamil, Catalogue of all manuscripts, p. 103 nr. 1063.
43 La sequenza prevede il lunedì un canone per gli angeli, il martedì catanittico, il mercoledìe il venerdì staurosimos e per la Theotokos, il giovedì per gli apostoli, il sabato per i defunti, cfr.husmann, Hymnus und Troparion, pp. 29, 34, 41.
44 Il codice, pergamenaceo, di ff. 224, misura mm 260 × 195; cfr. Gardthausen, Cataloguscodicum, p. 168; kamil, Catalogue of all manuscripts, p. 103 nr. 1069.
45 Si tratta di canoni paracletici ordinati secondo gli otto modi, la cui esatta destinazionenon è specificata nella bibliografia disponibile, ad eccezione del canone koinòs per il sabato (siveda supra, n. 41), cfr. husmann, Hymnus und Troparion, pp. 36, 42. Per altre indicazioni cfr.ora Getov - yovcheva, The Unedited Oktoechos Canons, p. 140 n. 5.
46 I due codici, pergamenacei, rispettivamente di ff. 242 e 253, misurano mm 260 ×197/195; cfr. Gardthausen, Catalogus codicum, p. 168; kamil, Catalogue of all manuscripts, p. 103nrr. 1067 e 1068.
47 Come si evince da husmann, Hymnus und Troparion, pp. 36, 42.48 Non sappiamo dire, per ora, se il manoscritto sinaitico conservi i canoni del Nuovo
Ottoeco di Giuseppe come blocco unitario oppure suddivisi fra i diversi giorni e alternati adaltri canoni (cfr. infra, pp. 87, 89, quanto osservato circa il Messan. gr. 109 e il Crypt. D. g. VI).
La presenza del Nuovo Ottoeco di Giuseppe, peraltro, è stata da noi indi-viduata, oltre che nei tre codici criptensi sopra menzionati, anche in altri ma-noscritti italogreci, come il Messan. gr. 121, i cui ff. 211r-217v, aggiunti alla finedel codice e databili alla prima metà del XII secolo49, conservano la fine dellaserie dei canoni del IV modo plagale50 (tav. 5); o come il Messan. gr. 10951 (XIIsecolo, seconda metà), dove il Nuovo Ottoeco, destinato all’ufficiatura mat-tutina dei giorni feriali, è integrato con una serie di canoni paracletici alla Theo-tokos, anonimi o attribuibili a vari autori, da eseguirsi ai vespri, dal sabato algiovedì52 (tav. 6).
Una struttura più articolata si riscontra nel Crypt. D. g. I, una Paracletica diorigine molto probabilmente criptense, databile alla seconda metà dell’XI se-colo, realizzata, quasi interamente, da Nicola per la committenza di Lazzaro53
(tav. 7). Il codice si apre, mutilo della parte iniziale, con i canoni dell’Ottoecodomenicale, quattro per ciascun modo54, con la presenza degli ¢nabaqmo… dopo
87
49 Tali fogli, pergamenacei, misurano mm 221 × 164 ca. Sul manoscritto cfr. A. Mancini, CodicesGraeci Monasterii Messanensis S. Salvatoris, Atti della R. Accademia Peloritana 22/2, 1907, pp. 1-263:188; per la bibliografia, Maria Teresa Rodriquez (a cura di), Bibliografia dei manoscritti greci del fondo delSS. Salvatore di Messina (Testi e studi bizantino-neoellenici 12), Roma 2002, pp. 106, 242-243.
50 Precisamente, del Nuovo Ottoeco di Giuseppe si sono conservati la parte finale del ca-none del giovedì, a partire dal secondo tropario dell’ode VIII, il canone del venerdì e quellodel sabato, recante l’inconfondibile acrostico. Secondo Augusto Mancini, «huius octoechifragmenta exstant passim in palimpsestis», cfr. Mancini, Codices Graeci, p. 188; tale affermazionerichiederà, certamente, un’accurata verifica. Sul f. 217v, a conclusione della serie dei canoni, èdisegnata una porta, decorata con motivi fitomorfi, che racchiude un epigramma in dodeca-sillabi con acrostico IWSHF, trascritto dallo stesso Mancini, ibid.
51 Il codice, pergamenaceo, di ff. 158, misura mm 260 × 205. Sul manoscritto cfr. Mancini, Co-dices Graeci, pp. 172-173; per la bibliografia cfr. Rodriquez, Bibliografia dei manoscritti, pp. 93-94, 230.
52 Nella parte feriale, il primo canone di ciascun giorno è quello attinto al Nuovo Ottoecodi Giuseppe, il secondo è quello dedicato alla Theotokos. Il manoscritto termina mutilo conun’integrazione di canoni paracletici per la Theotokos per i vespri del venerdì. Stando al catalogo(Mancini, Codices Graeci, pp. 172-173), l’ufficiatura trascritta nel codice sarebbe da attribuire aSofronio patriarca di Gerusalemme e a Giuseppe l’Innografo, sulla base della lettura dei loronomi all’interno di una cornice disegnata sul f. 1r, che racchiude alcuni versi oggi difficilmenteleggibili; al centro dei lati verticali della cornice due tondi raffigurano i due innografi.
53 Il codice, pergamenaceo, di ff. 176, misura mm 265 × 197. Sul manoscritto cfr. Rocchi,Codices Cryptenses, p. 367; Maria Giuseppina Malatesta zilembo, Gli amanuensi di Grottaferrata[I], BollGrott, n.s. 19, 1965, pp. 39-56: 48, 50; Lucà, Teodoro sacerdote, p. 152 e tav. 13; Id., Suorigine e datazione, p. 149 n. 7. Su questo codice si è basato il censimento delle collezioni di ca-noni della Paracletica curato da Eutychios Tomadakes, cfr. E. Tomadakes, KanÒnej tÁj Pa-raklhtikÁj, EEBS 39-40, 1972-1973, pp. 253-274.
54 Questo gruppo di canoni comprende, naturalmente, anche le due serie di canoni anastasimie stauroanastasimi attribuite, rispettivamente, a Giovanni Damasceno e Cosma di Maiuma.
le seste odi; i canoni sono intrecciati more liturgico, e ordinati secondo gli ottomodi; quindi troviamo il Nuovo Ottoeco di Giuseppe, seguito da una serie dicanoni di£foroi55; poi un’Acolutia deutšra, ovvero una Paracletica feriale conun canone per ciascun giorno56, seguita da un’altra serie di canoni di£foroi57;un’ultima sezione è costituita da un Theotokarion che mostra una stretta affinitàcon il contenuto del manoscritto Oxford, Bodleian Library, Lyell 94 (an. 1312)58.
Tra i secoli XI e XII si colloca il Crypt. D. g. IV59 (tav. 8), Paracletica di ori-gine calabrese, contenente già un abbozzo di Paracletica “moderna”, ovveroun unico ciclo che riunisce il materiale innografico secondo un ordinamentofunzionale alle esigenze della pratica liturgica. Troviamo, infatti, gli sticheriprosomi in onore della SS. Trinità per i vespri del sabato, seguiti da due canoniper le domeniche e un canone per ciascun giorno della settimana ad eccezionedel mercoledì, che ne ha due60.
88
55 Si succedono uno di seguito all’altro, senza rispettare l’ordine tonale, i seguenti canonidi vario genere: paracletico per s. Nicola, paracletico per s. Basilio, despotikòs per i malati,euktikòs per N.S. Gesù Cristo, paracletico per la Theotokos, s. Michele, i ss. Acindino <Pegasioe Anempodisto> e s. Nicola, paracletico per s. Michele, i ss. Quaranta Martiri <di Sebaste>,s. Irenarco e s. Nicola, che si interrompe, mutilo, con il primo tropario.
56 La sequenza, ordinata e completa per tutti gli otto modi, è: per gli angeli, catanittico,per s. Giovanni Prodromo, per gli apostoli, per la Theotokos, per i defunti. Questo ciclo dicanoni è preceduto dalla rubrica ’Akolouq…a b/ po…hma ’Iws¾f par�x tîn kanÒnwn tînsabb£twn; e, in effetti, si tratta di canoni ascrivibili a Giuseppe l’Innografo (si confrontino lestesse attribuzioni nelle Piccole acolutie tramandate dai codici Crypt. D. g. XI e, soprattutto,Crypt. D. g. XII), eccetto quelli del sabato, opera di Teofane Grapto; da rettificare, dunque, latrascrizione dell’ultima parola della rubrica proposta da Tomadakes (Tomadakes, KanÒnejtÁj ParaklhtikÁj, p. 263), che vi leggeva giovedì invece che sabato.
57 Si susseguono, senza rispettare l’ordine tonale, i seguenti canoni di vario genere: para-cletico per N.S. Gesù Cristo e la Theotokos, per i defunti, paracletico e�j toÝj Ag…ouj P£ntaj,per s. Barbara, per la Theotokos.
58 La trascrizione degli incipit degli inni del codice di Oxford è reperibile in Winkley, ABod leian Theotokarion, pp. 270-271 (la somiglianza tra il contenuto dei due Theotokaria non erasfuggita allo studioso, cfr. ibid., p. 273 n. 19); ulteriori notizie e specimina del manoscritto in Irm -gard hutter, Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften, III: Oxford, Bodleian Library, 3, Stutt-gart 1982, pp. 214-215 nr. 141 e Abb. 516-519; cfr. anche A. Turyn, Dated Greek Manuscripts ofthe Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Great Britain (DOS 17), Washington, D.C.1980, pp. 73-74 e pl. 51, 110c. I canoni alla Theotokos del manoscritto criptense, di vario generema ordinati secondo gli otto modi, sono da riferirsi ai vespri dell’intera settimana, dalla dome-nica al sabato, e sono attribuibili a vari autori, e in parte anonimi. Questo Theotokarion terminamutilo con il quinto tropario dell’ode III del canone del venerdì del IV modo plagale. A pro-posito della variabilità del repertorio del Theotokarion cfr. supra, n. 32.
59 Il codice, pergamenaceo, di ff. 232, misura mm 183 × 135. Sul manoscritto cfr. Rocchi,Codices Cryptenses, pp. 368-369; Malatesta zilembo, Gli amanuensi di Grottaferrata [IV], pp. 27,32-33; Lucà, Su origine e datazione, pp. 189, 199.
60 I canoni previsti per le domeniche sono quelli anastasimi di Giovanni Damasceno e
Una struttura già più regolare di Paracletica rifusa in unum è attestata dalCrypt. D. g. VI61 (tav. 9), manoscritto di origine criptense, databile agli inizi delXII secolo. Esso tramanda costantemente due canoni per ogni giorno dellasettimana, a partire dalla domenica fino al sabato successivo62. È da notare chei primi canoni della parte feriale sono attinti al Nuovo Ottoeco di Giuseppe.
Per finire, il Messan. gr. 5163 (tav. 10), un manoscritto di origine cipro-pale-stinese, come si evince dalla scrittura, databile alla fine del XII secolo, mostraormai perfezionata la struttura della moderna Paracletica, con l’ufficiaturacompleta e ordinata secondo gli otto modi a partire dai vespri del sabato, concui effettivamente comincia la giornata liturgica domenicale, fino all’orthrosdel sabato successivo64. Per quanto riguarda i canoni, per ciascun giorno nesono trascritti due65; nei giorni feriali, il primo dei due canoni è per lo più(quattro volte su sei) attinto al Nuovo Ottoeco di Giuseppe.
89
quelli per la Trinità, due dei quali attribuiti a Metrofane di Smirne. Per i giorni feriali sono prescrittii seguenti canoni: lunedì per gli angeli, martedì per s. Giovanni Prodromo, mercoledì staurosimose per la Theotokos, giovedì per gli apostoli, venerdì staurosimos, sabato anapausimos (per i defunti).Il manoscritto, acefalo, inizia con l’ode V del canone per gli angeli del lunedì del I modo autenticoe termina mutilo con l’irmo dell’ode III del canone per i defunti, prescritto per il sabato del IVmodo plagale; si è individuata, inoltre, un’ampia lacuna tra gli attuali ff. 54v e 55r.
61 Il codice, pergamenaceo, di ff. 183, misura mm 237 × 184. Sul manoscritto cfr. Rocchi,Codices Cryptenses, p. 369; Maria Giuseppina Malatesta zilembo, Gli amanuensi di Grottaferrata[II], BollGrott, n.s. 19, 1965, pp. 141-159: 147; Ead., Gli amanuensi di Grottaferrata [IV], pp. 27,33; Lucà, Su origine e datazione, pp. 149, 159 n. 42, 201 n. 231, 204 e n. 252.
62 La successione dei canoni è la seguente: per la domenica canoni anastasimo e stauroa-nastasimo, per il lunedì catanittico e per gli angeli, per il martedì catanittico e per s. GiovanniProdromo, per il mercoledì staurosimos e catanittico, per il giovedì due diversi canoni dedicatiagli apostoli, per il venerdì staurosimos e per la Theotokos, per il sabato un canone per i martiri,i gerarchi, i santi, i profeti e i defunti, e un altro anapausimos (per i defunti). Il manoscritto, ace-falo e con lacune testuali dovute alla caduta di qualche foglio, inizia con l’ode III del canonestaurosimos del venerdì del I modo autentico e termina mutilo con l’ode VI del primo canoneper gli apostoli del giovedì del IV modo plagale.
63 Il codice, pergamenaceo, di ff. 72, misura mm 312 × 220/222. Sul manoscritto cfr. Man-cini, Codices Graeci, pp. 99-101; la bibliografia relativa al manoscritto è reperibile in Rodriquez,Bibliografia dei manoscritti, pp. 54-55, 190-191. Una descrizione analitica del suo contenuto, conaggiornamento bibliografico, è pubblicata in Donatella Bucca, Catalogo dei manoscritti musicali grecidel SS. Salvatore di Messina (Biblioteca Regionale Universitaria di Messina), Roma 2011, scheda nr. 11.
64 Concludono il libro liturgico gli undici exapostilaria di Costantino VII Porfirogenito, se-guiti dagli undici heothinà anastasima di Leone VI il Sapiente e dalle corrispondenti letture evan-geliche. Tali inni, prescritti per la parte conclusiva dell’orthros domenicale, formano una sortadi appendice alla fine delle Paracletiche.
65 La sequenza dei canoni comprende: per la domenica canoni anastasimo e per la Theotokos,per il lunedì catanittico e per gli angeli, per il martedì catanittico e per s. Giovanni Prodromo,per il mercoledì staurosimos e per la Theotokos, per il giovedì per gli apostoli e per s. Nicola, peril venerdì staurosimos e per la Theotokos, per il sabato canone per i profeti, i martiri e i defunti.
* * *
Tentiamo, a questo punto, di tirare le fila del discorso, proponendo unaprima sintesi provvisoria. La nostra analisi ha posto in evidenza alcune linee diuna tradizione manoscritta dell’Ottoeco-Paracletica estremamente varia che, senella struttura va stabilizzandosi col tempo, nella scelta dei canoni si manterràpoco uniforme anche in epoca tarda66. Lo stesso testo a stampa più correntenelle odierne edizioni è il risultato di una scelta da un’immensa produzionepoetica, costituita dalle diverse raccolte elaborate nel corso dei secoli, che sa-ranno utilizzate come preziosi contenitori cui attingere nella selezione dellecomposizioni innografiche.
Sulla base dell’esame delle testimonianze raccolte, sembra che il NuovoOttoeco di Giuseppe sia l’unico ciclo paracletico feriale ad aver conosciuto,in età medievale, anche una tradizione manoscritta stabile e separata, nel ri-spetto della sua unitarietà d’origine e della sua uniformità stilistica e strutturale.Esso, infatti, rappresenta un tentativo da parte di Giuseppe di riorganizzarel’Ottoeco feriale per disporre di un’ufficiatura settimanale completa e uniformeper stile e struttura, che sostituisse gli informi e non standardizzati tentativi dicostruzione di Paracletica feriale che erano già correnti al tempo di Giuseppe,verso la metà del IX secolo. Ma il Nuovo Ottoeco dell’Innografo non riuscìa imporsi definitivamente, e continuò a circolare, tra la seconda metà del Xsecolo e almeno gli inizi del XII – per quel che abbiamo visto –, anche e so-prattutto come raccolta a sé stante, del tutto parallela alle altre serie di canoniferiali esistenti. Presto, d’altra parte, anch’esso fu usato come ciclo di canonicui attingere per la formazione della Paracletica “evoluta”, accanto alle altrefacies circolanti di Paracletica feriale67.
Dalla descrizione del contenuto del manoscritto più antico qui esaminato,il Sin. gr. 824, è emersa una non ben definita struttura interna, forse di transi-zione, che ha sollevato problemi di carattere terminologico che solo un esamesistematico dell’intera tradizione manoscritta potrà risolvere, favorendo, sispera, una più precisa categorizzazione. Ciononostante, questo nostro primo
90
66 Come è noto, il contenuto dei manoscritti non si era ancora sostanzialmente uniformatoe standardizzato al tempo dell’apparire della stampa, e così anche le edizioni greche dei secoliXVI-XVIII mostrano divergenze sensibili rispetto ai libri utilizzati oggi, cfr. ad esempio han-nick, Le texte de l’Oktoéchos, p. 50.
67 In particolare, limitatamente ai manoscritti da noi esaminati, è emerso che per i canoniper gli angeli del lunedì e, soprattutto, per i canoni per i defunti del sabato si è sovente fattoricorso agli inni di Teofane Grapto; in minor misura anche per i canoni per gli apostoli delgiovedì si sono preferite spesso composizioni di innografi diversi da Giuseppe l’Innografo.
sondaggio, unitamente alle notizie ricavabili da alcuni studi pregressi, permettegià di intravedere una distinzione tra diverse classi di manoscritti contenentil’Ottoeco-Paracletica, che si possono ricondurre, al di là delle differenze di re-pertorio, a due diverse strutture di base68: da un lato, manoscritti in cui i diversirepertori (Ottoeco domenicale = a; Paracletica feriale = b; Nuovo Ottoeco diGiuseppe = c) si susseguono uno dopo l’altro come entità separate, come si èriscontrato nei Crypt. D. g. XII (an. 969/970: b+c), D. g. XI (sec. X, secondametà: c+b), D. g. I (sec. XI, seconda metà: a+c+b); dall’altro, manoscritti in cuii repertori sono rifusi insieme in un unico ciclo che rispetta l’ordine liturgicoe la sequenza modale, sia pure con selezioni variabili dei testi, come si vedenel Sin. gr. 824 (sec. IX-X: abc, ma di tipo arcaico, con separazione fra reper-torio degli sticheri-càtismi e repertorio dei canoni), nei Crypt. D. g. IV (sec. XI-XII: ab) e D. g. VI (sec. XII, seconda metà: abc), e nel più evoluto Messan. gr.51 (sec. XII, fine: abc, completo di innografia minore, comprendente ancheinni per i vespri e per la liturgia), manoscritto che è ormai strutturalmente vi-cino a una moderna Paracletica a stampa.
Il quadro provvisorio desunto da questa prima analisi dei manoscritti re-periti pone, ovviamente, interrogativi sul numero e sulla qualità dei segmentimancanti – o sui probabili sviluppi peculiari a carattere locale – all’interno diquesto intricato percorso evolutivo, che una volta delineato, per quanto pos-sibile, nella sua completezza potrebbe finalmente restituire una visione d’in-sieme in cui ogni tassello trova la sua giusta collocazione.
L’esame della tradizione, peraltro, sembrerebbe confermare che le origini deimateriali innografici e delle tradizioni di canto confluiti nell’Ottoeco domenicalesiano da ricercare in area palestinese, dove nell’VIII secolo operavano i grandiinnografi Giovanni Damasceno e Cosma di Maiuma, cui sono attribuiti i canonianastasimi e stauroanastasimi che costituiscono il nucleo centrale dell’Ottoecodomenicale. Ma già nella prima metà del IX secolo il centro della produzioneinnografica si spostava da Gerusalemme e dai centri monastici limitrofi versoCostantinopoli. Qui si trasferì, proveniente dalla lavra palestinese di S. Saba,Teofane Grapto, i cui canoni per i defunti cantati il sabato costituiscono un ele-
91
68 Si deve avvertire che la schematizzazione proposta qui di seguito ha solo valore prov-visorio e orientativo. I “tipi” che vi si pongono in evidenza non vanno intesi con riferimentoal contenuto testuale del libro innografico, ma solo in relazione alla sua struttura organizzativadi fondo. La prosecuzione delle ricerche sull’Ottoeco-Paracletica permetterà verosimilmente,in prosieguo di tempo, l’elaborazione di categorie descrittive più raffinate, che tengano contoanche, nella definizione del “tipo”, delle diverse facies testuali sotto le quali si presenta ciascunodegli elementi costitutivi (ad esempio, le diverse tipologie di Piccola acolutia, o le differentiforme di Ottoeco domenicale).
mento fisso della Paracletica feriale. Ed è a Costantinopoli che si procedé al-l’arricchimento dell’Ottoeco domenicale e probabilmente all’elaborazione/rie-laborazione dei diversi cicli integrativi della Paracletica feriale: processi, questi,che dal cuore dell’Impero vediamo riverberarsi subito nelle province (o ex-pro-vince) bizantine, in ambito tanto siro-palestinese quanto italogreco. Decisivifurono gli anni di rinascita che seguirono la fine della controversia iconoclasta,quando intensa, nella capitale, fu l’attività sia di composizione di nuovi inni siadi sistemazione del materiale esistente: attività che dové catalizzare e intensifi-care il graduale – e probabilmente policentrico – processo evolutivo che staalla base della formazione della struttura della moderna Paracletica. Per quantoriguarda l’Ottoeco-Paracletica, fra tutti gli innografi implicati spicca, per la suaincessante attività, la figura di Giuseppe l’Innografo. A lui spetta il merito diaver contribuito in maniera determinante all’innovazione, sia fornendo nume-rosi canoni isolati che finirono per arricchire la Paracletica feriale circolante alsuo tempo, sia proponendo – forse in un secondo momento, e certamente consuccesso solo parziale – il suo Nuovo Ottoeco quale completamento unitarioe organico dell’ufficio feriale, a coprire gli intervalli tra le domeniche.
92
94
Tav. 2 - Crypt. D. g. XII, f. 61r. [85%](su concess. del Minist. per i Beni e le Attiv. Cult. – È vietata l’ulteriore riproduzione)
95
Tav. 3 - Crypt. D. g. XI, f. 121r. [75%](su concess. del Minist. per i Beni e le Attiv. Cult. – È vietata l’ulteriore riproduzione)
96
Tav. 4 - Crypt. D. g. XIV, f. 126r. [75%](su concess. del Minist. per i Beni e le Attiv. Cult. – È vietata l’ulteriore riproduzione)
97
Tav. 5 - Messan. gr. 121, f. 211v. [70%](su concess. della Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Cult.
e dell’Identità Siciliana – È vietata l’ulteriore riproduzione)
98
Tav. 6 - Messan. gr. 109, f. 150v. [60%](su concess. della Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Cult.
e dell’Identità Siciliana – È vietata l’ulteriore riproduzione)
99
Tav. 7 - Crypt. D. g. I, f. 89r. [60%](su concess. del Minist. per i Beni e le Attiv. Cult. – È vietata l’ulteriore riproduzione)
100
Tav. 8 - Crypt. D. g. IV, f. 25v. [90%](su concess. del Minist. per i Beni e le Attiv. Cult. – È vietata l’ulteriore riproduzione)
101
Tav. 9 - Crypt. D. g. VI, f. 63r. [65%](su concess. del Minist. per i Beni e le Attiv. Cult. – È vietata l’ulteriore riproduzione)
![Page 1: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: [con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022218/63209238c5de3ed8a70dc99c/html5/thumbnails/30.jpg)