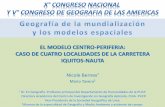STORIA DI UNA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AD ALGHERO LO QUARTER: DA PERIFERIA A CENTRO CULTURALE
Terra e potere alla periferia dell'impero: I Bologna tra Capaci e Marineo (XVI secolo)
Transcript of Terra e potere alla periferia dell'impero: I Bologna tra Capaci e Marineo (XVI secolo)
TERRA E POTERE NELLA PERIFERIA DELL’IMPERO: I BOLOGNA TRA CAPACI E MARINEO (XVI SECOLO)
Lavinia PinzarroneUniversità degli studi di Palermo
7UD�OD�ÀQH�GHO�4XDWWURFHQWR�H�L�SULPL�GHFHQQL�GHO�6HLFHQWR�WUD�L�SURWDJRQLVWL�GHOOD�VFHQD�SROLWLFD��HFRQRPLFD�H�VRFLDOH�GHOOD�FLWWj�GL�3DOHUPR�ÀJXUDQR�L�PHPEUL�di una famiglia dalle lontane origini bolognesi, i Beccadelli-Bologna1. Si trattava di un lignaggio potente e numeroso – costituito da abili e spregiudicati uomini politici – che riuscì a sfruttare a proprio vantaggio le opportunità di promozio-ne sociale offerte dalla capitale del Regno di Sicilia. Professionisti del diritto, i Bologna appartenevano a quel “ceto politico” che si affermò nelle città all’inizio dell’età moderna attraverso l’espansione dell’apparato statale e delle ammini-strazioni municipali e che trovò nel servizio al sovrano e nell’inclusione nella PRQDUFKLD� VSDJQROD�XQD�YLD�GL�SURPR]LRQH� VRFLDOH�ÀQDOL]]DWD� DOO·LQJUHVVR�QHL�ranghi della feudalità parlamentare siciliana. Palermo, in particolare, era uno spazio politico privilegiato dove avveniva la mediazione tra il potere centrale (la corte), i suoi rappresentanti locali (i viceré) e le prerogative e i privilegi delle FRPXQLWj��JUD]LH�DO�FRQWUROOR�GHL�ÁXVVL�ÀQDQ]LDUL�GHO�5HJQR�H�DO�JLUR�G·DIIDUL�LQ-torno al sistema delle gabelle e dei rifornimenti cittadini, vi erano opportunità di promozione sociale e risorse per quanti disponevano di capitali e reti di relazioni UDPLÀFDWH�QHO�WHVVXWR�SROLWLFR�HG�HFRQRPLFR�GHO�5HJQR�
Carriere pubbliche, esercizio del potere e disponibilità di capitali furono gli elementi che, opportunamente utilizzati, permisero alla famiglia Bologna di entrare a far parte della feudalità siciliana già alla metà del Cinquecento (1516-1565). Anche per i Bologna, infatti, come per la maggior parte degli uomini “nuo-vi” affermatisi nel corso del Cinquecento, l’aspirazione principale era quella di acquisire uno status feudale, che soltanto l’esercizio della giurisdizione su vassal-
�� �75$66(//,��������*,8))5,'$��������*,85$72��������SS����������\���������
108 Lavinia Pinzarrone
li sanciva indubitabilmente. Infatti, l’acquisizione di un titolo feudale e le attri-EX]LRQL�JLXULVGL]LRQDOL�DG�HVVR�OHJDWH�FRQWULEXLYDQR�D�GHÀQLUH�FRPH�QRELOLDUH�OD�complessa identità sociale di questi soggetti – che dovevano le proprie fortune DOOH�FDUULHUH�QHOO·DPPLQLVWUD]LRQH�H�DOOD�JHVWLRQH�GHL�ÁXVVL�ÀQDQ]LDUL�²�H�DSULYDQR�loro le porte del braccio militare del Parlamento siciliano.
Il prestigio e le basi economiche della famiglia si fondarono sull’esercizio del potere per conto e con il favore della monarchia. Il servizio e la fedeltà mostrati alla corona dai membri della famiglia consentirono a Francesco I Bologna – capo-stipite del ramo della famiglia di cui si occupa il presente lavoro – di tessere una UDPLÀFDWD� UHWH�GL� UHOD]LRQL�SROLWLFKH� HG�HFRQRPLFKH�²� FKH� FRLQYROJHYD�XRPLQL�G·DIIDUL�VLFLOLDQL�H�VWUDQLHUL��EDQFKLHUL��IHXGDWDUL��SXEEOLFL�XIÀFLDOL�²�ÀQDOL]]DWD�GD�XQ�ODWR�DOO·HVHUFL]LR�GL�XQ�UXROR�GL�SULPR�SLDQR�QHOOD�JHVWLRQH�GHOOD�ÀQDQ]D�SXE-blica del Regno e nel governo della città di Palermo e, dall’altro, all’acquisizione di possedimenti e titoli feudale.
/·LQÁXHQWH�UHWH�GL�UHOD]LRQL�VXOOH�TXDOL�)UDQFHVFR�%RORJQD�SRWHYD�FRQWDUH�QHO�Regno comprendeva anche i viceré: Francesco e il fratello Cola si schierarono a ÀDQFR�GHL�YLFHUp�8JR�0RQFDGD�H�(WWRUH�3LJQDWHOOL�GXUDQWH� L�GLIÀFLOL�DQQL�GHOOH�ULYROWH�GL�SULPR�&LQTXHFHQWR�LQ�6LFLOLD��������������VDOGDQGR�GHÀQLWLYDPHQWH�LO�destino del casato alla monarchia asburgica2. In quegli anni i Bologna seppero, infatti, destreggiarsi abilmente tra il governo di Palermo, l’articolata realtà socio-economica della capitale e la richiesta di fedeltà e servizio da parte della corona3. Tra il 1514 e il 1523, attraverso l’esercizio delle cariche più importanti della città – pretore, capitano di giustizia e giurati – essi governarono la capitale del Regno per sette anni consecutivi4��1HO������)UDQFHVFR�RWWHQQH�DQFKH�O·XIÀFLR�GL�WHVRULHUH�del Regno – incarico che, insieme con quello di maestro portulano, già ricopriva dal 1509 in sostituzione di Nicolò Vincenzo Leofante, tra i congiurati del ’23 – mentre alcuni anni dopo suo fratello Cola fu nominato secreto di Palermo (1528)5. In quegli anni, i giochi politici tra Bruxelles e la Castiglia per la successione di Carlo d’Asburgo rimbalzavano in Sicilia in rivendicazioni di antiche libertà e SULYLOHJL�ÀVFDOL�H�ORWWD�SHU�LO�SRWHUH��FRVu�GD�GHWHUPLQDUH�XQ�ULQQRYDPHQWR�GHO�FHWR�
�� � ,� %RORJQD� IXURQR� D� ÀDQFR� GHO� YLFHUp�0RQFDGD� QHO� ������ SDUWHFLSDURQR� DOO·XFFLVLRQH� GL�Squarcialupo nel 1517 e si mantennero fedeli alla corona durante la rivolta dei fratelli Imperatore – loro GLUHWWL�FRQFRUUHQWL�QHJOL�DIIDUL�²�QHO�������FIU��75$66(//,�������SS�����������%$9,(5$�$/%$1(6(��������SS�����������9,*,$12��������SS���������&$1&,/$��������SS��������
3 Sui rapporti tra il Regno di Sicilia e la monarchia spagnola al tempo degli Asburgo, si veda BENIGNO, 2011, pp. 373-392.
4 PINZARRONE, 2009, pp. 153-156.5 Francesco divenne pretore di Palermo ancora una volta nel 1540. Il suo nominativo,
insieme con quello di Giovanni Sollima, fu anche inserito dal viceré Gonzaga nella terna da inviare al sovrano per l’incarico di maestro razionale(AGS, Estado, legajo 1114, s.n, anno1540). La proposta GHO�YLFHUp�HUD��SHUz��YLQFRODWD�DOO·DQDOLVL�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�FRQWDELOH�GHOO·XIÀFLR�GHO�WHVRULHUH�GHO�Regno e non fu accolta poiché la giustizia contabile aveva riscontrato alcune irregolarità nei conti (ASPa, Tco, busta 147, sn., anno 1536). Per un quadro sulle carriere di Francesco e Cola Bologna cfr. GIUFFRIDA, 1999, pp. 440-482.
Terra e poTere nella periferia dell’impero 109
politico nel Regno: la “vecchia” oligarchia palermitana fu sostituita da uomini dalla comprovata fedeltà al nuovo sovrano – e ai suoi rappresentanti – interessati DOOD�JHVWLRQH�GHL�ÁXVVL�ÀQDQ]LDUL�SXEEOLFL��DWWUDYHUVR�LO�FRQWUROOR�GL�LQFDULFKL�VWUD-WHJLFL�FRPH�O·XIÀFLR�GHO�WHVRULHUH�H�TXHOOR�GHO�VHFUHWR�GL�3DOHUPR6.
Principale sponsor della carriera politica di Francesco Bologna fu il viceré Ettore Pignatelli (1517-1535): il sodalizio tra i due durò circa un ventennio e fu la “cabina GL�UHJLDµ�GL�QXPHURVH�RSHUD]LRQL�SROLWLFKH��ÀQDQ]LDULH�H� LPPRELOLDUL�FKH�YLGHUR�coinvolto Francesco nei primi decenni del XVI secolo7. Parte integrante del patrona-ge YLFHUHJLR�H�GHO�PHFFDQLVPR�ÀQDQ]LDULR�GHO�5HJQR��HJOL�HEEH�PRGR��FRQ�LO�IUDWHOOR�Cola, di gestire enormi quantitativi di denaro e di avere a disposizione somme consistenti da investire nell’acquisto di rendite, beni e possedimenti feudali. La maggior parte degli investimenti di Francesco fu rivolta all’acquisto della terra e a privilegi e titoli ad essa correlati. Infatti, nella Sicilia del Cinquecento per coloro che disponevano di capitali, la terra rappresentava non soltanto un oculato inve-VWLPHQWR�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�ÀQDQ]LDULR��PD�DQFKH�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�VRFLDOH��SRLFKp�consentiva l’accesso allo status feudale8. Il Cinquecento, in particolare, in Sicilia fu un secolo di accelerata mobilità sociale, durante il quale uomini provenienti dai ceti emergenti – come i Bologna – non ancora appartenenti al baronaggio siciliano, ma al quale sentivano già di poter essere assimilati per modelli e stili di vita, cercarono legittimazione attraverso il possesso della terra e l’esercizio della giurisdizione su vassalli9. Nel 1517, in seguito al ruolo svolto durante la rivolta del 1516 e nell’ucci-sione del ribelle Squarcialupo, Francesco ottenne il titolo di barone di Capaci con licentia populandi sui feudi Falconeri, Monterosso, Capaci, Baranzo (territori fuori Palermo) assegnatigli nel 1506, in occasione del matrimonio con Antonella Ma-strantonio dei baroni di Iaci, dalla madre, Virginia Amodei10. Nel XVI secolo le licentiae populandi erano privilegi concessi ai feudatari fedeli per meriti conseguiti nei confronti della corona e il loro rilascio rientrava tra le prerogative del patronage viceregio, in qualità di unico e diretto rappresentante del sovrano11. Inoltre, la pos-VLELOLWj�GL�SRSRODUH�LO�IHXGR�H�GL�HVHUFLWDUH�OD�JLXULVGL]LRQH�VX�YDVVDOOL�TXDOLÀFDYD�LO�possesso feudale, poiché assegnava al nuovo signore un seggio nel braccio militare del Parlamento siciliano. Il privilegio conferito a Francesco Bologna dal Pignatel-li rappresentava, pertanto, uno dei massimi riconoscimenti a sua disposizione da assegnare a sudditi fedeli e fu soltanto uno dei numerosi “affari” che segnarono il ventennale sodalizio tra i due.
6 Sull’articolata realtà politica del tempo rimando a VIGIANO, 2004, pp. 131-142.7 GIUFFRIDA, 1999, pp. 438-439, p. 463.8 MUSI, 2007, pp. 183-229.9 Sul tema della giurisdizione feudale nella Sicilia moderna si rimanda a CANCILA, 2009,
SS������H�DOOD�ELEOLRJUDÀD�LYL�FRQWHQXWD�10� � $63D�� &DPSRUHDOH�� EXVWD� ����� FF�� ����� ��� *LXJQR� ������$63D�� ,QYHVWLWXUH�� EXVWD� ������
fascicolo 650, anni 1506-1508.11 Cfr. BALISTRERI, 1979, pp. 8-10. Diversamente nel corso del XVII secolo, in un contesto
SROLWLFR� H� ÀQDQ]LDULR� SURIRQGDPHQWH� GLIIHUHQWH�� OD� FRQFHVVLRQH� GHOOH� OLFHQ]H� DELWDWLYH� GLYHQQH� XQ�titolo vendibile (AHN, Estado, libro 1015, cc. 116v-118v, 15 novembre 1611).
110 Lavinia Pinzarrone
Le rendite dei feudi ricevuti dalla madre nel 1506, la dote della moglie12 e i proventi degli importanti incarichi ricoperti costituivano il nocciolo stabile delle entrate di Francesco che nel corso degli anni investì nella baronia per miglioramen-ti e plurima benefacta �������ÀRULQL��FLUFD�������RQ]H���VRPPD�GHVWLQDWD�SHU�OR�SL��all’ampliamento delle strutture preesistenti e alla realizzazione di un belvedere, se-gno tangibile del profondo legame affettivo della famiglia verso la terra di Capaci13. 8Q�YHUR�H�SURSULR�FHQWUR�DELWDWR�QRQ�VRUVH��SHUz��QHOO·LPPHGLDWR��VROWDQWR�PROWR�più tardi, intorno agli anni ’70 del Cinquecento è possibile datare il primo nucleo insediativo a Capaci, censito per la prima volta nei riveli del 1583, quando risultano risiedere a Capaci 308 individui, per lo più impegnati nell’agricoltura14. Per tutta la prima metà del Cinquecento, l’attività ruotò, pertanto, esclusivamente intorno all’allevamento di bestiame, al cannameleto e alla torre di guardia del senato di Palermo che sorgeva nella porzione di spiaggia antistante e che faceva parte del sistema di difesa da mori e corsari dell’isola15. A partire dal 1578 la baronia fu inga-bellata per otto anni a Vincenzo Castiglione per 1240 onze l’anno16. La concessione della gabella fa supporre che proprio in quegli anni il centro abitato cominciasse a prendere vita e a costituirsi in unità amministrativa autonoma.
Le cause del ritardo nella fondazione di un centro abitato nella baronia di Ca-paci vanno, a mio avviso, ricercate nel complesso progetto di acquisizioni immo-biliari portato avanti dallo stesso Francesco Bologna nel corso degli anni ’20 e ’40 del Cinquecento, al termine del quale Capaci entrò a far parte di un complesso feudale molto esteso e articolato nel territorio del palermitano.
Infatti, l’intreccio tra gli affari immobiliari conclusi in quel periodo da France-sco e le scelte di schieramento politico appare ancora più evidente se analizziamo le operazioni portate a termine successivamente agli avvenimenti del 1522-23. Gli DUUHVWL�H�OH�FRQGDQQH�FKH�VHJXLURQR�DOOD�VYHQWDWD�́ FRQJLXUD�ÀORIUDQFHVHµ�GHL�IUDWHOOL�Imperatore riguardarono importanti personaggi della politica palermitana, tra cui Federico Abbatellis, conte di Cammarata, l’omonimo cugino barone di Cefalà, Ni-colò Vincenzo Leofante, Blasco Lanza e Giacomo Spatafora: tutti diretti concorrenti negli affari (zucchero) e sulla scena politica del clan Bologna17. L’accusa gravissima di fellonia portò alla condanna a morte di tutti coloro che furono ritenuti coinvol-ti nella rivolta e alla perdita dei beni feudali per i feudatari18. Ridisegnò, inoltre,
12� �/D�GRWH�DVVHJQDWD�GDO�EDURQH�GL�,DFL�DOOD�ÀJOLD�$QWRQHOOD�HUD�FRPSRVWD�GD�������ÀRULQL�������RQ]H��LQ�GHQDUR������RQ]H�LQ�DUQHVL��DOWUH�����RQ]H�LQ�©DXJPHQWXP�GRWHPª�H�RQ]H�����DVVHJQDWH�GD�Violante Mastrantonio, sorella della sposa (ASPa, Camporeale, busta 255, s.n., 18 settembre 1553).
13 Ibidem.14 ASPa, Trp, Riveli, busta 190, fasc. 1. LONGHITANO, 1988, p. 47.15 MAURICI, FRESINA, MILITELLO, 2008, pp. 170-174.16 Camporeale, busta 981, cc. 231-234, 19 aprile 157817� �%$9,(5$�$/%$1(6(��������SS����������75$66(//,��������SS�����������&$1&,/$��������
pp. 47-62.18 Alla base del potere feudale c’era la del sovrano che aveva il valore di un “dono”, il
tradimento del sovrano era uno dei motivi per cui i possedimenti feudali potevano ritornare alla corona (DELILLE, 1988, pp. 25-33).
Terra e poTere nella periferia dell’impero 111
O·RUJDQLJUDPPD�GHO�SRWHUH�QHO�5HJQR�GL�6LFLOLD�DSUHQGR�GHÀQLWLYDPHQWH�OD�VWUDGD�D�quei ceti emergenti che – con l’appoggio al viceré – manovravano da tempo in at-tesa dell’occasione propizia per sostituire la “vecchia” aristocrazia nelle stanze del comando. Infatti, lo studio delle rivolte di primo Cinquecento ha, ormai, mostrato come esse non furono fenomeni staccati tra loro, ma momenti diversi di uno stesso fenomeno caratterizzato dalla contrapposizione tra la vecchia nobiltà feudale e i QXRYL�FHWL�HPHUJHQWL�GHOO·DPPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH�GHOOH�FLWWj�GHPDQLDOL��LO�YLFHUp�VL�VHUYu�GHOOH�ULYROWH�SHU�HOLPLQDUH�²�DQFKH�ÀVLFDPHQWH�²�L�PDJJLRUL�HVSRQHQWL�GHOOD�nobiltà e della burocrazia ad essa legata ostili alle politiche asburgiche nell’isola e per comporre una nuova mappa del braccio militare del Parlamento, assegnando agli uomini a lui più fedeli i beni sequestrati19.
7UD�L�SRVVHGLPHQWL�FRQÀVFDWL�QHO������YL�HUD�DQFKH�OD�EDURQLD�GL�&HIDOj��DS-partenuta a Federico Abbatellis20. Su ordine del viceré Pignatelli, Cefalà fu in-camerata dalla Regia Corte e l’anno dopo se ne dispose la vendita21, ma anziché procedere a un’asta pubblica, la via scelta dalla politica fu quella di “pilotarne” la vendita: fatte salve tutte le procedure burocratiche, di fatto il Pignatelli e gli uf-ÀFLDOL�GHOOD�5HJLD�&RUWH�LQFDULFDWL�´VFHOVHURµ�O·DFTXLUHQWH�DOO·LQWHUQR�GHOOD�FHUFKLD�d’affari dello stesso viceré. La vendita di un feudo aveva delle ricadute impor-WDQWL�QRQ�VROWDQWR�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�ÀQDQ]LDULR��PD�VRSUDWWXWWR�SROLWLFR��SHUFKp�il nuovo barone di Cefalà avrebbe avuto accesso al Parlamento e partecipato, quindi, con diritto di voto al governo del Regno. Il Parlamento del 1522 – durante il quale il conte di Cammarata, Nicolò Vincenzo Leofante, Blasco Lanza e il conte di Adernò erano riusciti a bloccare l’approvazione del donativo alla Corona costi-tuendo un blocco con i rappresentanti delle città demaniali22 – aveva dimostrato quanto fosse delicata la sua funzione di mediazione tra gli interessi del Regno e quelli della monarchia asburgica per il mantenimento del consenso nell’isola23.
Dopo numerosi tentativi infruttuosi l’offerta accettata fu quella del neo tesorie-re del Regno Francesco Bologna, che si impegnò a versare alla Regia Corte 40.000 ÀRULQL��FLUFD�������RQ]H��SHU�O·DFTXLVWR�D�tucti i passati, cioè senza diritto di riscatto, della baronia di Cefalà. Oltre al possesso feudale il Bologna ottenne, con privilegio regio, l’esercizio del merum et mixtum imperium e la licentia populandi24. La cifra offerta dal Bologna era inferiore al valore della baronia – che garantiva una rendita annua di 1.500 ducati (650 onze circa) –, ma la storia familiare e i legami politici del nuovo
19� �%$9,(5$�$/%$1(6(�������S�������*,8))5,'$��������S������20� �$63D�� ,QYHVWLWXUH�� EXVWD� ������ IDVFLFROR� ������ DQQR� ������$63D�� ,QYHVWLWXUH�� EXVWD� ������
fascicolo 1927, anno 1556. MAURICI, 1985, pp. 47-52. 21 ASPa, Investiture, busta 1499, fascicolo 1291, anno 1526.22 CANCILA, 2007, p. 59.23 BENIGNO, 1995, pp.71-72. Il Parlamento siciliano nelle sessioni ordinarie – ogni tre anni –
FRQ�O·DSSURYD]LRQH�GHO�GRQDWLYR�HVSULPHYD�LO�FRQVHQVR�GHO�5HJQR�DO�SUHOLHYR�ÀVFDOH��3XU�QRQ�DYHQGR�poteri decisionali attraverso i capitoli di grazia votati e presentati al sovrano attuava una intensa proposta legislativa e svolgeva un importante ruolo di mediazione tra il potere centrale e la Sicilia (SCIUTI RUSSI, 1999, pp. 191-201).
24 ASPa, Investiture, busta 1499, fascicolo 1291, anno 1526.
112 Lavinia Pinzarrone
barone di Cefalà costituivano una garanzia di fedeltà alla politica asburgica in Sicilia e al viceré25. Per Francesco la concessione del merum et mixtum imperium�VLJQLÀFDYD�la possibilità di esercitare un dominio pieno su un territorio e i suoi abitanti e sanciva GHÀQLWLYDPHQWH�LO�VXR�LQJUHVVR�QHL�UDQJKL�GHOO·DULVWRFUD]LD�VLFLOLDQD��,QIDWWL��O·HVHUFL]LR�della giurisdizione – che non si limitava esclusivamente alle funzioni giudiziarie, ma FRPSUHQGHYD�DQFKH�TXHOOH�DPPLQLVWUDWLYH�H�ÀVFDOL�²�HUD�O·HOHPHQWR�FKH�QHOOD�6LFLOLD�moderna distingueva il feudatario da un semplice proprietario terriero, poiché gli consentiva un dominio signorile pieno su un territorio e i suoi abitanti.
Il bilancio dei primi casi di alienazione di beni del demanio vedono, così, trionfare in Spagna come in Sicilia i ceti dimostratisi più fedeli alla monarchia asburgica e ai suoi progetti di riforma delle istituzioni siciliane. Intanto nel 1548 )UDQFHVFR�%RORJQD�H�LO�ÀJOLR�*LOEHUWR�DYHYDQR�FRQFOXVR�XQ�DOWUR�LPSRUWDQWH�DF-TXLVWR�LPPRELOLDUH��OD�PDVVHULD�GL�0DULQHR��FRQÀQDQWH�FRQ�L�IHXGL�&RUULROL�H�5LVD-lagni nel territorio di Cefalà26. Appartenuta a Luigi e poi Salvatore Mastrantonio, barone di Iaci, suocero e cognato di Francesco, Marineo – soggetta iure proprietatis a 28 salme di frumento e 7 di orzo da corrispondere annualmente all’Ospedale Grande di Palermo – era stata venduta nel 1526 ai fratelli Vincenzo e Francesco Imbarbara27. Nel 1548 Gilberto Bologna presentò istanza presso la Regia Corte per recuperare iure prothomisionis sanguinis la masseria appartenuta al suo avo H�RUD�D�GLVSRVL]LRQH�GL�GRQQD�3ROLVVHQD�GH�,QJR��ÀJOLD�GL�9LQFHQ]R�,PEDUEDUD28, la quale era disponibile a concludere la transazione per 500 onze da depositare a suo nome nel banco di Marcantonio Pirrotta. Giudicata eccessiva la richiesta, Gilberto e Francesco proseguirono l’azione legale sino alla sentenza che assegnò loro il possesso della masseria e dispose di corrispondere all’erede degli Imbar-bara soltanto 70 onze come risarcimento per li milioramenti fatti a Marineo29. Il 5 novembre 1550 Francesco ottenne l’esercizio della giurisdizione feudale su Ma-rineo, la licentia pupulandi e la facoltà di unire il territorio della masseria a quello di Cefalà 30. Marineo si avviava così a diventare il cuore dei possedimenti feudali della famiglia nel corso del Cinquecento. La contiguità territoriale con Cefalà e la vocazione granaria avevano reso di particolare interesse per i Bologna l’ac-quisizione della masseria che si trovava nel distretto di produzione del grano destinato all’approvvigionamento della città di Palermo, diventata nel corso del Cinquecento la più importante piazza per il commercio del grano siciliano31. Non possono sfuggire ancora una volta le forti interconnessioni tra gli affari immobi-
25 La vendita di Cefalà fu oggetto di attenzione da parte dei visitatori che avevano aperto un’inchiesta sul tesoriere Francesco Bologna (ASPa, Tco, busta 147).
26 ASPa, Camporeale, busta 152, cc. 3-14, 26 novembre 1522, cc. 17-25, 4 gennaio 1526 e cc. 28-31, 18 dicembre 1549.
27 , ASPa, Camporeale, busta 152, cc. 17-25, 4 gennaio 1526. PINZARRONE 2010, cit., pp. 429-443.28 ASPa, Camporeale, busta 152, cc. 28-31, 18 dicembre 1549.29 Ibidem.30 ASPa, Protonotaro del Regno, vol. 298, cc. 99r-101v, 5 novembre 1550.31� �0$&5��������SS����������&$1&,/$�������SS����������
Terra e poTere nella periferia dell’impero 113
liari dei Bologna e il loro ruolo politico a Palermo: “l’affare” del grano fu, infatti, nella seconda metà del ‘500 il centro degli interessi e dei guadagni di questo ramo della famiglia. Nel 1560, dietro la rivolta scoppiata a Palermo contro le specula-zioni del prezzo del pane e le imposte, si giocò un’importante e decisiva partita non solo sulle politiche annonarie (e sul prezzo del grano), ma soprattutto sul controllo e il governo della città32. I ceti dirigenti cittadini, tra i quali si distinsero Gilberto e Pietro Bologna33, e la feudalità – abbandonata ormai qualsiasi velleità DXWRQRPLVWLFD�²� VL� VFKLHUDURQR�D�ÀDQFR�GHOOD�PRQDUFKLD�� VHJQR�©GL�XQ�PXWDWR�rapporto con la corona, nei confronti della quale il baronaggio siciliano aveva SHUGXWR�JUDQ�SDUWH�GHO�SURSULR�SRWHUH�FRQWUDWWXDOHª�34. Anche in quest’occasione i Bologna non si sottrassero a un ruolo da protagonisti, da un lato per non per-dere il forte legame di servizio e fedeltà che legava il casato alla monarchia degli $VEXUJR� H� FKH�QHO� �����SHU� ©VLQFHUDP�ÀGHP�HW� GHYRWLRQHPª�YDOVH� D�*LOEHUWR�il privilegio di trasformare Marineo in marchesato35�� GDOO·DOWUR�SHU�QRQ� UHVWDUH�tagliati fuori dall’affare annonario a Palermo e garantirsi così futuri guadagni.
$�SDUWLUH�GDO������)UDQFHVFR�%RORJQD�VWLSXOz�QXPHURVL�FRQWUDWWL�GL� ODYRUR�À-nalizzati al ripristino delle strutture della masseria di Marineo e alla sistemazione del territorio agricolo, allo scopo di renderlo il più possibile produttivo. L’accorta e diretta gestione del territorio da parte dei Bologna spinse, inoltre, l’accelerato-re verso la colonizzazione del territorio, così da garantire una presenza stabile di manodopera. Tra il 1552 e il 1553, una volta ottenuta la licentia populandi e l’auto-rizzazione ad unire i territori di Cefalà e Marineo, Francesco Bologna avviò anche OD�FRVWUX]LRQH�GHOOH�SULPH�FHQWR�FDVH�H�� LQ�VHJXLWR�DOOD�VXD�PRUWH��������� LO�ÀJOLR�Gilberto proseguì l’opera di ampliamento del nucleo insediativo portando a ter-mine la costruzione di altre duecento già nel 1559. Negli stessi anni, inoltre, furono DYYLDWL�H�SRUWDWL�D�FRPSLPHQWR�L�ODYRUL�GL�HGLÀFD]LRQH�GHO�FDVWHOOR�EDURQDOH�²�GLVSR-sto su più livelli – e di numerosi servizi necessari allo sviluppo del centro abitato: un lavatoio, un forno, una bottega da macellaio36. In breve tempo Marineo divenne un centro di discrete dimensioni: nel 1569 la popolazione censita risultava essere composta da 725 individui, mentre pochi decenni dopo, nel 1606, il numero degli abitanti era addirittura raddoppiato37. Intanto, nel 1576, Vincenzo Bologna succes-se al padre, Gilberto, come marchese di Marineo e barone di Capaci. Nell’ultimo trentennio del Cinquecento Vincenzo fu uno dei protagonisti principali della scena politica palermitana e non solo. Egli risedette a corte nel 1584, come ambasciatore
32 CANCILA, 1999.33 , AHN Estado, legajo 1252, s.n.. 34 CANCILA, 2007, p. 62.35 AGS, Sp, libro 936, cc. 83-85r, 8 aprile 1565. Per i servizi prestati da Francesco Bologna al padre,
Filippo II aveva già concesso a Gilberto due anni prima il titolo di conte di Marineo (AGS, Sp, libro 935, c. 69, 1563, cfr. anche ASPaConservatoria di Registro, Mercedes, busta 158, cc. 115-117, 22 luglio 1565).
36 SCARPULLA, 2002, pp. 165-196.37 Nel 1606 gli abitanti rivelati�HUDQR�JLj�������$63D��7US��5LYHOL��YRO�������DQQR�������$63D��
Trp, Riveli, vol. 400, anno 1606.
114 Lavinia Pinzarrone
della città, dove ne difese abilmente i privilegi messi in discussione dal visitatore Bravo38. A Madrid il marchese di Marineo, grazie anche al suo status di feudatario, ebbe modo di tessere una solida e duratura rete di relazioni che, successivamente, JOL�VDUHEEH�VWDWD�XWLOH�SHU�OD�QRPLQD�D�SUHWRUH�GL�3DOHUPR�QHO���������H�QHO�GLIÀFLOH�1598 e a stratigoto di Messina nel 1594 e poi nel 160439.
A Marineo il primo e più importante atto del nuovo marchese fu, il 20 gennaio 1576, la stipulazione dei Capitoli dell’università concessi dal Bologna ai suoi vas-salli. Il documento comprende un elenco di 64 capitoli regolanti la sfera ammi-nistrativa (nomina e compiti del capitano di giustizia, del baiulo, dei giurati, del secreto), sociale (matrimoni, funerali, testamenti, feste), ma soprattutto economi-ca della città (gabelle, usi civici, dogana, allevamento del bestiame, concessione delle terre ai vassalli) 40. In Sicilia già nel corso del XVI secolo si assistette a una PDJJLRUH�GHÀQL]LRQH�GHO�UDSSRUWR�WUD�VLJQRUH�H�FRPXQLWj��OH�XQLYHUVLWj�VLFLOLDQH�andavano acquisendo una identità, anche giuridica, sempre più autonoma e si rendeva, quindi, necessario regolamentare tutti gli aspetti concreti della vita de-gli abitanti41. Il carattere di norma condivisa che i Capitoli assunsero a partire dal XVI secolo è il segno della volontà di limitare qualunque forma di arbitrio ricon-GXFLELOH�D�HQWUDPEH�OH�SDUWL�²�VLJQRUH�H�YDVVDOOL�²��PD�VRSUDWWXWWR�GHOOD�©QHFHVVLWj�GL�XQ�FRQVHQVR�VHQ]D�LO�TXDOH�QHVVXQ�SRWHUH�D�OLYHOOL�GLYHUVL�SXz�IRQGDUVLª�42.
Le vicende dei Bologna di Marineo si conclusero, come quelle di molte al-WUH�IDPLJOLH�IHXGDOL�VLFLOLDQH��WUD�L�GHELWL��QHO������9LQFHQ]R�%RORJQD�IX�FRVWUHWWR�a vendere i feudi Casacca, Mendoli, Villafrati e a smembrare il marchesato di Marineo, che nel 1606 – gravato da troppe soggiogazioni – risultava sotto l’am-ministrazione della Deputazione degli Stati43��1HO������OD�VLWXD]LRQH�ÀQDQ]LDULD�dei marchesi di Marineo precipitò drammaticamente, poiché con la morte di Vin-cenzo vennero a mancare il suo prestigio e le sue garanzie politiche44. Francesco II Bologna, terzo marchese di Marineo, si dimostrò ben presto incapace di fornire ai creditori del padre le giuste garanzie. Pochi mesi dopo l’investitura a marche-se, i creditori pretesero la restituzione di tutte le somme dovute. Poiché France-sco non era in grado di soddisfare le richieste, la Regia Corte dispose la vendita GHO�PDUFKHVDWR�©DOOR�SL��RIIHUHQWH�FKH�IDUj�PHJOLR�FRQGLWLRQHª45. Il marchesato
38 AGS, Sp, legajo 983, 13 giugno 1584.39� ��$*6��6S��OHJDMR���������PDJJLR�������$*6��6S��OHJDMR���������JLXJQR��������$*6��6S��OLE��
�����F�������9DOODGROLG����DSULOH������40 ASPa, Notai defunti, notaio Vincenzo Gabriele, stanza I, vol. 17103, cc. 453r-461v, 25 luglio
1609. 41 FALSAPERLA, 1995, pp. 129-248. 42 CANCILA, 2007b, p. 93.43� �$*6�� 6S�� OLEUR� ����� FF�� ��������� ��� OXJOLR� ������$63D��'HSXWD]LRQH�GHJOL� 6WDWL�� EXVWD� ���
IDVFLFROR����DQQL������������VXOO·LVWLWX]LRQH�GHOOD�'HSLWD]LRQH�GHJOL�6WDWL�FIU��75,&2/,��������44 ASPa, Camporeale, busta 255, s.n., 6 ottobre 1614.45 ASPa, Camporeale, busta 984, cc. 245-250, 5 Marzo 1624. Le vendite di feudi a richiesta dei
FUHGLWRUL�FRPLQFLDURQR�D�YHULÀFDUVL�WUD�OD�ÀQH�GHO�&LQTXHFHQWR�H�O·LQL]LR�GHO�6HLFHQWR�FRQ�L�SURFHVVR�GL�commercializzazione dei feudi (DELILLE, 1983, p. 31).
Terra e poTere nella periferia dell’impero 115
fu acquistato da Vincenzo Pilo e Calvello, cognato di Francesco Bologna, che si impegnava a pagare tutti i creditori46. Vincenzo Pilo si presentava come l’unica JDUDQ]LD�SHU�L�%RORJQD�GL�PDQWHQHUH�LO�PDUFKHVDWR�©LQ�TXHOOD�PDJJLRU�KRQRUDQ]D�FKH�KDYHVVH�SRWXWRª�H�DQFRUD�LQ�IDPLJOLD47. È molto probabile, però, che l’opera-zione che aveva portato a questo risultato fosse concordata con il principale dei creditori, Vincenzo De Spucches, e che il Pilo, già amministratore dei beni eredi-tari di Vincenzo, mirasse sin dall’inizio ad acquisire la titolarità del marchesato.
,O�QXRYR�PDUFKHVH�GL�0DULQHR�VL�LQYHVWu�GHO�WLWROR�LO����OXJOLR������©D�PDQLEXV�H�SRVVHVVHª�GL�)UDQFHVFR�%RORJQD�©ROLPª�PDUFKHVH�GL�0DULQHR��1RQRVWDQWH�O·LVWLWXWR�feudale conferisse al nuovo signore tutti i poteri giurisdizionali, il Pilo e Francesco %RORJQD�VL�DFFRUGDURQR�SULYDWDPHQWH�DIÀQFKp�LO�%RORJQD��QHO�FRUVR�GHOOD�VXD�YLWD��potesse ancora fregiarsi del titolo di marchese di Marineo, esercitare la giurisdi-]LRQH�VXO�PDUFKHVDWR�H�QRPLQDUH�JOL�XIÀFLDOL��HFFHWWR� LO�QRWDLR48. Sarebbe rimasta di pertinenza di Vincenzo, come in passato, l’amministrazione effettiva dei beni, la riscossione delle gabelle e dei privilegi feudali, e il diritto di veto su qualsiasi decisione presa dal cognato in materia di giustizia49. Nella Sicilia moderna uno dei tratti distintivi dell’appartenenza all’aristocrazia era caratterizzato dalla dignità dello status nobiliare derivata dal consenso sociale, dalla riconoscibilità dell’appar-tenenza a un ceto privilegiato50��HFFR�FKH�SHU�)UDQFHVFR�%RORJQD�SRWHUVL�IUHJLDUH�GHO�titolo di marchese di fronte ai vassalli che avevano servito i suoi antenati, vivere nel castello posto al centro del feudo, esercitarvi la giustizia diventava una forma di legittimazione equivalente a quella giuridica dell’investitura feudale. L’accordo tra i due cognati, di fatto, rimase in vigore soltanto pochi mesi poiché, in seguito ad alcune divergenze di opinione, il Pilo ottenne dalla Regia Corte che l’accordo fosse dichiarato nullo51. Da questo momento, il titolo e i possedimenti feudali spettarono agli eredi di Vincenzo Pilo e nel 1634 con la morte di Francesco Bologna i Bologna GL�0DULQHR�VL�HVWLQVHUR�GHÀQLWLYDPHQWH52.
BIBLIOGRAFÍA
BALISTRERI, Vincenza, Le Licentiae populandi in Sicilia nel secolo XVII, Palermo, Athena 1979.
BAVIERA ALBANESE, Adelaide, “La Sicilia tra regime pattizio e assolutismo monarchico agli inizi del secolo XVI”, Studi senesi, XCII, 1980, pp. 189-310.
46� �9LQFHQ]R�3LOR�DYHYD�VSRVDWR�OD�PDJJLRUH�GHOOH�ÀJOLH�GL�9LQFHQ]R��*LXOLD��$63D��&DPSRUHDOH��EXVWD������FF��������������GLFHPEUH������$63D��,QYHVWLWXUH��EXVWD�������SURFHVVR�������DQQR�������
47 ASPa, Camporeale, busta 984, cc. 245-250, 5 Marzo 1624.48 ASPa, Camporeale, busta 984, cc. 211r-223r, 21 aprile 1622.49 Ibidem.50� �/$%$7287��������SS����������086,��������SS����������51 ASPa, Camporeale, busta 984, cc. 211r-223r, 21 aprile 1622.52 Nel XVII e XVIII secolo un altro ramo della famiglia, quello dei marchesi di Altavilla e
Sambuca e principi di Camporeale raccolse l’eredità simbolica del prestigio dei Bologna di Marineo (PINZARRONE, 2009).
116 Lavinia Pinzarrone
BAVIERA ALBANESE, Adelaide, “Sulla rivolta del 1516 in Sicilia”, BAVIERA AL-BANESE, Adelaide, Scritti Minori, Soveria Mannelli, Rubettino 1992, pp.171-210.
BENIGNO, Francesco, “Mito e realtà del baronaggio: l’identità politica dell’aristocrazia siciliana in età spagnola”, BENIGNO, Francesco, TORRISI, Claudio (eds.), Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi, Roma, Donzelli 1995, pp. 64-78.
BENIGNO, Francesco, “A patti con la monarchia degli Asburgo? La Sicilia spag-QROD�WUD�LQWHJUD]LRQH�H�FRQÁLWWRµ��GIUFFRIDA, Antonino, D’AVENIA Fabri-zio, PALERMO, Daniele (eds.), Studi storici dedicati a Orazio Cancila, Palermo, Associazione Mediterranea 2011, 4 vols, I vol., pp. 373-392.
CANCILA, Orazio, Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna, Palermo, Palumbo 1993.
CANCILA, Rossella, ,O�SDQH�H�OD�SROLWLFD��OD�ULYROWD�SDOHUPLWDQD�GHO�����, Napoli, Esi 1999.
CANCILA, Rossella, Gli occhi del principe. Castelvetrano: uno stato feudale nella Sici-lia moderna, Roma, Viella 2007.
CANCILA, Rossella, “Congiure e rivolte nella Sicilia del Cinquecento”, Medite-rranea. Ricerche storiche, 2007, 9, pp. 47-62.
DELILLE, Gerard, Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli, Torino, Einaudi 1988.FALSAPERLA, Tiziana, “Il governo feudale: amministrazione (Secoli XV-XVII)”,
LIGRESTI, Domenico (ed.), Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, riveli, Catania, Cuecum 1995, pp. 129-248.
GIUFFRIDA, Antonino, /D�ÀQDQ]D�SXEEOLFD�QHOOD�6LFLOLD�GHO�¶���, Caltanissetta-Ro-ma, Sciascia 1999.
GIURATO, Simona, /D�6LFLOLD�GL�)HUGLQDQGR�LO�&DWWROLFR��7UDGL]LRQL�SROLWLFKH�H�FRQÁLWWR�WUD�4XDWWURFHQWR�H�&LQTXHFHQWR������������, Soveria Mannelli, Rubettino 2003.
LABATOUT, Jean-Pierre, Le nobiltà europee dal XV al XVIII secolo, Bologna, Il Mu-lino 1999.
LONGHITANO, Gino, Studi di storia della popolazione siciliana, Catania, Cuecum 1988.
MAURICI, Ferdinando, FRESINA, Adriana, MILITELLO, Fabio, (eds.), Le torri nei paesaggi costieri siciliani (secoli XIII-XIX), Palermo, Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione 2008, 3 vols, vol. II., pp. 170-174.
MACRÌ, Geltrude, “Il grano di Palermo fra ‘500 e ‘600: prerogative e reti d’interesse”, Mediterranea. Ricerche storiche, 2010, 18, pp. 429-443.
MUSI, Aurelio, Il feudalesimo nell’Europa moderna, Bologna, Il Mulino 2007.PINZARRONE, Lavinia, “Dinamiche di mobilità sociale in Sicilia: potere, terra e
matrimonio. I Bologna tra XVI e XVII secolo”, Mediterranea. Ricerche storiche, 2009, 15, pp. 123-156.
PINZARRONE, Lavinia, “La formazione di un patrimonio feudale: gli “stati” del marchese di Marineo nel XVI secolo”, MUSI, Aurelio, NOTO, Maria Anna, Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell’Italia meridionale, Palermo, Associazio-ne Mediterranea 2011, pp. 429-443.
Terra e poTere nella periferia dell’impero 117
SCARPULLA, Antonino, “Dalla terra all’abitato. La fondazione della nuova Ma-rineo”, LOMBINO, Santo (ed.), Congregar gente: Santa Maria dell’Ogliastro e le città di nuova fondazione nella Sicilia moderna, Bolognetta, Comune di Bolog-netta 2002, pp. 165-196.
SCIUTI RUSSI, Vittorio, “Nobiltà e Parlamenti nella Sicilia di Filippo II”, BELEN-GUER CEBRIÀ, Ernest (ed.), Felipe II y el Mediterraneo, Madrid, Siciedad Esta-tal para la Conmemoraciòn de los centenarios de Felipe II y Carlos V 1999, 4 vols, vol. II, pp. 191-201.
TRASSELLI, Carmelo, Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L’esperienza siciliana 1475-1525, Soveria Mannelli, Rubettino 1982.
VIGIANO, Valentina, L’esercizio della politica. La città di Palermo nel Cinquecento, Roma, Viella 2004.
ABREVIATURAS UTILIZADAS
ASPa: Archivio di Stato di PalermoCamporeale: Archivio privato dei principi di CamporealeTrp: Tribunale del Real PatrimonioTco: Tribunale del ConcistoroInvestiture: Processi di InvestituraAHM: Archivo Historico Nacional de MadridAGS: Archivo General de SimancasSp: Secretarias Provinciales