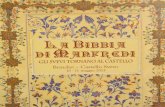FRATTAGLIE STORICHE: UN’INEDITA RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DI LAUNAC
Maschere, potere e rievocazioni storiche. Gli ultimi gladiatori
Transcript of Maschere, potere e rievocazioni storiche. Gli ultimi gladiatori
186
MASCHERE, POTERE E RIEVOCAZIONI STORICHE:GLI ULTIMI GLADIATORI
di Marxiano Melotti
Abstract: Tra maschere e potere esiste un rapporto antichissimo: il po-tere stesso è una maschera e spesso ricorre alle maschere. Un’analisi di casi lo conferma chiaramente.
Quando nel 1900 Guglielmo II, per attestare la pretesa continuità del suo Impero con quello di Roma, pose la prima pietra della fortezza «roma-na» di Saalburg, tutti i presenti erano vestiti da antichi romani, tranne il Kai-ser, cui come maschera bastava il potere. Quella cerimonia in costume è un esempio notevole di living history: un fenomeno largamente diffuso nell’età del nazionalismo romantico, in cui i nuovi Stati nazionali, per consolidare il proprio potere, tendevano a presentarsi come il risultato di un lungo pro-cesso storico.
L’800 ha forgiato molti eroi leggendari, come Arminio e Spartaco, diven-tati maschere del potere e del contropotere. In Italia anche le celebrazioni in co-stume del Natale di Roma, iniziate con un carattere quasi carnevalesco, acquisi-rono presto una valenza politica. L’immagine dell’antica Roma fu poi sfruttata dal fascismo per plasmare quella del regime. Oggi la living history è sempre più diffusa dappertutto anche come attività di edutainment e richiamo turistico.
In Italia le nuove attività in costume e i gladiators for picture che presidia-no il Colosseo rendono bene l’idea del passaggio alla postmodernità, con la sua commistione di turismo, cultura e divertimento. Il Comune di Roma ha mosso guerra ai nuovi gladiatori, ma ha rispolverato i festeggiamenti in costume per il Natale di Roma.
Specialmente in Italia la politica postmoderna è spesso caratterizzata da un mix di pubblico e privato, cultura e mercato, promesse mirabolanti e divertimento sfrenato e non rifugge neppure da allettamenti commerciali e compiacimenti sessuali e sessisti. Tipica è stata la festa organizzata a Roma da alcuni consiglieri regionali, che mostra chiaramente questa interconnes-sione di attività politiche e di attività ludiche. È il punto di arrivo di una cultura in cui il potere accetta persino di degradarsi con maschere di maiale. A differenza che nel Carnevale, in cui garantisce la temporaneità del ribalta-mento sociale, qui la maschera rivela il vero volto del potere.
187
Abstract: Between masks and power there is a long-standing connection: power itself is a mask and often uses masks. A case analysis clearly confirms this.
When in 1900, to attest the continuity of his empire with the Roman Empire, Wilhelm II laid the foundation stone of the «Roman» fortress in Saalburg, all the participants were dressed as ancient Romans, except the Kaiser, whose power was a sufficient mask. That ceremony was a remarka-ble example of «living history», largely uses in the age of Romantic nationa-lism, when the new nation-states, to consolidate their power, tried to show they were the result of a long historical process.
The nineteenth century created many legendary heroes, such as Ar-minius and Spartacus, who became masks of power and counter-power. In Italy the celebrations in fancy dress of the birth of Rome, which was originally connected with the Roman carnival, soon acquired a political meaning. Roman history was then exploited by fascism to shape the image of the regime. Today «living history» is becoming an important form of edutainment and a tourist attraction everywhere.
In Italy new activities in costume and the «gladiators for pictures» who garrison the Coliseum mark the transition to post-modernity, with its mix of tourism, culture and entertainment. The City of Rome contests the new gladiators, but has reintroduced events to celebrate in costume the Birth of Rome.
Especially in Italy, post-modern politics is often characterized by a mix of public and private interests, culture and market enterprises, amazing pro-mises and unbridled fun and does not even shy away from commercial enticements and sexual and sexist complacency. A typical expression was the party organized in Rome by some members of the Regional Council, which clearly shows the connection between political activities and leisure. It is the culmination of a culture where power even demeans itself with pig masks. But unlike the period of Carnival, when the masks ensure that the overthrow of the social order is merely temporary, here the masks reveal the real face of power.
1. Maschere, ricostruzioni e rievocazioni storiche
Tra maschera e potere esiste un rapporto antichissimo e quasi costitutivo. Il potere in sé stesso è in qualche modo una maschera: un individuo, un gruppo, una parte della popolazione si traveste per af-fermare e manifestare la propria alterità rispetto al resto della società.
188
Maschera e travestimenti marcano questo distacco e, in certi contesti culturali, lo ritualizzano o addirittura lo sacralizzano.
Nel mio intervento di due anni fa avevo proposto alcune rifles-sioni proprio sulla funzione straniante e sacralizzante della maschera con una serie di esempi che andavano da Tutankhamun a Padre Pio1. Ora vorrei invece esaminare quel che accade quando è il potere che si mette in maschera o, meglio, usa il travestimento per celebrarsi.
Una bella copertina della «Tribuna Illustrata» del 1900 mostra un impettito Guglielmo II mentre «pone la prima pietra del pretorio di Saalburg»: l’imponente fortezza «romana» fortemente voluta dall’im-peratore e audacemente costruita sulle fondamenta di un insediamen-to militare romano di età imperiale. La didascalia spiega anche che il Kaiser intendeva «far rivivere per un’ora l’antica Roma», circondato da «patrizi in manti di porpora, soldati legionari, matrone in candide vesti, bimbi col capo coronato di rose», tra pomposi festoni, insegne con le aquile imperiali e striscioni con la scritta «Ave Caesar»2.
Il potere celebra sé stesso con una grandiosa mascherata: Gu-glielmo II, erede del fondatore di un impero nuovo, fondato meno di trent’anni prima, appare trasportato nell’antica Roma. L’intera for-tezza, costruita sopra un vero sito archeologico, è una maschera che traveste il presente da passato e porta il passato nel presente, con l’intento di visualizzare, in modo estremamente concreto, il rapporto forte che il nuovo impero intende stabilire con il passato: Guglielmo II è un nuovo Cesare e la nuova Germania è la continuazione dell’an-tico Impero romano, di cui eredita e perpetua la tradizione militare, ingegneristica, organizzativa e amministrativa (benché per i Romani la «Germania» del loro tempo fosse un mondo altro e barbarico da combattere e sottomettere).
Va però notato che, mentre tutti gli altri presenti sono in masche-ra, l’imperatore non lo è: l’imperatore è sé stesso; la sua maschera non è la divisa che veste, ma il ruolo che riveste. In questo scenario carnevalesco l’imperatore non ha bisogno di travestirsi proprio per-
1 M. Melotti, Fantasie ibride. Il corpo e la maschera nella rete globale, in La maschera e il corpo. Tradizioni, riti e maschere del Mezzogiorno d’Italia, a cura di P. Sisto, P. Totaro, Progedit, Bari 2012, pp. 262-283.
2 «La Tribuna Illustrata della Domenica», 21 ottobre 1900, n. 42.
189
ché già esprime in quanto tale la continuità e la relativa ideologia: il suo nuovo impero è, in qualche modo, sempre esistito, sin dal tempo dell’antica Roma.
A travestirsi è invece tutto il resto: lo scenario e la gente che cir-conda l’imperatore. È l’antica Roma che emerge dal passato per avvol-gere il sovrano. Questa è la maschera che l’imperatore indossa: l’intera storia di Roma che si posa sulle sue spalle come un ampio mantello.
La fastosa cerimonia in costume di Saalburg è un esempio, inte-ressante e molto particolare, di living history e re-enactment a tema stori-co: una rievocazione storica in costume3.
Si tratta di un fenomeno antico, ma che, non a caso, ha raggiunto il suo apice politico tra gli ultimi decenni dell’800 e il primo ’900, nella fase saliente del nazionalismo romantico. Living history e re-enactment hanno accompagnato i processi romantici di riscoperta del passato a fini identitari e politici4.
I nuovi Stati nazionali avevano bisogno di costruire o di con-solidare una propria immagine che fosse autonoma da quella delle precedenti formazioni politiche e diversa da quella degli Stati che li circondavano, ma stabilisse anche qualche continuità con il pas-sato. Occorreva quindi «inventare una tradizione» (per dirla con Hobsbawm)5 che ancorasse il nuovo alla storia e trasmettesse ai cit-tadini dei nuovi Stati l’idea tranquillizzante (soprattutto per i sovra-ni) che il nuovo non fosse veramente tale (e quindi pericolosamente instabile), ma fosse il risultato, durevole e consolidato, di un lungo processo storico.
3 Su living history e re-enactment si vedano A. Agnew, History’s Affective Turn: Hi-storical Re-enactment and Its Work in the Present, «Rethinking History», 11, 3, 2007, pp. 299-312, e Historical Reenactment. From Realism to the Affective Turn, a cura di I. McCal-man, P. Pickering, Palgrave Macmillan, London-New York 2010.
4 M. Melotti, Turismo culturale e festival di rievocazione storica. Il re-enactment come strategia identitaria e di marketing urbano, in Contesti mediterranei in transizione. Mobi-lità turistica tra crisi e mutamento, a cura di R. Deriu, Milano, FrancoAngeli, 2013, pp. 144-154.
5 E.J. Hobsbawm, Introduction, in The Invention of Tradition, a cura di E.J. Hobsbawm, T. Ranger, Cambridge University Press, Cambridge 1983, pp. 1-14; trad. it. Introduzione, in L’invenzione della tradizione, a cura di E.J. Hobsbawm, T. Ran-ger, Einaudi, Torino 1987, pp. 3-17.
190
Se oggi ci troviamo in un mondo «liquido»6, dove tutti i fenomeni e le esperienze si confondono e s’intrecciano, il mondo di Guglielmo II e della fortezza di Saalburg era senza dubbio un mondo «solido» (o, almeno, credeva di esserlo), con istituzioni forti e incrollabili (lo Stato, l’esercito, le grandi università) che utilizzavano la storia per corrobo-rare e trasmettere quell’idea di forza e di solidità.
Ma i monumenti, pur solidissimi, non bastano. L’inaugurazione di Saalburg lo mostra chiaramente: perché l’invenzione della tradizione sia efficace, è necessario ricostruire o reinventare anche il patrimonio immateriale (che può essere costituito da miti, racconti, feste o altre espressioni della cultura popolare e della vita quotidiana).
È con questa funzione che nel corso dell’800 prendono gradual-mente piede le attività in costume storico e le rievocazioni di parti-colari avvenimenti, che permettono di arricchire i processi di costru-zione identitaria e di rendere più efficace – perché più chiaramente esperienziale – la reinvenzione del passato.
La Germania dell’800 forgia così tutta una serie di eroi leggen-dari: primo fra tutti Arminio, il guerriero germanico che nel 9 d.C. travolse le armate romane nella foresta di Teutoburgo. Ribattezzato «Hermann» (sin dal tempo della Riforma protestante di Martin Lu-tero, che voleva farne un simbolo della lotta dei popoli germanici contro Roma) e reinterpretato come il campione dell’autoctonia e dell’indipendenza tedesca, Arminio diventa una maschera del potere, indossata di volta in volta da alcuni dei suoi più cospicui esponenti, fra cui Guglielmo I, il fondatore del nuovo Impero tedesco, e Hitler, il fondatore del Terzo Reich.
L’altro grande mito che si afferma nello stesso periodo storico è quello di Spartaco, lo schiavo ribelle al potere di Roma. La figura di Spartaco ebbe un successo straordinario e fu immediatamente media-tizzata (come diremmo oggi) per essere utilizzata a sostegno di una vasta gamma di posizioni culturali e politiche.
Marx (che attinge alla Storia romana di Appiano) lo descrive come «il personaggio più sfolgorante [famoseste] di tutta la storia antica», «un grande generale», molto migliore di Garibaldi, e «un carattere nobile,
6 Z. Bauman, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge 2000; trad. it. Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002; 2a ed. con nuova introduzione 2012.
191
vero rappresentante dell’antico proletariato»7. Un gladiatore, espres-sione di una società militarista e schiavista, che considerava la guerra e la schiavitù come delle istituzioni naturali immutabili, diventa l’eroe di un proletariato in lotta per la propria emancipazione sociale contro il sistema storicamente esistente. Si tratta di un uso strumentale del passato, che comporta una «dilatazione arbitraria del paradigma delle classi e delle loro eventuali forme di coscienza»8, in contrasto con la realtà storica, dato che Spartaco non si prefiggeva né poteva prefig-gersi un’abolizione generale della schiavitù9.
Marx scriveva in una fase storica caratterizzata da una profonda trasformazione economica, politica e culturale. In Europa il proleta-riato si stava faticosamente formando una coscienza di classe – o per lo meno Marx pensava che se la stesse formando – e, al contempo, si stavano definendo o rafforzando i grandi Stati nazionali. L’antichità classica appariva come un serbatoio inesauribile di modelli da utiliz-zare non tanto per plasmare il presente quanto per spiegarlo.
Il grande rivoluzionario tedesco rimodellò similmente anche la figura di Arminio. Il principe dei Cherusci, che distrusse le legioni di Varo, viene presentato come l’eroe di una classe capace di combattere e di sconfiggere i propri nemici. Per Engels, affascinato come mol-ti altri autori del suo tempo, dal mito tacitiano dei «liberi germani», Arminio avrebbe avuto il merito di vincere una battaglia contro l’in-troduzione in Germania della proprietà privata, che il diritto romano considerava, con la famiglia e con lo Stato, la base dell’organizzazione sociale10.
7 K. Marx, Lettera a Friedrich Engels, 27 febbraio 1861; in Marx-Engels Gesamtau-gabe, Akademie Verlag, Berlin 20053, vol. 11, p. 377; trad. it. in K. Marx, F. Engels, Opere complete, Editori Riuniti, Roma 1973, vol. 41, p. 75.
8 A. Schiavone, Spartaco: le armi e l’uomo, Einaudi, Torino 2011, pp. 75-76.9 P. Mieli, Spartaco fu un guerriero (non un rivoluzionario). Sbagliato dipingerlo come
nemico dello schiavismo, in «Corriere della Sera», 8 febbraio 2011.10 F. Engels, Zur Urgeschichte der Deutschen (1881-1882), manoscritto pubblicato
in K. Marx, F. Engels, Werke, Dietz, Berlin 1962, vol. 19, pp. 425-473; trad. it. in Storia e lingua dei Germani, Editori Riuniti, Roma 1974. Si veda anche Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, Schweizerische Genossenschaftsbuchdru-ckerei, Hottingen-Zürich 1884; trad. it. L’origine della proprietà privata, della famiglia e dello Stato, Editori Riuniti, Roma 1963 (il libro, a quanto dichiara lo stesso Engels nella prefazione alla prima edizione, «rappresenta, in certo qual modo, l’esecuzione
192
Visto, però, che si tratta pur sempre di usi strumentali della storia, lo stesso personaggio può essere utilizzato anche molto diversamen-te. Ecco dunque che Arminio, da eroe transnazionale di un proleta-riato senza patria, diventa, per Guglielmo I e poi anche per Hitler, il fondatore dell’identità germanica, l’eroe ancestrale del nazionalismo tedesco e il simbolo precorritore della supremazia della grande Ger-mania11.
Il caso è particolarmente interessante. Come abbiamo visto, Gu-glielmo I mitizza Arminio, ormai divenuto il tedesco Hermann, e nel 1875 (cinque anni dopo la vittoria contro la Francia) inaugura nei pressi di Detmold, in Westfalia, nella foresta della battaglia, l’Her-mannsdenkmal, un imponente monumento in suo onore: una statua alta più di 26 metri, eretta su un basamento altrettanto alto, rivolta verso la Francia sconfitta. Paradossalmente, però, Guglielmo II che gli successe (dopo il brevissimo intervallo di Federico III) si presenta come l’erede di quello stesso Impero romano che Arminio aveva cla-morosamente sconfitto e, per confermare quella pretesa continuità, costruisce la fortezza «romana» sopra ricordata.
Gli esempi di utilizzo in chiave identitaria e politica del passato sono molto numerosi. Particolarmente efficace in proposito è appar-sa, già prima di Marx, la già richiamata figura di Spartaco12. Nel 1760 Bernard-Joseph Saurin, philosophe dramaturge, ne fece un eroe illumini-sta, che difendeva la «natura degli esseri umani contro la monarchia assolutista». Nel 1770 l’Abbé Raynard invocava «l’arrivo di un nuovo Spartaco per abbattere il sistema schiavistico». Nel 1791, durante la vittoriosa rivolta contro i francesi degli schiavi di Haiti, Toussaint
di un lascito» di Marx, scomparso l’anno prima). Sulla figura di Arminio in Engels si veda, specificamente, L. Canfora, Dalla selva di Teutoburgo alle guerre moderne. Quello slancio nazionalistico che resiste nei secoli, in «Corriere della Sera», 27 giugno 2012, pp. 20-21.
11 C. Risen, They need a hero, in «The National», 9 ottobre 2009 (versione elettronica: http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?aid=/20091009/review/7100 89994/1008). Si veda anche M. Melotti, The Plastic Venuses. Archaeological Tourism in Post-Modern Society, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2011, pp. 211-213.
12 A. Futrell, Seeing Red. Spartacus as Domestic Economist, in Imperial Projections. Ancient Rome in Modern Popular Culture, a cura di S.R. Joshel, M. Malamud, D.T. McGuire, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 2001, pp. 77-118.
193
Louverture, il loro capo, fu definito lo «Spartaco Nero». Nel 1809 il giovanissimo Franz Grillparzer, pensando ad Andreas Hofer, il ti-rolese che sfidò Napoleone, fece di Spartaco un eroe nazionalista, «speranza della patria». Nel 1831 un drammaturgo americano, Robert Montgomery Bird, in The Gladiator, ne fece addirittura un «eroe ame-ricano», perché il suo amore per la libertà sarebbe stato lo stesso che aveva animato la lotta per l’indipendenza dei coloni americani.
Ma vi sono esempi anche più drammatici. Nel 1918 Rosa Luxem-burg e Karl Liebknecht fondarono lo Spartakusbund, un movimento di estrema sinistra ispirato a uno Spartaco che «impugna la spada del-la lotta rivoluzionaria»13 ed è «fuoco e spirito, anima e cuore, volontà e azione per la rivoluzione del proletariato»14: un precursore, insomma, della lotta contro l’imperialismo moderno, che la Luxemburg aveva studiato e denunciato fra i primi. La rivolta della Luxemburg e di Liebknecht finì però nel sangue: furono entrambi assassinati, proprio come l’antico guerriero. Si tratta probabilmente del momento di mag-gior tensione mitopoietica della figura di Spartaco nei nostri tempi. La morte «vera» della Luxemburg e di Liebknecht in qualche modo lo sottrae al mondo del mito e lo porta nell’arena politica moderna, dimostrando che ancor oggi esistono dei gladiatori che si battono contro il sistema e muoiono per la libertà.
Tutti questi esempi fanno riferimento a un modo simile di utiliz-zare la storia: il passato diventa una maschera e uno strumento per la costruzione identitaria e politica del presente.
2. Il Natale di Roma e il Carnevale del potere
Naturalmente tutto ciò non avveniva soltanto in Germania. An-che nella nostra piccola Italia, che ancora cercava di costruire la pro-pria identità nazionale, furono utilizzati strumenti simili. Da questo
13 R. Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie, Zürich, 1916; in Id., Gesammelte Werke, vol. 4, Dietz, Berlin 2000, pp. 51-164; trad. it. La crisi della socialdemocrazia, in Id., Scritti politici, a cura di L. Basso, Editori Riuniti, Roma 1967, pp. 421-466.
14 K. Liebknecht, Trotz Alledem!, in «Die Rote Fahne», n. 15, 15 gennaio 1919; in Gesammelte Reden und Schriften von Karl Liebknecht, vol. 9, Dietz, Berlin 1968, pp. 675-679.
194
punto di vista la storia delle celebrazioni del Compleanno di Roma è un caso assai interessante che ci permette di riflettere sulle trasforma-zioni culturali e politiche della città15.
Nella prima metà dell’800, quando l’Unità d’Italia era ancora di là da venire e Roma era la capitale dello Stato Pontificio, la ricorrenza era celebrata soprattutto dagli stranieri che vi vivevano o vi soggior-navano. Si trattava di un evento ludico, lontano da ogni rivisitazione politica, che, rientrando di fatto nel Carnevale romano, utilizzava la storia per creare un’occasione di trasgressione. Gli stranieri si riuniva-no in una grotta a far bisboccia e magari ad amoreggiare in un roman-tico contesto dall’aria cadente, che ben si sposava con l’immagine no-stalgica e primitivista che portava nell’arretrata ma affascinante Italia del Centro e del Sud i ricchi viaggiatori inglesi, tedeschi e francesi del Grand Tour. Va notato che in queste romantiche o addirittura pre-romantiche forme di consumo del territorio, dei monumenti e delle tradizioni locali possiamo intravedere una serie di elementi di carat-tere ludico e sensoriale che sono riapparsi, in modo più consistente e sistematico, nella fase più recente del turismo culturale di massa e, in senso più generale, del consumismo postmoderno. Il distacco da una dimensione politica e il compiacimento estetizzante più o meno consapevole conducono infatti a forme comparabili di tematizzazio-ne della storia.
In quelle celebrazioni del Compleanno di Roma possiamo inoltre individuare una frattura (tipica del turismo) nel consumo del territo-rio, e soprattutto della sua immagine, fra comunità locale e «stranieri», turisti compresi. Per questi ospiti temporanei lo spazio civico è infatti un mondo «altro», in grado di accogliere facilmente attività speciali di carattere ludico o identitario. Da questo punto di vista Roma (so-prattutto nel periodo preunitario), con le sue cadenti rovine e la sua peculiare dimensione agreste-pastorale, raffigurata dai vedutisti del Grand Tour, rappresentava uno spazio particolarmente adatto a quel processo parainiziatico costituito dal turismo culturale protoroman-tico. Di fatto la città poteva essere pensata come un grande parco a tema o, meglio, svolgeva quell’insieme di funzioni che sono oggi
15 Si veda, in particolare, La storia racconta il Natale di Roma, a cura di M.E. Tit-toni, A. Nicosia, Gangemi, Roma 2007.
195
concentrate nei parchi tematici. Non deve quindi stupire lo sconcerto con cui la comunità locale assisteva (e in parte assiste ancora) a questa trasformazione dello spazio urbano. Un tempo, per lo meno prima della «carnevalizzazione della società»16, una simile trasformazione era consentita solo in precise situazioni di carattere rituale o semi-rituale, come appunto il Carnevale, con funzioni di mantenimento o di recupero di un equilibrio psicologico e sociale, e quindi anche politico, nella popolazione.
Le celebrazioni ottocentesche del Compleanno di Roma, anche per la loro natura allogena, avevano un carattere carnascialesco di rottura dell’ordine costituito (come conferma il fatto che in parte confluivano nel Carnevale vero e proprio) e non potevano essere molto apprezzate o comprese dalla comunità locale. Si trattava di una sorta di Carnevale degli artisti stranieri a Roma, cui prendevano parte anche degli artisti italiani: i pittori e gli scultori spagnoli sce-neggiavano una cavalleria che montava però degli asinelli; gli arti-sti tedeschi inscenavano l’artiglieria con cannoni di legno; gli italia-ni rappresentavano la fanteria e, naturalmente, si occupavano delle salmerie. I vari eserciti si davano appuntamento alla Torre Cervara, dove simulavano un assedio e una battaglia che si concludeva con un grande banchetto17.
Un commentatore che, negli ultimi anni del fascismo, ebbe a rac-contare questa festa (in un annuario di storia e cultura locale che vie-ne presentato proprio in occasione di ogni Compleanno di Roma), ne denunciava il carattere allogeno e l’impostazione ludica, in cui l’e-lemento militare (peraltro ineludibile in ogni rievocazione storica a tema romano) veniva trivializzato. Egli citava in proposito le parole di Ciceruacchio (già diventato un personaggio di primo piano sulla scena cittadina), che aveva nominato persino una Commissione di vigilanza per evitare «quelle buffonate delli forestieri, li quali oltrag-giavano i fasti dell’Eterna Città mascherandosi, mentre essi Roma-
16 M. Melotti, Oltre il carnevale. Maschere e postmodernità, in Il Carnevale e il Medi-terraneo. Tradizioni, riti e maschere del Mezzogiorno d’Italia, a cura di P. Sisto, P. Totaro, Progedit, Bari 2010, pp. 57-88.
17 G. Brigante Colonna, Natale di Roma, in «Strenna dei Romanisti», n. 2, Sta-derini, Roma 1941, pp. 1-4; A. Venditti, La torre e le grotte di Cervara, in «Specchio romano», blog, febbraio 2007, in www.specchioromano.it.
196
ni li avevano già celebrati con tanto decoro e dignità»18. Lo stesso commentatore peraltro coglieva bene il carattere della festa, in cui la «mascherata collettiva» assumeva «apparenza militare» e diventava un «Carnevale d’incosciente spensieratezza».
Quelle celebrazioni, che pure si proponevano di ricordare la na-scita di Roma, non possono essere considerate una vera forma di living history. Tuttavia, anche da quanto scrive il sopra citato autore, si vede come la rievocazione degli eventi storici sia intrinsecamente connotata da una forte ambiguità: la storia che si mette in maschera può essere celebrazione o Carnevale. Il potere ha usato per secoli la festa – e in particolare il Carnevale – come uno strumento di control-lo e di canalizzazione di tensioni e di pulsioni sociali che avrebbero potuto metterne in crisi la stabilità e ha accettato una temporanea so-spensione dell’ordine costituito e delle gerarchie. Il «popolo» può così mascherarsi da «potere», purché sia chiaro che si tratti solo di un tra-vestimento momentaneo. Con la medesima logica, il potere può offri-re, secondo il modello del panem et circenses, feste e spettacoli grandiosi che mettano in scena, assieme al divertimento, anche la forza – coer-citiva, punitiva ed economica – di chi li organizza. Allo stesso modo per rappresentare la propria forza può utilizzare alcuni degli stru-menti con cui la festa e il Carnevale rappresentano il potere. Ed è qui che può verificarsi un corto circuito incontrollabile: la rievocazione storica, così come la parata militare in costume o ogni altra esibizione di forza militare e di continuità storica di questa forza, si muovono sul pericoloso versante del divertimento, che da un lato rende accettabile il pur temibile potere, ma dall’altro ne mostra l’intrinseca debolezza, la transitorietà e la facile e immediata parodiabilità.
La situazione muta nei decenni successivi, con l’evolvere del con-testo politico. Il primo «vero» Compleanno di Roma viene celebra-to nel 1847, in una città ormai attraversata da fervori riformisti, che dopo il voltafaccia di Pio IX sarebbero diventati apertamente anti-papalini e repubblicani: un gruppo di liberali organizza una celebra-zione del Natale di Roma, con forme embrionali di living history e una serie di attività a tema romano ispirate a Romolo, Numa Pompilio e la Lupa Capitolina. Sul monte Esquilino, presso le terme di Tito, venne
18 G. Brigante Colonna, Natale di Roma, cit.
197
organizzato un grandioso banchetto: «Sorgeva nel mezzo la guerriera statua di Roma con davanti scolpita la Lupa che fu nutrice di Romolo […]. Di là si partivano come tanti raggi dal centro diverse mense e si cibavano i più che 800 cittadini che vi presero parte»19.
Gli animatori di questa celebrazione protestano contro l’inau-tenticità dell’altra festa: nel nuovo scenario culturale e politico viene insomma stabilita una demarcazione fra il Compleanno di Roma e il Carnevale. Nel 1848 «il movimento liberale, all’interno di una strate-gia tesa a operare un cambiamento delle feste romane tradizionali, da impertinenti e gaudenti a civili e celebrative, riuscì in breve tempo a limitare fortemente la sfrenatezza del Carnevale e a far fallire la bur-lesca celebrazione del Natale di Roma»20.
Nel 1849, proclamata la Repubblica Romana, la nuova città-Stato, in cerca di una propria identità forte, in discontinuità con la Roma dei papi, ricupera il ricordo dell’antica Roma repubblicana e, in questo quadro, inventa – o, meglio, reinventa – la festa del Compleanno di Roma. La notte del 21 aprile l’interno del Colosseo viene interamente illuminato con dei bengala «in modo da ottenere i più vaghi effetti ottici della superba mole»; più tardi viene similmente illuminata tutta la sua parte esterna rivolta verso il Tempio di Venere e Romolo e l’Ar-co di Costantino; quindi, per una via disegnata da fiaccole, il popolo sale in processione al Campidoglio, «medesimamente illuminato», per concludervi la giornata «con dignitosa esultanza e tranquilla gioia»21.
Ma è con Mussolini che la Roma antica è cannibalizzata per pla-smare l’identità del nuovo Impero. Sul modello di Guglielmo II, Mus-solini dà consistenza visiva a quell’asserita continuità22. Ne sono stru-
19 Il Natale di Roma celebrato il 21 aprile 1847. Banchetto Pubblico sul monte Esquilino alle Terme di Tito, in «Il Contemporaneo», Roma, 24 aprile 1847. Si veda anche Il natalizio di Roma e Pio IX, foglio a stampa, Roma 1848 (documento conservato nella Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma).
20 L. Nasto, Le feste civili a Roma 1846-1848, «Rassegna storica del Risorgimen-to», 1992, pp. 315-338, 334.
21 Dal manifesto fatto affiggere in tutta la città dal Triumvirato della Repub-blica Romana. Il manifesto si può leggere in B. Amante, Il Natale di Roma, Libreria Manzoni, Roma 18792, pp. 99-100.
22 A. Giardina, A. Vauchez, Il mito di Roma, da Carlo Magno a Mussolini, Laterza, Roma-Bari 2000; P.S. Salvatori, La Roma di Mussolini dal socialismo al fascismo (1901-1922), «Studi Storici», n. 3, 2006, pp. 749-780; M. Melotti, Turismo archeologico. Dalle
198
mento l’effettuazione di scavi archeologici, l’inaugurazione di nuovi musei, la realizzazione di grandi interventi urbanistici e architettoni-ci, fra cui la sistemazione dell’Ara Pacis Augustae e l’apertura della Via dei Fori imperiali, cui si accompagnano l’istituzione di cattedre universitarie «dedicate» e la celebrazione dei bimillenari di Virgilio (1930), Orazio (1936) e Augusto (1937).
In questa complessa e variegata rivitalizzazione della cultura ro-mana – tanto nella sua dimensione materiale di patrimonio monu-mentale e archeologico quanto in quella immateriale di repertorio di valori, miti, tradizioni e suggestioni artistiche e letterarie – spic-ca senz’altro la costruzione ex novo della grandiosa Via dell’Impero. Questa maestosa strada univa due dei più importanti poli simbolici della città: da una parte Piazza Venezia, che ospitava il relativamen-te recente Altare della Patria, monumento al potere regio e celebra-zione dei fasti militari del Paese, e Palazzo Venezia, con il famoso balcone da cui il Duce si sporgeva ad arringare le folle, e dall’altra il Colosseo, incontestabile simbolo della capacità costruttiva e della forza creativa dell’antico impero e da secoli landmark del Paese e del-la sua storia.
L’apertura nel 1932 di quella via, che aveva comportato lo sven-tramento di un intero quartiere con edifici e monumenti medievali (e pertanto una distinzione tra periodi storici da valorizzare e altri da dimenticare), aveva un significato ideologico: il regime creava un grandioso scenario per celebrare sé stesso e adoperava il più impo-nente degli edifici romani sopravvissuti al logorio del tempo come un’imponente quinta teatrale.
L’azione drammatica del regime si svolgeva quindi in una di-mensione storica e veniva di fatto «tematizzata». La Via dell’Impero, contenitore e vetrina al tempo stesso, in quanto spazio capace di ac-cogliere e mostrare fastose parate militari e civili, ma anche passeg-giata archeologica di carattere didattico e turistico aperta sui Fori e sui monumenti voluti da re, consoli e imperatori, era ed è un parco
piramidi alle veneri di plastica, Bruno Mondadori, Milano 2008; K. Terry, The Political Topography of Modern Rome. 1870-1936. Via XX Settembre to Via dell’Impero, in Rome: Continuing Encounters Between Past and Present, a cura di D.S. Caldwell, L. Caldwell, Ashgate, Farnham 2011.
199
a tema: uno spazio artificiale che utilizza la storia come strumento identitario, ludico ed educativo. Non è un caso che quella via an-cor oggi accolga ogni anno la principale parata militare dello Stato italiano, decine di migliaia di studenti in pellegrinaggio scolastico e centinaia di migliaia di turisti in cerca di forti emozioni archeologiche, nonché rappresentazioni di living history e parate storiche. Così la via si è anche profondamente radicata nell’immaginario collettivo e ha contribuito a creare un’immagine grandiosa della Roma antica, che è ormai imprescindibile, come visualizzazione dell’immagine profonda che, grazie alle retoriche di tanti regimi e, più recentemente, di ci-nema e televisione, abbiamo introiettato e ci attendiamo di rivedere ogniqualvolta ci accostiamo al mondo romano. In realtà, questa via, costruita soltanto nel 1932, è percepita come un «elemento autentico del paesaggio dell’antica Roma»23, di cui anche il cinema si è impos-sessato, proponendo, come accade nel Gladiatore e in altri film, parate di legionari su strade simili24.
In questa enorme e complessa opera di costruzione di un imma-ginario collettivo romanizzato e di romanizzazione dello Stato, Mus-solini ha utilizzato anche la living history, con grandi parate in costume ed eventi a tema romano. Soprattutto, però, Mussolini ha rivitalizzato la festa del Compleanno di Roma, su cui aveva già messo gli occhi prima ancora di andare al potere.
Nel 1921 il futuro duce aveva definito i contorni ideologici del suo rapporto con questa festa: «Se i socialisti hanno il Primo maggio, i popolari il 15 maggio e altri partiti di diverso colore altre giornate, noi fascisti ne avremo una: il Natale di Roma, il 21 aprile. In quel giorno, nel segno di Roma eterna, nel segno di quella città che ha dato due civiltà al mondo e ne darà la terza, noi ci riconosceremo e le legioni regionali sfileranno col nostro ordine, che non è militaresco e nem-meno tedesco, ma semplicemente romano»25. Il Natale di Roma viene
23 A. Giardina, Quella strada ormai nella storia non diventi parco giochi, in «Il Messag-gero», 4 agosto 2013, pp. 1 e 8-9. In realtà La Via dei Fori imperiali nasce come par-co giochi o maschera del potere, che, come mostra anche il recente dibattito politi-co sulla sua pedonalizzazione, ogni amministrazione cerca di riadattare e indossare.
24 Sul rapporto tra cinema e storia romana si veda, in particolare, J. Solomon, The Ancient World in the Cinema, Yale University Press, New Haven-London 2001.
25 B. Mussolini, discorso tenuto a Bologna il 3 aprile 1921; in Opera Omnia di
200
assunto come festa identitaria di parte: il partito si appropria di una ri-correnza calendariale per stabilire, in un’ottica di «religione politica»26, una propria giornata: una sorta di festa sacra in cui si celebra la Roma antica o, meglio, il suo mito e la sua immagine.
Qualche mese prima della marcia su Roma, Mussolini, in un di-scorso pubblicato sul «Popolo», aveva affermato che «celebrare il Na-tale di Roma significa celebrare il nostro tipo di civiltà ed esaltare la nostra storia e la nostra razza»27. Anche Mussolini aveva bisogno della sua maschera e Roma diventa quella del nuovo regime: «Roma è il nostro punto di partenza e di riferimento; è il nostro simbolo o, se si vuole, il nostro mito. Noi sogniamo l’Italia romana, cioè saggia e forte, disciplinata e imperiale»28. La festa per il Natale di Roma, con le sue parate in stile romano, diventa insomma il travestimento indos-sato per dare consistenza visiva a questa nuova mitopoiesi imperiale.
La living history mostra qui la sua straordinaria e pericolosa forza: crea e ritaglia un passato a nostra misura, e quindi, spesso, in chiave marcatamente etnocentrica e autoreferenziale.
Nello stesso discorso Mussolini aveva illustrato l’importanza di «una Roma di anime vive»: quasi un’inconsapevole living history in gra-do di dar vita ai monumenti.
Nel 1923 Mussolini istituisce la festa del Natale di Roma, che diventa immediatamente nazionale e assorbe la Festa del lavoro ita-liano, che nell’Italia fascista sostituisce un’altra precedente «invenzio-ne», il Primo Maggio, la festa internazionale dei lavoratori, di origine anarchica e socialista.
Le parole entusiastiche con cui il già ricordato studioso di età fa-scista descrive le celebrazioni del Natale di Roma sono estremamente significative: «Festa del lavoro e della giovinezza; e non c’è giorno più
Benito Mussolini, a cura di E. Susmel, D. Susmel, La Fenice, Firenze 1955, vol. 16, p. 244. Il 15 maggio era la giornata del lavoro cristiano, festeggiata dai cattolici nel giorno in cui nel 1891 Leone XIII aveva pubblicato la Rerum Novarum.
26 E. Gentile, Il fascismo come religione politica, «Storia Contemporanea», 1990, 6, pp. 1079-1106.
27 B. Mussolini, Passato e avvenire, in «Il Popolo d’Italia», 21 aprile 1922; in Opera Omnia di Benito Mussolini, a cura di E. Susmel, D. Susmel, La Fenice, Firenze 1956, vol. 18, pp. 160-161.
28 Ibidem.
201
bello e più santo di questo […] oggi pieno di sacrificio, di fede e di speranza. Non più mascherate. Questa è la sagra del lavoro pacifico e del lavoro cruento. Portiamo i cuori e i gagliardetti e le aquile ro-mane sull’altare della Patria»29. La retorica celebrativa ha completato la metamorfosi della festa, che, da evento carnascialesco, si è prima trasformata in festa civile, idealmente contrapposta al Carnevale, ed è poi diventata festa nazionale con valenze identitarie e nazionaliste. Tuttavia anche questa nuova festa, col suo tripudio di aquile e di ga-gliardetti, da un lato ripropone involontariamente l’originaria dimen-sione carnevalesca e dall’altro si adagia nel solco tracciato, ben prima di Mussolini, dalla spada del Kaiser Guglielmo II, altro epigono degli antichi Cesari.
La sovrapposizione tra il Natale di Roma e la Festa del lavoro crea però un evidente vulnus culturale e politico. Così, con la caduta del fascismo, viene ripristinata già nel 1945 la festa del Primo Maggio, mentre quella del Natale di Roma, diventata ideologicamente imba-razzante, finisce per essere abbandonata o ridimensionata. Perduta la sua funzione mitopoietica, forgiatrice di sentimenti nazionali e nazio-nalisti, riacquista un più tranquillo carattere locale.
Assistiamo qui al passaggio, sussultorio ma graduale, dalla moder-nità alla postmodernità. I gladiatori e i centurioni romani, che sotto Guglielmo II e Mussolini concorrevano a costruire la colorata e viva-ce maschera storica dei due imperi, restano in balìa di un mondo che nel giro di pochi decenni perde la sua solidità romantica, nazionale e industriale per acquisire progressivamente la liquidità della nuova società globale, postnazionale e postindustriale.
3. La foto e la maschera. I gladiatori precari della postmodernità
Il gladiatore cambia maschera: non rappresenta più un passato proposto dalle istituzioni statali come un modello politico ed educati-vo, ma impersona una caricatura della storia che funge da riferimento di un’esperienza (spesso ludica o turistica) sempre più immersa nel presente.
29 G. Brigante Colonna, Natale di Roma, cit., p. 4.
202
Quelle che un tempo erano maschere di un potere esistente sono ora maschere di un potere del passato, che operano senza averne uno alle spalle. L’esempio più tipico di questa trasformazione sono gli ancient Romans for pictures: quei figuranti vestiti da gladiatori, centurioni o imperatori romani che stazionano davanti al Colosseo per farsi fo-tografare a pagamento dai turisti.
Chi sono e a che servono? Possiamo pensarli come elementi di raccordo tra la dimensione atemporale dei monumenti e quella ef-fimera della vita quotidiana. Rappresentano la componente umana della storia. Si confondono tra i venditori ambulanti del merchandising globale che costituisce un’altra maschera della modernità e un’altra espressione del nuovo relativismo culturale e della nuova intercon-nessione planetaria, in cui le più diverse esperienze storiche, cultu-rali, politiche e religiose si equivalgono e si confondono. L’area del Colosseo è infatti un tripudio del consumismo turistico globale: banchetti che vendono, senza alcuna distinzione apparente, statuette di Augusto, David di Michelangelo, Totò, Padre Pio e Berlusconi; ambulanti stranieri che offrono tra mille sorrisi foulards cinesi con la scritta «Roma» stampata sopra un’immagine dell’Acropoli di Atene o magliette «I love Rome», con il cuore rosso ormai serialmente pre-sente in tutte le città del mondo; e invasivi furgoni che sommini-strano incessantemente bibite, panini e merendine a due passi dal monumento.
In un contesto simile non è certo facile prendere sul serio le vivaci coorti di pretoriani che, daga alla mano, inseguono i turisti e spesso importunano donne e ragazze. Certo, il tutto rientra in quel folclore italiano che, nonostante il comprensibile imbarazzo o disappunto che desta negli stessi italiani, costituisce, sin dai tempi del Grand Tour, una delle principali attrattive del viaggio in Italia. Il successo di questa strana attività è testimoniato non solo dalle molte migliaia di visita-tori che si fanno fotografare ogni anno con quei figuranti davanti al Colosseo, ma anche dai resoconti fotografici e dai diari di viaggio presenti in rete.
Un curioso libro in inglese (il cui titolo suona «Cento e uno posti da non vedere prima di morire») dedica ai gladiatori del Colosseo un intero capitoletto («The sidewalk outside the Roman Coliseum during the crazy gladiator’s shift») che presenta il marciapiede del Colosseo con i suoi «folli» gladiatori come il n. 67 dei posti del mondo da cui
203
stare alla larga. Rovesciando in modo spiritoso uno dei tòpoi delle gui-de turistiche − l’elenco dei luoghi «imperdibili», il cui prototipo risale addirittura alla lista ellenistica delle «Sette meraviglie del mondo» − il libro descrive certi fenomeni paradossalmente presenti in alcuni dei più celebrati luoghi turistici del pianeta. Scrive l’autrice: «Most of the-se gladiators are harmless, most interested in carrying on loud cell-phone conversations with their girlfriends than they are in accurately portraying ancient Rome»30.
Il testo sintetizza efficacemente quanto accade quasi ogni giorno davanti al Colosseo: «‘Ah, Christians to kill!’. He shouted in English. He ran at us, trident raised, and grabbed me by neck. ‘Come over here’, he said, gesturing forward a fellow gladiator. ‘Christians to kill, I love killing Christians!’. His friend obliged, holding a plastic sword to my throat as the crazy gladiator pointed his trident toward my chest and yelled: ‘Silicone, ha ha ha!’, as Mark snapped a photo»31. Come anche questo racconto conferma, si tratta di una presenza a tratti molesta, che incide profondamente sull’immagine del monumento. Ma in una società come la nostra, in cui la maggior parte delle espe-rienze passano attraverso le immagini, siano esse fotografie, pagine di Facebook o news televisive, il gladiator for pictures finisce per essere un elemento inscindibile dal monumento, divenendo, per così dire, monumento lui stesso.
Questi moderni gladiatori rappresentano, in realtà, un filtro im-portante, che contribuisce a collocare il monumento archeologico nello spazio storico-mentale dei fruitori, ricordando loro che si trova-no, sì, nella Roma contemporanea del turismo culturale di massa, del merchandising globale, della mercificazione dell’heritage, ma anche nel cuore della Roma antica. Certo, si tratta di un’attività di mediazione storica che esigerebbe ben altra preparazione di base: un background culturale che è invece sempre più scarso, se non assente, non solo tra i figuranti, ma anche tra i turisti. Significativa in proposito è la gaffe grossolana (riportata dalla stampa) del presidente del Parlamento canadese in visita a Roma, che, visti i figuranti del Colosseo, avrebbe chiesto quando fosse avvenuta la deportazione dei romani e si sa-
30 C. Price, 101 Places Not to See Before You Die, Harper, New York 2010, p. 159.31 Ivi, p. 160.
204
rebbe informato con partecipe preoccupazione della sorte di questi «discendenti degli aborigeni»32. È chiaro che, in un contesto globale e globalizzato di crescente perdita di conoscenza storica, accompagna-ta – grazie anche alla facilità di accesso ai media e alla diffusione del turismo – da un’intensificazione dei contatti con realtà diverse e lon-tane, la nostra capacità di decodificare e d’interpretare correttamente storie e culture diventa sempre più insufficiente.
Possiamo senz’altro parlare di «abusivismo folcloristico» e di «stalking del turista», come ha fatto a suo tempo il vicesindaco di Roma33, o descrivere sprezzantemente il grande «suq del Colosseo», come fanno spesso i giornali34; possiamo denunciare lo stravolgimen-to linguistico dei nuovi gladiatori, che parlano la «lingua infetta del turismo che degenera con le città d’arte italiane»35, e magari anche ironizzare, con una punta d’inconscio razzismo, sul fatto che questi figuranti «più che romani sono rumeni»36. Dobbiamo però contestua-lizzare questi fenomeni in un più ampio scenario di riassestamento a livello globale dei processi formativi ed educativi e del nuovo ruolo dell’edutainment nella costruzione del nostro rapporto con il tempo e lo spazio, ossia con la storia e le culture.
Troppo spesso tendiamo a rifiutare queste esperienze relegandole nell’ambito del kitsch. Si tratta invece, pur nella loro serialità, di espe-rienze che possono essere anche originali. Il legionario che ritaglia e lavora le sue scarpe da ginnastica in similpelle per trasformarle in san-dali romani compie una rifunzionalizzazione creativa che in qualche modo compensa l’appiattimento della commercializzazione.
Questi gladiatori della contemporaneità vivono, come tutti noi, le ansie e le paure della nuova «società dell’incertezza»37. Così qualche
32 F. Merlo, Gran suq Colosseo. L’antica Roma assediata dal kitsch, in «la Repubbli-ca», 14 marzo 2012, pp. 31-33.
33 L. Garrone, Via i questuanti mascherati dal Colosseo. Pronta una legge contro i centu-rioni, in «Corriere della Sera», Cronaca di Roma, 26 giugno 2010.
34 F. Merlo, Gran suq Colosseo, cit.; L. Larcan, Fori e Colosseo, basta bancarelle e legionari, in «la Repubblica», Cronaca di Roma, 29 marzo 2012.
35 F. Merlo, Gran suq Colosseo, cit.36 P. Brogi, Asterix e Obelix contro i centurioni di Roma, in «Corriere della Sera»,
Cronaca di Roma, 15 aprile 2012.37 Z. Bauman, La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna 1999.
205
anno fa hanno chiesto la creazione di un albo o di un registro ufficia-le, che desse loro una veste (o, meglio, una maschera) professionale. In rete si trova una testimonianza significativa di questa rivendica-zione identitaria. Un centurione ha spiegato davanti alle telecamere: «Siamo una figura storica inerente al Colosseo; vogliamo essere cataloga-ti… siamo un’attrazione»38. L’italiano è un po’ zoppicante, ma il senso è chiaro.
Il figurante prende inconsapevolmente atto della nuova dimen-sione «liquida» della società e rivendica un ruolo ibrido che è, al con-tempo, di attrazione e di figura storica. Si muove, insomma, tra leisure e culture, entertainment e funzione educativa: accetta e rivendica una di-mensione di edutainment. Al tempo stesso, però, reagendo alla disgre-gazione della vecchia società solida che assicurava contratti e identità forti, chiede di essere «catalogato», cioè di essere inserito in una strut-tura solida, come uno scaffale di biblioteca, che gli assicuri un’identità e soprattutto, come un libro, una collocazione precisa. Infine – ed è forse l’aspetto più inquietante – sollecita il pieno compimento del processo (già molto avanzato) di cristallizzazione e di folclorizzazione tu-ristica del Paese, in cui monumenti storici e attività in costume sono posti sullo stesso piano, come espressioni complementari di una se-rializzazione iconica che tutto riduce a una serie di immagini e di souvenir39. Del resto lo stesso Umberto Broccoli, sovrintendente ai beni culturali di Roma Capitale (come il Comune di Roma è stato ridenominato nel 2010), ha sostenuto che i centurioni non vanno de-monizzati, perché «fanno parte del folclore» della città40.
Il conflitto latente tra i figuranti e le istituzioni è però deflagrato in un vero e proprio scontro e per qualche tempo centurioni e gladiatori sono stati cacciati dal Colosseo. Questa grottesca guerra con le istitu-zioni ha assunto aspetti paradossali: abusivi, che esercitano un’attività marginale, controllata almeno in parte da organizzazioni malavitose41,
38 I centurioni occupano il Colosseo, in «Oggi», 4 aprile 2012, video http://www.oggi.it/video/notizie/2012/04/12/i-centurioni-occupano-il-colosseo.
39 M. Melotti, Oltre la crisi. Il turismo culturale tra riscoperta delle radici e lentezza rappresentata, in «La Critica Sociologica», n. 185, 2013, pp. 51-66.
40 Campidoglio, stallo sui falsi centurioni. «Ma se li autorizziamo, paghino le tasse», in «Corriere della Sera», Cronaca di Roma, 10 aprile 2012.
41 F. Merlo, Gran suq Colosseo, cit.
206
domandano un riconoscimento ufficiale; si dichiarano offesi da chi li accusa di esercitare attività ambulanti in maschera in aree tutelate e chiedono di non essere trattati come «maschere» ma come lavoratori; inscenano manifestazioni in costume e occupano il Colosseo al grido di «Fateci lavorare!»42. In sostanza, come ha ricordato la nota avvocata Giulia Bongiorno che li difende, rivendicano la piena dignità del loro lavoro43.
Con queste azioni il Colosseo muta statuto: da quinta teatrale per messinscene turistiche, da icona globale e sorta di gigantesco souve-nir, doppio inquietante e papà dei piccoli souvenir in vendita nelle botteghe e nelle bancarelle, ritorna a essere uno spazio identitario e un luogo di negoziazione politica, peraltro sempre in un contesto culturale postmoderno. Non casualmente durante le manifestazioni uno dei figuranti ha invocato il ritorno del loro prototipo: «Spartaco sindaco di Roma!», «Spartaco, riportaci al Colosseo!».
Un moderno gladiator for pictures invoca l’aiuto dell’ascendente an-cestrale che ha dato avvio al mito del gladiatore. Ma di che Spartaco si tratta? Il gladiatore ribelle degli storici antichi? Il leader del proletariato di Marx? Il rivoluzionario antimperialista di Rosa Luxemburg? Il pro-tagonista socialisteggiante e cristologico del film di Kubrick (1960) o, forse più realisticamente, quello, postpolitico e cripto-gay, del serial televisivo americano (Spartacus: Gods of the Arena, 2011) presentato in Italia proprio in quei giorni?
In una società liquida tutti questi modelli possono convivere e ibridarsi: i fenomeni e le esperienze perdono i loro contorni e si me-scolano in nuove complesse realtà. Soprattutto mancano le grandi certezze del passato. Le macrocategorie politiche o sono scomparse o sono diventate inadeguate. Viviamo in un mondo in gran parte già po-stindustriale e almeno in tendenza postnazionale. Gli aspetti tradizio-nali della «solida» mitopoiesi spartachista appaiono quindi troppo da-tati. La «scelta tra il bene e il male», come la definiva Rosa Luxemburg, poteva avere un senso ancora negli anni ’50, durante la guerra fredda,
42 M.E. Fiaschetti, I centurioni sfrattati non si arrendono e dal Colosseo marciano sull’al-tra Roma, in «Corriere della Sera», Cronaca di Roma, 3 giugno 2012.
43 M.E. Fiaschetti, Colosseo, Bongiorno avvocato dei figuranti: «Difendo il valore dei centurioni», in «Corriere della Sera», Cronaca di Roma, 18 luglio 2012.
207
quando uscì il romanzo di Howard Fast che ispirò il film di Kubrick (il cui sceneggiatore, Dalton Trumbo, non poté firmare il lavoro per-ché finito nelle liste di proscrizione del senatore McCarthy). Il nostro accostamento alla storia è sempre meno di carattere contenutistico e sempre più di tipo emozionale. Il passato è soprattutto un contenitore di emozioni, sensazioni ed esperienze, possibilmente appaganti. Ciò non significa però che una mitopoiesi forte, d’impronta ideologica e politica, sia scomparsa o debba scomparire; semplicemente si adatta al nuovo contesto.
Ecco allora che nelle strade di Roma può riprendere vita, magari sulla scia di un telefilm, uno Spartaco difensore dei diritti di questi nuovi «eroi» del precariato contemporaneo, invisibili a tutti, tranne che ai turisti. Poco importa che i nuovi ribelli indossino la masche-ra di quei soldati romani che lo Spartaco della storia (e del cinema) combatteva e che molti di loro probabilmente lo conoscano solo dal serial televisivo. L’eroe antico non è un «modello» politico, ma un’«immagine», utile a «tematizzare» una battaglia e ad attirare l’atten-zione dei media.
La storia è prima di tutto uno spazio di negoziazione: un enorme contenitore di esperienze, immagini, sensazioni, atmosfere cui fare riferimento per decorare o arricchire il nostro mondo. L’aspetto stru-mentale è presente, ma non primario; e in questo possiamo davvero vedere il passaggio dalla modernità alla postmodernità.
Lo Spartaco del racket dei gladiators for pictures riprende inconsape-volmente la mitologia spartachista e, al tempo stesso, forse altrettanto inconsapevolmente, celebra la nuova cultura televisiva del corpo e della sensorialità.
Lo Spartaco del serial televisivo incarna bene lo spirito della post-modernità. È un coacervo di emozioni esplosive che appaga perché risponde a un’esigenza diffusa; è un’illusione di forza e di sicurezza, ma anche un modello vincente di vita quotidiana: sesso, divertimento e, perché no, bellezza e cura del corpo.
In questa riproposizione del mito non viene «consumata» la storia, ma piuttosto l’atmosfera della Roma antica. L’aspetto più interessante è che questo modo emozionale (prepolitico o, meglio, postpolitico) di vivere il mito del gladiatore di fatto finisce per rivitalizzare un mo-dello profondamente radicato tanto nell’antico immaginario romano quanto in quello moderno di età romantica: il gladiatore come figura
208
di contatto tra i mondi e come essere che, perennemente sul ciglio della morte, sprigiona una speciale carica di vitalità e di sensualità. Le tensioni e le frustrazioni della vita quotidiana contemporanea vengo-no incanalate e neutralizzate. Il bisogno di ribellione viene appagato, in forma socialmente accettabile, dalla fruizione virtuale della violen-za del gladiatore, artefice di una violenza «istituzionale» senza con-trollo ma al tempo stesso legittima. Tuttavia il serial, nella sua patinata esaltazione dei muscoli, del sudore e del sangue, si mantiene tanto nel solco del tradizionale sguardo «granturistico» alla storia di Roma quanto in quello del film storico di qualità, in cui tutto è perfettamen-te ricostruito o per lo meno pensato e riesce addirittura a rappresen-tare una forma forte e convincente di living history e, in qualche modo, di edutainment.
Nel sito web possiamo trovare una delle ragioni del successo del serial sopra ricordato. Ogni elemento fa riferimento a forme forti di inclusione e di esperienzialità, che mescolano realtà e virtualità, storia e nuovi media, dimensione ludica e funzione identitaria: «Become a god of arena»; «Be the next Goddess of Capua»; «Join the Legions of Spartacus – become a fan on Facebook»; «Train and fight on Fa-cebook». Il mito di Spartaco è solo un elemento marginale di un’e-sperienza complessiva più ampia e articolata, al cui centro non c’è il guerriero antico, ma lo spettatore moderno, che consumando quel mito e immedesimandosi nelle sue storie di amore e di morte, di sesso e di violenza, entra a far parte di un sistema esperienziale che lo appaga e soprattutto lo fa sentire meno solo: parte, appunto, delle legioni di Spartaco. Il tutto però senza rischi per il sistema.
Cinema e politica, realtà e finzione si nutrono ormai delle stesse immagini. Assistiamo insomma a un’ibridazione e a una contamina-zione incrociata tra cultura dello spettacolo, immaginario cinemato-grafico e attività politica.
Un aspetto interessante di questo intreccio è rappresentato dal film italiano Benur (2012), diretto da Massimo Andrei: uno sguardo amaro e non retorico al nuovo mondo del lavoro, sempre più precario e sempre più invisibile, e alla condizione di vita di questi moderni gla-diatori. Un ex stuntman (scarto di quel mondo hollywoodiano che ha contribuito al successo dei gladiatori) si compra dal racket un posto di centurione davanti al Colosseo per cercare di sbarcare il lunario con le mance dei turisti; poi subappalta il posto a un immigrato clande-
209
stino di origine slava, che diventa, in modo molto romano, una sorta di schiavo. Il film naturalmente comprende diverse scene in costume al Colosseo e al Circo Massimo, con tanto di fuga in biga, secondo il modello del celebre Ben Hur (1959) di William Wyler. Durante le riprese sembra che gli attori siano stati confusi con i «veri» centurioni del Colosseo e che alcuni turisti abbiano chiesto loro di posare per una foto. Il corto circuito tra i diversi livelli della realtà è prosegui-to con la proiezione inaugurale, che prevedeva un red carpet con la biga del film e un’esibizione in costume del Gruppo Storico Romano (un’associazione che si è premurata di comunicare alla stampa di «non aver nulla a che fare con i cosiddetti gladiatori del Colosseo»)44.
Tuttavia l’intreccio forse più inquietante tra realtà e finzione ci-nematografica è rappresentato da un recente intervento di Russell Crowe, la star hollywoodiana che ha impersonato l’intrepido protago-nista del film Il Gladiatore di Ridley Scott (2000), interpretazione per cui ha ricevuto il Premio Oscar. Nel 2008, nel corso di una campagna di scavi lungo la via Flaminia, furono individuati i resti del mausoleo di Marco Nonio Macrino, il generale romano che ha ispirato il per-sonaggio del film. Nel 2012 la Soprintendenza, per mancanza di fon-di, ha annunciato l’intenzione di reinterrare il monumento. L’attore, indignato per la mancanza di rispetto verso quella tomba e stupito dall’incapacità italiana di valorizzare un sito diventato – grazie al film – di sicuro interesse turistico, grida allo scandalo, mentre l’American Institute for Roman Culture lancia una petizione on-line per salvare la tomba. Ecco allora che troupes televisive di tutto il mondo invadono l’area archeologica e i politici italiani denunciano quella «vergogna mondiale», obbligando il Ministero dei Beni Culturali a richiedere di corsa una dettagliata relazione sui fatti45. La politica mostra insomma la propria subalternità al potere della fiction e delle sue osannate ma-schere, mentre turismo e cinema affermano il loro nuovo ineludibile ruolo nelle pratiche di governance del territorio.
44 F. Montini, Red carpet tragicomico con il centurione Benur, in «la Repubblica», Cro-naca di Roma, 10 novembre 2012.
45 L. Larcan, Sos Tomba del gladiatore. Crowe «scatena» il web, «la Repubblica», Cro-naca di Roma, 11 dicembre 2012.
210
4. Totti, l’ultimo gladiatore
In questa proliferazione di gladiatori e di legionari ne emerge uno, che è diventato un modello per tutti gli altri. È il capitano della Roma, Francesco Totti, che nel 2001 ha effettuato un voto per la vittoria nel campionato della sua squadra: tatuarsi un gladiatore sul braccio de-stro. La Roma ha vinto e la promessa è stata mantenuta. Dalla spalla sino al gomito del calciatore ora campeggia la figura di un guerriero che, con elmo, gonnellina e aderente armatura, brandisce una daga o, meglio, un gladius. Da allora Totti è soprannominato «il gladiatore», nomignolo che si aggiunge ad altri, alcuni dei quali, come l’«ottavo re di Roma», ispirati alla storia della città di cui la squadra porta il nome. Il tatuaggio «gladiatorio», secondo alcuni, avrebbe portato a un’im-pennata delle vendite e dei noleggi del film di Ridley Scott, uscito nel 2000. È possibile che la distribuzione di quel film, che riscosse subito un grande successo di pubblico, abbia contribuito a rinverdire tra i più giovani l’interesse per il mondo romano, almeno nella sua dimensione epica e guerresca, suggerendo (a Totti per primo) questa investitura a difensore della romanità o, per lo meno, del popolo della Roma.
Il tatuaggio è di per sé una forma di mascheramento estremamen-te interessante: l’individuo non si limita a indossare una maschera, ma la incide indelebilmente sul suo corpo, finendo per assumerne in qualche modo il significato. L’immagine scelta, da metafora di un messaggio latente o di un sistema valoriale ed esperienziale, diventa sineddoche, come «parte» che mangia il «tutto». Il corpo del gladiato-re sul braccio di Totti non è un semplice elemento decorativo, ma un segno che, per chi lo porta e in questo caso anche per chi lo scorge, prima associa il tatuato al contenuto dell’immagine e poi lo trasforma nell’immagine stessa. Totti propone nella propria carne una rappre-sentazione di sé come combattente romano e finisce per incarnarla.
È possibile che nel caso di Totti, così come in altri, sopravviva qualche aspetto del valore rituale che in molte culture premoderne era attribuito al tatuaggio, come segno di un superato rito di passag-gio o di un’avvenuta iniziazione e quindi come indicatore dell’ingres-so in una classe di età o di individui speciali. La cultura contempora-nea ha trasformato il tatuaggio in un elemento decorativo di massa, che tuttavia marca l’adesione dell’individuo a un sistema di valori che, prima di essere quello specifico indicato dal tatuaggio, è, almeno in
211
Italia, quello generico del consumismo globale, che prevede anche il consumo del corpo o il suo utilizzo come una maschera.
Totti gladiatore rappresenta da questo punto di vista uno degli esiti moderni del processo di reinvenzione dell’antico, con uso del-la maschera gladiatoria a fine identitario e celebrativo. Ancora una volta possiamo misurare la distanza dalla retorica imperiale dei na-zionalismi tardoromantici e del primo ’900, in cui erano i sovrani e i dittatori che, in nome dello Stato, si travestivano da antichi guerrieri, a una narrativa postmoderna, in cui ad autocelebrarsi sono i singoli e privati individui. Nel nostro mondo, insomma, i calciatori (e altri simili personaggi) hanno preso il posto dei detentori del potere.
L’operazione di Totti, per quanto concettualmente sofisticata, non si fonda certo su studi di carattere filologico o storiografico e ha portato così a un interessante loop tra culture diverse, tanto che in rete furoreggiano immagini ibride, in cui, ad esempio, il «gladia-tore» romano Totti viene rappresentato nei panni – o meglio con l’armatura – dell’eroe greco Achille, protagonista del film Troy di Wolfgang Petersen, del 2004. Questo cortocircuito tra immaginari ribadisce la liquidità della cultura mediatica e dei contesti educativi e mostra l’interscambiabilità profonda nella cultura europea non solo contemporanea di civiltà greca e civiltà romana: la retorica roman-tica, così come la moderna rappresentazione cinematografica, fa di queste due civiltà mondi in costume difficilmente distinguibili, dove, in mezzo a bianche colonne e a imponenti monumenti, si combatte e si muore con sandali, toghe e tozze spade.
Il tatuaggio di Totti, vero nuovo eroe della contemporaneità e per questo anche modello comportamentale, ha portato naturalmente a forme di emulazione che hanno rilanciato alcuni dei principali sim-boli della storia romana. In rete si possono trovare immagini di com-plessi tatuaggi che incrociano il volto di Totti con legionari in armi dallo sguardo inquietante, lupe che allattano Romoli e Remi e bandie-re su cui campeggia la sigla SPQR. Sulla stessa linea l’International Tattoo Expo, tenutasi a Roma nel 2011, ha scelto come immagine del proprio manifesto uno scheletro mascherato da soldato romano, con elmo, scudo e un mantello rosso che sembra prodotto dagli schizzi di sangue del tatuato.
Prima che il dibattito politico sul centocinquantenario del Regno d’Italia, celebrato nel 2011, e su Roma Capitale portasse alla risco-
212
perta della storia, e in particolare della storia dell’antica Roma, è stato Totti a rilanciare con forza i simboli della romanità a livello nazionale e in contesti non necessariamente nazionalistici. Tuttavia non va tra-scurata la persistenza nella città di una cultura politica, per lo più gio-vanile, che si richiama esplicitamente al fascismo e utilizza i simboli dell’antica Roma in continuità con il modello mussoliniano. Scritte, in vernice rigorosamente nera, del tipo «Dal 753 a.C. padroni del mon-do» o manifesti con immagini del Colosseo, di fasci littori e di corpi virili in statuarie pose romane caratterizzano il paesaggio urbano.
Anche in questo specifico contesto il tatuaggio «romano» diven-ta uno strumento identitario di mascheramento, in cui dimensione individuale (si pensi alla moda della data di nascita tatuata in numeri romani), appartenenza civica, cultura politica e spesso anche passione calcistica s’intrecciano profondamente, confermando la liquidità va-loriale della società contemporanea.
Totti e i tatuati gladiatori-legionari suoi epigoni agiscono tutti sul medesimo piano iconico e si collocano nella medesima dimensio-ne storica: sono eroi dell’immaterialità e dell’etere, della liminalità e dell’eccesso. Tutto ciò ha rilanciato un forte senso di appartenenza alla cultura romana, che non si basa necessariamente su forme di coscienza storica d’ispirazione nazionalistica, ma scaturisce piuttosto dal mondo della cultura calcistica e del mito di Roma, intesa però come città della squadra.
Per par condicio possiamo analizzare anche un caso di maschera-mento femminile, in cui pure il mondo antico s’incrocia con la cultura contemporanea. Nel 2001, proprio come Totti, anche l’attrice Sabrina Ferilli fece un voto per la vittoria della Roma nel campionato di cal-cio, promettendo di spogliarsi in pubblico.
Il caso è piuttosto interessante: un’icona del cinema (realtà imma-teriale) si è proposta come un animale sacrificale (realtà materiale e sessualizzata) per il popolo. Con ciò ha preso forma una nuova im-magine ricorrente in rete: la Ferilli-Lupa. Una notevole interferenza tra miti e usi del mito. La Lupa (che, nella leggenda, avrebbe allattato Romolo e Remo) è il simbolo fondativo della città di Roma ed è an-che il simbolo identitario della squadra di calcio che ne porta il nome. Questo uso moderno decodifica il mito della Lupa, che torna a essere donna e recupera la sua dimensione sessuale, già individuata da alcuni autori antichi (fra cui Sant’Agostino, che parla espressamente della
213
Lupa come di una meretrice). La Ferilli-Lupa è una forma postmo-derna di living history: una rappresentazione del patrimonio immateria-le degli antichi.
Un uso simile e complementare del mito della Lupa compare in una recente campagna pubblicitaria di una nota marca di caffè, in cui, sullo sfondo di una fosca immagine dell’interno del Colosseo, compare una donna coperta solo da una pelliccia e in posa di lupa capitolina, che fissa con sguardo ferino lo spettatore. Anche in questo caso la lupa viene riproposta nella sua dimensione più sensuale come maschera del consumo, in cui sesso e caffè, nella logica della liquidità e della sensorialità pervasiva, appaiono come forme equivalenti.
Il gladiatore e la lupa costituiscono due maschere complementari della romanità e della sua mitopoiesi: Totti, maschio, guerriero, sim-bolo della forza e della violenza; la Ferilli, femmina, animale, simbolo della sessualità e del desiderio.
5. Le rievocazioni storiche e il potere di oggi
Ma veniamo ad oggi. Dove sono finiti i nostri gladiatori? Il bello della società «liquida» è che tutto è possibile. Nella liquidità totale ogni elemento si confonde, si trasforma, perde forma, ma a volte, sor-prendentemente, prende o riprende consistenza. Ecco dunque che, mentre il Comune e la Sovrintendenza archeologica di Roma muovo-no guerra ai figuranti in costume che stazionano davanti al Colosseo, lo stesso Comune di Roma rispolvera la festa per il Natale di Roma.
Con un mix di orgoglio localistico e di velleitarismo universali-sta, di populismo calcistico e di affermazione identitaria e politica, la giunta del (più o meno postfascista) sindaco Alemanno prima ha finanziato in grande stile il Compleanno di Roma e poi, nel 2012, ha organizzato le celebrazioni per il millesettecentesimo anniversario della battaglia di Ponte Milvio.
In una dimensione glocal (che afferma un’identità locale mentre accetta di fatto i nuovi modelli della cultura globale) Alemanno ha riscoperto la living history celebrativa di Guglielmo II e di Mussolini. Ciò non è naturalmente sfuggito alle ironie della stampa: «Ecco allora che il neosindaco di Roma Gianni Alemanno, durante il suo primo anno di reggenza, scende dal Campidoglio per festeggiare il Natale di
214
Roma con tutti gli onori del caso, passando in rassegna come un ge-nerale poco prima della battaglia, sotto un cielo plumbeo che faceva paura, le truppe di centurioni, di legionari, di gladiatori, di senatori e di ancelle posizionate al Circo Massimo»46. Ma, per forza di cose, il sindaco non ha potuto proporre la living history celebrativa che in una chiave ludica e turistica, che fotografa l’impostazione della politica nel nuovo contesto storico e culturale.
Negli ultimi anni, in parte proprio grazie all’intervento del sin-daco di formazione postfascista, il Natale di Roma ha gradualmente riacquistato un suo spazio. Si tratta di una celebrazione a livello locale e priva di ambizioni nazionali, che però raccoglie un crescente con-senso non solo tra i turisti stranieri (che, come abbiamo già ricordato, apprezzano e si attendono questo tipo di iniziative, nel quadro di una lettura folclorica della storia del nostro Paese), ma anche nella comu-nità locale e, fatto ancor più notevole, in una parte della comunità scientifica.
La rievocazione storica in Italia attraversa una fase delicata e com-plessa47. A lungo è stata abbandonata al volontarismo entusiastico di associazioni di appassionati, nel disinteresse pressoché totale delle istituzioni e degli studiosi. Poi il suo radicamento e il suo raffinamen-to in altri Paesi (soprattutto Regno Unito, Germania, Francia e più recentemente Spagna) hanno esercitato una benefica influenza anche nel nostro: è gradualmente migliorata la qualità delle pratiche e anche storici e archeologi hanno cominciato a utilizzarle o a offrire la loro consulenza. Musei e soprintendenze, in un contesto in cui la didattica e la comunicazione storica tradizionali hanno scarso appeal rispetto all’edutainment, propongono sempre più spesso installazioni o espe-rienze di archeologia sperimentale con living history, in forma diretta o virtuale. Le amministrazioni locali, consapevoli del successo della living history e assuefatte alla «cultura dei festival», nonostante le risorse finanziarie sempre più scarse, sostengono una pletora di iniziative in costume, la cui qualità dipende solo dal caso o dal buon gusto degli organizzatori. Per di più le periodiche polemiche sui gladiatori del
46 F. Longo, Ponte Milvio, 15mila euro per rievocare la battaglia di Costantino e Massen-zio, in «Paese Sera», 20 settembre 2012
47 M. Melotti, Turismo culturale e festival di rievocazione storica, cit.
215
Colosseo, che pure hanno ben poco a che vedere con le associazio-ni di rievocazione storica, contribuiscono ad alimentare le diffidenze verso la living history.
In altri Paesi questa attività costituisce da tempo uno strumen-to di divulgazione storica radicato nelle politiche del territorio. Un buon esempio è Tarraco Viva, il festival romano di Tarragona, isti-tuito oltre dieci anni fa per sostenere l’inserimento della città nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità gestita dall’Unesco48. Di-verse associazioni cercano inoltre di stabilire degli standard, con veri e propri regolamenti, anche per acquisire una propria legittimazione scientifica.
Non va peraltro dimenticato che il variegato mondo della living hi-story affonda le proprie radici non solo nell’archeologia sperimentale, ma anche e forse ancor più nell’accostamento postmoderno alla sto-ria, che prevede, come abbiamo detto, una forte componente senso-riale, emozionale e identitaria e un nuovo tipo di sapere, di cui diver-timento, apprendimento, divulgazione, affermazione di sé e attività collettive e di gruppo costituiscono parti inscindibili. Fare living history significa divertirsi, ma anche documentarsi e studiare; stare insieme con gli amici, ma anche comunicare ad altri il proprio sapere. In una parola, edutainment.
Nella capitale opera dal 1994 il già citato Gruppo Storico Ro-mano, oggi partner ufficiale di Roma Capitale. Il gruppo organizza ogni anno, in occasione del Natale di Roma, una serie di attività in costume che hanno costituito a lungo la parte più vivace, e forse an-che più interessante, di questa celebrazione. Peraltro, data la ricordata diffidenza che le circonda, queste attività non hanno mai ricevuto un chiaro ed esplicito sostegno da parte delle istituzioni, ma si sono imposte grazie alla pervicace passione di chi continuava a proporle e a realizzarle.
Il momento più spettacolare è senz’altro rappresentato dalla pro-cessione con centurioni, legionari, vestali e matrone che dal 2003 si
48 M. Seritjol, Tàrraco Viva: un festival internacional especializado en la divulgación histórica, «Mus-A: Revista de los Museos de Andalucía», n. 4, 2004, pp. 212-217; S. Sans, M. Seritjol, Tàrraco Viva. Jornades internacionals de divulgació històrica romana, Arola, Tarragona 2008; M. Melotti, Turismo culturale, cit.
216
snoda lungo la mussoliniana Via dei Fori imperiali: i bellicosi neoro-mani dell’Impero d’Italia hanno ceduto il campo ai pacifici figuranti che sfilano per turisti e curiosi. La nuova festa si è anche dotata di proprie «tradizioni», come la processione con la «Dea delle Acque» e un forziere che − come spiega nel sito della citata associazione Gianmarino Maurilio Colnago, in arte Gaio Cilnio Mecenate − custo-disce le «ampolle-cornucopie con le acque pure prelevate dalle sor-genti dei grandi fiumi fondatori della civiltà italica»: acque che costi-tuiscono un «patrimonio unico al mondo», perché «hanno plasmato la penisola e la nostra cultura arcaica». Le parole della pergamena rac-chiusa nel forziere sono piuttosto interessanti: «Soffermati e dedica un pensiero a questo patrimonio che ti appartiene […] Queste acque le ho raccolte nei luoghi dove originano e le dedico a chiunque si pon-ga in riflessione sul significato intrinseco della nostra comune matrice italica. Ora stimola la ricerca delle tue profonde radici culturali, ab-bine cura, tramandane il rispetto ai posteri: il fondamento del loro futuro è qui!»49. Di là dall’enfasi retorica, intesa a dare un po’ di colore «romano» al testo, s’intravede la coesistenza di elementi diversi: la passione per la storia, la dimensione politico-identitaria, il piacere del mascheramento storico-linguistico e l’attenzione all’aspetto educati-vo. La cerimonia ha anche un’innegabile valenza politica unitarista, contrapponendo implicitamente le acque dell’intera Penisola a quella della sorgente del Po, fulcro simbolico di un’altra invenzione politico-identitaria di moda sino a pochi anni fa. Tuttavia è evidente anche un intento didattico-formativo, che porta la mascherata nell’ambito dell’edutainment.
Questo impegno del Gruppo Storico Romano è testimoniato an-che dal piccolo museo didattico presente nella sede dell’associazione, dalle numerose attività didattiche di archeologia sperimentale e dalla «scuola di gladiatura», sorta di palestra per i gladiatori del secondo millennio, ma anche innovativo spazio di socializzazione offerto alla comunità civica.
Non va però dimenticato l’altro aspetto della living history, cioè l’intrattenimento, importante non solo per il pubblico, ma per gli stessi
49 Le Sacre Acque, in http://www.gsr-roma.com/museo/mecenate/acque.html (2008).
217
figuranti. Il tutto è a sua volta calato in uno scenario culturale che, per lo meno negli ultimi due decenni, ha avuto una forte base ludico-mediatica. Ecco allora «il concorso per la Dea Roma», che, come viene spiegato nel bando del 2013, «si prefigge di eleggere annualmente una ragazza che possa incarnare lo spirito di quella Dea, cara ai romani antichi che tanto amavano e ammiravano la loro città da vederla e raf-figurarla come una vera e propria divinità vivente»50. Naturalmente, sia per rispetto della storia antica, sia per moderna «correttezza politica», il concorso è aperto a tutte le «ragazze nate in Italia o qui residenti o di qualsiasi paese straniero che sia stato provincia o protettorato romano».
Lo stesso discorso vale per il resto della manifestazione, caratte-rizzata ormai da eventi improntati alla moda cultural-turistica cor-rente. Così, ad esempio, nel 2009 l’illuminazione dei Fori imperiali è stata seguita dallo spettacolo «Romagnificat – Dai Fori… la luce» («azioni visive con luci e proiezioni, musica e attori, ispirate alla cine-matografia»), mentre tra Ponte Sisto e il sottostante muraglione del Tevere campeggiavano «le installazioni dell’artista Kristin Jones ‘For-me di Lupa nel tempo’, una processione di cinquanta lupe di carte d’argento». Allo stesso modo nell’edizione del 2012 «un mosaico di visioni multiple, costruito armonicamente con la mole dei Mercati [di Traiano] attraverso ludiche invenzioni ottiche e percettive» disegnava «un percorso immaginifico» che delineava «il profilo di una Roma contemporanea, colta attraverso i momenti più densi del grande ci-nema italiano»51. È chiaro che, dai tempi austeri di Guglielmo II e di Mussolini, molta acqua è passata sotto i ponti del Tevere.
Negli ultimi anni il Natale di Roma ha conquistato uno spazio sempre maggiore. L’edizione del 2013, come riporta il sito del Grup-po Storico Romano, ha visto un corteo storico con la partecipazione di 1800 rievocatori appartenenti ad associazioni provenienti da dodici Paesi europei.
Ancora maggior attenzione ha suscitato però, nel 2012, la cele-
50 Dea Roma, in http://www.natalidiroma.it/Dea_Roma/Info_dea2012.html (2013).
51 Natale di Roma: proiezioni di luci e colori sui Mercati di Traiano, in «Roma Today», 21 aprile 2012 (http://www.romatoday.it/eventi/fuochi-natale-di-roma-2012-pro-iezioni-via-dei-fori-imperiali-21-aprile.html).
218
brazione dell’anniversario della battaglia di Ponte Milvio (312 d.C.), in cui Costantino sconfisse Massenzio. «La data», ha spiegato il sindaco Alemanno, «rappresenta un passaggio epocale, non solo per la città di Roma, ma per l’intera storia del cristianesimo, inteso come radi-ce profonda dell’identità e della civiltà europea»52. Ancora una volta emerge un uso dichiaratamente politico della storia, che recupera il nazionalismo d’inizio secolo, sia pur trasceso in chiave europea. Il sindaco lo ha definito un «avvenimento troppo importante nella sto-ria dell’umanità», da ricordare in modo «non semplificato e leggero», anche se «improntato a rigore, serietà e sobrietà»53.
Proprio il ridimensionamento di molti eventi pubblici, che ca-ratterizza l’attuale fase politico-culturale di crisi e di austerità, marca un’ulteriore differenza rispetto alla retorica celebrativa di anni più o meno lontani. La grande sfilata in costume inizialmente prevista è stata sostituita da un evento più contenuto (denominato In hoc signo vinces), in un’area non centrale: la ricostruzione di un castrum a Saxa Rubra, alcuni incontri con autorevoli studiosi e altre attività curate dall’associazione SPQR, «ferratissima sul tema», come si legge nel sito web dell’even-to, e di riconosciuta competenza, attestata dalla sua collaborazione «con importanti canali televisivi». Questa associazione ha simulato la battaglia, presentandosi «bardata di tutto punto, con costumi e armi dell’epoca perfettamente riprodotti […], secondo un modello didat-tico diffuso in molti Paesi europei, a cominciare dall’Inghilterra»54.
L’impostazione orientata all’edutainment è evidente. Va però sotto-lineato il richiamo alla televisione, che sembra essere ormai subentra-ta al mondo scientifico nell’attribuzione di autorevolezza.
A ciò si aggiunge la funzione specifica svolta dal cinema, sin dall’i-nizio del ’900, nella costruzione dell’immaginario visuale connesso alla civiltà romana, nonché lo stretto rapporto che esiste a Roma, gra-zie a Cinecittà (inaugurata da Mussolini nel 1937, nel giorno del Na-tale di Roma), fra le grandi case cinematografiche che producono film
52 Ponte Milvio, celebrazioni per i 1700 anni della battaglia, in http://terpag.blogspot.it/2012/10/ponte-milvio-celebrazioni-per-i-1700.html (2012).
53 Anno 312, Costantino vince a Ponte Milvio. Il Campidoglio celebra l’anniversario, in «la Repubblica», Cronaca di Roma, 25 ottobre 2012.
54 In hoc signo vinces: dopo 1700 anni Roma rivive la battaglia fra Costantino e Massen-zio, in http://www.eventinelxx.it/in-hoc-signo-vinces/ (2012).
219
in costume, i laboratori artigiani della città, il mondo «sommerso» delle comparse e, più recentemente, anche le associazioni di rievoca-zione storica. Si è insomma costituito un sistema di contaminazioni reciproche in cui Hollywood e Cinecittà si ibridano con la ricerca di storici e di eruditi e la fiction dà consistenza visiva al lavoro degli ap-passionati, a loro volta chiamati a «dar vita» alla fiction. Del resto, non dimentichiamolo, nessuno ha mai visto un «vero» gladiatore.
Il sito dell’associazione SPQR documenta la seria e variegata at-tività di questo gruppo, che rappresenta un buon esempio non solo di edutainment, ma d’imprenditoria innovativa rispondente alle mutate esigenze del mercato culturale55. Giorgio Franchetti, suo presidente, offre un quadro del lavoro del gruppo: «I nostri atleti hanno iniziato con un lungo periodo di ‘gestazione’ passato a fare ricerche di biblio-teca, di testi antichi, di fonti letterarie e iconografiche, per arrivare a disegnare quelle classi gladiatorie che erano proprie del periodo in questione, lasciando davvero poco spazio alla fantasia o alle remi-niscenze hollywoodiane. Per quasi due anni ci si è documentati e si sono studiate queste fonti e intanto, per due ore a settimana, ci si allenava per prendere dimestichezza con l’uso di equipaggiamenti a noi sconosciuti […]: un percorso di archeologia sperimentale, in cui, partendo dai manufatti (nella quasi totalità dei casi reperti di Pompei ricostruiti per peso e misure), si doveva capire come venivano usati, dal momento che non è arrivato sino a noi alcun manuale di combat-timento gladiatorio dell’epoca»56.
Anche questo gruppo vanta un Museo del Gladiatore e una Scuo-la di Gladiatura, anzi una Historical Gladiators School, «aperta alle donne», che rilascia persino un diploma. La presentazione in inglese ne rivela l’orizzonte anche turistico, mentre il fatto che si specifichi che questa scuola sia «the only one in Rome» apre uno spiraglio su un mondo di associazioni, tutte in cerca di legittimazione ma anche in competizione fra loro.
55 Ludus Magnus, http://www.ludusmagnus.info (2012).56 S. Todisco, Intervista all’associazione culturale SPQR, in «Antika Notizie», 23
settembre 2011, in http://notizie.antika.it/0010554_intervista-all-associazione-culturale-s-p-q-r/.
220
6. Dalla festa alla farsa. La maschera delle élites
Lo scenario che ha caratterizzato la politica italiana degli ultimi vent’anni è quello del cosiddetto «berlusconismo»: la principale for-ma assunta in Italia dalla politica postmoderna, con il suo mix di pubblico e privato, cultura e mercato, seriosità e divertimento, pro-messe mirabolanti e populismo spicciolo, immaginario televisivo e mobilitazioni di massa, allettamento commerciale e compiacimento sessuale e sessista.
Una delle sue espressioni più interessanti e significative è stata la festa organizzata nel 2010 al Foro Italico di Roma da alcuni espo-nenti della Regione Lazio: una festa «privatissima», ma organizzata da figure istituzionali, che ha posto in evidenza l’interconnessione, tipicamente postmoderna, della sfera politica (nella forma, in questo caso, della cena postelettorale) con quella ludica e scanzonata delle attività in maschera o in costume.
Un servizio fotografico, voluto dall’organizzatore (l’allora vice capogruppo del PDL alla Regione Lazio, Carlo De Romanis: nomen omen), ha immortalato lo spirito di quella festa, poi balzata al disonore delle cronache: uomini e donne vestiti da guerrieri greco-romani, con elmi e calzari; sensuali ancelle che porgono grappoli d’uva a giovani che brandiscono bottiglie di champagne mollemente adagiati in bian-che tuniche sulle scalinate, maschi en travesti con enormi parrucche bionde, ragazze sorridenti col capo incoronato d’alloro, uomini con maschere di maiale o di minotauro57.
L’antichità greca e romana non pensata più come un modello po-litico e organizzativo (siamo molti lontani dall’idea ispiratrice della fortezza di Saalburg o del mito di Spartaco), ma come un repertorio tematico e sensoriale per esperienze di tipo leisure. Ancora una volta è un’antichità dall’autenticità «relativa», in cui tutto si confonde, esat-tamente come nel Totti a un tempo gladiatore romano e guerriero greco. La festa di De Romanis è in effetti una celebrazione della figu-ra di Ulisse, in cui però i centurioni romani si mischiano ai compagni dell’eroe greco e alle creature zoomorfe dell’Odissea. Costumi e ma-
57 M. Favale, Ancelle e mojito, De Romanis festeggiò vestito da Ulisse, in «la Repubbli-ca», 19 settembre 2012.
221
schere non sono molto dissimili da quelli dei figuranti del Colosseo e, nel migliore dei casi, provengono dai negozi di forniture cinema-tografiche. Ancora una volta politica, cinema e cultura popolare si incrociano e si ibridano.
Probabilmente l’elemento più «romano» di simili feste è costitu-ito, più che dalla tematizzazione storica, dal loro impatto mediatico. Volendo stabilire un confronto con le attività leisure della classe di-rigente romana dell’età imperiale, l’elemento comune non è tanto il degrado in sé, che pure ha suscitato la legittima reazione dell’opinione pubblica, quanto l’ostentazione ludica di quel degrado. La festa «or-giastica» in costume ha la duplice funzione di affermare un’alterità eti-ca e comportamentale, che è anche un’asserzione di status, e di creare meraviglia e stupore: il potere che incanta e sorprende.
La stampa ha parlato in proposito di una cultura da «basso impero»58, innegabilmente contigua allo spirito da panem et circenses con cui fino a tempi recenti venivano offerti molti eventi pubblici e mediatici. Possiamo però pensare anche alle «cene eleganti» orga-nizzate dalla classe dirigente romana o dalla famiglia imperiale nelle lussuose residenze estive di Baia o di Sperlonga, con i loro ban-chetti a tema, allestiti in sale adorne di statue ispirate alle vicende di Ulisse.
I festini della Regione Lazio rappresentano un simbolico punto di arrivo della cosiddetta «società del divertimento», espressione del contesto culturale postmoderno in cui di fatto siamo ancora inseriti. Al tempo stesso vediamo riemergere il legame sotterraneo che unisce in modo diacronico e sincronico la comunicazione politica delle élites nel corso dei secoli così come le reazioni a questo tipo di manifesta-zioni. Il giudizio severo (e di fatto sprezzante), espresso dalla stampa italiana, non è molto diverso dai commenti severi di quella storio-grafia senatoria che, nei primi secoli dell’Impero, criticava il nuovo potere e ne denunciava i comportamenti.
Amaramente Marc Fumaroli legge la società contemporanea come un mondo in cui «l’impero attuale può permettersi di fare a meno degli schiavi e può allietarsi con i videogiochi» e «un manipolo di principi e di oligarchi ricchissimi vive pubblicamente alla stregua
58 S. Regazzoni, Basso Impero, in «Il Secolo XIX», 29 settembre 2012, pp. 1, 4.
222
dei falsi dèi antichi, servendo da umilianti modelli a una massa ster-minata di spettatori, mascherati di proposito da figuranti con tanto di peplo»59. Un mondo insomma in cui il potere – proprio come nel-la stampa che ritrae Guglielmo II alla cerimonia di Saalburg – non avrebbe neppur più bisogno di indossare una maschera, lasciando il travestimento al popolo.
Lo spirito della festa sopra citata è certamente molto diverso da quello della festa di Saalburg, ma la funzione è paradossalmente la medesima: il potere si maschera per celebrare sé stesso e la propria di-versità dal resto del mondo. Qui però è un’alterità giocosa e irridente, che non richiede la retorica istituzionale di Guglielmo II, di Mussolini o, in piccolo, di Alemanno. Il potere in maschera accetta addirittura di degradarsi con travestimenti da maiale. Ma, a differenza del Carneva-le, in cui la maschera degradante attesta e garantisce la temporaneità del ribaltamento dei ruoli sociali, qui la maschera rivela il vero volto del potere e celebra una concezione precisa della vita politica.
È in simili contesti che la maschera ritrova la sua straordinaria efficacia. Con il linguaggio ludico della nuova cultura, recupera la sua funzione primaria di formidabile strumento di demistificazione del potere.
59 M. Fumaroli, Spartaco. La rivolta di ieri e gli schiavi di oggi, in «la Repubblica», 16 marzo 2011.
Fig. 7 Guglielmo II pone la prima pietra della fortezza di Saalburg (da “La Tribuna Illustrata della Domenica”, 21 ottobre 1900).
Fig. 8 I monumenti riprendono vita. Attività di living history dell’Associazione Civiltà Romana.
Fig. 9 Marcia di legionari per il Natale di Roma (foto Camperclub4 Chieti).
Fig. 11 (a sinistra) Maschere o monumenti? I nuovi legionari del Colosseo (foto di Marxiano Melotti).
Fig. 10 (sopra) Natale di Roma tra spettacolo e divulgazione. Attività del gruppo storico Pactum Roma 753.