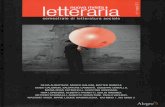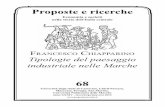Infiniti pensieri italiani. Paesaggio e ideologia nel Deserto della Libia di Mario Tobino
M.Boriani, A.Cazzani, le infrastrutture viarie storiche monumenti nel paesaggio e per il paesaggio.
Transcript of M.Boriani, A.Cazzani, le infrastrutture viarie storiche monumenti nel paesaggio e per il paesaggio.
MAURIZIO BORIANI, ALBERTA CAZZANI
L’ingegneria stradale prima della V.I.A.: le infrastrutture viarie storiche (XVIII-inizio del XX secolo), monumenti nel paesaggio e per il paesaggio.
Tra tutte le opere pubbliche, le grandivie di comunicazione rappresentano quel-le di maggiore complessità e impegno,non solo dal punto di vista tecnico-costruttivo ma anche da quello politico-amministrativo. Non si tratta infatti solodi superare erti pendii o larghe vallate, discavalcare grandi fiumi o di perforaremontagne: occorre anche governare gliespropri dei terreni necessari, definireaccordi con le popolazioni insediate lun-go i percorsi, impiegare con profitto unagrande quantità di forza lavoro.
Non è un caso che, anticamente, i pun-ti di partenza e di arrivo delle grandi stra-de erano segnalati da opere celebrative(archi monumentali, cippi, lapidi, ecc.)che esaltavano la difficoltà dell’opera re-alizzata, il suo valore civile (e militare) ela lungimiranza politica del suo commit-tente. Anche alcuni punti di particolareimportanza (i valichi, le gallerie, i ponti)erano spesso sottolineati da monumenti,iscrizioni, colonne votive, per celebrarel’opera realizzata, per orientamento e perprotezione del viaggiatore. Una volta ter-minata, la strada doveva essere tenuta inbuono stato, resa sicura, servita da fun-zioni di supporto al viaggiatore: casecantoniere, ospizi, stazioni di posta, al-berghi, magazzini e l’organizzazionelogistica conseguente. E’ naturalmentenei territori di più difficile accesso, lemontagne e, in particolare, le Alpi, che leopere di ingegneria stradale si fanno più
impegnative e che le strutture logistichedi supporto sono più frequenti e meglioorganizzate: numerose incisioni docu-mentano l’arditezza di muri di sostegno,ponti e gallerie e la presenza lungo la stra-da di ospizi e ricoveri. Si tratta di stampedi cui vi era grande richiesta da parte deiviaggiatori del Grand Tour, soprattutto apartire dal XVIII secolo : in esse si puòleggere il significato che i contempora-nei davano alle strade e alla loropercorrenza, nonché l’evoluzione di talisignificati nel corso del tempo e in rap-porto alla natura della strada illustrata.
Le immagini più antiche e, in genere,quelle che illustrano i tracciati stradali an-tecedenti alla rivoluzione stradale pro-mossa in età napoleonica, si soffermanospesso a documentare la difficoltà e lapericolosità dei percorsi: piccoli ponti inpietra senza sponde o precarie passerellein legno che scavalcano profonde forre,stradine a strapiombo su ripidi pendii,incidenti di viaggio. Il paesaggio apparein esse, più che grandioso, spaventoso.Descrivendo l’antica strada del SempioneGeorges Mallet scriveva: “Questa stradaera così disagevole che era poco frequen-tata dai viaggiatori quando io la feci nel1785. Le persone che come Rousseau,amano avere le vertigini, non avevanoaltro da fare allora che fare la strada delSempione a staffetta per soddisfare il lorogusto”1
Forte è il contrasto tra i paesaggi ri-
impaginato.p65 02/01/2006, 15.471
denti del fondovalle, popolati da operosicontadini e quelli della via dei monti: im-boccature di valli nebbiose, che fannopresagire niente di buono, ripide salite inluoghi deserti e pericolosi. Le immaginimostrano una natura ostile, dalla quale sirifugge e nella quale le opere degli uomi-ni sembrano insignificanti e precarie.
Le cose cominciano a cambiare quan-do con le guerre napoleoniche, portatesu tutto lo scacchiere europeo, si richie-de una radicale riforma del sistema dellecomunicazioni stradali, soprattutto nelsettore occidentale delle Alpi, a sostegnodei collegamenti con l’Italia. E’ signifi-cativo che Napoleone, nell’ordinare la re-alizzazione della nuova strada delSempione, scrive: “Le chemin depuisBrigue à Domo d’Ossola sera rendupraticable pour les canons”2
Esemplare illustrazione del nuovo at-teggiamento è riscontrabile in una cele-bre opera descrittiva dei lavori svolti alSempione e del nuovo e moderno itine-rario stradale, il Voyage pittoresque deGenève à Milan par le Simplon, edito aParigi per i tipi di P.Didot l’Aîné nel 1811.
Le immagini della nuova strada, so-prattutto nel tratto alpino, appaiono quiben diverse rispetto a quelle che illustra-vano gli itinerari di antico regime: unacarreggiata ampia, costeggiata da para-carri disposti a distanze regolari, pendiilievi e, soprattutto, l’esaltazione dell’ope-ra di ingegneria: monumentali muri di so-stegno, ponti dall’apparenza ben solida,ampie gallerie. Non più la piccolezza del-l’opera dell’uomo nei confronti della na-tura, bensì la celebrazione di una Naturapiegata ad essere umana grazie alla scien-
za e alla tecnica.A proposito dei lavori per una delle
più importanti opere realizzate sul ver-sante italiano del Sempione, la galleriadi Gondo, scrive ancora Mallet: “Ci im-maginiamo quello che doveva provare ilviaggiatore o l’abitante dei villaggi vici-ni che la sorte conduceva di notte in que-sti luoghi; camminando in una valle de-serta, all’improvviso il rumore dello scal-pello viene a mescolarsi con quello deltorrente; uomini sospesi alle rocce le mi-nano alla luce delle torce e il fracasso del-
le esplosioni della polvere da sparo fa ri-suonare le eco moltiplicate di queste mon-tagne. Io penso che, nel prossimo poemaepico, l’autore farà entrare il suo eroe agliinferi attraverso la valle di Gondo”3.
Nicolas Céard, l’ispettore in capo dei
Fig.1 – Il ponte di Banten (J.J. Schuechzer,1708). L’antica strada sovrastata dalla immen-
sità di una natura ostile
impaginato.p65 02/01/2006, 15.472
lavori del Sempione, era perfettamenteconsapevole che l’opera eseguita non do-vesse essere giudicata solo dal punto divista della tecnica ingegneristica: così ilPonte di Crevola è aussi etonnant quepittoresque, il Ponte sul torrenteBougnane è definito considérable e, ingenerale, l’Ecole des Ponts et Chausséesha contribuito potentemente ad “abbelli-re la Francia e a facilitare le sue comuni-cazioni”4.
Il nuovo tracciato doveva infondere si-curezza: lungo il lago Maggiore “un muroin conci regolari…delimita in tutta la sualunghezza la strada verso il lago; questostesso muro è coperto e coronato da la-stre in granito a spacco perfettamentetagliate…che hanno anche il vantaggiodi rassicurare i viaggiatori”5. Allo stessomodo, lungo la strada costiera del lagoLemano viene realizzato “un bel parapet-to, per prevenire gli incidenti e tranquil-lizzare il viaggiatore, che … non può per-cepire che cammina su di una cornice apicco sul fondo di un lago profondo 992piedi”6
Nella sua memoria Céard non trascu-ra neppure il fatto che il nuovo percorsoconsente di ammirare il paesaggio: “dal-la bella terrazza che la nuova strada for-ma in questi luoghi, è in vista l’altra co-sta del bel lago di Ginevra …Questa vi-sta presenta degli aspetti naturali più gra-vi, più severi, ma non meno magnifici diquelli del lago Maggiore…”7 L’ingegne-re era peraltro consapevole dell’impor-tanza del compito affidatogli: nel suo pro-getto “L’arte doveva fare tali sforzi inquesti luoghi, per non essere troppo in-dietro rispetto alla natura, che sembrava
qui avervi a piacere riunito tutto quelloche essa possiede per incantare gli oc-chi”8. Il Voyage pittoresque registra ilnuovo significato della via del Sempione:accanto alle opere di ingegneria stradalesono documentati i paesaggi che la stra-da attraversa e che, proprio grazie allastrada, possono essere osservati nella loromaestosità in tutta sicurezza. È evidentenelle vedute del Voyage il segno di quel-l’estetica del sublime e del pittoresco, chetanto aveva influenzato il pensiero delXVIII secolo, e di cui la nuova strada con-sentiva ora di fare esperienza anche almeno impavido e al più comodo dei viag-giatori. Le vette più inaccessibili, le gran-di e impetuose cascate, i ghiacciai dallenevi eterne diventano così soggetti pre-feriti della pittura di paesaggio, in aggiun-ta alle amene vedute dei borghi e dei cam-pi di fondovalle, delle rive dei laghi odella pianura.
Il contrasto tra l’ambiente maestosoed aspro della montagna, sublime appun-to, e la quiete pacifica della pianura, chefinalmente si raggiunge dopo il lungocammino, costituisce proprio una delleesperienze più ricercate dai nuovi viag-giatori, i primi touristes, che percorreran-no il Sempione in tutta sicurezza e conuna nuova attenzione per il paesaggio:“La natura non offre contrasto più evi-dente di quello che attende il viaggiatoresulle alture di Crevola: ai passaggi piùstretti, alle valli più selvagge, agli aspettipiù spaventosi, al rumore assordante diun torrente impetuoso, succedesubitamente una vasta piana, ben colti-vata, disseminata di abitazioni…una cal-ma, una sorta di tranquillità magica…”9..
impaginato.p65 02/01/2006, 15.473
Nelle vedute che illustrano il Voyagepittoresque appare evidente come la stra-da non sia più inserita nel paesaggio pernecessità, costretta ad adattarsi agliimpervi pendii e al salire e scendere divalli e di crinali: qui la strada fa essa stes-sa paesaggio e, al contempo, consente difruire in comodità e sicurezza dei paesag-gi che percorre. Lungi dai progettistil’idea di inserirsi a basso impatto nel pa-esaggio: all’opposto, si tratta di costruireun nuovo e più appassionante paesaggioattraverso l’esaltazione del dominio del-l’uomo sulla natura, ormai consentitodall’avanzante rivoluzione industriale.
Ci sarà chi addirittura rimpiangerà ilvecchio percorso, essendo il nuovo trop-
po facile e sicuro: “le rocce dellaMeiellerie, che si incontrano a metà cam-mino tra Evian e Saint-Gingolph, hannoperso, a seguito dei lavori per la nuovastrada, ogni loro valore pittoresco”10.
Pochi anni dopo la conclusione dei la-vori per il Sempione tocca alla restaurataamministrazione austriaca della Lombar-dia intraprendere la realizzazione di duenuove grandi vie alpine: le strade delloSpluga (1818-20) e dello Stelvio (1820-25). L’impresa, affidata all’ingegner Car-lo Donegani, non era da meno di quelladel Sempione, anche se qui la strada fudimensionata su di una larghezza di soli5 metri rispetto agli 8 della via francese:si trattava infatti di valicare due passi ben
Fig.2 – Il ponte di Crevola (R. von Luternau, 1805). La nuova strada napoleonica si impone con lasua monumentalità nel paesaggio
impaginato.p65 02/01/2006, 15.474
più alti, rispettivamente 2117 e 2759 metris.l.m. contro i poco più di 2000 delSempione.
Per raggiungere comodamente da Mi-lano i due itinerari si sarebbe per di piùresa necessaria l’apertura di una nuovastrada lungo la sponda orientale del lagodi Como (1824-31), per ampi tratti carat-terizzata da rocce scoscese a picco sul-l’acqua.
Anche in questo caso le nuove vie ap-parvero ai contemporanei audaci espettacolari al contempo, e anche in que-sto caso non mancarono descrizioni en-tusiaste e un gran numero di stampe chedivulgarono presso il grande pubblico siale opere eseguite che i paesaggi che esseattraversavano e contribuivano alcontempo a creare.
E’ interessante rileggere quanto scri-ve Splendiano Morselli a proposito dellastrada tra Lecco e Colico vista dal lagodurante la sua costruzione: “Noi passan-do in barca, cominciammo a veder segna-ta, alta un metro sopra la maggiore pie-na, una linea bianca, che seguitando an-che dove la rupe scendeva a picco…cifaceva sorridere increduli …si spiana, sicolma, si taglia, si fora. La giornataconsumavasi a fare buchi da mine, a ca-ricarle: venuta la sera brillavansi: e losbigottito navigante e il lontano abitatorevedevano, udivano centinaja dicolpi…romper le tenebre e il silenzio”11.Anche in questo caso è esaltata l’operadell’ingegno umano, capace di forzare laNatura e di piegarla ai suoi bisogni. Pa-role ancora più entusiastiche si spende-ranno per le strade dei passi montani. CosìDe Goehausin descrive la via dello Spluga
in una lettera del 1821, indirizzata al Pre-sidente del Governo Conte di Strassoldo:“…Col progredire del cammino crescesempre nel viaggiatore la sorpresa di que-sta strada meravigliosa nella cui esecu-zione difficoltà di ogni sorta si ebbero asuperare, ma quando si giunge al comu-ne di Spola la sorpresa diventa stupore.Un erto monte si affaccia al fianco destroche presenta il meraviglioso aspetto diuna sovrastante strada fatta a replicatiadirivieni, sostenuti da forti muri tutti
murati da sbarre da lato dei sottopostiprecipizi, e protetta da tre gallerie fab-bricate nel monte nei luoghi minacciatidalle valanghe”12.
Quello che però è significativo è tut-
Fig.3 – La cascato di Pianazza – Passo delloSpluga (J. Siegfried, 1840 circa). Il tracciato
stradale a ripidi tornanti è contemporaneamenteuna spettacolo degno di osservazione e un balco-
ne panoramico sul paesaggio alpino
impaginato.p65 02/01/2006, 15.475
tavia anche un altro aspetto della realiz-zazione di queste opere: il ruolo che essegiocano nel paesaggio e la consapevolez-za di questo già presente sia nei progettistiche nei primi viaggiatori che le percorre-vano. Continuando la descrizione dellavia lungo il lago di Como, Morselli scri-ve: “Dapertutto la fiancheggia il parapet-to, e volevasi anche orlarla di alberi, se ilmilitare non si fosse opposto. Però da trat-to a tratto fecero belle piazzette, con al-beri di diverse essenze; poi spesse fonta-ne; parapetti, tombe, ponti, il tutto è del-la costruzione più studiata: poi qua unavanzo di torre, lasciato in piedi per l’ef-fetto pittoresco: là le gallerie disposte in
modo che, come un cannocchiale, guidi-no l’occhio a fissare in lontananza un vil-laggio, un santuario, una vallea; le fine-stre che vi sono spalancate spianano in-nanzi veri panorami…”13. Ancora piùesplicito il commento che GiovanniDonegani, riporta a proposito delle ope-re progettate dal padre in corrispondenzadel passaggio dei Bagni di Bormio lungola strada dello Stelvio: “Il complesso diquesto lavoro presentasi, prima di giun-gervi, in sempre variate fogge. Or scorgesiprospetticamente il ponte, e non può com-prendersi né dove esso comunichi, né diqual strada sia in continuazione, chevedesi soltanto a ricomparire a qualche
Fig.4 – La valle dell’Adda dall’uscita della galleria di Bagni di Bormio (J.J. Meyer, 1831). Anche inquesto caso la strada costutiosce un nuovo punti di osservazione privilegiato sul paesaggio
impaginato.p65 02/01/2006, 15.476
distanza dopo il costone: ora vedesi mez-za apertura di galleria, ma non si com-prende qual forma e qual direzione essaabbia: ora nuovamente occupata la por-zione di apertura che scorgevasi, solo nericompare una porzione sull’altrolato…Questo variar d’aspetto nel mutardi posizione è prodotto da un masso dirocco piramidale, isolato, che trovasi allasinistra poco prima dell’imboccatura del-la strada. Quando però giungesi sulla di-rezione del ponte, scorgesi in linea rettala galleria in oscure pareti, e la parte prin-cipale di strada successiva sino al risvol-to, ossia al principio della valle delBraulio”.14 Con acume Ornella Selvafoltaparagona questa descrizione dell’operadel Donegani alla prassi del progettopaesistico del parco all’inglese, che po-chi anni prima Ercole Silva aveva divul-gato in Italia15.
Puntualmente, come per il Sempione,pittori ed incisori si prenderanno l’inca-rico di illustrare le nuove spettacolari stra-de: tutti i punti più significativi, sia perl’arditezza delle opere eseguite, sia perla magnificenza dei paesaggi attraversatie soprattutto osservabili dalla strada sa-ranno documentati e divulgati in tuttaEuropa, contribuendo in modo decisivoalla fama di questi itinerari alpini, degneporte all’agognato paesaggio mediterra-neo che i viaggiatori del Grand Tour an-davano ricercando16: innumerevoli rela-zioni e guide di viaggio, entusiasticamen-te descrivono l’itinerario compiuto. Unoper tutti il commento allo Spluga cheRodolphe Toepffer riporta nella sua ce-lebre guida: “…lo Spluga compete, datutti i punti di vista, col Sempione ed ha
forse il sopravvento su di esso per i suoimagnifici contorni e per le sue immensegallerie; è, ci sembra il valico degli arti-sti. Sul versante italiano, i luoghi non fan-no veduta, ma quadro e si crederebbe, inmille località, che Poussin abbia visitatoquesti luoghi”17.
I grandi passi alpini del Sempione, del-lo Spluga e dello Stelvio costituiranno ilprototipo di un approccio dell’ingegne-ria stradale di montagna che sarà in gra-do di reggere ai traffici per tutto il XIXsecolo e per alcuni decenni del XX (unamodernizzazione della strada delSempione avverrà solo nel 1959; moltitratti delle strade dello Stelvio e delloSpluga sono ancor oggi quelli tracciati dalDonegani). Ad altri compiti si dedicheràperaltro, nelle Alpi, l’ingegneria strada-le: la costruzione dei grandi trafori, gra-zie ai quali si sono di molto semplificati icollegamenti tra i due versanti, ma si èbanalizzato un tragitto un tempo orribilee ricercato al contempo. Le strade di pas-so si sono oggi ridotte a percorsi turisticio a collegamenti locali, mentre i grandiflussi di merci e di veicoli sono supportatidalle gallerie autostradali e ferroviarie.Resta tuttavia l’orgoglio per la grandeopera stradale ottocentesca, come testi-moniano le innumerevoli cartoline postali(le eredi povere delle antiche stampe) chedocumentano, in vedute aeree, il susse-guirsi dei tornanti. Sintomatica, sino a nonmolti anni fa l’esaltazione dellamotorizzazione privata che, grazie allastrada, consente a chiunque di raggiun-gere le alte quote dei passi alpini: in al-cune cartoline degli anni ’60 del ‘900 èritratta la fila ininterrotta di automezzi che
impaginato.p65 02/01/2006, 15.477
risalgono lentamente i tornanti dei pas-si montani, immagine considerata degnadi essere immortalata ed inviata a pa-renti ed amici per dire, con malcelatoorgoglio: ho valicato anch’io il grandepasso.
Nel periodo tra le due Guerre, conlo sviluppo della motorizzazione priva-ta, si assiste in Italia ad una nuova fasedel processo di modernizzazione del si-stema stradale, in particolare nelle zoneappenniniche e costiere che necessita-vano di un adeguamento alle nuove esi-genze della viabilistiche. È in particola-re lungo le impervie zone costiere deilaghi e dei mari che si realizzano alcu-ne delle opere di maggiore impegnoaprendo nuovi tracciati o più antichipercorsi.
Una delle realizzazioni più signifi-cative di questo periodo è quella del trat-to da Gargnano a Riva della GardesanaOccidentale, costruita nel 1929-31 percollegare direttamente il bresciano conil Trentino e il Brennero.
La strada, realizzata in condizioniorografiche particolarmente difficili,costituisce uno dei più rari e interessan-ti documenti italiani di moderna strada-parco strettamente integrata con l’am-biente naturale18.
L’ingegner Riccardo Cozzaglio,progettista della strada, si era postol’obiettivo di realizzare un percorso che,oltre a garantire una sede agevole per iltraffico, fosse in grado di rivelare al tu-rista le bellezze della costa.
La nuova via, con il susseguirsi digallerie scavate nella dura roccia e i
nuovi spettacolari panorami che consen-tiva di scorgere, entusiasmò a tal puntoda essere definita, “la più bella stradad’Europa”.
Il percorso era caratterizzato da nu-merosi manufatti: ponti, tombini,sovrappassi, gallerie artificiali, muri disostegno, piazzole di sosta e parapetti.
Queste opere, ad eccezione dei para-petti e dei rivestimenti in galleria, furonopreviste in calcestruzzo e cemento, men-tre i parapetti si realizzarono in muraturadi pietrame e i rivestimenti delle galleriein blocchetti di calcestruzzo di cemento.Paracarri e cippi erano “in scheggioni dipietrame ricavati dagli scavi e lavorati ascalpello”.
Si realizzarono gallerie per una lun-ghezza complessiva di km 5,350 circa, al-cune delle quali illuminate naturalmenteda ampie aperture praticate nella rocciaverso l’esterno: “Di galleria in galleria,imboccante ciascuna un paesaggio, stra-biliante, si ha l’impressione di un immen-so cannocchiale... Ogni apertura è l’oc-chio di un belvedere”19.
Ne risultò quella che fu descritta comeuna “balconata delle meraviglie”, “stra-da quanto mai incantevole, tracciata quasiall’altezza dell’acqua azzurra del lago esovente sospesa su prore di rupi, corridoibelvedere dagli interminabili rettifili fug-genti dalle svolte dolci, sinuose”20.
Seguirono negli anni successivi(1932-36) i lavori di rimboschimento epiantumazione di specie ornamentali suprogetto dell’ingegnere forestale GiulioAngelini, con la messa a dimora di oltre250.000 alberi, in particolare cipressi lun-go il lago e pini neri sui pendii superio-
impaginato.p65 02/01/2006, 15.478
ri21. Le piantagioni non servivano al soloconsolidamento dei pendii: “...al fine tec-nico-economico del miglioramento delregime idraulico del versante e dellavalorizzazione di una zona particolarmen-te adatta alla coltura forestale di speciepregiate, è venuto ad aggiungersi il nonmeno importante fine estetico-turisticodell’abbellimento del versante medesimo,fine che soltanto può raggiungersi colrestituire alle non poche zone ora brullee cespugliate, un bel manto boscato, uni-co degno ornamento alla bellissima nuo-va strada…”22.
Ne risultò una strada che viene anco-ra oggi considerata tra le più belle d’Ita-lia, sia per chi la percorre godendone levedute panoramiche immerso in una ve-
getazione progettata, ricca e varia; sia perchi la osserva dal lago, da dove si notauna serie di manufatti (ponti e gallerie inparticolare), vere e proprie opere d’arte,ben integrate nel contesto naturale dellaripida costa, comparendo e scomparen-do tra boschi di conifere, agrumeti e oli-veti che si alternano per tutto il percorso.
Diverse altre strade, basate su analo-ghe concezioni, furono realizzate neglistessi anni, come documentano due belleriviste del tempo: Le strade e Le vie d’Ita-lia, edite, non a caso dalla allora denomi-nata Consociazione Turistica Italiana. Traqueste, meritano di essere citati diversitratti della gardesana orientale, la stradadella sponda occidentale del lago di Iseo,la via Aurelia tra Sanremo e Ventimiglia,la strada costiera Amalfitana.
Sia le ormai antiche strade alpine che lepiù recenti vie lungo le coste dei laghi e deimari italiani rappresentano un contributo si-gnificativo alla storia dell’ingegneria ma an-che a quella dell’architettura del paesaggio.Meriterebbero quindi di essere preservate po-nendo attenzione al loro valore di bene cultu-rale, limitando gli interventi dimodernizzazione a quelli strettamente neces-sari o realizzando opere di miglioria ponen-do particolare attenzione al loro valorepaesaggistico. Purtroppo raramente si è pra-ticata una tale politica: adeguamenti proget-tati con fini esclusivamente utilitari o radicalitrasformazioni hanno spesso alterato il dise-gno originario; talvolta, come nel caso di lun-ghi tratti della gardesana occidentale o di por-zioni delle strade dello Spluga e dello Stelvio,i tracciati storici sono stati dismessi e lasciatiin abbandono. Con poca spesa avrebbero po-tuto essere conservati, se pure declassati adun uso per un traffico lento o pedonale. Privi
Fig.5 – La strada Gardesana Occidentale in unafoto attuale. E’ evidente la perfetta integrazione
tra il tracciato viario e l’arredo vegetaleappositamente progettato.
impaginato.p65 02/01/2006, 15.479
invece di manutenzione, situati in ambienti fa-cilmente sottoposti a fenomeni erosivi ofranosi, anche questi tratti stanno perdendo-si: si perderà con essi una parte importantedella storia di un’ingegneria stradale che,molti decenni prima della Valutazione di Im-patto Ambientale, aveva saputo ben integrarel’opera tecnica con l’attenzione per il paesag-gio.
1 G.MALLET, Lettres sur la route de Genève à Milanpar le Simplon, cit. in J.P.Haldi, Voyagers etdiligences à travers le Simplon, in AAVV, Voyagepittoresque de Genève à Milan par le Simplon,Bern, 1994, pp.11.2 cfr.:art.3 dell’arrêt del 7 settembre 1800, cit. inF.BARBEY, La route du Simplon, Genève, 1906.3 cit. in N.CÉARD, Mémoire et observationshistoriques et critiques sur la route du Simplon,Paris, 1820, p.314 N.CÉARD, op.cit., pp.33-34.5 ivi, p.35.6 ivi, p.37.7 ivi, p.38.8 ivi, p.35.9 Wiews to illustrate the Route of the Simplon,London, 1822.10 RAOUL-ROCHETTE, Lettres sur la Suisse, écritesen 1819, 1820 et 1821, Paris, 1828.11 S.MORSELLI, La Valtellina. La strada militare el’Adda descritte da un morto, in Grande Illustra-zione del Lombardo-Veneto, Milano 1859, pp. 169-170.12 ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, Fondodella Presidenza del Governo, Milano,13 novem-bre 1821, cit. in AAVV, Lo Spluga, un passo perl’Europa, Comitato italiano per il traforo ferrovia-rio dello Spluga, Milano, 1982, p.15.13 S.MORSELLI, op.cit. p.170.14 G.DONEGANI, Guida allo Stelvio ossia Notiziesulla nuova strada da Bormio all’incontro collapostale di Mals, Milano, 1842, pp.29-30.15 E.SILVA, Dell’arte dei giardini inglesi, Milano1813. Cfr.: O.SELVAFOLTA, Il paesaggio tecnicocome un giardino. “Le belle linee” e le “scenevariate” nelle strade dello Spluga e dello Stelvio,
in G.GUERCI (a cura di), Giardini e parchi di Lom-bardia. Dal restauro al progetto, Cinisello, 2001,pp.39-50.16 cfr. in particolare: J.J.MEYER, Voyage pittoresquesur la nouvelle route depuis Glurns en Tyrol parle Col de Stilfs (Passo di Stelvio) par la Valteline,le long du lac de Come, jusqu’à Milan, Zurich,1831.17 R.TOEPFFER, Voyages en zig-zag ou excursionsd’un pensionnat en vacances dans les CantonsSuisses et sur le revers italien des Alpes, Paris,1844, p.206.18 Per approfondimenti si rimanda a: A.CAZZANI,La Gardesana Occidentale: una parkway italia-na da conservare e valorizzare, in: G.GUERCI,L.PELISSETTI, L.SCAZZOSI (a cura di), Oltre il giar-dino. Le architetture vegetali e il paesaggio. Lastoria e la percezione del paesaggio. Metodologia,strumenti, fonti per l’analisi e la lettura del pae-saggio, Firenze,Olski, 2003, pp.129-14419 V.GIGLIO, La Gardesana Occidentale, in: “Cul-tura Moderna”, Milano, agosto 1932.20 M.RAMPERTI, Gardesana Occidentale, in: “Bre-scia”, Numero speciale dedicato alla GardesanaOccidentale, anno IV, ottobre 1931, TipografiaApollonio, Brescia, 193121 G.ANGELINI, Progetto di sistemazione idraulico-forestale della Gardesana Occidentale nei Comu-ni di Tignale - Gargnano - Toscolano Maderno eGardone Riviera. Relazione tecnica, Ministerodell’Agricoltura e Foreste, Milizia NazionaleForestale, Comando Coorte Brescia, Brescia, 1931,p.2.22 G.ANGELINI, Progetto di rimboschimento dellaGardesana Occidentale. Relazione, Ministero del-l’Agricoltura e Foreste, Milizia NazionaleForestale, Comando Coorte Brescia, Brescia, 1932.
impaginato.p65 02/01/2006, 15.4710