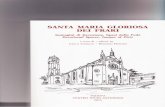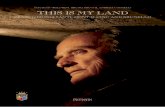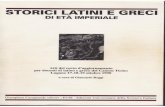Bosco, coltivazione e allevamento nelle Vite «storiche» dei santi italo-greci
Transcript of Bosco, coltivazione e allevamento nelle Vite «storiche» dei santi italo-greci
Studi di Filologia Antica e Moderna Collana diretta da Nicola Merola
13
Comitato scientifico Franca Eia Consolino , Giulio Ferroni, Guido Paduano, Giovanni Polara
Università degli Studi della Calabria - Dipartimento di Filologia PUBBUCATO CON UN CONTRJBU1V DEL DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA
DE:U. 'UNIVERSn'À OEU.A CAl.AHHlA ASSEGNATO OAl.U. REGIONE CALABRIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STUDI BIZANTINI
LA CULTURA SCIENTIFICA E TECNICA NELL'ITALIA MERIDIONALE BIZANTINA
Atti della sesta Giornata di studi bizantini Arcavacata di Rende , 8-9 febbraio 2000
a cura di Filippo Burgarella
e Anna Maria leraci Bio
~ Rubbettino
2006
Andrea Luzzi
Bosco, coltivazione e allevamento nelle Vite dei santi monaci italogreci (secc. IX-XII)
La mia indagine ha avuto come oggetto quel gruppo di Vite di santi nmnaci siculo-calabresi, fioriti in un arco temporale compreso tra il secolo nono e il secolo dodicesimo, alle quali è stato di recente riferito l'aggettivo "storiche"l, per rimarcare la loro specificità nei confronti del precedente capitolo dell'agiografia italogreca costituito da leggendari Bioi espressione di comunità ecclesiastiche cittadine2. Certo anche nelle Vite monastiche, ha scritto recentemente Enrica Follieri, "si incontrano elementi topìci propri del genere agiografico [ ... ]; ma gli sfondi delle narrazioni e i personaggi che le animano o:ffi:ono spesso allo storico una serie di indicazioni utili per ricostruire gli ambienti, le mentalità, le vicende che caratterizzarono gli ultimi secoli della presenza bizantina in Italia e i primi tempi della dominazione normanna"3. Le quattordici Vite prese in considerazione sono quelle di Elia il Giovane da Enna (BH(J4 e BHG
1 Cf. S. Caruso, Sicilia e Calabria nell'agìogr(lfia storica itala-greca. in S. Leanza (t) {a cura di), Calabria cristiana. Società Religione Cultura nel territorio della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. I. Dalle origini al Medio Evo (Atti del Convegno di studi, l'ahni-Cittanova 21/25 novembre 1994), Soveria Mannelli (Cz) I 999, pp. 563-604.
2 Su questa vern e propria frattura verifieatasi nella storia del! 'agiografia ita!ogreca cf. Acconcia Longo, Santi monaci italogreci. Alle origini del monastero di S. Elia di
Carbone, "Bollettino della Badia greca di Grottaferrata" n.s. 49-50, 1995-1996, p. 148.
3 Cf. E. Follìeri, l santi del! 'Italia greca, "Rivista di Studi Bizantini e Neoelleniei" n.s. l4, 1997 (pubbL 1998), p. 13.
4 F. Halk:ìn, Bibliotheca Hagiographica Graeca. Troisiéme édition mise à jour et con·ddèrablement augmentée (Subsidia bagiographic~ Sa), l-III, Bruxelles 1957.
138 Andrea Luzzi
Novum Auct.5 580)6, scritta qualche decennio dopo il 903, data della morte di Elia, da un anonimo monaco attivo, con ogni probabilità, nel cenobio fondato intorno ali' 884 dallo stesso Elia nella cosiddetta turma delle Saline (corrispondente ali' attuale piana di Gioia Tauro); la Vita di Elia Speleota da Reggio (BHG 581 )7, fondatore di un monastero rupe~ stre nei pressi di Melicuccà, dove lo Speleota mori nel secolo decimo inoltratos; il gruppo di cinque Vite di monaci siciliani del cenobio di S. Filippo di Agira vissuti nel decimo secolo, emigrati in Calabria e fondatori di vari monasteri tra Calabria settentrionale e Lucania, ovvero il Bios di Cristoforo da Collesano col figlio Macario (BHG 312)9 e quel~ lo dell'altro e più famoso figlio di Cristoforo Saba (BHG 161l)to, Bioi composti dal patriarca di Gerusalemme Oreste (morto a Costantinopoli nel l 005)11, insieme alle tre Vztae, conservatesi solo in redazione latin~ di Leone-Luca da Corleone (BHD2 4842)13, Luca da Demenna (BHL 4978)14 e Vitale da Castronovo (BHL 8697)15; il Bios di Nicodemo di
5 F. Halkin, Novum Auctarìum Bìbliothecae Hagiographicae Graecae (Subsidia hagia. graphica, 65), Bruxelles 1984.
6 Ed. G. Rossi Taibbi, Vita dì Sant'Elia il Giovane (Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici. Testi, 7), Palenno 1962 [ìn seguito Vita Eliae iunioris].
7 Ed. J. Stiltingh, Vita auctore discipulo monacho ex cod. Ms. 42 bibliothecae S. Salvatoris prope Messanam pag. 30, in Acta Sanctorum Septembris, III, Antverpiae rist. anast. Bruxelles 1970, pp. 848-887 [in seguito Vita Eliae Spelaeotae].
8 Sui dati cronologi desumibìii dalla Vita di Elia Speleota cf. E. Follìeri, La Vìta di san Fantino il Giovane. Introduzione, testo greco, traduzione, commentario e indici (Subsidill hagiographica, 77), Bruxelles 1993, pp. 101-112.
9 Ed. L Cozza-Luzi, Historia et laudes ss. Sabae et Macarii iunìorum e Sicilia, auctt?> re Oreste patriarcha Hierosolymitano, Romae 1893, pp. 71-96 [in seguito Vita Christophori et Macarii].
IO Ed. ibidem, pp. 5-70 [in seguito Vita Sabae itmìoris ). li Sul patriarca Oreste cf. E Burgarella, Chiese d'Oriente e d'Occidente alla
dell'anno mille, in G. Amaldi-G. Cavallo (a cura dì), Europa medievale e mondo bizantt· no. Contatti effettivi e possibilità di studi comparati (Tavola rotonda del XVIII Cm1Pn1s.rn
del CISH- Montréal, 29 agosto 1995) (Nuovi Studi Storici, 40), Roma 1997, pp. 201-207,
12 Socii Bollandiani, Bibliotheca Hagiographica Latina (Subsidia hagiographica, l· II, Bruxelles 1898-1901, rist. anast. Bruxelles 1992.
13 Ed. M. Stelladoro, La Vita di san Leone Luca dì Corleone. Introduzione, testo lati• no, traduzione, commentario e indici, Grottaferr&ta 1995 [in seguito Vita..,,,.,.,..~-.... """'"'
14 Ed. Vita s. Lucae abbatis, in Acta Sanctorum Octobris, Vl, Tongerloae 1794, pp. 337-341 [in Vita Lucae ab. Arment!l
15 Ed. Vita Auctore coaevo, antìqui.~ Manti, 1668, rist. n.nast Bru.xelles 1968, pp. Vittl
Bosco, coltivazione e allevamento nelle Vite 139
Cellarana (BHG e BHG Novum Auct. 2305)16, eremita sull'omonimo monte nei dintorni di Mammola nel secolo decimo, Bios composto dal monaco Nilo; la Vita, in duplice redazione, di Giovanni, soprannominato Terista (BHG 89417 e 894a)JS, fondatore dell'omonimo cenobio presso+Stilo, anch'egli vissuto, con ogni probabilità, nel decimo secolo•9; la celeberrima Vita Nili iunioris (BHG e BHG Novum Auct. 1370)20; il Bios di Bartolomeo terzo egumeno della Badia di Grottaferrata (BHG e BHG Novum Auct. 233)21, morto intorno al l 050, Bios composto da un monaco della Badia stessa; la Vita di Fìlareto il Giovane (BHG e BHG NovumAuct. 1513)22, monaco, nel secolo undecimo, presso il cenobio fondato da Elia il Giovane nella turma delle Saline, Vita redatta da un altro agiografo di nome Nìlo, che si è ritenuto di poter identificare con il teologo polemista di età normanna N ilo Doxopatre2J; i due Bioi, infine, di santi monaci vissuti ormai sotto la dominazione politica dei Normanni24: Bartolomeo da Simeri (BHG 235)25, il celebre fondatore, o, più correttamente, rifondatore, dei mo-
16 Ed. M. Arco Magrì, Vìta dì S. Nicodemo di Kellarana (Testi c studi bìzantino-neoc!lcnìci, 3), Roma-Atene 1969 [in seguito Vìta Nicodemì].
17 Ed. A. Pcters, Joannes Messor. seine Lebensbeschreibung und ihre Entstehung {Auszug aus der Bonnerphilosophischen Dissertation), Bonn 1955, pp. 29-49 [in seguito Vita loannis Messoris B].
18 Ed. ibidem, pp. 28-48.
19 Sulla cronologia di Giovanni Terista cf. A. Acconcia Longo, S. Giovanni Terista nell'agiografia e nell 'innografia, in Calabria Bizantina. Civiltà bizantina nei territori di Gerace e Stilo, Soveria Mannelli 1998, pp. 150-153.
20 Ed. G. Gìovanelli, Bioç IWÌ JtOÀLTEia TOÙ oaiov nar:pòç ilflWV NEiÀov T:OI} Ni:m1. Testo originale greco e Studio introduttivo (cod. greco criptense B. /3. li), Badia di Grottaferrata 1972.
21 Ed. G. Giovanelli, S. Bartolomeo Junìore confondatore dì Grottaferrata, Badia dì Grottaferrata 1962.
22 Ed. U. Martino, Nìlo, Vìta di s. Filareto di Seminara, Reggio Calabria 1993 fin Vìta Philareti iunloris].
23 Cf. S. Caruso, Sull'autore del Bios di S. Filareto il Giovane: Nilo Doxapatres?, "'Ent'tllptç 'E1:mptiaç Bu1;;avnv6Jv Irr01Jòwv" 44, 1979-1980 (pubbl. 1981). pp. 293-<04. Per la resa in italiano del nome di famiglia di Nilo cf. E. Follieri, Dal nome del llessarione al problema della resa in italiano dei nomi di jàmiglia bizantini, "Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici" n.s. 35, 1998 (pubbl. 1999). p. 137.
24 Non ho prestl in considerazione la Vìta del vescovo di Isola Luca da Melicuccà, defunto nel 1114, in quanto eterogenea ai quattordici Bioi monastici.
Ed. Il Bios Bartolomeo da Simeri tBHG "Rivista di Studi Bizantini 10'J6 (pubbL 1997). pp. 193-.:!74 fin ~lta
140 Andrea Lu111
nasteri di S. Maria Odigitria presso Rossano e del San Salvatore d1 Messina morto nel 1130 e Cipriano di Calamizzi (BHG 2089)26, l'egu~, meno del monastero di S. Nicola vicino Reggio Calabria che terminò la sua vita terrena in un anno compreso tra il 1210 e il 121527. Oltre n queste quattordici Vite monastiche ho inoltre tenuto presente la sezio0
ne "italogreca" dei Bioi di altri due santi monaci italogreci per lungo tempo vissuti e infme deceduti fuori d'Italia: Fantino il Giovane (Bl/0 Novum Auct. 3666zps, morto in Grecia, a Tessalonica, nel 974 circa c Gregorio da Cassano (BHL 367129 e 367230), defunto in Germania tra l'anno 998 e l'anno 999 nel monastero da lui fondato a Burtscheid vicino Aquisgrana.
Presentate in questa rapida ma doverosa carrellata le fonti agiogra~ fiche sulle quali ho condotto la mia indagine, posso finalmente entrare in medias res. Il bosco è considerato nelle Vite dei santi monaci italo· greci luogo d'elezione per coltivare quella che in un passo della Vita Nili viene definita "maestra di tutte le virtù", owero l'esichia, la vita solitaria, che rimane la massima aspirazione degli asceti anche quando conducono vita comune nei cenobi. Cosl a Giovanni Terista, alla ricerca di un luogo deserto dove poter vivere in solitudine e salvare la sua anima, indicano un luogo selvoso sul monte, "èv .,;<iJ ÒpH [ ... J .,;o:n;ov uì.roùrj''JI. Bartolomeo da Simeri, agli esordi della prima fase di eremitaggio della sua vita monastica "supplica l'eremita Biagio di essergli guida nella parte più interna del bosco, dove avrebbe potuto dedicarsi in solitudine a Dio, senza essere assolutamente impedito da nessuno"32,
Bartholomaei Patiriensis J; ho tenuto conto delle osservazioni critiche formulate da Stefano Caruso nella recensione alla suddetta edizione apparsa in Bizantinistica. Rivista di Studi Bizantini e Slavi, s. Il, l (1999), pp. 305-349.
26 Ed. G. Schirò, Vita inedita di s. Cipriano di Calamizzi dal cod. Sinaitico 11° 522, "Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata" n.s. 4, 1950, pp. 65-97.
27 Sui dati cronologici desumibili dalla Vita cf. D. Stiemon, Saint Cyprien de Calamizzi {t vers 1210-1215). Notule chrooologique, "Revue des études byzantìnes" 32, 1974, pp. 247-252.
28 Ed. Follìeri, La Vita ... cit [in seguito Vita Fantini iunioris].
29 Ed. A. Poncelet, Vita s. Gregorii abbatis prior; in Acta Sanctorum Novembris, TI, l, Bruxellis 1894, pp. 463-466 [in seguito Vita Gregorii prior].
30 Ed. A. Poncelet, Vita s. Gregorii abbatis posterior; in Acta Sanctorum Novembrìs, li. l, Bruxellis 1894, pp. 467-477.
31 Vita loannis Messoris B, p. 37.
32 Vita Bartholomaei Patiriensis, § 8,17-!9, p. 209: tKETEVH Tofuov ÒOT)'YÒV a:Ìrto)
141
in seguito, anche dopo aver dato vita a una comunità monastica, continuava a essere "tutto preso dalla vita eremitica e considerava le boscaglie e si figurava le contrade fitte di vegetazione dei monti"33.
è possibile vedere dai precedenti esempi, e altri se ne potrebbero addurre, il bosco in queste agiografie è indissolubilmente legato ai monti. L'assimilazione del bosco alla montagna è senza dubbio suggerita dall'espressione dell'epistola agli Ebrei "vaganti per i deserti, sui n1onti, tra le caverne e le spelonche della terra"34, espressione che è del resto esplicitamente considerata dal biografo di Elia Speleota motivo ìspiratore della scelta di Elia di condurre vita solitaria3s, ma tale assimilazione risulta perfettamente naturale nelle regioni in cui le Vite dei
italogreci sono in larga parte ambientate, Calabria e Lucania, dove la maggior parte della superficie era, allora come oggi, costituita da monti e colline e dove rimanevano liberi dal fitto mantello boschivo solamente alcuni tratti di costa e le vette più alte della linea degli alberi. Si può anzi affermare che proprio l'oro grafia di tali regioni, insieme alle peculiari condizioni climatiche, ha permesso lo sviluppo della fittissima trama forestale di cui resta visibile traccia ancora oggi, sebbene notevolmente ridotta rispetto all'età romana e medievale36. L'ampia estensione del mantello boschivo è occasionalmente sottolineata dagli stessi agiografi, come fa ad esempio Oreste nella breve Vita di Cristoforo e Macario quar~do ar~nota che "nell'eparchia di Mercurio c'erano molte e vaste foreste"J7, ribadendo il concetto, a poca distanza, nel presentare ""tfJV UÀflV [ ... ] Ù!l<j}tÀcujl'ij o'Ùcrav Àtav Kat cr<j>obpa Kanirnnov"38 dove i monaci erigerar1no una chiesa dedicata
YEVÉ<J8at n:pÒç 'tÙ 'tOÙ ÙÀ.<JOUç EVOO'tfpa, O'Ù Ò'UVrJOil'taL KU'tU~lOVaç <JXONXOUl 91ll~ n:apà. ~n]6evòç 'tÒ n:aprurav k~-tn:o6t1;6~-t~:voç.
33 Vìta Bartholomaei Patiriensìs. § 16,1-2, p. 216: oÀ.oç ~v 'tijç àvaxoopr]acwç, 1:e ).0"..<,~-tà.ç àveOKOJtftt{) Kat ,;à. Miota ,;ffiv òpffiv È<jlav'tcii;~:'to.
34 Hebr. 11.38.
35 Vìta Eliae Spelaeotae. § 38, p. 863: 1-lE!-LVTJ~-tÉvoç K<Ù Ù.'tOm:of..tKOU pTJ'tOÙ, $cioKov'toç· Tht' ÈpTJf.tl.aLç nÌI.aVW!lEVot, Kat opWl Kat <JnllÌI.aLOtç, Kat 'tO.tç tmaì:; 'tij·; yfìç.
36 Per quanto concerne la Calabria è stato calcolato che l" estensione dei boschi superasse, in tali epoche, di circa due terzi quella attuale: cf. L Gambi, Calabria (Le regioni d'Italia, 16), Torino 1965, p. 77.
37 Vìta Christophori et Macarìi. § 9, p. 82: Ka\ npòç nìv <oii MEpKouptcru Èn:apxtav Ù<jltKETO. ÈV ~ lJJtlÌPXOV 6pu~tffiveç (6pu~-toveç ed.) JtOÀÌ..OÌ KO.L Ù~-t!JltÌI.a<jldç (Ùj.ltjltÀa<j>Ùç ed.).
38 Vita Christophori et Macarii, § lO, p. 83.
Luzzi
all'arcangelo Michele. l selvosi monti alle volte potevano incutere ter~ rore, come bene dimostra repisodio narrato nella Vita dì Leone-Luca da Corleone che vede protagonista un certo Costantino da Cassano il quale, recandosi in visita ad un monaco del cenobio fondato da ._,..,,v .. ,.
Luca a Vena, smarrisce la strada e "per abrupta montium Mirum in modum uexatus deficiensque, sanctum Dei Lucam inuocare cum Iacrimis coepit"39. Sdraiati sotto il bosco (im:ò TÒ àì.ooç), questa volta non montano ma limitrofo alla costa, sono poi ì Saraceni, neri Etiopi, dagli occhi feroci, dalle facce deformi, e tutti simili a demoni che tanto atter'* riscono Nilo il Giovane mentre è in viaggio verso il monastero di S. Nazario per essere finalmente tonsurato4il. Di certo, nonostante il pro~ cesso di degradazione delle aree boschive nelle suddette regioni abbia avuto inizio già in epoca romana e bizantina41, le limitate possibilità e capacità di intervento unite alla scarsa densità di popolazione hanno impedito, almeno fino all'età moderna, di incidere in modo tale da stravolgere i caratteri preminenti di impraticabilità e di selvatichezza peculiari di siffatte aree42. E proprio grazie alle caratteristiche di impraticabilità e di selvatichezza il binomio bosco-monte perde altre volte questa connotazione di inquietante ostilità per acquistare la positiva valenza di salvifico, seppure temporaneo, rifugio. In occasione di una devastante scorreria saracena, ricorda Oreste nella Vita di Cristoforo e Macario, i siciliani, logorati dalla fame e dalla necessità, spostandosi di luogo in luogo, si nascondevano nelle spelonche e nei monti e nelle boscaglie più fitte (fkttfuT<hmç ì.6x~mç)43. Sempre lo stesso Oreste, ma questa volta nel Bios di Saba da Collesano e a pro~ posito di un'incursione dei "terribili Ismaelitì" in Calabria, precisa che tra coloro che avevano evitato le mani omicide dei Saraceni alcuni cer· cavano la salvezza nei luoghi fortificati, altri si nascondevano nelle folte boscaglie (opv~romv Àaatmç), altri ancora, percorrendo tutta la Calabria, giungevano ai confini della Longobardia44. Inoltre, nota Ore-
39 Vita Leonis-Lucae, p. 96,262-264.
40 Cf. Vita Nili iunioris, § 5, p. 51. 41 Cf., per la calabra, Gambi, Calabria ... cit., pp. 77-78.
42 Cf. C.M. Rugolo, boschivo e insedi'amenti umani nella Calabria medie-vale, in B. Andreolli-M. Montanari (a cura di), Il bosco nel Medioevo (Biblioteca di storia agraria medievale, 4), Bologna 1988, p. 323.
43 Cf. Vita Christophori et Macarii, § 8, pp. 81-82.
44 Cf. Vita Sabae iuniorìs, § Il, p. 21.
143
ste in occasione della quinta e ultima scorreria saracena nel territorio calabro~lucano registrata nella Vita di Saba, quando gli lsmaeliti giun-
persino a minacciare le dimore dei monaci sulle alture di LaJ~Oile~;ro, alcuni di questi, amanti dell'esichia, volevano nascondersi nelle foreste e nelle boscaglie degli ombrosi monti (tv 'TULç uÀmç KUL ÀOx!latç 1:rov KU'TUaKirov ÒpÉrov), pensando in tal modo di rimanere occulti agli invasori, ma Saba li avverte che quel rimedio è ormai inu-
convìncendoli a trasferirsi nel territorio di Salemo45. E nel Bios Nicodemi l'agiografo narra che "avvenuta una terribile rivolta fra i discendenti di Agar e devastando essi tutta quella zona, il beato [ ... ] allontanatasi dalla geute del luogo, rimase per lungo tempo fuggiasco per monti e spelonche e dimorò in eremitaggio, avendo raggiunto un paese in luoghi assai elevati, chiamato Cellarana, inaccessibile a molti, che era molto boscoso e selvoso"46. La stessa valenza protettiva del binomio bosco-monte, alternativa a quella dei luoghi fortificati, è affermata, seppure in maniera più sfumata e allusiva, in occasione di un'altra scorreria di "imrnundi et spurcissimi Agareni"47, anche nella Vita di Vitale da Castronovo: "fugientibus itaque cunctis, nitebantur alii per castella, alii per loca natura munita, imrninentia pericula declinare"48. Luca da Demenna, infine, abbandonando il ceuobio di S. Giuliano (sito lungo le sponde del fiume Agri) in seguito allo scontro tra l'imperatore bizantino Niceforo Foca e quello germanico Ottone I, stabilì "in privarum locum, naturaque munitum contendere, qui sive ad castelli aedificationem, sive ad munitionem non nimìo opere indigeret. Diversa igitur montana loca tentans, congruum tandem nactus est"49, dove Luca e i suoi monaci fonderanno il kastron dì Armento.
45 Cf. Vita Sabae ìunioris, § 45, p. 62.
46 Vita Nìcodemi. § 6, p. 100,116-121: Kaì. Ò'IÌ 'tWv 'tfjç 'Ayap ùrroy6vrov Èrravamciaeroç òewfjç yeva~-tÉVf}ç [ ... ] ò ~m:ciptoç. 'AJrcipaç òÈ 'tWv ÈKeì:ae Òpem Kat mtrtÀaimç lq.tci.Kpuve <jwyaòevrov KUL f}VÀL00rt èv 'tfj èpft~<!l. xropov òÉ 'ttVU Èv lHjJf}ÌI.O'tÉpotç 'tOJtOtç KU'taÀUI}ÒW Ke:M.cipava ÈJtLÀS'fO!-!EVOV Ka'taÀ.aOV ovta rravu À.oj(,.u00f}, àvflpro:n;mç ~SV noì,f.oiç Uf}U'tOV.
47 Su questa scorreria saracena che sarebbe avvenuta, secondo l'autore della Vita ntalis, trent'anni dopo la morte di Vitale, cf. S. Caruso, Sulla cronologia del dies natalis di s. Vitale da Castronovo dì Sicilia, "Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata" n.s. 52, 1998 [=S. Lucà-L. Perria (a cura di),' O!r(Opa. Studi in onore dì mgr Pau! Canart per il LXX compleanno, II], pp. 136-139.
48 Vita Vitalis, § 23, p. *33D.
49 Vita Lucae ab. Armenti,§ 9, p. 340A.
144 Andrea Luzzi
Uscendo dalla dimensione metafisica e a volte antitetica del selvoso monte considerato ora come pacifico luogo di esichia, ora come tetro suscitatore di inquietudine, ora come amichevole profferta di rifugio, per entrare in una dimensione, per così dire, più tecnica e materiale, si deve notare come sia assente, in tutte le agiografie prese in considerazione, una qualsivoglia descrizione della realtà boschiva. Al bosco, come si è visto nelle precedenti citazioni, ci si riferisce sempre con termini generici, non facendo alcun accenno alle varietà arboree di cui le foreste erano composte. L'unica parziale eccezione è costituita dal lungo elogio della Sicilia che si legge nelle prime pagine della Vita di Filareto il Giovane, dove l'agiografo Nilo, tra l'altro, sottolinea "anche la pregiata natura della legna dell'isola, (offerta da) cedri, cipressi e pini che producono fiaccole, di fitto fogliame questi e molto slanciati da terra"so, anche se è stato notato come siffatto elogio appaia basato su reminiscenze letterarie più che essere fondato sull'esperienza autopticasi. Possiamo comunque farci un'idea approssimativa delle varietà arboree costituenti bosco e sottobosco delle località in cui sono ambientati i Bioi dalla menzione della raccolta dei prodotti spontanei delle aree boschive. Iniziamo dalle generiche allusioni alle erbe selvatiche di cui si nutrono gli esicasti. Di "herbae" parla il biografo di Vitale da Castronovo a proposito del periodo di dodici anni di ascesi esercitato dal santo in Sicilia sul Mongibellosz, di radici di piante (pl~m j3o'ta.vffiv) e di germogli di alberi (a.Kpa. oévopwv) l'autore della Vita Fantini53, di erbe selvatiche (aypLm j3o'tcivm) l'agiografo di Filareto il Giovanes4, quello di Fantino il Giova-
50 Vita Philareti iunioris, p. 36,8-11: Ka't ~VÀù.N <jn)cnç ·nf!ta· KÉbpot 'tÉ <Prtltt Kat Kv:rcapt't'tOl, Kat ai o~oaç <j!Épouom :rceilKat, ÙljJaXO!tOL 'tLVE<; UV'tat Kat ÀLaV yijl:lev U3tEp1']pf!ÉVat.
51 Cf. S. Caruso,ll Bios di s. Filareto il Giovane (Xl sec.) e la Calabria tardo-bìzantiM na, in S. Leanza (t) (a cura di), Sant'Eufemia d'Aspromonte. Atti del Convegno di il bicentenario del/ 'autonomia (Sant'Eufemia d 'Aspromonte 14-16 dicembre 1990), Soveria Mannelli 1997, p. 93. Su boschi e foreste in Sicilia, in part. nell'età norrnanna, cf. V. von Falkenhausen, La foresta nella Sicilia normanna, in La cultura materiale in Sicilia, Palermo 1979, pp. 73-82 e P. Corrao, Per una storia del bosco e dell'incolto in Sicilia tra Xl e XIII secolo, in Andreolli-Montanati (a cura di), Il bosco nel Medioevo cit., pp. 351-368.
52 Vita Vitalis, § 4, p. *27 A. 53 Cf. Vita Fantini iunioris, § 12,6-8, p. 414. 54 Cf. Vita Philareti iunioris, p. 96,15-16. In un altro
a ffenna che Filareto si cibava di verdure selvatiche N.X~1unrmv
Bosco, coltivazione e allevamento nelle Vite 145
ness, e quello di Bartolomeo da Simeri56. Ma queste indeterminate menzioni, topica espressione del regime alimentare vegetariano peculiare dell'anacoresi57, risultano poco significative. Talvolta però la raccolta dei frutti spontanei del bosco viene caratterizzata con maggiore dovizia di particolari. Ad esempio Oreste nella Vita di Cristoforo e Macario ricorda che Cristoforo, ritiratosi a vita solitaria nella regione di Ctismass nei dintorni del monastero siculo di S. Filippo di Agira, si cibava "-coì:ç e'ÙptcrKOj!Évmç ÙKpobp{,mç KaL ònmpmç Èv -et\) bpu~-tt\)"59, quindi di frutta e probabilmente di noci, nocciole o castagne selvatiche, dal momento che -cà ÙKpoùpua sono propriamente detti i frutti con guscio legnoso6o, Questa notizia del resto ben si accorda con la plus minusve coeva Cronaca di Sicilia6t del giureconsulto · Abiì 'Alì 'al I:Iasan 'ibn Yal;lyà, che indica la presenza, nella zona dell'Etna, di pini, di cedri e, appunto, di noccioli e di castagni62. Di sicuro una certa quantità di castagne (àpt8j!6v -ctva Kacr-cavrov) raccoglieva Nicodemo in Calabria sul monte Cellarana, mangiandole dopo averle cotte in un piccolo tegame e bevendone anche il decotto63. Nilo il Giovane, passato a vita eremitica nella turma di Mercurio, si accontentava, dice l'agiografo, "-coì:ç mhoj!a-rmç ùpuòç KEpa-cimç, !!'UPOLVWV (mirti) TE -coì:ç Kapnoì:ç Kal KO!!UPWV (corbezzoli)"64. L'espressione -coì:ç aù-ro~-ta-rmç ùpuòç KEpa-clmç risulta leggermen-
55 Cf. Vita Fantini iunioris, § 28,6, p. 432.
56 Cf. Vita Bartholomaeì Patiriensis, § 9,27, p. 210.
57 Sul particolare regime alimentare osservato dagli anacoreti italogrecì cf., ad esemE. Morinì, Aspetti organizzativi e linee di spiritualità nel monachesimo greco in
Calabria, in Leanza (t) (a cura di), Calabria cristiana ... cit., pp. 271-275.
58 Corrispondente ali' odierna Tisima: cf. L. R. Ménager, La "byzantinìsatìon" religicuse de l'ltalie méridionale (IX"-Xll" siécles) et la polìtìque monastique des normands d'ltalie, "Revue d'hìstoire ecclésiastìque'' 53, 1958, nota 5 a p. 764.
59 Vita Chrìstophori et Macariì, § 4, p. 76.
60 Cf. T. Fìx, lemma 'A~<:p6opva, <a. in H. Stephanus et alii, Thesaurus Graecae I, Parisiìs 1831, rist. anast. Graz 1954.
61 Tàrìb Siqilliah: opera di cui è andato perduto il testo originale, parzialmente a noi noto grazie alle citazioni di altri autori.
62 Cf. M. Amari, Biblioteca arabo-sicula, I, Torino-Roma 1880, pp. 204 (secondo la citazione di Yaqut) e 235 (secondo la citazione di 'al Qazwlnì, che però omette la menzio-
dei """''""''" Cf, Vita 1vu:'omHtn
146 Andrea
te ambigua. Tà KEpa:na, letteralmene "cornetti'', sono infatti i frutti del carrubo, di cui, come leggiamo nel Vangelo di Luca, si nutriva il Figliol prodigo6s. Ma la specificazione opv6ç (letteralmente '"della quercia") fa una certa difficoltà, perché il frutto della quercia è la ghianda, in greco l)nÀavoç. Varie le interpretazioni del passo da parte dei traduttori moderni: Giovanelli propone "carrube silvestri''66, la monaca Maximi, in neogreco, optando per le ghiande, "ay pta l)t::Àa...ì; viota -rfìç opv6ç"67. Tenendo però conto sia del passo evangelico del fatto che opùç può genericamente indicare anche un albero diver.;c so dalla quercia68 è forse preferibile rendere in italiano tutta l'espres.., sione con "i prodotti spontanei del carrubo". Sempre nella Vita Nili e per la stessa turma di Mercurio è menzionata un'altra specialità erborea selvatica commestibile: gli asparagi (mtapnyLa69). Questi vegeta .. li sono protagonisti di un gustoso quadretto che per la sua freschezza vagamente naiJ merita di essere riportato per esteso.
Nell'aggirarsi un giorno il beato Stefano (uno dei discepoli di Nilo) trovò i cosiddetti asparagi, e raccolti li e lessatili li presentò ali' ora del pasto. n Padre, dopo averne presi e provatone contro il solìto un certQ. piacere, domandò al compagno se anche egli avesse sentito la medesi~ ma dolcezza. E poiché quegli lo ammise, gli fu comandato dallo so Padre di gettarli fuori: "Questi dice infatti - che sono amari natura, li ha conditi il diavolo e li ha fatti dolci"70.
65 Lu. 15,16.
66 G. Giovanelli, Vita di S. Nilo, fondatore e patrono di Grottaferrata. Versione e note, Grottaferrata 1966, p. 32.
67 [Maximi (mon.)], 'O oawç Nt:ìÀOç o KaJ,.afJp6ç, 'O Bioç mii oa{ov NetAov -roil Néov (910-1004), Eiaaywyt) Kpt"ttKlj ÈKoomç Toil Ket!-liv01J - Me,;ci<jlpa:atç k)(OÀta- 'Y!J.VOypa<jltKÒ epyo 00t01J, 'Op!J.UÀL(l XaÌc.KtÒLKij; 1991, p. 119.
68 Cf. G. Dindorf, lemma ApiJr;, v6r;, t1. in H. Stephanus et alii, ThesauntS Graecae Linguae, m, Parisiis 1833, rist. anast Graz 1954.
69 Forma con aferesi di àmrupciywv, diminutivo depotenziato dal classico do:ltdj)(J.'I'O!,;.
70 Vita Nili iunioris, § 28, p, 75: nspuof}XOfJ.ZVOç òé l'IDt8 ò !J.UKapLOç !,;écpavoç ,;à M:yo!J.eva oJtapciyta· Ka't O'Uvayayrov a'Ù'tà Kat e'ljJT)aa; :n:apé6TJKEV €v 'toU yeuoaa9at, MeTaAa!'lrov ÒÈ èl; atttrov o Timl\p, KUL ooç; :n:apà. O'IYVTJ9ELGV i)6ovijç aioiloJlevoç, ~:n:Uee'to Toil haipau, e'lye Kal atl'tÒç ·~,·~·"""'·~~ l]a6e'to. Tot1 òll O'U~tlj>pwvl]oavtoç, pi:tjJm aìrrà a'Ù'toil "Tama tj!T]at, mKpà Tuyxcivovta
Bosco, coltivazione e allevamento nelle Vite 147
Sia nella Vita di Fantino il Giovane7t che in quella di Nilo il Giovanen sono inoltre ricordate, sempre relativamente alla turma di Mercurio, le pere selvatiche, tuttora diffuse nei boschi lucani (rispettivamente àxpciùeç e aypw. àrtiùta73): aspre e dure quando si trovano ancora sugli alberi, ai primi freddi, cadute a terra, divengono marcescenti e dolcissime74• Del resto alberi e arbusti selvatici offrivano un decisivo complemento alimentare non solo alle mense dei parchissimi anacoreti, ma anche a quelle dei laici, specialmente nei periodi di difficoltà di approvvigionamento, come è testimoniato dal patriarca Oreste nella Vita di Saba da Collesano in particolare nell'episodio che vede protagonista nella turma di Latiniano il figlioletto di uno dei parenti di Saba, trasferitisi colà in seguito a una scorreria dei Saraceni: il giovanetto, narra l'agiografo, subì il morso di una vipera mentre stava raccogliendo, per il pasto, erbe eduli ((3o'tavaç Èùroùtf.tOVç)75. E a proposito degli animali selvatici che frequentavano i boschi medievali nei Bioi oltre ai serpenti s'incontrano anche orsi76, cervi77 e cinghiali7&. Frequentemente gli autori delle Vite, nel solco della tradizione agiografica, fanno ricorso all'animale silvestre per dar modo al santo di esercitare le sue virtù taumaturgiche e per affermare i ben noti topoi della superiorità dell'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, sugli esseri irrazionali, e del potere sugli animali del monaco assimilato ad Adamo nel suo primitivo stato di innocenza79. A tale proposito mi limito a proporre la scena della
di Vitale da Castronovo in cui il santo è raffigurato nelle vallate tra ì monti di Turri (probabilmente da identificare con Torre Perticaraso) e di Armento come una sorta di san Francesco d'Assisi ante litteram.
71 Cf. Vita Fantini iunioris. § 12,3, p. 414.
72 Cf. Vita Nili iunioris, § 30, p. 77. Diminutivo depotenziato di amov.
74 Cf. F. Pratesi-F. Tassi, Guida alla natura della Basilicata e Calabria, Milano 1979, p. 132.
75 Cf. Vìta Sabae iunìoris, § Il, p. 21. 76 Cf. Vìta Christophori et Macarìi, § 15, pp. 87-88; Vita Eliae Spelaeotae, §§ 47-48,
867; Vita Fantini iunioris. § 24, l-9, p. 428.
Cf. Vita Nicodemi, § 17, p. 124,388-396; Vita Vìtalis, § 7, p, *28B.
Cf. Vita Fantini iunìoris, § 12,1-19, pp. 414-416.
Su tale tema cf. Follieri, La Vita ... cit., p. 45 con le note 38 e 39, p. 498 e p. 510 (commentario a 24,1
Storici),
148 Andrea Luzzi
Agrestia animalia, duce Domino, veniebant, omnique deposita ferita~ te, sacros huius viri pedes lingebant, nec inde, nisi suscepta benedic· tionis gratia, recedebant. Et non solum hoc, sed et moltitudo volucrum ad speluncam properabant, ut tanti Patris possent benedictionis acci~ pere portionem. lpse vero communes escas, quas solitus erat comede· re, illis manu propria ministrabat: quibus data benedictione, acsi natu~ rae loqueretur humanae, dicebat: ite vos amodo, ut veniant aliae81.
Connesso con gli animali selvatici è naturalmente anche il tema della caccia, presente in alcuni Bioi nello stereotipato topos agiografico del romanzesco ritrovamento dell'eremita ad opera dei cacciatonsz.
Foreste e incolto in genere erano poi il luogo dove si praticava l'allevamento allo stato brado del bestiame grosso, nelle Vite rappresentato soprattutto da bovini ed equini, attività nel medioevo a carattere eminentemente silvo-pastorale, a causa della limitata estensione dì prati in grado di fornire adeguato foraggio83. Significativa è la descrizione delle difficoltà che comportava l'allevamento allo stato brado nella Calabria del secolo undecimo offerta nella Vita di Filareto il Giovane, il quale svolse, per conto del suo monastero, l'attività dì pastore sia di buoi che di cavalli.
Quegli nella premurosa cura della mandria dei buoi era forse alla pari dei compagni faticando e preoccupandosi, per non dire anche di più; soffrendo nel freddo, consumandosi nella fatica, esplorando vette di monti e dirupi e sorgenti e fiumi a causa del pascolo. Facendo il pasto~ re combatteva giorno e notte contro freddo e ghiaccio e le sferzate dei venti84 [ ... ] Voi tutti uno per uno sapete come è duro e pieno di fatiche
81 r7ta Vitalis, § 7, p. *28A-B.
82 Cf. Vita Fantini iunioris. § 15,9-13, p. 418; Vita Bartholomaei Patiriensis, § 12,1· 26, p. 212. Su questo tema agiografico cf. Follieri, La Vita ... cit., p. 38 con la nota 13. A dei cacciatori. ma in contesti affatto diversi, si allude anche nella Vita Leonis-Lucae, p. 92,214 e nella Vita Ioannis Messoris B. p. 41.
83 Cf. M. Montanari, L 'alimentazione contadina nel! 'alto medioevo (Nuovo Medioevo. Il}, Napoli 1979, p. 223.
84 Vita Philareti iunioris, p. 80,16-23: "Oç ('Oç ed.} €v t.tÈv ·dj :rtep'L 'to'Ùç ~oaç K:at 'tÒ
~ouKroÀ.tov on:ouò'(i Kat kmt.tEÀ.EL<;t cruvoùmv 'i.oroç È:rtionç rtov<iv KaÌ. <jlpov-'ttl;;rov ÈKeì:voc; 1lv, 'i va f,tll ÀÉyro m't :rtÀÉov· èv 'ljrt)xst 'taÀatrruprihl, ilv KOIXCt'tl À<YIJf,U:voç· Kopulj>àç K!ll qxipayyaç, !(aL rrmàç K!lL EVEK'!l
•vmu.E,rnc· 'lJÙì(EL 'te K!lÌ :rt(t'(E'tt\1 Kat aép!.W Kpuf.«)tç :rtpo-mur,utmv. :1totfi<lLVù111.
Bosco, coltivazione e allevamento nelle Vite 149
il pascolo dei cavalli, nei quali viene sempre osservato molto disordine a causa della loro naturale selvatichezza; infatti, se hanno alcuni che li conducono e come guide, tuttavia l'irrazionalità precede affatto l'insensibilità, e del tutto convenientemente: infatti questi basandosi sulla velocità delle zampe non vogliono, o per meglio dire, non possouo essere condotti al pascolo docilmente[ ... ]. Infatti tale è la natura dei cavalli: tutta calda e bollente; perciò essi, più di ogni altra specie di animali, sono eccitati dai loro appetiti naturauss.
Oltre alle piante eduli poco fa ricordate il bosco offriva anche altre importanti risorse. Nella Vita di Elia Speleota sì narra che un monaco "fu inviato un giorno dai confratelli in alta montagna per procurare ntcraav"s6. Si allude qui, evidentemente, all'estrazione della viscosa pece bruzia trasudante dalle incisioni praticate su pini e cerri, molto apprezzata fin dall'epoca romana e variamente impiegata87• Quella della Vita di Elia Speleota non costituisce I 'unica attestazione di essa nella tradizione agiografia italogreca. Un canto popolare in dialetto calabro, purtroppo non corroborato da altre testimonianze letterarie,
85 Ibidem. pp. 84,21-86,6: "Io-rs òk :~taV'twv Vft<Ì.ÌV tKaomç ~ 'tWV LMWV VOI! lÌ UKÀllpa 'tLç èO"tL Kat ilìpo1rwv [tEO'tfi' èv lì!) :n:oÀÙ (n:oÀÙ cod. Messan. gr. 29, :n:oÀAlj ed. e cod. Neapolit. II A 26) n:pò; 't<\) à.ypt(!l 'tÒ a:mK'tOV (èhaK't<lV ed.) !j>UOLKooç FO'tiN ÙEÌ 6smpov!tsvov· et yàp JtpociyoV'taç nvaç rxoum ,;ai.ha Kat JtPOllYtl'topa;, ù~J..' l-t à.Xoyia. n:av'tmç tijç à.vat06l'JOtaç È!;cipxet, Katl!ci.Aa etldrtwç· tÒKU'tl'J'tt yàp noooov ÈJtepeLMI!Eva, vé~wem 't(;(U't(;( EÙKOÀ.lOç où ~oVÀ.Il'tm i], !tdMOV où l:lci:l1JVll'taL [ ... ]. Totat'rtll yàp l((;(t n T<ÒV 'tmtwv !j>Vmç 6EPilli 'tLç OÌVll Kat ll:rtEpl;;Éouoa· lìtò Kat npòç 'tàç lj>UOLKÒ.ç opÉ!;nç Jtà.oav UMllV l;;q)wv lj>umv Ì'mo'l]V'tm (Èn-rot1V'tm ed.).
86 Vìta Eliae Spelaeotae, § 94, p. 885: 'Yn:ò lìÈ 'tWv ~wvaxrov 'tOiJ mtllAaiou ('toùç llJ1Àaiouç ed.) Ù,"toO'taÀEtç Èv 'totç Ù1!JtÌ,o(ç opwt JtpÒç 'tÒ Èpyal;;eofJm Jttooav. Quanto al luogo dove tale raccolta sarebbe stata effettuata si deve notare che il preteso toponimo TOÙç II'l]ì.aiouç. interpretato come accusativo plurale, dipendente dal participio Ù:rtOO'taÀeiç, di un sostantivo indicante una località identificata, a partire dal Minasi, con ìl monte Pidia sito a settentrione di Delianova (cf. l'excursus di GiLLseppe Rossi Taibbi in Vita Eliae iunioris, p. 203 con la nota 8}. nasce in realtà da un'errata lettura del manoscritto da parte dell'editore bollandista. In base a un controllo autoptico sul codice del passo in que:stuJne (f. 48), il testo va infatti rettificato in 'tOiì OJtllAalou, genitivo singolare riferito
!!Ovaxtiw, interpretando quindi la frase "inviato dai monaci della spelonca (scilicet ìl monastero rupestre nei pressi di Melicuccà)" e non "inviato dai monaci a Pilei"
87 Sullo sfruttamento della pece bruzia in età nonnanno-sveva c[ P. De Leo, Mestieri. lavoro nelle documentari latine, in Me.vtieri, lctvoro e nella Caltsbria medlfi!Wllll: organizzazwm. Atti dell'VIli Ctmgresso storico calabrese, P<llml Soveria Manndli 1993, p. 133.
150 Andrea Luzzi
tramanda infatti che dalla raccolta di pece bruzia sull'Aspromonte avrebbe tratto i poveri mezzi di sussistenza anche Leo (o Leone) di Africo, futuro santo patrono di Bovass.
Ma la risorsa più importante e sfruttata del bosco medievale era senza dubbio il legno e gli stessi monaci sono più di una volta presentati nei Bioi intenti al taglio di alberi per procurarsi il legname. Emblematica in tal senso la rappresentazione dì Leone-Luca da Corleone che, recatosi a far legna "ad usus monasterii" e raccoltane una certa quantità, ritenendo di non avere la forza necessaria per trasportarla tutta in una sola volta, decide dì dividerla "in duas sarcinulas". Preso il primo carico sulle spalle si avvia quindi verso il monastero, convinto di dover ripetere il percorso per trasportare il secondo carico di legna, ma questo invece lo seguirà miracolosamente da solo tra lo stu-:: pore dei confratellì89. Nella Vita di Saba da Collesano è poi ricordato l'utilizzo della legna per realizzare una sorta di argine contro lo straripamento del fiume Sinni che era giunto a minacciare il monastero e le sue vigne9o. Occuparsi di alberi poteva comportare anche dei rischi: l'autore della Vita di Elia il Giovane, ad esempio, annovera, tra le numerose categorie di miracolati dal santo, anche quella composta da "coloro i quali erano caduti dagli alberi e avevano le membra del corpo spezzate"9t; al monaco Luca, poi, incaricato da Elia Speleota di abbattere un albero sul ciglio di un burrone che ostruiva parzialmente l'ingresso del monastero rupestre, s'impiglia la veste nei rami e precipita insieme all'albero stesso nel dirupo, pur rimanendo miracolosamente indenne grazie alle preghiere del santo92• L'abbattimento degli alberi si riallaccia alla alacre attività agricola, attuata su più ampia scala, che,
88 Tale canto, segnalato per la prima volta e parzialmente trascritto e commentato da A. Basile, San Luca di Bova santo calabrese dimenticato?, "Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata" n.s. 2, 1948, pp. 132-135, è stato in seguito integralmente pubblicato da V. Nadile, La pietà nelle preghiere e nei canti popolari di tradizione bizantina, in Calabria Bizantina. Civiltà bizantina cit., pp. 90-91. Sul santo patrono di Bova cf. A. Acconcia Umgo, S. Leo, S. Luca di Bova e altri santi italogrecì, in Calabria Bizantina. li territorio grecanico da Leucopetra a Capo Bntzzano, Soveria Mannelli 1995, pp. 75-77.
89 Cf. Vita Leonis-Lucae, p. 88,167-178.
90 Cf. Vita Sabae iunioris, § 13, pp. 23-24.
91 Vita Eliae iunioris, § 33,658-660, p. 50; n:imovte; ÈK KCÙ Ollvtpl~Ofll'-VOL'tÙ f,1ÉÀ111:0\Ì \>W!!U:iLlJ<:,.
92 Cf. Vita Elia<' 52-53. pp. 868-869.
Bosco, coltivazione e allevamento nelle Vite 151
per usare le parole di Filippo Burgarella, "si verificò nel Mezzogiorno italiano, anche al di fuori delle province bizantine, a partire dal X secolo ed investì la terra con diboscamenti, dissodamenti, bonifiche [ ... ]"93, attività della quale i monaci furono non gli unici, ma certo tra i più attivi protagonisti. Mi limiterò a ricordare a tale proposito la pratica del diboscamento per mezzo del fuoco, tecnicamente nota come debbio, che presenta il duplice vantaggio di liberare rapidamente il terreno dall'intricata vegetazione incrementandone sensibilmente, nello stesso tempo, la fertilità. Tale tecnica dì diboscamento è, come è noto, chiaramente attestata più volte nelle due Vìte composte dal patriarca di Gerusalemme Oreste sia relativamente alla già ricordata regione di Ctisma nelle vicinanze di Agira94, sia in relazione alla turma di Mercurio95. Più problematica è la menzione del debbio nell'episodio della Vita Nili che presenta i monaci della comunità nilìana a lavoro su un monte, mentre, per usare le parole dell'agiografo, "facevano rotolare gli alberi incendiati per diboscare e rendere il territorio produttore di grano anziché di legno"96. Il demonio si prepara a recar loro danno, ma Nilo, avvertito dì ciò in spirito, per tutto il giorno li sorveglia e li incoraggia a pregare incessantemente per difendersi dal nemico. Il demonio finisce con l'allontanarsi svergognato, e l'unico danno che riesce a produrre, facendo cadere un grosso albero, è la morte di un cane. Meglio sembrerebbe adattarsi a tutta la situazione descritta nell'episodio il participio KEKO!l!lÉVa, "tagliati", anziché KEKau!lÉva, "bruciati", considerato anche il fatto che la confusione tra le due forme è tutt'altro che inspiegabile dal punto di vista paleografico: è sufficiente infatti che nel primo my si accorci il tratto verticale iniziale, per leggere, in una minuscola con lettere assai ravvicinate, -Kauinvece di -KO!l-· Con questo passo della Vìta Nili siamo direttamente passati dall'incolto alla coltivazione. Più volte nei Bioi i monaci sono raffigurati mentre adempiono il precetto che comanda di lavorare, per
93 Cf. F. Burgare!la, Lavoro. mestieri e professioni negli atti greci di Calabria. in Mestieri. lavoro e professioni cit., p. 77.
94 Cf. Vita Christophori et Macarii. § 3. p. 76.
95 Cf. ibidem. § 10, p. 83; Vita Sabae iunìoris. § 7, p. 15.
Q!J Vita Nili iunioris, ~ 43, p. 87: Tùiv bè àOENpriìv èv KllÀLOV't(l)V 'ttl TÒ àvoi:l;at tmÌ (~vtÌ 1;;1H,Ofjll.1jJlJ\J,
152 Andrea Luzzi
usare l'espressione dell'autore della Vita Gregori prior, "in agricultu~ ra laborando"97. Nicodemo di Cellarana, narra l'agiografo Nilo, presa una piccola zappa che possedeva e allontanatosi alquanto dalla cella, cominciò a zappare la terra98. Stefano, il rozzo discepolo di N ilo il Giovane già prima menzionato, lavorando con i monaci, vecchio di più di settanta anni e assai incurvato dalla vecchiaia e dalle molte malat~ tie, non alzava la testa nella messe o nell'aia per l'intero giomo99. Filareto il Giovane, ricevuto dall'egumeno l'incarico di lavorare un terreno del monastero un tempo produttore di fichi ma ormai inselva~ tichitosi, prende anch'egli la zappa e altri attrezzi agricoli e si reca a compiere la sua attività di dissodamento grazie alla quale l'incolto si trasformerà in un orto rigoglioso1oo. Elia Speleota, nonostante la sua
menomazione (per un episodio di mala sanità aveva perso tutte le dita della mano sìnistralOl), con la sola mano destra zappava diii· gentemente e alacremente "ev 'te 'tqJ àypq> Ka't 'tqJ Krptq>"Io2. Si noti, in quest'ultimo caso, la distinzione, tecnicamente molto precisa, tra l'attività agricola svolta nel campo, ovvero in aperta campagna, e quel~ la svolta nell'orto. Fra le colture del campo gli autori dei Bioi citano con una certa frequenza le leguminose (senza specificazione di fami .. glia: i legumi secchi, ocr:rrpta o ocrrrpsa, come è noto, erano una delle componenti principali del regime alimentare monastico), e inoltre i cereali (frumento e orzo), e le vigne, colture ampiamente testimoniate aoche nelle fonti documentarie. Un solo riferimento, invece, alla tivazione degli olivi, ma molto interessante per la storia dell'ulivicol~ tura nella Calabria e Lucania prenormanne e finora, per quel che risulta, non messo in evidenza. Lo si trova nella Vita di Saba da Collesano, precisamente nell'episodio relativo alla penuria d'olio necessario per alimentare le sacre lampade dell'altare verificatasì nel monastero di S. Michele arcangelo sito nella turma di Mercurio, penu .. ria alla quale porrà poi rimedio il taumaturgico intervento di Saba. Il patriarca Oreste in tale passo annota, relativamente all'olio, che '•non
97 Vita Gregorii prior. § 4, p. 464. 98 Cf. Vita Nicodemi, § IO, p. 108.
99 Cf. Vita Nili iunioris, § 94, p. 130. JOO Cf. Vita Philareli iunioris, pp. 92,25-94,12. 101 Cf. Vita Eliae § IO, p. 852. 102fbidem. 13. p.
Bosco, coltivazione e allevamento nelle Vite 153
era possibile trovame in quei confini poiché la regione non era adatta alla produzione dell'olio e, se lo si voleva acquistare nella stagione propizia alla sua produzione, si era costretti ad accingersi a un viaggio dì tre e talvolta sette giomi"l03. Se Oreste non ha qui introdotto un dato inventato al fine di conferire una patina di veridicità al ben noto topos agiografico della miracolosa moltiplicazione dell'olio, più volte presente anche nell'agiografia italogrecaJ04, e dobbiamo dunque ritenere veritiera la sua affermazione, questo passo della Vita di Saba costituirebbe una diretta testimonianza del fatto che nel decimo secolo l'ulivicoltura non era praticata nella turma di Mercurio, a differenza di quanto invece accade oggi nella stessa regionetos. Del resto questo dato sembrerebbe ben accordarsi con la scarsa diffusione della coltivazione dell'olivo fino alla metà del secolo undecimo, rilevata, su base documentaria, da Augusto Lizìer complessivamente per gran parte dell'Italia meridionaletoo e da André Guillou relativamente alla turma delle Saline e alla Calabria centro-settentrionale in generelo7. La Vita Fantini sembrerebbe infine offiire una testimonianza, per la prima metà del decimo secolo e per il versante tirrenico lucano o calabro settentrionale, della coltivazione del lino e della sua lavorazione con la tecnica della scotolatura, delle quali non si trova attestazione, per la stessa zona, nelle fonti documentarie finora editeJ08• Passando alle colture dell'orto, oltre alle frequenti e generiche citazioni di ortaggi e ver-
103 Vita Sabae iunioris, § 38, pp. pp. 52-53: [lTJOÈ òwm:òv ~v Èv n)iç optmç ÈKEt
vmç EUpELV, OÙK Ènn:ytÙ€Lffiç rrpÒç ÈÀ.atOU <j)opÙv ÈXOUOTjç 't1Ìç zwpaç K<Xt ~OUÌI.éj!Evòç nç OOvllOaa6m Ka't'U ye 't'ÒV TOÙ ÈÀatou Katpov (KatpÒv, ed.), 't'pttÒV Tjj!EpWv òòòv Èvime oè Kat buù ljvayKul;;e't'o a't'éì-.ì-.w6m.
104 Sui topoi agiografici connessi con l'olio, con particolare riguardo per l'agiografia ìtalogreca, cf. V. von Falkenhausen, Gregor von Burtscheid und das griechische Monchtum m Kalabrien, "Romische Quartalschrìft fùr christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte" 93, 1998, p. 223 con le note 42 e 43.
IOS Ct:, ad esempio, la bella descrizione del paesaggio moderno della regione offerta da B. Cappelli, Una voce del Mercurion, "Archivio Storico per la Calabria e la Lucania" 23. 1954, p. l (ora in Idem, li monachesìmo basiliano ai confini calabro-lucani, Napoli !963 [col titolo: Voci del Mercurion], p. 201).
106 Cf. A. Lizìer, L'economia rurale dell'età prenormanna nell'Italia meridionale !Studi su documenti editi dei secolì IX-Xl), Palermo 1907, p. l 22.
107 Cf. A. Guìllou, La tourma des Salines dans le thème de Calabre (%P! siècle), "M•6latt~tes de Française de Rome. 83, 1971, p. l O (ora in idem, Culture
~ìt4ranitine (Vfr,Xle s.). London 1978 Reprints CS76], X),
§ 13, 1·17, p. 416 commentario pp. 498-499.
154 Andrea Luzzi
dure, Àa:x_ava, altro caposaldo dell'alimentazione dei monaci, e di alberi da frutta, sono ricordate distintamente le erbe medicinali, nella Vita di Luca da Demennato9, e le cipolle, nella Vita di Vitale da Castro .. novo, anche se in un contesto un po' ambiguo, in quanto, nonostante 1 'agiografo affermi esplicitamente la loro provenienza dall'orto uo, sembrerebbero in realtà appartenere piuttosto a una specie selvatica tossicalll. Ma è ormai tempo di chiudere, non prima, però, di aver notato che, al di là delle pur numerose menzioni di colture e tecniche agricole, la misura di quanto gli autori dei Bioi e il pubblico al quale questi si rivolgevano fossero il prodotto di una civiltà rurale e conta,. dina è data, in ultima analisi, dall'alta frequenza delle metafore agri~ cole impiegate nelle Vite, spesso non di meccanica derivazione bibliA ca, metafore alle quali gli agiografi ricorrono, talvolta dichiarandolo esplicitamente ~ è questo il caso dell'autore della Vita di Filareto iJ Giovanell2 ~, per risultare più chiari e convincenti nel loro discorso.
109 Vita Lucae ab. Armenti, § 9, p. 340: herbaria cataplasmata, et epithemata languidi& apponebat.
IlO Vita Vitalis, § 8, p. *28: Vade et affer in medio mensae de cepis hortì: has enim S. Vitalis solitus erat cum pane hordeaceo manducare.
Ili Come suggerisce l'effetto nocivo da esse esercitato sul commensale dì Vitallll. Augusta Acconcia Longo ha avanzato l'ipotesi che si tratti di cipolle selvatiche del genere della scilla, inserendo tale episodio nel solco della tradizione agiografica iniziata dal'asee· ta Cirillo lo Scillofago e codificata letterariamente da Cirillo di Scitopoli: cf. Acconcilt Longo, Santi monaci italogreci ... cit., p. 145.
112 Vita Philareti ìunìoris, p. 116,6-10: "Ean o€ 'ttç Ka'tlhepoc; :n;sp't 't0U't01J
cbtoppfJ'tO'tEpoç lWt ~a6trtepoç 8v (Ov ed.) oi] Kaì. ÈK !pucrtKO'Ù 'tLVoç :n:al~al\et~'!lfl.-KU'tà 11ta.v ;;Éooç Ìlltl~OÀ'Ì]V KU6' OOOV OlOv 'tf Ù:n;opoiJOL ltl)iJcr<X:n:c,()o·l}~ 'tOt•'tou ( 'tO'Ù'tou ed.) m) ;tt{)ppùl nmJ
OO:!I:'fl~cEC. K (tl