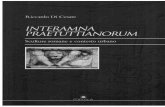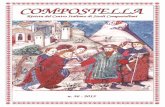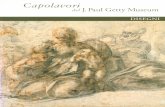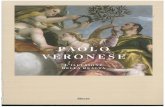Qualche considerazione su Palladio e Roma: una veduta topografica e i disegni dall'antico
Il doge Giovanni Gradenigo, lo scultore Andriolo de' Santi e i disegni di Grevembroch
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Il doge Giovanni Gradenigo, lo scultore Andriolo de' Santi e i disegni di Grevembroch
5ÈÈ.,\1'il - '',,,i, ,.:liiA ,t.,,L tjhli--,lc*l',: ,-t, :ì tr_
lltTi.rritt !-'rl' ir r-it l-,:.i\tiir,.....,rr1- .." .,;-i uir:]llit lF'eeiig- ) '---
:r rr.lrt Lii .'rlll,-il b',
'- \t i) . L)'t\\ir).. t-ì,1 li|i\t :]i0\\ t,lD
lr.i[,'O'i,...- .t'.r r ri..' ìll-L Lll r\r\-f(ll!l,t\l
10 1 ._-ì
,$l,.il
SANTA MARIA GLORIOSADEI FRARI
Immagini di Devozione, Spazi della Fede
DetsotionaL Spaces, Images of Piety
a cura di
C*ro Consnro - DBSoRAH Howano
PADOVACENTRO STUDI ANTONIANI
2015
Santa Maria Gloriosa dei Frari : immagini di devozione, spazi dellafede = devotional spaces, images of Piety / a cura di = edited byCarlo Corsato, Deborah Howard. - Padova : Centro Studi Antoniani,2015. - XXVIII, 324 p., [128] carte di tav. : ill. ; 24 cm.(Centro Studi Antoniani ; 5ó)
rsBN 978-88-95908-00-7
I: Corsato, Carlo
II: Howard, Deborah
1: Venezia - Santa Maria Gloriosa dei Frari
726.5094531r - Ed. 22.
Con il contributo della Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari,Yenezia
Con il patrocinio dell'Archivio di Stato di Venezia
ISBN 978-88-9s908-00-7
O 2015 Associazione Centro Studi AntonianiPiazza del Santo, 11 - I. 35123 Padovaemaíl: i nfo@cent rostud.iantonía ni- ilwww. c ent ro s t u di an t o ni an i. i t
O 2015 Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, VeneziaSan Polo 3072 - 30125 Yeneziaemail: basilica@basilic adeifrai. it
È vietata la riproduzione, anche parziale, effettuata con qualsiasi mezzo, compresala fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.The photocopying of any pages of this publication is illegal.
zqouFqte(A
tId
a
a
I!a
III
I
I
:
"
INDICE GENERALE
DEBoRAH HowARD - Canro Consero, Santa Maria Gloríosa dei Frari:Architecture and Community
Crnro Consrro - RENATa MARZI, Padi Guardiani e Panoci di Santa MariaGloiosa dei Frai, 1241-2015
Identità e rappresentazione I ldentity and Representation
Dor,{el CoopeR - Marueu KovAÒEuc, Chist's Blood Framed in Silver and
Marble at the Frai .
Lvore Haurerr, n Sure G&te of Heaven,: The Sactisty at Santa Maia GlorÌosa
dei Frai .
MADDATENA Besso, Nel cuore rli Venezía: il restauro del coro dei Frari. ' '
ISABELLA CEccHrNr, [Jn'assenza illustre- L'Assunta di Tiziano, i Ftai e
I'Accademía ( I II ó-I917/I9I9)
MARrA ANToNELLA BELLTN - PATRTzIA Vorplro, lz wtrate della cqppella
Comer nella chiesa dei Frari ....MoN,rcA DEL Rro - GIUSEPPE SAccÀ, Il bilancio sociab della comunità dei Frai
(1920-1960): Vittore Chialina e I'archivio parrocchiale
Comunità e scuole / Community and Confraternitíes
M,lnrrN Gxer, Il campo dei Frai. Appunti sulla formazione, la funzionee lo percezione
Massrno BrssoN, Le confratemite ai Frai: architettura e fruizione degli
spazi. . . .
CARro CoRSAro, Public Piety and Pivate Devotion: The Abar of the Cross'
Titian and the Scuola della Passione at the Frai
JoNernar.r Glrxot, Frali and Fratelll: The Frai and Music for ty'ze Scuole
IsABELLA CEcct{INI, I Fiorentini (ti Frai: uso pubblico dello spazío religioso
in età modema.
IAìN FENLoN, Claudío Monteverdi at the Frai
15
27
39
53
63
77
91
101
tt7
127
139
324 INDICE GENERALE
L'arte della memoria / Memorialisation
Cnrsrrxe Gu,cRNreRr , Il monumento funebre di Francesco DQndolo nella saladel Capitolo ai Frai .
Srr,vre D'AMsrosIo, Il doge Giovanni Gradenigo, lo scultore Andnob de'Santi e i disegni di Grevembroch
Mencener Br.v, The Emiliani Chapel in the Frari: Background andQuestions
Mrcner, HocnMeNN, In famiglia Bemardo nella chiesa dei Frari ....,,..Vrîloruo PAJUSCo, Devozione e committenza: Giuseppe Volpi di Misurete
ai Frari .
Arte e committenza I Art and Patronage
ALLrsoN SHERMAN, . Soli Deo Honor et Gloria": Pietro Inmbardo e il ta'mezzo di Santa Maia Gloiosa dei Frai .
LoRENzo GIovANNT Buoruxxo, Revisilirzg the Frai's High Altatpiece: The Assun-ta Frame and Titian as Régisseur
VrcroRrA AvERy, o Belo et onorato per onor ancho suo": Alessandro Vittoria'sZane Ahar Reconsidere<l
EleÌle Frosro - VALENTINA SAPTp:NZ^, Andrea Vicentino ai Ftai .
Ar,Essro PASIAN, Z'Aìbero Serafico di Pietro Negi: note storiche, iconografia,committenza
Tevore ( 1-128)
ABBREVIAZIoM FoNTI aRcHMIsrIcHE
FoNTr ForocRAFrcHE
BIBLIoGRAFIA
INDICE DEr NoMI E DEI LUocHI . . .
INprce osr-LA BASTLTCA DEr FRAzu , , . .
151
163
177
187
199
2tl
22:1
:r-:
:rT"
SIrvrl D'Atrenosro
IL DOGE GIOVANNI GRADENIGO,LO SCULTORE ANDRIOLO DE' SANTI
E I DISEGNI DI GREVEMBROCH*
Il perduto monumento funebre del doge Giovanni Gradenigo, mortonel 1356, si trovava nella sala capitolare dei Frari, la stessa che avevaaccolto, intorno al 1339, quello di un suo predecessore, Francesco Dan-dolo (Tav. 62)t. L'aspetto, in parte originario, della tomba è restituitoin un acquarello di Jan Grevembroch (1754), in cui appare un sarcofagogià allora non più integro ma ancora situato nel Capitolo, come si indi-ca nella didascalia del foglio (Tav. 67),. Il disegno fu pubblicato, per laprima volta, nel resoconto sui restauri che, a inizio Novecento, avevanointeressato la chiesa3, e in seguito fu descritto nei fondamentali contribu-ti sui dogi di Venezia del 1939 e del 19ó0a, dove si segnalò l'autorevoleattestazione di Marin Sanudo (m. 153ó) che aveva indicato il sepolcronel medesimo ambientes. Più recentemente, è stato verificato come talecollocazione rispecchi quella primitiva, dato che è ricordata in più cro-nache veneziane già della seconda metà del XrV secoloó.
L'acquarello non è stato, invece, valorizzato quale fonte privilegiataper indagare almeno tre problematiche che ruotano attorno aÌ monu-mento, a partire dai motivi che portarono ad una scelta di sepoltura,per questo doge, proprio nella basiÌica dei Frari. Si tratta, inoltre, di
* Ringrazio Nicola Riccadona, per aver facfitato i sopralluoghi ai Frari, e TizianaFranco per il generoso accompagnamento nella ricerca.
t Vedi CRrsrrNA GueRl.rIERr in questo volume.2 JAN GREvEMBRoCH, Monumenta. Veneta. et antiquis rudeibuq templorum, alia-
rum4ue Aedìum Vetustate coll.apsantm collecta studio, et cura Peti Grad.onici tacobiSer., 3 voll., BMCV, ms. Gradenigo-Doìfin 228, 1754-1759,I, f. 26.
3 Al.oo Scor,qR.t, La chíesa di Stq. Maria Gloiosa dei Frai ed il suo recente restauto,n Venezia. Studi di arte e storia o, 1 (1920), pp. 148-171 (fig. a p- 171).
a ANDREA DA Mos\o, I dogi di Venezia, con particolere iguardo alle loto tombe,Ongania, Venezia 1939, pp. 8ó-87, 352, fie. 22; IDEM, I dogi di Venezía nella vita pub-blica e privata, A. Martello, Milano 19ó0, pp. 127, 563.
5 MAùN SANUDo, Vítae ducum venetotum, < Rerum Italicarum Scriptores >, a curadi LuDovrco MuMroRl, XXII, Milano 1733, col. ó41.
ó Derne hNcus, The îombs of the Doges of Venice, Cambridge University press,Cambridge 2OO0, pp. 217 nota 13; 224 nota 13.
164 s[\'IA D'AMBRosIo
una testimonianza che aiuta a comprendere il momento e le cause dellasua dispersione, anche grazie ad altri disegni, dello stesso autore, menocottos"i.rti in sede critica. Permette, infine, di interrogarsi su quale fosse
la configurazione originaria dell'arca che può essere ipotizzata confron-tando il sarcofago ritratto con alcune tombe veneziane affini nella tipolo-gia, rintracciabiii in particolare nella produzione, di metà Trecento, delloscultore lagunare Andriolo de'Santi e della sua bottega.
IGRADENrcoerFnenr
Tra la fine deÌ Duecento e la prima metà del secolo successivo furonoeletti ben tre dogi appartenenti alla famiglia Gradenigo, la cui nominaporlò il casato, già considerato tra i più illustri del patri'ziàto veneziano,all'apice della sua fortuna: PieÍo (1289-13ll), Bartolomeo (1339-1342) e
Giovanni (1355-135ó)?. A differenza degli avi, sepolti rispettivamente nelmonastero di San Cipriano di Murano e nell'atrio della basilica di SanMarco8, Giovanni fu inumato nella chiesa francescana della città dopola morte awenuta l'8 agosto del 1356, a seguito di poco pirì di un annodi governoe. Per i dogi di Venezia era usuale che fossero gli esecutoritestamentari a prowedere alla loro sepolturaro e, in questo caso, taleruolo era ricoperto dalla moglie e dai figli: lo si ricava dal testamentodi Giovanni, dettato il 7 gennaio del 1353, mentre si preparava in veste
di podestà alla partenza per Capodistria, nel quale, però, egli non diedealcuna disposizione riguardo al luogo dove voleva essere tumulatorr.
La collocazione del suo monumento in questo specifico confesomendicante, piuttosto che in altre chiese veneziane alúettanto ambite. izpimis i Santi Giovanni e Paolot2, può essere, comunque, giustificata da
7 GruseppE GuLLtNo, Una famiglia netla stoia: i Gradenigo, ín Grade, Venezía, i Gt-denígo. Catalogo della mostra (Venezia, BNM, Libreria Sansoviniana, 1 giugno - IIuglio 2001), a cura di MaRrNo ZoRzI e SusY MARcoN, Edizioni della Laguna, \'e2001, pp. 130-153; FRANco RossÌ, Quasí una dinastía: i Gradenigo tra ){1lI e )( '*::Èit Grado, Venezía, i Gradenígo, pp. 154-187.
3 hxcus, îàe îombs, pp. 85-86, 124-132.e FMNco Rossl, Giotanni Gradenigo, ( Dizionario biografico degli itaìiani '. llltr'
Roma 2002, pp. 306-310.ro Sulla committenza dei monumenti dogali di questo periodo, cf. MÌcGl-E T:r'
lz tombe dei dogi di Venezia (ca. 1250-1400). A proposíto del libro di Deha Èax.< Ateneo Veneto ), 189 (2002), pp. ó1-70 (p. ó4); GHERARDo Onlx-u, Corpo serrEs-e sacco dí paglía. Le onoranze funebi deí dogi, in Cangande della Scala. I-a "t::tt c icorredo funebre di un príncipe nel medioevo europeo. Catalogo della mosu'a \'su'Museo di Castelvecchio, 23 ottobre 2004 - 23 gennaio 2005), a cura di P.!o'-{ Ir -ErroRE NAproNE - Grerq Menre V,cMNIN1, Marsilio, Yenezia 2O04, pp. 201-20i g L.
tt ASYe, Notaile, Testanenti,b. 540A, n. 79 (Rossr, Giaranní Gladenigo, W * ,-t2 La facies funeraria, in epoca medievale, della chiesa domenicana ri\:'q-
come quella francescana a partire dagli anni Venti-Trenta del XIV se.^olo t Iindagata da TTZLANA FRANco, Scuhura e pittura del îrecento e del pimo G.o.Ú
IL DOCE CIOVANNI GRADENIGO 1ó5
diversi motivi. Innanzitutto si deve ricordare la notizia, riportata nellacinquecentesca cronaca Magno, di un decreto del Maggior Consiglio invirtù del quale, dopo Andrea Dandoìo (m. 1354), sarebbero state proibitealtre tombe dogali in San Marco; tale decisione, tuttavia, non è, almenofino ad ora, suffragata da ulteriori documentirs. A1 di là di questa notizia,va rilevato che ai Frari erano stati sepolti, oltre a importanti esponentidella classe dirigente della Repubblica'a, due dogi predecessori di Gio-vanni Gradenigo: il citato Francesco Dandolo e, ancora prima, all'epocadella più antica chiesa francescana, Jacopo Contarini (m. 1280). Questiriposava, infatti, in un'arca sontuosa che Sanudo poté ancora vederenel chiostro 15 e di cui, probabilmente, si conserva la lastra frontale delsarcofago, inserita nel portale di passaggio tra il chiostro dei Fiorentinie quello della Trinità'6.
Dalla lettura dei testamenti di alcuni membri della famiglia Grade-nigo emerge, inoltre, il suo intenso legame con i frati minori di Veneziache, nel corso del Trecento, ricevettero, in più occasioni da parte delcasato, richieste di sepoltura e aiuti economici per la ricostruzione dellaloro basilica, ar,viata nel terzo decennio del Trecentor?. È questo il caso,ad esempio, di un omonimo deì doge che, nel testamento del 1346, or-dinò di essere ( meso in una archa de piera in terra a basso " all'internodell'edificio'8. Si possono, poi, menzionare altri due fatti significativi,relativi a figli di Pietro Gradenigo, zio di Giovannire. Fiordeliso, mogliedi Nicolò Gradenigo, nelle sue ultime volontà dettate nel 1348, vi chieseuna sepoltura con l'abito nde le sorore del tergo ordene de santo Fran-cesco >, lasciando nlibre XXV per la fabricha ' e altre per le esequie ele messe2o. Pii.r noto nella letteratura critica, è invece il testamento del
Il gotico, ín Ia basilica dei Santi Gíotanni e Paolo. Pantheon della Serenissima, a curadi Grusspps PAVANELLo, Marcianum Press, Venezia 2O12, pp.67-75.
13 Mrr"reo CAsrNr, l gesli del pincipe. Ia fesîa poliîica a Firenze e Venezia in etàinascímentale, Marsilio, Venezia 199ó, pp. 31, 57 nota 13. Cf, anche PrNcus, IheTombs, p. 14ó; Merrrr GllEr., Facciate sacre a scopo profano. Venefia e la política deimonumenti dal Quattrocento al Setfecenfo, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,Venezia 2002, p. 38.
ra Come testimoniano le due tombe erette attomo al 1336-1337 e conseÌlate inchiesa; cf. WoLFcANG Worrprs, l^a scubura veneziana gotica (1300-1460), 2 voll., Ye-rezia 1976, catt. 31, 38.
's Ser'.uoo, Vitae ducum, col. 572; PtNcus, The Tombs, pp. 82-83.16 La sua individuazione si deve a Guroo Trcr-Bn, Riesame del cantiere del Duomo
di Gemona (1280-1337), in Gemona nella. potia det Fiult una socieÍà cittadina nelTrecento. Alti del convegno (Gemona del Friuli, 5-6 dicembre 2008), a cura di ProroCAMMARoSANo, CERM, Trieste 2OO9, pp. 155-252 (p. 1ól nota 23).
17 Vedi DesoRAs HowARD - CARro CoRsATo in questo volume.tB ASYe, Notaile, TestqtLenti,b 483, n 84 (Rossr, Grad.enigo, Giovannt, pp. 30ó, 309).re FRANco Rossr, Píetro Gradenigo, < Dizionario biografico degli italiani,, LMII,
Roma 2002, pp. 344-349-
'zo Ar,noNro SARroRr, Ar.cfti?io Sartoi. Documenti di stoia e arte francescana, a cuÍadi GrovaNu LursETro, 4 voll., Biblioteca Antoniana, Padova 1983-1989, If2, pp. 1883-1884 n. 1.
t66 SIL!'IA D'AMBROSIO
1327 di Marco, fratello di Nicolò. Egli aveva stabilito di destinare, perl'erezione di un convento francescano, una considerevole somma che,concessa nel 1391, in parte venne utilizzata per iÌ cantiere dei Frari:furono allora alzate, infatti, le paraste delle navate minori a livello delcoro, sulle quali compaiono gli stemmi gentilizi con la serie di gradini'z'.Anche più tardi altri esponenti del casato, o personaggi che vi eranocollegati per legami di parentela, scelsero questa chiesa come luogo disepoltura: la dogaressa Maddalena Contarini (m. 1373), moglie di Bar-tolomeo Gradenigo, fu tumulata nel menzionato monumento di JacopoContarini, poiché apparteneva al suo stesso ramo familiare22, mentreun certo Lorenzo Gradenigo, figlio di Marco, nel 1386, chiese di essereinumato nel convento23.
Ad eccezione deila dogaressa Maddalena Contarini, non è noto dovele tombe, non più esistenti, indicate nei documenti fossero collocate, cosìcome non è precisabiìe su quale parete del Capitolo venne eretta quelladi Giovanni: ciò a causa delle radicali trasformazioni che questa sala hasubìto tra Sette-Ottocento e, soprattutto, alla genericità delle indicazionifornite daÌle cronache trecentesche e dalle successive fonti veneziane2a.Eppure la sala, che oggi conserva unicamente il mausoleo Dandolo, man-tenne lungo i secoli un'importante destinazione funeraria, dato che vi sitrovavano, perlomeno, altre quattro tombe, anch'esse andate disperse:quella nella quale Maria Zane, nel 141ó, dispose di essere sepolta e cheaveva già accolto le spoglie del marito e del figlio'?s; l'arca di BertuccioQuerini (m. 1430), di cui si è salvata l'epigrafe (Venezia, Seminario
'zr Isrooro Gerl, S. Maia Gloriosa dei Frari. Storia di una ptesenza francesczzra Venezia, Grafiche Veneziane, Yenezia 1992, pp. 41-42: ANroNIo IACoBINI, L'archtz-tura religiosa, ií Sîoùa di Venezia. Temi. L'arte, I, ^îteccar'i, Roma 1994, pp. 185--:(p. 195); Grovrr{u VarENzANo, Santa Maia Gloiosa dei Frai, it L'architettura gc.1:trenezian&. Atti del convegno (Yenezia, 27-29 novembre 1996), a cura di FRr.i(=-ValcaNo\ER e WoLFcANc WoLTERS, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, \-m2000, pp. 123-130 (p. 129); EADEM, L'architettura mendícante a Venezia: Santí Git,€.úe Paolo e Santa Maia Gloriosa dei Frai, in Il secolo di Giotto nel Veneto, a ctaz ùGToVANNA VarENzANo e FEDERTCA ToMoLo, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ec la-Yenezia 20O7, pp. 527-557 (p. 539).
2'z Horrv S. HuRLBURT, The Dogaressa of Venbe, 1200-1500: Wife and lcon. Èi4-Macmillan, New York-London 2006, W- 142, 190, 279 r'otz 16.
'z3 Senronr, Archí,/ío Saúoi, Ixz, pp. 1768-1769 n. 49; 1769 n. 52. Ci- h.cR.osll, Marco Gradenigo, < Dizionario biografico degli italiani,, L\{II, Rooa lG,pp.332-339.
2a FRANcESco SANsovrNo, Venezia cittd nobilissima et singolate, Iacomo Sarq,Venezia 1581, ff. 69v,239ri FRANcEsco SANSovINo - GIovANf.'r STRTNGA, l a.ra. .:rnobilíssima et singolare, Atobello Salicato, Venezia 1ó04, ff. 159r, 38Or: R.rSarsorrro - GrusrrN'raNo MaRrrMoNI, Venezia città nobilissima et singoLare, S.eà@ a
Venezia 16ó3, pp. 192, 57O.
'z5 Fn-cNcesco FERRAru, 1/ Francescanesímo nel Veneto: dalle oigini ; :a IS. Francesco dcl Deserto. Appunti per une storia della provincia teneta di -iÉ
-iDocumentazione Scientifica Editrice, Bologna 1990, p. 362.
Patriarcale)'z6; un sepolcro riservato al casato Foscarini, forse cinquecen-tesco2?, e un quarto appartenente ai Gradenigo. Era il monumento cheCristina Morosini, vedova di Marco Gradenigo, nel testamento del 1548,indicava <in Capitolo in alto a man destrao2s, ossia sulla parete a destradella porta di comunicazione con il chiostro della Trinità.
L'" noronrnco sEpuI,cRo ' r,rsro o,c, FLAMINTo CoRNrn
L'acquarello di Grevembroch (Tav. 67) ritrae un sarcofago che, allametà del Settecento, era già stato danneggiato: penso, infatti, sia daescludere che il disegno vada considerato come un "non finito o, poichésarebbe l'unica eccezione all'interno della raccolta, sempre precisa nelrestituire le opere scultoree.
Al riguardo risulta particolarmente significativa la coeva testimonian-za di FÌaminio Corner, che nel 1749 accennava alla presenza nel Capi-tolo dei Frari delli honorifico sepulcro ' di Giovanni Gradenigo, mentrenel 1758 lo definiva ( minore > rispetto ai monumenti degli altri dogicustoditi in basilica e nel chiostro2e. Il diverso tono potrebbe significareche la manomissione, attestata nell'acquarello, era awenuta proprio nelbreve giro d'anni che separa le due versioni del testo, anche perché quelsepolcro, in origine, doveva essere n honorifico, piuttosto che n minore n,come si illustrerà a breve.
La vicenda può, forse, essere messa in relazione con i massicci lavoriawiati nel 1753-1754 per smantellare le tombe poste nel chiostro dellaTrinita; tali operazioni vennero poi riprese in conseguenza ai crolli diparte del refettorio d'inverno che, awenuti nel 1775 e nel 1778, determi-narono danni anche all'adiacente Capitolo30. Grevembroch riuscì, tra iÌ1754 e il 1759, a riprodurre quattro di questi numerosi sepolcri destinati
IL DOGE CIOVANNI CRADENICO 167
'z6 GTANNANToMo Moso Nr, la Chicsa e il Seminaio di Santa Maia. della Salute inVenezie, Aîtorrelli, Verrezia 1842, pp. 81-82 n. 72; EuueNuer-e ANroMo CrcocNA, Co,.pasdellc kcrizioni di Venezia e delle isole della laguna veneta, a cúta di Pter*o PAzzr conil contributo di SaRA BERcAMAsco, Edizioni Biblioteca Orafa di SantAntonio abate,Yenezía 2OOl, p. 1004 n. 14ó.
27 S,reroru, Archtuio Saftoi, lU2, pp. 1778 n. 110; l78l n. 134.
'z3 lbidem, pp. 1817 n. 81; 1820-1821 n. 20.
'?e Fr,{MrNro CopNpp., Ecclesiae Venetae antiquis monumentis nunc etiam pimumeditis íllustrat@ ac in decades d.istributae, 14 voll., Johannis Baptistae pasquali, Venetiis1749, IX-)<, p. 300; Ioeu, Notizie storiche dclle chiese e monasteti di Venezia e Totcellotratte dalle chiese eenete e torcellane, Giovanni Manfrè, padova 1258, p. 3ó7 (come ènoto, l'edizione italiana uscì con diversi rimaneggiamenti).
30 Sanronr, Archivío Sartoi, M, pp. 1818, 1916 nn.71-72; 1917-1924i cÍ. IDEM,Guida stoico-artktica della Basilica di S, M. Gloiosa. dzi Frai ín VeneTia, ll Mes-saggero di Sant'Antonio, Padova 1949, pp. 152, 155; Iosu, S. M. Gloriosa dei Frui,Il Messaggero di Sant'Antonio, Padova 195ó, pp. ó9-70; GA.î1 S. Maria Gloiosa,pp. 54-55, 105-107.
168 SILVIA D'AMBROSIO
ad essere distrutti o dispersi poco dopo. Tre erano lastre terragne sullequali compariva il ritratto dei defunti e, nei primi due casi, un'iscri-zione: quella della "venerabilis domina Francisca Martiniaco" (m. 13ó4,Tav. ó8a), quella di un vescovo (m. 1380, Tav. 68b), e una terza conun personaggio in abiti militari (Tav. 68c)3r.
Iì quarto era un monumento piìr articolato con la statua di un cava-liere armato stesa sulla cassa sotto la quale, tra le mensole, era inseritoun riquadro figurato con cornice a doppia dentellatura e l'arma gentiliziaripetuta: il rilievo centrale mostrava il committente inginocchiato davantialla Madonna con il Bambino e un'iscrizione in francese antico con lasua data di morte, il 24 dicembre del 1337 (Tav. 69a)3'?. A mio parere,il solo gisant potrebbe essere riconosciuto in un'opera (Londra, Victoriaand Albert Museum) per la quale è stata avanzata la coretta datazione,per via stilistica, al 1370 circa (Tav. ó9b)33: le due figure sono, infatti,sowapponibili in diversi dettagli, dalla posizione dei corpi all'armaturaindossata, fino ai particolari della spada lungo il fianco sinistro e dellenzuolo funebre.
Fu la soppressione del convento dei Frari, a seguito della quale labasilica divenne parrocchia e i locali comunitari trasformati in caserrnae poí destinati ad Archivio (1810-1815)34, a causare la sistematica elimi-nazione dei sepolcri che si sono ricordati nella sala capitolare e di quelliche affollavano il chiostro della Trinità, già di molto ridotti durante ilavori settecenteschi. Quelle pareti conservano, infatti, poche tracce dellaloro facies funeraria d'età medievale: alcune epigrafi, degli stemmi isolarie parti della tomba del celebre medico Guido da Bagnolo (m. 1362):'.È in questo contesto che dovette awenire anche la dispersione dell'ar-ca Gradenigo: nel 1815 Giannantonio Moschini, infatti, nominat'a ne-
3r GreveuRoor, Monumenta Veneta, l, ff. 30, 41, 5ó; CIcocNA, Corpus, p. lll-nn. 255, 257 .
12 Gnevaurnocu, Monumenta Veneta, 1II, f. 44; Crcocna, Corpus, p, l01l n. 19133 Wolrers, Itt scuhura venezÌana, cat. 115. Nel pubblicare il pezzo JoH\ P:-
HrNrrssv (Catalogr.re of lralirm Sculpture ín the víctoia and Albert Musewn, 3 tlHer Majesty's Stationery Office, London 1964, I, cat.50) riportava la sua prorer:=:za da una chiesa della Giudecca dove era stato acquistato dal collezionista Jo-1-:Henry Fitzhenry che, generoso benefattore del museo inglese, lo donò nel l9l0: --:;indicazione non può, tuttavia, escludere una sua più antica collocazione pre-.. -chiostro francescano. Sulla figura di Fitzhetu'y (m. 1913), si veda Psrsn DE\T e E:-':È-:N^ptoNE, Reading and witing at the v&A. An episode in the collection of ltalian G-:,.,:sculpturc, "Joir:raal of the History of Collections ", 24, 2 (2011), pp. l-14.
3a Uvspeto Fnerzor - Drre Dr STEFANo, Ic chiese di Venezia, Nheri, Veneia ::-:p. 46; FRANcEscA CAvazzaNA RoMANELLT, Il Metfoio d'estate nel convento dei F-:- :Venezia, ora sede dell'Archivio di Stato. Storia e restaui, ( Bollettino d'Arte", óS ::!,'pp. 13-33; SAIrToru, Arcàivio Saftorí, 1V2, pp. 1925 n. 107; 1953-1989; G.rrn.,i r,l:--:Gloiosa, pp. 1O9-718.
3s ALsenro Rrzzl, Scultura estema a Venezia. Corpus delb sculture etaticlt :i:-',r'to di Venezía e della sua Laguna, Stamperia di Venezia Editrice, Venezia l9Sl : i:caf,73, î,2; CrcocNA, Corpus, p. 1002 nn. 133-134.
IL DOGE GIOVANNI GMDENIGO 169
Capitolo solo lurna del doge Francesco Dandolo, poiché, evidentemente,quella del collega non era più in loco36.
L,( ARCA DORATA MOLTO BELLA ) VTSTE N,T MA TN SA,IUOO
Iì confronto tra il monumento disegnato da Grevembroch e analo-ghe tombe veneziane tre-quattrocentesche permette di integrare, almenoin via di ipotesi, le parti mancanti nell'acquarello facendo immaginarel'u honorifico o aspetto di queÌla che Marin Sanudo aveva descritto comeun'( arca dorata molto bellao37. Il foglio ritrae la fronte di un sarcofagopensile retto da mensole fogÌiacee con lo stemma di famiglia: tra i so-stegni awebbe potuto comparire l'epitaffio, assente però già all'epoca diSanudo, La cassa si caratterizzava peî una cornice superiore, con ornativegetali, e una inferiore modanata, sporgenti al centro e agli angoÌi perinquadrare tre nicchie a conchiglia; queste, alternate da lastre e fian-cheggiate da colonnine tortili, dovevano ospitare altrettante statue a tuttotondo delle quali, allora, si conservava solo quella di sinistra. La figura,che si spera possa riemergere da qualche collezione privata o museale,risulta di incerta identificazione iconografica: il libro che tiene tra lemani farebbe pensare, infatti, a san Giovanni evangelista, in onore deldefunto, ma il suo volto barbato si abbinerebbe meglio alla raffigurazio-ne di un san Bartolomeo3s.
La tipologia del sarcofago dogale trova un felice accostamento conle arche, simmetriche tra loro, dei signori Ubertino (m. 13a5) e Giaco-mo II da Carrara (m. 1350) che, dall'inizio dell'Ottocento, si fronteggianoagli Eremitani di Padova, in prossimita de a controfacciata (Tav. ?0):erette da Andriolo de' Santi nella cappella maggiore della chiesa diSant'Agostino, le tombe, considerate tra le più fastose nel panoramadella produzione sepolcrale veneziana del Trecento, erano integrate adun'ampia decorazione affrescata da Guariento, di cui sopralvivono alcunisignificativi frammenti riferibili a una scena paradisiaca3e. Dopo la lororealizzazione, questo tipo di sarcofago conobbe una certa diffusione in
ró GrANNANroNro Moscrn"r, Gaida per la città dí Venezia all'amico delle Belle Arti,2voll., Avisopoli, Venezia 1815, II, pp.200-201.
3i Saruoo, Vitae ducum, col. 641; il passo è ricordato in Da Mosro, I dogí di Ve-
nezia, p. 86i lozu, I dogi di Venezia nella vita, p. 127; PrNcus, The Tombs, p- 217 not,13; Rossr, Q4asi una dinastia, p. 182; Ioeu, Giownni Grudenigo, p. 309-
13 Un simi-le san Bafolomeo ritratto con i-l libro si trova, ad esempio, nel rilievocentrale deÌ sarcofago del doge Bartolomeo Gradenigo in San Marco (cf. Pwcus, îfueTombs, p. 128).
re La proposta di riconoscervi questo soggetto è di ZULETKA MuF./tr, Il Paradisodei Cataresi. Propaganda politica e magníficenza dinastica nelle pitture di Guariento a&nt'Agostino, in Arte di corte in ltalia del Nord PrcgtammL modelli, artisti (1330-1402ca-). Atti del convegno (Lausanne,24-26 maggio 2012), a cura di SERENA RoMANo eDE\rsE ZARU, Viella, Roma 2013, pp. 95-122.
170 SIL!'IA D'AMBROSIO
terra veneta, a partire da due monumenti per i quali spesso, in sede
critica, si è avanzato il nome di Andriolo o si è indicata un'attribuzio-ne alla sua bottegaao: quello del giureconsulto Rainiero degli Arsendi(m. l35S) (Padova, basilica del Santo, chiostro del Capitolo, Tav, Tla)at,e quello veronese di Giovanni della Scala (m. 1359) (Verona, Santa Ma-ria Antica, cimitero scaligero, Tav. 71b)a'. Tuttavia, rispetto al modelloiniziale, queste immediate repliche presentano due notevoli varianti: laraffigurazione, nella nicchia mediana, di una Madonna con il Bambinonon stante ma seduta in tronoas e una semplificazione, nella forma,dell'arcosolio superioreaa.
A Verona, entrambe le varianti verranno, in seguito, riproposte indue sepolcri quattrocenteschi i cui sarcofagi, sebbene esibiscano dellemodifiche nell'ornamentazione rispetto ai prototipi carraresi, si collo-cano, comunque, in questa tradizione. Si tratta dell'arca di Barnaba daMorano (m. 1411) (Verona, San Fermo Maggiore, Tav.72), riferita al la-picida lagunare Antonio da Mestre e attorno alÌa quale era afflescato unGiudizio [Jniversab di Martino da Verona, conservatosi in frammentias, e
a0 Cf. Amú SGaRTELLA, Per un iesame del cnrp.Js di magister Andriolus tajapiera.< Commentari d'arte ", XVIII, 2012, Îasc.52-53, pp. 22-36 (pp.27-28)', E,ioEM, I nflessidellla scultura veronese del îrecento sulla produzione scultorea di Andtíob de'Santi-
" Commentad d'arten, XD(, 2013, fasc. 54-55, pp. 45-55 (pp. 47-50).4r 'WoLrers, La scuhura veneziana, cat. 83; IDEM, Il îrecento, in Iz scuhure de..
Santo di Pado,'ta, a cura di GrovANNr LoRENzoNrr, Pozza, Vicenza 1984, pp. 5-30 (pp. l+l5); Rurn WoLFF, Le tombe dei dottoi ol Santo: considerazíonì sull.a laro tipologit, ,f-Santo,, fasc. l-3, 42 (2002), pp. 277 -297 (pp.282-284)-
a2 WoLrERs, ht scultura,/eneziana, cat. 84; S[vtA D'AMsnosro, Il monumento rutt-bre di Giovanní delLa Scala e fut chíesa dei Santi Feflno e Rustico al Ponte Na.'i, .\'è-rona lllustrata ", 19 (2006), pp. 43-57; ETToRE NApIoNE, Iz Arche Scalígere dí VetezAllemandi, Venezia 2009, pp. 198-200, 322-329,469,471.
a3 Per un reportorio dei numerosi ri-lievi veneziani trecenteschi di questo tiFalcuni dei quali di spiccata cultura andriolesca, si veda SZILARD PAPP, Ua Cristo 6.--buito a.d Andiolo de Santi nello Szépmúvészeti Múzeum di Budapest, * Arte Vere '69 (2012), pp. 11-21.
aa Per la tomba di Giovanni della Scala, che ha subìto ben quattro u?sla-ziE .di cui si conserva unicamente la cassa, si può immaginare un baldacchino "-i'E'a quello del monumento di Rainiero degli Arsendi, testimoniato dagli eruditi r<enesi del Settecento; cf. D'AMsnosro, Il monumento funebre, p.43; NaPro\E. IJ -{=iScaligere, p. 323.
as Sulla tomba di Barnaba da Morano, si rimanda, con bibliografia precedc. rcontributi di Tquu Fp.aNco, Tombe dí uomini eccellenti (dalla fine del )all olk r-.metà del XV secolo), ln I Senti Feftno e Rustico. Un cubo e una chiesa in Vero,s t sdi Plolo Gour"nru e Carenln GEMMA BRENzor.'r, Federico Motta, Milano 20O{. p. 3r-261 (p.241); Etoeu, Tombe di medíci e gìutìsti in San Fermo Maggiore a lizc. rMedíoevo: immagini e ideologie. AIti del convegno (Parrna,23-27 settembre :rc. rcura di A*runo CARLo QurNrAvALLE, Electa, Milano 2005, pp. 608-618 (p. ól:. F-Quid superbìtís misseù? Devozìone, orgoglio di casta e memorie famikai nei nt'ú-ti funebi di ambito reneto tra Tre e Quattrocento, in 14 Morte e i suoí rtui it f!ù, tMedioevo e prima età modcrna, a cura di FRnNcEsco SenTsrnnqr - Greri lrfr*u \'rfl -ANNA ZANGARTNT, Firenze University Press, Firenze 2007, pp. 181-208 (pp. l!'r 16.
IL DOGE GIOVANNI GR.ADENIGO I7I
di quella di Paolo Filippo Guantieri (m. 1430) (Verona, Santa Maria dellaScala), scolpita daì padovano Bartolomeo Crivellari dopo il 1432 e, poi,arricchita dalla decorazione pittorica di Giovanni Badile 0443-1444t46.
A differenza delle repliche, nel sarcofago del doge la figura centraledella Vergine con il figlio, doveva essere in piedi, come conferma laforma allungata della corrispondente nicchia: il riferimento principaleè, dunque, con le tombe dei signori padovani dove quelle statue furonorealizzate da Bonino da Campione in un momento successivo al lavoro,evidentemente rimasto incompiuto, di Andrioloa?. Al proposito non credoche, ab origine, il monumento di Giovanni Gradenigo non fosse statocompletato nella sua decorazione, come si vede nel disegno (Tav. 6?),poiché non si spiegherebbero altrimenti le parole ammiraie di Sanudo edi corner: sulla base degli esempi citati, vanno anzi immaginate piccolestatue non solo sulla fronte ma anche nelle due nicchie laierali, non ri-tratte dall'acquarello. Più problematico risulta pronunciarsi, invece, sullapossibilità che sopra il cataletto ci fosse stata la raffigurazione distesadel defunto, secondo una soluzione che, per quanto riguarda i sepolcridei dogi, ha la sua prima attestazione nell'arca di Andrea Dandolo del1354 circa e, poi, una larga fortunaa8.
Non è dato sapere, neppure, se la parte scultorea avesse un comple-tamento pittorico sotto al baldacchino, già perduto nel Settecento. En-trambi i dogi precedenîemente sepolti ai Frari erano, infatti, ritratti nellelunette sopra i sarcofagi, con la moglie e al cospetto della Vergineae: in
aú Sullo scultore padovano, cf. GreN MaRrA V^R*.nNr, L,autore d.ell'arca Guantieri ínS. Marin dclla Scala d.i Verona, < Atti e memorie dell'Accademia di agdcoltura scienzelettere di Verona,, 15ó (19?9-1980), pp.239-2ítt sul monumento e sugli affreschi sivedano, anche per rinvii bibliografici, TrzrANA FMNco, pisanello et les expéiences com-plémentaires de la peinture et de la sculpture à Vérone entre 1420 et j440, in Hsanello,Atti del colloquio (Parigi, Musée du Lourre, 26-28 glugno 199ó), a cura di DoMrNreuEConoerrmr, 8,. _Py, Padgi 1998, pp. 121-160 (p. 135); Mauro Covt, Ilna proposta perGiovanni Badile, anistu (laterab ", ir Santa Maia della Scata. ta grande ìyabriia"dei Servi di Maia in Verona: stoia, tradomazíoni, consetva.zione, i cura di AnrwoSANDRIù, Frati Selvi di Maria, Verona 2006, pp. 283-299.
a7 11 definitivo riconoscimento della mano del maestro lombardo si deve a LeuuCAvAzzrNr in Giovanni da Mílano. Capolavoi del gotico fra Iombardìa e Toscana. C^ta-logo della mostra (Firenze, Galleria dellîccademia, l0 giugno - 2 novembre 200g), acura di DANEtn PARENTT, Giunti, Firenze 2008, cat. 3l; EADEM, Un'incursione di Boninoda Campione alla cotte deí Caîares| in Arte di corte in halia del Nord, pp. 37-ó1 (condatazione al 1375 circa). Una cronologia al 1351-1352 circa è invece proposta da Ar.lteSc*reue, Ossentazíoni suglí ìnflussi campionesí nelle opere di Andìo[o ie' Santi, . ArteLombarda ", 170-171, 2014, l-2, pp.2O-3O (p. 26).
a3 Pwcus, The Tombs, pp. 132-147 Elosu, Hatd times and ducal radiance. AndreaDaydolo and the consbaction of the ruler in founeenthcentury Veníce, iî Venice rccon_si.dered. The history and cíúlization of an italian city-sto.te,'a cura di JoHN MARTTN eDer,uvrs Rou,u,ro, Johns Hopkins University press, Baltimore-Londra 2000, pp. g9_13ó,
ae Alla decorazione pittorica dei monumenti dei dogi eretti ca il Duecentà e il Tre_cento ha dedicato un intervento TrzrANA FRANco (Iz pitnre delle tombe dogak (n -fiVsecolo), in Tombe dogali: la commemorazione deì principi della repubblùa ,eneziana.
172 s[\'rA D'AMBRosIo
quella di Jacopo Contarini la rappresentazione era a mosaico, secondol'attestazione di Sanudo, mentre il monumento di Francesco Dandoloesibisce la coppia ducale nella tavola di Paolo Veneziano (Tav. 62). Latipologia della tomba Gradenigo fa, tuttavia, propendere per un'eventualeaggiunta ad afflesco, come si vedeva, fino al 1815, sopra l'urna del dogesuo successore, Giovanni Doìfin (m. 13ó1), nella configurazione che ebbenella cappella maggiore della basilica dei Santi Giovanni e Paoloso.
ANDRToLo ne'SaNrr ATToRNo AL 135ó e r sARcoFAco u Peolo Sewllr
L'aver calato la tomba Gradenigo nel più ampio panorama scultoreogotico veneziano consente di proporre, in mancanza di documenti sullasua committenza, una cronologia di riferimento; in questo modo si potràvalutare, altresì, la possibilità che la sua esecuzione sia da ricondurreall'attività lagunare di Andriolo de' Santi, visto che è in quella cuÌturafigurativa che si rintracciano i riscontri più puntuali. Dato che, neìlastruttura, il sarcofago risulta speculare agli illustri modelli carraresi,piuttosto che ai monumenti di Rainiero degli Arsendi e di Giovanni dellaScala, penso sia lecito suggerire una sua ragionevole datazione attorno al135ó, ossia a ridosso della morte del doge. Avendo a disposizione unica-mente un disegno, invece, la questione attributiva deve essere affrontatacon la massima cautela.
Tuttavia, il percorso di Andriolo, protagonisîa della scena artisticadell'entroterra veneto tra il 1342 e il 1375, si connota per un forte le-game con la sua città natale, soprattutto nella prima fase della propriaattivitàst, sebbene proprio a Venezia non restino suoi lavori documenta-ti52. Dopo aver diretto la realizzazione dei due portali della chiesa fran-cescana di San Lorenzo a Yicenza (1342-1345)s3, egli risulta impegnatoa Padova, dove rimangono Ìe opere eseguite oltre la metà del secolo, apartire dalle arche carraresi; per questa commissione rimane la ben nota
Atti del convegno internazionale di studi (Venezia, Centro tedesco di studi veneziani,Fondazione Giorgio Cini, 30 settembre - 2 ottobre 2010), in corso di stampa).
s0 Sugli affreschi reaìizzati da Guadento per la tomba Dolfin, si rimanda, concompleta bibliografi.a, a Zutanxt MuRAr, in Lt basilica dei Santi Giotanní e Paolo,cat. l3b.
sr Loursr Bounour, îime-kceping in fourfeenth-century Venetian sculpture: Andriobde Santi's absetrteeísm, nThe sculpture joumal,, 19.1 (2010), pp. 102-107.
s'? Sul problema dell'attMta di Andriolo a Yenezia nella sua fase giovanile, si vedaANNA ScARRELLA, Andiolo de' Santí al Palazzo Ducale di Venezia, " Commentari d'arte >,
X!aI, 2010, fasc. 45, pp. 39-49.sr I documenti del cantiere vicentino sono stati pubblicati da Roooro GN-L}, Con-
îibùti alla stotia della scullura veneziana. L - Andiolo de Sa/rli, < Archivio Veneto,,44-45 (1949), pp. 1-40; cf. la revisione di Lourse Bourour, The Franciscans and AiPatronage ín fuúe Medieval ltaly, Cambridge University Press, Cambridge 2OO4, pp. 7l-88. Per i due portali si veda, da ultimo, Luca TRE\,lsaN, Il tempio di San Inrenzo aVicenza, Zel, Treviso 2011, pp. 69-77.
IL DOGE CIOVANNI CRADENICO 173
quietanza di pagamento del 1351, relativa alla tomba di Giacomo II, cheperò fu firmata a Venezia assieme ai soci Alberto di Ziliberto e Fran-cesco di Bonaventurasa. Il successivo incarico attestato risale al 1364,quando gli venne affidata la costruzione di una cappella, andata perduta,nella chiesa degli Eremitaniss. Tra la ricewta del 1351 e il contrattodel 1364 va ricordato un atto del 30 marzo del 1354 nel quale un (serAndriolum taiapiera > veniva eletto arbitro per dirimere una lite tra dueartistisó. Nonostante la genericità del nome, è improbabile che si trattidi un omonimo: viene, infatti, specificata la qualifica di tagliapietra e ildocumento, oltre ad essere stato redatto a Yenezia, si colloca bene, dalpunto di vista cronologico, nel percorso di Andriolo de'Santi.
La sua più che plausibile presenza in città nel 1354, la lacuna docu-mentaria del decenlio successivo e, soprattutto, la corrispondenza con learche carraresi, rendono perlomeno verosimile l'ipotesi di un suo direttocoinvolgimento nell'erezione della tomba di Giovanni Gradenigo. Siamo,d altronde, in un momento particolare per il contesto artistico lagunare,dato che nel 1355 era stato impiccato Filippo Calendario, l'architettodella fase trecentesca di Palazzo DucaÌe secondo la tradizione cronachi-stica, coinvolto nella congiura di Marino Falier5?: la sua uscita di scenadovette lasciare, in città, un vuoto che fu colmato, negli anni Sessanta,da Andrea da San Felice, a mio a\,viso, allievo dello stesso Andriolo,documentato autore dei sepolcri dei due dogi successori del Gradenigo,il citato Giovanni Dolfin (m. 1361) e Lorenzo Celsi (m. 13ó5)s8.
ta Gsror"AMo BrscARo, I-e tombe di Ubertìno e Jacopo Da Carrara, "l{rte",lI, 2(1899), pp. 88-97 (p.97, doc. I). Dell'abbondante bibliografia sui monumenti carraresi,si segnaìano i contributi di WoLrERs, Lt scultura gotica, caft.40-41; GurDo TtcLER, Lscultura del Ttecento a Padova, in Giotto e il suo tempo. Catalogo della mostra (Pa-dova, 25 novembre 20OO - 29 aprile 2001), a cura di Vrrronro SGARBT, Federico Motta,MiÌano 2000, pp- 248-261 (pp. 250-251); ANNA MARrA Spuzzr, Andiob de' Santi e lnsua bottega, (Il Santo', Îasc. l-3, 42 (2002), pp.329-334i ZILETK Munet, Ie arche diUbetino e lacopo II da. Carara nel percorso at'tistico di An&íolo de' Santi, "Predella,,33 (2013), pp. 185-200.
5; Il documento è stato reso noto da ANDREA MoscHETn, Studi e memorie di anetrecentesca padovana, 11, Andriolo de Santi scultore veneziano, " Bollettino del MuseoCivico di Padovan, IV,2l (1928), pp.281-297 (p. 293, doc. I). La commissione dellacappella è stata indagata recentemente da CaÙo Pùuscr, Il cotnplesso degli Eremimnia Padova: l'orchitettura dí chiesa e convento dalle oigini a oggi, tesi di dottorato,Università degli Studi di Padova, 2010-2012, pp. 83-110; Mun-lo, Iz arche di Ubertínoe lacopo II, pp. 193-195.
56 Brscreo, lz tombe, p. 97 doc. II.17 Sul dibattito critico attorno alla figura di Filippo Calendario, cf. Guroo Tr-
etw' Iz facciate de| Palnzzo, I'ispirazione dell'anista. fui cultuta figurativa di 'FilippoColatdaio', in Il poema dcl fempo. I capiteui del Palauo Ducale di Venezia: storia eiconografia, a cura di ANToNro MANNo, Canal & Stamperia, Ve\ezía 1999, pp. l7-33jIDLr{, L'apporto bscano alla scukura veneziana del îrccento, ín Il secolo di Giotto nell'eneîo, a c\Ía di GroveM{e VArENzaNo e FEDEPJCA ToNroLo, Istituto Veneto di Scienze,l.ettere ed Arti, Venezia 2OO7, pp- 235-275 (pp. 237-238).
53 Su-rra D'Auarosro, in ln basilica deí Santi Giovanni e Paolo, cat. l3a.
174 sLVrA D'AMBRosro
L'analisi dell'acquarello consente, infine, di guardare sotto una diversaluce la presenza, ai Frari, sulla parete di fondo del transetto settentrio-nale, di un altro sarcofago appartenente alÌa medesima tipologia: quellodestinato alle spoglie di Paolo Savelli (m. 1405), che la Repubblica onoròcon solenni esequie, adoperando il ritratto equestre ligneo che sowastal'urnase (Tav. 73). Luso, nel monumento Savelli, di un sarcofago il cuimodello dipende da esemplari della metà del XW secolo, costituisce unproblema spinoso che è stato, in passato, più volte sollevato dagli studio-si, pensando che tale scelta fu forse espressamente prescritta dal defuntoo dall'esecutore testamentarioóo. Recentemente, invece, con bella evidenzale sole tre piccole statue della fronte sono state attribuite allo scultoreveneziano Filippo di Domenico, con una cronologia attorno al 1405ót.
Come per il sarcofago di Giovanni Gradenigo, i confronti tipologicipiù efficaci per quello Savelli si rintracciano con le arche di Ubertino eGiacomo II, soprattutto per la nicchia centrale con una Madonna conBambino stante. La profilatura dei riquadri e la cornice inferiore appaio-no, invece, identiche a quelle del sepolcro dogale: sono, infatti, caratteriz-zate da un peculiare andamento a livello delle parti aggettanti, circolarenel mezzo e rettilineo ai lati, a differenza di quelle che arricchiscono letombe carraresi, arrotondate e percorse da una decorazione vegetale. Siè di fronte, certo, alla <ripresa) di un prototipo precedente che, allora,non era più .alla modao a Venezia ma che aveva, nella stessa chiesa,l'esempio prestigioso dell'< arca dorata molto bella' del doge GiovanniGradenigo.
Asstnect
The tomb of Doge Giovanni Gradenigo (d. 135ó) is no longer extant, but ir isrecorded in a water-colour by Jan Grevembroch, which depicts it aìready aÌteredbut still in its original position in the Chapter House of the Frari. This chaprer-
se Cf. TTZIANA Fnxco, Michele Giambono e il monumento a Cortesía da krep, flPoligrafo, Padova 1998, p. 38; GNER, Facciate sacre, pp. ó7, 85 nota 289.
ó0 Cf., anche per il dibattito critico, WoLrERs, ltt scultura veneziana, c2lL l:='.ADRIANA Aucusrr, Monumento funebre dí Paolo Savelli, in Pisanello. I luoghi d"l gottrintemazionalc nel Veneto, a cura di FnlPpA M. ArsERTr GAUDroso, Electa, Mi-lano l9gÉpp. 322-323.
6r Leuu Cavezam, Un Profeta venezíeno di Filíppo di Domenico, in Le plaisir àrI'an du Moyen Age: commande, production et réception de I'oeuvre d'art, tulanges ahommage ò Xavier Barral i Ahet, Éditions A. et J. Picard, Parigi 2012, pp. ó(Mt:(p, ó09); Eeoeu, Da lacobello DaLIe Masegne a Bonino da Campíone, da Ma$trc,a.d AAa d'Este: qualche altro frammento di Mantoya tatdogotica, ii L'artisîa giro'.asÈforestiei, awentuiei, emigranti e missiotai nell'arte del Trecento in haJit del \rèAtti del convegno (Univerité de Lausanne, 7-8 maggio 2010), a cura di Sepesr Rq,ae DAMEN CERUTn, Viella, Roma 2O12, pp.241-268 (p. 249 nota 18).
IL DOGE GIOVANNI GRADEMGO 175
considers the evidence of the drawing in order to shed light on three aspects: onthe choice of the Franciscan friary for this Doge's tomb; on its original fourte-enth-century form; and on the reasons for its eventual destruction. The chapterthen investigates the changes inflicted from the middle of the eighteenth centuryonwards on the cloister where the Chapter House was located; indeed, the removalof the funerary monuments from its walls began at this time. The appearance ofsome of these lost tombs has been presewed in Grevembroch's drawings, whichhave allowed us to identifu a gísant (now London, Victoria and Albert Museum)as originating from this location. Lastly, on the basis of comparison with othersarcophagi of a similar t,?ology, it has been possible to date the ducal tomb toaround 1356; to attribute it to the workshop of the Venetian sculptor Andriolo de'Santi; and to identify it as an important precedent for the tomb of Paolo Savelliin the church of the Frari-
T.\: 67 &r/1,/,,!, ,L1 ,/,!,b,1trlr, '1/rIrr,,rrrli Ii,r1i, l,
a;r^1tiIti (;úrl. 1!.ì)l 26 (Jl\4(l\i l!1S
ttlLr :úld .atlikldR, dr Jrn Cr.\rmCr'à!Lnigo D!lJin 208).
{a)
T^\. 68 - \a) kÌpide di Ftrukeya \tani1lt..òt (b) I4strd linebt. ìl t::Tìniilàt (.) Lasttu lìLtd,c li sucn.ìeb ùcl .l1iosîtu.lelLa T.i,ìtti. t:t, ::ù|oùttrE la Vù1.1r1, f, loll. 30,41, 5ó (BMCV MS Gjaclcnigo Dolii :
i , -._:;.--:-;:-.:"
-].
ì,..r lF. 1t ìltJ fì\f, :,, lf),\
//N ./N -/t\ / 7Í:-îf /r: ,zf -,\\ tl.$iiiryrJlQssl0\?1 t?lltìiù"ìì
t I 'l'-'
II
!ì,\ aìrl - (r) lt,r,,rrrl,) ljjrrln li !rtji./) nl tjntnt rltlkt /,iiilri. (ln laù Gjc\rnlb,().h, '\r,),,r/,,ùrrld lllr,/r. lll. lol..].+ (Bù'lC\', NIS crad.Digo D!lJiÌr 201ì)i {b) Scùlto,.\rnczi.no .5/.rrl titlli/. li lrùnn), Londù, \;irtùir ind Alb.f ùlurcunr.
î{
-
L 1r) l,rlil(),) (lc Sr!ìLi l ,,brll))..., arl SrnLo. .hros1,o (lc CrpiLolo;
.tîiti l.lLr strla, \i.ronr, .hicsa di
'torùh. di lÌ.tritù) 1..!li Ar1.rLli, Prdo\a,(b) An.l .lo d. S.nti (ÌDl)ilo) iÌrrraSinri \4r,ia A,,ricr, s!polc,cr, scaìigc,o.
3F,{3'S
Tav 72 - Anronio da Mcstre e Mafino da Verona. ?òrróa di Ballù1!.t ::Da, cliesa di San Feùno Maesiore.