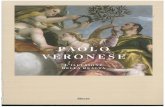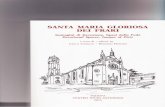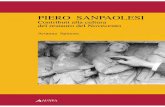Computer vision, archaeological classification and China's terracotta warriors (2014)
Contributi a Baccio da Montelupo scultore in terracotta, in "Nuovi Studi". 19, 2014
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Contributi a Baccio da Montelupo scultore in terracotta, in "Nuovi Studi". 19, 2014
REDAZIONE
ANDREA BACCHI DANIELE BENATI ANDREA DE MARCHI FRANCESCO FRANGI
GIANCARLO GENTILINI ALESSANDRO MORANDOTTI
Si ringrazia Milvia Bollati per l’aiuto nella redazione di questo volume
COMITATO CONSULTIVO INTERNAZIONALE
KEITH CHRISTIANSEN EVERETT FAHY MICHEL LACLOTTE JENNIFER MONTAGU
MAURO NATALE SERENA ROMANO ERICH SCHLEIER ANNE MARKHAM SCHULZ
TABULA GRATULATORIA
Silvana Bareggi Antonio Barletta Ezio BenappiEdoardo Bosoni Luigi Buttazzoni e Roeland Kollewijn Maurizio Canesso
Carlo Cavalleri Giancarlo e Andrea Ciaroni Ferdinando ColomboGiovanni Cova Minotti Fabio De Michele Gerolamo Etro Gianni e Cristina Fava
Paola Ferrari Enrico Frascione con Federico e Sasha Gandolfi Vannini Marco Galliani, Profilati spa Luigi Gambaro Matteo Lampertico Silvano Lodi jr.
Mario, Ruggero e Marco Longari Jacopo Lorenzelli Silvio Maraz Sascha Mehringer Alfredo e Fabrizio Moretti Gianna Nunziati Carlo Orsi Walter Padovani
Andreas Pittas Huberto Poletti Luca e Patrizia Pozzi Davide Sada Alvaro Saieh Simonpietro Salini Giovanni Sarti Tiziana Sassoli
Pier Francesco Savelli Mario Scaglia, Sit spa Bruno Scardeoni Rob e Paul Smeets Edoardo Testori Marco Voena
Si ringrazia per il sostegnoIntesa Sanpaolo
© 2014 TIPOGRAFIA EDITRICE TEMI S.A.S. - Tutti i diritti riservatiDirettore responsabile: Luca Bacchi
Registrazione nr. 912 presso il Tribunale di TrentoPubblicazione annuale. Euro 60,00
Progetto grafico: Paolo Fiumi e Gabriele Weber. Realizzazione a cura della redazioneSelezioni colore e bicromia: Tipolitografia TEMI - Trento
Redazione: 20121 Milano - Via Fatebenefratelli, 5 - Tel. e Fax 02/6599508Distribuzione e abbonamenti: Libro Co. Italia, 50026 San Casciano V.P. (Firenze)
Tel. 055/8228461 Fax 055/8228462 e-mail: [email protected] 978-88-97372-73-8
INDICE
5EMANUELE ZAPPASODI
Ambrogio Lorenzetti“huomo di grande ingegno”: un polittico
fuori canone e due tavole dimenticate
23GIOVANNI GIURA
Una fotografia per Ghirlandaio
31ANTONIO BUITONI
Percorso di Giovanni Antonio Bazzitra Reggio, Bologna e Parma
51DAVID LUCIDI
Contributi a Baccio da Monteluposcultore in terracotta
103FRANCESCO DE CAROLIS
«Per sua divotione». Il Crocifisso Berensonnel Libro di spese diverse di Lorenzo Lotto
109ANNE MARKHAM SCHULZ
The Life and Works of Jacopo Fantoni, Venetian Sculptor
123LUCA SIRACUSANO
“Egli supererà ogni aspettatione”.Il giovane Girolamo Campagnafra il collezionismo d’Oltralpe
e la basilica del Santo
145FERNANDO LOFFREDO
Il Pan Barberini, Giacomo da Cassignolae la scultura in marmi coloratinella cerchia di Pirro Ligorio
175GONZALO REDÌN MICHAUS
Un ritratto di Boncompagno Boncompagnidi Bartolomeo Passerotti
nella colección casa de Alba
181STEFANO PIERGUIDI
Gian Lorenzo Bernini e Antonio Raggialla cappella Alaleona
nei Santi Domenico e Sisto
193SILVIA MASSARI
Giuseppe Maria Mazza e l’‘accademia’ di palazzo Fava: nuovi documenti, nuove opere
211GIOVANNI SANTUCCI
Un disegno di Giovacchino Fortiniper il soffitto della chiesa
di San Filippo Neri a Firenze
223MARCO RICCÒMINI
Rossi e Piola: un’inedita combine
227ABSTRACTS
51 DAVID LUCIDI
CONTRIBUTI A BACCIO DA MONTELUPO SCULTORE IN TERRACOTTA
Se intendiamo analizzare gli eventi artistici che caratterizzarono a Firenze l’ultimo decennio del Quattrocento e i primi anni del secolo successivo non potremmo fare a meno di notare co-me questi siano stati contrassegnati dal fecondo scambio di esperienze avvenuto all’interno di una generazione di pittori e scultori tutti nati fra il 1465 e il 1475, tra i quali si distinse Bartolo-meo di Giovanni d’Astore de’ Sinibaldi, meglio conosciuto con il nome di Baccio da Montelupo. Proveniente dall’omonima cittadina del contado fiorentino dove nacque all’incirca nel 1469 1, Baccio visse per lungo tempo a Firenze, almeno fino al 1522, dove intraprese a partire dai pri-missimi anni novanta del Quattrocento un’intensa e longeva attività nelle vesti di poliedrico e versatile scultore, oggi noto principalmente per il ruolo assegnatogli unanimemente dalla criti-ca quale principale interprete in campo scultoreo della religiosità savonaroliana 2 e capofila nel-la produzione di carattere devozionale a cavallo tra i due secoli, in terracotta e in legno 3, nella fattispecie come autore di innumerevoli Crocifissi già lodati dal Vasari nella Vita a lui dedicata 4.
L’approdo dello scultore nella città di Firenze e l’ingresso nei principali circuiti artistici non fu agevole come accadde per altri suoi coetanei colleghi giunti dalla provincia e non avvenne prima del 1487 in quanto da una portata al catasto sottoscritta dalla madre Lisabetta proprio in quell’anno Baccio è registrato ancora nella sua città natale al fianco del fratello maggiore Astore e dell’ultimogenita Ismeralda 5, mentre il più grande, Piero, nato nel 1463, si apprestava a pren-dere i voti con il nome di fra Benedetto, nel convento domenicano di San Marco a Firenze 6. É plausibile che abbia ricevuto i primi rudimenti artistici nella città natale, iniziando ad acquisi-re confidenza con la plastica fittile già all’interno delle fornaci di Montelupo, patria della lavo-razione ceramica, svolgendo una sorta di saltuario discepolato, vista quella sua predisposizio-ne alle attività artistiche forse emersa sin dalla fanciullezza, senza però apprendere quelle no-zioni, come lo studio dell’arte del disegno, della scultura antica e delle opere dei primi maestri del Rinascimento fiorentino, fondamentali per una personalità che più avanti si sarebbe distin-ta nella città dei Medici per le doti di modellatore in terracotta e di scultore in legno, marmo e bronzo. Tale ritardo rispetto alle consuetudini del tempo, che prevedevano l’ingresso in botte-ga dei giovani apprendisti già intorno ai dieci anni, valse a Baccio almeno agli inizi un cammi-no difficoltoso rispetto alle esperienze dei suoi colleghi, in linea con quanto sembra conferma-re anche Giorgio Vasari che raccontava di un giovane Montelupo il quale “sviato dai piaceri” – o come meglio qui crediamo dalle risicate aspirazioni che in quel momento l’ambiente cultura-le del contado poteva offrirgli – “poco o nulla stimava l’arte” ma, “venuti gli anni della discre-zione, i quali arrecano il senno seco, gli fecero subitamente conoscere quanto egli era lontano dalla buona via; per il che vergognatosi degli altri che in tale arte gli passavano innanzi, con bo-nissimo animo si propose seguitare, ed osservare con ogni studio quello che con la infingardag-gine sino allora aveva fuggito” 7.
Nonostante l’età già avanzata Baccio dovette inserirsi in una delle migliori botteghe di scul-tura della città gestite in quegli anni da personaggi del calibro di Benedetto da Maiano, Giulia-no e Antonio da Sangallo, acquisendo perciò da subito l’occasione di mettersi al passo con gli
DAVID LUCIDI52
studi e riuscendo ad ottenere “que’ frutti che la credenza di molti da lui più non s’aspettava” 8. Egli trasse senza dubbio un considerevole vantaggio anche dalla posizione del fratello Piero, alias fra Benedetto, all’interno del convento domenicano di San Marco, uno dei maggiori cen-tri di produzione artistica della città tra le cui mura Baccio svolgerà gran parte della sua inizia-le carriera. Congiunzione che gli valse probabilmente anche l’auspicato lasciapassare verso il celebre, omonimo Giardino mediceo, l’accademia ante litteram voluta dal Magnifico dove al-le ordinanze dell’anziano discepolo di Donatello, Bertoldo, si educavano i giovani più promet-tenti – “Michelagnolo di Ludovico Bonarroti, Giovan Francesco Rustici, Torrigiano Torrigia-ni, Francesco Granacci, Niccolò di Domenico Soggi, Lorenzo di Credi e Giuliano Bugiardi-ni, e de’ forestieri: Baccio da Montelupo, Andrea Contucci dal Monte San Savino, ed altri” 9 – meditando e studiando la cospicua raccolta d’arte di casa Medici fatta di sculture classiche, di-segni e cartoni dei maestri del primo Rinascimento, di cui il giardino rappresentava una sorta di museo a cielo aperto.
Nonostante gli studi degli ultimi trent’anni, in particolare quelli di Borgo-Sievers 10, di Ca-roline Elam 11 e Nicoletta Baldini 12, siano riusciti a sfatare le tesi sostenute in passato da Karl Frey 13 (1907) e in seguito da Andrè Chastel 14 (1952), che negavano l’effettivo ruolo formativo svolto dal giardino e la sua frequentazione da parte di alcuni degli artisti citati dal Vasari, anco-ra oggi tuttavia permangono delle incertezze sul loro reale coinvolgimento tra i prediletti di casa Medici 15. Diversamente infatti da quanto accaduto per Michelangelo, la cui presenza alla cor-te del Magnifico è appurata da numerose fonti storiche e biografiche 16, o, ad esempio, con An-drea Sansovino, Niccolò Soggi 17 e Francesco Granacci 18, per altri sussistono ancora numero-se perplessità sulla reale frequentazione del Giardino di San Marco per l’assenza di notizie do-cumentarie19. É appunto il caso del nostro Baccio, a cui non è ancora stato dedicato uno studio approfondito capace di mettere in luce eventuali rapporti di famigliarità con l’entourage medi-ceo; spetta quindi alle pagine qui di seguito fornire le motivazioni necessarie a ristabilire questo legame, che non divenne esclusivo come per il Buonarroti, ma non per questo meno importante dato che tutte le personalità capaci di influenzare l’attività di Baccio intorno alla metà degli an-ni novanta del Quattrocento furono strettamente legate ai circoli culturali laurenziani.
La prima di queste fu il prete e antiquario fiorentino Francesco di Santi di Jacopo Albertini, personaggio nato come Baccio intorno al 1469 in una zona del contado, il villaggio di Acone, e giunto già dai primissimi anni Ottanta del secolo a Firenze dove intraprese un percorso che, dopo una breve esperienza come pittore, lo vide dedicarsi alla carriera ecclesiastica e allo stu-dio del diritto romano 20. É lo stesso Albertini a ricordare come all’età di dodici anni vada situa-to il suo ingresso nella bottega di Domenico Ghirlandaio 21 e in seguito l’approdo, forse in virtù di tale frequentazione, nella cerchia di Lorenzo il Magnifico dove poté approfondire la sua for-mazione umanistica e musicale sotto gli auspici di Agnolo Poliziano, Naldo Naldi e di un musi-co di nome Antonio 22. Il prologo della sua celebre opera considerata la più antica guida di Fi-renze, il Memoriale di molte statue et picture sono nella inclyta cipta di Florentia, dato alle stam-pe nell’agosto del 1510 a Roma e dedicato proprio al suo caro amico Baccio da Montelupo, è colmo di riferimenti ai sentimenti fraterni e a quell’“antiqua amicizia” che sembrava aver lega-to i due sin dalla fanciullezza o come preferisce l’Albertini “per fino a teneris annis” 23. Viste le qualità di Baccio celebrate dall’amico quale intenditore di pittura, se non fossimo a conoscenza
BACCIO DA MONTELUPO 53
dei dati raccolti dai registri catastali dai quali emerge che Baccio nel 1487 si trovava ancora nel contado, saremmo portati a far combaciare tale tenera età con l’ingresso di Francesco nella bot-tega del Bigordi, avvenuto intorno al 1481 24, per confluire in seguito nella comune frequenta-zione della versatile fucina ghirlandaiesca al cui interno avrebbe potuto concretizzarsi il legame tra il Montelupo e il suo più celebre compagno, Michelangelo Buonarroti.
Sebbene tale contesto sembri allinearsi perfettamente con il racconto vasariano secondo cui Lorenzo de’ Medici “dolendosi che nei suoi tempi non si trovassero scultori celebrati e nobili, come si trovavano molti pittori di grandissimo pregio e fama deliberò di fare una scuola; e per questo chiese a Domenico Ghirlandaio che, se in bottega sua avesse de’ suoi giovani che inclini fussero a ciò, gl’inviasse al giardino” 25, appare alquanto difficoltoso immaginare la formazione dello scultore di Montelupo all’interno della bottega del Bigordi. Difatti la predilezione accor-data alle arti plastiche nella scelta degli artisti presenti nel Giardino di San Marco, deducibile anche solo dalle specializzazioni future dei singoli personaggi, oltre alla fucina del Ghirlandaio, al cui interno effettivamente si educarono solo una minoranza dei giovani citati dal Vasari, chia-ma in causa anche altre importanti, versatili botteghe fiorentine del tempo come quella dei San-gallo, di Andrea del Verrocchio o di Benedetto da Maiano, al cui interno, seppure per un perio-do ristretto, poté consumarsi la formazione artistica del nostro Baccio, al pari di Andrea Sanso-vino, Pietro Torrigiani, Rustici o dello stesso Michelangelo.
Tra queste è l’atelier di Benedetto da Maiano quello che più di tutti sembra aver incoraggia-to e stimolato la prima attività del nostro scultore 26 attraverso un assiduo esercizio grafico con-dotto sulle opere del maestro prodotte nel corso dell’ultimo quarto del Quattrocento 27, in par-ticolare su quella folta schiera di modelli fittili impiegati per la produzione marmorea o anche come lavori autonomi, che permettevano al Da Maiano di reclamare un ruolo guida anche nel-la plastica in terracotta. Modelli che lo stesso Baccio avrebbe potuto studiare all’interno del-la bottega del maestro o addirittura anche acquistare, come accadde per numerosi altri artisti che vennero in possesso di prototipi di Benedetto 28 in seguito alla “svendita” di sculture, finite o anche solo abbozzate, presenti nelle tre botteghe che al momento della sua morte nel 1497 il maestro aveva a pigione a Firenze 29. Proprio Baccio comparve come testimone insieme a Leo-nardo del Tasso, fedele collaboratore del Da Maiano, nell’atto di inventariazione dei numerosi beni, in primis sculture, presenti nella sua casa/bottega in via San Gallo nell’aprile del 1498 30.
In effetti gli apporti della critica più recente dai quali è emersa una rivalutazione della produ-zione fittile di Benedetto 31 forniscono numerosi spunti comparativi fra i gruppi plastici realiz-zati dal maestro tra il 1488 e il 1495, o quelli di artisti educatisi nella sua bottega, come fu Leo-nardo del Tasso 32, e gli esiti raggiunti da Baccio alla metà degli anni novanta del Quattrocento, in particolare nel campo della produzione di Compianti o Pietà in terracotta policroma 33. Sog-getti che trovarono enorme diffusione a Firenze sia in pittura che in scultura a cavallo tra i due secoli, toccando la loro acme in concomitanza alla predicazione del frate domenicano Girola-mo Savonarola, promotore di una religiosità austera e penitenziale fondata principalmente sul-la meditazione della Passione di Cristo. Si deve al pioneristico studio di Wilhelm Bode (1887) 34 – il primo ad affrontare il tema della Pietà in scultura – l’aver individuato nella poetica savona-roliana e nell’indirizzo devozionale intrapreso dall’arte fiorentina sul finire del Quattrocento le cause di una così capillare proliferazione nel territorio fiorentino di questo particolare genere
DAVID LUCIDI54
di manufatti, ma anche l’aver segnato con forza il percorso di tutta la critica successiva, peraltro incline a sottovalutare, sia dal punto di vista della plastica rinascimentale che dei rapporti tra arte e religione, una produzione troppo spesso avvolta in un’aura di serialità e popolarità ad es-sa non sempre confacente. In realtà, come precisato giustamente da Francesco Caglioti, quella sotto il frate ferrarese fu solo la fase culminante e quella di maggior intensità di un ben determi-nato movimento pauperistico diffuso in seno alla chiesa e parallelamente anche in campo artisti-co già prima del Savonarola 35. Se infatti i vertici qualitativi di una rappresentazione già consoli-data dovettero raggiungersi a Firenze con la celebre tavola dipinta originariamente dal Perugi-no nel 1493 per il convento di San Giusto alle Mura (Firenze, Galleria degli Uffizi) 36, nella Pie-tà in terracotta policroma dei Musei di Berlino37 – l’opera da cui prese spunto proprio il saggio di Bode – o nel monumentale gruppo di Andrea della Robbia ora al Bargello databile intorno al 1505 38, la prima testimonianza significativa di tale iconografia apparve già nel decennio pre-cedente con la Pietà modellata da Benedetto da Maiano tra il 1480 ed il 1490 per l’altare della famiglia Lapi nella chiesa fiorentina di Santa Maria Nipotecosa 39, le cui parti frammentarie, un Busto della Vergine dolente e l’intera figura della Maddalena, si conservano ora presso il Museo “Amedeo Lia” di La Spezia 40 e in una collezione privata newyorkese 41. Opera che, divenuta il prototipo per tutte le riedizioni del tema, nel corso del 1494, quando oramai il testimone era già in mano ai giovani scultori allenatisi nel giardino di sculture del Magnifico destinati a diventare i migliori plasticatori in terracotta del rinascimento fiorentino, veniva ancora scrupolosamente ricalcata dallo stesso Benedetto da Maiano per volontà del nobile Francesco Talducci nella cap-pella di famiglia in Santa Trinita a Prato 42.
Sarà proprio con uno di questi soggetti che il Montelupo dovrà confrontarsi nella sua prima opera a noi nota eseguita tra il 1494 e il 1495 per la chiesa di San Domenico a Bologna, il Com-pianto sul Cristo in terracotta 43, originariamente policromo, destinato agli spazi della cappella Bolognini, detta anche del Capo di San Domenico 44, e sarà proprio il confronto con le imma-gini modellate e scolpite da Benedetto a ridosso degli anni novanta del Quattrocento a rivelare quali furono realmente le esperienze vissute da Baccio negli anni immediatamente precedenti alla commissione felsinea. Il Compianto bolognese riconducibile allo stesso arco temporale nel quale il Nostro è ricordato per la prima volta dai documenti in procinto di sposarsi 45 (1493) e di divenire “habitans florentie” 46 (1494), appare il segno di un’ormai raggiunta stabilità familiare, coronata l’anno successivo anche dalla nascita del primogenito Giovanni 47, nonché di una rag-giunta autonomia produttiva. Inoltre la commissione di un soggetto religioso di tale carica pie-tistica si dimostra ancor più importante se considerata alla luce del contesto cui era destinata e del confronto con una differente, quanto radicata, tradizione artistica autoctona già da almeno due decenni affermatasi in ambito emiliano sul medesimo tema liturgico. Baccio, padrone di un linguaggio contenuto, severo e moderato, capace di tenersi a debita distanza dall’elusività e dal crudo realismo dei Compianti di ambito bolognese 48, sembra assecondare i canoni figurativi co-dificati da Niccolò dell’Arca e Guido Mazzoni solo nell’impianto compositivo della raffigura-zione, che prevedeva, stando agli illustri precedenti, almeno otto personaggi con al centro della narrazione il corpo di Cristo disteso a terra o adagiato su di un sepolcro ligneo 49, dei quali pur-troppo oggi rimangono solamente la Vergine, Maria Maddalena, una Pia donna e la testa di una figura maschile identificabile probabilmente con Giuseppe d’Arimatea 50.
46.
BACCIO DA MONTELUPO 55
Dal punto di vista linguistico evidenti si mostrano i legami con la più recente tradizione fit-tile fiorentina, se si confronta la figura intera di Maria con la frammentaria Vergine del Museo Lia di La Spezia, come detto parte di una Pietà eseguita da Benedetto da Maiano sul finire de-gli anni ottanta 51, si comprende chiaramente che la Vergine bolognese è legittima erede di quel-la spezzina nelle geometrie del capo e nell’anatomia del volto, come testimoniano il condotto nasale stretto ed affusolato, le profonde affossature ovoidali che circoscrivono entrambi i bul-bi oculari e le pronunciate arcate sopraccigliari. Ugualmente anche la Maddalena dolente e la Pia donna nelle pose, nella dilatazione ovoidale dei volti angelici 52, nei ripiegamenti occhiella-ti delle vesti nell’avambraccio 53, nella disposizione incrociata delle braccia serrate intimamente al petto, così come nella posizione dell’indice di una delle due mani che rimane sempre distan-ziato dalle altre dita, si legano strettamente alle figure angeliche del maestro poste ad ornamen-to della cappella aragonese in Sant’Anna dei Lombardi a Napoli, della tomba Strozzi in Santa Maria Novella e dell’ altare di San Bartolo in San Gimignano. Tuttavia il Montelupo si discosta dalle morbidezze epidermiche di Benedetto per una resa più cruda e sentita dei tratti fisiogno-mici dei personaggi, come testimonia la contrazione ad angolo acuto delle arcate sopracciglia-ri che rappresentano un carattere distintivo del devoto linguaggio montelupiano, volto a raffi-gurare i protagonisti della scena sacra in atto di profonda commozione interiore che mai si ri-verbera nelle apparenze esteriori, se non appunto nella contrazione accentuata dei muscoli del-la fronte e nell’espressione languida, dimessa degli sguardi, manifesto di una profonda e senti-ta religiosità. La scelta dello scultore è quella di condurre il lessico artificioso, a volte esuberan-te, soprattutto nei panneggi, proposto dal Da Maiano nelle opere degli anni novanta verso una sintesi formale e volumetrica della scena sacra capace di accordarsi perfettamente con le assor-te, castigate interpretazioni dei personaggi, concrete manifestazioni dell’influenza savonarolia-na nell’arte dello scultore. Il gruppo per i domenicani bolognesi rientrava nell’ambito di una campagna di lavori, principiata già nel 1493 per volere del giureconsulto Lodovico Bolognini e di sua moglie Giovanna Ludovisi 54, che prevedeva una serie di sculture in terracotta realiz-zate oltre che da Baccio, anche dal più illustre esponente della plastica fittile emiliana, Niccolò dell’Arca 55, e da un’artista che in quegli anni sembrava potersi candidare quale suo erede nel-la produzione bolognese in terracotta, Vincenzo Onofri 56. Fu per primo lo storico Francesco Filippini in un articolo del 1928 57 a ricondurre la paternità del Compianto, oggi conservato ne-gli spazi del Museo di San Domenico allestito all’interno della chiesa, alla mano del nostro scul-tore, riconoscendolo in quel “Bazo fiorentino che fa le figure di tera cote” ricordato dai docu-menti 58 e ad avanzare l’ipotesi che la commissione del gruppo fosse da collegare allo stretto le-game incorso tra gli ambienti domenicani delle due città. Secondo lo studioso ad aprire le por-te a Baccio verso la più importante commissione sarebbe stata, da un lato la presunta realizza-zione per i frati bolognesi di un busto-ritratto in terracotta del beato domenicano Sant’Antoni-no Pierozzi 59, arcivescovo di Firenze, desunto dalla maschera funeraria in cera ancora oggi con-servata presso il convento di San Marco, dall’altro la morte di Niccolò dell’Arca, avvenuta nel 1494, che avrebbe lasciato spazio allo scultore di Montelupo come successore del celebre mae-stro alla decorazione della cappella del Capo di San Domenico. Per quanto riguarda il ruolo ri-coperto da Baccio in quegli anni a Bologna, ci resta difficile immaginare come egli abbia potuto rimpiazzare nell’immediato il nume della plastica fittile bolognese e scavalcare contemporanea-
47-48.
44-45.
43.
46.
57-58.
DAVID LUCIDI56
mente nelle gerarchie cittadine Vincenzo Onofri, scolaro e fedele prosecutore del linguaggio di Niccolò, attivo negli stessi anni per la cappella del Capo di San Domenico con due busti in ter-racotta di Sant’Alberto Magno e del beato Raimondo di Peñafort 60, il quale a Bologna era de-stinato a rappresentare una sorta di ponte tra la violenta espressività quattrocentesca dello scul-tore ‘de Apulia’ 61 e il monumentale naturalismo cinquecentesco che a breve Alfonso Lombar-di avrebbe importato in città 62. Quindi la preferenza accordata a Baccio rispetto all’Onofri, ol-tre a implicare l’introduzione di importanti variazioni nella raffigurazione di un tema sacro co-me quello del Compianto che in ambito emiliano aveva trovato da tempo una sua definita iden-tità iconografica, sembra rispondere a una diretta volontà del committente, Ludovico Bologni-ni, intento a favorire per l’ennesima volta, dopo le precedenti incursioni di Pagno di Lapo Por-tigiani 63 e Francesco di Simone Ferrucci 64, l’ingresso a Bologna di una nuova ventata di cultu-ra umanistica fiorentina. Sebbene il legame con l’ambiente domenicano di San Marco a Firen-ze appaia a prima vista il tramite più probabile per la commissione, nonché una costante nelle vicende biografiche e lavorative di Baccio, relegarne l’esecuzione entro tali limiti significhereb-be negare l’influenza esercitata dall’ambiente culturale del Magnifico sulla produzione giovani-le del Montelupo e tralasciare l’importanza storica di una figura di spicco della società felsinea del tempo, come appunto Lodovico Bolognini, e conseguentemente gli importantissimi svilup-pi di una delicata situazione politica che proprio tra il 1494 e il 1495 vide coinvolte le diploma-zie delle due città in relazione alle vicende della corte medicea.
Il Bolognini infatti già a partire dal 1490-1491 iniziò a coltivare stretti rapporti, sia epistola-ri che culturali, con l’entourage laurenziano 65, in particolare con Agnolo Poliziano con cui con-divideva la passione per il diritto romano 66, e trovandosi già dal settembre del 1494, fino a tut-to l’anno successivo, a Firenze in carica come podestà 67 ebbe modo di conoscere i fasti dell’e-tà laurenziana ancora vivi e fecondi nonostante la morte del Magnifico avvenuta già da due an-ni. Erano tempi burrascosi per la famiglia Medici in preda alla sciagurata parentesi politica ge-stita dalla fragile personalità del figlio di Lorenzo, Piero ‘il fatuo’, che presto avrebbe condot-to all’ingresso del sovrano Carlo VIII di Francia in città (novembre 1494), alla cacciata della fa-miglia 68, fino al saccheggio e alla confisca di numerosi beni appartenuti alla casata fiorentina 69. Giovanni II Bentivoglio, fedele sostenitore della causa medicea, intervenne nelle annose vicen-de diplomatiche in qualità di prestanome nell’acquisto del Giardino di San Marco 70 così che, se le sorti della famiglia fiorentina fossero precipitate ulteriormente, entrando in possesso della ricca raccolta d’arte, ne avrebbe favorito in futuro una loro eventuale riacquisizione 71. Anche Baccio presumibilmente, al pari dell’ amico Michelangelo che nel corso del 1494 veniva ancora ricordato “scultore nel giardino” 72, rimase legato agli spazi e ai personaggi della casata fiorenti-na fino ai giorni a ridosso dell’ingresso di Carlo VIII, venendo in contatto con gli esponenti del-la corte bolognese giunti a Firenze al seguito del Bentivoglio per trattare la vendita del Giardi-no. Non è un caso quindi se due dei più stretti e fidati diplomatici del signore di Bologna, Gio-vanfrancesco Aldrovandi e Ludovico Bolognini, noti in patria oltre che per il ruolo civile ed isti-tuzionale, soprattutto per le attività di mecenatismo artistico, sfruttando tale favorevole situa-zione chiamarono alle proprie ordinanze nei mesi seguenti e a poche settimane di distanza l’u-no dall’altro due noti personaggi dell’entourage laurenziano come Baccio da Montelupo e Mi-chelangelo Buonarroti 73 per lavorare nei cantieri da essi patrocinati all’interno della chiesa dei
BACCIO DA MONTELUPO 57
domenicani bolognesi: il primo, all’arredo scultoreo della cappella del Capo di San Domenico dove alla morte di Niccolò dell’Arca era rimasta in sospeso la realizzazione, probabilmente già programmata, di un Compianto in terracotta, il secondo al completamento dell’Arca di San Do-menico lasciata incompiuta alla scomparsa del celebre scultore pugliese74.
La sosta di Baccio in città per mettere in opera il gruppo è attestata tra il gennaio e l’apri-le del 1495 75, dopo di che non si hanno più tracce documentarie del Montelupo almeno fino all’ottobre del 1496 quando i frati del convento domenicano di San Marco a Firenze versarono allo scultore parte del compenso per il monumentale Crocifisso destinato alla loro chiesa 76; la prima, testimonianza della produzione fiorentina sebbene Baccio, oramai ventisettenne, avesse probabilmente già alle spalle una cospicua mole di lavoro purtroppo ad oggi ancora sconosciu-ta. Il Crocifisso, ora conservato in una sala del Museo di San Marco, era esposto in origine nel coro del tempio dei domenicani, dove dall’alto vigilava le condotte dei frati chiamati a rigetta-re, spinti dall’ossequio della dottrina del Savonarola, la distrazioni arrecate loro dalla sensualità e dalla bellezza corruttrice delle opere d’arte. Ciò non valeva per il Cristo del Montelupo, fau-tore di un linguaggio vigoroso e sobrio, destinato a commuovere gli animi nella dolorosa con-templazione del mistero liturgico, solo a tratti marcato da più intensi accenti drammatici, lon-tano da qualsivoglia artificio formalistico e speculazione intellettuale, che nelle forme emacia-te, nella cruda e potente anatomia, nella contenuta espressività, diveniva il manifesto figurativo della mistica savonaroliana 77.
Considerata la mancanza di riferimenti precisi sulla formazione, le frequentazioni e l’evolu-zione stilistica dello scultore prima del Compianto bolognese, il monumentale Crocifisso dome-nicano rappresenta una sintesi eloquente degli esiti raggiunti in quegli anni dalle due maggiori botteghe fiorentine impegnate nella lavorazione del legno, come la fucina dei Sangallo e quel-la concorrente dei fratelli Da Maiano. Il grandioso, ascetico Cristo di San Marco coniuga infat-ti l’asciutto, corpulento naturalismo messo in scena un decennio prima da Giuliano da Sangal-lo con il crocifisso per la chiesa della Santissima Annunziata (1481-1482) 78 e l’enfasi monumen-tale di quello intagliato da Benedetto da Maiano per il Duomo di Santa Maria del Fiore (1490 ca.) 79, opera quest’ultima che per ragioni compositive, struttura anatomica, scelte figurative e vicinanza cronologica, vista la breve distanza di anni che lo separa dagli esordi fiorentini di Bac-cio, andrebbe considerata il modello che più di altri influenzò il linguaggio del Montelupo sul-lo scorcio del Quattrocento. Tale ascendente non sembra tuttavia tramutarsi in una dipenden-za culturale e linguistica nei confronti dei più celebri maestri, tanto che Baccio, proprio con il Cristo di San Marco, sembra imporsi prepotentemente al monopolio dei Da Maiano e dei San-gallo nel campo della produzione di Crocifissi lignei.
Alla scarsità di notizie sulle prime fasi dell’attività di Baccio vanno ad aggiungersi anche le sanguinose vicende che coinvolsero l’ordine domenicano e in particolare Girolamo Savonarola, raggiunto nel corso dei primi anni del 1497 dalla pesante scomunica e dal “sospetto di eresia” inflittigli da papa Alessandro VI Borgia 80 e nel 1498 arso sul rogo in piazza della Signoria. La rivolta della fazione degli “arrabbiati” che prese d’assedio le mura del convento di San Marco 81 mise in fuga numerosi artisti divenuti negli anni ferventi sostenitori del Savonarola, tra i quali anche Baccio, costretto a interrompere la veloce ascesa nel contesto artistico cittadino e ritorna-re da fuggiasco a Bologna. Il racconto del secondo soggiorno felsineo è inserito all’interno della
59.
DAVID LUCIDI58
Vita del Beato Ieronimo Savonarola 82 scritta da un anonimo del secolo XVI ispiratosi alla prece-dente Vita latina dedicata al frate dai suoi più vicini confratelli domenicani 83. Stando alle paro-le dell’ignoto compilatore il Nostro, “gran maestro nella scoltura”, dovette rifugiarsi nella città felsinea dapprima in casa di un canonico della cattedrale di San Pietro poi presso un certo Ca-millo Serpe dove aveva trovato conforto come molti altri seguaci del Savonarola fuggiti da Fi-renze 84. Nella città dei Bentivoglio egli continuò a svolgere l’attività di plasticatore in terracot-ta che già tre anni prima gli aveva recato enorme successo con il Compianto per San Domeni-co, realizzando per la Metropolitana bolognese una serie di tredici busti, oggi perduti, raffigu-ranti gli Apostoli e il Salvatore definiti “tanto mirabili che la città corse a vederli” 85. Al medesi-mo periodo sembra risalire anche una bellissima scultura lignea raffigurante San Sebastiano già nella chiesa di Santa Maria del Baraccano, opera attribuita in passato ad Alfonso Lombardi, poi alla scultrice bolognese Properzia de’ Rossi 86 e infine da Alessandro Parronchi a Donatello 87, ma che è stata sapientemente ricondotta da Francesca Petrucci alla mano di Baccio da Monte-lupo in virtù sia della dipendenza verso i canoni quattrocenteschi toscani codificati anni prima dagli omonimi Santi scolpiti da Antonio Rossellino per la Collegiata di Sant’Andrea ad Empoli e da Matteo Civitali per la chiesa di San Quirico a Monte San Quirico, sia della strettissima pa-rentela stilistica con il più tardo San Sebastiano nella Badia di San Godenzo, che a breve vedre-mo, scolpito da Baccio nel 1506 88.
La fuga bolognese dello scultore sembra quindi essersi consumata nel breve giro di un an-no visto che nel 1499 egli risulta nuovamente impegnato a Firenze nella realizzazione di alcu-ne sculture per la chiesa di San Lorenzo 89. Tra le opere d’arte di più elevata fattura all’interno del tempio laurenziano Francesco Albertini nel suo Memoriale ricordava, riferendosi in prima persona a Baccio, che “la tavola marmorea del sacramento con li suoi ornamenti è di Desiderio, excepto Christo sopra il calice, che è di tua mano, quando facesti il crucifixo et li Angeli allo al-tare maiore al tempo fui sacrista in decta chiesa” 90. Sulle vicende esecutive e conservative del Tabernacolo del Sacramento scolpito da Desiderio tra il 1458 circa e il 1461, compresi i numero-si spostamenti che subì nel corso dei secoli, possiamo esprimerci oramai con una certa sicurez-za 91, mentre qualche dubbio permane sull’intervento di Baccio che riguardò anche altre impor-tanti opere della chiesa. Due documenti editi dal Moreni, in cui l’Albertini è registrato nel 1498 come cappellano 92 e il 5 Novembre 1500 in veste di “nostro sagrestano” 93, dimostrano che ef-fettivamente l’attività del Montelupo nella basilica laurenziana è da collocarsi con esattezza a ri-dosso di quelli stessi anni 94, così come sembrano confermare anche altri documenti pubblica-ti da James Beck 95 che, nell’estate del 1499, registrano dei pagamenti proprio per un crocifisso ligneo e un paio d’Angeli in terracotta policroma destinati all’altare maggiore della chiesa, co-me appunto ricorda il Memoriale 96. Opere che un sommario delle attività previste in San Lo-renzo per quell’anno svela essere state commissionate effettivamente dal canonico Albertini 97, cancellando quindi ogni eventuale dubbio sulla partecipazione di Baccio all’arredo scultoreo della mensa del tempio mediceo.
Sia degli Angeli in terracotta policroma che del Crocifisso ligneo si è persa oggi ogni traccia, sebbene quest’ultimo per lungo tempo sia stato associato al Cristo pollaiolesco in legno di su-ghero oggi conservato in una cappella del transetto destro della chiesa 98. Per quanto riguarda invece il Gesù bambino benedicente di marmo, le sorti del racconto offertoci dall’Albertini fu-
46.
69.
70.
65.
BACCIO DA MONTELUPO 59
rono riproposte qualche decennio più avanti anche dal Vasari nella Vita di Desiderio da Setti-gnano. Racconta il biografo aretino che al vertice del celebre Tabernacolo “eravi un fanciullo di marmo tondo, il qual fu levato, et oggi si mette in sull’altar per le feste della Natività di Cristo, per cosa mirabile; in cambio del quale ne fece un altro Baccio da Montelupo, di marmo pure, che sta continuamente sopra il tabernacolo del Sacramento” 99. La narrazione vasariana segue nitidamente le tracce del canonico Albertini arricchendole tuttavia di maggiori dettagli aned-dotici confermati a loro volta dalle fonti archivistiche riguardanti l’opera di Desiderio. Impor-tanti contributi usciti a più riprese sull’argomento hanno permesso di chiarire le complesse vi-cende vissute nel corso dei secoli dal complesso desideriesco, a partire dal fatto che il Bambino fu rimosso dalla sua collocazione originaria forse nel corso dei lavori che interessarono la chie-sa durante 1499, in concomitanza quindi con la commissione a Baccio anche dei gruppi plastici per l’altare, e fu trasferito in sagrestia come oggetto liturgico autonomo impiegato in occasione delle feste della Natività per essere esposto sulla mensa dell’altare 100. Già nel 1503 tale destina-zione sembrava aver trovato ulteriore considerazione tanto che i canonici di San Lorenzo si im-pegnarono a fornirlo di una base in terracotta eseguita da Benedetto Buglioni 101. In tale luogo è documentato nel 1507, nel 1526 102 e ancora nel 1546, anno in cui il Bambino di Desiderio, an-dato in frantumi per lo sciagurato comportamento di un canonico, come emerge da uno scritto compilato in quell’anno da Pier Francesco Riccio segretario del duca Cosimo I de’ Medici, fu affidato alla mano dello scultore Niccolò Tribolo il quale, impegnato in quegli anni a sovrinten-dere la fabbrica laurenziana, provvide alla sua riparazione 103. Non sappiamo se in seguito a tali eventi il Cristo di Desiderio sia rimasto ancora negli ambienti della Sagrestia o sia stato riposi-zionato nella sua originaria collocazione, certo è che il Bambino attualmente posto al vertice del Tabernacolo eucaristico in San Lorenzo reca segni evidenti di quell’infausto evento lasciando quindi presupporre con una certa sicurezza come nel corso dei secoli, probabilmente nel 1677 quando il complesso fu sistemato lungo il transetto 104, l’opera di Desiderio sia stata ricollocata nella sua sede originaria mentre quella scolpita dal Montelupo, di cui presto dovettero perder-si le tracce, sia da rintracciare tra uno dei vari piccoli Redentori in marmo comparsi sul merca-to antiquario nel corso degli anni passati o conservati in alcune raccolte museali del mondo 105.
Nel corso degli anni tale articolata vicenda attributiva ha portato a numerose e controver-se aperture critiche in merito alla contesa paternità del Bambino tra Desiderio e Baccio, su tut-te quella di Alessandro Parronchi che nel 1965 propose di identificare nel piccolo Cristo, già al Museo di Cleveland, il prototipo originale desideriesco mentre in quello di San Lorenzo la copia eseguita posteriormente dal Montelupo 106. In realtà abbiamo visto come tutto possa risolversi oggi in favore di una situazione diametralmente opposta a quella delineata anni fa dallo studio-so. Di tutti gli esemplari citati in precedenza è infatti il Cristo bambino in marmo del Musée du Louvre, recentemente esposto alla mostra su Desiderio da Settignano tenutasi tra il 2006 e il 2007 nelle sedi di Parigi, Firenze e Washington, che, in linea con quanto affermato dal Planiscig 107, dal Gaborit 108 e in quell’occasione dal Bormand 109, sembra possedere tutte le carte in regola per ritenersi “una copia al tempo stesso molto fedele e molto interpretata dell’opera di Desi-derio”110, rivelando un’invenzione stilisticamente più avanzata e da un punto di vista anatomi-co conforme alle compatte, voluminose fisionomie del Montelupo, su cui sembrano sintonizza-te anche alcune repliche in stucco dell’esemplare parigino come quella presso il Museo Bardini
65.
66.
DAVID LUCIDI60
di Firenze 111, e che ritroveremo a distanza di quasi due decenni in un’opera di soggetto e tipo-logia affine eseguita dallo scultore per il tabernacolo eucaristico nella Pieve di San Leonardo a Segromigno, presso Lucca, nel 1518 112.
In quel giro di anni in cui dovette consumarsi l’esperienza per il tempio laurenziano Bac-cio tornò nuovamente a confrontarsi con un soggetto di intensa carica emozionale modellando una Pietà in terracotta, ora in collezione Turchi a Firenze, pubblicata nel 1970 su ‘Paragone’ da Hildegard Utz con un’attribuzione a Giovanni della Robbia 113, uno dei figli del rinomato pla-sticatore fiorentino Andrea, dediti entrambi alla produzione di simili complessi statuari, come testimonia la Pietà al Museo del Bargello di Firenze. Tale attribuzione trovò l’assenso della cri-tica fino alla pertinente proposta avanzata per primo da Giancarlo Gentilini 114, ricalcata suc-cessivamente dal Turner 115 e rimasta fino ad oggi immutata, di ricondurre la paternità dell’ope-ra a Baccio da Montelupo con una datazione intorno al 1495, anno in cui l’artista era impegna-to nell’esecuzione del Compianto in terracotta per la chiesa di San Domenico a Bologna. Ed è proprio con il gruppo felsineo, con il monumentale Crocifisso scolpito nel 1496 per la chiesa di San Marco a Firenze e quello di più piccole dimensioni eseguito per la personale venerazione del Savonarola 116, opere che rappresentano il vertice qualitativo della produzione di Baccio an-teriore al 1500, che la nostra Pietà mostra inequivocabili affinità stilistiche e culturali. Puntua-li sono le tangenze con le figure del Compianto bolognese, in alcuni tratti addirittura sovrappo-nibili; la devota figura di Maria, infatti, assisa su un seggio quasi interamente celato dalle ampie e monumentali stoffe dell’abito monacale secondo l’effige della Mater dolorosa, quasi a voler glossare le parole del Savonarola, “vestita come poverella, semplicemente, et coperta che appe-na se gli vedeva il viso” 117, si mostra, al pari dell’analogo personaggio felsineo, priva di qualsi-asi inflessione espressiva capace di distrarre il fedele dall’ossequio della pratica liturgica, men-tre nella posa magniloquente e nella gestualità armoniosa ben si presta ai più alti ed impertur-babili esempi di gravitas romana. Parimenti l’abilità dimostrata nel foggiare con così attenta mi-nuzia il corpo del Cristo esanime, elegante nelle proporzioni e raffinato nella modellazione de-gli arti, ben si allinea al coinvolgimento emotivo suscitato dal grande Crocifisso di San Marco in cui emerge la medesima, distintiva propensione di Baccio per il ritrarre al naturale, cresciuta sullo studio della scultura ellenistica, dei virulenti nudi donatelliani e pollaioleschi, e per ultimo sulle potenti, vigorose corporature dei crocifissi dei Da Maiano e dei Sangallo. Se in quello do-menicano le muscolature appaiono animate da un più intenso accento drammatico, è nell’altro piccolo Cristo conservato nella cella del Savonarola che si manifestano con maggiore eviden-za le affinità con la Pietà di collezione privata, riproponendo in dimensioni inferiori, ma pari-menti monumentali, la medesima lavorazione formosa delle muscolature, modellate con estre-ma precisione anatomica e animate da vivacissimi trapassi chiaroscurali. Se tuttavia Baccio nel Compianto per San Domenico a Bologna e nel Crocifisso di San Marco riuscì a celare i frutti del-le esperienze giovanili sotto una spessa e uniforme cappa di austero rigore formale, espressione dell’ambiente domenicano in cui nacque e dell’influenza esercitata sulla sua arte dalla spiritua-lità savonaroliana, in questa Pietà, con una cronologia più avanzata e probabilmente destinata ad una contemplazione più intima ed esclusiva – come sembrano suggerire le dimensioni più contenute – emergono chiaramente sia le tracce di una formazione compiuta tra i poli cultura-li del Giardino mediceo di San Marco e le stanze dell’attiguo convento domenicano, sia i segni
67.
68.
60-61.46.59.64.
53-54.
55-56.
64.
63.
BACCIO DA MONTELUPO 61
di un linguaggio più evoluto, con ormai alle spalle gli arcaismi delle prime opere note, ispirato ai più alti esempi della scultura antica e alle imprese plastiche di artisti suoi coetanei. Mi riferi-sco ai gruppi in terracotta del Museo statale di Berlino 118, del Victoria and Albert di Londra 119, del Metropolitan Museum di New York 120 e del Museum of Art di Philadelphia 121, che manife-stano profondi legami con il magniloquente lirismo di Benedetto Da Maiano e una cronologia compresa tra il 1495 e i primissimi anni del 1500. Sulla paternità di questi esemplari sono stati più volte proposti i nomi di Leonardo del Tasso 122, di Giovanni della Robbia 123, Andrea San-sovino 124 e Baccio da Montelupo 125, chiamando in causa l’intera congrega di artisti che le fonti ricordano alternativamente tra gli apprendisti nella bottega di Benedetto, tra le ferventi schiere del Savonarola o tra i banchi della proto-accademia di San Marco. Opere che al pari della Pie-tà in questione testimoniano quel particolare rapporto osmotico, seppur moralmente antitetico, istauratosi nel corso dell’ultimo decennio del Quattrocento tra i frati domenicani e casa Medi-ci. Se infatti da un lato i richiami e i tonanti sermoni di natura escatologica pronunciati dai pul-piti di San Marco e Santa Maria del Fiore “reclamavano un’arte concisa e disadorna per favo-rire la contemplazione del divino e offrirsi alla comprensione dei più semplici et illetterati” 126, dall’altro necessitavano di un linguaggio figurativo in cui i valori della dottrina domenicana po-tessero congiungersi agli “ideali umanistici e neoplatonici diffusi nell’ambiente laurenziano, in una concordia di idee sublimate dall’autentica condotta cristiana” 127. Cosi in tali opere, il con-cetto di pietas, che per i latini inneggiava al sentimento d’amore verso la patria ed i propri con-giunti, ma anche a valori di morigeratezza e decoro, in ambito religioso ben si confaceva a sti-molare nei fedeli atteggiamenti di provata commozione. Ancor più se stimolato dalle proprietà mimetiche della terracotta, materiale che negli ambienti culturali medicei richiamava a quegli stessi valori etici di austerità e integrità tanto declamati in passato da Plinio, fautore di un’arte semplice ed incorruttibile in contrapposizione ai fasti dei propri tempi, e permetteva inoltre di coniugare il naturalismo affabile e quotidiano dell’estetica savonaroliana con le forme sobrie e monumentali della scultura antica.
Da un punto di vista tipologico la matrice vesperbildiana inscenata dall’artista, rara rispet-to a quella di più consueto utilizzo in cui il corpo del Cristo rigidamente proteso in posizione orizzontale (come nelle Pietà fiorentine citate in precedenza) si offriva ad una partecipazione maggiormente concitata del compianto, conferisce al gruppo statuario un elevato valore iconi-co. Al pari infatti della celebre Pietà vaticana di Michelangelo il Cristo, piegato quasi su se stes-so, con le gambe che dovevano apparire un tempo reclinate verso terra e sorretto perfettamen-te dall’ampia e salda massa piramidale della Vergine, sembra concedere solo ad essa la contem-plazione del corpo esanime, giustificandone, date anche le dimensioni contenute, una fruizione colta e riservata per gli spazi di qualche importante cappella gentilizia. Questo non basta a sta-bilire se in origine il gruppo fosse accompagnato dalle figure di Maria Maddalena e di San Gio-vanni evangelista, che solitamente in raffigurazioni di questo tipo occupavano ai lati lo spazio della scena. Ad alimentare tale eventualità si aggiunge infatti la statua in terracotta dipinta, in collezione privata, di un San Giovanni inginocchiato. Il giovane Santo, che in origine possede-va entrambe le braccia, oggi mutile, di cui una era portata asceticamente al petto mentre l’al-tra in atto di sorreggere la testa o la spalla di Cristo, doveva esser parte anch’esso di una Pie-tà a quattro figure, posto alla destra del gruppo centrale secondo la consueta tipologia attestata
51.52.
49.
DAVID LUCIDI62
lungamente in area fiorentina a cavallo tra i due secoli. La monumentalità e la sintesi volumetri-ca del panneggiare fluido e corposo, la posa calibrata, l’espressione dimessa, alterata solamente dal consueto corrucciamento della fronte, sono tutti elementi che portano ad assegnarne la pa-ternità al Montelupo e a collegarlo, per via anche di un’indiscutibile concordanza cronologica, stilistica e dimensionale (entrambe misurano un’altezza di 70 centimetri), al gruppo in questio-ne. Le due opere rappresentano un anello di congiunzione tra gli esiti linguistici delle esperien-ze strettamente savonaroliane di fine Quattrocento e la più intensa fase lavorativa inaugurata all’ aprirsi del secolo successivo proprio con la Pietà Turchi e prolungatasi almeno fino al 1508, anno in cui lo scultore è documentato a Venezia al seguito del pittore domenicano fra Bartolo-meo 128. Baccio nel corso di questi anni trasferì la sua sfera d’influenza dalle stanze del conven-to di San Marco, dove aveva focalizzato la sua attività negli anni passati, ai luoghi adiacenti alla chiesa della Santissima Annunziata. In questo ritaglio cronologico il Montelupo con sulle spal-le una già numerosa famiglia composta da ben quattro “bocche” 129 aveva raggiunto una conso-lidata stabilità economica e come risulta dalla portata catastale del 1504, era da poco entrato in possesso di un “principio di un casetta” situata in via Ventura 130, l’attuale via Laura, nei pres-si del tempio dei padri serviti 131, dove immaginiamo impiantò anche la sua composita, poliva-lente bottega di scultura. Probabilmente si trattava di quello stesso edificio ancora in costruzio-ne, ovvero “una casa cominciata nella via di Ventura, appreso a Servi che vi è la scritta per ap-pigionarla” 132, registrato nell’inventario dei beni di Benedetto da Maiano stilato l’anno dopo la sua morte, nel 1498, e poi concesso in affitto ad un legnaiolo; elemento questo che suggerisce la predisposizione di quei locali ad ospitare una produzione artistica affine a quella del Monte-lupo. Fu senza dubbio la pratica raggiunta nel campo dell’intaglio ligneo e della plastica in ter-racotta, congiunta alla vicinanza della sua casa-bottega alla chiesa dell’Annunziata, a valergli la commissione tra il 1504 e il 1506 di una vasta serie di sculture per il tempio servita e per la Ba-dia di San Godenzo in Val di Sieve, complesso che dal 1482 risultava alle dipendenze dell’ordi-ne fiorentino 133. Era già noto alla critica il documento che attestava nel febbraio del 1504 l’im-pegno di Baccio da Montelupo, definito per l’occasione “schultore di terre”, nell’esecuzione di un Crocifisso per l’altare della chiesa dei Servi a Firenze; opera oggi purtroppo dispersa e di cui non possiamo precisare né le dimensioni, né il materiale, considerando anche il magistero acqui-sito nella lavorazione del legno che permetteva infatti allo scultore di padroneggiare la realizza-zione di Crocifissi in qualsiasi misura anatomica, come testimoniano il monumentale Cristo di San Marco, quello di piccole dimensioni conservato nella cella del Savonarola o quello ‘proces-sionale’ realizzato nel 1501 per un certo Amaddio d’Amaddio del Giocondo 134. Inoltre non si può escludere una modellazione in creta per il Cristo ai Servi, vista anche la sua specifica com-petenza nell’arte della coroplastica, come esplicitamente sottolineato nel relativo pagamento 135 e come ricorda un’ulteriore traccia archivistica, inedita, rinvenuta presso l’Archivio di stato di Firenze, secondo cui sempre tra il febbraio e il marzo del 1504, Baccio fu incaricato di esegui-re per la medesima chiesa fiorentina anche un Cristo nel sepolcro, parimenti disperso, da espor-re nella sagrestia della chiesa durante il venerdì santo di quell’anno 136.
Il buon esito di tali commissioni valse a Baccio un incarico molto più impegnativo: l’esecu-zione dell’arredo scultoreo per la Badia di San Godenzo, in Val di Sieve, comprendente un va-sto repertorio di sculture in legno e terracotta. Da quanto emerso dal registro di pagamento ef-
76-77.
50.
BACCIO DA MONTELUPO 63
fettuato nel 1506 da un certo Valerio di Fruosino 137, Baccio realizzò un San Sebastiano a dimen-sioni naturali in legno di tiglio, sei busti raffiguranti i Santi Godenzo, Luciano e Marziano, il Cri-sto, la Vergine e San Giovanni, “due innocentini di rilievo”, un San Giovanni battista e San Gi-rolamo, sempre di rilievo e a figura intera, che dovevano affiancare una maestosa pala d’altare istoriata, forse la stessa per cui Baccio doveva fornire sei riquadri con Storie della vita di San Go-denzo. A chiudere la commissione era un ennesimo Cristo morto a dimensioni naturali, analo-go a quello realizzato l’anno prima per la Santissima Annunziata, comprensivo di un basamen-to in legno “a uso di sepoltura” ordinato a un legnaiolo di nome Jacopo 138. Un ampio reperto-rio di sculture purtroppo quasi totalmente perdute che avrebbe permesso di comprendere con maggior chiarezza l’evoluzione del linguaggio del Montelupo e in particolare di studiare l’arti-colazione della sua prosperosa, composita bottega a dieci anni dalle ultime opere documentate.
Del corpus godenziano è tornato alla luce solo il bellissimo San Sebastiano in legno di tiglio139, conservato ancora all’interno della chiesa dove fu rinvenuto in un completo stato di abbandono nel corso del 1909 da Giovanni Poggi 140. Lo slanciato ed elegante martire raffigurato, come fa notare Francesca Petrucci, secondo un’inconsueta iconografia che lo porta a sollevare il braccio verso l’alto ricollegandosi all’esempio offerto qualche anno prima da Luca Signorelli nel Marti-rio di San Sebastiano nella Pinacoteca di Città di Castello 141, testimonia la consistente evoluzio-ne avvenuta nel linguaggio del Montelupo, incline ad abbandonare gli arcaismi di stampo quat-trocentesco e le ascetiche fisionomie di sentore savonaroliano delle prime opere – si veda a tal proposito il confronto già suggerito nelle pagine precedenti con il San Sebastiano bolognese – in forza di una maggiore enfasi dinamica e volumetrica delle anatomie che qui sembrano espan-dersi e rigonfiarsi, pur seguendo le medesime linee compositive, in un turgore distribuito uni-formemente in ogni parte del corpo. Il tutto appare sintonizzato sugli esempi della scultura an-tica di moda in quegli anni a Firenze, come il Torso Gaddi, conservato nella dimora dell’omo-nima famiglia 142, l’Apollo 143 e il Torso del Belvedere 144, o la testa del cosiddetto Alessandro mo-rente 145, prototipi visibili nelle raccolte antiquarie della Roma papale che al tempo affascinava-no numerosi artisti tra i quali Michelangelo, che ad esempio aveva riproposto dettagliatamente le fisionomie e la torsione spasmodica della testa ellenistica nella figura del Giona alla Sistina o nella Vergine del celebre Tondo Doni 146. Anche Baccio, suo grande amico e frequentatore della bottega fiorentina del maestro, dove un tempo doveva conservarsi un disegno a sanguigna, ora al Museo di Casa Buonarroti 147, frutto di uno studio dal vivo del generale macedone, sembra offrire nella testa del suo San Sebastiano un omaggio al prototipo greco, riedito tuttavia alla luce di un sentire personalissimo, più arcaizzante e devoto, ben diverso rispetto a quello buonarro-tiano. Lo sconquasso arrecato al patrimonio storico-artistico dalle soppressioni napoleoniche e dell’Italia post-unitaria colpì in maniera significativa anche il ricco arredo scultoreo della Badia godenziana, decretando una sventurata dispersione delle opere di Baccio, passate forse in altri edifici di culto o confluite col tempo all’interno di raccolte private. É quanto avvenne a mio av-viso per il busto di Redentore in terracotta policroma conservato nel Museo di Palazzo Venezia a Roma, dove giunse nel corso del 1919 per dono del fiorentino Carlo Angeli come opera del luc-chese Matteo Civitali. Attribuzione che in seguito ha trovato una più coerente assegnazione al-la mano di Baccio da Montelupo da parte del Santangelo (1954) 148, il quale, intravedendo le af-finità linguistiche con opere come il San Sebastiano o le tarde prove lucchesi dello scultore ave-
70.
69.
70.
72.
DAVID LUCIDI64
va ipotizzato una datazione che andava oltre la cronologia delle opere di San Godenzo (1506). Il successivo intervento del Turner 149 e quello più recente di Cristiano Giometti all’interno del neo-edito catalogo del Museo (2011) 150 hanno invece preferito fissarne l’esecuzione alla metà degli anni novanta per via delle consonanze ravvisate nelle figure del Compianto bolognese, con le quali il busto dividerebbe la medesima, morbida modulazione delle chiome e la descrizione lineare dei tratti somatici, caratterizzati dalla peculiare conformazione arcuata delle arcate so-praccigliari. In realtà nella terracotta romana non sembra potersi rinvenire il modellare asciut-to e sintetico delle forme, oppure filamentoso ed elementare dei capelli, che abbiamo visto ca-ratterizzare le figure bolognesi, e nonostante permangano ancora i grafismi e il sintetismo for-male degli esordi, il busto di Palazzo Venezia dimostra un vitalismo nel trattamento della capi-gliatura, gorgheggiante e ondulata, e una lenticolare resa mimetica del volto, quasi fosse deriva-ta da una maschera funeraria, ancora sconosciuti al Baccio degli anni novanta. Caratteri che ini-ziarono ad emergere durante il primo lustro del Cinquecento proprio nel San Giovanni di col-lezione privata, gemello nel trattamento somatico e nelle linee del profilo, per poi concretizzar-si nel San Sebastiano, identico nella morfologia del volto, nella morbida e arieggiata modulazio-ne dei capelli, e nell’atteggiamento di contenuto, sospirato patetismo. Ciò lascia supporre che la scultura di Palazzo Venezia condivida con il corpus di opere eseguite da Baccio per la Badia di San Godenzo oltre ad un’analoga cronologia anche la medesima provenienza, che permette-rebbe quindi di riconoscerlo in una delle sei teste ricordate dai documenti 151. Considerando i canoni dell’estetica montelupiana e in generale dell’arte fiorentina, ancora fortemente caratte-rizzata ad aprirsi del Cinquecento dall’austero clima savonaroliano, sono infatti convinto che il busto romano non sia da identificare con un Cristo Redentore, in quanto di tale soggetto man-cano sia i consueti attributi iconografici, come la corona di spine o la barba tipicamente bifor-cuta, sia quell’atteggiamento di contenuto dolore codificato dalla consueta espressione spirante della bocca dischiusa, dai contorni affilati e dalle arcate sopraccigliari pateticamente inarcate, in linea con i dettami dell’Umanesimo cristiano. Vi ritroviamo invece un limpido volto giovani-le dall’ampia fronte tersa, delicato nel trattamento epidermico, che se dovesse trovare un cor-rispettivo nel corpus di sculture per San Godenzo rappresenterebbe a mio avviso una delle tre immagini dei santi pellegrini ed eremiti Gaudenzio, Marziano o Luciano 152, come anticamen-te sembrava confermare un’iscrizione sulla base della scultura di Palazzo Venezia, che ricorda-va il personaggio raffigurato, di cui era illeggibile il nome, proprio con l’aggettivo “peregrinus”. É quindi più logico immaginare che il “Cristo” citato nel contratto godenziano raffigurasse in realtà la consueta effige del Redentore diffusa in area fiorentina a cavallo tra Quattro e Cinque-cento, caratterizzato da un più monumentale taglio a metà busto, fornito della tipica tunica ca-stamente abbottonata fin sul collo e del mantello adagiato all’antica su una spalla.
Sembra rispondere perfettamente a questa descrizione un busto di Redentore, in terracotta dipinta, che fino a qualche tempo fa si trovava proprio all’interno della Badia di San Godenzo, da riconoscersi quindi in una delle teste che originariamente facevano parte dell’arredo sculto-reo della chiesa realizzato da Baccio entro il 1506. Il Cristo nei tratti somatici e morfologici del volto ricalca perfettamente le forme della testa di Palazzo Venezia, si veda la complessità esecu-tiva degli incavi oculari ben scavati e indagati meticolosamente negli effetti chiaroscurali, tutta-via rispetto a questa presenta una maggiore intensità espressiva consona ad un soggetto di mag-
49.80-81.
70.
72.
72.
82.
BACCIO DA MONTELUPO 65
giore carica pietistica come doveva essere appunto l’immagine del Redentore. A questo andreb-be poi associata un’altra scultura in terracotta forse anch’essa appartenente al medesimo grup-po, un busto di San Giovanni evangelista, già in una collezione privata a Udine ed ora di ignota ubicazione, documentato da una foto conservata presso la fototeca del Kunsthistorisches Insti-tut di Firenze. L’opera, nonostante alcune differenze nell’intonazione emozionale e nell’artico-lazione del panneggio, giustificabile con la necessità di introdurre variazioni espressive e tipolo-giche al fine di evitare elementi di ripetitività all’interno di un repertorio di sculture che contava ben sei “teste al naturale”, dimostra chiare assonanze soprattutto con il già nominato San Gio-vanni evangelista genuflesso, a cui si avvicina in particolare per la medesima, animata cascata di capelli sulle spalle, articolata in flessuose ciocche compatte e raccolte sulla testa in uno zampil-lante ciuffo di capelli annodato. É inoltre possibile assegnare alla mano di Baccio da Montelu-po un’altra terracotta che sembra potersi collegare alle sculture eseguite per i cantieri della San-tissima Annunziata o di San Godenzo. Si tratta di un figura di Cristo, ora conservata presso l’O-ratorio del Santissimo Crocifisso di Fontelucente presso Fiesole, pubblicata nel 1994 da Maria Grazia Ciardi Duprè dal Poggetto con un’ attribuzione a Francesco di Simone Ferrucci in vir-tù delle affinità, a mio avviso incompatibili, riscontrate con alcune figure del Monumento fune-bre di Leonardo Tartagni in San Domenico a Bologna eseguite dallo scultore nel 1473 153. L’ope-ra non proviene dalla chiesa fiesolana, che fu edificata solo nel corso del Seicento 154, e non sem-bra raffigurare un Cristo in Pietà come invece sostenuto, pur con qualche riserva, dalla studio-sa. Al tempo del suo ritrovamento nel corso degli anni settanta del Novecento la statua era in-fatti fornita di gambe in legno che ne integravano le forme del corpo, forse nell’intento di recu-perare la sua antica funzione liturgica di Cristo deposto legata alle celebrazioni pasquali 155, per-duta presumibilmente in occasione del trasferimento dell’opera all’interno dell’edifico attuale. A testimoniarlo è, sia il degrado visibile alla base del perizoma, dove si notano tracce irregolari di rotture ed esfoliazioni da contatto causate probabilmente dalla sua ciclica esposizione in oc-casione dei ‘Sepolcri’ e il successivo ricollocamento sotto la mensa di un qualche altare, sia una questione puramente anatomica. Il Cristo di Fontelucente infatti risponde perfettamente alle dinamiche strutturali di un corpo senza vita adagiato in posizione orizzontale sulla pietra sepol-crale, allungato nelle muscolature del ventre e con la testa che si inclina su un lato, priva di qua-lunque sostegno del collo.
Al fianco di una produzione che potremmo definire in un certo senso ‘ufficiale’ e riservata al-la devozione chiesastica, il Montelupo al pari dei suoi colleghi cresciuti tra le mura del giardino di San Marco, depositari di una certa pratica nella lavorazione dell’argilla, diede vita a cavallo dei due secoli anche ad una fortunata produzione di immagini devozionali di piccolo formato, in particolare figurine e statuette ‘ambientate’ di santi eremiti, le quali rispondevano alle richieste di una religiosità ispirata alle letture del Beato Dominici. Queste suggerivano la presenza nelle case di immagini in cui i fanciulli potessero rispecchiarsi e scorgere, in un’affabile epifania ter-rena, episodi salienti di scene sacre, ma anche alle aspettative di una committenza colta, affasci-nata dal rinato gusto ‘ellenistico’ 156, già così ampiamente coltivato nell’entourage laurenziano, per le curiositas e quindi per figure arricchite di ambiziosi spunti naturalistici e dettagli aneddo-tici. Così accadeva in particolare per i soggetti di maggiore carica pietistica o penitenziale, co-me la Maddalena in preghiera nel deserto, il San Girolamo eremita e penitente o il San Giovanni
83.
49.
73-75, 62-63.
DAVID LUCIDI66
adolescente nel deserto raffigurati con corporature emaciate e sofferenti sullo sfondo di ambien-tazioni desolate e lunari, fatte di pietre scalfite in alcuni casi popolate da vivaci animaletti, capa-ci da un lato di suggestionare l’animo fervente dei fedeli, mentre dall’altro offrivano agli artisti la possibilità di allenarsi in estrosi esercizi naturalistici. All’interno del vasto catalogo di piccole terrecotte sparse oggi tra le numerose collezioni pubbliche e private, ricondotto variamente al-la mano dei più abili plasticatori del tempo come Andrea e Jacopo Sansovino, Giovanfrancesco Rustici, Pietro Torrigiano, Agnolo di Polo e il ‘Maestro del David e del San Giovannino’, si pos-sono rintracciare anche alcune tipologie, attestate in varie redazioni con leggere varianti icono-grafiche, che reclamano per sensibili ragioni stilistiche un’appartenenza al catalogo del Monte-lupo. Si tratta di due versioni del soggetto della Maddalena penitente nel deserto, l’una raffigu-rante una giovane eremita stante su di un’arida rupe, con le mani giunte e lo sguardo sollevato in orazione verso il cielo, avvolta in una corposa e fluente pelle di cammello con una rigogliosa chioma di capelli allungata fin quasi a terra che ne copre interamente le asciutte membra, l’altra inginocchiata ai piedi di uno scoglio roccioso da cui sgorga un flebile rivolo d’acqua, con le ma-ni giunte in preghiera al petto, fornita dei medesimi attributi iconografici della precedente 157. A queste si aggiunge un San Girolamo ritratto nella consueta iconografia del santo penitente, ge-nuflesso, in atto di percuotersi il petto con un macigno e accompagnato dal leone dalla folta cri-niera che fa capolino ai suoi piedi. In tutte e tre le sculture ritroviamo i tratti essenziali del lin-guaggio espresso da Baccio sin dai suoi esordi bolognesi e fiorentini, segnato dalla predilezione per capigliature articolate in rivoli sinuosi simili a lunghe bisce, per volti macilenti, scavati nel-le orbite oculari e descritti da tratti fisionomici schematici. Le tre sculture si imparentano anche per la medesima qualità incisiva del modellato, per l’espressione atona, sognante, e soprattutto per un’indagine anatomica tendente alla sintesi dei volumi piuttosto che alla minuziosa ricerca naturalistica ravvisabile nella coeva produzione di altri artisti.
Non sono tuttavia solamente le doti di ottimo plasticatore in terracotta e scultore in legno a valere a Baccio da Montelupo la citazione vasariana tra gli artisti della ‘terza era’. Nel dicembre del 1505 il Montelupo, assieme ad un certo Sandro di Niccolò di Bartolo, compare come testi-mone in un contratto stipulato da Michelangelo a Carrara per l’acquisto di alcune carrate di mar-mi158. Egli quindi in contemporanea agli impegni per i padri serviti di Firenze e San Godenzo si recò presso le cave carraresi al fine di reperire del materiale lapideo da impiegare in un’impre-sa scultorea oggi purtroppo sconosciuta. Affascinante è l’ipotesi che Baccio fosse in quel tempo un collaboratore del Buonarroti il quale era impegnato a licenziare contemporaneamente impor-tanti commissioni a Roma e a Siena. I marmi citati nel documento carrarese, giunti nella botte-ga fiorentina di Michelangelo per mano di un certo Matteo di Cuccarello, erano infatti destina-ti alla monumentale sepoltura commissionatagli dal Papa Giulio II per la basilica di San Pietro in Vaticano, tuttavia, come ricorda una lettera indirizzatagli nel 1510 dal padre Ludovico 159, il Buonarroti nel medesimo torno di anni aveva ordinato altri quattro blocchi dai quali ricavare le statue per l’Altare Piccolomini nel Duomo di Siena, complesso plastico cui iniziò a lavorare dal 1501 e per il quale tre anni dopo fornì quattro – che saranno anche le uniche – delle quindici sculture commissionategli 160. Proprio tali marmi relativi alla commissione senese non furono mai impiegati da Michelangelo a causa degli impegni con il pontefice, che lo spinsero gradualmen-te ad abbandonare il cantiere Piccolomini 161, e furono venduti ancora integri all’amico Mon-
86-87.
88.
BACCIO DA MONTELUPO 67
telupo a Firenze 162. L’errata interpretazione dell’evento ha spinto la critica a dividersi sulla pa-ternità michelangiolesca delle statue senesi e, a partire dal contributo di Charles De Tolnay, au-torevole biografo del Buonarroti, a chiamare in causa per queste proprio un intervento di Bac-cio 163. In realtà, come già avevano precisato il Valentiner 164, più recentemente Enzo Carli 165, e come infine ha chiarito Francesco Caglioti, i quattro pezzi di marmo non lavorati giunti nel-le mani di Baccio non vanno identificati con le uniche quattro statue consegnate dal Buonarro-ti 166 nel corso del 1504 e ancora oggi sul fronte del Monumento Piccolomini 167. Testimonianze le quali, oltre a dimostrarsi lontane dalle opere eseguite fino a quel tempo dal Montelupo, con-fermano l’imprecisione critica che aleggiava, e tutt’ora in parte permane, sulla definizione del-la personalità del nostro scultore nel campo della produzione marmorea, relegata peraltro a po-chissime testimonianze concentrate nella fase molto avanza della sua carriera. Solo di recente è emersa all’attenzione degli studi un’opera che potrebbe contribuire in maniera sostanziale al-la ricostruzione del profilo di Baccio scultore in marmo: un altorilievo raffigurante la Madonna con il Bambino, in collezione privata, che Tommaso Mozzati ha pertinentemente ricondotto ad una fase giovanile del Montelupo, ancora fortemente segnato dagli esordi nel giardino del Ma-gnifico e dipendente da un immaginario figurativo di marca verrocchiesca, ricorrente in quegli stessi anni anche tra suoi illustri coetanei, in primis Giovanfrancesco Rustici 168.
Oltre ai molti impegni nel campo della coroplastica e un’importante operosità come sculto-re in marmo, nel corso del primo decennio del Cinquecento Baccio aveva alle spalle una decen-nale attività nell’intaglio di Crocifissi lignei dei quali, a detta del Vasari, un “infinito numero per Italia ne fece” 169. In questo vasto corpus di Cristi “tutti ripieni di bonissima grazia”170 ce n’erano sicuramente alcuni che dovevano distinguersi per pregio esecutivo o maggiore impatto devozio-nale, come quelli ricordati dall’aretino nel corso del Cinquecento ancora all’interno delle chiese fiorentine delle Murate 171 e di San Pier Maggiore 172, e in particolare quello eseguito per i mo-naci di Santa Flora e Lucilla di Arezzo “tenuto molto più bello degli altri” 173. É infatti quest’ul-timo, conservato ancora nello stesso luogo dove fu scoperto nei primissimi anni del Novecen-to da Alessandro Del Vita 174, a documentare il vertice qualitativo raggiunto da Baccio nel cor-so del primo decennio del secolo XVI, rappresentando insieme al monumentale Cristo di San Marco e a quello custodito nella sagrestia della cattedrale di San Martino a Lucca, assegnato-gli da Anne Markham Schulz 175, uno dei tre capisaldi per delineare l’evoluzione del linguaggio del Montelupo in tale ambito. Tappe che permetterebbero di distinguere all’interno della vasta mole di Crocifissi riferiti alla mano di Baccio 176 quelli da considerare frutto di una produzio-ne autografa o quantomeno usciti dalla sua bottega, da quelli accostati alla sua mano solamen-te per aver mostrato un analogo, accentuato patetismo, bocche dischiuse, sguardi patetici e fe-rite slabbrate, o più semplicemente per questioni geografiche 177.
D’altra parte ho già avuto modo di dimostrare come persino l’omogenea serie di Cristi che la Lisner aveva avvicinato, coerentemente, alla bottega del nostro scultore 178 sia invece da ricon-durre ad un neo-emerso intagliatore di Crocifissi, Antonfrancesco Bugiardini, fratello del cele-bre pittore Giuliano, il quale confrontandosi con il maggiore esponente fiorentino in tale cam-po, senza entrarvi necessariamente in stretti rapporti di collaborazione, aveva dato vita ad un lin-guaggio molto vicino a quello del Montelupo 179. Andrebbero necessariamente individuati quin-di dei limiti entro i quali poter distinguere una produzione riferibile direttamente a Baccio o al
84.
DAVID LUCIDI68
massimo ai suoi più stretti collaboratori, e quella invece improntata ad un ductus più corsivo e seriale tipico di quelle botteghe di scultura specializzate nel replicare i modelli più in voga nella religiosità cittadina. É un lavoro questo che merita senza dubbio una più ampia e approfondita trattazione, ci limiteremo quindi per ora ad affrontare solamente quei casi che risultano di fon-damentale interesse al fine di avallare con maggior concretezza la paternità di Baccio per alcune sculture in terracotta qui presentate. Un ruolo di fondamentale importanza è ricoperto dal Cro-cifisso conservato nella chiesa di Santa Maria a Settimello, nei pressi di Firenze, forse originaria-mente eseguito per le monache camaldolesi in via della Scala 180, che costituisce insieme ad altri due esemplari molto simili tra loro, quello nella chiesa delle monache di Montalve a Castello 181 e quello conservato nel transetto della parrocchiale di San Casciano 182, un gruppo di sculture stili-sticamente omogenee eseguito dal Montelupo nel corso del primo quinquennio del Cinquecento.
Il Cristo di Settimello, che già la Lisner accostava al Redentore di Arezzo 183, in realtà sem-bra anticipare di qualche anno il linguaggio più maturo espresso da Baccio con l’esemplare are-tino, databile intorno al 1510, più armonioso nelle proporzioni, nella sintonia degli arti e carat-terizzato da una minuziosa indagine anatomica volta a modulare in maniera meno essenziale e più enfatica la muscolatura del torso. Ciò spinge a collocare cronologicamente l’opera in pros-simità degli incarichi intrapresi nel cantiere servita fiorentino e per la Badia di San Godenzo, comunque non oltre il limite del 1506 tracciato dal San Sebastiano. A confermare una tale data-zione entro il primo quinquennio del secolo e ad assegnare la paternità dell’opera a Baccio so-no le consonanze stilistiche che possiamo scorgere tra il Crocifisso di Settimello e il già citato Cristo morto presso l’Oratorio del Santissimo Crocifisso di Fontelucente. Il corpo della scultu-ra fiesolana appare infatti identico al Cristo di Settimello nell’asciuttezza, nella definizione ana-tomica del busto longilineo e snello, così come nella potente definizione del volto, caratterizza-to dalla medesima espansione ovoidale, dalle arcate sopraccigliari inarcate e molto rilevate, da zigomi e canali nasali pronunciati, orbite oculari affossate in crateri concentrici, occhi e bocche aperte come un taglio di lama nella carne fresca. La sovrapponibilità tra i due volti è così evi-dente che le due sculture andrebbero realmente considerate il risultato di un medesimo conte-sto lavorativo, in linea con quanto avvenne proprio nel cantiere della Santissima Annunziata di Firenze, luogo per cui Baccio venne incaricato di eseguire in contemporanea proprio un Croci-fisso e un Cristo nel sepolcro.
Del periodo compreso tra l’esecuzione del San Sebastiano per San Godenzo (1506), opera che segna una tappa fondamentale nell’evoluzione linguistica di Baccio, e il 1513, anno in cui egli sembra rientrare prepotentemente al centro delle vicende artistiche cittadine, rimangono solo pochissime notizie, di cui la più importante è il soggiorno consumatosi nella città dei Do-gi tra l’aprile e il novembre del 1508 184. Notizia confermata anche dalla narrazione dell’amico Francesco Albertini il quale, nel prologo del suo Memoriale dato alle stampe nel 1510, ricordava che Baccio prima di quella data “trascorse più tempo nella riccha ciptà di Venectia”, nella qua-le lasciò “memoria in marmo et bronzo degna di fama, laude et assai commendatione...” 185. Al soggiorno lagunare le fonti riferiscono solamente un intervento, menzionato da Francesco San-sovino nella sua Venetia città nobilissima: la figura marmorea di Marte 186 per il Monumento fu-nebre di Benedetto Pesaro nella chiesa di Santa Maria dei Frari, complesso commissionato do-po il 1503 alla bottega di Giovambattista e Lorenzo Bregno 187. L’attendibilità delle parole del
85.
84-85.
62-63.70.
78-79.
71.
BACCIO DA MONTELUPO 69
Sansovino, che scriveva solo pochi decenni dopo lo svolgimento degli eventi, non è bastata tut-tavia alla critica, per ultimo il monumentale volume di Anne Markham Schulz 188, a certificare una collaborazione di Baccio a lavori già avviati con l’officina bregnesca. In effetti, come ha fatto notare la studiosa, se da un lato persistono elementi che confortano il riferimento del Marte ad un artista fiorentino, a differenza del pendant Nettuno distintamente veneziano, dall’altro que-sti non sembrano trovare corrispondenza con gli esiti stilistici raggiunti da Baccio nel corso del-la sua precedente attività 189. Tale criterio di giudizio, in parte condivisibile, andrebbe però og-gi ridiscusso con maggior attenzione. I rari studi dedicati allo scultore di Montelupo hanno ten-tato infatti di analizzare il suo fecondo operato esclusivamente in relazione a quegli ideali “de-mocratici-repubblicani” 190 che ispiravano la folta schiera di artisti raccoltisi come una ‘scuola’ intorno alle mura del convento di San Marco e in seguito alla figura di fra Bartolomeo191, pro-motori di un’arte severa e monumentale strettamente legata alla spiritualità domenicana. Gli in-terrogativi suscitati dal Marte determinano ora la necessità di considerare per il nostro Baccio, noto principalmente per opere di carattere spiccatamente devozionale e pietistico, l’eventualità di una produzione legata anche a soggetti profani, essenziale e scontata per un artista educato-si sui reperti antichi di casa Medici e forte della tradizione vasariana che lo vorrebbe autore di un Ercole per Pierfrancesco de’ Medici 192.
Non a caso è proprio con altre opere ispirate all’antico, già in passato pertinentemente acco-state da Giancarlo Gentilini e Francesca Petrucci alla mano del fiorentino, che sembra potersi rintracciare quel medesimo filo conduttore necessario a collegare le due fasi dell’attività di Bac-cio consumatesi tra la metà del primo decennio del Cinquecento e i primi anni del successivo. Si tratta di un busto di Apostolo, o forse meglio di Filosofo antico, ora presso la Galleria Longari di Milano, e di tre sculture in terracotta invetriata raffiguranti i Santi Pellegrino, Romano e una Vergine con il Bambino conservati nella chiesa lucchese di San Concordio in Contrada 193. Opere quest’ultime già ricondotte da Francesca Petrucci alla mano di Baccio evidenziandone il legame, forte ormai dal tempo delle esperienze savonaroliane in San Marco, con alcuni esponenti della famiglia dei Della Robbia, in particolare con fra Mattia e fra Ambrogio che proprio a Lucca in quegli anni fornirono varie sculture invetriate per il convento domenicano di San Romano, luo-go da cui provengono probabilmente anche i nostri santi 194. I busti lucchesi, collocabili nel pri-mo quindicennio del Cinquecento, oltre a dimostrare i frutti di una collaudata collaborazione di Baccio con l’officina robbiana e una dimestichezza con la tecnica dell’invetriatura, paiono in-tonarsi a quel medesimo, colto ed austero classicismo pienamente individuabile nella figura del Marte veneziano 195, sebbene fino a quel momento inedito nell’arte del Montelupo. Tra questo e il busto di Filosofo sono evidenti le consonanze stilistiche riscontrabili nel modo di definire la forma degli occhi, inscritti in ellittici e spessi contorni a mandorla, nella dilatazione ovoidale e nel sintetismo volumetrico dei volti, nello sguardo assorto e meditabondo, solo lievemente cor-rucciato per il rigonfiamento delle sopracciglia. Ma è soprattutto con il San Pellegrino che si ri-levano più efficaci concordanze stilistiche, indirizzate verso un’accentuazione volumetrica del-le forme, un irrobustimento delle masse plastiche e una lievitazione dei tratti fisionomici perce-pibile nel rigonfiamento delle arcate sopraccigliari che si sviluppano seguendo quel peculiare disegno a rondine tipico dello scultore fin dagli esordi. Parimenti le possenti masse della figura veneziana sembrano accrescersi nei volumi sui contorni delle più asciutte e definite membra del
97-99.93-94.92.
95-96.
95-96.
DAVID LUCIDI70
San Sebastiano di San Godenzo imparentandosi con esso anche per la posa ancheggiante e sa-pientemente ponderata, con un piede adagiato a terra e l’altro lievemente sollevato, che confe-risce alla divinità romana un atteggiamento in fieri. Dinamica che sembra potersi riscontrare pu-re nei due Santi lucchesi, i quali registrano la medesima evoluzione plastico volumetrica appar-sa con il Marte e il perfetto connubio tra spiritualità savonaroliana e influssi di cultura classica.
Non troppo dissimile, né troppo lontano cronologicamente dalle sculture in questione, avreb-be dovuto apparirci anche il famoso Ercole eseguito secondo il Vasari 196 per Pierfrancesco de’ Medici “il giovane” (Firenze 1487-1525), figlio di Lorenzo il popolano del ramo cadetto della dinastia fiorentina. La commissione di un soggetto di tale valore simbolico per la città gigliata e in particolare per la casata medicea che, sostenuta ideologicamente dal De laboribus Herculis di Coluccio Salutati 197, era solita identificarsi simbolicamente con l’exemplum virtutis offerto dall’eroe romano capace con la sua clava di domare la “Florentia prava” 198, si intonava perfet-tamente al particolare clima encomiastico stimolato dal ritorno dei Medici al governo nel 1512 e dall’elezione nel corso dell’anno successivo del nuovo pontefice Leone X alias Giovanni de’ Medici il quale, al tempo della sua cavalcata trionfale in città tenutasi nel novembre del 1515, veniva accolto in piazza della Signoria proprio da un’enorme statua di Ercole modellata in stuc-co da Baccio Bandinelli 199.
Il Montelupo sembra aver vissuto la fase migliore della sua carriera proprio in corrisponden-za di questa fervente stagione culturale in cui, ricorda il Vasari, proliferavano in città un nume-ro infinito di “feste e spettaculi” favoriti dalla munificenza del pontefice e di casa Medici. Tra il 1511 e il 1512 partecipò al fianco di Jacopo Sansovino, Zaccaria Zacchi, Baccio Bandinelli e Do-menico Aimo da Varignana al celebre concorso voluto dal fiorentino Piero Pitti per la realizza-zione di una Madonna con il Bambino in marmo destinata a una nicchia del Mercato nuovo di Firenze 200; avvenimento in cui sembra potersi riconoscere il primo, precoce intervento della lon-ga manus medicea nelle commissioni artistiche cittadine già prima del loro reinsediamento av-venuto nel settembre del 1512 201. Alle convinzioni avanzate prima da James Balogh e in segui-to da Brouce Boucher di riconoscere nella scultura effimera raffigurante la Vergine con il Figlio in braccio del Museo di Budapest, il modello presentato in quell’occasione dal Tatti 202, giudicato migliore degli altri e poi scavalcato per questioni politiche da quello del Bandinelli 203, si associa in questa sede la proposta di identificare in un’analoga scultura in terracotta policroma, passata recentemente ad una vendita Sotheby’s di New York 204, il prototipo consegnato per l’occasione dal Montelupo. Ne confermerebbero una cronologia sui primissimi anni dieci del Cinquecento le concordanze culturali e stilistiche con il ristretto gruppo di opere che qui abbiamo ricondotto ad una fase ancora poco conosciuta e mal documentata della produzione di Baccio tra il 1510 e il 1515. Avvolta in complessi panneggi foggiati in ampi padiglioni ammaccati nelle superfici e af-filati nelle bordure, ritratta con un volto dai volumi espansi, lo sguardo lambiccato, tratti soma-tici sintetici e lineari, la particolare pettinatura a treccia che conferisce al volto maggiore roton-dezza, la nostra Madonna con il Bambino ricorda molto da vicino le figure del Filosofo antico, del Marte veneziano e dei tre santi lucchesi. In particolare della Madonna in San Concordio sembra riproporre la medesima idea del Bambino rannicchiato in una goffa postura seduta – elemento quest’ultimo che rappresenterà uno degli idiomi linguistici distintivi del figlio Raffaello – e svi-luppare un’analoga voluta roteante del manto descritta da pieghe larghe, appiattite e dalla consi-
70-71.
90.
89, 91.
91, 99.95, 92-94.
BACCIO DA MONTELUPO 71
stenza biscottata. Il percorso già avviato da Baccio nel San Sebastiano di San Godenzo e nel più tardo Crocifisso di Arezzo, guidato dalla volontà di abbandonare i torpori anatomici e il pateti-smo savonaroliano della prima produzione fiorentina, sembra trovare anche nella Madonna per il Mercato nuovo una sorta di conferma definitiva per gli sviluppi di quella tendenza consolida-tasi nelle figure modellate e scolpite nel corso degli anni dieci, volta a privilegiare gradualmente una maggiore sintesi volumetrica dei corpi e una più accentuata astrazione lineare dei tratti so-matici, come vedremo in particolar modo nelle opere dell’attività tarda. Momento a cui France-sco Caglioti ha recentemente collegato un Sant’Antonio abate fittile della Galleria Bacarelli di Fi-renze 205, che a detta dello studioso potrebbe riconoscersi nell’omonimo santo commissionato a Baccio per la Pieve di San Leonardo vicino Lucca nel corso del 1515 206.
Quello del Mercato nuovo non fu comunque un evento isolato nella carriera del Montelu-po il quale, in un momento di grande encomio cittadino verso la famiglia Medici in cui “si fa-cevano per tutta Fiorenza dagli amici e divoti di quella casa molte armi del pontefice in pie-tre, in marmi, in tele ed in fresco” 207, fu chiamato a lavorare in uno dei luoghi di maggior ri-levanza culturale della città, quale era il tempio servita della Santissima Annunziata. Qui nel giro di breve tempo si concentrarono i più significativi eventi artistici mentre negli spazi adia-centi della “Sapienza” 208 erano solite riunirsi vivaci congreghe di artisti 209 e tenevano botte-ga personaggi di spicco come Andrea del Sarto, seguito dal fidato Franciabigio210 e da giovani promettenti come Rosso Fiorentino e Jacopo Pontormo, Andrea Sansovino e l’allievo Jacopo Tatti 211, Giovanfrancesco Rustici e Baccio Bandinelli 212. Come già detto a pochissimi passi da lì, in via Ventura, l’attuale via Laura, abitava e teneva bottega anche Baccio da Montelupo, il quale non più di una decina d’anni prima aveva dato avvio a un solido legame lavorativo con l’ambiente dei frati serviti, ancora pienamente vivo nel corso del secondo decennio del seco-lo. Baccio all’interno del cantiere dell’Annunziata si presentava nelle vesti di principale, non-ché unico, scultore impegnato nell’ornamentazione plastica della chiesa al fianco della squa-dra di pittori che sotto la guida di Andrea del Sarto affrescava tra il 1513 e il 1515 le pareti nel chiostrino dei voti 213. Apparentemente estraneo ai meccanismi di questa fervente congre-ga d’artisti che ai Servi formarono una vera e propria ‘scuola’ 214, nel corso del 1513 il Monte-lupo ricevette la commissione per una maschera in cera del cardinale Giliano de’ Medici, fra-tello del pontefice, la cui decorazione pittorica fu affidata al Rosso Fiorentino 215 e sempre in quell’anno fu coinvolto in un altro significativo incarico finora sottaciuto dalla critica sebbene delineato dal Vasari e da alcune inedite testimonianze documentarie. Nella Vita del Pontor-mo racconta l’aretino che “volendo i frati de’ Servi fare alcun segno della divozione e servitù loro verso detta casa e pontefice [Leone x, Giovanni de’ Medici], fecero fare di pietra l’arme di esso Leone, e porla in mezzo all’arco del primo portico della Nunziata, che è in sulla piaz-za; e poco appresso diedero ordine che ella fusse da Andrea di Cosimo [Feltrini] pittore mes-sa d’oro e adornata di grottesche, delle quali era egli maestro eccellente, e dell’imprese di Ca-sa Medici; ed oltre ciò, messa in mezzo da una Fede e da una Carità. Ma conoscendo Andrea di Cosimo che da sé non poteva condurre tante cose, pensò di dare a fare le due figure ad al-tri: e così chiamato Iacopo [Pontormo], che allora non aveva più che dicianove anni [siamo quindi nel 1513], gli diede a fare le dette due figure, ancor che durasse non piccola fatica a di-sporlo a volere fare..” 216.
70.84.91.
DAVID LUCIDI72
I ruoli di decoratore e di frescante ricoperti rispettivamente dal Feltrini 217 e dal Pontormo in quest’impresa appaiono ineccepibili, mentre sulla paternità dell’emblema mediceo che ancora oggi si trova al centro del prospetto del portico dell’Annunziata 218 la critica si è sempre espres-sa in maniera molto cauta senza mai offrire il nome di un plausibile candidato. Di contro Phi-lippe Costamagna 219 e per ultimo Alessio Assonitis 220, hanno proposto di assegnare al Feltrini la completa esecuzione dell’opera anche nelle parti scultoree, senza tuttavia prendere in consi-derazione il fatto che in quel preciso spiraglio cronologico Baccio era l’unico scultore attestato nel cantiere alla realizzazione di stemmi in pietra. Ciò rende quindi poco plausibile il riferimen-to dell’arme Medici a un diverso artista ed effettivamente leggendo i documenti che registrano l’attività del Montelupo ai Servi nel corso del 1513 ci accorgiamo da subito che egli, oltre ad es-sere pagato per la maschera in cera del duca di Nemours, ricevette compensi proprio per l’e-secuzione di un’ “arme sopra la porta”. Opera quindi che possiamo plausibilmente identifica-re in quella ricordata dal Vasari, decorata dal Feltrini, arricchita da dipinti dal Pontormo e po-sta “in mezzo all’arco del primo portico della Nunziata”, sopra la porta principale d’ingresso al tempio. Perfino il saldo dei pagamenti sembra rispecchiare la successione cronologica tracciata dal racconto vasariano, tanto che Baccio, il primo ad essere chiamato in causa per questo lavo-ro, cominciò a ricevere la somma congiunta per il ritratto e l’arme a partire dal 30 agosto 1513, poi il 18 e il 30 di settembre, il 7 ottobre fino all’8 di novembre dello stesso anno 221, mentre il Feltrini, contemporaneamente impegnato insieme al Rosso Fiorentino a dipingere un’altra in-segna medicea nello spazio di passaggio tra il portico e l’ingresso della chiesa 222, ottenne i primi pagamenti a partire dal 3 settembre 223 . Il Pontormo, chiamato invece ad intervenire solo quan-do lo stemma probabilmente era già stato dorato e affisso sul muro esterno del chiostro, ricevet-te il suo compenso gradualmente tra il novembre del 1513 e il giungo dell’anno successivo 224.
L’abilità dimostrata nell’emblema mediceo posto in posizione prominente sulla piazza dell’An-nunziata valse a Baccio un altro incarico rilevante ricordato ancora una volta dal Vasari, ovve-ro l’esecuzione di un’insegna papale per la residenza del cardinale Lorenzo Pucci 225 che anco-ra oggi possiamo vedere in mostra sull’angolo del palazzo tra via Pucci e via dei Servi, di fron-te alla chiesa di San Michele in Visdomini. Il Pucci, asceso al porporato per volere di papa Le-one X nel concistoro del settembre 1513 226, in quegli anni si distinse come uno dei più munifi-ci elargitori in termini di commissioni artistiche, in particolare di armi celebrative della casata medicea, nei confronti del tempio dell’Annunziata 227, luogo dove ebbe modo di apprezzare in prima persona le doti del Montelupo nel campo della scultura lapidea. L’eco congiunto dei due stemmi determinò negli anni a seguire un’ampia fortuna per la tipologia coniata da Baccio, sia a Firenze che nelle zone limitrofe, in particolare in quelle del pistoiese dove forte era l’influenza del cardinale Pucci, vescovo coadiutore del capoluogo toscano dal 1509 al 1518. Recentemente Louis Alexander Waldman ha riportato alla luce un documento che registra in data 7 novem-bre 1516 la commissione al pittore fiorentino Andrea di Salvi Barili di uno stemma in pietra del papa Leone X per il fronte del Palazzo comunale di San Marcello Pistoiese 228; incarico che ob-bligava il Barili a uniformarsi a quello che al tempo era ritenuto il prototipo iconografico di ri-ferimento nell’esecuzione delle insegne leonine. Questo tuttavia non era rappresentato dall’ar-me fornita nel 1513 da Francesco di Bartolomeo Teli 229, fedele scultore di casa Medici, per la facciata del Palazzo pubblico della vicina Pistoia, bensì lo stemma scolpito da nostro Baccio sul
BACCIO DA MONTELUPO 73
canto di palazzo Pucci a Firenze, opera che in origine, stando a quanto descritto nella stipu-la con il Barili 230, doveva apparire finemente intagliata, ornata da una veste policroma d’oro e d’argento, e arricchita di una colorazione azzurra sullo sfondo, oggi difficilmente immaginabile viste le drammatiche condizioni conservative in cui versa.
La versatilità acquisita nel corso di una carriera quarantennale portò il Montelupo a dedi-carsi anche ad altri ambiti della produzione artistica, come testimoniano gli incarichi per la chiesa di Santa Maria delle Carceri a Prato, dove fu chiamato a realizzare una cancellata bron-zea (1516) 231, per il tempio di Santa Maria a Colle di Val d’Elsa, dove nel 1515 fu incaricato di eseguire un’edicola marmorea 232, oppure la commissione nel 1516 di una “girandola” per la festa di San Giovanni evangelista a Firenze 233. Tali “girandole” erano dei congegni effime-ri costituiti da un’armatura in legno, accuratamente rifinita da ornamentazioni plastiche, a cui venivano applicati fuochi d’artificio che davano vita ad un suggestivo spettacolo di luci e fra-gori 234, assumendo, come ricorda il Vasari, sembianze “di trombe di fuoco e di razzi et altri fuochi lavorati ...ora forma di tempio, ora di nave, ora di scogli e tal’ora d’una città o d’uno Inferno, come più piaceva all’inventore” 235. Al pari dell’attività nel campo della ceroplastica tale esperienza collocava idealmente Baccio su quella flebile linea di confine che nella Firenze nel Rinascimento demarcava la distanza tra alto artigianato e produzione artistica, segnando le distanze tra personalità inclini esclusivamente alle arti maggiori e personaggi, quali France-sco d’Angelo detto il Cecca 236, Orsino e Antonio Benintendi 237, Sandro di Lorenzo 238, Jaco-po d’Antonio detto il Nunziata 239 o Jacopo di Bonaccorso conosciuto come il Baia bombar-diere 240, anch’essi scultori, pittori o architetti, ma dediti principalmente ad attività di secon-do piano, come la ceroplastica, la profumeria e la pirotecnica. Personalità spesso descritte dal Vasari in termini umoristici, considerati alla stregua di “fantocciai” 241, che in realtà ricopriro-no anche ruoli significativi al fianco di esponenti di spicco nel contesto culturale cittadino 242. Proprio tali articolati apparati, spesso accompagnati da un complesso repertorio di figure mo-dellate con materiali effimeri 243, nel corso del Cinquecento attirarono l’interesse non più so-lo di generici legnaioli o di modesti architetti ‘tuttofare’ impiegati nelle feste cittadine quali esperti di pirotecnica o di congegni effimeri, come le “girandole”, le macchine da processio-ne chiamate “nuvole” 244, o i famosi “ceri” di San Giovanni 245, ma anche artisti eminenti del-la scena fiorentina. É il caso del nostro Baccio o di quelli meglio documentati di Niccolò Tri-bolo, autore di multiformi complessi ingegneristici, secondo quanto raccontano Vasari e Ago-stino Ademollo 246, e di Bernardo Buontalenti, noto anche con il nome di Bernardo “delle Gi-randole”, distintosi in gioventù per le sue doti di scenografo e per la passione verso congegni stravaganti e polimaterici.
Nel caso delle girandole si trattava quindi di veri e propri apparati effimeri che per ma-gnificenza, costo, complessità progettuale ed esecutiva, – Baccio venne ricompensato con una cifra molto consistente di oltre duecento fiorini d’oro 247 – potevano essere accostati ai suntuo-si archi celebrativi eseguiti nel 1515 per l’ingresso trionfale di Leone X a Firenze 248. Evento per cui Baccio fu coinvolto nella messa in opera e nella decorazione plastica di due diversi appara-ti con competenze che gli aprirono la strada, in virtù anche di quell’anzianità da cui trassero so-stegno giovani artisti come il Pontormo 249 e Aristotele da Sangallo 250, verso incarichi più spic-catamente progettuali e architettonici meglio attestati negli anni successivi.
DAVID LUCIDI74
Come già messo in evidenza da Ilaria Ciseri 251 e più di recente da Tommaso Mozzati 252, a fa-cilitare l’organizzazione delle compagnie d’artisti chiamati a realizzare in poche settimane i mo-numentali archi trionfali, concorse una duplice tipologia di spartizione degli incarichi che da un lato rispecchiava la sfera territoriale di influenza delle maggiori botteghe, dall’altro privilegiava l’impiego di nuclei d’artisti forti di una collaborazione già collaudata. Ecco quindi che il grup-po della ‘Sapienza’ composto da Andrea del Sarto, Giovanfrancesco Rustici, Jacopo Sansovino, Andrea Feltrini, Giuliano Bugiardini, Francesco Granacci, Pontormo, Rosso Fiorentino, che in quegli anni aveva monopolizzato gli spazi della Santissima Annunziata e di via dei Servi, si tro-vò unitamente a lavorare per gli apparati situati tra Via del Proconsolo e Piazza del Duomo 253, e anche Baccio, forse proprio in virtù delle già ricordate incursioni al fianco del gruppo della ‘Sapienza’ nel cantiere servita durante il 1513, fu coinvolto nell’esecuzione di almeno uno dei suntuosi complessi effimeri. Si trattava dell’enorme arco trionfale eretto tra il palazzo del Bar-gello e la chiesa antistante della Badia Fiorentina, pagato dalla Magistratura degli Otto di Pra-tica a nome di Francesco Granacci 254 e comprendente, oltre a monumentali colonne e struttu-re in legno, emblemi e iscrizioni celebrative della casata medicea, anche numerose insegne pa-pali, pannelli istoriati e numerose figure di rilievo modellate in terracotta255. Se dal racconto del Vasari desumiamo che spettò al Granacci con l’assistenza di Aristotele da Sangallo, esperto di scenografie, l’ideazione e il progetto del grandioso edificio, sembra potersi delineare invece per Jacopo Pontormo e Baccio da Montelupo un impiego nella realizzazione dei numerosi dipinti e soprattutto di un vasto repertorio di sculture, composto da statue monumentali in terracotta, ma soprattutto di immagini fittili di piccoli dimensioni che, ricordava l’aretino, “si sono smarri-te e sono per la case de’ cittadini” 256.
L’altro apparato in cui intervenne il Montelupo fu quello eretto in prossimità della porta San Pier Gattolini, la prima ad essere varcata dal pontefice al suo ingresso in città il 30 novembre 1515. L’esecuzione dell’edificio, composto “di 4 colonne grandissime di 16 braccia alte e gros-sissime, darientate, con base e capitegli come quelle di Santo Spirito, con più altre colonne pia-ne con grandi architrave e cornicioni e fregi, come a tale colonne si richiede, con tante figure in tutti e quadri e vani, tutti di mano di buoni maestri” 257, spettò alla mano congiunta di tre artisti: un pittore di nome Jacopo di Sandro 258, uno scultore, Baccio e un certo Piero da Sesto, “ma-estro di legname molto pratico” 259, supervisore nella progettazione dell’arco. La triplice colla-borazione all’apparato di Porta Romana, analogo nella spartizione dei lavori al ruolo corporati-vo della squadra d’artisti impegnata nell’impresa di via del Proconsolo, non doveva essere nuo-va ai circuiti della committenza cittadina e potrebbe quindi rivelarsi utile in futuro per ricucire alcuni vuoti biografici e lavorativi di Baccio che, come si è detto, possedeva competenze anche nell’ambito della progettazione architettonica.
La prossimità con le celebrazioni leonine, l’omonimia con il pontefice e con il celebre pro-tettore della città di Firenze, nonché la posizione di spicco che lo vedeva rivolto in direzione di piazza della Signoria, permettono di considerare in questa congiuntura anche la monumen-tale statua bronzea raffigurante San Giovanni evangelista, commissionata a Baccio dai consoli dell’Arte della seta per una nicchia esterna di Orsanmichele 260: ennesimo omaggio al nuovo pa-pa Medici offerto in questo caso da una delle più potenti corporazioni fiorentine. L’opera, che fu installata tra il 18 e il 20 di ottobre del 1515 261 e valse al nostro scultore la cifra di “340 fiori-
106, 99.
BACCIO DA MONTELUPO 75
ni” 262, vide competere nei mesi precedenti numerosi artisti, tra i quali ancora una volta il Mon-telupo e Jacopo Sansovino, che a detta del Vasari sebbene “facesse più bello modello di terra che Baccio” non riuscì per l’ennesima volta ad aggiudicarsi la commissione 263. A differenza del precedente concorso per il Mercato nuovo gli arbitri chiamati a valutare le prove dei vari ma-estri in questo caso non considerarono solamente l’ingegno nella creazione del modello in ar-gilla e la capacità di articolare i corpi nello spazio secondo i più aggiornati indirizzi della nuova maniera – ambito in cui Jacopo sembrava eccellere più degli altri come testimonia il fatto che Andrea del Sarto, dal San Giovanni ideato dal Tatti, trasse l’omonimo personaggio dipinto nel-la celebre Madonna delle Arpie 264 – ma dovettero valutare soprattutto l’abilità nella tecnica fu-soria che permettesse di ottenere una somma perfezione nel getto in bronzo di una statua di ta-le imponenza, complessità e importanza simbolica. É proprio su questo campo che il Montelu-po, più anziano ed esperto del Sansovino, ebbe la meglio tanto che “quando egli ebbe fatto la figura di terra, chi vide l’ordine delle armature e le forme fattele addosso, l’ebbe per cosa bellis-sima, considerando il bello ingegno di Baccio in tal cosa” 265. L’efficienza pratica del Montelu-po, al cui fianco non dobbiamo escludere la presenza di una figura specializzata nella colata del bronzo, così come accaduto nel caso della Predica del Battista di Giovanfrancesco Rustici qual-che anno prima 266, andava quindi a compensare il distacco figurativo che il modello di Jacopo aveva inizialmente guadagnato agli occhi dei contemporanei, giudici e artisti, chiamati ad espri-mersi sulla competizione. In una Firenze che andava affollandosi di pose accattivanti, gorgheg-gianti panneggi e superbe torsioni, come testimonia la serie monumentale di Apostoli marmo-rei destinati alla tribuna di Santa Maria del Fiore in lavorazione tra il 1512 e il 1518 per mano dei principali artisti del tempo, come Jacopo Sansovino (San Giacomo Maggiore; 1512) 267, Be-nedetto da Rovezzano (San Giovanni; 1513) 268 e Baccio Bandinelli (San Pietro; 1517) 269 – ope-ra quest’ultima che il Montelupo fu poi chiamato a giudicare l’anno successivo insieme con An-drea Ferrucci 270 – Baccio si presentava ancora come uno degli ultimi eredi di quella maniera sec-ca, asciutta e tagliente propria ancora della tradizione quattrocentesca fiorentina. Tale devozio-ne, stimolata forse anche dalla volontà dei committenti di adeguarsi alle illustri fusioni del Ghi-berti (San Matteo) e Donatello (San Ludovico; San Pietro) esposte a soli pochi metri dal San Gio-vanni, portò lo scultore a guardare il celebre gruppo bronzeo eseguito dal Rustici tra il 1506 e il 1511 per il Battistero di Firenze, vanto della concorrente Arte di Calimala, convertendone tut-tavia le monumentali e torte posture in un linguaggio sobrio e arcaizzante sebbene ugualmente imponente, che spinse il Baldinucci a riconoscere nel nostro Baccio un seguace ‘attardato’ del-la scuola del Ghiberti271. La figura grandiosa dell’Evangelista, ora esposta all’interno del Museo di Orsanmichele, animata da ritmi falcati goticheggianti, da un dinamico ductus lineare caratte-rizzato da significative ascendenze neo-ghibertiane, sembra essere stata concepita dallo sculto-re alla stregua di un enorme bassorilievo, dilatato, schiacciato e ieratico ad una visione perfetta-mente frontale, ma allo stesso tempo di sapiente artificiosità volumetrica se consideriamo l’an-gusto e ombroso spazio della nicchia cui era destinato e dove emergeva con vigorosa imponen-za, quale degno omaggio al neoeletto pontefice Giovanni de’ Medici.
Se con il San Giovanni Baccio sembra coronare definitivamente l’ascesa ai ranghi più eleva-ti della scena artistica, a chiudere la passerella di una longeva e faticosa carriera giunse un altro importante incarico rappresentato dalla sepoltura per il cardinale pistoiese Niccolò Pandolfi-
106.
DAVID LUCIDI76
ni, destinata alla cappella di famiglia nella chiesa della Badia Fiorentina; luogo che qualche an-no prima aveva ospitato gli esordi di un altro grande scultore coetaneo di Baccio, Benedetto da Rovezzano 272. Della tomba non resta oggi alcuna traccia e la ricostruzione degli eventi è affida-ta semplicemente alla biografia di Raffaello da Montelupo 273 e alle scoperte documentarie pre-sentate da Louis Alexander Waldman. Dai documenti pubblicati dallo studioso si evince che i lavori al monumentale complesso della Badia fiorentina impegnarono Baccio a partire dall’ot-tobre del 1514 per almeno tre anni 274, fino all’insorgere di alcune complicazioni in seguito all’e-lezione cardinalizia del Pandolfini nel 1517 275 – una nuova stipula effettuata in quell’arco di tempo aveva infatti sancito l’inserimento nel progetto anche di sculture in bronzo destinate ad accrescerne la magnificenza – per trovare poi una definitiva interruzione, come ricorda lo stes-so Raffaello 276, in seguito alla morte del prelato il 17 settembre dell’anno successivo. Le ricer-che del Waldman hanno permesso tuttavia di fissare l’arresto dei lavori in un momento che pre-cedette la scomparsa del cardinale pistoiese, dato che Baccio già un mese prima di tale evento sembra essere entrato in rapporti con un certo Lorenzo Bini, banchiere fiorentino legato alla fa-miglia Medici, il quale, interessato a comprare una sepoltura marmorea “pro uno cardinali” in via di ultimazione, si era accordato con lo scultore per un compenso di duecento fiorini neces-sario a completarla nel corso dei dieci mesi futuri 277. Ciò suggerisce che la sospensione dei la-vori vada riferita a una volontà ante mortem del committente e non è nemmeno da escludere a tal punto, come d’altra parte anni prima era accaduto allo scultore Donato Benti con l’analo-ga sepoltura affidatagli dallo stesso Niccolò per la sede vescovile di Pistoia mai portata a com-pimento 278, che anche il sepolcro commissionato al Montelupo, le cui vicende aspettano anco-ra di essere approfondite, fu concepito anch’esso in origine per la cattedrale pistoiese e solo in seguito, con l’ascesa al porporato del Pandolfini, destinato agli spazi della cappella di famiglia nella Badia di Firenze 279.
Le vicende legate al monumentale complesso, che Raffaello da Montelupo ricordava essere valso al padre una cifra di ben duemila fiorini, appaiono di straordinaria importanza per valu-tare la composizione della bottega di Baccio, comprendente oltre a semplici lavoranti, scalpelli-ni e squadratori – uno di questi doveva essere quel Lapo d’Antonio Lapi che il 17 ottobre 1516 s’impegnava a ritirare in Carrara per conto del Montelupo un blocco di marmo nero lavorato da impiegare come fregio 280 – anche giovanissimi, promettenti scultori, come appunto il figlio Raf-faello 281, ma anche maestri già ben affermati. Tra questi c’erano il fiesolano Simone Mosca 282, il cosiddetto Cicilia 283, entrambi collaboratori temporanei del Montelupo, e forse anche il vol-terrano Zaccaria Zacchi 284. Per quanto riguarda il primo le date in cui Raffaello racconta di fre-quentare l’entourage paterno (1518-1520) combaciano perfettamente con quel torno di anni in cui il Mosca portava a termine la decorazione, già iniziata da Benedetto da Rovezzano 285, del basamento per l’Orfeo scolpito da Baccio Bandinelli per casa Medici 286. Egli infatti aveva fatto ritorno a Firenze proprio nell’estate del 1519 287, dopo essere stato impegnato dal 1517 al fian-co di Antonio da Sangallo nei lavori per il chiostro di San Pietro in vincoli a Roma 288, per poi tornare nella città eterna nel corso dell’anno successivo, e Baccio, consapevole della sua abili-tà nell’intaglio, si impegnò tempestivamente ad arruolarlo nella prestigiosa commissione Pan-dolfini. La stessa cosa sembra essere avvenuta per il Cicilia, artista già apparso sulla scena nel 1515 con la lastra tombale Tornabuoni in San Jacopo in Campo Corbolini 289. Se, come affer-
BACCIO DA MONTELUPO 77
ma Francesco Caglioti, la mano che scolpì la sepoltura fiorentina è la stessa che eseguì l’Arcan-gelo Gabriele e il San Paolo nell’enigmatico complesso Michiel-Orso in San Marcello al Corso a Roma 290, lo scultore attivo nella bottega del Montelupo alla fine del secondo decennio del Cin-quecento si trovava già al suo terzo impegno con un monumento funebre nel giro di pochissi-mi anni, testimoniando quindi la prontezza di Baccio nel selezionare per un’impresa di eccezio-nale importanza le migliori personalità che il contesto artistico poteva fornirgli in quegli anni.
Per quanto riguarda invece Zaccaria Zacchi non sembra un caso che proprio nel corso del 1519, a chiusura dei lavori Pandolfini, egli venisse arruolato da Pietro Torrigiani nella squadra di scultori fiorentini che avrebbero dovuto aiutarlo nell’esecuzione della tomba di Enrico VIII nella cattedrale di Westmister a Londra 291. Del resto due anni dopo, quando le sorti della se-poltura regale inglese sembravano rallentare, forse proprio in virtù della fortuna riscossa con il progetto Pandolfini, lo stesso Baccio inviò in Inghilterra tramite la Compagnia fiorentina dei mercanti Giovanni Cavalcanti e Pierfrancesco de’ Bardi il modellino per una nuova tomba del sovrano – immaginiamo non troppo dissimile da quello per il sepolcro Pandolfini presentato a Lorenzo Bini al momento della vendita del complesso funebre 292 – al fianco di quelli spediti contemporaneamente anche da Jacopo Sansovino 293 e dal Bandinelli 294.
A confermare l’inserimento del Montelupo nei più orditi meccanismi di una committenza internazionale giunse nel marzo del 1520 l’incarico per la realizzazione della sepoltura mar-morea nella chiesa di San Michele in Foro a Lucca in onore del prelato Silvestro Gigli 295, già vescovo di Worcester 296, esponente di spicco di una ricca famiglia di mercanti-banchieri atti-vi alla corte di Enrico VII, strenuo sostenitore della politica di Enrico VIII, e non a caso per-sonaggio coinvolto anche nelle vicende relative al sepolcro per il re inglese 297. I contatti con la famiglia lucchese erano però iniziati già prima del complesso in San Michele in Foro, quando Baccio, in procinto di trasferire gradualmente la sua attività in direzione di Lucca, ricevette nel settembre del 1518 la commissione di un tabernacolo eucaristico in marmo destinato alla pieve di San Leonardo a Segromigno Monte 298; opera anche questa, come la precedente im-presa Pandolfini, inizialmente affidata a Donato Benti 299 e poi passata in mano a Baccio ridot-ta nei costi e nella magnificenza delle forme. Un ruolo significativo nell’affidamento dell’in-carico al Montelupo toccò al canonico della chiesa, un certo Domenico Sinibaldi di Lucca il quale aveva già supervisionato l’originario progetto bentiano e che forse in virtù della proba-bile parentela con il nostro Baccio – entrambi appartenevano alla casata dei Sinibaldi – decise di rivolgersi a quell’artista considerato il miglior candidato a succedere al defunto Matteo Ci-vitali nel ruolo di principale scultore in marmo e terracotta in terra lucchese. Pari importan-za nell’assegnazione del tabernacolo al nostro Baccio spettò a Giovanni Paolo Gigli, lo stesso personaggio che due anni più tardi affidò al Montelupo il compito di eseguire la sepoltura in onore del fratello Silvestro in San Michele in Foro a Lucca, scolpita a quattro mani da Baccio e dal figlio Raffaello 300 entro il 1522, di cui oggi rimane solamente un bassorilievo marmoreo raffigurante la Vergine con il Bambino. Una fonte ottocentesca anteriore a quella “fatal devasta-zione” che portò allo smembramento del sepolcro e in seguito alla dispersione dei marmi 301, tramanda ancora oggi il ricordo di un monumento pensile, inserito in uno spazio voltato a botte, al centro del quale doveva trovarsi l’arca con l’effige distesa del defunto, mentre in bas-so incorniciato tra due pilastrini era posto l’epitaffio celebrativo del Gigli, chiuso in alto dal-
101.
105.
DAVID LUCIDI78
la già citata icona mariana, a cui andavano ad aggiungersi ornati architettonici e numerose fi-gurine che dovevano completare la sepoltura ai vertici della balaustra o ai lati del sarcofago. Proprio tale opera, la cui memoria ne evoca la perduta magnificenza e grandiosità, avrebbe senza dubbio rappresentato un importante riferimento per ricostruire l’idea compositiva al-la base sia del quasi coevo monumento Pandolfini sia del modellino inviato in Inghilterra per la sepoltura di Enrico VIII.
Il legame con la famiglia Gigli determinò una svolta significativa per la carriera del Montelu-po, determinò importanti scelte nell’operato dell’artista fiorentino il quale, stando al volere del committente Giovanni Paolo, nelle due imprese per Segromigno e San Michele in Foro dove-va rifarsi espressamente ad illustri, nonché analoghi, precedenti realizzati in ambito lucchese da Matteo Civitali. Il Tabernacolo di Segromigno avrebbe dovuto rispecchiare da un punto di vista iconografico e tipologico, sebbene più grande di un terzo, il complesso plastico della pieve di Lammari (1496-1501)302, mentre nella tomba in San Michele in Foro Baccio era chiamato a ri-calcare gli schemi compositivi della Tomba di Pietro da Noceto nella cattedrale lucchese di San Martino 303. Quello che si conserva o si ricorda ancora oggi delle opere del Montelupo testimo-nia il rispetto riservato ai dettami tracciati nei rispetti contratti e parimenti l’abilità dello scul-tore dimostrata nell’aggiornare, senza evidenti sconvolgimenti, le tracce di una cultura ancora prettamente quattrocentesca in direzione di una maggior enfasi dinamica e una più disinvolta attenzione anatomica propria degli artisti della maniera moderna.
Assuefazione alla poetica figurativa del Civitali, presente nel contesto culturale lucchese a quasi vent’anni dalla morte del maestro, che immaginiamo dovette riverberarsi in maniera an-cor più radicata nella produzione artistica di carattere più spiccatamente devozionale e popola-re riservata alle numerose chiese e luoghi del contado.
Da tempo, ragionando sulla particolare, arcaizzante soluzione dinamica di stampo neo-civi-talesco studiata dal Montelupo per la tunica del San Giovanni evangelista bronzeo di Orsanmi-chele (1515), dove il mantello sul ventre si aggroviglia in un turbinio rotante, affilato e innatura-le facendo perdere alla figura qualunque consistenza anatomica nella zona sottostante del cor-po, mi sono chiesto se soluzioni di pari arditezza e nostalgico quattrocentismo si potessero rin-venire anche in altre sculture collocabili nel medesimo torno di anni e per tale motivo possa-no servire a riportare ulteriori opere nel catalogo di Baccio ancora molto spoglio in quel rita-glio cronologico. Ho avuto modo di riscontrare soluzioni identiche a quelle del grande Evan-gelista bronzeo solamente in due Madonne con il Bambino in terracotta non a caso tradizional-mente attribuite a Matteo Civitali, come il rilievo conservato nel Museo di Villa Guinigi a Luc-ca, in origine entro un’edicola di Piazza Bernardini 304, e quello posto in origine in un taberna-colo viario di Valpromano di Camaiore (Lucca), ora presso il Museo del Bargello di Firenze 305. Opere che dialogano strettamente con il grande San Giovanni, sia per il distintivo, elegante an-cheggiamento neogotico conferitogli dallo scultore, nonostante il taglio a mezza figura, sia per le evidenti soluzioni linguistiche adottate, in particolare nel modo di plasmare le vesti delle due Madonne caratterizzate da risvolti appiattiti e bordure laminari, così come dal distintivo turbi-nio dei tessuti che dal ventre sembrano poi distribuirsi vorticosamente alle altre parti del cor-po. La devota ascendenza verso il linguaggio dello scultore lucchese che Baccio da Montelupo era stato tenuto a rispettare nella realizzazione del Tabernacolo di Segromigno e della Tomba Gi-
101.
106.
102-103.
106.
BACCIO DA MONTELUPO 79
gli inducono ad avanzare un’attribuzione al fiorentino anche delle due terrecotte che in effetti, ad un’attenta analisi, paiono anch’esse derivate, nella tipologia e nella composizione, dalla Ver-gine con il Bambino eseguita dal Civitali per l’Arca di San Regolo in San Martino a Lucca (1480-1484 ca.), restituite però con un linguaggio evidentemente più aggiornato, enfatico, morbido nella tornitura dei volti e disinvolto nell’articolazione dei panneggi, che ben si differenzia dalle ultime prove offerte dal maestro sul finire del Quattrocento.
Convinzione che trova un significativo supporto nei contributi dedicati ai due rilievi da Fran-cesco Caglioti in occasione della mostra su Matteo Civitali del 2004 306. Lo studioso, in disac-cordo con la critica precedente, volta a considerare l’esemplare di Villa Guinigi una derivazio-ne da quello fiorentino307 e quest’ultimo un prodotto della fucina civitaliana nel corso degli anni ottanta del Quattrocento 308, aveva fatto notare come in realtà fosse il rilievo Guinigi una delle ultime prove di Matteo Civitali mentre la Madonna con il Bambino del Bargello, per la presen-za di numerose varianti nei dettagli e di un “impronta da maniera moderna non più incipiente ma in pieno corso” 309, sia da considerare una fondamentale testimonianza della fortuna del Ci-vitali e della proliferazione delle sue invenzioni sia in area lucchese che fiorentina nel corso del primo quarto del Cinquecento.
Lasciando per ora aperta l’eventualità che il rilievo lucchese, in linea con quanto affermato dal Caglioti, sia ancora espressione diretta dell’ultimo Civitali, viene da chiedersi chi altro allo-ra, se non il nostro Baccio, chiamato più volte a impersonare nelle fasi ultime della sua carriera proprio lo spirito del maestro, possa aver modellato le forme del rilievo mariano del Museo del Bargello, così palesemente ispirato ad una delle icone più importanti scolpite tempo prima dal Civitali. Conferme che oltretutto giungono anche da un confronto di natura stilistica con l’uni-ca figura superstite del Sepolcro Gigli, che con il gruppo del Bargello dimostra una sovrappo-nibilità di tratti, in particolare nel taglio degli occhi della Vergine, nella condotta sintetica e fi-lamentosa delle chiome, nella definizione lineare del condotto nasale, nei volti dei due bambi-ni, e in particolar modo nei panneggi delle vesti ampie, ammaccate, dalla consistenza quasi sfo-gliata delle superfici.
L’opera, che nelle forme ossute e tondeggianti del volto trova un’ulteriore termine di con-fronto nel Cristo del Tabernacolo di Segromigno, sembra potersi legare strettamente anche ad una altra bellissima scultura riconducibile al periodo lucchese di Baccio, il Redentore in terracotta conservato presso il Victoria & Albert Museum di Londra, proveniente dalla collezione fioren-tina Gigli-Campana e già catalogato dal Pope-Hennessy come opera di artista fiorentino ese-guita intorno al 1520-1525 310. Nel Cristo londinese 311, si avverte quella medesima tendenza già emersa nel Filosofo antico, nei due santi di San Concordio in Contrada a Lucca, nel Marte vene-ziano e anche nel gruppo modellato dal Montelupo probabilmente per il concorso del Merca-to nuovo, dove il patetismo contenuto di estrazione savonaroliana codificato da fronti acciglia-te, bocche recise da lame affilate, lascia spazio a soluzioni compositive di maggior misura intel-lettuale e sobrietà posturale. Inoltre emergono evidenti consonanze stilistiche anche con opere più tarde, prossime o già oltre la metà del secondo decennio del Cinquecento, come appunto la Madonna con il Bambino del Museo del Bargello, o il volto del Cristo del Tabernacolo di Segro-migno e della Vergine del sepolcro Gigli, quest’ultimi sorprendentemente vicini, se non addirit-tura sovrapponibili con il Redentore londinese. Condivide con questi infatti la medesima torni-
101, 105.
104.
103.
105.
101.
100.
99, 93-94, 71.89, 91.
103, 101.105.100.
DAVID LUCIDI80
tura levigata ed essenziale dei volumi, il taglio malinconico degli occhi a mezzaluna rivolta ver-so il basso, il gusto per profili appuntiti e affusolati, per labbra taglienti, asciutte e meno carno-se rispetto alle opere del passato, così come il movimento dei capelli che scivolano sinuosamen-te verso il basso in ciocche filamentose. Una capigliatura che, per via di quel processo di sintesi e monumentalizzazione caratterizzante tutte le opere della maturità di Baccio, appare descrit-ta con più sommarietà e indagata con minore virtuosismo rispetto alle prove degli anni Novan-ta del Quattrocento.
L’ultima fase della carriera vissuta da Baccio in territorio lucchese aspetta ancora significativi approfondimenti, a partire dall’individuazione di un’esatta cronologia per il suo definitivo allon-tanamento da Firenze. Se infatti la commissione del Tabernacolo di Segromigno nel 1518 e i lavo-ri per l’edificazione del tempio di San Paolino avviati dal 1519 rappresentano solo un’anticipa-zione dei suoi futuri spostamenti in direzione di Lucca, l’approdo definitivo in città non avven-ne certamente prima del 1523, come dimostrano esplicite testimonianze storiche e documenta-rie, in primis la biografia del figlio Raffaello 312. Egli racconta che il padre al tempo dei lavori al-la sepoltura Gigli, conclusa nel 1522, continuava a coltivare ancora numerosi interessi lavorati-vi a Firenze 313 dove manteneva ancora la propria residenza presso il ‘popolo’ di San Pier Mag-giore 314. A portare nuova luce sulle vicende biografiche e sull’attività del Montelupo nel corso degli anni venti giunge ora anche un inedito, fondamentale contributo documentario, anticipa-to più di un secolo e mezzo fa da Giuseppe Campori all’interno del suo prezioso volume dedi-cato alle memorie di artisti del territorio carrarese 315. Lo storico infatti riportava la notizia, de-sunta da un atto rogato il 15 luglio del 1521 da Baccio a Carrara, che lo scultore si impegnava a prendere in affitto per un anno intero il primo piano e tutto il pian terreno di una casa presso la via Nuova 316, luogo dove presumibilmente il fiorentino mise in piedi una vera e propria bottega per i lavori che in quel tempo lo impegnavano principalmente a Lucca. Tale notizia sconosciuta agli studi prodotti sulla figura di Baccio, è stata definitivamente confermata con il ritrovamento dell’atto in questione, trascritto in appendice, all’interno del corpus notarile nell’Archivio di stato di Massa. Il tutto lascia dedurre che Baccio, impegnato durante il 1521 sia ai lavori per il Monu-mento Gigli che alla progettazione e decorazione del tempio di San Paolino (1519-1532), aves-se deciso di spostare temporaneamente la sua bottega nei pressi delle cave di Carrara dove più agevolmente avrebbe potuto sbozzare, lavorare e soprattutto spedire con minore onere i marmi verso Lucca. La stipula del 1521 richiama tuttavia anche un altro importante accadimento nel-la biografia del Montelupo che viene ricordato con la solita meticolosità da Raffaello. Secondo il racconto del figlio, in seguito alla morte avvenuta a Carrara nel 1520 dello scultore spagno-lo Bartolomeo Ordonez, impegnato nell’esecuzione dei monumenti funebri per Filippo il Bel-lo e Giovanna la Pazza e per Francisco Ximénez de Cisneros 317, un certo Giovanni da Fiesole, aiutante dell’artista burgense a Barcellona e sovrintendente delle imprese carraresi, giunse nel-la bottega del Montelupo per assoldare giovani aiutanti da impiegare nei cantieri interrotti alla morte dell’artista spagnolo, convincendo nell’occasione anche il giovane, promettente figlio del Nostro 318. Sebbene sia lo stesso Raffaello a parlare di Firenze quale luogo dell’incontro, sembra poco plausibile immaginare che Baccio, esauritasi oramai la collaborazione con il Mosca e il Ci-cilia, e vista la gravosità degli impegni che in quegli anni era chiamato a sopperire, si sia privato di una larga fetta della sua bottega comprensiva del figlio, abile sia nell’intaglio del marmo che
105.
BACCIO DA MONTELUPO 81
nella modellazione in creta, e di quei giovani squadratori e scalpellini che lo avevano già assisti-to nelle vicende della sepoltura Pandolfini tempo prima. Appare invece più logico pensare che Giovanni da Fiesole, necessitato a cercare manovalanza per il completamento dei sepolcri rea-li spagnoli in attesa dell’arrivo di altre più esperte maestranze, che in effetti poco dopo arriva-rono da Napoli 319, abbia fatto effettivamente una visita alla bottega del Montelupo, senza ne-cessariamente arrivare fino a Firenze visto che nel 1521 erano entrambi cittadini carraresi. Ta-le dinamica spiegherebbe il consenso di Baccio alla proposta del fiesolano che in questo modo avrebbe potuto usufruire della manovalanza dei giovani aiutanti del Montelupo senza tuttavia privare quest’ultimo di un fondamentale ausilio.
Sono questi gli ultimi eventi significativi nella carriera del Montelupo, le cui notizie dopo il 1522 sembrano diradarsi improvvisamente, forse in concomitanza al brusco rallentamento della sua attività oramai quarantennale, interrottasi poi definitivamente intorno al 1537. Un documen-to citato infatti da Gaetano Milanesi menzionava la condizione vedovile della moglie di Baccio, una certa Lucrezia 320, ma l’impossibilità di verificare la testimonianza citata dall’erudito senese, lascia tuttavia ancora steso un velo d’incertezza sulle ultimi anni di vita di Baccio il quale, anco-ra nel 1530 risultava essere sposato con una certa Agnoletta 321, la stessa donna documentata al suo fianco nella portata catastale fiorentina del 1504 e quindi per gran parte della sua esistenza.
DAVID LUCIDI82
APPENDICE DOCUMENTARIAa cura di DAVID LUCIDI E SARA CAVATORTI
Abbreviazioni:ASF, Archivio di Stato di FirenzeASM, Archivio di Stato di Massa AOSMF, Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore
1. Registro di nascita dei figli di Baccio da Montelupo: Giovanni, Pierfrancesco e Raffaello AOSMF, Registro battesimi maschi, n. 6, 1492 – 1501, c. 63r. Domenica 20 dicembre 1495Giovanni Cristoforo di Bartolomeo di Giovanni popolo di San Lorenzo nacque adì 19 hore 2AOSMF, Registro battesimi maschi, n. 6, 1492 – 1501, c. 113r. Sabato 23 febbraio 1498Pierfrancesco di Bartolomeo di Giovanni d’Astore popolo di S. Ambrogio nato adì 23 hore 3AOSMF, Registro battesimi maschi, n. 7, 1502 – 1512, c. 44r. Martedì 4 luglio 1504Raffaello Bastiano Romolo di Bartolomeo di Giovanni scultore popolo di S. Piero Maggiore nato adì 9 hore 7
2. Pagamento per un Cristo deposto per la chiesa della Santissima Annunziata di Firenze:ASF, Corporazioni religiose soppresse, S. S. Annunziata, 119, n. 701, Entrata ed uscita del Camerlingo, c. 52r. n. 42;
c. 54 r. n. 42.Febbraio 1504Alla sacresta [...] fiorini I d’oro in oro a Baccio da Montelupo per conto del Cristo el quale fa per chiesa portò fra-
te Stefano da Milano sacrestano L. 7Marzo 1504Alla sacresta 14 di marzo f. 3 sono per parte del Cristo nel sepolcro per venerdì santo a Baccio da Montelupo por-
tò lui detto contati f. 3
3. Documenti inediti riguardo alla commissione al Montelupo di un’immagine in cera di Giuliano de’ Medici e di un’ arme in pietra per la chiesa della Santissima Annunziata;
ASF, Corporazioni religiose soppresse dal Governo francese, S.S. Annunziata, 119, n. 705, cc. 107, 112c. 10730 settembre. A Bacio da Montelupo a dì 30 detto fiorini 3 d’oro in oro sono per lamagine di giuliano e per larme
sopra la porta portò maestro Aucchio Ll. 21 Ss. – c. 1128 novembre. A Bacio da Montelupo a di decto f. 8 s. 8 sono per resto de limagine digiuliano de medici e per larme
sopra la porta portò lui contanti f.8 Ss. 8 –
4. Documento relativo alla presa in affitto da parte di Baccio da Montelupo di una casa in Carrara per un anno il 15 luglio 1521 ASM, Notarile Carrara, notaio Galvano Parlanciotto (1518-1523), busta 5, filza 4 c. 312v:1521, luglio 15
BACCIO DA MONTELUPO 83
s.c. die 15 iulii 1521 indictione 9a
Lorius olim Dominici Lombardelli de Casapodio hoc presenti publico instrumento et cetera dedit concessit et locavit et cetera magistro Baccio da Montelupo sculptori presenti et conducenti per totum primum solarium una cum eius came-ram et totum terrestrum domus ipsius Lorii posita in burgo Carraria loco dicto in Via Nova iuxta viam publicam a lateribus presentis dicti locatoris et heredes Petrantoni de Calvanis de Carraria vel si qui et cetera hinc ad unum annum proxime fu-turum hoc in addiso quod liceat ipsi Lorio et eius familia vagandi et agire et transire per scalas et per dictum primum sola-rium ut possit ire ad1 terr secundum solarium quem dictus Lorius et eius familia habitat. Et hoc ideo quia […] dictus magi-ster Baccius promisit et solemniter concessit dicto Lorio presenti er stipulanti et cetera dictis solario camera et terrestro uti ad morem boni condivisoris nec non eidem Lorio dare et solvere et nomine pensionis dicti solaris camera et terrestri pro to-to2 dicto anno ducatos quatuor cum dimidio alterius ducati auri solvendi per ipsum magistrum infra menses sex proxime fu-turi omni iuris et facti exceptione remota finito autem dicto anno eidem Lario dictum solarium cameram et terrestrum ressi-grare potius melioratum quam deterioratum que omnia et cetera. Sub pena et obligatione omnium eorum bonorum et cetera.
Item in finem et cetera. Renuntiantes et cetera.In domo mei notarii presentibus Bastiano Nelli de Carraria et Matheo Felicis de Spiciano testibus.
1 Segue terr depennato per un errore del notaio: terrastrum?2 toto nell’interlinea.
* Questo contributo trae spunto dalla Tesi di Laurea magistrale discussa presso l’Università degli Studi di Perugia, nel corso dell’anno accademico 2008/2009, dal titolo: “Baccio da Montelupo (1469 - 1535). Dal giardino di Lorenzo il Magnifico alla nuova restaurazione medicea”. Per tale motivo e per il continuo sostegno dimostratomi sento il dovere di ringraziare ancora una volta Gian-carlo Gentilini, in quell’occasione anche relatore della tesi. Tutta la mia riconoscenza va inoltre a Tommaso Mozzati che ha guidato le mie ricerche, così ugualmente a Michela Zurla che ha seguito e sostenuto la loro concretizzazione. Desidero ringraziare in partico-lare Alfredo Bellandi e Francesco Ortenzi per i numerosi suggerimenti offertimi, Ilaria Giuliano, Francesco Traversi e Lorenzo Prin-cipi con i quali ho avuto modo di discutere approfonditamente su molte questioni e infine Sara Cavatorti, per il suo impagabile aiuto nella trascrizione dei documenti.
1 La data di nascita di Baccio è alquanto controversa sebbene compresa in un ritaglio di anni ridottissimo. La portata cata-
stale compilata nel 1480 a Montelupo dalla madre Lisabetta, lo ricorda di anni dieci e quindi nato nel 1470 o al più l’anno prece-dente, mentre in altri due documenti simili registrati nel 1487 a nome di Lisabetta e nel 1489 a nome di Baccio insieme al fratello maggiore Astore, il nostro scultore è ricordato in entrambe le occasioni di anni venti; cfr. J. D. TURNER, The Sculpture of Baccio da Montelupo, Providence 1997, pp. 216-217, doc. 3; R. GATTESCHI, Baccio da Montelupo. Scultore e architetto del Cinquecento, Firen-ze 1993, p.28, nota 5. In realtà sui documenti ci sarebbe da fare una precisazione molto importante; Turner e Gatteschi pubblica-no infatti due differenti registri appartenenti alla medesima portata catastale, di cui uno sembra rappresentare l’originale (10 ot-tobre 1487), l’altro invece una copia postuma dell’atto (3 agosto 1489). Se nel primo l’età di Astore e Baccio è rispettivamente di 24 e 20 anni, nel secondo, in cui entrambi compaiono in veste di sottoscrittori, la loro età sembra essere rimasta invariata se non fosse per quell’aggiunta di due anni che compare di fianco ai nomi tra parentesi a testimoniare come il documento sebbene por-ti la data 1489 vada riferito alla situazione economica della famiglia di Montelupo nei due anni precedenti. Elemento che sembra quindi non confermare definitivamente per Baccio una data di nascita nel 1469 lasciando aperta un’ipotesi plausibile anche per il 1467. A chiarire tuttavia definitivamente la diatriba è la portata catastale di Baccio al 21 maggio 1504, quando lo scultore si dichiara trentacinquenne confermando quindi la sua data di nascita nel 1469, cfr. TURNER, The Sculpture...cit. (nota 1), pp. 223-224, doc. 8.
2 Ciò deriva in particolare dal ruolo assegnato al Montelupo di fervente seguace di Girolamo Savonarola tramandato dalle fonti a lui coeve. Esempio calzante a tal proposito è la narrazione proposta da una biografia del Savonarola compilata da un ano-nimo autore dei primissimi anni del Cinquecento per molto tempo attribuita alla mano di un certo Pseudo-Burlamacchi: “Men-tre ardeva la fiamma della persecuzione contro il Padre Girolamo molti dei seguaci suoi fur costretti lasciar Firenze, et mutar pa-ese: tra quali fu uno scultore molto eccellente domandato Bartolo da Monte Lupo”: P. GINORI CONTI, La Vita del Beato Ieronimo
DAVID LUCIDI84
Savonarola scritta da un anonimo del sec. XVI e già attribuita a Fra Pacifico Burlamacchi, Firenze 1937, p. 201. Si deve poi alle me-morie di Padre Vincenzo Marchese il merito di aver incrementato la fortuna di Baccio all’interno della sua monumentale opera sugli artisti domenicani, dove non manca più volte di ricordare il Montelupo tra la schiera dei ferventi savonaroliani, investendo-lo del ruolo di principale scultore dell’ordine, al fianco di altri importanti artisti come Simone del Pollaiolo, detto il Cronaca, San-dro Botticelli e Fra Bartolomeo: V. MARCHESE, Memorie dei più insigni pittori, scultori e architetti domenicani del p. Vincenzo Mar-chese dello stesso istituto, 3 voll., Firenze 1854, I, p. 381.
3 É quanto fino ad oggi sembra emergere dagli unici due consistenti studi dedicati alla figura dello scultore di Montelupo, tra cui ricordiamo il contributo di Francesca Petrucci pubblicato oramai quasi trent’anni fa e quello di John Douglas Turner: F. PETRUCCI, Baccio da Montelupo a Lucca, in ‘Paragone’, 417, 1984, pp. 3-22; TURNER, The Sculpture...cit. (nota 1).
4 G. VASARI, Le Vite de’ più eccellenti pittori scultori ed architetti, edizione a cura di G. Milanesi, 9 voll., Firenze 1878-1885, IV, 1879, pp. 539-549.
5 Il documento, citato da Riccardo Gatteschi (GATTESCHI, Baccio...cit. [nota 1], p. 28) è pubblicato e trascritto integralmen-te da John Turner: TURNER, The Sculpture...cit. (nota 1), pp. 216-217.
6 A. F. VERDE, La congregazione di San Marco dell’ordine dei frati predicatori. Il reale della predicazione savonaroliana, in ‘Memorie domenicane’, 14, 1983, p. 171; TURNER, The Sculpture...cit. (nota 1), p. 218, doc. 4.
7 VASARI, Le Vite...cit. (nota 4), IV, 1879, p. 539.8 Ibidem.9 Sono ben tre fonti storiche a ricordare l’esistenza del Giardino “in sulla piazza San Marco”: le Vite di Giorgio Vasari nelle
edizioni torrentiana e giuntina (G. VASARI, Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue, insino ai tem-pi nostri, [1550], 2 voll., Torino 1986, vita di Michelangelo, Torrigiano e Francesco Granacci, pp. 594-595; 803-804; 882-883; VASA-RI, Le Vite...cit. [nota 4], IV, 1879, pp. 258-259; ivi, p. 513; VI, 1881, pp. 599-600; ivi, p. 201; VII, 1881, pp. 141-143; VIII, 1881, p. 141), Ascanio Condivi (A. CONDIVI, Vita di Michelangelo Buonarroti [1553], Milano 1998, pp. 23-30; 94-97) e l’Anonimo Magliabe-chiano (Il Codice Magliabechiano, a cura di K. Frey, Berlin 1892, pp. 110-113).
10 L. BORGO - A. H. SIEVERS, The Medici Garden at San Marco, in ‘Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz’, XXXIII, 1989, pp. 237-256.
11 C. ELAM, Il palazzo nel contesto della città: strategie urbanistiche dei Medici nel gonfalone del Leon d’Oro, 1415-1530, in Il Palazzo Medici Riccardi di Firenze, Firenze 1990, pp. 44-57; C. ELAM, Il giardino delle sculture di Lorenzo de’ Medici, in Il giardino di San Marco. Maestri e compagni del giovane Michelangelo, a cura di P. Barocchi, Firenze 1992, pp. 151-172; C. ELAM, Lorenzo de’ Medici’s Sculpture Garden, in ‘Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz’, XXXVI, 1992, pp. 41-84.
12 N. BALDINI, Quasi Adonidos hortum. Il giovane Michelangelo al giardino mediceo delle sculture, in Giovinezza di Michelangelo, a cura di K. Weil-Garris Brandt, C. Acidini Luchinat, J. D. Draper, N. Penny, Firenze 1999, pp. 49-56. Cfr. per ultimo il saggio della stu-diosa apparso nel catalogo della Mostra fiorentina dedicata alla committenza artistica sotto il pontificato di Leone X: N. BALDINI, “Qual-che gentilezza di cose antiche”. Del giardino di Lorenzo il Magnifico in piazza San Marco, di alcuni artisti e del cardinale Giovanni de’ Me-dici, in Nello splendore mediceo. Papa Leone X e Firenze, catalogo della mostra a cura di N. Baldini - M. Bietti, Firenze 2013, pp. 59-67.
13 Il Frey confuse lo spazio creato da Lorenzo nei pressi del convento di San Marco con un altro Giardino appartenuto a Clarice Orsini, moglie del Magnifico, il quale a suo volta ne ereditò il possesso solo alla morte della consorte avvenuta nel 1488, de-terminando così anche una confusione cronologica sull’effettiva presenza di artisti nominati dal Vasari, come Leonardo da Vinci, che secondo la teoria dello studioso avrebbero potuto farvi il loro ingresso solo dopo quella data: K. FREY, Michelangiolo Buonar-roti. Sein Leben und seine Werke, Berlin 1907, pp. 62-64.
14 A. CHASTEL, Vasari et la légende médicéenne: l’”Ecole du Jardin de Saint Marc”, in ‘Studi vasariani’, atti del convegno in-ternazionale per il IV centenario della I edizione delle Vite del Vasari (Firenze, Palazzo Strozzi, 16 - 19 settembre 1950), Firenze 1952, pp. 159 -167.
15 La Elam, in effetti, nonostante riconosca la reale presenza del Giardino e un apprendistato svoltosi al suo interno per ar-tisti come Michelangelo, Leonardo, Torrigiano e Granacci, per altri personaggi considera la menzione vasariana frutto di una stra-tegia architettata dal biografo per dar vita al mito mediceo di una Proto-accademia, antesignana della futura Accademia del Dise-gno. ELAM, Il giardino...cit. (nota 12), pp. 166-169.
16 Ivi, pp. 167-168.17 Sulla veridicità di una presenza di questi due artisti presso l’entourage del Magnifico cfr. i recenti contributi di Nicoletta Bal-
dini: N. BALDINI, Niccolò Soggi, Firenze 1997, pp. 25-28; N. BALDINI, Andrea Sansovino. I Documenti, Monte San Savino 1999, pp. 21-23.18 Oltre a Vasari, a ricordare la presenza del Granacci nel Giardino di Lorenzo il Magnifico è anche il Condivi il quale lo ri-
corda “molto famigliare” del Buonarroti individuandolo proprio in quel personaggio che spinse Michelangelo verso il “giardin de’ Medici a San Marco”, cfr. CONDIVI, Vita... (nota 9), pp. 9-11.
BACCIO DA MONTELUPO 85
19 Del medesimo avviso è anche Nicoletta Baldini in: BALDINI, “Qualche...cit. (nota 12), p. 63.20 F. ALBERTINI, “Memoriale di molte statue et Picture sono nella inclyta Cipta di Florentia”, [1510], a cura di Waldemar H.
de Boer, Firenze 2010.21 U. PROCACCI, Del “Memoriale di molte statue et picture sono nella inclyta cypta di Florentina di Francesco Albertini, in ‘An-
tichità viva’, XXV, 4, 1986, p. 7.22 Ivi, pp. 7-8.23 ALBERTINI, Memoriale...cit. (nota 20), pp. 78, 93. 24 Ibidem.25 VASARI, Le Vite...cit. (nota 4), VI, 1881, p. 141.26 Ipotesi questa peraltro già avanzata in passato anche da John Turner e per la quale risulta essere decisiva il confronto so-
prattutto con la produzione maianesca di crocifissi lignei, icone imprescindibili di riferimento per il nostro Baccio ad inizio anni no-vanta del Quattrocento: TURNER, The Sculpture...cit. (nota 1), pp. 8-36.
27 Per la frequentazione michelangiolesca della bottega di Benedetto da Maiano cfr. J. BECK, Benedetto di Lionardo da Ma-iano e Michelangelo giovane, in Giuliano e la bottega dei Da Maiano, convegno internazionale di studi (Fiesole, 13-15 giugno 1991), a cura di D. Lambertini, Firenze 1994, pp. 176-181.
28 É questo il caso di Simone del Pollaiolo detto il Cronaca, architetto e legnaiolo, entrato in possesso di un crocifisso ligneo di Benedetto da Maiano, così come Lorenzo di Credi, Cosimo Rosselli (D. CARL, Benedetto da Maiano, Ein Florentiner Bildhauer an der Schwelle zur Hochrenaissance, 2 voll., Regensburg 2006, I, p. 525), e Leonardo del Tasso che del maestro, oltre ad ottene-re gli spazi della bottega posta in via dei Servi, sembra ereditare anche il completamento di alcune commissioni, come quella ri-cordata del Vasari dell’altare marmoreo di Santa Chiara in via dei Serragli, ora al Victoria & Albert Museum di Londra (CARL, Be-nedetto...cit. [nota 28], pp. 386, 523, doc. 23; T. MOZZATI, Giovanfrancesco Rustici. Le compagnie del Paiuolo e della Cazzuola, Fi-renze 2008, pp. 66-68.
29 CARL, Benedetto...cit. (nota 28), pp. 523-530. 30 Tale documento era già apparso nel contributo di John Turner su Baccio da Montelupo il cui nome è stato correttamen-
te trascritto dallo studioso americano come “Bartholomeo Iohannis Astoris”. É giusto ricordare che nei due monumentali volumi dedicati dalla studiosa tedesca Doris Carl a Benedetto da Maiano il medesimo documento è trascritto riportando un nome erra-to, “Marcho Iohannis Astoris” al posto di quello corretto precedentemente ricordato dal Turner; TURNER, The Sculpture...cit. (no-ta 1); CARL, Benedetto...cit. (nota 28), p. 528, doc. 26.
31 F. CAGLIOTI, Nuove terracotte di Benedetto da Maiano, in ‘Prospettiva’, 126/127, 2007, pp. 15-55.32 M. COLLARETA, voce Leonardo del Tasso, in Dizionario Biografico degli Italiani, 38, 1990, pp. 302-303. 33 La rappresentazione in scultura del tema della Pietà si diffuse con enorme fortuna già nei primi decenni del Trecento in
area franco-germanica, dove la consuetudine di recitare le preghiere nell’ora dei Vespri – che nel Breviario corrispondeva al mo-mento della discesa dalla Croce – innanzi al corpo del Cristo disteso sulle gambe della Vergine, ne aveva determinato la denomi-nazione di Vesperbild. Successivamente, questo particolare genere di rappresentazione figurativa trovò larga diffusione anche in Italia grazie alle presenza di maestranze nordiche itineranti, è il caso ad esempio del gruppo marmoreo del tedesco Hans von Fer-nach nel Duomo di Milano (1390-1393), ben presto imitate da botteghe locali di artisti impegnati a declinare e moltiplicare l’ico-nografia originaria secondo canoni espressivi legati alle differenti geografie artistiche e devozionali della penisola. Collocato cro-nologicamente tra i capitoli canonici della scesa dalla croce e la deposizione nel sepolcro ma non codificato dalle fonti evangeliche, né dal culto ufficiale, la messa in scena del compianto sul Cristo defunto lasciava ampia immaginazione interpretativa e narrativa a mistici, esegeti, in particolare quelli di ispirazione francescana, e conseguentemente anche agli artisti. Mentre in ambito emilia-no, lombardo e ticinese particolare attenzione venne rivolta ad una figurazione concitata, corale, dolorosa e soprattutto umaniz-zata del corpo morto del Redentore, arrivando a comprendere nella scena sacra fino ad otto personaggi, in ambito toscano, a par-tire dagli antefatti di Alberto di Betto d’Assisi e del Vecchietta a Siena, e di Dello Delli a Firenze, si scorse l’esigenza di privilegia-re l’intimità di un rapporto affettivo madre-figlio perpetuandolo nel momento della meditazione del corpo del Redentore da par-te di Maria, solitamente accompagnata dalle figure della Maddalena e del San Giovanni evangelista virginis custos. Su questo tema cfr. W. KÖRTE, Deutsche Vesperbilder in Italien, in ‘Kusthgeschichtliches Jahrbuch der Biblioteca Hertziana’, I, 1937, pp. 1-138; W. PINDER, Die Pietà, Leipzig 1922; G. SWARZENSKI, Italianische Quellen der deutschen Pietà, in Festschrift für H. Wölfflin, Munchen 1924, pp. 127-128. Si deve a Giancarlo Gentilini il merito di aver discusso più recentemente tale problematica, fornendo un’am-pia sintesi sulle soluzioni iconografiche e tipologiche legate alla rappresentazione della Pietà in scultura nel Rinascimento fioren-tino: G. GENTILINI, Una Pietà di Andrea della Robbia, Firenze 1991, pp. 3-6.
34 W. BODE, der Beweinung Christi von Giovanni della Robbia und der Einfluss des Savonarola auf die Entwicklung der Kunst in Florenz, in ’Jahrbuch der Königlich Preußischen Kunstsammlungen’, VIII, 1887, pp. 217-226. Studio pubblicato nuovamente
DAVID LUCIDI86
in: W. BODE, Florentiner Bildhauer der Renaissance, Berlin 1902, pp. 335-350. Per ultimo va menzionato il contributo di Ferenc Ve-ress sul tema della spiritualità savonaroliana ispiratrice della celebre Pietà vaticana di Michelangelo Buonarroti: F. VERESS, Miche-langelo e Savonarola: la Pietà di San Pietro, in ‘Zeitschrift für Kunstgeschichte’, 4, 2010, pp. 539-554.
35 CAGLIOTI, Nuove... cit. (nota 31), p. 21.36 A. CECCHI, La Pietà del Perugino per San Giusto degli Ingesuati, in Gli Uffizi. Studi e ricerche. 1, Firenze 1984, pp. 29-35; P.
SCARPELLINI, Perugino, Milano 1984, pp. 34, 82; GENTILINI, Una Pietà...cit. (nota 33), p. 3, nota 3.37 Vedi nota 34. 38 GENTILINI, Una Pietà ... cit. (nota 33), pp. 8-11.39 D. CARL, Bartolomeo Lapi, Benedetto da Maiano und die “Pietà” für Santa Maria Nepotecosa, ‘Mitteilungen des Kunsthisto-
rischen Institutes in Florenz’, 51, 2007(2008), pp. 267-270.40 G. GENTILINI, Catalogo delle sculture, in La Spezia. Museo Civico Amedeo Lia. Sculture terracotta, legno, marmo, La Spezia
1997, pp. 61-66, cat. 7; CAGLIOTI, Nuove...cit. (nota 31), pp. 20-21. Per ultimo: T. MOZZATI, Benedetto da Maiano, Madonna dolen-te, in Il cotto dell’Impruneta. Maestri del Rinascimento e le fornaci di oggi, a cura di G. Gentilini - R. C. Proto Pisani, Firenze 2009, pp. 92- 95, cat. II.10.
41 CAGLIOTI, Nuove...cit. (nota 31), pp. 20-21.42 Ibidem.43 F. FILIPPINI, Baccio da Montelupo in Bologna, in ‘Dedalo’, 8, 1927/1928, pp. 527-542; I. B. SUPINO, L’arte nelle chiese di Bo-
logna, 2 voll., Bologna 1938, I, pp. 256-258. 44 P. VENTURINO ALCE, La Basilica di San Domenico in Bologna, Bologna 1994, p. 15.45 Nel corso dell’aprile del 1493 Baccio accetta la dote di 11 fiorini portata dalla futura sposa Caterina di Bartolomeo di Gio-
vanni di Masino, come ricorda un atto sottoscritto nel quartieri fiorentino di San Michele Visdomini dai pittori Jacopo di Piero da Mediolano e Domenico di Tommaso Curradi: L. A. WALDMAN, The Patronage of a Favourite of Leo X: Cardinale Niccolò Pandolfini, Ridolfo del Ghirlandaio and the Unfinished Tomb by Baccio da Montelupo, in ‘Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Flo-renz’, 48, 2004 (2005), p. 124.
46 Il documento rinvenuto dal Waldman nel fondo notarile dell’Archivio di stato di Firenze, certifica che “Bartholmeus Io-hannis Astoris schultor de Montelupo” nel gennaio del 1494 si trovava a Firenze dove ricevette una somma di 25 fiorini per il suo so-stentamento da parte di un barbiere suo concittadino: Ibidem.
47 Vedi Appendice n. 1. Personaggio che Gaetano Milanesi nell’albero genealogico della famiglia di Baccio posto alla fine del commentario alla Vita vasariana descriveva come pittore (VASARI, Le Vite... cit. [nota 4], IV, 1879, pp. 549), ma che in realtà in un atto del gennaio 1528 compare come “scultore” del popolo di San Pier Maggiore di Firenze: WALDMAN, The Patronage ... cit. (nota 45), p. 126.
48 A. EMILIANI, Dal realismo quattrocentesco allo stile patetico e “all’antica”, in Niccolò dell’Arca seminario di studi, a cura di G. Agostini - L. Ciammitti, Bologna 1989, pp. 221-231; Il compianto sul Cristo Morto. Quattro capolavori della scultura emiliana del Quattrocento, a cura di J. Bentini - L. Fornasari Schianchi, Bologna 2000.
49 G. GENTILE, Testi di devozione e iconografia del Compianto, in Niccolò dell’Arca seminario di studi, a cura di G. Agostini - L. Ciammitti, Bologna 1989, pp. 167-213.
50 Sembra ragionevole l’identificazione in Giuseppe d’Arimatea per la mancanza di qualsiasi tipo di copricapo, attributo in-vece di Nicodemo. Cfr. W. STECHOW, Joseph of Arimathea or Nicodemus?, in ‘Studien zur toskanischen Kunst. Festschrift Ludwig Heydenreich, München 1964, pp. 296-297; J. D. TURNER, Baccio da Montelupo, in Il Giardino di San Marco. Maestri e compagni del giovane Michelangelo, a cura di P. Barocchi, Firenze 1992, pp. 119-120, cat. 25.
51 Già in Santa Maria Nipotecosa per l’Altare Lapi; cfr. CAGLIOTI, Nuove ... cit. (nota 31), pp. 20-21.52 CARL, Benedetto... cit. (nota 28), II, tav. 94, p. 111. 53 Ivi, tav. 11, pag. 33 .54 VENTURINO ALCE, La Basilica ... cit. (nota 44), pp. 15-16.55 Niccolò dell’Arca tra l’agosto e il settembre del 1493 riceveva pagamenti per una figura di San Domenico da porsi “sopra
la grada de la Capella de la Testa” di San Domenico, cfr. C. GALASSI, Niccolò dell’Arca, in La scultura al tempo di Andrea Mantegna, catalogo della mostra a cura di V. Sgarbi, Milano 2006, pp. 108-111; A. SARCHI, Niccolò dell’Arca. San Domenico, in Emozioni in ter-racotta, Guido Mazzoni Antonio Begarelli. Sculture del Rinascimento emiliano, catalogo della mostra a cura di G. Bonsanti - F. Picci-nini, Modena 2009, pp. 113-114, cat. 11.
56 E. MORRA, Il percorso artistico di Vincenzo Onofri, in ‘Il Carobbio’, 11, 1985, p.183 e nota 15. R. GRANDI, La scultura a Bo-logna nell’età di Niccolò, in Niccolò dell’Arca seminario di studi, atti del convegno (Bologna, 26-27 maggio 1987), a cura di G. Ago-stini - L. Ciamitti, Bologna 1989, pp. 39-41.
57 FILIPPINI, Baccio... cit. (nota 43), p. 527.
BACCIO DA MONTELUPO 87
58 Appendice documentaria, doc. 7; cfr. TURNER, The Sculpture...cit. (nota 1), pp. 218-219.59 FILIPPINI, Baccio... cit. (nota 43), p. 527. Proprio a Firenze si conservano numerose testimonianze in terracotta e stucco del
Santo arcivescovo di Firenze morto nel 1459, frutto di una produzione seriale a calco che aveva i suoi modelli originali di riferimen-to per le fattezze del volto nella maschera funeraria conservata ancora oggi presso il convento di San Marco e nel busto in terracotta collocato in un tabernacolo nel transetto destro di Santa Maria Novella.
60 SUPINO, L’arte... cit. (nota 43), p. 254, nota 31; MORRA, Il percorso... cit. (nota 56), p. 183, nota 15; GRANDI La scultura... cit. (nota 56), p. 39. I due busti eseguiti nel corso del 1493 a soli due mesi dalla morte di Niccolò dell’Arca, si conservano oggi nelle col-lezioni del Museo civico di Bologna.
61 Proprio l’Onofri, che quattro anni dopo venne incaricato di eseguire per San Petronio un Compianto in terracotta poli-croma, diede prova di agire nella stretta osservanza dei drammatici canoni espressivi codificati anni prima da Niccolò dell’Arca nel Compianto di Santa Maria della Vita e in opere analoghe da Giudo Mazzoni. Cfr. MORRA, Il percorso... cit. (nota 56), pp. 181-184; R. D’AMICO, Vincenzo Onofri in San Petronio, in ‘Strenna storica bolognese’, 41, 1991, pp. 103-114; Quest’ultimo contributo associato ad una efficace campagna fotografica, è pubblicato anche in: Il Compianto sul Cristo morto. Quattro capolavori della scultura emilia-na del Quattrocento, a cura di J. Bentini - L. Fornasari Schianchi, Bologna 1996, pp. 116-118.
62 MORRA, Il percorso... cit. (nota 56), pp. 181-196, speciatim 185.63 A. FORATTI, L’ attività di Pagno di Lapo Portigiani in Bologna, in Miscellanea di storia dell’arte in onore di Igino Benvenuto
Supino, Firenze 1933, pp. 353-373.64 Francesco di Simone Ferrucci aveva eseguito in San Domenico la sepoltura del giurista bolognese Alessandro Tartagni
(1482-1483), detto Alessandro da Imola, maestro di Lodovico Bolognini, e in San Francesco il monumento funebre a Vianesio Al-bergati seniore (1485 ca.). Per le vicende relative al soggiorno bolognese dello scultore cfr. P. PARMIGGIANI, Francesco di Simone Fer-rucci tra Bologna e Roma: i sepolcri di Alessandro Tartagni e Vianesio Albergati seniore (con un’ipotesi per quello di Francesca Torna-buoni), in ‘Prospettiva’, 113/114, 2004, pp. 73-97.
65 “Nato circa il 1447, da Giovanni Bolognini e Lucrezia Isolani, e istruito alle leggi da Alessandro da Imola, ne fu poscia pro-fessore per più anni egli stesso in Bologna e in Ferrara. Chiamato indi a Roma dal Pontefice Innocenzo VIII, con cui era stretto in af-finità, fu presso lui alcun tempo in decider le cause. Fu onorato col titolo di consigliere da Carlo VIII Re di Francia; e da Lodovico Sforza duca di Milano. Chiamato auditor di Rota e podestà a Firenze verso il 1495. Da Alessandro VI fatto avvocato concistoriale e senatore di Roma; da Giulio II nominato senator di Bologna, e inviato in suo nome a Luigi XII Re di Francia; dalla qual ambascia-ta, tornato a Roma, mentre viaggiava di nuovo verso Bologna, sorpreso da malattia in Firenze, ivi morì a 19 di Luglio 1508”. E con-tinuando : “Sopra ogni cosa prò deesi lodar la premura di questo illustre giureconsulto nell’emendare e nel rendere all’antica e sin-cera loro lezione i libri delle Pandette. Una lettera a lui scritta dal Poliziano ci fa vedere ch’egli aveva scritto a tal fine a Lorenzo dè Medici, perché si consultasse su un certo passo il famoso codice di esse prima serbato in Pisa, poi in Firenze; e il Poliziano mandan-dogli a nome di Lorenzo la copia del passo da lui richiesto loda il Bolognini dell’opera a cui erasi accinto e desidera che da tutti gli altri giureconsulti sia in ciò imitato. Il Bolognini poi venuto a Firenze dopo la morte del Poliziano [1494], ed avendo avuto sott’oc-chio le collazioni delle Pandette fatte da questo grand’uomo, di esse si valse a correggerle”: G. TIRABOSCHI, Storia della letteratura ita-liana, 8 voll., 1822-1826, VI, Milano 1824, pp. 849-850.
66 G. FANTUZZI, Notizie degli scrittori bolognesi, 8 voll., Bologna 1781-1790, II, 1782, pp. 260-270. 67 TIRABOSCHI, Storia... cit. (nota 65), II, 1824, pp. 849-850.68 L. LANDUCCI, Diario Fiorentino dal 1450 – al 1516 di Luca Landucci continuato da un anonimo fino al 1542, Firenze 1883,
pp. 73-76.69 L. BESCHI, Le antichità di Lorenzo il Magnifico: caratteri e vicende, in Gli Uffizi. Quattro secoli di una galleria, atti del con-
vegno internazionale di studi (Firenze 1982), a cura di P. Barocchi - P. Ragionieri, 2 voll., Firenze 1983, I, pp. 161-176; p. 169; ELAM, Lorenzo ...cit. (nota 11), p. 164.
70 Acquisto che venne ratificato il 6 novembre del 1495: ELAM, Lorenzo...cit. (nota 11), pp. 51, 76; K. WEIL-GARRIS BRANDT, N. BALDINI, Cronologia ragionata del periodo giovanile di Michelangelo (1475-1504) con particolare riguardo al primo soggiorno roma-no, in Giovinezza ... cit. (nota 12), p. 441.
71 Il Bentivoglio era creditore nei confronti di Piero de’ Medici di una cifra di ben 18.000 fiorini: immaginiamo quindi, co-me fa notare la stessa Caroline Elam, che l’acquisizione del Giardino sia stata anche una sorte di garanzia per un debito difficilmen-te colmabile dalla casata fiorentina in una tale condizione politico-economica: ibidem.
72 Come appare in una lettera scritta a Firenze dal giovane chierico Ser Amadeo al fratello scultore Adriano Fiorentino. G. POGGI, Della prima partenza di Michelangelo da Firenze, in ‘Rivista d’arte’, IV, 1906, pp. 33-37; BALDINI, Quasi... cit. (nota 12), p. 53. Gli studi di Caroline Elam hanno ben chiarito come il Giardino di San Marco continuasse nella sua funzione di ‘scuola’ anche do-po la morte di Lorenzo il Magnifico, avvenuta l’8 aprile 1492, sotto l’ala del figlio Piero: ELAM, Lorenzo...cit. (nota 11), pp. 50-58.
DAVID LUCIDI88
73 Baccio come già detto in precedenza è attestato a Bologna tra il gennaio e l’aprile del 1495 dai documenti relativi ai lavo-ri in San Domenico; nulla però vieta di immaginare un prolungamento del suo soggiorno, forse cominciato qualche mese prima al pari dell’amico Michelangelo, la cui presenza nella città dei Bentivoglio è certificata almeno per un anno intero a partire dall’otto-bre 1494 fino al dicembre dell’anno successivo; WEIL-GARRIS BRANDT - BALDINI, Cronologia ...cit. (nota 70), p. 441.
74 Per ultimo si rimanda al contributo di Andrea Emiliani sul primo soggiorno bolognese di Michelangelo tra il 1494 e il 1495, con un percorso attraverso la bibliografia precedente relativa all’impegno del Buonarroti nel completamento dell’Arca di San Domenico: A. EMILIANI, Michelangelo a Bologna, in Giovinezza ... cit. (nota 12), pp. 127-137.
75 A ricordarlo sono due documenti conservati presso l’Archivio di San Domenico a Bologna: il primo che registra pagamen-ti nel gennaio 1495 ai cosiddetti “Maystri del sepulcro”, l’altro invece tra il marzo e l’aprile del 1495, a Baccio e ad un certo mae-stro Antonio, probabilmente il pittore chiamato a dipingere le statue: TURNER, The Sculpture ...cit. (nota 1), pp. 217-218, docc. 5-5a.
76 Il documento è pubblicato da Francesco Filippini e in seguito trascritto nuovamente in Turner: FILIPPINI, Baccio... cit. (no-ta 43), p. 534; TURNER, The Sculpture... cit. (nota 1), p. 220, catt. 6-7.
77 PETRUCCI, Baccio ... cit. (nota 3), pp. 7-8; R. SPINELLI, Baccio Sinibaldi detto Baccio da Montelupo, Crocifisso, in L’officina della maniera. Varietà e fierezza nell’arte fiorentina del Cinquecento fra le due repubbliche 1494 – 1530, a cura di A. Cecchi - A. Na-tali - C. Sisi, Venezia 1996, pp. 90-91, cat. 9.
78 M. LISNER, Zum bildhauerischen Werk der Sangallo, I, in ‘Pantheon’, XXVII, 1969, pp. 99-119; M. LISNER, Holzkruzifixe in Florenz und in der Toskana, Monaco 1970, pp. 87-88; G. GENTILINI, in Per la storia della scultura, catalogo della mostra a cura di M. Ferretti, Torino 1992, pp. 22-31; G. GENTILINI, Proposta per Michelangelo giovane: un piccolo Crocifisso in legno di tiglio, in Pro-posta per Michelangelo giovane. Un crocifisso il legno di tiglio, catalogo della mostra a cura di G. Gentilini, Firenze 2004, pp. 15-16.
79 LISNER, Holzkruzifixe ...cit. (nota 78), pp. 79-80.80 Cfr. L. MARTINES, Savonarola. Moralità e politica nella Firenze del Quattrocento, Milano 2008, p. 165, nota 3, con tutta la
bibliografia storica di riferimento.81 P. PARENTI, Storia fiorentina, a cura di A. Matucci, 2 voll., Firenze 1994-2005, II, pp. 51-54.82 GINORI CONTI, La Vita ... cit. (nota 2), pp. 201-203.83 R. RIDOLFI, Soluzione di un fondamentale problema svonaroliano: dipendenza dello Pseudo-Burlamacchi dalla “Vita latina”,
in ‘La Bibliofilia’, XXXVII, 1935, pp. 401-418.84 Ibidem.85 GINORI CONTI, La Vita ...cit. (nota 2), p. 202. Sebbene in passato queste opere sono state erroneamente identificate nell’o-
monima serie di busti eseguita intorno alla metà del terzo decennio del Cinquecento da Alfonso Lombardi per la chiesa di San Giu-seppe di Via Galliera, poi passate alla cattedrale di Ferrara, (FILIPPINI, Baccio... cit. [nota 43], pp. 540-542) nulla esclude che anche il nostro Baccio possa aver portato realmente a termine una commissione di tale onere per la cattedrale di San Pietro a Bologna, di cui però sembra essersi persa ogni traccia già a partire dalla fonti storiche cinque e seicentesche cittadine come il Lamo, il Masini e il Malvasia che non ne fanno alcuna menzione.
86 Smentita poi dal Supino: I. B. SUPINO, L’arte nelle chiese di Bologna, II, Bologna 1938, p. 438.87 A. PARRONCHI, Il San Sebastiano ligneo di Santa Maria del Baraccano, in ‘Atti e memorie dell’Accademia clementina di Bo-
logna’, XI, 1974, pp. 59-66. Pubblicato anche da A. PARRONCHI, Donatello e il potere, Firenze 1980, pp. 187-211; A. PARRONCHI, Do-natello. Saggi e Studi 1962-1997, pp. 124-133.
88 PETRUCCI, Baccio... cit. (nota 3), p. 8.89 ALBERTINI, Memoriale... cit. (nota 20), p. 11.90 Ibidem.91 Cfr. a tal proposito i fondamentali studi di: I. CARDELLINI, Desiderio da Settignano, Milano 1962, pp. 217-235; A. BUTTER-
FIELD - C. ELAM - A. V. COONIN, Desiderio da Settignano’s Tabernacle of the Sacrament, in ‘Mitteilungen des Kunsthistorischen Insti-tutes in Florenz’, XLIII, 1999, 2/3, pp. 333-357. Cfr. più recentemente il contributo di Tommaso Mozzati che offre una sintesi del-le vicende critiche precedenti sul monumento con annessa bibliografia di riferimento: T. MOZZATI, Desiderio da Settignano, Taber-nacolo del Sacramento, in Desiderio da Settignano. La scoperta della grazia nella scultura del Rinascimento, a cura di M. Bormand - B. Paolozzi Strozzi - N. Penny, Parigi 2007, pp. 228-235.
92 D. MORENI, Delle tre sontuose cappelle medicee situate nell’imp. Basilica di S. Lorenzo di Firenze, descrizione istorico-criti-ca del Canonico Domenico Moreni, Firenze 1813, pp. 236-238.
93 D. MORENI, Continuazione delle Memorie istoriche dell’Ambrosiana imperial basilica di S. Lorenzo di Firenze, 2 voll., Fi-renze 1816-1817, I , 1816, p. 134.
94 Tale dinamica come proposto da Francesca Petrucci (PETRUCCI, Baccio ... cit.[nota 3], p. 20, nota 42), farebbe cadere l’ipo-tesi avanzata dal Kurz di riconoscere il Cristo bambino di Baccio in quello portato in processione nel corso del 1497 ricordato nel-
BACCIO DA MONTELUPO 89
la Vita latina del Savonarola: O. KURZ, A Group of Florentine Drawings for an Altar, in ‘The Journal of the Warburg and Courtald Institutes’, XVIII, 1955, pp. 35-53.
95 J. BECK, Desiderio da Settignano (and Antonio del Pollaiolo) Problems, in ‘Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz’, 28 , 1984, p. 214.
96 A ricordare il materiale dei due gruppi di sculture è un inventario del 1507 relativo ai beni appartenenti alla chiesa di San Lorenzo dove nel descrivere l’arredo scultoreo dell’Altare maggiore vengono menzionati “uno crocifixo di rilievo” e “Due Angeli di terra coloriti , posti in su due pilastri intagliati et dipinti”: ivi, pp. 214, nota 31.
97 Ivi, p. 222, nota 29.98 Di tale avviso Francesco FILIPPINI, Baccio ... cit. (nota 43), p. 534. Opera di cui in realtà Margrit Lisenr ne ha dimostrato
la provenienza dal complesso di San Basilio e ne ha fornito un’attribuzione, tuttora incontestata, ad Antonio del Pollaiolo intorno al 1470, cfr. LISNER, Holzkruzifixe ... cit. (nota 78), pp. 74-75.
99 VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), III ,1878, p. 108. 100 M. BORMAND, Il Bambino di San Lorenzo, in Desiderio da Settignano. La scoperta della grazia nella scultura del Rinascimen-
to, a cura di M. Bormand - B. Paolozzi Strozzi - N. Penny, Parigi 2007, p. 239. Tra le varie ipotesi avanzate in passato dalla critica sulla destinazione del Bambino e sulle motivazioni della sua rimozione dal tabernacolo vanno ricordate quella dei coniugi Paatz (W. - E. PAATZ, Die Kirchen von Florenz, 6 voll., 1940-1955, II, 1955, pp. 560-561), convinti che tale scelta fosse coincisa con una diffe-rente utilizzazione del complesso marmoreo per fini non più eucaristici – poi smentiti in questa direzione dal Gaborit (J. R. GABORIT, Desiderio da Settignano, Baccio da Montelupo et le Bambino de San Lorenzo, in Art, Objets d’art, collections, Études sur l’art du Mo-yen-Âge et de la Renaissance sur l’historie du goût et des collections, Paris 1987, pp. 97-103) – e quella del Kurz (O. KURZ, A Group of Florentine Drawings for an Altar, in ‘Journal of the Warburg and Courtald Institutes’, XVIII, 1-2, 1955, pp. 35-53).
101 BUTTERFIELD - ELAM - COONIN, Desiderio ... cit. (nota 91), pp. 333-357. 102 BORMAND, Il Bambino ... cit. (nota 100), p. 239, nota 10.103 BUTTERFIELD - ELAM - COONIN, Desiderio ... cit. (nota 91), pp. 345-349, doc. IX, p. 356.104 BORMAND, Il Bambino ... cit. (nota 100), pp. 236-239.105 Tra le versioni in marmo eseguite da autori diversi derivate dal prototipo desideriesco vanno ricordati i due esemplari con-
servati al Musée du Louvre a Parigi (uno attribuito proprio a Baccio da Montelupo, l’altro più vagamente ad un anonimo fiorentino), nel Museo della cattedrale di Prato (attribuito a Francesco di Simone Ferrucci) e quello fino a qualche tempo presso il Museum of Art di Cleveland, recentemente tornato sul mercato internazionale per scelte collezionistiche del Museo americano, e alcuni esem-plari in stucco: Firenze, Museo Stefano Bardini; Berlino, Staatliche Museen; Amsterdam, Rijksmuseum; Cambridge, Fitzwilliam Mu-seum; Detroit Istitutes of Arts; Ottawa, Musée des Beaux-Arts du Canada: BORMAND, Il Bambino ... cit. (nota 100), p. 246, cat. 26.
106 A. PARRONCHI, Sulla collocazione originaria del Tabernacolo di Desiderio, in ‘Cronache di archeologia e storia dell’arte’, 4, 1965, pp. 73-97.
107 L. PLANISCIG, Desiderio da Settignano, Wien 1942, p. 35. 108 GABORIT, Desiderio ... cit. (nota 100), pp. 100-102.109 BORMAND, Il Bambino... cit. (nota 100), pp. 240-243, cat. 24.110 GABORIT, Desiderio ... cit. (nota 100), p. 101.111 CARDELLINI, Desiderio ... cit. (nota 91), p. 292 (da Desiderio); GABORIT, Desiderio ...cit. (nota 100), p. 103, nota 39 (da
Desiderio); E. NERI LUSANNA - L. FAEDO, Il Museo Bardini a Firenze, Milano 1986, pp. 259-260, cat. 196 (da Desiderio da Settigna-no); M. BORMAND, Desiderio da Settignano (da), Gesù Bambino benedicente, in Desiderio da Settignano ... cit. (nota 91), pp. 246-249.
112 P. GUIDI, La Pietà di Lammari e la Pietà di Segromigno, in ‘Arte cristiana’, 3, 1915, pp. 68-70; PETRUCCI, Baccio... cit. (nota 3), pp. 3-6; A. MARKHAM SCHULZ, Glosses on the Career of Desiderio da Settignano, in Verrocchio, and Late Quattrocento Italian Sculp-ture, a cura di S. Bule - A. Phipps Darr - F. Superbi Gioffredi, Firenze 1992, pp. 179-188, fig. 128 - 129; TURNER, The Sculpture... cit. (nota 1), pp. 134-135. G. GHILARDUCCI, in Segromigno storia e territorio, a cura di G. Bedini - G. Ghilarducci, Lucca 2009, pp. 30-34.
113 H. UTZ, Una ‘Pietà’ sconosciuta di Giovanni della Robbia, in ‘Paragone’, 245, 1970, pp. 26-30.114 Gentilini ravvisava legami profondi con il Compianto eseguito nel 1495 per la chiesa di San Domenico a Bologna, cfr.
GENTILINI, Una Pietà ... cit. (nota 33), p. 15, nota 33.115 TURNER, The Sculpture... cit. (nota 1), pp. 159-160, cat. 8b.116 L’attribuzione del crocifisso custodito nella cella del Museo fiorentino di San Marco, divisasi in passato alternativamen-
te tra Baccio da Montelupo (PAATZ, Die Kirchen... cit. [nota 100], III, 1952, p. 36) e Benedetto da Maiano (LISNER, Holzkruzifixe ...cit. [nota 78], pp. 80-81) è stato più di recente confermata, oltre che dal Turner (TURNER, The Sculpture... cit. [nota 1], pp. 192-193), anche da Gentilini in: GENTILINI, Proposta ...cit. (nota 78), p. 59.
117 G. SAVONAROLA, Prediche sopra Amos e Zaccaria, ed a cura di P. Ghiglieri, 2 voll., Roma 1971, II, p. 25.
DAVID LUCIDI90
118 Proveniente dal convento delle Cappuccine di Firenze: W. BODE, Gruppe der Beweinung Christi von Giovanni della Robbia und der Einfluss des Savonarola auf die Entwicklung der Kunst in Florenz, in ‘Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlun-gen’, 8, 1887, pp. 217-226; A. MARQUAND, Giovanni della Robbia, Princeton 1920, pp. 76-77; H. SACHS, Staatliche Museen zu Ber-lin. Skulpturen Sammlung. Majolika Plastik der Italienischen Renaissance, Berlin 1964, p. 23, cat. 18; GENTILINI, Una Pietà ... cit. (nota 33), pp. 6 -8, note 37-38.
119 Anch’esso di provenienza fiorentina: J. POPE-HENNESY, Catalogue of Italian Sculpture in the Victoria and Albert Museum, London 1964, pp. 238-239, cat. 240.
120 W. R. VALENTAINER, Renaissance Sculptures, in ‘Bullettin of the Metropolitan Museum of Art’, 9, 1914, pp. 142-145, spe-ciatim 143 (late work of Benedetto da Maiano); J. BRECK, The Metropolitan Museum of Art. Italian Renaissance Sculpture. Twenty Pictures, New York 1933, p. 3, fig. 8 (come Giovanni della Robbia, workshop of); GENTILINI, Una Pietà ... cit. (nota 33), p. 8, no-te 37-38; CAGLIOTI, Nuove ... cit. (nota 31), p. 21, 40, nota 36.
121 GENTILINI, Una Pietà ... cit. (nota 33), pp. 8, 15, nota 39; F. CAGLIOTI, Benedetto da Maiano a Philadelphia: un terzo Spi-ritello per l’Altare Correale, in ‘Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa’, 4, 9/10, 2000(2002), pp. 123, 132, nota 37; CA-GLIOTI, Nuove... cit. (nota 31), pp. 21, 40, nota 36, con annessa bibliografia precedente.
122 Attribuzione espressa da GENTILINI, Una Pietà ... cit. (nota 33), pp. 6-8; GENTILINI, Catalogo ... cit. (nota 40), p. 64.123 Vedi nota 118.124 Come proposto da Giancarlo Gentilini per il gruppo di Philadelphia: GENTILINI, Una Pietà ... cit. (nota 33), pp. 8, 15,
nota 39. 125 Verso questo fronte sembra indirizzarsi Francesco Caglioti per il gruppo statuario della Johnson Collection, opera che
nonostante tutto a detta dello studioso rimane strettamente dipendente da prototipi maianeschi, cfr. CAGLIOTI, Benedetto ...cit. (nota 121), p. 123, nota 37.
126 GENTILINI, Una Pietà ... cit. (nota 33), p. 11.127 PETRUCCI, Baccio ...cit. (nota 3), 1984, p. 9.128 Si rimanda alla nota 184. 129 La portata catastale risalente al 1504 registra oltre a Baccio la moglie Agnoletta, la figlia Lucrezia di sette anni, i figli
Giovanni di anni nove e il terzogenito Pierfrancesco di anni cinque: TURNER, The Sculpture... cit. (nota 1), pp. 222-223, doc. 8. A questi andrà ad aggiungersi anche l’ultimo dei figli, Raffaello, nato nel luglio di quell’anno. Si rimanda all’Appendice documen-taria n. 3-4 per la trascrizione degli atti di battesimo, inediti, di Giovanni e Pierfrancesco, registrati presso l’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore.
130 TURNER, The Sculpture... cit. (nota 1), pp. 222-223, doc. 8.131 A confermare con maggior certezza la localizzazione della casa di Baccio è un documento legato indirettamente al Mon-
telupo trascritto da Allison Luchs all’interno della sua monografia dedicata alla chiesa fiorentina del Cestello, in cui “Bacio scul-tore da Montelupo” è ricordato abitatore in Via Laura e in rapporto di vicinanza con un certo Francesco di Giovanni Legnaiolo: A. LUCHS, A Cistercian Church of the Florentine Renaissance, New York-London 1977, p. 327, doc. 10.
132 CARL, Benedetto... cit. (nota 28), p. 526.133 G. POGGI, Un San Sebastiano di Baccio da Montelupo nella Badia di San Godenzo, in ‘Rivista d’arte’, VI, 1909, p. 134.134 L’opera fu poi donata dallo stesso Ammadio alla Compagnia di Gesù Pellegrino, che aveva la propria sede in uno spa-
zio adiacente alla zona absidale del tempio domenicano di Santa Maria Novella. Un Crocifisso, rintracciato agli inizi del 1900 in un luogo sotterraneo del tempio fiorentino, esposto attualmente sull’altare della cappella detta dell’Ora, fu ritenuto lo stesso re-alizzato da Baccio agli inizi del ‘500; TURNER, The Sculpture...cit. (nota ), p. 221, doc. 7b. Seguendo tuttavia la via tracciata an-ni prima da Walter Paatz, l’opera a mio avviso, sebbene vada considerata non distante dalla produzione del Montelupo, sembra più consona ai modi di altri artisti di ispirazione più puramente classica e monumentale come Andrea Sansovino; cfr. W. PAATZ, Berichte über die Sitzungen des Institutes, in ‘Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz’, 3, 1931, pp. 360-361. A questo andrebbe aggiunto quello di più modeste dimensioni collocabile cronologicamente a quel medesimo ritaglio cronologi-co, passato qualche anno fa sul mercato antiquario e ricondotto coerentemente da Alfredo Bellandi alla mano del nostro Bac-cio: A. BELLANDI, Baccio da Montelupo, Crocifisso, in Tardogotico e Rinascimento cinque maestri italiani, a cura di M. Natale, To-rino 2004, pp. 28-33.
135 ASF, Corporazioni religiose soppresse, S.S. Annunziata, n. 199, Debitori e Creditori, Libro bianco dal 1504 al 1510, c. 42. Il documento è pubblicato da C. VON FABRICZY, Sculture in legno di Baccio da Montelupo, in ‘Miscellanea d’arte’, IV, 1903, p. 67; TURNER, The Sculpture... cit. (nota 1), p. 224, doc. 10.
136 Appendice documentaria n. 2.137 Il documento è stato pubblicato per primo dal Fabriczy nel corso del 1903: FABRICZY, Sculture...cit. (nota 135), pp. 67-68.
BACCIO DA MONTELUPO 91
138 Ibidem; TURNER, The Sculpture... cit. (nota 1), pp. 225-226, doc. 11.139 La scultura, dopo i contributi documentari del Fabriczy e il rinvenimento del Poggi che valsero una enorme rivaluta-
zione della figura del Montelupo all’occhio della critica, fu esposta alla celebre mostra medicea “Il primato del Disegno”, tenutasi in Palazzo Strozzi a Firenze nel corso del 1980: L. PAOLUCCI, in Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinquecento. Il pri-mato del disegno, catalogo della mostra a cura di L. Berti, Firenze 1980, pp. 63-64, cat. 46. In seguito fu sottoposta ad un accura-to intervento di restauro durato fino al 1987 operato dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze: M. BIETTI - F. PETRUCCI, L’Abbazia di S. Godenzo e il San Sebastiano restaurato, Firenze 1989; TURNER, The Sculpture... cit. (nota 1), pp. 124-127, cat. 5a ; M. CIATTI - F. PETRUCCI - M. VENTURI - S. VESTRI, Il ‘San Sebastiano’ di Baccio da Montelupo, in Le antologie di ‘OPD Restauro’, 3/ la scultura lignea policroma. Ricerche e modelli operativi di restauro, a cura di L. Speranza, Firenze 2007, pp. 35-44. Per ultimo sull’opera in-serita in contesto di particolare influenza sull’arte del Montelupo dell’ambiente domenicano di San Marco e in particolare di Fra Bartolomeo cfr. I. URIBE, Fra Bartolomeo y el San Sebastián de Baccio da Montelupo, in ‘Storia dell’arte’, 27, 127, 2010, pp. 5-10.
140 POGGI, Un San Sebastiano ...cit. (nota 133), pp. 133-135.141 BIETTI - PETRUCCI, L’Abbazia... cit. (nota 139).142 V. SALADINO, Firenze, Gli Uffizi, Sculture antiche, Firenze 1983, pp. 110-111; M. C. MONACO, Arte ellenistica. Torso Gad-
di, in L’officina ... cit. (nota 77), pp. 152-153, cat. 40.143 F. HASKELL - N. PENNY, Taste and Antique. The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, New Haven-London 1982, pp.
148-151. L’opera, nota fin dalla fine del Quattrocento, quando era in possesso del cardinale Giulio della Rovere nel suo palazzo romano, godeva di una vasta fama nel corso dei primissimi anni del Cinquecento, venendo ripresa dal Buonarroti nella figura di nudo di sinistra del Tondo Doni, cfr. A. NATALI, L’antico, le Scritture e l’Occasione. Ipotesi sul Tondo Doni, in Gli Uffizi. Studi e Ri-cerche, 2, Firenze 1985, p. 22.
144 La scultura conservata ai Musei Vaticani di Roma, molto nota già nel corso della prima metà del Quattrocento, entrò nel corso del 1506 tra le collezioni di Giulio II e divenne assai celebre nel corso dei primi anni del secolo in particolare per le at-tenzioni che ad essa riservò Michelangelo, traendone ispirazione per la figura di San Giuseppe per il Tondo Doni, cfr. HASKELL - PENNY, Taste ... cit. (nota 143) pp. 311-314: NATALI, L’antico ... cit. (nota 143) pp. 21-37.
145 Attestato solo intorno alla metà del Cinquecento a Roma, ove rimase almeno fino al 1569 quando giunse a Firenze nel-le raccolte medicee, cfr. HASKELL - PENNY, Taste ... cit. (nota 143), pp. 134-136.
146 A. NATALI, La Bibbia in bottega. Le scritture, l’antico, l’occasione, Firenze 1991, pp. 77-88; A. NATALI, L’officina della ma-niera moderna, in Storia delle arti in Toscana. Il Cinquecento, Firenze 2000, pp. 60-61.
147 Ivi, pp. 86-101.148 A. SANTANGELO, Museo di Palazzo Venezia. Catalogo delle sculture, Roma 1954, p. 68.149 J. D. TURNER, Baccio da Montelupo, Testa di Giuseppe d’Arimatea, in Il Giardino ...cit. (nota 11), pp. 119-120, cat. 25.150 C. GIOMETTI, Museo Nazionale di Palazzo Venezia. Sculture in terracotta, IV, Roma 2011, p. 32, cat. 2.151 Il documento relativo alle sculture per San Godenzo, pubblicato per ultimo dal Turner, ricorda che il Montelupo ese-
guì “3 teste grandi sancto Ghaldenzio, sancto Luciano e sancto MArtiano” e altre “3 teste belle al naturale cioe Ja di Xpo e Ja di Madonna e Ja di sancto Giovanni: TURNER, The Sculpture ... cit. (nota 1), pp. 225-226, doc. 11.
152 Sulle vicende biografiche dei tre santi cfr. M. BROCCHI, Vite de Santi e Beati fiorentini, II, Firenze 1752, pp. 199-208.153 M. G. CIARDI DUPRÈ DAL POGGETTO, La bottega di Giuliano e Benedetto da Maiano nel Rinascimento fiorentino, Firen-
ze 1994, pp. 53, 67, cat. 9. 154 M. C. DE SIMONE - G. STORTONI, Fontelucente, Firenze 1986, pp. 12-15.155 La memoria del ritrovamento è stata fornita direttamente alla Ciardi Duprè da monsignor Giustino Formelli, autore
della scoperta dell’opera: CIARDI DUPRÈ DAL POGGETTO, La bottega ...cit. (nota 153), p. 53.156 G. GENTILINI, Nella Rinascita dell’antichità, in La civiltà del cotto. Arte della terracotta nell’area fiorentina dal XV al XX
secolo, Firenze 1980, p. 88.157 A. BELLANDI, Bartolomeo Sinibaldi detto Baccio da Montelupo, in I Della Robbia. Il dialogo tra le Arti nel Rinascimento, a
cura di G. Gentilini, Milano 2009, pp. 352-353, cat. 84.158 L. BARDESCHI-CIULICH, I contratti di Michelangelo, Firenze 2005, pp. 37-38.159 Il Carteggio di Michelangelo. Edizione postuma di Giovanni Poggi, a cura di P. Barocchi -R. Ristori, Firenze 1965-1983,
I, 1965, p. 118, n. LXXXVI.160 Il monumentale complesso marmoreo voluto da cardinale arcivescovo di Siena Francesco Todeschini Piccolomini vide
succedere alla propria esecuzione ben tre mani di celebri artisti, inizialmente quella di Andrea Bregno che nel 1485 aveva termina-to il monumentale altare commissionatogli nel 1481 almeno nelle parti principali, poi quella di Pietro Torrigiano in una brevissima parentesi che lo vide autore della statua del San Francesco tra il 1500 e il 1501 e a partire dallo stesso anno quella del Buonarroti,
DAVID LUCIDI92
chiamato ad eseguire per il prelato senese ben quindici statue, di cui però solo quattro vennero eseguite dallo scultore fiorentino; F. CAGLIOTI, La Cappella Piccolomini nel Duomo di Siena, da Andrea Bregno a Michelangelo, in Pio II e le arti. La riscoperta dell’antico da Federighi a Michelangelo, a cura di A. Angelini, Milano 2005, pp. 452-460.
161 Ibidem.162 La lettera così recita: “é stato da me a questi dì Matteo di Cuccherello e dicie che fece venire più tempo fa quattro pezzi
di marmo per tuo conto per fare quelle figure de cardinale di Siena e che, non le volendo tu, gliele facesti dare a Baccio da Monte-lupo”: Il Carteggio ... cit. (nota 159), I, 1965, p. 105, n. LXXIII.
163 C. DE TOLNAY, Michelangelo, I: Youth (1943), Princeton 1947, pp. 229-231.164 W. R. VALENTINER, Michelangelo’s Statuettes of the Piccolomini’s Altar in Siena, in ‘The Art Quarterly’, V, 1942, pp. 22-
23; W. R. VALENTINER, Michelangelo’s Piccolomini Statuettes and the Madonna in Bruges, in Studies of Italian Renaissance Sculpture, London-New York 1950, pp. 211-212.
165 E. CARLI, Michelangelo e Siena, Roma 1964.166 Di tale avviso sembra essere ancora Riccardo Gatteschi: GATTESCHI, Baccio... cit. (nota 1), pp. 63-65.167 CAGLIOTI, La Cappella ... cit. (nota 160), p. 460.168 T. MOZZATI, “Fece...una nostra donna col figlio in collo”: tradizione e maniera moderna nelle Vergini con Bambino di Gio-
vanfrancesco Rustici, in ‘Nuovi studi’, 8, 2003, p. 43; MOZZATI, Giovanfrancesco ... cit. (nota 28), pp. 29-30, fig. 13.169 VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), IV, 1879, p. 541.170 Ibidem. 171 Il convento delle Murate, venne fortemente danneggiato dall’alluvione del 1557 e in seguito nel corso dell’Ottocento ri-
dimensionato per accogliere le prigioni cittadine, con seguente dispersione delle opere d’arte ivi contenute; cfr. O. FANTOZZI MI-CALI - P. ROSSELLI, Le soppressioni dei conventi a Firenze. Riuso e trasformazioni dal sec. XVIII in poi, Firenze 1980, p. 79, cat. 7.
172 La chiesa di San Pier Maggiore, soppressa dall’ordinamento Leopoldino nel 1786 venne in seguito abbattuta per pro-blemi strutturali: cfr. FANTOZZI – MICALI - ROSSELLI, Le soppressioni ... cit. (nota 171), p. 79, cat. 7; p. 237, cat. 83. Tale edificio su-bì un notevole sviluppo architettonico a partire dal 1506 con l’edificazione di nuove cappelle e le rispettive decorazioni plastiche o pittoriche a cui parteciparono i maggiori artisti fiorentini attivi a cavallo tra Quattro e Cinquecento, come Lorenzo di Credi, An-drea del Sarto, il Franciabigio, Francesco Granacci: M. BIETTI, Dal Savonarola al pontificato di Leone X: artisti e patroni in San Pier Maggiore a Firenze, in Nello splendore... cit. (nota 12), pp. 127-137. Baccio intervenne nella decorazione degli spazi eseguendo un Crocifisso commissionatogli forse dalla Compagnia del Santissimo Crocifisso proprietaria di un altare all’interno della chiesa e sulla cui paternità ascrivibile al Montelupo sembrano concordare le più autorevoli fonti storiche fiorentine come il Borghini (R. BORGHI-NI, Il Riposo, in cui della pittura, e della scultura si favella, de’ più illustri pittori, e scultori, a delle più famose opere loro si fa mentio-ne, e le cose principali appartenenti a dette arti s’insegnano, Firenze 1584, ed. a cura di M. Rosci, Milano 1967, p. 406), il Baldinuc-ci (F. BALDINUCCI, Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua, Firenze 1681-1728, ed. a cura di F. Ranalli, 7 voll., Firenze 1845-1847, I, 1845, p. 582) e il Richa (G. RICHA, Notizie istoriche della Chiese fiorentine Divise ne’ suoi Quartieri opera di Giuseppe Richa della Compagnia di Gesù Accademico e Socio Colombario, 10 voll., Firenze 1754-1762, I, 1754, p. 142): ivi, p. 137, note 61-62.
173 VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), IV, 1879, p. 541.174 A. DEL VITA, Opere d’Arte ignote o poco note;di un crocifisso di Baccio da Montelupo ritrovato nella chiesa di S. Fiora e Lu-
cilla in Arezzo, in ‘Rivista d’arte’, 7, 1910, pp. 90-92.175 A. MARCKHAM SCHULZ, An Unknown Crucifix by Baccio da Montelupo, in ‘Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes
in Florenz’, 42, 1998 (1999), pp. 190-197.176 Una lista complessiva dei Crocifissi entrati nel catalogo di Baccio intagliatore dopo i contributi dei coniugi Paatz e di
Margrit Lisner è pubblicata da GATTESCHI, Baccio... cit. (nota 1), pp. 59, 66, note 5-6.177 Indicativo a questo proposito è vedere quanto accaduto nel caso di una seriale produzione di Crocifissi, il cui esemplari
di qualità più elevata caratura si conservano nella chiese di San Niccolò a Prato, in San Pietro a Perticaia a Rignano sull’Arno e nel-la prepositurale di Santa Maria a Panzano, associati per molto alla mano del Montelupo ma, come chiarisce per ultimo anche Mas-simo Vezzosi, riferibili ad una bottega di scultura volta a replicare i modelli del Montelupo con “ruvida espressività”; M. VEZZOSI, in Quattro crocifissi lignei restaurati, Firenze 1998, pp. 15-19; C. CANEVA, Un crocifisso ligneo restaurato, Firenze 1994. Per ultimo si rimanda all’importante contributo di Francesco Traversi: F. TRAVERSI, Il maestro di Monsanto. Un crocifissaio nella Toscana del XV e XVI secolo, in ‘Arte cristiana’, CI, 878, 2013, pp. 331-343. Oppure il caso, ben più grave, del Crocifisso veneziano nella Scuola di San Fantin, palesemente lontano dai canoni figurativi del Montelupo e in generale da quelli dell’arte fiorentina del pieno Rinasci-mento: E. MERCKEL, Il Crocifisso della Scuola di San Fantin riconosciuto allo scultore Baccio da Montelupo, in Arte nelle Venezie, Sa-onara 2007, pp. 225-232. Altro esempio è il contributo di John Douglas Turner il quale sembra rinvenire in due crocifissi fiesolani quei caratteri tipici della produzione di Baccio che invece sento di relegare ad una produzione al massimo di bottega in quanto di-
BACCIO DA MONTELUPO 93
stante per carica pietistica e intensità espressiva dalle opere dello scultore di Montelupo: J. D. TURNER, Two Crucifixes attributed to Baccio da Montelupo, in ‘The Sculpture Journal’, 11, 2004, pp. 49-54.
178 LISNER, Holzkruzifix ... cit. (nota 78), p. 84.179 D. LUCIDI, Antonfrancesco Bugiardini. Una nuova figura di intagliatore di crocifissi nella Firenze del Cinquecento, in ‘Nuo-
vi studi’, 15, 2009, pp. 69-83. Un ulteriore esemplare riconducibile alla produzione di Antonfrancesco Bugiardini è stato presentato da Francesca Petrucci alla mostra “Da Paolo Uccello a Vasari”, attualmente in corso presso il Palazzo Pretorio di Figline Valdarno: F. PETRUCCI, in Da Paolo Uccello a Vasari, catalogo della mostra a cura di N. Pons, Firenze 2013, pp. 110-113, cat. 10.
180 GATTESCHI, Baccio ... cit. (nota 1), p. 59. L’opera passò dopo il 1650 nella chiesa di San Piero a Monticelli e infine giun-se nella collocazione attuale.
181 LISNER, Holzkruzifix ... cit. (nota 78), p. 83. L’opera è stata recentemente pubblicata in: P. STIBERC, Ricerca anatomica e innovazioni nelle tecniche costruttive nella scultura lignea fiorentina del Quattrocento, in Scultura lignea. Per una breve storia dei si-stemi costruttivi e decorativi dal medioevo al XIX secolo, Roma 2012, pp. 58-59, fig. 20. Forse si tratta dello stesso crocifisso ricor-dato dal Vasari in San Pier Maggiore che, in seguito alla soppressione della chiesa nel 1786, probabilmente passò all’ordine del-le Montalve di San Jacopo Ripoli che ne ereditarono i beni: Cfr. FANTOZZI – MICALI - ROSSELLI, Le soppressioni ... cit. (nota 171), p. 237, cat. 83. Sulle vicende assai complesse legate al trasferimento del Crocifisso, già in San Pier Maggiore, cfr. il contributo di Mo-nica Bietti che sembra offrire una dinamica differente degli eventi successivi alla soppressione del tempio: BIETTI, Dal Savonarola ... cit. (nota 172), pp. 132-133.
182 LISNER, Holzkruzifix ... cit. (nota 78), p. 84; TURNER, The Sculpture... cit. (nota 1), pp. 178-179.183 LISNER, Holzkruzifix ...cit. (nota 78), p. 84.184 A tramandare la notizia è una lettera risalente al 1512, conservata in un libro di ricordanze del convento domenicano di
San Marco a Firenze che ricordava la presenza di Baccio a Venezia nel corso del 1508 essendo intervenuto come tramite per la spe-dizione dalla laguna in direzione di Firenze di alcuni colori destinati al pittore fra Bartolomeo, che tempo prima a Venezia aveva ri-cevuto la commissione di un pala d’altare per il convento di Murano. Cfr. MARCHESE, Memorie... cit. (nota 2), II, pp. 363, doc. III.
185 ALBERTINI, Memoriale ... cit. (nota 20), p. 93.186 “La statua pedestre di Benedetto Pesaro fu fatta da Lorenzo Bregno. Et il marte di marmo lo scolpì Baccio da Montelu-
po Fiorentino”, cfr. F. SANSOVINO, Venetia, città nobilissima et singolare, descritta in xiiii libri, Venezia 1581, c. 66.187 A. MARCKAM SCHULZ, Giambattista and Lorenzo Bregno. Venetian Sculpture in the High Renaissance, New York 1991, pp.
192-196, cat. 28, tav. 28-32, 34-35.188 Ivi, p. 195. In merito alla bibliografia precedente vanno ricordati gli interventi di Soravia (G. SORAVIA, Le chiese di Ve-
nezia, 3 voll., 1822-1824, II, 1823, Venezia p. 47 f.) che attribuiva a Baccio entrambe le figure, del Kriegbaum (F. KRIEGBAUM, Mon-telupo, Baccio da, in Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler, a cura di U. Thieme - F. Becker, Leipzig 1931, T-B, XXV, p. 86) che individuava un intervento dello scultore nel Nettuno e non nel Marte, lo Zahn (J. BURCKHARDT, Der Cicerone, a cura di A. von Zahn, II, Leipzig 1869, p. 662) favorevole a intravedere nel monumento una collaborazione tra Baccio e Antonio Minello, e infine il McAndrew (J. MCANDREW, Venetian Architecture of the Early Renaissance, Cambridge-London, 1980, p. 487) il quale ha pensato di ricondurre l’intervento del Montelupo solo ad anni molto avanzati, dopo il 1523 anno della morte di Lorenzo Bregno. Di pare-re negativo è invece il TURNER, The Sculpture... cit (nota 1), pp. 207-208, cat. 29 c, che non vede plausibile l’attribuzione al Monte-lupo del Marte espungendolo dal catalogo dello scultore fiorentino.
189 MARCKAM SCHULZ, Giambattista ...cit. (nota 187), p. 195.190 L. BERTI, Per gli inizi del Rosso Fiorentino, in ‘Bollettino d’arte’, VI, LXVIII, 18, 1983, p. 54.191 Ibidem.192 VASARI, Le Vite...cit. (nota 4), IV, 1879, p. 541.193 PETRUCCI, Baccio ... cit. (nota 3), p. 15; G. GENTILINI, I Della Robbia. La scultura invetriata del Rinascimento, 2 voll., Fi-
renze 1992, II, pp. 456, 481; F. PETRUCCI, in I Della Robbia ... cit. (nota 157), pp. 375-376, cat. VII.4 a, b.194 GENTILINI, I Della Robbia ... cit. (nota 193), pp. 456, 481; PETRUCCI, Baccio ... cit. (nota 3), p. 15; PETRUCCI, in I Della Rob-
bia ... cit. (nota 157), pp. 375-376, cat. VII.4 a, b.195 Ibidem.196 Racconta l’aretino che “Fece [Baccio] uno Ercole per Pier Francesco de’ Medici”: VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), IV,
1879, p. 540.197 L. CAVAZZINI, 1400-1410: l’alba del Rinascimento, in La Primavera del Rinascimento. La scultura e le arti a Firenze, cata-
logo della mostra a cura di M. Bormand - B. Paolozzi Strozzi, Firenze 2013, pp. 69-73, speciatim. 70, con bibliografia precedente. 198 Sono le parole contenute in un motto di un antico sigillo duecentesco attestante già in quegli anni la fortuna iconografi-
ca dell’eroe romano in città, L. D. ETTLINGER, Hercules Florentinus, in ‘Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz’,
DAVID LUCIDI94
XVI, 1972, pp. 119-142. Sul soggetto iconografico dell’Ercole e la sua diffusione nell’ambiente artistico letterario di primissimo quattrocento cfr. il recente contributo di Enrica Neri Lusanna incentrato sul fecondo cantiere della porta della Mandorla della cattedrale di Santa Maria del Fiore: E. NERI LUSANNA, “Gareggiando, virtuosamente nella scultura s’esercitavano”. Apici tardogoti-ci e visione umanistica nei cantieri fiorentini, in Bagliori dorati. Il Gotico Internazionale a Firenze 1375-1440, catalogo della mostra a cura di A. Natali - E. Neri Lusanna - A. Tartuferi, Firenze 2012, pp. 31-32, con bibliografia di riferimento.
199 Oltre ad essere documentato dalle fonti cronachistiche del tempo e dai documenti relativi all’organizzazione del sun-tuoso corteo cittadino l’Ercole bandinelliano è ritratto nell’affresco di Giorgio Vasari in Palazzo vecchio raffigurante proprio Le-one X che attraversa Piazza della Signoria; cfr. I. CISERI, L’ingresso trionfale di Leone X in Firenze, Firenze 1990, pp. 86-91; I. CI-SERI, “Con tanto grandissimo e trionfante onore”. Immagini dall’ingresso fiorentino di Papa Leone X nel 1515, in BALDINI - BIETTI, Nello splendore ... cit. (nota 12), pp. 237-249.
200 La narrazione dell’evento spetta al Vasari nella Vita di Jacopo Sansovino: VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), VII, 1881, p. 491.201 Se intendiamo dar credito alla versione del Vasari secondo il quale il concorso andrebbe situato in concomitanza con
il ritorno di Jacopo Sansovino a Firenze e alla commissione del San Giacomo marmoreo per la cattedrale di Santa Maria del Fio-re, eventi certificati entrambi dai documenti nel 1511, dobbiamo immaginare uno svolgimento della competizione durante quel medesimo anno. Cronologia che nonostante trovi d’accordo il Boucher è stata spostata dallo studioso leggermente più avanti, al-meno a cavallo con l’anno seguente, quando più plausibile sarebbe stato un reale coinvolgimento da parte della fazione filo-me-dicea, come d’altra parte messo in evidenza anche dallo stesso Vasari: si rimanda a tal proposito alla discussione già affrontata nel mio precedente contributo (D. LUCIDI, Zaccaria Zacchi volterrano: una nota sulla formazione e qualche aggiunta al catalogo del-lo scultore, in ‘Nuovi studi’, 18, 2012, p. 141) e più particolare alle parole spese sull’argomento da B. BOUCHER, The Sculpture of Jacopo Sansovino, New Haven and London 1991, 2 voll., II, p. 319, cat. 8.
202 J. BALOGH, in ‘Studien in der alten Skulptursammlungdes Museums der bildenden Kunste’, IX, 1937-1939, pp. 45-75; BOUCHER, The Sculpture... cit. (nota 201), II, p. 319, cat. 8.
203 Racconta il Vasari in merito al Tatti che “se bene gli fu perciò allogata questa opera, fu nondimeno indugiato tanto a provvedergli e condurgli il marmo per ora et invidia d’Averardo di Filicaia, il quale favoriva grandemente il Bandinello et odia-va il Sansovino..”: VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), VII, 1881, p. 491; BOUCHER, The Sculpture...cit. (nota 201), II, p. 319, cat. 8.
204 L’opera (dimensioni 74,9 cm), in origine di proprietà dell’antiquario fiorentino Stefano Bardini e acquisita nel 1912 dai coniugi Von Pannwitz, è comparsa nel catalogo della vendita Sotheby’s (New York, Gennaio 2012, lotto 323) con un’attri-buzione al “Maestro dei bambini irrequieti”.
205 L’opera è stata presentata dalla Galleria Bacorelli di Firenze all’esposizione londinese “Frieze Moster”, nel 2012, mentre nel 2011 e 2013 esposta alla “Biennale dell’Antiquariato” di Firenze (cfr. XXVIII Biennale mostra mercato dell’antiquariato, cata-logo della mostra, Firenze 5-15 ottobre 2013). L’opera vanta uno studio inedito di Francesco Caglioti di prossima pubblicazione.
206 GUIDI, La Pietà di Lammari ... cit. (nota 112), pp. 68-70.207 VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), VI, 1881, pp. 247-248.208 E. FERRETTI, La Sapienza di Niccolò da Uzzano: l’istituzione e le sue tracce architettoniche nella Firenze rinascimentale,
in ‘Annali di storia di Firenze’, 4. 2009, pp. 89-149, speciatim 116, nota 188.209 Si vedano in particolare le vicende legate alla Compagnia della Cazzuola al cui interno militavano anche numerosi ar-
tisti che avevano sede lavorativa stabile proprio negli spazi della Sapienza: MOZZATI, Giovanfrancesco... cit. (nota 28), pp. 89-90.210 A. CECCHI, Profili di amici e committenti, in Andrea del Sarto: 1486-1530; dipinti e disegni a Firenze, Milano 1986, p.
47; A. NATALI, Andrea del Sarto, Milano 1998, p. 37.211 Come ricorda Vasari nella Vita di Andrea Sansovino: VASARI, Le Vite, cit... (nota 4), IV, 1879, p. 515; CECCHI, Profi-
li ... cit. (nota 210), p. 47.212 Il discepolato del Bandinelli presso il Rustici è ricordato dal VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), VI, 1881, p. 136. Sulle vicen-
de relative alla bottega del Rustici presso gli spazi della Sapienza cfr. MOZZATI, Giovanfrancesco ... cit. (nota 28), p. 89 e nota 449. 213 Tra questi Rosso Fiorentino, Jacopo da Pontormo e il Franciabigio, anche se per breve tempo comparvero anche Giu-
liano Bugiardini e Baccio Bandinelli impegnati anch’essi nella realizzazione di un affresco nel 1513, probabilmente quello raffi-gurante lo Sposalizio della Vergine, opera che in seguito a delle divergenze con i frati committenti del dipinto, fu poi eseguita dal Franciabigio. J. SHEARMAN, Rosso, Pontormo, Bandinelli and Others at S.S. Annunziata, in ‘The Burlington Magazine’, CII, 1960, pp. 152-156; L. PAGNOTTA, Giuliano Bugiardini, Torino 1977, p. 19, note 17-19.
214 Secondo quanto aveva acutamente messo in evidenza alcuni decenni orsono L. BERTI, Per gli inizi del Rosso Fioren-tino, in ‘Bollettino d’arte’, ser. VI, LXVIII, 18, 1893, pp. 45-60. Gruppo che per intenti e cultura andava idealmente ad oppor-si, alla concorrenziale scuola di San Marco, arroccata intorno alla figura di fra Bartolomeo, fautrice di una pittura “casta, severa, puristica”. A, NATALI, La Scuola dell’Annunziata, in L’Officina ... cit. (nota 78), pp. 167-169.
BACCIO DA MONTELUPO 95
215 D. FRANKLIN, Rosso in Italy. The Italian Career of Rosso Fiorentino, Milano 1994, p. 296, doc. 4a/b, 5; A. NATALI, Ros-so Fiorentino, Firenze 2006, pp. 13, 296, doc. 3.
216 VASARI, Le Vite ... cit. (nota 4), V, 1880, pp. 247-248.217 La personalità del Feltrini decoratore emerge a chiare linee a partire dalla narrazione vasariana che lo descriveva “ra-
ro maestro nelle grottesche de’ tempi nostri” e autore di “molti begli ornamenti” in occasione dei cerimoniali per l’ingresso di Leone X nel 1515 al fianco del Sansovino e Andrea del Sarto per la realizzazione della facciata effimera di Santa Maria del Fiore: VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), V, 1880, pp. 207-208; ivi, VI, 1881, p. 251. Assieme al Sarto e al Franciabigio il Feltrini compare già a partire dal 1507 in occasione delle dipintura delle cortine per l’altare della chiesa dei Servi e sembra proseguire ancora nel 1511 in occasione degli affreschi sarteschi al Cenacolo di San Salvi: NATALI, Andrea ... cit. (nota 210), pp. 43, 47.
218 Al pari delle vesti consunte dell’affresco del Pontromo del quale, strappato nel corso del 1955, rimangono solamente le tracce colorate delle figure, cfr. P. COSTAMAGNA, Pontormo, Milano 1994, p. 108, cat. 6. L’emblema mediceo scolpito da Baccio fino ad inizio Seicento campeggiava sull’arco del portico ad una sola arcata del tempio servita, poi sostituito nel 1601 dal grande loggiato eretto da Giovan Battista Caccini. Cfr. A. ASSONITIS, Pontormo, pittore leonino, in Nello splendore... cit. (nota 12), p. 261.
219 Ivi, pp. 107-108, cat. 6. 220 ASSONITIS, Pontormo ... cit. (nota 218), pp. 261-163.221 I documenti relativi alle date del 31 agosto, del 7, 10 e 18 settembre, e del 7 ottobre, rintracciati presso l’Archivio di
stato di Firenze sono stati pubblicati precedentemente da FABRICZY, Sculture...cit. (nota 135), p. 68; FRANKLIN, Rosso...cit. (nota 215), p. 271; TURNER, The Sculpture...cit. (nota 1), p. 227, doc. 12. I documenti inediti riguardanti i pagamenti effettuati a Baccio il 30 settembre e l’8 novembre dello stesso anno, sono trascritti in Appendice n. 3.
222 Cfr. FRANKLIN, Rosso... cit. (nota 215), pp. 12-13.223 F. M. CLAPP, Jacopo Carucci da Pontormo. His Life and Work, Oxford 1916, p. 9, nota 15.224 Ivi, p. 275.225 “Datosi dunque all’arte con tutte le forze, ed esercitandosi molto in quella, divenne eccellente e raro: e ne mostrò sag-
gio in una opera di pietra forte, lavorata di scarpello in Fiorenza sul cantone del giardino appiccato col palazzo de’ Pucci, che fu l’arme di papa Leone X; dove son due fanciulli che la reggono, con bella maniera e pratica condotto”: VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), p. 540. Opera che ancora oggi è visibile, sebbene in condizioni conservative drammatiche, sul canto dell’edificio in sulla piaz-za di San Michele Visdomini. Qui oltre al Vasari la ricordava il Baldinucci anche se a quel tempo, quando cioè i lavori di amplia-mento del palazzo non erano ancora stati intrapresi, non occupava lo spazio attuale ma quello angolare delle mura del giardino della residenza che facevano angolo appunto tra via dei Pucci e via dei Servi: “Fra le prime cose che essi operasse in Firenze, fu un arme di Papa Leone X, in mezzo a due putti che si vede in sula cantonata del muro del Giardino delle case de’ Pucci sul can-to di Via de’ Servi”. BALDINUCCI, Notizie... cit. (nota 172), I, 1845, p. 582.
226 CECCHI - NATALI - SISI, L’officina della maniera, in L’officina ... cit. (nota 78), p. 34.227 Il cardinal Pucci fece affrescare al Rosso Fiorentino ben tre armi in omaggio al nuovo pontefice all’interno degli spa-
zi della chiesa servita e tra queste, una in particolare ricordata dal Vasari sopra la porta dell’oratorio di San Sebastiano decorata con “due figure, che in quel tempo fece maravigliare gli artefici, non si aspettando di lui quello che riuscì”; VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), V, 1880, p. 156; NATALI – CECCHI - SISI, L’officina ... cit. (nota 78), pp. 33-34; J. SHEARMAN, Rosso, Pontormo, Bandinelli and Others at SS. Annunziata, in ‘The Burlington magazine’, 102, 1960, 685, pp. 152-156, speciatim 153; FRANKLIN, Rosso... cit. (nota 215), p. 17.
228 L. A. WALDMAN, The Painter as Sculptor: a New relief by Andrea di Salvi Barili, in ‘Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz’, 43, 1999 (2000), pp. 200-207.
229 Per la trascrizione del documento riguardante l’impegno di Francesco di Bartolomeo Teli e la presenza al suo fianco dell’orafo fiorentino Antonio di Salvi si rimanda a J. ROGERS MARIOTTI, Al servizio di papa Leone: Antonio di Salvi, Galieno ricama-tore, e Michelangelo, in Un metodo per l’antico e per il nuovo: in ricordo di Chiara d’Afflitto, a cura di F. Falletti - F. Fiorelli Male-sci - M. L. Strocchi, Firenze 2011, pp. 45-52. Questo valente scultore è emerso all’attenzione degli studi solo recentemente, nono-stante il ruolo ricoperto alle ordinanze del cardinale Giovanni de’ Medici, il futuro Leone X, dovette essere alquanto significativo, almeno nel campo dell’intaglio lapideo. Egli fu chiamato infatti ad eseguire tra il 1512 e il 1513 almeno due armi celebrative del nuovo pontefice e ad intervenire nel cantiere delle sepolture medicee in San Lorenzo. J. ROGERS MARIOTTI, Un libro di spese di casa Medici per gli anni 1512-1513 e l’attività di alcuni artisti attivi per papa Leone X, in Nello splendore ... cit. (nota 12), pp. 272-273.
230 WALDMAN, The Painter... cit. (nota 229), pp. 200-207.231 L’opera che secondo i termini del documento doveva essere di ben 2100 libbre, commissionata a Baccio il 7 ottobre del 1516
con la mediazione del priore della chiesa pratese Baldo Magini, avrebbe dovuto rispettare nelle forme il disegno della grata di Miche-lozzo eseguito decenni prima per il tabernacolo della Santissima Annunziata di Firenze e doveva comprendere l’esecuzione anche di
DAVID LUCIDI96
una base di marmo liscia e di una cornice. Il lavoro che doveva essere in opera entro l’ottobre successivo non venne tuttavia esegui-to dal Montelupo tanto che un cancello provvisorio fu eseguito solo tre anni dopo mentre spettò al Buontalenti nel 1588 realizzare un vera e propria balaustra marmorea. P. MORSELLI, Una commissione a Baccio da Montelupo per il cancello di S. Maria delle Carceri a Pra-to, in ‘Archivio storico pratese’, 56. 1980, pp. 153-160; P. MORSELLI, Florentine Sixteenth-Century Artists in Prato: New Documents for Baccio da Montelupo and Francesco da Sangallo, in ‘The Art Bullettin’, 64, 1982, pp. 52-59.
232 L’elegante edicola marmorea eseguita da Baccio da Montelupo originariamente per la chiesa di San Jacopo a Colle di Val d’Elsa oggi conservata nel tempio di Sant’Agostino, fu commissionata allo scultore il 5 settembre del 1515 e terminata per il novem-bre dell’anno successivo. Un’aggiunta alla stipula effettuata nel febbraio 1516 ricorda inoltre come Baccio avesse appaltato l’esecuzio-ne di due scaloni di marmo, probabilmente gli inginocchiatoi, ad un certo Francesco di Piero di Michele di Salvestro da Colle il quale nel 1518, a testimoniare come a quel tempo il complesso marmoreo di Baccio fosse già stato eseguito, fu incaricato di fabbricare una grata bronzea per custodire la sacra immagine della Vergine dipinta sul fondo della cappella, cfr. GATTESCHI, Baccio... cit. (nota 1), pp. 105-108; TURNER, The Sculpture... cit. (nota 1), pp. 131-133; 234-235;
233 Il documento rinvenuto tra le deliberazioni degli Otto di Pratica presso l’omonimo fondo dell’Archivio di stato di Firen-ze è stato pubblicato per la prima volta da Ilaria Ciseri e in seguito riproposto dal Turner. CISERI, L’ingresso ... cit. (nota 199), p. 278; TURNER, The Sculpture... cit. (nota 1), p. 240, cat. 18.
234 A raccontarlo minuziosamente è Vannoccio Biringuccio nel suo trattato “Della Pirotechnia” dove ricorda che “questo edi-fico (in riferimento alla Girandola) si costumava di legname , anzi e di necessita di non d’altro fare l’intestimento del suo composito & si cuopre & si ingrossa & e si riduce quasi alli termini con legarvi e stringervi sopra fieno & di poi carta impastata & al proposito dipinte erano primamente, fatte queste d’una compositione di vasi l’un sopra l’altro con varii nascimenti di cose ornati di figure di ri-lievo, perche rapresentassero qualche senso fabuloso, o d’historia, perché non paresse cosa a caso, o fatta senza intenderle. Hor que-ste tal figure & componimento el maestro secondo el suo ingegno & sua arte di disegno l’andava dispensando, & così le operation de fuochi che voleva che si mostrassero, o che gli pareva al proposito”. V. BIRINGUCCIO, De Pirotechnia, Venezia 1540, edizione a cura di A. Carugo, Milano 1977, pp. 165-166.
235 A raccontarlo è il Vasari nella Vita del Tribolo dove per l’occasione presenta una descrizione tecnica molto accurata dell’ap-parato, cfr. VASARI, Le Vite... cit. (nota 4 ), VI, 1881, pp. 92-93.
236 Importante figura di legnaiolo architetto noto principalmente per le doti dimostrate quale produttore di macchine da guerra, apparati effimeri, giochi d’acqua, di cui celebre è la Vita a lui dedicata dal VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), III, 1878, pp. 195-204. Sulla per-sonalità del Cecca cfr. F. QUINTERIO, Francesco d’Angelo detto il Cecca, in Dizionario Biografico degli Italiani, 49, Roma 1997, pp. 656-658.
237 Orsino Benintendi fu a capo di una prolifica attività dedita alla produzione di immagini devozionali che aveva il suo fulcro nella bottega in via de’ Servi. Alla sua morte nel 1498 fu Antonio, il più giovane della famiglia Benintendi a prendere in mano l’attività paterna, supportata sia dalle pratiche devozionale legate al tempio della Santissima Annunziata, che andava riempiendo in quegli anni gli spazi interni di immagini votive che dalla committenza della famiglia Medici. G. MASI, La ceroplastica in Firenze nei secoli XV-XVI e la famiglia Benintendi, in ‘Rivista d’arte’, 9, 1916, pp. 124-134; P. MORSELLI, Immagini in cera votive in Santa Maria delle Carceri di Prato nella prima metà del ‘500, in Renaissance Studies in Honor of Craig Hugh Smith, Firenze 1985, pp. 327-339; A. BELLANDI, Plasticatori e Ceraiuoli a Firenze tra Quattro e Cinquecento, in La grande storia dell’artigianato, III, Firenze 2000, pp. 192- 195; G. GENTILINI, Antonio d’Orsino Benintendi, Busto del cardinale Giovanni de’ Medici, in BALDINI - BIETTI, Nello splendore... cit. (nota 12), pp. 416-418, cat. 36.
238 Su questa problematica quanto intrigante personalità artistica la cui attività, soprattutto nel campo della coroplastica, è do-cumentata tra il 1518 e il 1544, cfr. L. A. WALDMAN, Sculptor and Performer in Early Cinquecento Florence: the Career of Sandro di Lo-renzo, in ‘Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz’, 49, 2005 (2006), pp. 119-132.
239 Pittore, pirotecnico e bombardiere Nunziato d’Antonio di Domenico detto il Nunziata (1468-1525) padre del celebre al-lievo di Ridolfo Ghirlandaio, Toto del Nunziata, più volte fu impegnato nella realizzazione di girandole e di apparati effimeri in occa-sioni di spettacoli e allestimenti viari cfr. L. A. WALDMAN, “Se bene era dipintore di fantocci”.Nunziata d’Antonio, Painter, Pyrotechni-cian and Bombardier of Florence, in ‘Paragone’, 703, LIX, 2008, pp. 72-86.
240 Per una biografia dell’artista completa anche delle fonti bibliografiche di riferimento si rimanda a: MOZZATI, Giovanfrance-sco... cit. (nota 28), pp. 357-359.
241 Termini con cui l’aretino indicava solitamente quei pittori “plebei” dediti alla realizzazione di opere effimere come i famosi “Ceri di San Giovanni”, condannati per essere complessi faceti e di breve durabilità: VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), III, 1878, p. 201.
242 Esemplare a questo proposito il caso di Orsino Benintendi chiamato a realizzare in cera tre effigi di Lorenzo il Magnifico con l’ “aiuto e ordine” di Andrea del Verrocchio (VASARI, Le Vite... cit. [nota 4], III, 1878, pp. 373-374) e nel 1496 di soprintendere la realizzazione da parte di Benedetto da Maiano di una maschera funeraria in creta, tratta da un modello in cera evidentemente fornito da Orsino, e dipinta poi dal Botticelli. Cfr. CARL, Benedetto... cit. (nota 28), p. 526, doc. 16.
243 Si veda in tal senso ancora una volta la descrizione offerta dal Biringuccio: ivi, p. 165 r.
BACCIO DA MONTELUPO 97
244 Le nuvole erano complessi architettonici composti di telai in ferro e legno che sorreggevano una mandorla decorata con cherubini e angeli in materiali effimeri al cui interno veniva posta la persona o il santo intestatario della festa che in quel modo pote-va manifestarsi alla folla. A descrivere minuziosamente questa pratica è ancora una volta il Vasari nella vita del Cecca ingegnere fio-rentino: VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), III, 1878, p. 200.
245 Grossi ceri sontuosamente decorati e istoriati, la cui goffaggine e in particolare la loro deperibilità nel tempo spingevano il Vasari a definirli “fantocci da ceri” e considerare i propri artefici dipintori plebei. VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), III, 1878, pp. 195-204.
246 Proprio quest’ultimo ricorda che “una delle sue macchine da fuochi, ammirabile in quel tempo, rappresentava la città di Sodoma, e si vedeva Lot con le figliuole che di quella uscivano tra la pioggia di fuoco prodotta da una quantità di razzi, che da tut-ta la macchina si mandavano in alto, ricadendo a guisa di pioggia. Dopo l’assedio, lo stesso Tribolo fece le macchine dell’inferno con Orfeo che libera Euridice, e della Pace che metteva fuoco a un monte di armi che aveva ai piedi. Ma quest’ultima prese fuoco, di mo-do che dall’incendio della Pace si levò augurio di guerra, e Cosimo pensò a fortificare lo Stato...”. A. ADEMOLLO, Marietta de’ Ricci, ovvero Firenze al tiempo dell’assedio, Firenze 1841, p. 394.
247 Il documento datato 23 ottobre 1516 recita che “Spese extraordinarie et per loro a Baccio da Montelupo sculptore fiorini dugento ventidue larghi d’oro in oro et lire cinque piccole hebbe fino di giugno 1515, hebbe in più partite come appare al quader-no del depositario segreto B. c. 31 per fare una girandola per honorare la festa di San Giovanni, li quali deneari paghò il Depositario perché in quest’anno non si fece festaioli”: CISERI, L’ingresso ...cit. (nota 199), p. 278.
248 Per le vicende legate ai cerimoniali leonini si rimanda al capitale contributo di Ilaria Ciseri che attualmente in occasione della mostra dedicata alla figura di Leone X è tornata sull’argomento con un nuovo contributo: CISERI, L’ingresso ...cit. (nota 199); CISERI, “Con tanto... cit. (nota 199), pp. 237-249.
249 Il quale a detta del Vasari per tale occasione si acconciò con Baccio da Montelupo “scultore d’età”: VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), VI, 1881, p. 255.
250 Si tratta del pittore Bastiano figlio di Maddalena da San Gallo, sorella dei celebri architetti e legnaioli Giuliano e Anto-nio il Vecchio, conosciuto e apprezzato dalla famiglia Medici per le sue doti di organizzatore di apparati effimeri e di scenografo di cui il Vasari racconta che “gli fu lodato tutto quello che fece in Fiorenza nella venuta di papa Leone, facendo in compagnia di Fran-cesco Granacci un arco trionfale dirimpetto alla porta di Badia, con molte storie; che fu bellissimo”, (VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), VI, 1881, p. 436). Sul profilo biografico di Bastiano detto Aristotile da Sangallo cfr. il prezioso contributo offerto da Tommaso MOZ-ZATI, Giovanfrancesco... cit. (nota 28), pp. 349-352.
251 CISERI, L’Ingresso ... cit. (nota 199), pp. 31-43.252 MOZZATI, Giovanfrancesco ... cit. (nota 28), pp. 271-273.253 In particolare nell’allestimento degli apparati che dovevano ornare la facciata di Santa Maria del Fiore furono impiegati
Jacopo Sansovino, nelle vesti di scultore e architetto, Andrea di Cosimo Feltrini, che fece “molti ornamenti e grottesche”, Andra del Sarto insieme a due suoi garzoni, e Giovanfracesco Rustici, che in quell’occasione eseguì alcune statue “che furono tenute bellissi-me”: VASARI, Le Vite...cit. (nota 4), VI, p. 206; CISERI, L’Ingresso ... cit. (nota 199), p. 113.
254 Pittore che aveva raggiunto un fama invidiabile nell’allestimento di spettacoli viari, di mascherate carnevalesche e in ge-nerale nella progettazione di spettacoli pubblici. C. VON HOLST, Francesco Granacci, München 1974, pp. 46-48; 146-148; VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), V, 1880, p. 342.
255 CISERI, L’Ingresso ... cit. (nota 199), pp. 100-101.256 VASARI, Le Vite ... cit. (nota 4), IV, 1879, p. 541.257 La narrazione tratta dal Diario fiorentino di Luca Landucci è trascritta integralmente da CISERI, L’Ingresso... cit. (nota
199), p. 64, nota 9; p. 194, doc. IX.258 Non deve trattarsi di quel pittore fiorentino allievo di Andrea del Sarto conosciuto con il nome di Jacone, bensì di Jacopo
di Domenico Foschi noto anche come “Jacopo di Sandro” in virtù dell’acquisizione del patronimico, consueta nella tradizione fio-rentina, per la decennale vicinanza al suo maestro Sandro Botticelli, pittore nato a Firenze nel corso del 1463, fervente savonaroliano e amico di Michelangelo con il quale collabora in occasione degli affreschi della Sistina quando insieme ai pittori Jacopo dell’Indaco, Francesco Granacci, Angelo di Donnino del Mazziere e Giuliano Bugiardini raggiunge il maestro a Roma nel 1508. Cfr. R. NUCCE-TELLI, Foschi Jacopo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 49, Roma 1997, pp. 110-111; VASARI, Le Vite ... cit. (nota 4 ), VII, p. 175.
259 A definirlo così è il Vasari all’interno della Vita di Bastiano da Sangallo dove racconta che Piero da Sesto è incaricato nel 1525 in occasione della festa di San Felice in Piazza di portare a compimento, immaginiamo nella sua struttura architettonica, un ar-co effimero di legname istoriato dal pittore Jacone. VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), VI, pp. 451-452.
260 In tale luogo era ospitata fino a quel momento la monumentale immagine marmorea dell’evangelista Giovanni scolpita nel 1377 da Simone di Francesco Talenti poi ricoverata in seguito agli eventi del 1515 nel Giardino degli innocenti, a disposizione dell’Ar-te della seta, e attualmente custodita nel museo omonimo. G. KREYTEMBERG, in Bagliori dorati... cit. (nota 198), pp. 112-113, cat. 9.
DAVID LUCIDI98
261 A ricordare la data del 18 ottobre è Luca Landucci nel suo diario fiorentino: “É a di 18 d’ottobre 1515, si pose quel-lo San Giovanni Vangiolista di bronzo in Orto San Michele e levarono quello che v’era di marmo”: LANDUCCI, Diario... cit. (no-ta 68), p. 351. É il Cambi invece a riportare che “Addì 20 d’ottobre [1515] l’Arte di Por Santa Maria fecie porre a horto San Mi-chele al suo pilastro, l’avvocato dell’Arte loro S. Joanni Vangilista di bronzo, e levoronne uno, che v’era di marmo, che non era te-nuto troppo figura buona”. G. CAMBI, Istorie di Giovanni Cambi cittadino fiorentino, 4 voll., Firenze 1785-1786, III, 1786, p. 81.
262 “Di poi fece per l’Arte di Por Santa Maria la figura di S. Giovanni Evangelista di metallo posta nella facciata dell’ora-torio di Orsanmichele, che fu stimata molto bella: ed io trovo che furon dati a Baccio per questo lavoro fiorini 340”. BALDINUCCI, Notizie ... cit. (nota 172), I, 1845, p. 582.
263 VASARI, Le Vite...cit. (nota 4), VI, 1881, p. 177; BOUCHER, The Sculpture... cit. (nota 201), p. 358, cat. 73.264 Ovvero la pala che il Vasari [VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), VI, 1881, p. 177], ricorda eseguita da Andrea del Sarto per
le monache di via Pentolini, ora agli Uffizi. 265 Ivi, IV, 1879, p. 540.266 Il Rustici infatti nella fusione delle statue del gruppo avvenuta negli spazi della Sapienza fa ricorso all’abilità nella tec-
nica fusoria di un certo Benardino di Antonio da Milano. MOZZATI, Giovanfrancesco... cit. (nota 28), p. 89; G. MILANESI, Scritti va-ri sulla Storia dell’arte toscana, Siena 1873, p. 258, doc. VI.
267 La figura dell’apostolo, commissionatagli il 20 giugno 1511, fu portata a compimento, dopo numerose interruzioni nel corso del 1513 e del 1515, solo nel 1517. BOUCHER, The Sculpture... cit. (nota 1), II, pp. 318- 319, cat. 7.
268 F. VOSSILLA, Il ciclo degli Apostoli nel Duomo di Firenze, a cura di C. Cinelli - J. Myssok - F. Vossila, Firenze 2002, pp. 65-75. Per i documenti cfr. G. POGGI, Il Duomo di Firenze, ed. a cura di M. Haines, 2 voll., Firenze 1988, II, pp. 148-149, doc. 2165.
269 VOSSILLA, Il ciclo... cit. (nota 268), pp. 65-75: Per i documenti cfr. POGGI, Il Duomo ... cit. (nota 268), II, p. 150, doc. 2172; L. A. WALDMAN, Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court, Philadelphia 2004, docc. 76-77, pp. 32-33; docc. 78, 81-82, pp. 33-35, 36-38.
270 POGGI, Il Duomo... cit. (nota 268), II, p. 151, doc. 2178. 271 BALDINUCCI, Notizie... cit. (nota 172), I, 1845, p. 581.272 E. LUPORINI, Battista Pandolfini e Benedetto da Rovezzano nella Badia Fiorentina. Documenti per la datazione, in ‘Pro-
spettiva’, 33-36, 1984, pp. 112-123.273 La biografia di Raffaello che racconta i fatti della vita dello scultore fino all’anno 1527 fu scritta nel corso degli ulti-
mi anni della sua esistenza, conclusasi nel 1566, e rappresenta un preziosissimo documento che aiuta a ricostruire, oltre che le vi-cende biografiche dello scultore, anche il periodo della tarda attività del padre Baccio da Montelupo. Il documento, frammenta-rio, è stato trascritto per primo da Gaetano Milanesi nel Commentario alla Vita di Baccio e Raffaello di Montelupo, inserito in ap-pendice alla Vita dedicata ai due personaggi dal Vasari. G. MILANESI, Commentario alla Vita di Baccio e Raffaello di Montelupo, in VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), IV, 1879, pp. 551-562; R. GATTESCHI, Vita di Raffaello da Montelupo, Firenze 1998, pp. 119-125.
274 La data del contratto iniziale per la sepoltura Pandolfini stilato a Pistoia nel 1514 presso il notaio Giovanni Cioci, og-gi purtroppo disperso, si deduce da una stipula effettuata quattro anni più tardi tra Baccio e un certo Raffaello Pucci in cui veni-va definito rispetto agli accordi originari, un ulteriore incremento alle parti del complesso. WALDMAN, The Patronage... cit. (no-ta 45), pp. 109, 123, doc. 5.
275 J. S. MILNER, The Politics of Patronage: Verrocchio, Pollaiuolo and the Forteguerri Monument, in Artistic Exchange and Cultural Traslation in the Italian Renaissance City, a cura di J. S. Campbell - S. J. Milner, Cambridge 2004, pp. 221-245. L’elezione ad un rango superiore nelle gerarchie ecclesiastiche portò senza dubbio un accrescimento in prestigio e complessità dell’impresa, situazione che in effetti determinò nel gennaio del 1518 una nuova stipula tra il committente e il Montelupo per un chiarimento dei termini di esecuzione del complesso. WALDMAN, The Patronage... cit. (nota 45), p. 123, doc. 6.
276 Così riporta Raffaello da Montelupo nella sua biografia in merito alla sepoltura Pandolfini alla Badia fiorentina: “no’ s’è mai messa in opera, perché mancò quel vescovo e poi non si esegu’”. MILANESI, Commentario... cit. (nota 273), p. 554.
277 WALDMAN, The Patronage... cit. (nota 45), p. 123, doc. 7.278 C. VON FABRICZY, Allogazione della tomba di Niccolò Pandolfini a Donato Benti, in ‘ Rivista d’arte’, III, 1, 1905, pp. 176-180.279 Su tale questione si rimanda al contributo di F. CAGLIOTI, Novità su Baccio da Montelupo e il cardinale Niccolò Pandol-
fini, in corso di stampa. Vedi nota 205.280 Ivi, p. 127, doc. IV.281 “Stetti nella mia bottega insino alli 16 anni, che furano dua anni, dove presi tanta pratica de’ ferri e chosì acconciatamente,
che io intagliava de’ fogliami insieme con quelli altri maestri che v’erano, che c’era per uno il Moscha, un altro Salvestro Cofacci da Fiesole, un altro Stoldo da Setignano e un suo fratello giovanino; e di più ci venne da Napoli uno che si chiamava el Cicilia, molto famoso in quel tempo, per intagliare la sepoltura si trova nella Badia di Fiorenza”. VASARI , Le Vite ... cit. (nota 4), IV, 1879, p. 554.
BACCIO DA MONTELUPO 99
282 Ibidem.283 Secondo Vasari venuto da Napoli appositamente per intagliare la sepoltura, ma in realtà già conosciuto a Firenze nel
1515 per la lastra tombale del Tornabuoni, già in San Jacopo in Campo Corbolini, ed ora presso il Museo di San Marco di Firen-ze; cfr. VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), IV, 1879, pp. 484-485.
284 LUCIDI, Zaccaria ... cit. (nota 201), pp. 143-146.285 Benedetto lascerà Firenze per recarsi in Inghilterra nel 1519 ed è proprio da quel momento che sembra subentrare la
figura del Mosca per portare a compimento la decorazione del basamento. E. LUPORINI, Benedetto da Rovezzano, Milano 1964, p. 120, nota 158.; F. CAGLIOTI, Donatello e i Medici: storia del David e della Giuditta, 2 voll. Firenze 2000, I, p. 148, nota 47.
286 “Non molto dopo, essendo una state tornato a Firenze, ed avendo buon nome fra gli artefici, Baccio Bandinelli, che fa-ceva l’Orfeo di marmo che fu posto nel cortile del Palazzo Medici, fatta condurre la basa di quell’opera da Benedetto da Rovez-zano, fece condurre a Simone i festoni ed altri intagli bellissimi che vi sono, ancorchè un festone vi sia imperfetto e solamente gra-dinato”. VASARI, Le Vite... cit. (nota 4 ),VI, 1881, p. 299.
287 Contemporaneamente al termine dei lavori per l’Orfeo del Bandinelli. B. KATHLEEN WEIL-GARRIS, On Pedestals: Mi-chelangelo’s David, Bandinelli’s Hercules and Cacus and the Sculpture of the Piazza della Signoria, in ‘Römisches Jahrbuch für Kun-stgeschichte’, 20, 1983, pp. 377-415.
288 R. BARTALINI, Su Simone Mosca, Jean Mone e la tomba di Ferry Carondolet, in ‘Prospettiva’, 71, 1993, p. 55; J. ROGERS-MARIOTTI, Selections from a Ledger of Cardinal Giovanni de’ Medici 1512-1513, in ‘Nuovi studi’, 9, 2001/2002, pp. 123-125.
289 M. G. CIARDI DUPRÈ DAL POGGETTO, Sull’attività italiana di Alonso Berruguete, in ‘Commentari’, XIX, 1968, 1-2, pp. 127-130; A. NATALI, Cicilia, Lastra Tombale di Luigi Tornabuoni, in L’officina ... cit. (nota 78), pp. 340-341, cat. 124; A. NATALI, L’Officina della maniera moderna, in Storia delle Arti in Toscana. Il Cinquecento, a cura di R. P. Ciardi, Firenze 2000, pp. 70-71.
290 F. CAGLIOTI, Alonso Berruguete in Italia: un nuovo documento fiorentino, una nuova fonte donatelliana, qualche ulterio-re traccia, in Scritti di Storia dell’Arte in onore di Sylvie Beguin, Napoli 2001, pp. 121-123. Sulle vicende cronologiche e attributi-ve sul complesso cfr. G. DONATI, Un giovane scultore fiorentino e la congiuntura sansovinesca del pieno Rinascimento, in ‘Prospet-tiva’, 130/131, 2008, pp. 107-134.
291 LUCIDI, Zaccaria ... cit. (nota 201), p. 143.292 Nell’atto di stipula del contratto con il banchiere Lorenzo Bini Baccio è tenuto a “finire e complere dictam sepulturam
marmoream infra dictos decem menses proxime futuros, modo et forma et secundum formam cuiusdam modelli lignei penes ip-sum Batholomeum existentem...”. WALDMAN, The Patronage ... cit. (nota 45), p. 123, doc. 7.
293 C. M. SICCA, Pawns of International Finance and Politics: Florentine Sculptors at the Court of Henry VIII, in ‘Renaissance Studies’, 20, 1, 2006, pp. 1-34, speciatim 4, nota 15.
294 Ivi, p. 3.295 Il contratto della sepoltura è trascritto e pubblicato da SICCA, Pawns of International Finance... cit. (nota 293), pp. 22-
23, note 77-78.296 M. CREIGHTON, The Italian Bishops of Worcester, in Historical Essays and Reviews, London 1902, pp. 202-234; SICCA,
Pawns of International Finance... cit. (nota 293), p. 22, nota 74.297 É proprio il Gigli, vescovo di Worcester, a intimare al Torrigiani nel giugno del 1519 di ritornare a Londra per sovrin-
tendere l’esecuzione della tomba di Enrico VIII rimasta in sospesa per il viaggio in Italia intrapreso dallo scultore nei primi mesi dell’anno. Ivi, p. 14, nota 50; pp. 20-23.
298 Solo a partire dal 1915 in seguito cioè alle scoperte documentarie del Guidi il tabernacolo di Segromigno ha perso la consueta attribuzione al maestro lucchese Matteo Civitali in favore di quella a Baccio da Montelupo; E. RIDOLFI, L’arte in Luc-ca studiata nella sua cattedrale, Lucca 1882, pp. 305-307; GUIDI, La Pietà di Lammari ... cit. (nota 112), pp. 69-70. L’opera entrata oramai saldamente nel dibattito critico legato alla figura del Montelupo, precoce testimone del linguaggio dello scultore espresso nel corso del più avanzato soggiorno lucchese, è stata dibattuta da un punto di vista iconografico e stilistico già da PETRUCCI, Bac-cio ... cit. (nota 3), pp. 3-6 e TURNER, The Sculpture... cit. (nota 1), pp. 134-135, 240-241. Per ultimo la questione è stata affrontata, soprattutto dal punto di vista documentario in un recentissimo contributo sulla Pieve di San Leonardo: G. GHILARDUCCI, La Pie-ve di Segromigno attraverso i secoli, in Segromigno storia e territorio, a cura di G. Bedini - G. Ghilarducci - M. Martinelli - G. Pe-troni - G. Tori, Lucca 2009, pp. 30-34.
299 Il contratto con Donato Benti sottoscritto nel 1511 era accompagnato anche da un cartone dove erano prestabilite for-me e misure e doveva valere lo scultore la cifra di ben 200 ducati: Ivi, pp. 186-188; Appendice I-II.
300 “mi fu portato la mia parte insino a Lucca, dove m’ero fermo a finire la sepoltura del vescovo de’ Gigli in Santo Miche-le, che la faceva mio padre, il quale mi lasò a finire la figura del morto e una Nostra Donna ‘nun tondo di mezzo rilievo (...)”: MI-LANESI, Commentario... cit. (nota 274), p. 557.
DAVID LUCIDI100
301 Ricorda lo storico lucchese Matraia che “al principio di questo secolo, epoca del rifacimento e rinalzamento della cap-pella suddetta, fu per opera dell’ignoranza gettato a terra, e venduti i marmi ricchi di preziosissimi ornati ad un marmista, che due anni fa ancor viveva, unitamente alla bellissima figura giacente del vescovo nella cui testa fu fatto un vaso da pestarvi il sale (...)”, SICCA, Pawns... cit. (nota 293), p. 22, nota 76.
302 Ivi, p. 189, appendice III.303 Il documento di allogazione della sepoltura, che si conserva presso l’Archivo di stato di Lucca, stipulato in data 28 mar-
zo 1520 in parte recita: “(...) facere unum sepulchrum pulchrum et sepulturam ornatam de marmore carrariense cum arca pro mor-tuo et sepoltura prout et secundum modellum sepolturae Petri de Noceto in cappella Sancti Reguli in cathedrali lucana videlicet similem illi vel meliorem (...)”. Il documento intero è trascritto da SICCA, Pawns... cit. (nota 293), pp. 22-23, nota 77.
304 F. CAGLIOTI, Matteo Civitali, Madonna col Bambino, in Matteo Civitali e il suo tempo. Pittori, scultori e orafi a Lucca nel tardo Quattrocento, catalogo della mostra di Lucca, a cura di C. Baracchini - M. T. Filieri, Milano 2004, pp. 522-523, cat. 5.20.
305 Ivi, p. 525. Qui rimase murata fino al 1931 quando gli eredi Santini-Gori la venderono per 25.000 lire al Museo nazio-nale del Bargello. Cfr. M. T. FILIERI, Edicole sacre nel XV secolo, in Immagini di devozione a Lucca, catalogo della mostra a cura di M. T. Filieri, Lucca 1998, p.14, fig. VI.
306 CAGLIOTI, Matteo ... cit. (nota 304), pp. 522-525.307 Di questo parere era infatti Linda Pisani che riteneva la Madonna di Villa Guinigi una replica di quella presso il Mu-
seo del Bargello: L. PISANI, In margine a Matteo Civitali. Indagini sulla scultura a Lucca nella seconda metà del XV secolo, in Luc-ca città d’arte e i suoi archivi. Opere d’arte e testimonianze documentarie dal Medioevo al Novecento, a cura di M. Seidel - R. Silva, Venezia 2001, pp. 211, 213, fig. 2.
308 C. PEDRETTI, in Leonardo e la Pulzella di Camaiore. Inediti vinciani e capolavori della scultura lucchese del primo Rinasci-mento, catalogo della mostra di Camaiore, a cura di C. Pedretti, Firenze 1998, p. 71, cat. 7.
309 CAGLIOTI, Matteo... cit. (nota 304), p. 523.310 Inventory of Art Objects Acquired in the Year 1861 in, Inventory of the Objects in the Art Division of the Museum at
South Kensington, Arranged According to the Dates of their Acquisition. I, London: 1868, p. 3. E. MACLAGAN LONGHURST H. MAR-GARET, Catalogue of Italian Sculpture. Text. London: Victoria and Albert Museum, Londra 1932, p. 61; J. POPE-HENNESSY, Catalogue of Italian Sculpture in the Victoria and Albert Museum, London 1964, I, p. 210; F. NEGRI ARNOLDI, Scultura Italiana al Victoria and Albert Museum I&II, in ‘Commentari’, XXI, 1970, pp. 212-213.
311 Ho avuto modo di rinvenire anche un altro esemplare gemello di questo Redentore, probabilmente una copia derivata da un calco ottocentesco, che attualmente si conserva presso il Castello di San Martino il località Soverzano a Minerbio (Bologna).
312 Baccio, dopo aver trascorso del tempo a Firenze a causa di una malattia che aveva colpito il figlio Raffaello, ritornò a Lucca nel 1522 per mettere in opera la sepoltura Gigli. Cfr. MILANESI, Commentario ... cit. (nota 274), p. 557.
313 La bottega del Montelupo sembra portare avanti anche una cospicua produzione di ornato architettonico (finestre, por-te e camini), come ci appare dal documento appena citato o come mette in mostra un altro databile al 1521. Cfr. WALDMAN, The Patronage ... cit. (nota 45), p. 125.
314 Si tratta di due atti, un primo rogato il 4 aprile 1522 nel quale un certo Domenico di Marco di Lorenzo, conosciuto con l’appellativo di Beccho, dichiarava di lavorare quattro pezzi di terra in Pian di Scò per Baccio da Montelupo, in quel momento a Firenze, un secondo datato 14 febbraio 1522 in cui lo scultore è attestato come abitante nel popolo di San Pier Maggiore di Firen-ze. Cfr. WALDMAN, The Patronage... cit. (nota 45), pp. 125-126.
315 G. CAMPORI, Memorie biografiche degli scultori, architetti, pittori nativi di Carrara, e di altri luoghi della Provincia di Mas-sa, Modena 1873, p. 277.
316 Ibidem. Appendice documentaria n. 4.317 Opere assegnatagli tra il maggio e il novembre del 1519 in seguito alla morte improvvisa dello scultore settignanese Do-
menico Fancelli. Sull’argomento si rimanda al recentissimo contributo di Michela Zurla, con particolare attenzione alle vicende relative ai rapporti di dipendenza tra i due artisti: M, ZURLA, Domenico Fancelli, i re di Spagna e la congiuntura carrarese, in Nor-ma e capriccio. Spagnoli in Italia agli esordi della “maniera moderna”, catalogo della mostra a cura di A. Natali - T. Mozzati, Firen-ze 2013, pp. 137-143.
318 Racconta così Raffaello: “Ora sendo stato a questo modo insino alli 16 anni, achadè che tornò di Spagnia un Giovanni da Fiesole squadratore, e veniva da Carara, dove era morto uno schultore spagnuolo che si chiamava Ordonio, valentissimo, dove faceva la spoltura d’un Re di Spagnia e un’altra d’un vescovo, che andavano in Balzalona. Sendo morto, no’ v’era chi finissi certe figure e tonde e di mezo rilievo, e questo Giovanni era venuto a Fiorenza per menare qualche giovane che le facessi, e perché con mio padre lavorano delli altri garzoni da Fiesole, costui venne a vedere in botega nostra quelli del suo paese, e così vidde certe fi-gurine di marmo e di chreta che avevo fatte io, e se ne meravigliava di quella ettà; giudicando che io sarei stato buono a finire quel-
BACCIO DA MONTELUPO 101
le cose che s’erano bozate a Carara: e così domandò a mio padre se voleva che lui mi menassi, che mi farebbe dare buona privisio-ne. Io n’ero desideroso per levarmi dinanzi a mio padre, che continovamente mi rimproverava le spese che mi dava, e ne lo pre-gai mi lasassi andare. Benchè non molto volentieri, pure ci partimo; e arrivati a Carara (...). Così fra dua giorni fui messo a lavora-re dov’erano fra intagliatori, squadratori, e schultori da 12 omini (...) così vi stetti un anno, e mi davano 6 scudi il mese e le spese. Achadè in questo tempo la morte di Papa Leone”. Cfr. MILANESI, Commentario... cit. (nota 274), pp. 554-555.
319 Le mansioni a cui era destinata la squadra del Montelupo non dovevano andare oltre quelle di semplice manovalanza o al massimo di rifinitura, tanto che come racconta Raffaello non posso troppo tempo all’arivo da Napoli di due importanti e af-fermati scultori come Gian Giacomo della Porta e Girolamo Santacroce: “ma arivorno apunto dua maestri napolitani, uno chia-mato mastro Giaiacomo e l’altro Irenimo Santa Croce; e per essere omoni fatti, si dette più fede a loro, come veramente sapeva-no più di me sai (...)”. Ibidem.
320 VASARI, Le Vite... cit. (nota 4), IV, 1879, p. 548, nota 1.321 Baccio, che aveva nominato Raffaello suo figliolo amministratore dei propri beni, concede in affitto ad un certo Fran-
cesco, fratello di sua moglie Agnoletta, alcuni possedimenti nel Comune di Castelfranco in Valdarno Superiore giunti in suo pos-sesso, come dote per il matrimonio. WALDMAN, The Patronage... cit. (nota 45); TURNER, The Sculpture... cit. (nota 1), pp. 243-244.
43. BENEDETTO DA MAIANO: Altare Terranova, particolare. NAPOLI, Sant’Anna dei Lombardi.
44. BACCIO DA MONTELUPO: Compianto, particolare. BOLOGNA, San Domenico.
45. BACCIO DA MONTELUPO: Compianto, particolare. BOLOGNA, San Domenico.
46. BACCIO DA MONTELUPO: Compianto. BOLOGNA, San Domenico.
47. BENEDETTO DA MAIANO: Pietà, particolare. LA SPEZIA, Museo civico Amedeo Lia.
48. BACCIO DA MONTELUPO: Compianto, particolare. BOLOGNA, San Domenico.
51. LEONARDO DEL TASSO: Pietà. BERLINO, Bode Museum.
52. SCULTORE FIORENTINO: Pietà. PHILADELPHIA, Museum of Art.
56. BACCIO DA MONTELUPO: Pietà, particolare. FIRENZE, collezione Turchi.
53. BACCIO DA MONTELUPO: Pietà, particolare. BOLOGNA, San Domenico.
54. BACCIO DA MONTELUPO: Pietà, particolare. FIRENZE, collezione Turchi.
55. BACCIO DA MONTELUPO: Pietà, particolare. BOLOGNA, San Domenico.
57. BACCIO DA MONTELUPO(?): Busto di Sant’Antonio Pierozzi. FIRENZE, San Marco.
58. PLASTICATORE FIORENTINO: Maschera funeraria di Sant’An-tonino Pierozzi. FIRENZE, San Marco.
63. BACCIO DA MONTELUPO: Pietà, particolare. FIRENZE, collezione Turchi.
60. BACCIO DA MONTELUPO: Pietà, particolare. BOLOGNA, San Domenico.
61. BACCIO DA MONTELUPO: Pietà, particolare. FIRENZE, collezione Turchi.
62. BACCIO DA MONTELUPO: Cristo deposto. FONTELU-CENTE (Fiesole), Oratorio del Santissimo Crocifisso.
68. BACCIO DA MONTELUPO: Tabernacolo eucaristico, particolare. SEGROMIGNO MONTE (Lucca), pieve di San Leonardo.
65. DESIDERIO DA SETTIGNANO: Tabernacolo del Sacramento, particolare. FIRENZE, San Lorenzo.
66. BACCIO DA MONTELUPO: Cristo bambino benedicente. PARIGI, Musée du Louvre.
67. BACCIO DA MONTELUPO: Cristo bambino. FIRENZE, Museo Stefano Bardini.
69. BACCIO DA MONTELUPO: San Sebastiano. BOLOGNA, già Santa Maria del Baraccano.
70. BACCIO DA MONTELUPO: San Sebastiano. SAN GODENZO, Badia.
73. BACCIO DA MONTELUPO: Compianto, partico-lare. BOLOGNA, San Domenico.
74. BACCIO DA MONTELUPO: Cristo deposto, parti-colare. FONTELUCENTE (Fiesole), oratorio del San-tissimo Crocifisso
75. BACCIO DA MONTELUPO: Cristo deposto. FONTELUCENTE (Fiesole), oratorio del Santissimo Crocifisso.
76. BACCIO DA MONTELUPO: Pietà. FIRENZE, collezione Turchi. 77. BACCIO DA MONTELUPO: San Giovanni Evangelista, particolare. FIRENZE, collezione privata.
78. BACCIO DA MONTELUPO: Cristo deposto. FONTELUCENTE (Fiesole), oratorio del Santissimo Crocifisso.
79. BACCIO DA MONTELUPO: Crocifisso. SETTIMELLO (Fi), Santa Lucia.
80. BACCIO DA MONTELUPO: San Giovanni Evangelista. FIRENZE, col-lezione privata.
81. BACCIO DA MONTELUPO: Busto di santo. ROMA, Museo nazionale di palazzo Venezia.
82. BACCIO DA MONTELUPO: Redentore. SAN GODENZO, Badia. 83. BACCIO DA MONTELUPO: San Giovanni evangelista, particolare. Già UDINE, collezione privata.
88. BACCIO DA MONTELUPO: San Girolamo penitente, FIRENZE, collezione privata.
86. BACCIO DA MONTELUPO: Maddalena penitente. FIRENZE, collezione privata.
87. BACCIO DA MONTELUPO: Maddalena penitente, FIRENZE, col-lezione privata.
90. JACOPO SANSOVINO: Madonna col Bambino. BUDAPEST, Szépmvészeti Múzeum.
91. BACCIO DA MONTELUPO: Madonna col Bambino. Collezione privata.
92. BACCIO DA MONTELUPO: Madonna col Bambino. LUCCA, San Concordio in Contrada.
93-94. BACCIO DA MONTELUPO: San Pellegrino, San Romano. LUCCA, San Concordio in Contrada.
95. BACCIO DA MONTELUPO: Monumento a Benedetto Pesaro, partico-lare. VENEZIA, Santa Maria dei Frari.
96. BACCIO DA MONTELUPO: San Pellegrino, particolare. LUCCA, San Concordio in Contrada.
97. BACCIO DA MONTELUPO: Apostolo o filosofo antico, particolare. MILANO, Galleria Longari.
98. BACCIO DA MONTELUPO: San Giovanni Evangelista. FIRENZE, Museo di Orsanmichele.
102. MATTEO CIVITALI (?): Madonna col Bambino. LUCCA, Museo nazionale di Villa Guinigi.
103. BACCIO DA MONTELUPO: Madonna col Bambino. FIRENZE, Museo nazionale del Bargello.
104. MATTEO CIVITALI: Arca di San Regolo, particolare. LUCCA, San Martino.
105. BACCIO DA MONTELUPO: Monumento Gigli, particolare. LUCCA, San Michele in Foro.































































































![Il sondaggio stratigrafico nella sede centrale della Cassa di Risparmio di Modena (1985-1986): lo scavo, Modena 1988 [Donato Labate, Luigi Malnati] con contributi di Silvia Macchioro,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6331a3fc8d2c463a58007daf/il-sondaggio-stratigrafico-nella-sede-centrale-della-cassa-di-risparmio-di-modena.jpg)