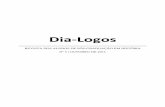Spinosa A. (2011), Piero Sanpaolesi. Contributi alla cultura del restauro del Novecento, Alinea...
Transcript of Spinosa A. (2011), Piero Sanpaolesi. Contributi alla cultura del restauro del Novecento, Alinea...
TESTI E RICERCHE DI STORIA DEL RESTAURO / 2collana diretta da Stella Casiello e Giuseppe Cruciani Fabozzi
finito di stampare nel giugno 2011d.t.p.: “Alinea editrice srl” - Firenzestampa: Genesi Gruppo Editoriale - Città di Castello (Perugia)
© copyright ALINEA EDITRICE s.r.l. - Firenze 201150144 Firenze, via Pierluigi da Palestrina, 17 / 19 rossoTel. +39 55 / 333428 - Fax +39 55 / 6285887.fax
tutti i diritti sono riservati:nessuna parte può essere riprodotta in alcun modo(compresi fotocopie e microfilms)senza il permesso scritto dalla Casa Editrice
ISBN 978-88-6055-632-5
e-mail: [email protected]:/www.alinea.it
DIREZIONE DELLA COLLANAGiuseppe Cruciani Fabozzi
COMITATO SCIENTIFICOStella CasielloMarco Dezzi BardeschiLuigi MarinoUsama Amdam
IMMAGINE DI COPERTINA:Mano destra di Piero Sanpaolesi alla scultura di Tino da Camaino sul portale centrale della facciata del Duomo di Siena, marzo 1967 (da Archivio DIRES, Firenze, n. 493.11).
Arianna Spinosa
SOMMARIO
6 INTRODUZIONE Giuseppe Cruciani Fabozzi
8 PRESENTAZIONE Renata Picone
10 PREMESSA Arianna Spinosa
13 1. LA FORMAZIONE E I RIFERIMENTI CULTURALI13 La formazione culturale: l’ambiente toscano e l’influenza dei maestri soprin-
tendenti
29 1.2 I RESTAURI CONDOTTI TRA IL 1933 E IL 1943 29 Prime sperimentazioni nel restauro figurativo nel Laboratorio di Restauro dei
Dipinti di Firenze35 La serie di limitate prove di consolidamento chimico delle superfici lapidee47 Esperienze di collaborazione nei cantieri di restauro della Soprintendenza ai
Monumenti di Firenze
65 2. IL SECONDO DOPOGUERRA, IL RUOLO DI SANPAOLESI NELLA RICOSTRUZIONE
63 L’attività di Soprintendente ai Monumenti e alle Gallerie: l’opera nelle pro-vince di Pisa, Livorno, Lucca e Apuania. 1943-1945
76 La problematica del restauro, dal monumento alla tutela dei centri storici e alla salvaguardia del territorio
95 2.1 I RESTAURI CONDOTTI TRA IL 1943 E IL 196095 I restauri dell’architettura95 Il Camposanto Vecchio a Pisa94 Il “recinto sacro”: antichi problemi di conservazione delle pitture
murali105 La ricostruzione postbellica della copertura del Camposanto 109 Il recupero degli affreschi: dalle operazioni di strappo alla chiusura
delle quadrifore 133 La chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno a Pisa 140 La chiesa di San Piero a Grado a Pisa
142 La tutela dei centri storici nel dopoguerra e il caso di Pisa158 La tutela paesistica alle soglie della speculazione edilizia176 Le principali esperienze museali177 Il Museo di San Matteo a Pisa189 La Villa Guinigi a Lucca192 La Galleria Sabauda a Torino
205 3. IL CONTRIBUTO ALLA CONSERVAZIONE DEI MATERIALILAPIDEI
205 La conservazione delle superfici architettoniche: dalla stagione dell’illusione chimica all’autenticità materiale
215 Le sperimentazioni e la riflessione teorica sul tema della conservazione delle pietre dell’architettura
215 La nascita dell’Istituto di Restauro dei Monumenti 217 Il cantiere della conservazione delle superfici architettoniche:
un connubio tra didattica e ricerca222 Il “modello teorico” applicato: riflessioni sull’autenticità materica
231 3.1 I RESTAURI CONDOTTI TRA IL 1960 E IL 1970242 L’Arco di Alfonso d’Aragona a Napoli243 Note storiche245 Il consolidamento chimico dei marmi
265 RIFLESSIONI SULLA METODOLOGIA DEL RESTAURO
279 APPARATI279 Profilo biografico281 Scritti di Piero Sanpaolesi286 Scritti su Piero Sanpaolesi288 Appendice documentaria
297 INDICE DEI NOMI
6
INTRODUZIONE
Giuseppe Cruciani Fabozzi
Ho accolto con vero piacere l’invito a presentare questo volume (il secondo della collana edita da Alinea e diretta insieme alla Prof.ssa Stella Casiello) che viene a colmare - sedici anni dopo la pubblicazione, a cura di Piero Roselli, del quaderno monografico Le pietre dell’architettura - un vuoto sempre più avvertibile nell’oramai denso panorama di studi sui capofila della “scuola italiana” del restauro, di cui Piero Sanpaolesi fu senza dubbio uno degli esponenti di spicco a livello internazionale.
Infatti la figura di Sanpaolesi, pur rientrando a pieno titolo fra i protagonisti della intensa stagione di rinnovamento della cultura disciplinare che porterà nel 1964 alla formulazione della Carta di Venezia, è rimasta a lungo confinata in una sorta di limbo da una letteratura di settore incline a svalutarne l’operato, tanto da risultare quasi del tutto marginale rispetto a Maestri indiscussi quali Piero Gazzola, Roberto Pane e Guglielmo De Angelis d’Ossat (per non dire di Cesare Brandi con cui il Nostro si trovò spesso in aperto dissidio).
Se si considera quindi l’ostracismo che gli venne decretato con la condanna som-maria del suo metodo di “indurimento” delle “pietre dell’architettura” e che tut-tora perdura in alcuni ambienti, l’accurata ricognizione critica condotta da Arianna Spinosa sotto la guida di Renata Picone segna il punto d’arrivo di una progressiva crescita di attenzione (a partire dalla mostra allestita nel 1981 per la VI Assemblea Generale ICOMOS) nei riguardi della poliedrica attività svolta da Sanpaolesi fino al 1960 nell’Amministrazione delle Belle Arti e dopo di allora in ambito accademico, rompendo così definitivamente la tenace congiura del silenzio - assimilabile a unìin-generosa damnatio memoriae - sul suo impegno a difesa del patrimonio monumen-tale.
Un impegno, scientifico e operativo, teso a preservare l’ “autenticità” del testo architettonico, salvaguardando quanto di esso ci è pervenuto, che Sanpaolesi identi-ficava con la “materia originale” del manufatto, cui dovevano quindi essere rivolte le cure del restauratore, rigettando le tradizionali pratiche di rifacimento, fondate per lo più su ipotesi e “analogie stilistiche”, che continuavano a ricevere avallo da parte degli stessi Organi ministeriali.
Il convincimento che nessuna ri-produzione, per quanto vero-simile, potesse surrogare il valore intrinseco dell’opera d’arte come di ogni testimonianza storica genuina, costituisce in estrema sintesi il caposaldo concettuale su cui Sanpaolesi ha incardinato la propria “filosofia” del restauro, che volle rimarcare ancora una volta nel suo ultimo intervento (gennaio 1980), dove osservava: «Se sommiamo dunque, come in molti restauri si può fare con metodo aritmetico, la distruzione delle aggiunte per ritrovare un’antica forma da quelle nascosta e i rifacimenti successivi, che spesso raggiungono l’entità di copia, operati per ricomporre que-sta forma antica o presunta tale, troveremo che nello stesso tempo si smantellano due forme antiche di edificio a vantaggio dell’esecuzione di un falso antico, cioè di una copia».
7
Oltre a delineare un vivace profilo del fondatore dell’Istituto fiorentino di Re-stauro dei Monumenti (il primo attivato in una Università italiana), mettendone in giusta luce la coerenza di pensiero e le non comuni capacità tecniche e organizzative, il libro di Arianna Spinosa compie per la prima volta, sulla base di nuove indagini documentali, una sistematica disamina dell’intero corpus di lavori che Sanpaolesi ebbe modo di eseguire nel campo del restauro e della museografia.
Prima di chiudere questa breve presentazione del volume - al quale auguro, in-sieme alla positiva accoglienza degli studiosi, un’ampia diffusione presso i corsi universitari di “Teorie e storia del restauro” - mi preme porre in risalto come esso non si limiti a integrare le notizie raccolte da precedenti ricerche, corredando il testo di un apparto illustrativo in gran parte inedito, ma fornisca precisi ragguagli su casi scarsamente indagati, quale il controverso restauro dell’Arco di Alfonso d’Aragona a Castelnuovo, di cui l’Autrice, grazie all’esame del carteggio rinvenuto presso l’Archivio della Soprintendenza di Napoli, ha potuto per la prima volta ricostruire in dettaglio le varie fasi, sgombrando il campo dagli equivoci che, senza un effetti-vo controllo scientifico dei dati, avevano indotto ad addebitare per intero i vistosi fe-nomeni di alterazione dei marmi dell’Arco all’“infausto” intervento di Sanpaolesi.
Come ancien élève dell’Istituto di Restauro creato dal Professore nell’Ateneo fiorentino non posso dunque, a nome anche dei Colleghi che lo avevano affiancato nello svolgimento dell’attività didattica e di ricerca (fra cui Marco Dezzi Bardeschi, Francesco Gurrieri, Carla Pietramellara e Gennaro Tampone), che dichiarami grato ad Arianna Spinosa per il suo contributo al doveroso riconoscimento dell’impulso dato da Sanpaolesi all’affermarsi di una nuova consapevolezza delle finalità e dei limiti dell’esercizio restaurativo, cui incombeva ed incombe tutt’oggi il compito di preservare il testo monumentale tanto dai guasti del degrado quanto da quelli di una volgare contraffazione della sua autenticità formale e materiale.
Firenze, 12 aprile 2011
8
PRESENTAZIONE
Renata Picone
Il volume di Arianna Spinosa – inserito nella collana Testi e ricerche di Storia del Restauro diretta da Stella Casiello e Giuseppe Cruciani Fabozzi – approfondisce lo studio dell’attività scientifica e operativa di Piero Sanpaolesi.
Sulla base di un’ampia documentazione inedita, vagliata con rigore filologico, la Spinosa ha avviato uno studio sistematico sull’intero complesso dell’attività re-staurativa del maestro fiorentino, precisandone il contributo fornito alla disciplina in qualità di architetto-restauratore, quale responsabile delle Istituzioni di tutela attive in Toscana negli anni cruciali della ricostruzione post-bellica, e come docente uni-versitario.
La carriera di restauratore militante, svolta incessantemente da Sanpaolesi dagli anni trenta del Novecento fino a tutti gli anni ’70, viene dall’Autrice letta con ma-turità critica e inquadrata nel coevo dibattito sul restauro, sviluppatosi peraltro con straordinaria ricchezza di apporti e sperimentazioni proprio in quegli anni, in Italia e in Europa.
Il volume vede la luce a circa quarant’anni dall’ “uscita di scena” di questo in-terprete significativo quanto discusso di tale dibattito, dopo una lungo silenzio sto-riografico che ha riguardato la sua attività, anche a causa degli esiti controversi di alcuni trattamenti di ‘indurimento’ della pietra da lui sperimentati. Grazie anche a studi come questo è possibile, oggi, con una opportuna ‘distanza storica’, iniziare a colmare tale vuoto storiografico, per leggere e comprendere con equilibrio approcci, metodi ed eredità culturale di uno dei massimi protagonisti del restauro italiano del Novecento.
L’ampia disamina condotta da Arianna Spinosa – che approfondisce il contributo teoretico, scientifico e sperimentale dato da Sanpaolesi in campi molto ampi del restauro, che spaziano dalla specificità architettonica del trattamento lapideo, alla tutela paesistica dei lungarni pisani – consente oggi di individuarne talune invarianti, che hanno inciso sull’attuale fare restaurativo, e su alcuni orientamenti contempo-ranei della disciplina. Influenzato nella prima fase dal pensiero di Gustavo Giovan-noni, Sanpaolesi ha mirato alla costruzione, in ciascuno dei settori del restauro da lui esplorati, di un metodo filologicamente fondato, che prende avvio da un inedito percorso conoscitivo dell’opera e si attua in un processo di azioni restaurative cultu-ralmente consapevoli e tecnicamente avvedute.
La rigorosa coerenza di pensiero, le non comuni capacità tecniche, l’attenzione alla autenticità materiale dell’opera nella sua flagrante astanza, non sostituibile da copie o riproduzioni, sono solo alcuni degli aspetti della figura dello studioso fioren-tino, che emergono dalla lettura di questo denso volume.
Sulla base di fonti non ancora vagliate dalla critica architettonica - reperite in massima parte presso l’Archivio Centrale dello Stato, presso gli archivi delle so-printendenze, dell’Istituto Centrale del Restauro e dello “storico” Laboratorio foto-
9
grafico dell’Istituto fiorentino di Restauro dei monumenti fondato dal maestro nella Facoltà di Architettura del capoluogo toscano – l’Autrice avvia opportunamente la sua ‘lettura’ di Sanpaolesi dalla fase di formazione e dei primi studi, che, coniugando componenti tecniche e umanistiche, lo avvicinarono al tema della conservazione del-le superfici. Quindi la Spinosa passa ad esaminarne il fondamentale apporto prestato nel campo della tutela e salvaguardia dei centri storici toscani nei difficili anni della ricostruzione, per giungere ad una generale revisione del personaggio, esaminato nella complessità dei suoi interessi.
L’ultima parte del volume affronta l’approccio teoretico di Sanpaolesi, a partire dal suo Discorso sulla metodologia generale del restauro dei monumenti, dato alle stampe nel 1973. Anche dalle pagine del Discorso, così come dalla sua fervente ope-rosità di restauratore, emerge costante l’attenzione all’autenticità dell’architettura, considerata non solo nella sua consistenza estetico-figurativa, ma anche materico-strutturale, e si evidenzia un metodo che, attraverso una rigorosa fase analitica e un ricercato equilibrio tra prassi, ricerca e didattica, affronta la sperimentazione .del rapporto tra scienza e restauro.
Avendo seguito questo lavoro sin dalla sua genesi, nell’ambito del dottorato in “Conservazione dei beni architettonici”, e poi nei suoi sviluppi negli anni successivi, sono grata a Giuseppe Cruciani Fabozzi, Adriano Bartolozzi e agli altri allievi diretti del maestro, che hanno favorito questa ricerca e reso possibile la realizzazione di un virtuoso esempio di collaborazione tra istituzioni universitarie allo scopo di un avanzamento delle conoscenze.
10 Arianna Spinosa
PREMESSA
Arianna Spinosa
Il presente volume costituisce il risultato di un lavoro di ricerca, intrapreso nell’ambito del dottorato in Conservazione dei Beni Architettonici, sulla figura di uno dei maestri del restauro del secondo Novecento, ancora poco noto nella sua interezza, Piero Sanpaolesi.
Un percorso di studi, avviato dall’esame delle controverse vicende del restauro dei paramenti marmorei dell’Arco di Alfonso d’Aragona a Napoli, per poi riper-correre a ritroso non solo la sua carriera di restauratore militante ma anche le tappe dell’evoluzione della cultura del restauro italiana del Novecento, comune ai per-sonaggi del secondo dopoguerra, fatta di un raffinato sapere tecnico e di temerarie scelte di campo di cui oggi ravvisiamo eredità e nuovi approcci disciplinari.
Lo studio, all’interno di un’analisi generale del personaggio, si propone di evi-denziare la molteplicità degli ambiti del restauro in cui il Nostro ha operato, teso a sondare per lo più contributi innovativi e inediti. A partire da una revisione della sua nutrita attività di architetto-restauratore, di storico dell’architettura e di docente universitario, vengono chiariti i termini e le modalità con le quali Sanpaolesi affronta i temi significativi del dibattito sulla disciplina del restauro, che si sviluppa a partire dagli anni trenta, attraversa il periodo bellico e della «ricostruzione», e giunge fino al momento di revisione, sul finire degli anni settanta. Dalla lettura condotta emerge il costante approccio al tema del restauro attraverso gli strumenti della ricerca appli-cata, spesso di natura empirica, tramite una continua attenzione alla conservazione dell’architettura costruita, di alto valore monumentale, e alle specificità della sua consistenza estetico-figurativa ma anche materico-strutturale.
Partendo da una visione del restauro permeata dal pensiero di Gustavo Giovan-noni, negli ambienti della soprintendenza fiorentina, Piero Sanpaolesi acquisisce il bagaglio teorico e operativo dell’architetto-restauratore e partecipa attivamente e quel processo di rinnovamento, passando dalla teoria alla prassi, che abbandona i lasciti del restauro ottocentesco e si proietta verso i più aggiornati criteri espressi dalla Carta del Restauro di Atene del 1931.
Dal 1943 al 1960 si impegna nella ricostruzione postbellica, come Soprintenden-te ai Monumenti e alle Gallerie delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Apuania, profondamente lacerate dalle distruzioni belliche. A tale periodo, fino ad ora poco conosciuto nella sua ampiezza, è dato ampio spazio e rilievo nella parte centrale del volume nell’intento di sottolineare come il longevo operato del soprintendente pisano, in questa parte del territorio toscano, abbia innescato positivi processi di va-lorizzazione e di tutela sia delle riconosciute emergenze monumentali che di quelle minute forme artistiche inglobate nei tessuti storici, che rischiavano di essere travol-te dalla furia ricostruttrice.
Sulla base di un corpo documentario inedito, viene dedicato un approfondimento ad alcuni restauri postbellici, tra cui primeggia a livello architettonico il restauro del Camposanto Monumentale di Pisa con i suoi famosissimi affreschi medievali e a livello urbanistico la tutela del centro storico di Pisa da cui si evincono le prime intu-izioni di Sanpaolesi sulla salvaguardia paesistica. Nel cantiere del restauro per dannidi guerra, infatti, ritroviamo il rinnovarsi di scelte, metodi e strategie di intervento che fanno capo ad un consapevole approccio metodologico della disciplina, solo più tardi sistematizzato.
11
Alla luce delle vicende indagate Sanpaolesi rientra a pieno titolo nell’alveo dei «soprintendenti della ricostruzione», insieme ad altri personaggi illustri come Ce-schi, Perogalli, De Angelis, Gazzola ed altri.
La sua metodologia del restauro, raccolta nel volume del 1973, prende vita nell’ambiente accademico, quando da docente, prima a Pisa poi a Firenze, di Ca-ratteri Stilistici e Costruttivi dei Monumenti e Restauro dei Monumenti, continua la personale ricerca sulle maggiori espressioni architettoniche e sul loro rapporto di sintesi tra forma e struttura. Sono i grandi temi dell’architettura storica, infatti, che vedono il Nostro assolutamente impegnato nel dare un contributo originale rispetto ai tradizionali studi, come per la cupola di Santa Maria del Fiore e per tutte quelle espressioni minori dell’architettura che ruotano intorno a questi grandi esempi e con essi intrecciano forme, stili, tecniche, varianti costruttive, ecc.
Nell’ambito della conservazione del patrimonio architettonico è costante l’inte-resse verso la permanenza della autenticità materiale, in cui ricade la sperimentazio-ne di nuove tecniche di consolidamento dei materiali lapidei. All’interno dell’Istituto di Restauro dei Monumenti, da lui fondato nella facoltà di Architettura di Firenze, grazie alla collaborazione di un gruppo di «valenti allievi», Sanpaolesi inaugura la tematica della conservazione delle superfici lapidee architettoniche e scultoree se-condo un rigoroso equilibrio tra prassi, ricerca e didattica, in cui non solo rinnova l’interesse nel rapporto tra scienza e restauro ma perviene ad una chiara sistema-tizzazione dell’indagine analitica che precede il momento operativo del restauro. Su tali presupposti vengono riletti alcuni dei già noti casi di restauro delle facciate lapidee fiorentine con l’impiego di tecniche moderne, mentre maggiore attenzione è rivolta proprio al caso napoletano del consolidamento dei paramenti marmorei dell’Arco di Alfonso d’Aragona, ancora non sufficientemente conosciuto nei dettagli del cantiere messo in opera.
Con questo modello di ricerca, ed in generale della disciplina, Sanpaolesi giun-ge negli anni settanta a confrontarsi con le diverse scuole del restauro in Italia, da cui emergono punti comuni e sostanziali contrapposizioni, una tappa fondamentale all’interno dell’evoluzione della cultura del restauro, determinando attuali orienta-menti e metodologie di intervento.
Lo scritto che segue mira alla comprensione della figura di Piero Sanpaolesi, nel tentativo di estrapolare dall’ampia prassi operativa, espletata in ogni campo del restauro, i nodi critici del suo pensiero. La successione degli argomenti si affida ad una serrata sequenza cronologica, imprescindibile per un esame generale dell’atti-vità dell’architetto. La prima parte del volume si interessa del periodo della forma-zione, che giunge sino alle soglie della seconda guerra mondiale ed investe le prime esperienze nella Soprintendenza fiorentina; la seconda degli anni della ricostruzione, che lo vedono attivo nella Soprintendenza di Pisa, e poi il periodo nell’Università di Firenze. Quest’ultimo coincide con il momento più intenso delle sperimentazioni di consolidamento delle superfici lapidee che hanno decretato la “fortuna” critica dell’autore. Il testo si conclude con una riflessione più ampia sulla metodologia del restauro applicata dal Sanpaolesi alla luce delle attuali acquisizioni critico-culturali.
Per ciascuna di queste fasi è stato opportuno indagare gli esiti operativi di alcuni significativi casi di restauro, riletti alla luce di una documentazione inedita rinvenuta dalle ricerche di archivio, con particolare attenzione al cantiere del restauro, dove spesso ritroviamo l’apporto innovativo del Sanpaolesi.
Il volume riporta negli apparati il profilo biografico dell’autore, una completa bi-bliografia dei suoi scritti - ambedue ampliati rispetto a quelli redatti nel 1978 (Scrittivari di storia, restauro e critica dell’architettura di Piero Sanpaolesi, Firenze 1978) – e ancora un’aggiornata bibliografia sulla figura di Sanpaolesi, a testimonianza del contributo che il restauratore ha trasmesso all’attuale cultura del restauro. A con-clusione si riporta una raccolta di scritti, lettere e relazioni tecniche autografe, che accompagnano gli argomenti trattati nel testo.