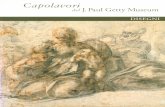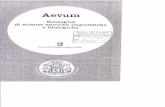Modelli, disegni e perizie di architetti "romani"
Transcript of Modelli, disegni e perizie di architetti "romani"
ECCLESIA TRIUMPHANS
architetture del Barocco siciliano
attraverso i disegni di progetto
XVII-XVIII secolo
a cura di Marco Rosario Nobile, Salvatore Rizzo, Domenica Sutera
catalogo della mostraCaltanissetta, 10 dicembre 2009 - 10 gennaio 2010
Edizioni Caracol
Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione
Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali, dell’Educazione Permanente edell’Architettura e dell’Arte contemporanea
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta
Università degli Studi di Palermo Area Biblioteca centrale della Regione Siciliana “A. Bombace” Palermo
Maria Giuffrè, Università degli Studi, Palermo Elisabeth Kieven, Biblioteca Hertziana, Roma Marco Rosario Nobile, Università degli Studi, Palermo Rosalba Panvini, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali diCaltanissetta Salvatore Rizzo, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali diCaltanissetta Aurora Scotti Tosini, Politecnico di Milano Luciano Patetta, Politecnico di Milano
Coordinamento generale Rosalba Panvini
Ideazione e coordinamento scientifico Marco Rosario NobileDomenica Sutera
Direzione della mostra Salvatore Rizzo
Coordinamento amministrativo, della sicurezza, dei trasporti e deiprestiti Salvatore RizzoFrancesca BenniciCarmelo MoscaGiuseppe Sardo
Coordinamento tecnico, organizzativo, ufficio stampa e segreteria Salvatore RizzoFrancesca BenniciLeonardo CumboIrene CravottaIrene D’AtriCarmelo MoscaGiuseppe Sardo
Progetto espositivo ed illuminotecnico Salvatore Rizzo
Elaborazione dei testi dei pannelli didattici Domenica Sutera
Consulenza per l’esposizione dei disegni Ignazio Lodato, Laboratorio di restauro della Biblioteca centrale dellaRegione Siciliana “A. Bombace” di Palermo
Restauri Daniela Campanella, Francesco Di Stefano, Cecilia La Gattuta, IgnazioLodato, Laboratorio di restauro della Biblioteca centrale della RegioneSiciliana “A. Bombace” di Palermo Arabella Bombace, Vincenzo La Porta, Bianca Pastena, AntoninoSciortino, Laboratorio di restauro della Galleria Regionale Palazzo Abatellisdi Palermo Edoardo Anastasi, Acireale (Ct) Giovanni Calvagna, Aci Sant’Antonio (Ct)
Realizzazione dei supporti espositivi e dei disegni Daniela Campanella, Francesco Di Stefano, Cecilia La Gattuta, IgnazioLodato, Laboratorio di restauro della Biblioteca centrale della RegioneSiciliana “A. Bombace” di Palermo
Collocazione delle opereDaniela Campanella, Francesco Di Stefano, Cecilia La Gattuta, IgnazioLodato, Laboratorio di restauro della Biblioteca centrale della RegioneSiciliana “A. Bombace” di Palermo Carmelo Mosca, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientalidi Caltanissetta
ECCLESIA TRIUMPHANS. ARCHITETTURE DEL BAROCCO SICILIANO
ATTRAVERSO I DISEGNI DI PROGETTO, XVII-XVIII SECOLO
Caltanissetta, ex Palestra Bilotta 10 dicembre 2009 - 10 gennaio 2010
La mostra è organizzata dalla: Area Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali diCaltanissetta Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura -Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura
con la collaborazione della Area Biblioteca centrale della Regione Siciliana “A. Bombace” diPalermo © 2009 Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali edAmbientali e della Pubblica Istruzione © 2009 Caracol, Palermo
Comitato d’onore Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Siracusa Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta Antonio Staglianò, Vescovo di Noto Michele Pennisi, Vescovo di Piazza ArmerinaPaolo Urso, Vescovo di RagusaSalvatore Leonarda, Abate dell'Abbazia benedettina di San Martino delleScale, PalermoMauro Morcone, Capo Dipartimento del Ministero dell’Interno, DirezioneCentrale per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, Roma Roberto Lagalla, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Diego Cammarata, Sindaco di Palermo Corrado Valvo, Sindaco di Noto Gesualdo Campo, Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali diCatania Giuseppe Gini, Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali diTrapani Vera Greco, Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa Adele Mormino, Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali diPalermo Mariella Muti, Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali diSiracusa Rosalba Panvini, Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali diCaltanissetta Claudio Torrisi, Direttore dell’Archivio di Stato di Palermo Giulia Davì, Direttore della Galleria Regionale Palazzo Abatellis di Palermo Gaetano Gullo, Direttore della Biblioteca centrale della Regione Siciliana“A. Bombace” di Palermo Giovanni Solonia, Padre Provinciale della Provincia Monastica dei FratiMinori Cappuccini di Siracusa
Comitato promotore Nicola Leanza, Assessore dei Beni Culturali, Ambientali e della PubblicaIstruzione della Regione Sicilia Vincenzo Emanuele, Dirigente Generale del Dipartimento dei BeniCulturali e Ambientali, dell’Educazione Permanente, dell’Architettura edell’Arte Contemporanea Marco Rosario Nobile, Professore ordinario, Università degli Studi diPalermo Rosalba Panvini, Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali diCaltanissetta Salvatore Rizzo, Dirigente del Servizio per i Beni Bibliografici ed Archivisticidella Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta
Comitato Scientifico Richard Bösel, Istituto Storico Austriaco, Roma Aldo Casamento, Università degli Studi, Palermo Giovanna Curcio, IUAV, Venezia
Movimentazione delle opere Salvatore RizzoGiuseppe Sardo
Allestimento espositivo Proservice s.r.l., Palermo
Realizzazione dei pannelli didattici e didascalici Tipolitografia Paruzzo s.n.c., Caltanissetta
Manutenzione impianti di sicurezza Secur Point s.r.l., Caltanissetta
Trasporti e imballaggio delle opere De Marinis s.r.l. Fine Art Services & Transports, Napoli
Assicurazione delle opere Milano Assicurazioni s.p.a.
Enti e soggetti prestatori Archivio di Stato di PalermoArchivio Storico Diocesano - Curia Arcivescovile di Catania Archivio Storico Diocesano - Curia Vescovile di Mazara del Vallo Area Biblioteca centrale della Regione Siciliana “A. Bombace” diPalermoBiblioteca Alagoniana - Curia Arcivescovile di Siracusa Biblioteca Comunale della città di Noto Biblioteca Comunale della città di Palermo Curia Arcivescovile di Palermo Curia Vescovile di Noto Curia Vescovile di Ragusa Facoltà di Architettura - Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architet-tura di Palermo Galleria Regionale Palazzo Abatellis di Palermo Marco Rosario Nobile, Palermo Museo Diocesano “Mons. Giovanni Speciale” - Curia Vescovile diCaltanissetta Museo-Pinacoteca dei Frati Minori Cappuccini di Caltagirone
CATALOGO DELLA MOSTRA
Cura scientifica e coordinamento delle ricerche Marco Rosario NobileSalvatore RizzoDomenica Sutera
Coordinamento dei materiali Salvatore Rizzo
Redazione Monica CraparoEmanuela GarofaloStefania GuastellaFederica Scibilia Domenica Sutera
Realizzazione editoriale, progetto grafico e impaginazione Edizioni Caracol, Palermo
Autori dei contributi scientifici Giuseppe Antista, Maria Mercedes Bares, Silvana Bartolozzi, AngeloBruccheri, Maria Rita Burgio, Monica Craparo, Maria Sofia Di Fede,Emanuele Fidone, Emanuela Garofalo, Giuseppina Leone, Erik H. Neil,Marco Rosario Nobile, Fulvia Scaduto, Federica Scibilia, DomenicaSutera
Bibliografia e revisione dei testi Marco Rosario Nobile, Domenica Sutera
Fotografie Maria Mercedes Bares, Noto Enzo Brai - Publifoto, Palermo Gero Cordaro, Palermo Monica Craparo, Palermo Rodolfo Leotta, Catania Ignazio Lodato, PalermoGiuseppe Nicoletti, Caltanissetta
Ringraziamenti Un particolare e riconoscente ringraziamento per la preziosa disponibilitàed amichevole collaborazione va rivolto a tutti i parroci, i rettori dellechiese interessate, i funzionari delle biblioteche, dei musei, delle universi-tà, delle soprintendenze, al personale degli archivi e delle curie, al perso-nale di custodia della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta e aquanti a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione della mostra edel catalogo e in particolare a: Vincenzo Abbate, Angela Agnello, Giuseppe Antoci, EmanuelaAmoroso, Giuseppe Arezzo, Antonio Baionetta, Rudi Bascetta, StefanoBiondo, Giuseppe Cabibbo, Ignazio Cannarozzo, Carmela Cappa,Giovannella Cassata, Concetta Celestini, Santo Cillaroto, RobertaCiviletto, Mariano Colletta, Giovanna Cuttitta, Evelina De Castro,Maria Dell’Utri, Maddalena De Luca, Leo De Simone, Teresa DeSimone, Caterina Dessy, Carmelo Di Maria, Giuseppe Di Maria, SergioDi Mauro, Giuseppe Di Vita, Pietro Floridia, Antonella Francischiello,Vincenzo Fugaldi, Luigi Gattuso, Vito Genova, Margherita Giacalone,Alfio Gibilisco, Claudia Giordano, Angelo Giunta, Giuseppe Greco,Filippo Guttuso, Javier Ibánez Fernández, Stefania Lanuzza, ManuelaLeone, Teresa Lombardo, Alessandra Longo, Giuseppe Lumera, EugenioMagnano Di San Lio, Salvatore Maiana, Salvatore Maiore, Guido Meli,Francesca Migneco, Massimo Naro, Antonino Nestler, VincenzinaNovello, Claudia Oliva, Francesco Orecchio, Giuseppe Paci, SalvatorePagano, Milena Pasqualino, Carlo Pastena, Antonino Piazza, Luigi Pico-ne, Vittorio Pirillo, Pietro Pisciotta, Giuseppe Randazzo, MariaReginella, Salvatore Riciputo, Paolo Russo, Salvatore Russo, LiboriaSalomone, Stefania Santini, Luca Saraceno, Giuseppe Schiera, MarziaScialabba, Giorgio Scimeca, Giorgio Scimone, Carmelo Signorello,Valeria Sola, Grazia Spampinato, Maria Giuseppa Spanò, GiuseppeStella, Luigi Stivala, Francesca Testa, Isidoro Turdo, Enza Vasapolli,Carmela Vella, Giuseppe Zavettieri. Associazione Nazionale Carabinieri,Sez. “G. Ugolini” - Caltanissetta, Confraternita della SantissimaAnnunziata di Ispica, I.S.A.S. sede di Caltanissetta, I.T.A.S. “L. Russo” -Caltanissetta, Istituto Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta, LiceoGinnasio “R. Settimo” di Caltanissetta, Istituto d’Istruzione Superiore“Sen. Angelo Di Rocco” di Caltanissetta, Provincia Regionale diCaltanissetta, SiciliAntica - Caltanissetta
Vietata la venditaVietata la riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
Ecclesia triumphans: architetture del Barocco siciliano attraverso idisegni di progetto, 17.-18. secolo: catalogo della mostra Caltanissetta,novembre 2009/ a cura di Marco Rosario Nobile, Salvatore Rizzo,Domenica Sutera. - Palermo: Caracol, 2009.ISBN 978-88-89440-55-11. Disegni architettonici - Sicilia - Sec. 17.-18. - Esposizioni -Caltanissetta - 2009.I. Nobile, Marco Rosario <1963->. II. Rizzo, Salvatore <1956->.III. Sutera, Domenica <1975->720.222458 CCD-21 SBN Pal0222067CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”
Caracol s.n.c. – Via M. D’Azeglio, 27 – 90143 Palermoe-mail: [email protected]
I momenti in cui la storia e la cultura siciliana hanno prodotto risultati artistici di levatura internaziona-
le sono molteplici ed è una straordinaria occasione, offerta dalla proficua collaborazione tra la
Soprintendenza di Caltanissetta e l’Università degli Studi di Palermo, quella che individua, nel ruolo della
Chiesa e nelle risposte progettuali offerte da grandi architetti del Seicento e del Settecento, un argomento di
grande fascino degno di attenzione e soprattutto testimoniato da elaborati di alta qualità.
Tra i compiti di un uomo politico con incarichi istituzionali, come quelle che riveste il sottoscritto, c’è l’ob-
bligo di fare emergere e mettere in risalto i valori positivi offerti dalla nostra storia e dalla tradizione con
finalità e implicazioni molto più ampie di quelle legate al singolo evento o alla occasionale -ma sempre
importante- riscoperta o rilettura di materiali artistici. Un sentito ringraziamento va pertanto ai curatori,
agli organizzatori, agli studiosi che hanno permesso la realizzazione di questo importante momento di
accrescimento civile e di attenta riflessione su una parte fondamentale del nostro passato.
Nicola Leanza
Assessore dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana
Una mostra che raccoglie preziosi modelli e soprattutto disegni e progetti di architettura religiosa, firmati
da alcuni tra i più prestigiosi professionisti del Settecento siciliano, rappresenta per la nostra regione un feli-
ce e considerevole evento. Attraverso preziosi oggetti, restaurati in buona parte per l’occasione, e spesso a
rischio di facile degrado e di dispersione, si può agevolmente dimostrare la vocazione internazionale della
nostra isola, la grande attitudine al dialogo e la capacità di reinterpretazione delle mode che dominava com-
mittenti, architetti ed artisti.
Consapevoli che il progresso civile passa attraverso il recupero di storie e memorie del nostro passato per illu-
minare l’attualità, siamo lieti di presentare la mostra e il prezioso catalogo curati dalla Soprintendenza di
Caltanissetta e dall’Università degli Studi di Palermo.
Vincenzo Emanuele
Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali,
dell’Educazione Permanente, dell’Architettura e
dell’Arte Contemporanea
La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ha accolto con entusiasmo la proposta
di Marco Rosario Nobile di organizzare la mostra Ecclesia Triumphans. Architetture del Barocco siciliano
attraverso i disegni di progetto, XVII-XVIII secolo, che è stata allestita all’interno dei locali demaniali del-
l’ex palestra Bilotta. La mostra scaturisce da uno studio avviato su disegni siciliani del Seicento e del Settecento
nei quali sono rappresentati progetti di architetture del tempo relativi in particolare ad edifici ecclesiastici.
Molti di essi furono realizzati dopo il terremoto del 1693 verificatosi in Sicilia in cui andarono distrutti diver-
si edifici di culto; altri disegni sono, invece, relativi a complessi religiosi costruiti nelle zone risparmiate da quel-
l’evento calamitoso.
Alcuni di tali documenti iconografici riportano soltanto idee progettuali mai attuate e, pertanto, costituiscono
una fonte di informazione notevole per quanto riguarda gli indirizzi architettonici dell’epoca, oggetto di ana-
lisi delle tematiche di questa mostra. Come si avrà modo di vedere gli edifici furono progettati dai più grandi
architetti dell’epoca come Giacomo Amato, Giovanni Amico, Rosario Gagliardi, Giovan Battista Cascione
Vaccarini, Andrea Gigante, etc…, e su committenza di mecenati e prelati che, raffigurati in alcuni dipinti
presentati nel percorso espositivo, condizionarono probabilmente le scelte architettoniche degli ideatori.
Anche il catalogo, in cui sono raccolte, attraverso immagini e apparati iconografici, le opere esposte nella
mostra, rappresenta una preziosa testimonianza di uno dei momenti più intensi della storia dell’architettura
siciliana anche perché proprio in quel tempo maturarono correnti e linguaggi trasmessi da ambienti culturali
esterni all’isola -come quello romano- e che tuttavia improntarono la formazione degli architetti e dei proget-
tisti siciliani. Da ciò potrà evidenziarsi la capacità degli architetti locali di elaborare modelli e schemi estranei
al proprio ambiente.
Si è ritenuto opportuno ospitare la mostra nei locali di un’ex palestra in cui si sono formate generazioni di nis-
seni, sperando che la sua funzione possa trasferirsi in ambito culturale.
La scelta, peraltro, è ricaduta su locali ubicati nel centro storico di Caltanissetta, convinti che questa zona rap-
presenti il punto nevralgico del tessuto urbano, come di ogni insediamento e, in quanto tale, da recuperare e
rivitalizzare.
La sorveglianza della mostra e le visite guidate sono state affidate agli studenti di tre scuole di Caltanissetta,
che rappresentano parte di quel pubblico che fruisce del patrimonio e degli eventi culturali, al fine di riappro-
priarsi della propria storia e delle proprie radici.
Un particolare riconoscimento va espresso al professore Marco Rosario Nobile e al suo gruppo di lavoro per l’im-
pegno profuso in questa ricerca, grazie alla quale i fruitori della mostra potranno riappropriarsi di aspetti fon-
damentali della storia dell’architettura prodotta in Sicilia, nella quale poi si fondano le acquisizioni delle epo-
che successive. A Salvatore Rizzo, responsabile del Servizio per i Beni Bibliografici e Archivistici di questa
Soprintendenza, esprimo un sincero apprezzamento per aver allestito il percorso espositivo in cui è chiaramen-
te leggibile, attraverso i grafici di progetto, l’evolversi dei linguaggi che sostanziano l’architettura del Sei-
Settecento siciliano.
Rosalba Panvini
Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta
Abbreviazioni
a. p. archivio parrocchialeASDCt Archivio Storico Diocesano di CataniaASDPA Archivio Storico Diocesano di Piazza ArmerinaASDM Archivio Storico Diocesano Mazara del ValloASPa Archivio di Stato di PalermoASSM Archivio Storico di San Martino delle ScaleASSMC Archivio Storico Santuario Madonna della Consolazione Termini ImereseBASr Biblioteca Alagoniana di SiracusaBCN Biblioteca Comunale di NotoBCNi Biblioteca Comunale di NicosiaBCPa Biblioteca Comunale, PalermoBCRS Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, PalermoBFTp Biblioteca Fardelliana, TrapaniBNM Biblioteca Nazionale di MaltaBNP Biblioteca Nazionale di Francia, Parigicoll. p. collezione privataDISPA Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura dell’Università di PalermoF.E.C. Fondo Edifici di Culto, Ministero dell’Interno, RomaGRS Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, PalermoMAEC Archivo General y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, MadridMDCl Museo Diocesano di CaltanissettaPMCC Pinacoteca Museo dei Frati Minori Cappuccini, CaltagironeV&A Victoria and Albert Museum, Londra
INDICE
PREMESSA, Marco Rosario Nobile, Domenica Sutera 13
PROGETTARE PER LA CHIESA. GLI ARCHITETTI, IL LAVORO, IL DISEGNO, Marco Rosario Nobile 15
DISEGNI DI FABBRICHE GESUITICHE CONSERVATE PRESSO LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE, Maria Rita Burgio 25
MODELLI, DISEGNI E PERIZIE DI ARCHITETTI “ROMANI”, Domenica Sutera 36
L’ICONOGRAFIA PERDUTA: LA MEMORIA DEI DISEGNI ATTRAVERSO FOTOGRAFIE E RIPRODUZIONI
DEL NOVECENTO, Federica Scibilia 46
COMMITTENTI E ARCHITETTI 55
1. I COMMITTENTI E L’ARCHITETTURA: ALCUNI RITRATTI, Emanuela Garofalo 57
2. UNA RAFFIGURAZIONE SETTECENTESCA DELLA CATTEDRALE DI NOTO NEL RITRATTO DEL
SACERDOTE E CAVALIERE DI MALTA GIOVANNI DI LORENZO, Maria Mercedes Bares 61
3. L’AUTORAPPRESENTAZIONE DELL’ARCHITETTO, Marco Rosario Nobile 63
IL DISEGNO DI PROGETTO 67
4. GUARINO GUARINI. LA CHIESA DEI PADRI SOMASCHI A MESSINA, Marco Rosario Nobile 69
5. I PROSPETTI DELLE CHIESE DI S. MATTEO A PALERMO E DELLA SS. ANNUNZIATA A MESSINA,Maria Sofia Di Fede 70
6. ARCHITETTURA DIPINTA. PROSPETTI CHIESASTICI DI PALERMO IN UN QUADRO DELLA
COLLEZIONE ALBA DI SIVIGLIA, Domenica Sutera 72
7. UN DISEGNO PER LA DECORAZIONE DELLA CHIESA DEL SS. SALVATORE A PALERMO,Domenica Sutera 76
8. I DISEGNI DELLE CHIESE TRAPANESI «ACCHIUSI» AI VOLUMI DELLE VISITE VESCOVILI,Giuseppe Antista 78
9. ROMANO CARAPECCHIA. DISEGNI PER IL COMPLESSO DEI CAVALIERI DI MALTA A MARSALA,Marco Rosario Nobile 84
10. DISEGNO PER PROSPETTO CHIESASTICO (APPARATO EFFIMERO PER LA CATTEDRALE DI
SIRACUSA?), Emanuele Fidone, Marco Rosario Nobile 86
11. NICOLA MICHETTI. DISEGNI PER LA CHIESA E IL CONVENTO DEI PADRITEATINI A SIRACUSA,Marco Rosario Nobile 89
12. GIOVANNI AMICO. DISEGNI PER LA «LIBRARIA» DEL MONASTERO DI SAN MARTINO DELLE
SCALE, Domenica Sutera 92
13. ROSARIO GAGLIARDI. DISEGNI PER LA CHIESA E IL MONASTERO DI S. CHIARA A NOTO,Maria Mercedes Bares 95
14. ROSARIO GAGLIARDI, GIOVAN BATTISTA CASCIONE VACCARINI. DISEGNI PER LA FACCIATA
DELLA CHIESA DI S. MARIA DELLE STELLE A COMISO,Monica Craparo 100
15. ROSARIO GAGLIARDI. DISEGNI PER LA CHIESA MADRE DI S. GIORGIO A RAGUSA, Marco Rosario Nobile 102
16. UN DISEGNO PER LA FACCIATA DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE
A TERMINI IMERESE, Domenica Sutera 106
17. FELICE CUCCHIARA. PROSPETTO PER LA CHIESA DI S. LEONARDO A SERRADIFALCO (?),Silvana Bartolozzi 110
18. ORAZIO FURETTO. DISEGNO PER LA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA A CORLEONE,Federica Scibilia 112
19. PAOLO LABISI. DISEGNI PER IL COMPLESSO DEI CROCIFERI A NOTO, Emanuela Garofalo 114
20. PAOLO LABISI. DISEGNI CHIESASTICI, Emanuele Fidone 120
21. ANDREA GIGANTE. DISEGNI PER LA CHIESA DEL MONASTERO DEL SS. SALVATORE A NOTO,Giuseppina Leone 122
22. FRANCESCO BASILE. DISEGNI PER IL CONVENTO DI S. MARIA DI GALA DEI PADRI BASILIANI,Erik H. Neil 125
23. GIOVAN BATTISTA CASCIONE VACCARINI. DISEGNI PER LA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA
A COMISO, Monica Craparo 127
24. ANDREA GIGANTE. DISEGNO PER LA CHIESA DI S. ROCCO A MOTTA D’AFFERMO,Monica Craparo 129
25. ANDREA GIGANTE. DISEGNI DI PER LA CHIESA DEL CARMINE A SCIACCA, Monica Craparo 130
26. PAOLO BATTAGLIA. DISEGNI PER LA CHIESA DI S. MARIA DELL’OGNINELLA AL RINAZZO
A CATANIA, Tiziana Abate 134
ALTARI E ARREDI 137
27. DISEGNI PER TABERNACOLI E PER UNA CAPPELLA, Emanuela Garofalo 139
28. DISEGNI PER UN TABERNACOLO E UN OSTENSORIO, Emanuela Garofalo 142
29. NICOLÒ PALMA. DUE DISEGNI DI ALTARI, Federica Scibilia 144
30. DISEGNI DI ALTARI IN UNA RACCOLTA DI MODELLI, Emanuela Garofalo 147
31. PAOLO LABISI. DISEGNI PER LA SACRESTIA E ARREDI DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA
A ISPICA, Fulvia Scaduto 150
32. DISEGNO DEL TABERNACOLO PER LA CHIESA DEI CAPPUCCINI A MAZZARINO,Emanuela Garofalo 152
33. APPARATI EFFIMERI LUNGO LA NAVATA DELLA CATTEDRALE DI PALERMO, Domenica Sutera 154
MODELLI E MICROARCHITETTURE 159
34. MODELLI E MICROARCHITETTURE LIGNEE, Domenica Sutera 161
35. L’ANTICA CUSTODIA DELLA CHIESA DEI PADRI CAPPUCCINI DI MAZZARINO, Angelo Bruccheri 167
BIBLIOGRAFIA 169
13
PREMESSA
Marco Rosario Nobile, Domenica Sutera
Negli ultimi due decenni le mostre dedicate all’architettura sono diventate un’apprezzata consuetudine e le remore
o diffidenze di istituzioni pubbliche per finanziare l’esposizione di disegni o di modelli si sono attenuate notevol-
mente. Le rappresentazioni originali non sono più considerate l’ombra sbiadita dell’architettura costruita (che per
ragioni ovvie non si può mettere in mostra se non fotograficamente), cara solo a sparuti addetti ai lavori, ma stru-
menti che riescono a offrire un quadro più generale dell’architettura del tempo o uno spaccato del lavoro prelimina-
re dell’architetto.
Su un fronte diverso l’apprezzamento pubblico per l’architettura prodotta in Sicilia tra Sei e Settecento, anche questo
impossibile da immaginare meno di mezzo secolo fa, ha conseguito risultati notevoli -si pensi ai riconoscimenti Unesco-
, ma si è anche arrestata sul filo di alcuni superficiali e incrollabili luoghi comuni. Così -e naturalmente con lodevoli
eccezioni- la percezione dell’architettura isolana passa ancora per schematismi che possiamo sommariamente elencare:
l’improvvisazione e la fantasia artigianale; la traduzione dialettale e un po’ goffa di esempi blasonati che giungono diret-
tamente dalle capitali (Roma in primo luogo); un genius loci intriso di esotismo, di arcaismi, di superstizioni.
In realtà, come ha evidenziato Henry Millon, la caratteristica comune più evidente del primo Barocco in Europa è
l’identità locale. Certamente non mancano le tendenze all’internazionalismo, che via via (e soprattutto nel
Settecento) avranno il sopravvento, ma il Barocco europeo come lo vediamo oggi è costituito da un mosaico di espe-
rienze regionali in qualche modo connesse o intrecciate.
Questa mostra nasce quindi dall’idea di offrire al pubblico un primo quadro della professionalità degli architetti nella
Sicilia tra Sei e Settecento davanti al tema del progetto chiesastico.
In Sicilia, come in ogni altro luogo dell’Occidente cattolico, la chiesa trionfante dell’età del Barocco costituiva il
committente più autorevole, spesso aperto più di altri alle novità, in grado inoltre di mobilitare risorse immense da
investire in architetture, apparati simbolici, in progetti gratificanti per chi aveva la fortuna di ricevere un incarico.
Una delle peculiarità del caso siciliano appare poi legata a una singolare sovrapposizione di ruoli. A parte pochi casi
(quasi esclusivamente concentrati nella parte orientale dell’isola, dove sussisteva una solida tradizione di trasmissio-
ne familiare del mestiere) i maggiori architetti siciliani, attivi tra tardo Seicento e primo Settecento, sono perlopiù
essi stessi religiosi.
Di fronte a questa situazione sociale appare concreta l’ipotesi che per un lungo periodo si considerasse pressoché
ovvio il parallelismo tra determinate professioni. Per alcune ragioni, almeno in parte intuibili, architetti autorevoli e
colti (in grado di padroneggiare il latino o la matematica) si diventava solo se si era intrapresa una carriera ecclesia-
stica. Si può inoltre immaginare che il successo internazionale di architetti religiosi come Juan Caramuel de
Lobkowitz, Guarino Guarini, Andrea Pozzo, venuti alla ribalta grazie soprattutto a pubblicazioni specialistiche e uni-
versalmente noti per la loro erudizione, delineasse modelli da perseguire.
Diventa a questo punto facile comprendere come l’ufficio religioso, apparentemente secondario (almeno nella nostra
percezione attuale), comportasse una particolare attenzione all’architettura chiesastica e a tutti quegli aspetti (come
per esempio la buona conoscenza della liturgia, dei dettami del Concilio di Trento) che potevano rendere agevole il
rapporto con la committenza. Per l’ambiente siciliano, nonostante la specificità, tali figure sono quanto di più simi-
le all’idea di architetto che possediamo ancora oggi.
Una tale condizione vincente non impediva conflitti e scontri (proverbiali quelli che interessarono Giovan
Battista Vaccarini, forse superati solo dall’incredibile catena di contestazioni che caratterizzarono l’attività di
Paolo Labisi) e si presta perfettamente a illuminare il ruolo degli architetti e dell’architettura in una delle fasi
più intense e ricche della storia isolana. In realtà l’architettura religiosa conservava una profondità di interesse
ECCLESIA TRIUMPHANS
14
ECCLESIA TRIUMPHANS
pubblico che oggi solo confusamente possiamo cogliere.
Non si trattava, come si potrebbe credere, della mobilitazione esclusiva di ristrette comunità di fedeli o della mera
cerchia dei finanziatori, dal momento che -oltre alle rendite su cospicue proprietà- il meccanismo delle donazioni e
delle messe per i defunti costituiva la voce di maggiore introito per le fabbriche. Il livello di coinvolgimento sociale
appare ancora più vasto, poiché l’architettura veniva percepita come strumento di magnificenza civile. Da queste pre-
messe nasceva la necessità di ricorrere a professionisti affermati, a procedure condivise (per esempio i concorsi), a
perizie esterne che avevano il compito di garantire la qualità dei risultati. I progetti sono spesso revisionati, sottopo-
sti a veri e propri processi pubblici, e gli architetti devono continuamente affinare tutti i loro strumenti e strutture
di consenso (reali o retoriche) per creare o mantenere il successo. Se a questo si aggiunge la concorrenza interna tra
gli stessi operatori, si potrà percepire l’intensità della sfida che muoveva gli architetti.
Per la prima volta, testimonianze di questa vicenda (ritratti, progetti, modelli) sono riunite per delineare confronti e
paralleli, per aiutare a comprendere in maggior misura che ruolo svolgesse il progetto all’interno del rapporto tra gli
architetti e tra questi ultimi, la chiesa e il pubblico.
Si tratta di materiali preziosi, spesso soggetti a fenomeni di dispersione e di deperibilità. Le diocesi, le cattedrali, le chie-
se parrocchiali, gli ordini religiosi sono istituzioni che archiviavano documenti di spesa e progetti, ma solo una piccola
parte di questi preziosi materiali si è conservata. Il collezionismo privato (che risale già al Settecento) ha prodotto uno
squilibrio ancora avvertibile: solo in Sicilia sud orientale, nei territori della ex diocesi di Siracusa, si conserva la percen-
tuale più alta di disegni di architettura (escludendo dal conteggio i volumi di Giacomo Amato, conservati alla Galleria
Regionale della Sicilia di palazzo Abatellis a Palermo), non tanto perché quella zona sia stata oggetto di grandi campa-
gne costruttive dopo il terremoto del 1693 (un argomento che dovrebbe valere anche per gli ambiti catanesi), ma pro-
babilmente perché il collezionismo otto-novecentesco ha solo sfiorato questa parte dell’isola. Chi scrive ha assistito in
più occasioni alla “scomparsa” di disegni, conservati in piccoli archivi parrocchiali, per potere affermare che si tratta di
un patrimonio a rischio, facile preda in un’epoca che ha riscoperto l’antiquariato in tutte le sue forme. Mettere in mostra
queste opere ha anche l’ambizione di alzare la soglia dell’attenzione collettiva e della tutela.
36
ECCLESIA TRIUMPHANS
MODELLI, DISEGNI E PERIZIE DI ARCHITETTI “ROMANI”
Domenica Sutera
Nella storia dell’architettura siciliana d’età barocca ricorrono spesso episodi in cui appare decisivo il ruolo assunto da
disegni e modelli veicolanti il linguaggio usato a Roma. Affrontare l’argomento significa mettere insieme le commis-
sioni di progetti a professionisti attivi nella città capitolina, pervenuti sull’isola per corrispondenza o tramite diretta
convocazione degli artefici; casi relativi a perizie compiute da autorevoli personalità, che si rivelano spesso risolutive
per progetti impegnativi e a lungo dibattuti e che possono obbligare all’elaborazione di nuove soluzioni. Per la com-
mittenza l’obiettivo era introdurre anche in Sicilia i traguardi raggiunti dall’architettura di Roma, in quel momento,
e ancora per lungo tempo, città culturalmente dominante nel mondo cattolico. In quest’ottica si possono spiegare le
ragioni della fortuna professionale ottenuta nell’isola, e in particolare nella sfera ecclesiastica, da quegli architetti, sici-
liani e non, laici e religiosi, che potevano vantare periodi di apprendistato a Roma o potevano sfruttare contatti con
la città e il suo ambiente.
I casi di seguito esposti, circoscritti all’architettura religiosa, sono quasi tutti già noti agli storici, tuttavia, se somma-
ti e inseriti nel quadro generale della produzione siciliana d’età barocca, illuminano sugli orientamenti di gusto della
committenza, sulla formazione e sulla professione dell’architetto, sui gradi di “resistenza” che la tradizione regionale
oppone sia in termini di contrasto che di rielaborazione di determinate suggestioni.
Come è noto, dal secondo Cinquecento la prassi di richiedere progetti a personalità esterne, spesso provenienti dalla
penisola italiana, è ormai consueta nell’isola1. La vicenda della ricostruzione della matrice di Piazza (oggi Piazza
Armerina) appare, alla luce dei nostri ragionamenti, un caso per tanti aspetti emblematico e tuttavia isolato in rela-
zione al più ampio contesto siciliano degli anni trenta del Seicento. La lunga e controversa consulta progettuale inne-
scata dal testamento del barone Trigona2 per la riforma della fabbrica religiosa, in cui furono coinvolti professionisti
attivi in tutto il territorio siciliano, si risolverà solo nel 1628 con un progetto elaborato da un architetto provenien-
te da Roma: Orazio Torriani3. In realtà, già nel 1610, il modello di una delle soluzioni proposte per la chiesa era stato
condotto a Roma per essere valutato dall’Architetto del Popolo Romano in carica, all’epoca Girolamo Rainaldi.
Inoltre il primo invito a Giulio Lasso, architetto solito a firmarsi «romanus» e le successive convocazioni di tre per-
sonalità esponenti della Compagnia di Gesù (che prevedeva un periodo di formazione presso la sede centrale
dell’Ordine a Roma), tra cui Natale Masuccio e Tommaso Blandino, svelano intenti coerenti da parte della commit-
tenza sin dall’inizio della consulta, culminante poi con la scelta definitiva di un impianto «di chiesa assai comoda et
capace, et sopra tutto conforme all’uso moderno»4. Tale fu infatti il giudizio conferito dal vescovo di Catania, il
romano don Innocenzo Massimo, al progetto di Orazio Torriani, «Architetto militare et civile di Sua Maestà Catolica
in Roma», giunto a Piazza per la prima volta il 27 giugno 1627 e pagato ottanta onze per redigere nuovi disegni5.
Dai documenti sappiamo che i sei elaborati (oggi scomparsi)6, redatti a Roma dall’architetto e poi consegnati perso-
nalmente al vescovo dietro un pagamento di cento onze, erano quotati con misure espresse in palmi romani, dotati
di leggenda, acquerellati e, dal momento che il progetto si innestava su una preesistente chiesa, contemplavano una
doppia tinta -«Per inteligentia della presente pianta è da notarsi che il color pavonazzo sono Muri vecchi che resta-
no et il color giallo è tutta fabricha nova da farsi»7- e l’impiego del tratteggio per le parti sezionate. Per la commit-
tenza8 il progetto di Torriani -sebbene non del tutto eseguito- intendeva “importare” (e per la prima volta in Sicilia),
gli esiti spaziali e formali raggiunti in S. Ignazio e in S. Andrea della Valle a Roma; a queste architetture celebri della
controriforma si ispireranno poi rispettivamente, la chiesa dei Gesuiti di Siracusa, avviata nel 1647 secondo un costo-
so modello ligneo pervenuto l’anno seguente da Roma, e la cupola della chiesa di S. Maria di Monte Carmelo a
Mazzarino, fabbrica fondata dal principe Giuseppe Branciforte e ultimata nel 1664 con una calotta a sesto rialzato
e con un tamburo ritmato da sedici colonne libere binate. In quest’ultimo caso veniva applicato probabilmente il
37
ECCLESIA TRIUMPHANS
progetto non realizzato di Torriani per la cupola della matrice di Piazza, spiegabile attraverso la circolazione dei dise-
gni dell’architetto nel contesto più immediato. A Mazzarino e a Piazza -così come nella chiesa gesuitica di
Siracusa- risulterebbe infatti coinvolto l’architetto lucchese Francesco Buonamici9, un altro interprete di scuola
romana e di fiducia della Compagnia di Gesù, il cui compito di mediare nuove forme e consolidati linguaggi loca-
li si pone alla base del successo professionale raggiunto in Sicilia (Trapani, Palermo, Siracusa) nella prima metà
del Seicento10.
Una presenza di artefici romani nell’isola, contemporanea al caso di Piazza, è riscontrabile nella vicina Leonforte, una
cittadina feudale edificata a partire dal 1610 dal barone Nicolò Placido Branciforte Lanza11, che stava avviando anche
l’ampliamento della residenza cinquecentesca a Palermo. A quanto sembra12 fu il barone stesso a disegnare l’impian-
to urbano del nuovo centro avvalendosi però della collaborazione di maestri palermitani e romani. Non è un caso,
infatti, che la moderna Leonforte contempli temi e criteri progettuali risultato di una mediazione tra quanto attua-
to in grande scala a Palermo e a Roma: monumentali piazze ovali e rettangolari, attraversate da strade rettilinee;
ampie scalinate (tra le quali risalta scenograficamente quella a rampe multiple e contrapposte) e diverse fontane pub-
bliche. La chiesa madre (1611-1659), realizzata dall’architetto romano, non altrimenti noto, Alberto Bernarini, si
apre su una piazza che risulta tangente, insieme al vicino palazzo baronale, all’imbocco del corso principale posto tra
due porte urbiche -così come a Palermo-, ai limiti dell’abitato.
Nel contesto del primo Seicento -qui delineato attraverso due episodi significativi che al confronto con la coeva pro-
duzione locale appaiono precoci-, le scelte evidenziate possono essere spiegate all’interno di strategie di distinzione e
di autoaffermazione che sembrano connotare il comportamento di alcuni aristocratici e vescovi committenti. In real-
tà, attraverso una diffusione pressoché capillare sull’isola, gli ordini religiosi si affidavano al linguaggio romano delle
sedi centrali per aderire alle esigenze di uniformità e di identità fissate dalla controriforma.
Dalla seconda metà del secolo in poi, la forza di suggestione della capitale del Barocco impone una nuova preferen-
za di gusto e di linguaggio. I primi segnali di questo cambiamento si hanno, infatti, in seno alla produzione degli
stessi ordini. Tuttavia, indipendentemente dalla congregazione di appartenenza, agli architetti religiosi nati in Sicilia
e con un periodo di formazione a Roma veniva assicurata, al ritorno nell’isola, una attività sicura e veloce. Esperienze
evidenti di questa vicenda sono: i progetti del sacerdote-architetto Michele Blasco13 e la folgorante carriera del camil-
liano Giacomo Amato nella capitale, appena rientrato da Roma (1684) e in possesso di una formazione decennale
probabilmente svolta anche presso l’atelier di Carlo Fontana14. La vicenda professionale di Giacomo Amato innescò
«meccanismi di emulazione»15, aprendo e delineando la strada per il successo ad architetti siciliani o attivi nell’isola
Piazza Armerina. Cattedrale, veduta esterna Sciacca. Chiesa madre, veduta esterna
38
ECCLESIA TRIUMPHANS
G. Amato, prospetto della chiesa di S. Teresa alla Kalsa a Palermo, 1698, cm 60 x 94 (GRS)
39
ECCLESIA TRIUMPHANS
quali Giuseppe Mariani, recatosi più volte a Roma, ma soprattutto Tomaso Maria Napoli e Filippo Juvarra, inseriti
attivamente nell’entourage del Cavalier Fontana.
Nella seconda metà del XVII secolo le commissioni “esterne”, con progetti dal linguaggio romano direttamente
redatti in Sicilia attraverso appositi viaggi seguiti da lunghe permanenze o effettuati a distanza da operatori già affer-
mati, si limitano, per quanto finora noto, a un caso tuttavia estremamente significativo, registrando in generale una
certa autonomia da parte della civiltà costruttiva locale nei confronti dell’architettura di Roma. Nel 1686 a Catania,
dopo la devastante eruzione dell’Etna che nel 1669 aveva distrutto la chiesa del monastero di S. Nicolò l’Arena, l’or-
dine dei Benedettini, come riportato dalla storiografia16, convocherà dalla sede di Montecassino l’architetto romano
Giovan Battista Contini per stilare un progetto di ricostruzione. Il cantiere, avviato nel 1687, avrebbe dato luce -ma
con una certa ingerenza da parte della committenza-, a una delle fabbriche religiose più imponenti e suggestive della
Sicilia, risultato di una revisione in chiave barocca della chiesa benedettina di S. Giustina a Padova, edificata nel
Cinquecento17. Nessun documento finora noto ha dato conferma della permanenza dell’architetto romano nell’iso-
la; appare lecito supporre che in realtà il progetto fosse arrivato per corrispondenza, secondo una prassi già seguita
da Contini e da altri suoi colleghi18. Contini era un professionista colto e titolato; insieme a Carlo Fontana e Matthia
De Rossi era stato allievo di Bernini, di cui aveva ereditato cariche (architetto misuratore della Camera Apostolica,
dal 1681) e commissioni; nel 1686 era già accademico di merito (1673) e principe dell’Accademia di San Luca
(1683) e, in quanto tale, insieme a Fontana e De Rossi, era un protagonista dell’insegnamento della disciplina e della
codificazione di un rinnovato classicismo da trasmettere e da diffondere in Europa19 attraverso progetti o disegni
redatti nell’ambito dei concorsi accademici di architettura (dal 1677). Questi ultimi dovevano inoltre rispettare «cri-
teri normalizzati»20, secondo convenzioni grafiche che saranno perfezionate agli inizi del Settecento da Domenico
Martinelli, Francesco Fontana e Filippo Juvarra: proiezioni ortogonali, chiarezza nella grafia e nell’esposizione del
G. Amato, sezione della chiesa di S. Teresa alla Kalsa, 1698, cm 94 x 60 (GRS)
40
ECCLESIA TRIUMPHANS
R. Carapecchia, disegno di progetto per una chiesa basilicale in Sicilia (Londra, Courtauld Institute of Art, Conway Library, Witt Collection 4643, f. 30)
soggetto, uso della grafite, dell’inchiostro e dell’acquerello (generalmente gradazioni di grigio per indicare preesisten-
ze o proiezioni, rosa e giallo per le parti nuove o per le sezioni), ombreggiature a 45° con luce incidente da sinistra, impie-
go di leggende, scale grafiche e scritte illustrative. Le modalità perseguite erano tali da permettere di identificare imme-
diatamente progetti provenienti da Roma o da artefici che nella città avevano seguito il percorso formativo presso
l’Accademia. Ci riferiamo, a esempio, ai disegni di Romano Carapecchia per il rinnovamento della cattedrale di Catania
(due sezioni longitudinali, 1709), prodotti nell’ambito di un concorso indetto dal vescovo Andrea Riggio in seguito alla
necessità di ricostruire la fabbrica dopo il terremoto del 1693, oppure alle tavole di progetto inviate dallo stesso per la
riforma della chiesa dei Cavalieri di Malta a Marsala (pianta, sezione e prospetto, 1715)21. Altri disegni commissionati
per la chiesa dei Teatini di Siracusa (prima metà del XVIII secolo), sono stati elaborati da un architetto proveniente dal-
l’accademia romana e allievo di Carlo Fontana: Nicola Michetti, dal 1732 architetto ufficiale dell’Ordine a Roma22.
Come è stato già osservato (si veda il saggio di Marco Rosario Nobile, infra), questi disegni avrebbero influenzato e ade-
guato ai modi “romani” le abitudini grafiche degli architetti siciliani, anche di quelli di cui non risultano viaggi formati-
vi a Roma; non stupisce, infatti, ritrovare tali convezioni nel progetto di Giovanni Amico per la libreria di San Martino
delle Scale (1733) o di Rosario Gagliardi per la pianta della chiesa di S. Giorgio a Ragusa (1744). All’autopromozione
perseguita dall’accademia romana attraverso i suoi prodotti bisognerebbe poi sommare il successo editoriale registrato in
Europa, così come in Sicilia23, da pubblicazioni relative all’architettura religiosa costruita a Roma dai grandi maestri,
come l’ Insignium Romae Templorum (Roma 1684), i Disegni di vari altari e cappelle (Roma s.d., probabilmente tra 1690-
1691) e il terzo volume di Studio d’Architettura civile dedicato alle chiese (Roma 1721), per capire il livello di diffusione,
intorno ai primi decenni del Settecento, raggiunto da un linguaggio «da esportare»24. Nel decennio successivo, la “risco-
perta” dell’architettura di Francesco Borromini (anticipata già dal fortunato trattato di Andrea Pozzo Perspectiva pictorum
et architectorum, Roma 1693-1700), tanto nella stessa Roma, quanto nell’Europa meridionale, orienterà in Sicilia la ricer-
41
ECCLESIA TRIUMPHANS
ca di autori quali Giovanni Amico (chiesa di S. Oliva ad Alcamo, 1723) o Giuseppe Mariani (SS. Cosma e Damiano ad
Alcamo, 1723), sviluppata, tuttavia, attraverso il filtro di una cultura libresca e incisoria25. Se da un lato gli architetti sici-
liani seguivano attentamente gli sviluppi dell’architettura romana come fonte di ispirazione e di aggiornamento, ma anche
per raggiungere maggiore consenso attraverso soluzioni progettuali alla moda, dall’altro si moltiplicavano nell’isola, e fino
al tardo Settecento, le richieste di progetti autorevoli. L’obiettivo di instaurare rapporti diretti con Roma perseguito dai
livelli più alti della committenza attraverso elaborati dalle firme prestigiose era tale da oltrepassare l’intero ambiente pro-
fessionale siciliano. A una data imprecisata (ma riferibile alla prima parte del pontificato di Clemente XI, 1700-1721) è
da riferire un gruppo di sei disegni acquerellati prodotti da Carlo Fontana per gli arredi lignei della biblioteca di un mona-
stero cappuccino siciliano non ancora identificato26. Nel 1715 Filippo Juvarra, dietro un compenso di quaranta scudi
romani, elaborava a Roma un progetto per l’altare maggiore della chiesa oratoriana di S. Ignazio all’Olivella a Palermo,
di cui oggi sono pervenuti tre disegni preparatori in scala di canne siciliane27. Sebbene il progetto di Juvarra sia stato rea-
lizzato solo in parte, divenne comunque modello per successive opere, come gli altari della chiesa di S. Caterina (1731-
1741) e di S. Chiara (1741-1751) a Palermo, mentre la forma del ciborio fu ripresa dall’architetto Nicolò Palma nel mau-
soleo realizzato in occasione dei solenni funerali del re Filippo V celebrati nel 1747 in cattedrale. Nel 1722 i Padri Teatini
della chiesa di S. Giuseppe (secondo una prassi che sarà seguita dai confratelli di Siracusa) incaricavano l’architetto
Francesco Ferrigno di inviare a Roma il rilievo delle pareti absidali affinché fosse elaborato un nuovo progetto per il rive-
stimento marmoreo. Anche in questo caso l’ipotesi più attendibile sembra essere un diretto coinvolgimento di Nicola
Michetti, come già accennato, al servizio della casa generalizia di S. Andrea della Valle a Roma28. Nel 1728, su richiesta
della Deputazione del Regno, l’architetto Ferdinando Fuga sarà convocato a Palermo per redigere un progetto per la
costruzione di un ponte sul fiume Milicia, presso Altavilla. Nella capitale Fuga riceverà poi ulteriori incarichi per gli inter-
ni del palazzo Butera, per il convento delle Stimmate e per quello di S. Vito, mentre nel 1730 elaborerà per gli Oratoriani
F. Juvarra, progetto per l’altare della chiesa di S. Ignazioall’Olivella a Palermo, 1715 (da C. D’Arpa, 1998)
C. Fontana, progetto per arredi lignei della biblioteca di un monastero cappuc-cino siciliano, primi decenni del XVIII secolo (da Carlo Fontana..., 1977)
42
ECCLESIA TRIUMPHANS
V. Bracci, progetto per la chiesa di S. Nicolò l’Arena a Catania, 1775 (daM.R. Nobile, 2000)
un nuovo progetto per il prospetto della chiesa di S. Ignazio all’Olivella29. Tra il 1727 e il 1728, su iniziativa del vescovo
Tommaso Marini, fu indetto un concorso per la facciata della cattedrale di Siracusa; non è attualmente noto il nome dell’
autore del progetto vincitore, tuttavia, il linguaggio del prospetto suggerirebbe l’ipotesi di elaborati provenienti da Roma
motivata dalla presenza di alcuni temi desunti dall’architettura della città capitolina come la soluzione dell’atrio, l’artico-
lazione con un telaio di colone libere giganti, i dettagli scultorei delle volute e l’idea di incorniciare la statua della santa
entro una grande finestra centrale30. Come è noto, il progetto di Giovan Battista Vaccarini per il prospetto del duomo di
Catania fu al centro di opposizioni da parte dell’ambiente cittadino. L’architetto, conosciuto anche a Roma dove aveva
completato gli studi e dove era entrato in contatto con il cardinale Ottoboni e con Luigi Vanvitelli, si recò nella città papa-
le tra il 1733 e il 1734 per sottoporre al giudizio dell’Accademia di San Luca il modello della sua proposta. L’approvazione
da parte della celebre istituzione, oltre a consentire la prosecuzione del cantiere, rafforzò l’autorità dell’architetto in ambi-
to professionale attraverso l’assegnazione di cariche prestigiose e l’affidamento di importanti commissioni31.
Nella seconda metà del secolo sono registrabili ulteriori casi relativi a progetti per opere siciliane inviati da Roma da
stimate personalità. L’architetto trapanese Francesco Nicoletti, collaboratore di Pietro Passalacqua e accademico di
San Luca, risulta essere l’autore del progetto elaborato tra il 1760 e il 1761 per l’ammodernamento della cappella di
S. Ignazio nella chiesa del Gesù presso Casa Professa a Palermo. Nonostante l’esistenza di un disegno già predispo-
sto da Nicolò Anito, ingegnere della fabbrica, i Gesuiti si affidarono prima al giudizio dell’architetto “romano” e poi,
definitivamente, al relativo controprogetto32.
Si ha notizia che il famoso architetto Luigi Vanvitelli avesse elaborato un disegno di un ciborio per la cattedrale di
Siracusa, commissionato dal vescovo Francesco Testa. A un periodo compreso tra il 1765 e il 1775 risalgono alcuni
grafici di presentazione redatti da Luigi Valadier per altare da destinare al duomo di Monreale. La tavola raffiguran-
te la struttura nella sua interezza è di grande formato (cm 88 x 200); il disegno è realizzato a inchiostro nero e gri-
gio, acquerellato in grigio e bruno su una base preparatoria a grafite e su un fondo in rosa pallido. Il progetto fu
L. Valadier, progetto di altare per il duomo di Monreale, 1765-1775 (daL’oro di Valadier, 1997)
43
ECCLESIA TRIUMPHANS
richiesto ancora dall’arcivescovo Testa tramite il suo agente romano, Monsignor Pietro Antonio Tioli33. In entram-
bi i casi questi progetti per arredi ecclesiastici erano considerati opere magnifiche in quanto doppiamente pregiate,
per disegno e per materiali adottati. L’eleganza delle soluzioni proposte e il prestigio delle personalità artistiche coin-
volte accrescevano di riflesso l’autorità della committenza.
Nella seconda metà del secolo sembra nuovamente l’ordine dei Benedettini a richiedere progetti dal linguaggio romano.
L’architetto Carlo Marchionni verrà convocato nel 1763 per elaborare una soluzione per la chiesa della Maddalena a
Messina, mentre nel 1775 sarà uno dei protagonisti, insieme ad altri architetti romani come Francesco Navone, Andrea
Vici e Virgilio Bracci, nell’ambito del concorso indetto dai Padri Benedettini di Catania per la nuova facciata della chie-
sa del monastero di S. Nicola L’Arena34. Anche il lungo cantiere della matrice di Piazza sembra concludersi, negli anni
settanta del Settecento, con la scelta di un progetto romano inviato per corrispondenza dall’architetto Nicola Giansimoni
per l’impiombatura della cupola, al centro di una nuova consulta. Il progetto verrà poi scartato dagli architetti Francesco
Battaglia e Salvatore Attinelli perché giudicato “teorico” e irrealizzabile per il caso di Piazza, sebbene Giansimoni avesse
elaborato una tavola (cm 37,7 x 26) completa di pianta, sezione e prospetto della cupola con misure espresse sia in palmi
romani che in palmi siciliani35. Nel 1760 anche l’architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia, rientrato a Palermo da Roma
e fregiato dalla vincita del secondo premio del concorso clementino del 1758, aveva prodotto elaborati dotati di doppia
scala metrica per il rinnovamento dell’area presbiteriale della chiesa di S. Ignazio per conto dei Padri Oratoriani che, come
visto in più occasioni, erano soliti affidare al linguaggio romano ogni nuova opera intrapresa36. In questo caso, oltre le
affinità riscontrate tra il progetto palermitano e la proposta vincitrice del concorso clementino, l’episodio appare signifi-
cativo per comprendere il “segno” impresso sugli architetti siciliani -e soprattutto sui disegni di progetto elaborati dagli
stessi- da un’esperienza formativa compiuta a Roma.
N. Giansimoni, progetto per l’impiombatura della cupola della chiesa madre di Piazza, 1770 (ASDPA)
44
ECCLESIA TRIUMPHANS
NOTE1 M. GIUFFRÈ, La Sicilia, in Storia dell’ar-chitettura italiana. Il Seicento, a cura di A.Scotti Tosini, voll. 2, Milano 2003, II, pp.560-573.2 «Si voli issu testaturi chi si mandinu achiamari architeturi periti pratici et valen-thomini in tali professioni undi li predictiarchitetturi si troviranu per tutti li parti etlochi dillu mundu». Testamento del BaroneMarco Trigona, Piazza Armerina 1930,LXXV, pp. 58-59.3 Per approfondimenti e per i documentirelativi alla permanenza di Orazio Torrianiin Sicilia si rimanda a D. SUTERA, OrazioTorriani in Sicilia, in «Palladio», 43, 2009,pp. 5-24. Per la vicenda della ricostruzionedella chiesa madre di Piazza si veda: ID.,La chiesa madre di Piazza Armerina. Dalla
riforma cinquecentesca al progetto di Orazio
Torriani, Caltanissetta 2009, in corso distampa.4 Archivio Storico Diocesano di PiazzaArmerina (ASDPA), Fondo CollegiataChiesa Madre, Costituzioni e stabilimenti diMonsignor Don Innocenzo Massimi Vescovo
di Catania nell’anno 1627, 15-4-6 (incorso di inventariazione), ff. 366-367.5 Ivi, Archivio I, Mandati, n. corda 60, f.106 r.6 «pianta principale di tutta la chiesa, cap-pelle e choro, con le sue misure distinta-mente poste, segue il disegno del spaccatodi dentro, per l’alzata delle cappelle, pila-stri, e disegno della cuppola per di dentro,segue il disegno della facciata d’innanzi,ombreggiato d’acquarello, con l’alzato edisegno della cuppola di fuori, segue ildisegno fatto a parte d’un altare che ande-rà nella Croce di detta chiesa, colorito dimischio, con diversi modani per potere ilscarpellino lavorare le basi, et cornicioni».Ivi, n. corda 62, f. 101 r. 7 Ivi, Discorso sopra la Pianta della Madre
Chiesa della Città di Piazza in Sicilia fatta
da Horatio Torriani Ingeniero et Archi. to
Romano di sua Maestà in Roma, stanza II,Misc. 1-5-3, ff. s.n.8 La nomina di Torriani per la matrice diPiazza non era stata comunque una sceltacasuale. Si trattava di un consulente pre-scelto da committenze religiose come iBenedettini, gli Agostiniani e i Gesuiti,mentre la partecipazione al “concorso ainviti” per S. Pietro, nel 1607, e come
perito esterno nella “competizione consul-tiva” per la chiesa gesuitica di S. Ignazioannessa al Collegio Romano, nell’aprile1627 (pochi mesi prima della convocazio-ne in Sicilia), attestavano una particolarecompetenza nella progettazione e valuta-zione di nuovi impianti chiesastici. Il giu-dizio del vescovo sull’impianto proposto,infatti, così continuava: «cavato dallaforma delle più belle chiese che siano statefatte in Roma». D. SUTERA, Orazio
Torriani in…, cit., p. 9.9 Buonamici fu a capo del cantiere diPiazza a partire dal 1635.10 M.R. NOBILE, Buonamici e la Sicilia, inArchitettura nella storia, Scritti in onore diA. Gambardella, a cura di G. Cantone, L.Marcucci, E. Manzo, voll. 2, Milano2007, I, pp. 261-268.11 Fino al 1639 aveva avuto in tutela, inqualità di zio, il già citato GiuseppeBranciforte, principe di Mazzarino. Siveda A. D’ ALEO, Mazzarino e la sua storia,San Cataldo (CL) 1991, pp. 24-30. Perapprofondimenti: S. PIAZZA, Dimore feu-dali in Sicilia fra Seicento e Settecento,Palermo 2005, pp. 19-21.12 G. MAZZOLA, Notizie storiche sulla vetu-sta Tavaca e sulla moderna Leonforte,[Nicosia 1924], Leonforte 1990; D.LIGRESTI, Sul tema delle colonizzazioni inSicilia nell’età moderna. Una perizia del
Seicento sulla costruzione di Leonforte, in«Archivio Storico per la Sicilia Orientale»,fasc. II-III, Catania 1974, pp. 377-383.13 Blasco vantava un apprendistato roma-no da pittore. All’architetto sono attribui-ti i progetti per la facciata della matrice diSciacca (1656, su indicazione dello stesso,il modello di riferimento doveva essere lachiesa teatina di S. Andrea della Valle aRoma), per la chiesa della Compagnia diGesù nella stessa città (1668, dove ilmodello di S. Andrea della Valle vieneespressamente citato per i pilastri dellachiesa) e per le cupole dipinte nella catte-drale di Agrigento e in S. Ignazioall’Olivella a Palermo (1682-1683). SuMichele Blasco si rinvia a: C. D’ARPA,Committenza oratoriana a Palermo. La
chiesa di Sant’Ignazio Martire all’Olivella,
la casa della Congregazione e l’oratorio di
San Filippo Neri, tesi di dottorato in“Storia dell’Architettura e Conservazionedei Beni Architettonici” (X ciclo), tutors
A. Samonà, G. Ciotta, C. Conforti,Università degli Studi di Palermo 1997,pp. 175-177; M.R. BURGIO, Il complessogesuitico di Sciacca, Sciacca 1998; L.NICOLOSI, La chiesa madre di Sciacca: ilprogetto di Michele Blasco e il cantiere del
XVII secolo, in «Lexicon. Storie e architet-ture in Sicilia», 7, 2008, pp. 66-69. SuGiacomo Amato: M.S. TUSA, Architetturabarocca a Palermo. Prospetti chiesastici di
Giacomo Amato architetto, Siracusa 1992.14 Si veda in proposito M.R. NOBILE,Progetti di Carlo Fontana nei disegni di
Giacomo Amato a Palermo, in «Il disegnodi architettura», 20, 1999, pp. 38-40.15 Ivi, p. 39.16 F. BERTUCCI, Guida del Monastero dei
PP. Benedettini di Catania, Catania 1846;M. GAUDIOSO, L’Abbazia di San Nicolòl’Arena di Catania, in «Archivio Storicoper la Sicilia Orientale», s. II, a. V, fasc. II-III, 1930, pp. 199-243; V. LIBRANDO,Notizie storiche sul monastero di San Nicolò
la Rena di Catania, in Quattro progetti peril monastero di S. Nicolò L’Arena, Catania1988.17 R. BÖSEL, Typus und Tradition in derBaukultur gegenreformatorischer Orden, in«Römische Historische Mittelungen», 31,1989, pp. 239-253.18 Per una ricerca archivistica più aggior-nata sul progetto di Contini per la chiesadi S. Nicolò l’Arena a Catania si veda E.GUIDOBONI, C. CIUCCARELLI, D.MARIOTTI, La ricerca documentaria, inCatania. Terremoti e lave dal mndo antico
alla fine del Novecento, Istituto Nazionaledi Geofisica e Vulcanologia, «SGA StoriaGeofisica Ambiente», a cura di E. Boschi,E. Guidoboni, Roma-Bologna 2001, pp.300-301. Nel 1686 Contini inviava inSpagna anche un progetto per il campani-le della cattedrale di Saragozza. Su GiovanBattista Contini si rimanda alle informa-zioni bio-bibliografiche elaborate daSimonetta Pascucci nel volume In urbearchitectus. Modelli Disegni Misure. La pro-
fessione dell’architetto, Roma 1680-1750, acura di B. Contardi, G. Curcio, Roma1991, ad vocem.19 G. CURCIO, La città degli architetti, ivi,pp. 143-153.20 Ivi, p. 146. Si veda anche E. KIEVEN, Ildisegno architettonico come mezzo di comu-
nicazione tra committente e architetto, ivi,
45
ECCLESIA TRIUMPHANS
pp. 76-77.21 I disegni relativi al duomo di Cataniasono conservati presso il CourtauldMuseum di Londra. Si veda M.R. NOBILE,I volti della “sposa”. Le facciate chiesastichedella Chiese Madri nella Sicila del Settecento,Palermo 2000, p. 33. Per approfondimen-ti sulla vicenda della ricostruzione dellafabbrica dopo il sisma e sulla bibliografiarelativa si rimanda anche a: S. CALOGERO,La ricostruzione della cattedrale di Catania
dopo il terremoto del 1693, in «Synaxis»,XXII, 1, 2004, pp. 113-148. Per i disegniinviati a Marsala si veda la scheda di MarcoRosario Nobile, infra.22 Per approfondimenti si rimanda allascheda di Marco Rosario Nobile, infra.23 Sul tema si rinvia a D. SUTERA, Teoria earchitettura nell’Italia d’ età barocca, in Labiblioteca dell’architetto. Libri e incisioni
(XVI-XVIII secolo) custoditi nella Biblioteca
Centrale della Regione Siciliana, catalogodella mostra (Palermo 2007) a cura diM.S. Di Fede e F. Scaduto, Palermo 2007,pp. 89-94.24 J. PINTO, Architettura da esportare, inStoria dell’architettura italiana. Il
Settecento, a cura di G. Curcio, E. Kieven,voll. 2, Milano 2000, I, pp. 110-133. 25 D. SUTERA, Teoria e architettura…, cit.,p. 91.26 Carlo Fontana. The Drawings at Windsor
contributo di S. BOSCARINO, Vaccariniarchitetto, Catania 1992.32 F. SALVO S.J., Francesco Nicoletti, unarchitetto siciliano a Roma, in L’architetturadel Settecento in Sicilia, atti del Seminario(Palermo 1989) a cura di M. Giuffrè,Palermo 1997, pp. 173-177, 392-393. Siveda anche M.C. RUGGIERI TRICOLI,Costruire Gerusalemme. Il complesso gesuiti-
co della Casa Professa di Palermo dalla sto-
ria al museo, Milano 2001, pp. 150, 250.33 Per approfondimenti si rimanda al volu-me L’oro di Valadier. Un genio nella Romadel Settecento, a cura di A. González-Palacios, Roma 1997, pp. 156-163. M.R.NOBILE, I volti della “sposa”…, cit., pp. 21,30 nota 6.34 Ivi, p. 114.35 Il disegno è oggi custodito pressol’ASDPA, Fondo Collegiata Chiesa Madre,stanza II, Misc., Lavori in chiesa madre sec.XVIII e XIX, 1-5-17, ff. s.n. Per approfon-dimenti si veda: D. SUTERA, Il “progetto” diNicola Giansimoni per l’impiombatura
della cupola della chiesa madre di Piazza, inLa Madonna delle Vittorie a Piazza
Armerina. Dal Gran Conte Ruggero al
Settecento, catalogo della mostra (PiazzaArmerina, 2009), Napoli 2009, in corso distampa.36 C. D’ARPA, Committenza oratoria-na…, cit., pp. 253-269.
Castle, by A. Braham and H. Hager,London 1977, pp. 200-201. 27 I tre schizzi autografi di Juvarra sonocustoditi presso la Biblioteca NazionaleUniversitaria di Torino. C. D’ARPA,Committenza oratoriana…, cit., pp. 239-243; ID., Un progetto di Filippo Juvarra perun altare a Palermo, in «Il disegno di archi-tettura», 18, 1998, pp. 47-49.28 Sulla vicenda si rinvia al contributo di S.PIAZZA, Le scelte architettoniche dei Teatinia Palermo: il cantiere della chiesa di S.
Giuseppe in «Regnum Dei-CollectaneaTheatina», 49, Roma 2003, pp. 251-264.29 Nel 1767 l’architetto ormai famoso tor-nerà una seconda volta a Palermo per ela-borare un drastico progetto di riformadella cattedrale, ispirato a un severo classi-cismo romano. M. GIUFFRÈ, E.H. NEIL,M.R. NOBILE, Dal viceregno al regno. LaSicilia, in Storia dell’architettura italiana. IlSettecento, cit., I, p. 321. Per gli interventidi Fuga in Sicilia si rimanda inoltre ai saggispecifici contenuti in: Ferdinando Fuga.1699-1999 Roma, Napoli, Palermo, a curadi A. Gambardella, Napoli 2001.30 M. GIUFFRÈ, E.H. NEIL, M.R. NOBILE,Dal viceregno al regno…, cit., p. 325;M.R. NOBILE, I volti della “sposa”…, cit.,pp. 19-31.31 Ivi, pp. 33-51, 131 e segg. Sull’attivitàdi Giovan Battista Vaccarini si rimanda al