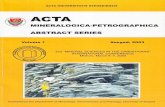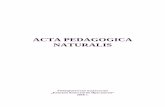Modelli grafici e testuali di P.Berol. 8877 (Acta Isidori)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Modelli grafici e testuali di P.Berol. 8877 (Acta Isidori)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINADipartimento di Civiltà Antiche e Moderne
ACCADEMIA FIORENTINA DI PAPIROLOGIA E DI STUDI SUL MONDO ANTICO
ANALECTA PAPYROLOGICA
diretti daRosario Pintaudi
condirettoreDiletta Minutoli
comitato scientificoAlain Delattre
Lucio Del CorsoHermann Harrauer
Antonio López GarcíaGabriella Messeri Savorelli
Paola PrunetiPaola Radici ColaceDominic RathboneAntonino Zumbo
segretaria di redazioneMaria Teresa Fontana
in copertina:PSI IX 1092 – Callimaco: Chioma di Berenice
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana
ISSN 1122-2336
© 2013, SICANIA by GEM s.r.l.Via Catania 62, 98124 [email protected]
Tutti i diritti sono riservati dall’Editore.È vietata la riproduzione, anche parziale, dell’opera.
MODELLI GRAFICI E TESTUALI DI P. BEROL. 8877(ACTA ISIDORI)
Il gruppo di papiri conosciuto sotto il nome di Acta Martyrum Alexandrinorum non è mai stato studiato dal punto di vista bibliologico e grafico, né come fenomeno unitario, né dal punto di vista dei singoli epi-sodi librari che lo costituiscono, nonostante fornisca abbondante materia di riflessione sulla circolazione libraria, prassi di lettura, e più in generale sui moduli grafici e librari dell’antichità. In attesa di uno studio comples-sivo di questi materiali e delle prassi scrittorie che li hanno prodotti, ci si occuperà, in questo contributo, di un papiro in particolare, P. Berol. 8877, che presenta interessanti spunti di analisi e di approfondimento dal punto di vista paleografico e di disposizione testuale. Fornisco di seguito, prima di approfondirne gli aspetti precipui, i dati necessari alla collocazione del papiro nell’ambito degli studi.
P. Berol. 88771
Editio Princeps: W.G. uxkull-GyllenbAnd, Ein neues Bruchstück aus den sogenamnten heidnischen Märtyrerakten, Sitzungberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, XXVIII, 1930, pp. 664-79.
Riedizioni: Musurillo54 IVc, CPJ II 156c, Musurillo61 IVc.Bibliografia: h. Musurillo, The Acts of the Pagan Martyrs, Oxford
1954; Acta Alexandrinorum, edidit h. Musurillo, Lipsiae 1961; A. bAuer, Heidnische Märtyrakten, «APF» 1 (1901), pp. 29-47; A. nePPi ModonA, Il nuovo frammento berlinese degli “Atti dei Martiri Alessandrini” (p. 8877), «Aegyptus» 12 (1932), pp. 17-24; A.J. hArker, Loyalty and Dissidence in Roman Egypt: the Case of Acta Alexandrinorum, Cambridge 2008.
Repertori: MP³ 2220, LDAB 33.
1 Si fornisce qui, per la prima volta, l’immagine a colori del papiro. Ringrazio G. Poethke e F. Reiter che l’hanno gentilmente fornita, nonché la Papyrussammlung dei musei nazionali di Berlino che è la proprietaria dei diritti di riproduzione.
270 ADRIANO MAGNANI
Riproduzione fotografica:
Descrizione:
Frammento di papiro largo cm 11 ed alto 12 con testo dell’Actum sul verso; il recto contiene conti non meglio specificati (fattura2). Il papiro si pre-
2 W.G. uxkull-GyllenbAnd, Ein neues Bruchstück aus den sogenannten heid-nischen Märtyrerakten, Sitzungberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, XXVIII, 1930, p. 664; la descrizione dell’editore princeps, particolarmente dal punto di vista paleografico, è superata. Il papiro, dopo un periodo di irreperibilità (di cui dà notizia: h.
Modelli grafici e testuali di P. Berol. 8877 (Acta Isidori) 271
senta tagliato abbastanza nettamente in forma quadrata: l’editore lo ha data-to alla fine del II d.C. inizio III, e questa datazione ha trovato concordi gli studiosi. Il frammento ci restituisce resti di due colonne di scrittura contigue separate da un intercolunnio di circa due centimetri: è conservato il margine superiore, mentre il testo è mutilo sugli altri tre lati: il supporto scrittorio ap-pare di discreta qualità. Al centro del documento sono presenti due grosse lacune incolonnate: la superiore, più estesa, turba buona parte della sezione di sinistra della seconda colonna. La parte sinistra del foglio di papiro presenta una striscia uniforme di colore più scuro rispetto al resto: si tratta, forse, di una kollesis ed in questa direzione ci spingerebbero anche i deterioramenti del supporto alla sua destra. Il testo, che corre contro le fibre, è vergato in una scrittura nitida e di agevole lettura, che cerca di imitare le librarie coeve3, ver-gata con un calamo sottile. Si tratterebbe di una mano allenata nella scrittura di documenti di cancelleria4 (e vedremo come anche questo fattore ha in questa sede la sua importanza): l’andamento è veloce, talvolta compresso (II, 13), le legature sono assai frequenti. Notevoli, per il loro modulo grande: A, D, K, L, N, R, «, U, F, W. Tuttavia ciò che è particolarmente degno di nota in questo documento è la particolare disposizione del testo: le battute dei differenti per-sonaggi del dialogo vengono introdotte dai rispettivi nomi al caso nominativo con sensibile rientro rispetto al profilo sinistro della colonna, separato da ciò che precede e segue da interlinee di maggiore ampiezza: i nomi sono poi incor-niciati da coppie sovrapposte di trattini orizzontali o ondulati.
Trascrizione:
Col. I º»inarca (o| dei%na)?º ºetai o$ti a\po a"ºllo ti nu%n 5 º .eto
Musurillo, The Acts of the Pagan Martyrs, Oxford 1954, p. 118) dovuto alle vicende belli-che, è oggi normalmente consultabile presso la Papyrussammlung di Berlino.
3 uxkull-GyllenbAnd, Ein neues Bruchstück..., cit., p. 664.4 G. Messeri-r. PintAudi, Documenti e scritture, in Scrivere libri e documenti nel
mondo antico, Firenze 1998, (Papyrologica Florentina XXX), pp. 35-53; G. cAvAllo, La scrittura greca e latina dei papiri, Pisa 2008, pp. 85 ss.
272 ADRIANO MAGNANI
(o| dei%na)?º º .ai» gena- ºrª+º» ekate- ºn fa»in 10 º au\tou% poélei eºi\»eklhéqh»an º a\poé tino» º e"qno» toè }Alexaºndreéwn 15 tºelou%»i tou - eilºkuéka»i §/ Pºo»eidw%ni º ..ª – – – – –
Col. II -% }I»iédwro» -% kªalaèº leégei, kuérie «eba»teé, Bªaélbillo», ªperiè tºw%n »w%n pragmaétwn. tªou\nantiéon ª»oiè deé,º vac. }Agriéppa, proè» a£ ei\»hªgei% periè }Iou- 5 ªdaiéwnº a\\ntikata»thé»omai. vac. e\nkªalw% au\toi%» ªo$ti kºaiè o$lhn thèn oi\koumeénhn ªe\piceirou%»in ªtara麻»ein. vac. dei% deè toè kat} e$kaª»ton ±7 º ªkrinºei%ªnº toèn o"clon. ou"k ei\»in }Alªexandreu%»in o|moiopaqei%», troép§ deè Ai\guptªiéwn o|moi%oi 10 ou"k ei\»i‹n› i"»oi toi%» toén foéron telªou%»i; ±7 º -% }Agriéppa» -% ªAi\ºgªupºtiéoi» e"»th»an foérou» ªoºi| a"rcªonte» ª..º.ª.º.ª...ºn: touétoi» deè ou\deié». -% Bªaélºbillo» -% 15 i"de e\piè pªhliéºkhn toélmhn h! o\ qeªoè» au\tou% h! – – – – –
Col. II, 1: i=»idwro»; 10: i=»oi; 13: oudei=»;
Traduzione:Col. II---] Isidoro: “signore Augusto, [Balbillo] dice cose [giuste] circa que-
sti affari. [Per quanto ti riguarda, invece], Agrippa, controbatterò alle cose
Modelli grafici e testuali di P. Berol. 8877 (Acta Isidori) 273
che affermi [circa i Giudei]. Li accuso di [voler] sconvolgere l’intero uni-verso. È necessario [giudicare] di tutta (quella) folla considerando caso per caso. Non hanno comportamento simile agli Alessandrini: in questo sono [simili] piuttosto agli Egiziani. Non sono forse simili quelli che pagano il tributo (pro-capite)?
Agrippa: “i governanti imposero tributi agli Egiziani [---] invece a questi (i Giudei) nessuno (li impose)”
Balbillo: “guarda a quale insolenza o il [loro] dio [ o ---
Commento:Le integrazioni e correzioni al testo, laddove non specificato altrimenti, risalgono
all’editore p.Col. II3: tªounantion integrazione di C.H. Roberts: vedi h. Musurillo, The Acts of the
Pagan Martyrs, Oxford 1954, p. VI; v.A. tcherikover-A. fuks, Corpus Papyrorum Ju-daicarum, Cambridge 1957, II, p. 61.
8: L’editore p. legge ª»kopºeiªnº; parenta ... ªkrinºeiªnº è integrazione di: CPJ, p. 79.
Scopo del presente studio vuole essere l’individuazione di particolari moduli grafici testimoniati da questo papiro, ed una conseguente indagine, laddove possibile, sulle pratiche di lettura ad esso connesse. Il papiro berli-nese, e per raffronto gli altri degli Acta Isidori, deve esser preso in conside-razione quindi da due punti di vista differenti: dal punto di vista strutturale interno e da quello bibliologico e materiale. Dalla sovrapposizione di que-sti due punti di vista scaturiranno delle considerazioni che forse getteranno ulteriore luce sullo statuto letterario e comunicativo di questo particolare gruppo di papiri.
Il papiro berlinese e gli altri papiri degli Acta Isidori
Il testo in questione ci restituisce un dialogo5 tra più personaggi (quat-tro almeno) di accertata esistenza storica; lo statuto di questo testo è stato oggetto di ampi dibattiti nella critica, ma per quel che ci serve in questa sede ci limiteremo a dire che si tratta, con ogni probabilità, di libellisti-ca politica di produzione alessandrina, proveniente dal ginnasio6, con alla
5 Per le seguenti riflessioni ho tenuto conto di: J. Andrieu, Le dialogue antique: structure et présentation, Paris 1954.
6 J. delorMe, Gymnasion. Etude sur les monuments consacrés à l’éducation en Grèce,
274 ADRIANO MAGNANI
base una effettiva conoscenza7 degli atti processuali che videro protagonisti i personaggi in questione8, produzione paraletteraria che seguiva canali al-ternativi di diffusione libraria, cioè ristretta in precise cerchie intellettuali e politiche9.
Il dialogo si svolge all’interno di una cornice storico-narrativa a carat-tere giudiziario: ci troveremmo d’innanzi ad un caso di cognitio extraordi-naria10 riservata all’imperatore attorniato dalla sua corte.
Ma è la particolarità della disposizione grafica delle battute dei per-sonaggi – introdotte, come si è detto, dal nome al nominativo, posto al
Paris 1960; h.i. MArrou, Storia dell’educazione nell’antichità, ed. it. Roma 1994, pp. 143 ss.; M. rostovzev, Storia economica e sociale del mondo ellenistico, vol. III, Firenze 1973, pp. 138-156; W.v. hArris, Lettura e istruzione nel mondo antico, ed.it. Bari 1991, pp. 152-166; A. lukAszeWicz, Les édifices publics dans les villes de l’Egypte romaine, Warszawa 1986, pp. 58-60; M. kleiJWeGt, Ancient Youth, Amsterdam 1991, pp. 247 ss.; f. burkhAlter, Le Gymnase d’Alexandrie: Centre administratif de la Province Romaine d’Egypte, «BCH» 116 (1992), 1, pp. 345-373; con particolare attenzione alla documentazione papirologica: M. hAMdi ibrAhiM, L’éducation gréco-romaine en Egypte di I au IV siècle de notre ère, d’après les papyrus, (in neogreco con riassunto parziale in francese) Athènes 1972, «AQHNA», (Suggramma periodikon thV en AqhnaiV episthmonikhV etaireiaV 13), pp. 239 ss.; P. GAuthier, Notes sur le rôle du gymnase dans les cités hellénistiques, in Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus, Kolloquium, München, 24. bis 26. Juni 1993, herausgegeben von M. Wörrle und P. zAnker, München 1995, pp. 1-11; b. leGrAs, Néotês, recherches sur les jeunes grecs dans l’Egypte Ptolémaïque et romaine, (Hautes études du monde gréco-romain 26), Genève 1999.
7 Sulla probabile genesi di questi testi vedi: s. ronchey, Les procès – verbaux des martyres chrétiens dans les Acta Martyrum et leur fortune, «MEFRA» 112 (2000), pp. 723-752.
8 Mi permetto di rinviare al mio volume: A. MAGnAni, Il processo di Isidoro. Roma e Alessandria nel primo secolo, Napoli 2009, pp. 41 ss.
9 Sulla paraletteratura rinvio alle utili considerazioni generali dell’Introduzione e nelle prime pagine di: d. couéGnAs, Paraletteratura, ed.it. Firenze 1997; vedi inoltre: d. del corno, La letteratura popolare nei papiri, in Proceedings of the xIV International Congress of Papyrologists, Oxford, 24-31 July 1974, (Greco-Roman memoirs 61) London 1975, pp. 79-84; d. henniG, Zu neuveröffentlichten Bruchstücken der “Acta Alexandrinorum”, «Chiron» 5 (1975), pp. 317 ss.; su questa letteratura underground e sulla sua diffusione si legga: h. niederMeyer, Über die antike Protokoll-Literatur, Diss. Göttingen 1918, pp. 54 ss.; r.J. stArr, The circulation of Literary Texts in the Roman World, «CQ» 37 (1987), pp. 213-23; n. leWis, La memoire des sables, Paris 1988, p. 193; c. sAlles, La lettura nella Roma antica, ed. it. Milano 2004, pp. 145 ss.
10 P. de frAncisci, Sintesi storica del Diritto Romano, Roma 1968, pp. 494-503; i. buti, La “Cognitio extra ordinem” da Augusto a Diocleziano, «ANRW», II 14 (1982), pp. 29-59; J.G. Wolf, Claudius Judex, in Die Regierungszeit des Kaisers Klaudius (41-54 n. Chr.), Internationales Interdisziplinäres Symposion aus Anlaß des hundertjäringen Jubiläums des Archäologischen Instituts der Universitat Freiburg i. Br., 16-18 Februar 1991, herausgegeben von v. M. strockA, Mainz 1994, pp. 148-155.
Modelli grafici e testuali di P. Berol. 8877 (Acta Isidori) 275
centro della colonna e circondato da un’ornamentazione grafica compo-sta da un piccolo tratto convesso sovrapposto ad uno orizzontale di pari lunghezza11 – che colpisce immediatamente. In altre parole, come si potrà evincere dalla semplice lettura del testo, le parti dialoganti sono in comu-nicazione tra loro, almeno in questa edizione dell’Actum, grazie ad espe-dienti tecnici particolari che evidenziano al massimo i nomi degli inter-locutori ponendoli al centro della colonna e dotandoli di segni riempitivi probabilmente orientati ad attrarre l’attenzione del lettore. Siamo quindi al di fuori, tanto graficamente quanto testualmente, dal modo “tradizio-nale” di rappresentazione grafica del “dialogo”. All’interno del testo sono assenti, infatti, intercalari come e"fh ed ei&pen, che nei dialogici testi greci (e latini) servono a sottolineare il cambio di personaggio, che qui è affidato, quindi, esclusivamente ad espedienti grafici.
Messa in evidenza questa particolarità del papiro berlinese è opportu-no notare che gli altri papiri che riportano squarci del processo del ginna-siarca Isidoro d’innanzi all’imperatore Claudio, presentano strutture grafi-che interessanti ed assimilabili, almeno in parte, a quelli che vediamo qui in opera. Osserviamoli nello specifico: P. Brit. Lib. 278512 presenta il dialogo con i nomi dei personaggi ai quali vengono attribuite le battute all’interno del corpo del testo in caso nominativo. Questi nomi, che nel papiro berli-nese sono posti graficamente in sì bella evidenza, sono in questo caso posti all’interno del testo. Diamone un breve saggio:
Klauédio»º Kai%»ar: meriézw »oi thèn h|- meéran. »unepeéneu»aºn kaiè oi| »unkaqhémenoi 10 paénte» »unklhtikoi,èº ei\doéte» oi/oé» e\»tin a\nhèr o| I\»iédwro». Klauédiºo» Kai%»ar: mhdeèn u|peèr qe- ouè» kataè tou% e\mou%º fiélou ei"p+»:13
Stesso discorso a proposito dell’altro papiro che ci riporta gli atti del
11 r. bArbis luPi, Uso e forma dei segni di riempimento nei papiri letterari greci, in Proceedings of the xIx International Congress of Papyrology, Cairo 2-9 September 1989, General Editor A.H.S. El-Mosalamy, Cairo 1992, pp. 503-510.
12 Editio Princeps: h.i. bell, A new fragment of the Acta Isidori, «APF» 10 (1932), pp. 5-17; riedizioni: Musurillo54 IVb, CPJ II 156b, Musurillo61 IVb; repertori: MP³ 2221, LDAB 0041.
13 Traduzione: [Claudio] Cesare: “Ti concedo questo giorno”. [Tutti i senatori] che sedevano in qualità di assessori, [acconsentirono], sapendo che genere d’uomo fosse [Isidoro. Claudio] Cesare: “Per gli [dei! Che tu non abbia] a dir nulla [contro il mio] amico.
276 ADRIANO MAGNANI
processo di Isidoro: P. Cairo Inv. 1044814. In questo testimone, oltre ai nomi al nominativo posti all’interno del corpo del testo, notiamo l’uso di piccoli spazi vuoti che sono di uso tutt’altro che infrequente nei manoscrit-ti e dei papiri antichi (particolarmente in Aristofane ad esempio15), solita-mente, ma non sempre, per sottolineare i cambi di interlocutore. Sarebbe interessante chiedersi se, dietro questa apparente ridondanza di espedienti, si nasconda un qualche resto di due pratiche di messa in evidenza dei per-sonaggi confluite nello stesso testo inavvertitamente o per quiescenza di trasmissione. Diamone anche qui piccolo saggio:
Klaºuédio» Kai%»ar: ªpolºloué» mou fiélou» a\peékteina», }I»iédwre 5 ª}I»iºédwro»: ba»ileéw» h"kou»a tou% toéte ªe\pºitaéxanto». kaiè »uè leége tiéno» qeélei» ªkaºthgorhé»èw é. Klauédio» Kai%»ar: vac. a\»falw%» ªe\ºk mou»ikh%» ei&,}I»iédwre vac. }I»iédwro»: vac.16
W. Chrest. 1417 è in parte sovrapponibile al papiro Brit. Lib. 2785 e presenta lo stesso tipo di struttura dialogica, quindi di più non se ne dirà.
Come si vede, sullo stesso episodio del processo di Isidoro abbiamo quattro papiri con tre soluzioni di disposizione testuale differenti tra loro (ma anche diverse tipologie di qualità e di utilizzazione del supporto scrit-torio), il che ci dà un primo saggio sulla variabilità di soluzioni grafico-testuali presentate da questo tipo di testo. Un punto in comune, tuttavia, sembra già potersi desumere dal raffronto tra questi documenti: in un modo o nell’altro esistevano, all’interno e all’esterno del testo, espedienti atti ad evidenziare e ben definire, nel dialogo, i ruoli e le parole da attribu-irsi ad ogni personaggio.
14 Editio Princeps: t. reinAch, L’Empereur Claude et les antisémites Alexandrins d’après un noveau Papyrus, «REJ» XXXI, 62 (1895), pp. 161-178; XXXII, 63 (1896), p. 160; riedizioni: Musurillo54 IVa, CPJ II 156d, Musurillo61 Iva; repertori: MP³ 2219, LDAB 0030.
15 J.c.b. loWe, The Manuscript Evidence for Changes of Speaker in Aristophanes, «BICS» 9 (1962), pp. 27-42.
16 Traduzione: Claudio Cesare: “Isidoro, hai ucciso molti miei amici”. Isidoro: “Ho obbedito all’imperatore che allora mi comandava. Anche tu fa’ il nome di chi vuoi, e io l’accuserò”. Claudio Cesare: “sei davvero un figlio di una ballerina, Isidoro”. Isidoro…
17 Editio Princeps: u. Wilcken, Alexandrinische Gesandtschaften vor Kaiser Claudius, «Hermes» 30 (1895), pp. 481-498; riedizioni: BGU I 511, Musurillo54 IVa, CPJ II 156a, Musurillo61 IVa; repertori: MP³ 2219, LDAB 0030.
Modelli grafici e testuali di P. Berol. 8877 (Acta Isidori) 277
Da quali moduli grafici deriva la disposizione testuale di questo papiro?
1) Protocolli giudiziariLe ipotesi che possono essere prese in considerazione per rispondere
a questa domanda sono numerose: cercheremo di passarle in rassegna par-tendo dalle implicazioni dovute al testo trasmesso dal papiro e allargando progressivamente l’orizzonte ad altre influenze.
La prima ipotesi quindi da prendere in considerazione è che il papiro risenta, nella sua disposizione grafica, di influenze derivate dalla struttura testuale dei protocolli processuali. Il dibattimento processuale, lo scambio di battute, nella sua prassi generale, prevede l’uso dell’oratio recta e di una serie di accorgimenti testuali atti a riprodurre nel testo l’andamento dia-logico del processo. Inoltre, anche se lo studio del Coles18 richiederebbe un aggiornamento del materiale preso in esame, possiamo affermare che il processo in periodo imperiale, veniva protocollato secondo uno sche-ma abbastanza fisso: formule introduttive, elenco e carica dei partecipanti, luogo del processo, descrizione dei parlanti, verbi introduttori (con predi-lezione per il genitivo assoluto), uso degli intercalari (ei&pen ed a\pokriénw in differenti forme), passaggi narrativi intermedi, krié»i» con formule di destinazione e di consultazione-deliberazione, formule conclusive e defi-nizione del documento. Confrontando i papiri che ci restituiscono gli Acta Isidori con quanto sin qui affermato possiamo mettere in evidenza ancora una volta l’eccezionalità della disposizione testuale del testimone berlinese: registriamo infatti l’assenza delle formule, nel testo, che vengono tradizio-nalmente impiegate per introdurre la battuta dell’eventuale personaggio. Questa funzione è esclusivamente espletata dagli accorgimenti grafici con-cepiti come extratestuali: c’è il puro dialogo ma manca la cornice dialogica pur rintracciabile negli altri testimoni.
2) Testi drammatici e retorici: tra statuti narrativi e soluzioni graficheAvviciniamoci allora a quei testi letterari che, a vario titolo, possono
essere accostati ai nostri papiri a causa del loro carattere dialogico: la tradi-zione greco-latina circa i dialoghi è, come sappiamo, tanto ricca quanto mul-tiforme e sfuggente nelle sue manifestazioni e definizioni. Una cosa sono i dialoghi di Platone, cosa diversa quelli di Cicerone, una cosa gli Atti dei Martiri, altra i Dialoghi di Luciano, una cosa i Mimiambi di Eroda, un’altra
18 r.A. coles, Reports of Proceedings in Papyri, (Papyrologica Bruxellensia 4), Bruxelles 1966, pp. 9 ss.
278 ADRIANO MAGNANI
le Commedie di Aristofane, altri ancora fenomeni parateatrali come le ilaro-die ed i mimi alessandrini. Pur nella diversità delle manifestazioni di questo genere di strumento comunicativo l’itinerario da seguire partirà dalle scelte che si possono individuare sulla base della disposizione del testo, poi si in-terrogherà sul pubblico cui questo genere di testi si rivolgeva e sui canali di comunicazione con esso, infine si avvarrà di eventuali riscontri sul piano del materiale papirologico. Il dialogo registrato all’interno di questi testi non è un dialogo di tipo filosofico, in cui le domande e le risposte si concatenano alla ricerca di un effetto di convincimento o di persuasione intellettuale, né un dialogo previsto per un accompagnamento musicale in un contesto di azione drammatica tradizionale e neppure un dialogo tra personaggi mera-mente letterari, come quelli di Luciano19. Si tratta di un testo in prosa atto a riprodurre, a beneficio del lettore-ascoltatore, lo scambio di battute tra personaggi storici ben delineati, con un fine di propaganda politica e forma-zione intellettuale: questo testo quindi non investiga ma rappresenta.
Lo spostamento dei nomi propri all’esterno del corpo del testo, che nella tradizione che conosciamo si è verificato per agevolarne la lettura, a quale esigenza risponde nel caso del nostro papiro? Posta la facile identi-ficabilità dei nomi e della battute all’interno degli altri papiri del processo di Isidoro, a quale ragione dobbiamo dunque legare la novità di soluzione grafica del papiro berlinese? La soluzione ideale sarebbe certamente quel-la di abbinare a questo elemento di variabilità grafico-testuale un fattore di ordine cronologico. Quale di queste “edizioni” degli Acta Isidori è la prima? Il testo è stato concepito alla sua origine come provvisto di questi accorgimenti, o si tratta di una manipolazione successiva alla prima edi-zione? E se questa manipolazione c’è stata quale era il suo fine ultimo? In base alle conclusioni tratte da J. Andrieu20 nella sua monografia sul dialogo antico potremmo avanzare sin da ora l’ipotesi che il papiro di Berlino sia il risultato ultimo di un processo grafico di cui gli altri papiri rappresentano una fase intermedia, testimoniato dalla progressiva scomparsa della para-graphos come segno di interpunzione nei dialoghi e dal progressivo affer-marsi di espedienti esterni al dialogo quali gli intercalari. Se è vero però che l’uso di simili intercalari costituisce senz’altro una delle caratteristiche for-ti del testo dialogico di tipo filosofico o genericamente “drammatico”, ne dovremo conseguire che la presenza di questa particolare predisposizione testuale spinge progressivamente al di fuori di quest’orbita le redazione del
19 A.r. bellinGer, Lucian’s Dramatic Technique, «YCLS» 1 (1928), pp. 1-40.20 Andrieu, Le dialogue antique…, cit.
Modelli grafici e testuali di P. Berol. 8877 (Acta Isidori) 279
testo registrata dal papiro berlinese e lo proietta verso un momento cro-nologicamente successivo, ma soprattutto verso un altro statuto grafico-testuale rispetto agli altri papiri che testimoniano il processo21.
Anticamente nei testi dialogici22 a vario titolo il passaggio da una voce all’altra e da un personaggio all’altro era assicurato da una serie di espe-dienti non uniformi che andavano da accorgimenti interni (preparazione del lettore al cambio di persona tramite particolari battute) ad accorgimenti esterni (in particolare l’uso del dicolon e della paragraphos). Nei mano-scritti più tardi, ma esclusivamente in quelli dei comici latini, i nomi dei protagonisti sono posti all’inizio della piece, per esteso, al nominativo. Una sigla, di solito una lettera greca, accompagna questi nomi e, all’interno del testo, essa sostituirà la forma estesa del nome. Nei manoscritti greci della commedia antica invece non c’è traccia di tutto ciò: secondo gli studiosi per la maggior parte dei casi lo spostamento di scena e di interlocutore era assi-curato dai movimenti del coro e dalle notazioni, in senso deittico, interne al testo; rubriche concepite come quelle che abbiamo visto sopra per il teatro latino trarrebbero le proprie origini dalla Neéa di cui abbiamo poche testi-monianze dirette ed indirette. In questo frangente i papiri ci sono venuti però in aiuto: il codice papiraceo più importante che ci restituisce buona parte di ciò che noi conosciamo di Menandro (P. Cair. JE 4322723), datato al V secolo, prima dell’inizio della commedia Heros e dopo la u|poéqe»i» pre-senta la lista dei personaggi al nominativo introdotti dalla dicitura: taè tou% draémato» proé»wpa. Si pensa che questa struttura si debba far risalire ad una edizione alessandrina del testo, ma non abbiamo strumenti sufficienti per poterne essere certi, registriamo semplicemente il fatto raccordandolo con la disposizione testuale dei nostri papiri. Quella della messa in eviden-za dei personaggi all’inizio della pièce non è un espediente che si possa far risalire all’autore: il suo sviluppo a partire dall’epoca alessandrina pare deb-ba farsi risalire ai grammatici, che spesso si limitarono a riprendere, ai fini di una migliore lettura, dall’interno del testo stesso i nomi dei personaggi trasportandoli all’inizio. Ne conseguirebbe, per i nostri testi, la conferma che la fase con i nomi isolati al centro della colonna sia una fase succes-siva, frutto di una operazione simile. Tuttavia è da notare che nel papiro
21 Andrieu, Le dialogue antique…, cit., pp. 330 ss.22 Per i testi tragici si veda: l. sAviGnAGo, Eisthesis. Il sistema dei margini nei papiri
dei poeti tragici, Alessandria 2008.23 Editio Princeps: G. lefebvre, Papyrus de Ménandre, Le Caire, 1911; repertori:
MP³ 1301, LDAB 2745.
280 ADRIANO MAGNANI
berlinese i nomi dei protagonisti vengono sì posti in evidenza nel modo illustrato, ma non ricompaiono affatto all’interno del testo, come accade invece nei testi comici. Inoltre, ed anche questo possiamo desumerlo da tutte le testimonianze manoscritte che ci trasmettono dialoghi drammatici e filosofici, i nomi dei personaggi venivano citati per esteso al nominativo un’unica volta, per poi essere richiamati da una sigla all’interno del testo: se procedessimo per via analogica ne dovremmo arguire che il testo del papiro berlinese ci restituisce le battute iniziali del processo di Isidoro, ma poiché il testo è mutilo e non possiamo fare nessuna affermazione circa la durata del dibattimento, ci limitiamo a registrare anche questa possibilità.
Queste conclusioni circa il rapporto con i moduli grafici del dramma possono essere ulteriormente confermate da una recente revisione24 del mate-riale papirologico riferibile al mondo delle rappresentazioni sceniche. L’autri-ce, al termine del volume, identifica, nella pur grande varietà di soluzioni che fanno di ogni papiro un caso a sé stante, una serie di coordinate desumibili dal materiale: questi papiri presentano caratteristiche tipiche dei documenti che ne rivelano al tempo stesso la destinazione d’uso. Vediamo punto per punto:
1) la scrittura non è mai formale, tanto meno canonizzata, viene fatto uso, al contrario, di grafie corsiveggianti, non scevre da correzioni e da abbreviazioni;
2) il materiale scrittorio è spesso frutto di riutilizzo, viene sfruttato a fondo, l’impaginazione e l’incolonnamento sono spesso sciatti;
3) compaiono sigle drammatiche, indicazioni registiche, note musicali.Il papiro berlinese non rientra agevolmente in nessuna di queste tre
categorie: è vergato in una scrittura elegante tracciata da mano esperta ed educata allo stile di cancelleria, non ci sono né correzioni né abbreviazioni. Il materiale scrittorio è di buona qualità anche se riutilizzato (verso), il testo è impaginato in modo accurato e soprattutto è privo di qualsiasi sigla o espediente grafico che rinvii ad indicazioni sceniche tranne che per la particolare disposizione dei nomi. Per gli altri papiri degli Acta Isidori in questo senso poco resta da aggiungere: essi presentano certamente soluzio-ni grafiche che li avvicinano ai papiri “scenici”, ma gli elementi cogenti non ci sono, soprattutto quelli ascrivibili al punto 3.
3) Verso una lettura drammatizzataPosto dunque lo scarso contatto tra questi papiri ed i moduli testuali
che gravitano attorno agli antichi generi del dramma tradizionale e del dialo-
24 t. GAMMAcurtA, Papyrologica Scaenica, Alessandria 2006, pp. 239 ss.
Modelli grafici e testuali di P. Berol. 8877 (Acta Isidori) 281
go, resta da chiedersi se si tratti di edizioni che hanno a che fare con il mondo della rappresentazione retorico-scenica o sono da studiarsi nel controverso ambito delle pratiche di lettura, solitarie e collettive, del mondo antico.
Analizziamo la prima ipotesi:
Esclusi i fenomeni di lettura pubblica a carattere folkloristico-popola-re25, pur diffusi a quei tempi particolarmente in Egitto e a Roma26, ma che presupponevano sia una materia fantastica, sia delle figure di professionisti della “lettura pubblica” che mal si accorderebbero con la classe sociale cui facevano appello questi testi, un altro episodio letterario che potrebbe essere d’aiuto alla nostra indagine in questa direzione, spostandoci anche nell’am-bito delle pratiche di lettura antiche, è costituito dai mimi di tradizione ales-sandrina27, in particolare quelli che conosciamo meglio: i Mimiambi di Ero-da28. I dati che a noi interessano in questo discorso, desumibili dal rotolo dei Mimiambi, sono i seguenti: erano testi destinati alla recitazione monologica, una consuetudine che ci riporta nell’ambiente alessandrino tardo-ellenistico e romano29; c’è un abbondante uso della paragraphos ed un altrettanto fre-quente uso degli spazi vuoti ai fini di una lettura guidata. Il Mastromarco è convinto che i Mimiambi di Eroda fossero destinati alla recitazione pub-blica, con accompagnamento musicale: certamente i nostri testi non sono dei mimi30 ma forse dalla strutturazione scenica e grafica dei mimi hanno ereditato qualcosa; ma che essi potessero essere fatti oggetto di lettura pub-
25 A. scobie, Storytellers, storytelling, and the novel in Graeco-roman Antiquity, «RhM» 122 (1979), pp. 229-259.
26 M. AndreAssi (a cura di), Mimi greci in terra d’Egitto: Charition e Moicheutria, Bari 2001; e. esPosito, Il fragmentum Grenfellianum (P. Dryton 50), Bologna 2005, pp. 41 ss.; citando un famoso passo dei Deipnosofisti di Ateneo (I 19c-20b, XIV620d-621f).
27 b. sAJevA, Il mimo, in La cultura ellenistica: filosofia, scienza, letteratura, (Storia e civiltà dei Greci 9), Milano 1977, pp. 254-265; G. tedeschi, Lo spettacolo in età ellenistica e tardo antica nella documentazione epigrafica e papiracea, «PapLup» 11 (2002), pp. 87-187.
28 Editio Princeps: f.G. kenyon, Classical Texts from Papyri in the British Museum, London 1891; repertori: MP³ 485, LDAB 1164; considerazioni fatte avendo presente: G. MAstroMArco, Il pubblico di Eronda, Padova 1979.
29 b. Gentili, Nuovi aspetti del teatro ellenistico: contaminazione e canto a solo, in La cultura ellenistica: filosofia, scienza, letteratura, (Storia e civiltà dei Greci 9), Milano 1977, pp. 361-373, poi ripreso e sviluppato in: Lo spettacolo nel mondo antico, Roma 2006.
30 Nessun raffronto possibile con i papiri dei mimi citati da: h. WieMken, Der Griechische Mimus, Bremen 1972, pp. 45-149. I nomi sono sempre abbreviati e richiamati con la sigla, e nei nostri papiri mancano elementi di improvvisazione lasciati all’iniziativa dell’attore.
282 ADRIANO MAGNANI
blica, magari con l’intervento di uno o più voci, è una ipotesi interessante da verificare. Abbiamo visto come, in almeno due casi, i nomi vengano citati sempre per esteso, sia all’esterno (P. Berol. 8877) che all’interno (P. Cairo Inv. 10448 e Brit. Lib. 2785) del testo, ed in uno c’è un uso interessante degli spazi vuoti (P. Cairo Inv. 10448): non registrato l’uso di paragraphos. Potremmo perciò ipotizzare che l’edizione rappresentata dal papiro berli-nese31 fosse destinata alla “recitazione”, pur mantenendo un certo carattere di “ufficialità”, mentre le edizioni testimoniate dagli altri papiri alla sempli-ce lettura “privata”, espressione quindi di una letteratura di consumo32. In effetti l’attenzione posta nel far distinguere con certezza l’andamento dialo-gico del testo nelle sue fasi deve farci riflettere: era evidentemente interesse dell’estensore di questi scritti puntare sull’intellegibilità del testo nel suo dipanarsi, ma solo dal punto di vista della lettura o anche da quello di una eventuale recitazione? Infatti nel papiro berlinese sarebbe complicato di-stinguere le battute se non ci fossero le “rubriche”, e cioè i nomi evidenziati in quella maniera. Abbiamo inoltre da chiederci, analizzando il testo nella prospettiva di una eventuale rappresentazione scenica cosa essa aggiunge-rebbe all’intellegibilità del testo e se vi possano essere sezioni del testo che possano essere comprese appieno solo presupponendo una sua messa in scena: anche in questo caso la risposta è negativa, non foss’altro perché così si presupporrebbe che il testo dell’Actum fosse stato concepito ab initio per la messa in scena, cosa che non si può di certo affermare.
Un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione riguarda il complesso mondo dei metodi di lettura nel mondo antico33. Sull’argo-mento esiste una bibliografia considerevole: basterà dire, in via prelimina-re, che la lettura nel mondo antico era, se non specificato altrimenti, ad alta voce e presupponeva la “partecipazione” fisica del lettore al testo tramite movimenti e impostazioni della voce, in modo da ottenere una sorta di recitazione drammatizzata del testo34. Questo genere di lettura è attestato
31 Che poi proprio il papiro di Berlino, che sembra un libro di un certo pregio, servisse a questo genere di rappresentazioni è un’altra cosa che non si può affermare con certezza.
32 G. cAvAllo, Veicoli materiali della letteratura di consumo. Maniere di scrivere e maniere di leggere, in o. Pecere-A. strAMAGliA (a cura di), La letteratura di consumo nel mondo greco-romano, Cassino 1996, p. 40.
33 f. di cAPuA, Osservazioni sulla lettura e sulla preghiera ad alta voce presso gli antichi, «RAAN» 28 (1953), pp. 59-99.
34 l. del corso, La lettura nel mondo ellenistico, Bari 2005, pp. 86-90; vedi anche: d. Potter, Martyrdom as Spectacle, in r. scodel (ed.), Theater and Society in the Classical World, Ann Arbor 1993, pp. 53-88.
Modelli grafici e testuali di P. Berol. 8877 (Acta Isidori) 283
largamente nei testi antichi35, ove leggiamo non solo di lettori professionisti chiamati a recitare opere in pubblico ma anche attori, che potevano coin-cidere o meno con il lettore, che gesticolavano ed interpretavano il testo in una sorta di pantomina36. Inoltre queste esibizioni dei rappresentanti della Seconda sofistica toccavano spesso argomenti e soggetti a carattere storico37: evidentemente il raffronto tra pratiche declamatorie ed esibizioni parateatrali sarebbe da approfondire in questo senso. Resterebbe infatti da chiedersi se fossero attestate letture a carattere dialogico che presumessero la compresenza di più lettori sul “palco” in azione “drammatica”, posto che il nostro testo potesse avvalorare, per caratteristiche interne, una let-tura di questo tipo. Nell’ambito della Seconda sofistica questo genere di esibizione veniva chiamato dialeéxi» e faceva parte, secondo l’Anderson38, del comune repertorio di questi professionisti della parola: ma si trattava, il più delle volte, di un informale scambio di battute tra il sofista ed il suo pubblico: questi scambi di battute erano all’insegna dell’improvvisazione e difficilmente venivano poi messi per iscritto.
In occasione delle feste efebiche nel ginnasio si teneva una serie di ago-ni, a quanto pare a carattere esclusivamente ginnico. Ciò non toglie che il ginnasio, in età imperiale, fosse sede anche di altre feste, aperte alla parteci-pazione di soggetti più adulti, che prevedessero anche esibizioni a caratte-re culturale (declamazioni, rappresentazioni teatrali, gare di poesia)39 tra le quali potrebbero rientrare con una certa facilità i testi degli Acta: sebbene
35 i. bAloGh, Voces paginarum, «Philologus» 82 (1927), pp. 84-109 e 202-240; h.J. MAr-tin, Pour une histoire de la lecture, «Revue française d’histoire du livre» 2 (1977), pp. 583-609; r.J. stArr, Reading aloud: Lectores and Roman Reading, «CJ» 86 (1991), pp. 337-43.
36 Plin. Jun., Epistulae, IX, 34, che ne parla come di prassi diffusa; vedi anche: v.A. sirAGo, La seconda sofistica come espressione culturale della classe dirigente del II sec., «ANRW» II 33, 1 (1989), pp. 50 ss.
37 f. robert, Cersièn au\tai%v lalei%n (Luc. Salt. 63): rhétorique et pantomime à l’époque impériale, in G. AbbAMonte et alii (a cura di), Discorsi alla prova, Atti del quinto colloquio italo-francese, Napoli-S. Maria di Castellabate (Sa), 21-23 settembre 2006, Napoli 2009, pp. 225-257.
38 G. Anderson, The Second Sophistic, London 1993, p. 67; vedi inoltre: G.W. bo-Wersock, Greek Sophists in the Roman Empire, Oxford 1969, pp. 17-58; sirAGo, La seconda sofistica …, cit., pp. 36-78; Anderson, The Second Sophistic, cit., pp. 47-68; s. nicosiA, La seconda sofistica, in G. cAMbiAno-l. cAnforA-d. lAnzA (a cura di), Lo spazio letterario delle Grecia antica, Vol. I.3, Roma 1994, pp. 85-116; G. Anderson, L’intellettuale e il primo impero romano, in I Greci. Storia, Cultura, Arte, Società, 2.III, Torino 1998, pp. 1123-1146; s. sWAin, La conferenza, in I Greci. Storia, Cultura, Arte, Società, 2.III, Torino 1998, pp. 1183-1198.
39 b. leGrAs, Néotês, recherches ..., cit., Genève 1999, pp. 249 ss.
284 ADRIANO MAGNANI
il carattere altamente sovversivo e di aperta critica verso certi imperatori (anche se non tutti gli imperatori: negli Acta Appiani40 ci sono parole di approvazione verso il filelleno Marco Aurelio) tenderebbe ad escludere la recitazione di questi testi durante feste sponsorizzate dal potere imperia-le, restringendone la fruizione in occasioni precise ed in cerchie limitate di fruitori. In questa prospettiva si potrebbe pensare ad essi anche come dei progymnasmata utilizzati nell’ambito del ginnasio come filoni narrativi di riferimento per l’esercizio dei giovani, ma l’ipotesi non tiene poiché in questi testi manca l’elemento di improvvisazione, essendo invece il conte-sto storico e prosopografico tracciato con precisione e non appartenente al mondo del mito o della storia passata. Inoltre il fenomeno degli Acta attra-versa almeno due secoli della vita di Alessandria sotto il dominio romano, un periodo che presuppone una volontà di conservazione dei fatti che va al di là della performance occasionale e presuppone una rielaborazione lettera-ria del testo in una fase successiva e l’incanalamento in una precisa tradizio-ne narrativa. Tuttavia ciò che si può pure sottolineare in questa prospettiva è che questi testi erano probabilmente utilizzati e circolavano all’interno del ginnasio e contribuivano senz’altro a formarne l’atmosfera politica e cultu-rale: atmosfera non particolarmente benevola verso il potere romano.
Inoltre ci sarebbe da chiedersi se gli Acta fossero letti e proposti al pubblico come fenomeno letterario e testuale unitario, e se si possa indivi-duare, nel panorama complessivo degli Acta Martyrum Alexandrinorum, e in particolare negli Acta Isidori, una suddivisione in fasi successive e con-catenate dell’azione dialogica.
Consideriamo brevemente le due possibilità: la prima sembra da esclu-dere, poiché un complesso di almeno 33 papiri che riportano squarci di processi di almeno nove personaggi differenti, vissuti in epoche lontane tra loro rende poco probabile la lettura complessiva delle loro gesta in un unico flusso narrativo. Qualche considerazione in più è da farsi a proposito degli Acta che vedono protagonista Isidoro: comprimario dell’azione al cospetto di Claudio assieme ad Isidoro è l’altro ginnasiarca Lampone41. Ora, a fianco di Isidoro, in un altro testo ascrivibile agli Acta, in una cornice cronologica e spaziale precedente ai fatti narrati nei papiri di Isidoro, compare un altro
40 P. Oxy. I, 33, col. II, vv. 6 ss.; editio princeps: The Oxyrhynchus Papyri, I, London 1898, n. 33 (Brit. Libr. inv. 2435 = P. Lit. Lond. 119); riedizioni: Musurillo54 XI, CPJ II 159a, Musurillo61 XIa; repertori: MP³ 2232, LDAB 40.
41 A. MAGnAni, Filone, Lampone e le “letture” di Caligola, «An.Pap.» 16-17 (2004-2005), pp. 75-80.
Modelli grafici e testuali di P. Berol. 8877 (Acta Isidori) 285
personaggio che sembra aver parte decisiva nei fatti narrati. Infatti in P. Oxy. VIII 1089, col. II, Isidoro ed un certo Dionisio si presentano, nel tempio di Serapide ad Alessandria, ad un abboccamento con il prefetto d’Egitto Aulo Avillio Flacco42. Tutto questo ci pone d’innanzi a due possibilità: o postulare l’esistenza di un Actum Dionisii, di cui però l’esito processuale curiosamente non viene a coincidere con quello di Isidoro a Roma, o, ed è l’ipotesi più economica, dobbiamo immaginare l’azione del processo di Isidoro, Lampone e Dionisio dotata di un antefatto alessandrino che poi prevedeva la scomparsa di quest’ultimo personaggio.
4) Performances letterarie nel ginnasio alessandrinoSi tratta, come abbiamo detto, di testi letterariamente elaborati e che
presupponevano un pubblico informato dei fatti e di livello culturale me-dio-alto; inoltre non abbiamo un’idea precisa del luogo ove circolassero questi testi né di che uso se ne facesse: molti indizi ci spingono, ovviamen-te, nella direzione del ginnasio43 di Alessandria e dell’attività intellettuale e libraria44 ad esso afferenti. Che il testo in questione provenisse dalla bi-blioteca annessa alla struttura o da una raccolta privata di un membro del ginnasio che metteva a disposizione i suoi testi, poco importa in questo caso specifico (anche se la riutilizzazione di materiale di scarto per questo genere di testi spingerebbe più che altro verso la seconda ipotesi). Il gin-nasio era in effetti luogo per eccellenza deputato, nella capitale egiziana in particolare, alla cultura della classe intellettuale di formazione greca tanto in periodo tolemaico che in quello romano: durante le feste che vi si tene-vano non mancavano agoni scenici o pubbliche letture (in apposite sale: a\kroathéria45) legati a fenomeni culturali come la “Seconda sofistica46”, e in
42 G. bAstiAnini, Lista dei prefetti d’Egitto dal 30 a.C. al 299 d.C., «ZPE» 17 (1975), p. 271; e 38 (1980), p. 76; J. schWArtz, Prefets d’Egypte sous Tibere et Caligula, «ZPE» 48 (1982), pp. 189-192.
43 Per una rassegna archeologica mi limito a rimandare a: h. von hesberG, Das griechische Gymnasion im 2. Jh. v. Chr., in Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus, Kolloquium, München, 24. bis 26. Juni 1993, herausgegeben von M. Wörrle und P. zAnker, München 1995, pp. 13-27.
44 Assai prudente sulla connessione diretta tra ginnasi e raccolte librarie è: r. nico-lAi, Le biblioteche dei ginnasi, «Nuovi annali della scuola speciale per archivisti e bibliote-cari» 1 (1987), pp. 17-48.
45 Su quelli ritrovati recentemente ad Alessandria, nel sito di Kom-el-Dikka, si veda: AA.vv., Alexandria. Auditoria of Kom el Dikka and Late Antique Education, (Supplement VIII to «JJP») Warsaw 2007.
46 Nel caso specifico: b.W. Winter, Philo and Paul among the sophists, Cambridge 1997,
286 ADRIANO MAGNANI
questa particolare categoria di performances potremmo inserire l’utilizzo di questo genere di testi. Dal punto di vista culturale e politico infatti gli ambienti della Seconda sofistica alessandrina, come testimoniato da Dione di Prusa, Teone e lo stesso Filone di Alessandria, presentano numerose assonanze con l’ambiente ginnasiale e quindi con quello che produsse gli Acta tanto dal punto di vista culturale quanto da quello di vista politico: soprattutto sono curiose le coincidenze tra Filone47 e Dione48, che pure non sono scrittori coevi, nel giudizio negativo sull’attività dei “sofisti” ad Alessandria, giudizi che concentrano l’attenzione sul medesimo punto pur venendo da prospettive diverse. Ambedue infatti delineano, nelle loro opere, un ritratto essenzialmente negativo di questo movimento politico-culturale ad Alessandria: ma mentre sia Filone che Dione criticano le rica-dute politiche dell’attività di questi personaggi sui precari equilibri politici della città, Filone punta la sua attenzione sulla comunità ebraica, in alcuni suoi settori profondamente imbevuta dell’indispensabile formazione cul-turale ellenica, della città invitandola a reagire compatta per presentarsi al potere romano come possibile interlocutore politico privilegiato, mentre Dione sembra essere particolarmente interessato a prestare supporto alla politica imperiale di pacificazione e di coesione culturale condotta da Ve-spasiano49. Le testimonianze letterarie, tra le quali una importante dello stesso Dione50, che abbiamo circa questo movimento ed alla sua influenza a vario titolo sulla vita politica ed intellettuale di Alessandria d’Egitto, poi, ci avvicinano al mondo delle esibizioni retoriche in pubblico su argomenti attinenti ai rapporti, spesso conflittuali, con il potere51. In questa direzione
pp. 19-112. Le pagine dedicate a Filone (pp. 83 ss.) sono particolarmente interessanti per la consonanza della polemica dello scrittore giudaico alessandrino con gli argomenti utilizzati negli ambienti politici ed intellettuali greco-macedoni della metropoli d’Egitto.
47 Winter, Philo…, cit.48 P. desideri, Dione di Prusa. Un intellettuale greco nell’Impero Romano, Messina
1978, pp. 61-186.49 boWersock, Greek Sophists…, cit., pp. 32 ss.; A. brAncAcci, Rhetorike
Philosophousa, Napoli 1985, pp. 66-97; c. frAnco, Intellettuali e potere nel mondo greco e romano, Roma 2006, pp. 121 ss.
50 Ad Alexandrinos, XXXII, 7-11.51 M. JòzefoWicz-dzielskA, La Participation du milieu d’Alexandrie à la discussion
sur l’idéal du souverain dans les deux premiers siècles de l’Empire Romain, «Eos» 64 (1976), pp. 43-58; e. cizek, La littérature et les cercles culturels et politiques à l’époque de Trajan, «ANRW» II 33, 1 (1989), pp. 17 ss; P.r. MAlosse, Sophistiques et tyrannies, in Approches de la Troisième Sophistique, Hommage à Jacques Schamp, édités par E. Amato, Bruxelles 2006, pp. 157-178.
Modelli grafici e testuali di P. Berol. 8877 (Acta Isidori) 287
di studio saremo supportati anche dal fatto che, nella zona di Kom-El-Dikka, ad Alessandria, ci sono stati due ritrovamenti per noi interessanti: il primo è quello degli a\kroathéria, il secondo di due52 iscrizioni pro-venienti dal medesimo sito, che si riferiscono ad un ginnasiarca Isidoro probabilmente discendente del nostro. La pratica di letture pubbliche di un testo53, nel ginnasio, tramite un a\nagnw»thé» professionista è prassi dif-fusa nell’ambiente culturale greco-ellenistico e particolarmente a Roma, ed è attestata anche a livello iconografico54. La lettura pubblica commentata di testi filosofici è pratica trasversale in tutte le scuole, particolarmente in quella stoica55: anche se questa sembra essere idealmente la più vicina agli ambienti che produssero gli Acta, con il suo forte colorito antitirannico e polemico verso alcuni imperatori, l’opposizione all’Imperatore di cui sono testimoni gli Acta Isidori è cosa diversa rispetto a quella, per esem-pio, degli Acta Appiani: qui l’opposizione, giova ricordarlo, è meramente politica mentre negli Acta più tardi si tinge anche di un probabile risvol-to filosofico. Comunque queste pratiche, che ad Alessandria si associano con il fiorire della “Seconda sofistica”56, sono ben attestate tanto nel mon-do della letteratura quanto suffragate dalle testimonianze archeologiche. Alessandria è, nel terzo secolo della nostra era, se non proprio la capitale culturale dell’Impero romano per lo meno uno dei centri più importanti, e numerose testimonianze letterarie la vedono attraversata da conferenzieri, intellettuali e politici di alto livello, sia pagani che cristiani. Nulla ci vieta di ipotizzare che i testi degli Acta venissero recitati pubblicamente nel ginna-sio alessandrino o negli auditoria di cui abbiamo parlato, d’innanzi ad un pubblico qualificato e politicamente orientato: i fenomeni associabili alla Seconda sofistica sono infatti abbastanza variegati e vanno dalla “predica-zione popolare” sino all’esibizione culturale di alto livello. Restano fissi però, in questa varietà di performances, alcuni punti quali l’esaltazione del
52 A. lukAszeWicz, Some remarks on the Trial of Isidorus and on Isidorus Junior, «JJP» 30 (2000), pp. 59-65; id., Tiberius Claudius Isidorus: Alexandrian Gymnasiarch and Epistrategus of Thebaid, in t. GAGos-r.s. bAGnAll (edd.), Essays and text in honor of J. David Thomas, (American Studies in Papyrology 42), Oakville 2001, pp. 125-129.
53 c. sAlles, La lettura …, o.c., p. 71 e ss; l. del corso, La lettura …, o.c., pp. 86-90.54 G. cAvAllo, Tra “volumen” e “codex”. La lettura nel mondo romano, in Storia
della lettura, a cura di G. cAvAllo e R. chArtier, Bari 2004, p. 46.55 h.G. snyder, Teachers and Texts in the Ancient World, London 2000, pp. 14-44.56 M.b. trAPP, Images of Alexandria in the writings of the Second Sophistic, in
A. hirst-M. silk (edd.), Alexandria, Real and Imagined, Ashgate 2004, pp. 113-32; c. frAnco, Intellettuali e potere..., cit., pp. 114 ss.
288 ADRIANO MAGNANI
patrimonio culturale ellenico, la critica verso il potere romano (anche in presenza dell’imperatore stesso) e di conseguenza l’uso della parrh»iéa57 spinto sino alle conseguenze estreme: tutti elementi rintracciabili facilmen-te nei testi degli Acta.
Inoltre il periodo in cui vengono prodotti i papiri degli Acta è il pe-riodo, per il bacino del Mediterraneo nell’evo antico, di maggiore diffusio-ne dell’alfabetizzazione e conseguentemente di produzione e fruizione di letteratura e “paraletteratura” di consumo58. Questi dati che si raccolgono attorno al nostro papiro dovrebbero nuovamente confrontarsi con notizie a carattere temporale: dovremmo infatti chiederci nuovamente a quale pe-riodo far risalire la predisposizione del testo come presentataci dal papiro berlinese. Gli Acta non furono di certo scritti tutti nel terzo secolo, e gli Acta Isidori, in particolare59, presentano una serie di elementi che ci spin-gono in direzione di una messa per iscritto abbastanza rapida rispetto ai fatti in essi narrati. Fino ad un certo punto i nostri papiri furono riservati alla sola lettura personale o per lo meno così vennero trasmessi. Ad un certo punto, forse in coincidenza con il diffondersi ad Alessandria dell’uso di recitazioni pubbliche di testi e contestualmente a fenomeni di recru-descenza dell’opposizione a Roma60, gli Acta vennero predisposti per un tipo di lettura diversa rispetto a quella tradizionalmente praticata, e così riusciremmo a spiegarci il perché della particolare predisposizione testuale del P. Berol. 8877.
Riassumiamo ora brevemente i vari passaggi di questo studio: si è par-titi da una considerazione delle caratteristiche interne del testo riportato dal
57 G. scArPAt, Parrhesia: storia del termine e delle sue traduzioni in latino, Brescia 1964.58 c.h. roberts, Literature and Society in the Papyri, «MH» 10 (1953), pp. 264-279;
G. cAvAllo, Dal segno incompiuto al segno negato, «QS» 38 (1978), pp. 471 ss.; G. cAvAl-lo, Alfabetismo e circolazione del libro, in M. veGetti (a cura di), Oralità, scrittura, spet-tacolo, Torino 1983, pp. 166-186; W.v. hArris, Lettura e istruzione nel mondo antico, ed.it. Bari 1991, pp. 198-319; G. cAvAllo, Veicoli materiali della letteratura di consumo. Maniere di scrivere e maniere di leggere, in o. Pecere-A. strAMAGliA (a cura di), La letteratura di consumo nel mondo greco-romano, Cassino 1996, pp. 11-46.
59 Mi permetto di rinviare, in merito, alle pagine introduttive del mio volume: A. MAGnAni, Il processo di Isidoro. Roma e Alessandria nel primo secolo, Napoli 2009.
60 Penso in particolare ai tumulti in occasione della visita dell’imperatore Caracal-la: P. benoît-J. schWArtz, Caracalla et les troubles d’Alexandrie en 215 ap. J.-C., «Etu-des de Papyrologie» 7 (1948), pp. 17-33; A. lukAszeWicz, Alexandrie sous les Severe set l’Historiographie, in l. criscuolo-G. GerAci (a cura di), Egitto e storia antica: Dall’Elle-nismo all’età araba, Atti del colloquio internazionale, Bologna 31 agosto-2 settembre 1987, Bologna 1989, pp. 491-496.
Modelli grafici e testuali di P. Berol. 8877 (Acta Isidori) 289
papiro berlinese, un dialogo a carattere giudiziario con personaggi storici come protagonisti. Si è visto come si possa probabilmente postulare una derivazione da moduli strutturali protocollari per gli altri testimoni degli Acta Isidori, ferma restando la peculiarità del papiro berlinese che presenta delle caratteristiche strutturali particolari, sulla cui origine ci si interroga in questa sede. Si sono considerate le caratteristiche del dialogo antico tanto dal punto di vista intrinseco quanto da quello delle testimonianze materiali: ne abbiamo dedotto che, nel panorama del dialogo antico e delle sue rappre-sentazioni grafiche, il papiro berlinese resta un’eccezione importante, dal momento che i passaggi di battuta da un personaggio all’altro sono affidati non a segni diacritici tradizionali (paragraphoi, spazi vuoti o altro), né a evi-denze interne come l’uso di verbi introduttivi e in genere di spie logico-lin-guistiche che preparino il lettore al cambio di personaggio, quanto piuttosto all’uso del nome del personaggio al nominativo posto, in modo isolato, al centro della colonna, spezzando il normale incolonnamento del testo.
Si è passati all’analisi dello statuto narrativo del testo ed alle eventuali ricadute di esso sulla disposizione testuale. Anche in questo caso, il con-fronto con la bibliografia in merito ha ulteriormente messo in evidenza la peculiare disposizione del testimone berlinese: registrazione del puro dialo-go e curiosa assenza della cornice dialogica che sempre accompagna questi testi. Entrata nell’ambito dei testi dialogici e degli espedienti extra-testuali ad essi collegati, questa indagine è proseguita secondo due direzioni: quella del dialogo filosofico-letterario e quella del dialogo scenico-drammatico (dalla tragedia ai mimi). Sia dal primo punto di vista che dal secondo ci si è chiesti se la struttura grafica del dialogo antico letterario-filosofico o dram-matico possa aver avuto una qualche influenza sulla disposizione testuale del papiro berlinese: il risultato, confermato dalla bibliografia in merito ed anche da recenti indagini papirologiche, è che, se qualche influenza può esserci stata (essenzialmente espedienti tecnici volti ad una maggiore intel-ligibilità del testo e dell’alternarsi della fasi dialogiche), essa si è sviluppata, nel papiro berlinese, in un modo peculiare che non trova riscontri effettivi nel materiale giunto sino a noi. Ultima ipotesi che si è voluto verificare è stata quella di un testo iscrivibile nelle pratiche di lettura pubbliche e semi-drammatiche diffuse nei principali centri culturali dell’Impero nei primi tre secoli dell’era cristiana.
Questa indagine, almeno nella prospettiva della collocazione di que-sto papiro in un contesto intellettuale e sociale preciso e dell’identifica-zione di possibili pratiche di lettura, è quella che sembra aver prodotto i risultati più interessanti, risultati surrogati dalle recenti scoperte archeo-logiche degli auditoria di Kom-El-Dikka. Gli Acta sono inquadrabili, con
290 ADRIANO MAGNANI
una certa sicurezza, nell’ambito dei movimenti culturali gravitanti attorno alla Seconda Sofistica: basta infatti anche una lettura generica dei principali testi61 in merito per rendersi conto di quanto questi testi abbiano punti di contatto in maniera sorprendente con questo specifico orizzonte culturale. I personaggi appartenenti a questa corrente culturale di periodo imperiale presentano, in effetti, una serie di caratteristiche che li accomunano tra di loro e di cui troveremo riscontro nei personaggi protagonisti degli Acta in generale, e in Isidoro in particolare. Innanzitutto questi personaggi appar-tengono generalmente a grandi famiglie aristocratiche, sono in relazione diretta con i grandi dell’Impero Romano, assumono per conto delle città da cui provengono funzioni ufficiali presso il potere centrale, ed infine si fanno garanti della cultura ellenica in un rapporto talvolta conflittuale con il potere. Isidoro è un rappresentante di una famiglia62 che ha dato, con ogni probabilità, alla città di Alessandria più di un ginnasiarca; in ogni caso il personaggio presente in questo papiro è stato a capo di alcune ambascerie della città di Alessandria all’imperatore Caligola prima e Claudio successi-vamente, episodi storici che ci hanno indirettamente rivelato come questi personaggi fossero bene inseriti nelle vicende politiche della capitale; infine quella degli Acta è quindi, con ogni probabilità, para-letteratura a carattere libellistico-politico, scritta e diffusa in ambienti relativi al ginnasio ales-sandrino, e dotata di una carica nazionalistico-eversiva. I testi venivano probabilmente letti in presenza di un pubblico selezionato, riunito in sale apposite, da uno (o più) lettori che, secondo alcune testimonianze lettera-rie analizzate, si occupavano della “drammatizzazione” del testo. Il papiro berlinese sarebbe dunque la testimonianza di una sorta di canovaccio con le battute divise secondo i vari personaggi: se questo testo fosse previsto per
61 G.W. boWersock, Greek Sophists in the Roman Empire, Oxford 1969, pp. 17-58; G. Anderson, The Second Sophistic, London 1993, pp. 47-68; s. nicosiA, La seconda sofistica, in G. cAMbiAno-l. cAnforA-d. lAnzA (a cura di), Lo spazio letterario delle Grecia antica, Vol. I.3, Roma 1994, pp. 85-116; l. Pernot, L’art du sophiste à l’époque romaine: entre savoir et pouvoir, in c. levy-b. besnier-A. GiGAndet (edd.), Ars et Ratio, Actes du Colloque international organisé à Créteil, Fontenay et Paris du 16 au 18 octobre 1997, Bruxelles 2003, pp. 126-142; J.J. flinterMAn, Sophists and emperors: A reconaissance of sophistic attitudes, in b.e. borG (ed.), Paideia: The World of the Second Sophistic, Berlin 2004, pp. 359-376; M.b. trAPP, Images of Alexandria in the writings of the Second Sophistic, in A. hirst-M. silk (edd.), Alexandria, Real and Imagined, Ashgate 2004, pp. 113-132; l. Pernot, La Retorica dei Greci e dei Romani, ed. it. Palermo 2006, pp. 150 ss.; P.r. MAlosse, Sophistiques et tyrannies, in e. AMAto (ed.), Approches de la Troisième Sophistique, Hommage à Jacques Schamp, Bruxelles 2006, pp. 157-178.
62 Vedi nota 52.
Modelli grafici e testuali di P. Berol. 8877 (Acta Isidori) 291
la lettura da parte di un solo professionista possiamo immaginare che le in-terruzioni facilitassero i cambi di tono e di “mimica” nella lettura, nel caso in cui invece questo testo fosse previsto per la lettura da parte di più pro-fessionisti dobbiamo postulare, oltre alla presenza di più copie strutturate in modo identico, anche che ogni copia “personale” avrebbe contenuto la suddivisione in battute di tutti i personaggi, ipotesi a dire il vero assai poco economica per un libro di questo genere.
Ne consegue che, almeno dal punto di vista della struttura interna del dialogo e della suddivisione per battute, il papiro di Berlino risulte-rebbe essere tributario di molteplici metodologie di disposizione testuale che spaziano dal protocollo giudiziario, al dialogo filosofico-letterario, dal dramma al testo recitato in sessioni pubbliche. Ci si è chiesti, in queste pagine, cosa abbia spinto lo scriba a strutturare il nostro papiro in questo modo: le ipotesi formulate sono state numerose ed in ogni caso abbiamo visto che a questa particolare conformazione doveva corrispondere un par-ticolare intento divulgativo, un particolare uso, una particolare pratica di lettura. Ma una ulteriore luce sul problema può essere senza dubbio data dalla considerazione dei punti di riferimento grafici e “bibliologici” che il nostro scriba ebbe nella strutturazione del testo, chiedendosi quale tipo di libro, quale tipo di testo influenzò il nostro. Ma questo particolare aspetto sarà oggetto di un successivo e specifico contributo.
Napoli Adriano Magnani ([email protected])
AbstrAct
The purpose of this essay is to pinpoint particular graphic modules attested by P. Berol. 8877 (Acta Isidori), and, where possible, to conse-quently explore the reading practices related to it. The Berlin papyrus will therefore be considered both from a bibliographical and material point of view as well as regards the graphic arrangement of the text. The overlap-ping of these two perspectives casts new light upon the literary and graphic status of this text, relating it to the phenomenon of public readings in the Second Sophistic.
INDICE GENERALE
Rosario Pintaudi L’ANVUR e le riviste italiane di papirologia pag. 7
Diletta Minutoli Ancora due frammenti laurenziani: Thucydides, Historiae V 57,2 Homerus, Ilias O 619-623 » 11
Diletta Minutoli-Rosario Pintaudi Esodo (IV 16-VII 21) in un codice di papiro della collezione Martin Schøyen (MS 187) » 17
Kristin De Troyer The textual character of the Exodus Codex of the Schøyen Collection (MS 187; RA 866) » 57
Rosario Pintaudi Ancora oroscopi greci su papiro: appunto per la compilazione di un oroscopo (PL III/995) » 81
Rosario Pintaudi Frammento di tavola planetaria » 87
Diletta Minutoli Vendita di vino con anticipazione di prezzo (PL III/696) » 89
Ágnes Mihálykó Frühchristlicher Brief » 95
Rosario Pintaudi-Dominic Rathbone Due lettere dell’archivio di Heroneinos nella collezione Martin Schøyen (MS 244/18; MS 244/23) » 105
Gabriella Messeri Savorelli-Rosario Pintaudi Heroniniana IV » 111
Hermann Harrauer-Rosario Pintaudi Due ordini di pagamento in denaro dall’“Archivio” degli Apioni (?) (PL III/721; PL III/449) » 137
Rosario Pintaudi Materiali per una riflessione su indirizzi, prescritti e protocolli. Note di lettura e nuove edizioni » 143
Marie Legendre Réutilisation, notes et ratures: une lettre fragmentaire et un recensement de bétail dans un papyrus arabe de la Bibliothèque Laurentienne » 171
Lucia Criscuolo Quale Cleopatra? Un’identificazione incerta » 185
Angiolo Menchetti-Rosario Pintaudi Le nuove iscrizioni del dromos di Narmuthis » 193
Rodney Ast-Roger S. Bagnall-Ali Drine-Zsuzsanna Várhelyi Two Latin Accounts on Amphora Walls from Gigthi » 205
Klaas A. Worp (ΔΙΑ)ΦΥΛACCΩ + dat.: a linguistic regionalism in inscriptions from christian egypt? » 237
Marcello Spanu Un mortarium e due pelves bollati da Antinoupolis » 241
Daniele Castrizio Le monete del castrum di Narmuthis » 255
Harald Froschauer Textilien in Florenz. Zur Ikonographie zweier Clavus-Fragmente » 261
Adriano Magnani Modelli grafici e testuali di P. Berol. 8877 (Acta Isidori) » 269
docuMenti Per unA storiA dellA PAPiroloGiA
Giovanni Indelli-Francesca Longo Auricchio Il materiale ercolanese nel Fondo Vogliano conservato a Firenze » 295
Klaus Fabian Otto Rubensohn, unveröffentlichte Briefe aus den Jahren 1904-1910 an Evaristo Breccia und eine Antwort Breccias von 1911 » 299
Rosario Pintaudi Girolamo Vitelli docente al R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze » 331
Silvia Strassi Giorgio Zalateo (Trieste 19 ottobre 1916-Trieste 29 dicembre 2010) » 347
Giuseppe Dino Baldi Firenze e l’Istituto di studi superiori nei disegni e nelle lettere di Carlo Michelstaedter (con due lettere inedite di Emilio Michelstaedter) » 355
Libri ricevuti » 419
Indici a cura di Paola Pruneti » 437