Modelli omerici nell'Alcesti di Euripide: testo e intertesto
“Perfetti modelli di dimore”: la casa alle Triennali
Transcript of “Perfetti modelli di dimore”: la casa alle Triennali
Le case Nella Triennale
dal Parco al QT8
a cura di
Graziella Leyla Ciagà
Graziella Tonon
TriennaleElecta
In copertina
P. Bottoni, Padiglione per mostre
in via Pogatschnig, sulla destra
Casa Ina-casa di P. Lingeri e L. Zuccoli
Coordinamento editoriale
Cristina Garbagna
Redazione
Maria Grazia Luparia
Coordinamento grafico
Dario Tagliabue
Progetto grafico e copertina
Sebastiano Girardi
Studio Camuffo, Venezia
Impaginazione
Sara De Michele
Coordinamento tecnico
Mario Farè
Controllo qualità
Giancarlo Berti
Le case nella Triennale
dal Parco al QT8
Milano, Palazzo della Triennale
19 maggio 2005 – 24 luglio 2005
in collaborazione con
Catalogo e mostra a cura di
Graziella Leyla Ciagà
Graziella Tonon
Ideazione e coordinamento
Fulvio Irace
Hanno collaborato
Antonio Colnago, Maria Teresa Feraboli,
Tommaso Tofanetti
Allestimento
Giovanni Marzari con Antonello Agolino,
Gianluca Dossi, Alessia Girardelli,
Véronique Schwalm
I materiali esposti in mostra appartengono a
Archivio Piero Bottoni, DPA, Politecnico
di Milano; Archivio storico, Fondazione
La Triennale di Milano; Fondo Luigi Figini
e Gino Pollini, MART, Rovereto; Archivio
Gianni Mantero, Como; Centro Studi
Giuseppe Terragni, Como; Collezione privata,
Milano; Collezione Studio Albini Associati,
Marco e Francesco Albini, Milano
Il modello della Casa giardino di Piero Bottoni
– finanziato dal Dipartimento di Progettazione
dell’Architettura, Politecnico di Milano –
è stato realizzato da Renato Aiminio
e Francesco Montaldo con Emanuela
Bartolini e Beatrice De Carli
(Laboratorio di Modellistica, DPA)
Le animazioni in 3D delle case unifamiliari
costruite alla V Triennale sono state curate
da Nunzio Marsiglia con Francesco Maggio
e Marcella Villa, realizzazione tecnica
di Marco Alesi (Università di Palermo,
Dipartimento di Rappresentazione)
Si ringraziano
Marco Albini, Fabio Bassanini,
Giancarlo Consonni, Davide Mantero,
Massimo Fortis, Sara Iannuzzi,
Ferruccio Luppi, Paola Pettenella,
Maurizio e Marilisa Pollini, Carlo Prosser,
Renzo Riboldazzi, Francesco Samassa,
Elisabetta Terragni
© 2005 La Triennale di Milano
Una realizzazione editoriale
Mondadori Electa S.p.A., Milano
www.electaweb.it
Dal momento della sua fondazione, la Triennale di Milano ha progressivamente allargato la sfera
dei propri interessi alle tematiche dell’architettura e dell’urbanistica. Dal dopoguerra a oggi, queste
discipline hanno inciso profondamente sull’equilibrio dei territori e sulla vita delle persone, soprattutto
in relazione alla questione dell’abitare, in continua oscillazione tra la dimensione soggettiva del vivere
luoghi costruiti su misura di chi li abita, e quella oggettiva della “casa” intesa come necessità
funzionale e diritto sociale.
La Triennale di Milano, nel corso di questi ultimi decenni, ha partecipato in maniera attiva al dibattito
che si è sviluppato attorno a queste problematiche, raggiungendo con la realizzazione del QT8
un altissimo livello di coinvolgimento sia progettuale sia etico e sociale.
La casa dovrebbe costituire per tutti un meraviglioso progetto di intimità, fatto di oggetti, colori,
tessuti, materiali, luci: un teatro ideale nel quale ciascuno dovrebbe poter allestire la rappresentazione
quotidiana della propria vita. Uno spazio privato nel quale trovare rifugio e protezione; il luogo
del presente e al tempo stesso l’archivio della memoria.
Nelle moderne metropoli, dove la tipologia straniante del “non-luogo” sembra dilagare, anche le case
tendono a perdere il loro valore di rifugio dell’intimità e di custodia della memoria personale.
Da qui la necessità di affrontare il tema dell’abitare nella logica di una rinnovata cultura del progetto,
che inserisca la costruzione delle case all’interno di un sistema di design urbano capace di restituire
agli uomini la dimensione originaria dei territori come “luoghi degni di essere vissuti”.
Secondo questa prospettiva, un dibattito sulla casa e sull’abitare costituisce un momento di intensa
riflessione sugli uomini e sulle prospettive della loro esistenza. Un dibattito che la Triennale intende
promuovere e sviluppare, non solo ponendo la questione abitativa al centro delle proprie attività
di ricerca ma impegnandosi concretamente, sulla base degli accordi stretti con il Comune di Milano,
a ideare e realizzare, in forma di prototipi sperimentali, nuove e innovative soluzioni progettuali
che dal tema della casa si estenderanno progressivamente a una molteplicità di tematiche relative
allo sviluppo delle città e alla qualità della vita dei loro abitanti.
Davide Rampello
Presidente della Triennale di Milano
Fondazione La Triennale di Milano
Consiglio d’Amministrazione
Mario Boselli
Paolo Caputo
Roberto Cecchi
Silvia Corinaldi Rusconi Clerici
Arturo Dell’Acqua Bellavitis
Carla Di Francesco
Davide Rampello, Presidente
Collegio dei Revisori dei conti
Adriana Rampinelli, Presidente
Domenico Salerno
Andrea Vestita
Direttore Generale
Andrea Cancellato
Comitato scientifico
Silvana Annicchiarico, design, moda, arti
decorative e visive
Aldo Bonomi, industria e artigianato
Fausto Colombo, nuovi media,
comunicazione e tecnologia
Fulvio Irace, architettura e territorio
Collezione permanente del design
Silvana Annicchiarico, conservatore
Elisa Testori
Settore Affari Generali
Annunciata Marinella Alberghina
Elena Cecchi
Franco Romeo
Settore Biblioteca, Documentazione, Archivio
Tommaso Tofanetti
Roberto Giusti
Settore Iniziative
Laura Agnesi
Roberta Sommariva
Settore Servizi Tecnici Amministrativi
Marina Gerosa
Pierantonio Ramaioli
Anna Maria D’Ignoti
Giuseppina Di Vito
Isabella Micieli
Franco Olivucci
Alessandro Cammarata
Ufficio Marketing e Comunicazione
Laura Benelli
Valentina Barzaghi, collaboratore
Maria Chiara Piccioli, collaboratore
Ufficio Stampa
Antonella La Seta Catamancio
Damiano Gullì, collaboratore
10 Presentazione
Fulvio Irace
12 La casa per tutti
La Triennale e la città
Graziella Leyla Ciagà
34 QT8: urbanistica e architettura
per una nuova civiltà dell’abitare
Graziella Tonon
Le case e le Triennali
106 “Perfetti modelli di dimore”:
la casa alle Triennali
Massimiliano Savorra
126 Schede
a cura di Maria Teresa Feraboli, Roberto Dulio, Stefano Poli
Apparati
168 Bibliografia generale
a cura di Maria Teresa Feraboli, Laura Montedoro
Abbreviazioni
APBArchivio Piero Bottoni, Dipartimento di Progettazionedell’Architettura, Politecnico di Milano
FLTMArchivio storico, Fondazione La Triennale di MilanoArchivio fotografico, Fondazione La Triennale diMilano
MARTFondo Luigi Figini e Gino Pollini, Archivio del ’900,Mart, Rovereto
MVMarcella Villa, Architettura demolita, tesi di laurea,relatore Nunzio Marsiglia, correlatore FrancescoMaggio, Università di Palermo, Facoltà diArchitettura, a.a. 2003-2004
FPMFondazione Piero Portaluppi, Milano
AAMCollezione Studio Albini Associati, Marco e Francesco Albini, Milano
AMCArchivio Gianni Mantero, Como
CPMCollezione privata, Milano
sommario
Nel 1957, considerando quanto una storia
delle Triennali risultasse impossibile –
risolvendosi, qualora la si fosse tentata, in
una esperienza “antistorica” – Agnoldomenico
Pica provava a spiegare la “singolarità”
o meglio, l’“unicità” di mostre apertesi ogni
volta “sotto il segno dello scandalo”1.
È evidente come, degli eventi espositivi,
il critico cogliesse il compito “eminentemente
provocatorio”, più che documentario,
assegnato alle Triennali a partire dalla loro
nascita. E in effetti, nella sua “giustificazione
esegetica” Pica ben comprendeva che “non
si trattava di mostrare il più recente volto
delle cose, l’ultimo aspetto del mondo, il più
inedito atteggiamento dell’arte, ma di indicare
quali questo volto, questo aspetto, questo
atteggiamento sarebbero stati per essere
domani o – almeno – quali si avrebbe voluto
che essi fossero”2. In tal senso, l’architettura
– e nello specifico la casa, “monumento
del secolo” – può essere considerata il tema
portante del racconto delle prime Triennali,
il riflesso ideale di quel volto, aspetto,
atteggiamento, evocati da Pica.
Verso l’architettura: le esposizioni di Monza
Apertasi nel 1923 nella villa Reale di Monza3,
la “Prima mostra internazionale delle arti
decorative” propone quella che è stata
definita “una campanilistica messa in scena”,
attraverso un’organizzazione di centottantasei
sale “addobbate come fiere di paese”4, e un
programma fondamentalmente ripreso, ma
in forme ridotte, da quello attuato vent’anni
prima nella grande esposizione di Torino5.
Tuttavia, nel corso della mostra si intuisce
quanto l’architettura possa diventare il terreno
comunicativo più efficace per la vendita della
merce esposta. Difatti, al congresso degli
espositori presieduto da Vittorio Pica, insieme
alle discussioni nate intorno all’opportunità
di una manifestazione selettiva piuttosto che
esaustiva e ridondante, emerse l’esigenza –
espressa tra gli altri da Depero e Prampolini,
all’intraprendente ideatore nonché direttore
generale dell’esposizione Guido Marangoni –
di una maggiore “misura architettonica”6 con
edifici realizzati all’aperto “con libertà di stile”7,
in quanto solo il “valore promozionale e
iconologico insito nelle piccole costruzioni
effimere” avrebbe permesso di “offrire una
ambientazione congruente e degna agli
insiemi di oggetti destinati ad essere
‘rappresentati’ nel e dal padiglione”8.
Dall’allestimento al padiglione provvisorio,
la necessità di una presenza significativa
dell’architettura si affacciava in maniera
preponderante anche negli scritti apparsi
durante e subito dopo la rassegna monzese9.
Malgrado le richieste avanzate al congresso
del 1923 e gli auspici di Marangoni10, nel
1925 l’introduzione nella “Seconda mostra
internazionale delle arti decorative” di una
sezione dedicata all’“Edilizia ed arte
pubblica”11 si rivelò, tuttavia, insufficiente,
soprattutto se confrontata con la presenza
“architettonica” alla concomitante esposizione
parigina delle arti decorative12. Peraltro, fra
le sottosezioni “Estetica del lago” e “Estetica
della montagna”, dominava ancora – nelle
parole di Marangoni – il senso di uno
“dei campi più pittoreschi e meglio graditi
al pubblico della I Biennale: quello dell’arte
paesana e folkloristica”13.
Bisognerà attendere l’esposizione del 1927
per assistere ai primi, tangibili segni
di architetture concrete, come il padiglione
del libro delle case editrici Treves e
Bestetti-Tumminelli14. Confermando il ruolo
del progettista nel sistema produttivo
industriale, nonché dell’architetto quale
allestitore di stand, la terza mostra monzese
si arricchiva di “manifestazioni d’architettura,
piene di fermenti per l’avvenire”15, non solo
con le “internazionali” e dirompenti
esercitazioni grafiche dei giovani del Gruppo
7, ma anche grazie alle colte e raffinate
proposte degli architetti del “Labirinto”
o degli artisti, diventati architetti per
l’occasione, Depero, Casorati, Sobrero,
Deabate, Menzio e Chessa.
“Perfetti modelli di dimore”:La casa alle Triennali
Massimiliano Savorra
106
Certo, tanto nelle Botteghe d’arte e nella sala
della “Comunità dei cultori delle arti e
mestieri” di Giandante, quanto nello spazio
occupato dai modelli e dai disegni di Pollini,
Figini, Rava, Larco, Terragni, non emergeva
ancora la questione della casa. Come è noto,
gli obiettivi erano dichiaratamente altri.
I membri del Gruppo 7 affronteranno il
problema con impeto, facendolo divenire
oggetto di riflessione specifica, soltanto dopo
aver visitato la Weissenhofsiedlung e le tre
altre grandi mostre di Stoccarda, dove
peraltro si ritrovarono a esporre i loro progetti
“razionalisti”16.
Infatti, la questione della casa – di sicuro non
nuova per la cultura architettonica italiana,
ma nuova nella sua dimensione di massa17 –
irromperà nel dibattito culturale nazionale
proprio dopo l’esposizione del Weissenhof18,
destando l’interesse oltre che dei giovani
architetti presenti alla mostra monzese, anche
di quei protagonisti dell’architettura italiana,
che in tempi e modi diversi visitarono
l’insediamento-modello tedesco19.
A partire dagli anni successivi alla Grande
Guerra, paesi come l’Italia, dove la questione
abitativa era fortemente sentita, si trovarono
a fronteggiare le medesime difficoltà, legate
al superamento dei criteri costruttivi
tradizionali e all’introduzione di metodi
industriali per ridurre costi e tempi. In tal
senso, il Weissenhof rappresentava un
laboratorio privilegiato, una vetrina di offerte
modello per soluzioni concrete20.
Un osservatore attento dell’evento tedesco
come Griffini mise in evidenza – in una
conferenza tenuta nel novembre 1927 –
proprio la mostra dei materiali, allestita come
corollario del quartiere, in cui erano esposti
i sistemi costruttivi adottati nella Siedlung21.
Nel marzo del 1928 – sulle pagine
della neonata “Domus” – constatando il fiorire
degli studi attorno al problema della casa
economica e i lodevoli tentativi tedeschi
e olandesi, Griffini rimarcava ulteriormente
l’importanza del Weissenhof “per il
107
G. Ponti, E. Lancia, Casa per vacanze,IV Triennale di Monza, 1930 (FLTM).
Casa per vacanze, vista prospettica, IV Triennale di Monza, 1930.
perfezionamento di uno tra i sommi beni
dell’uomo ed una delle sue maggiori
aspirazioni: la casa comoda e bella”22.
La “colonia” di Stoccarda risultava di sommo
interesse, “essendo in essa rappresentati
tentativi ed espressioni diverse e coordinate
della nuova tendenza, elementi chiari e
convincenti scaturiti dalla logica severa e
precisa che governa gli odierni indirizzi”23.
Negli scritti di Griffini, così come nelle
riflessioni di buona parte dei membri del
Gruppo 7, l’idea lecorbusiana della casa-
macchina – “la casa cioè dove ogni
particolare deve essere studiato con
razionalità rigorosa e deve in tutto soddisfare
all’ideale del massimo rendimento col minimo
sforzo”24 – è assunta come tópos retorico per
mettere in atto, una volta assimilati i
meccanismi della casa “logica”, la
sperimentazione di nuove realtà abitative.
Un’idea di casa, del resto, ripresa anche
dal Gant, il gruppo degli architetti “novatori”
torinesi25, all’esposizione per il decennale
della Vittoria – tenutasi nel 1928 al parco
del Valentino a Torino – e che risulta centrale
nella proposta di Casa Elettrica nella mostra
monzese del 1930.
Dopo l’esposizione del 1927 si delinea
dunque un’idea di “‘razionalizzazione’
dei comportamenti domestici, di definizione
di uno ‘stile nazionale’ perlomeno nelle forme
dell’arredo, di ‘domesticizzazione’ della
disciplina, unitamente a progetti, senz’altro
‘razionali’, di incentivazione della produzione
e del consumo di tutto ciò che va a costituire
108
il panorama domestico”26, e soprattutto
si comprende il fondamentale ruolo della
effettiva costruzione di architetture che
per così dire “espongono se stesse”,
nello specifico di case-manifesto.
Non va dimenticato inoltre quanto esperienze
progettuali e riflessioni teoriche sulla casa
rispecchiassero direttive della politica fascista
in tema di abitazioni, nate in prima istanza per
risolvere le drammatiche condizioni delle città
più congestionate, e rafforzate via via dai
dettati ideologici e propagandistici sull’assetto
della famiglia27. Del resto, le esperienze
architettoniche europee che influenzarono
l’idea di casa sul versante tecnologico-
costruttivo e su quello stilistico-formale,
si innestarono su una tradizione di studi
sulla casa contadina e sulla casa pompeiana
o latina, portati avanti da architetti italiani
di formazione diversa, come sarà evidente
nella quarta, non più Biennale, esposizione
del 1930.
Prototipi e sperimentazioni:
1930, le prime case-manifesto
Affermatone il carattere permanente,
e sancitane la scadenza triennale, la
manifestazione fu ufficialmente riconosciuta
dallo Stato italiano28 e affidata
provvisoriamente alla gestione di un
commissario straordinario, il senatore
Giuseppe Bevione, in attesa che venisse
nominato il consiglio di amministrazione.
L’organizzazione dell’esposizione fu affidata
a un direttorio composto da Gio Ponti, Mario
Sironi e Alberto Alpago Novello, quest’ultimo
in seguito sostituito da Carlo Alberto Felice.
Nel programma gli “ordinatori” individuano
i criteri di selezione degli oggetti, indicando
come parametri la “modernità di
interpretazione”, l’“originalità di invenzione”,
la “perfetta esecuzione”, l’“efficienza
di produzione”. La IV Triennale metteva
in evidenza, per la prima volta in maniera
lampante, i “problemi di produzione e
di economia”, come avvertiva la premessa
al catalogo ufficiale29. Si domandava in tal
senso di andare oltre, come sosterrà Pica,
“di arrivare a proposte, a forme, a strutture
che fossero di per se stesse valide, in
assoluto, al di fuori anche del tempo, e che
non si affidassero soltanto al solletico
della novità, o alle compiacenze effimere
della moda”30. Produzione ed economia,
109
L. Lovarini, Casa del dopolavorista, vista interna, IV Triennale di Monza,1930 (FLTM).
Gruppo 7, Casa Elettrica, ingresso del padiglione, IV Triennale di Monza,1930 (CPM).
E. Faludi, Progetto di villa sul lago, IV Triennale di Monza, Galleriadell’Architettura, 1930.
U. Cuzzi, Progetto di villa al mare, IV Triennale di Monza, Galleriadell’Architettura, 1930.
E.A. Griffini, Progetto di villa in collina, IV Triennale di Monza, Galleriadell’Architettura, 1930.
Progetto di villa in collina, spaccatoassonometrico, IV Triennale di Monza,Galleria dell’Architettura, 1930.
G. Pulitzer Finali, Progetto di villa al mare, IV Triennale di Monza, Galleria dell’Architettura, 1930.
111
termini “esatti” da affiancare a quello più
ambiguo di sperimentazione, divenivano gli
elementi fondanti di un mutamento graduale:
dagli oggetti di uso quotidiano esposti negli
ambienti della villa Reale ai modelli abitativi
di tre case costruite nel parco circostante,
il rinnovamento filtrava attraverso il proposito
di dare inedite espressioni formali a una
nuova concezione “etica e pratica” della vita,
come scrisse Ponti, riconoscendo quanto
“i problemi d’arte sono per il nostro Paese
problemi di prestigio nazionale e di decoro
rappresentativo della nostra civiltà, da cui
dipendono, con un valore economico di alte
possibilità di sviluppo, autorità e vantaggio
nei mercati del mondo”31.
Protagonista indiscusso delle ultime
esposizioni monzesi e delle prime milanesi,
Ponti orchestra magistralmente attorno a sé
un manipolo di progettisti, giovani e meno
giovani, con l’obiettivo comune di concretare
la sua articolata filosofia dell’abitare, ben
espressa negli articoli apparsi su “Domus”
e nella raccolta di scritti del 1933 intitolata
La casa all’italiana32. Non può pertanto
sfuggire, nei tre anni che separano le ultime
esposizioni monzesi, la febbrile e incessante
ricerca su più livelli, non ultimo quello
linguistico: per la casa l’obiettivo da
raggiungere risultava essere – come ricordava
Ponti – lo stile italiano.
Sorte infatti per volere di Ponti, le case erette
nel parco, diversamente caratterizzate per
destinazione sociale, affermavano in maniera
decisiva rispetto alle precedenti edizioni il
contributo essenziale dell’architettura, e non
soltanto nella ridefinizione dello spazio
domestico; tre piccoli edifici che, più di ogni
altro oggetto esposto in mostra, in uno spirito
efficientistico e didascalico manifestavano la
responsabilità dell’architettura come tecnica
d’intervento33.
Al di là delle disuguali connotazioni
ideologiche e linguistiche assunte dalle tre
case-padiglioni, va rimarcato quanto esse,
in modo parallelo, esplicitassero i propositi
e le riflessioni sulla casa e sui diversi modi
di abitare. E se la Casa di Vacanze di Ponti
e Lancia, realizzata grazie al finanziamento
di “La Rinascente” e della De Angeli Frua,
si riallacciava a quei progetti di piccole dimore
destinate a una agiata classe borghese
apparsi su “Domus” a partire dalla sua
nascita34, la Casa del Dopolavorista della
pittrice Luisa Lovarini si legava, come è stato
sostenuto, a “quel ‘Villaggio’ che è forma
di conclusione, soprattutto ideologica, dei
Concorsi nazionali dell’Opera nazionale
dopolavoro”35. Grazie alla partecipazione
fondamentale della Società Edison, Luigi
Figini e Gino Pollini – con la collaborazione
di Piero Bottoni36 per gli ambienti di servizio,
e di Guido Frette e Adalberto Libera per parte
degli arredi interni – hanno modo di realizzare
la Casa Elettrica, definendo una planimetria
più articolata rispetto agli altri prototipi
abitativi, e dimostrando al contempo una
consapevole attenzione verso funzioni,
percorsi, orientamento. E se è vero che, con
la Casa del Dopolavorista, la Casa di Vacanze
e la Casa Elettrica, si tentava di sciogliere
i nodi della questione sul piano “di ideologia
110
comunicativa”, è pur vero che in mostra
durante la quarta triennale si esposero anche
progetti tesi alla definizione di un nuovo modo
di abitare, per quanto taluni ancora lontani
dalla “standardizzazione” – o “tipificazione” –
della casa moderna, pubblicizzata ormai
perfino su riviste rivolte a una platea di lettori
non specialisti37. Infatti, il direttorio richiese
sotto forma di concorso agli architetti italiani
lo sviluppo di un unico tema – una villa
moderna per l’abitazione di una famiglia
media – “affinché l’architettura, che presiede
e governa le manifestazioni delle arti
applicate, fosse degnamente rappresentata
nella IV Triennale”38. Più di una cinquantina
di autori inviarono i progetti, che furono poi
selezionati, oltre che dal direttorio, anche da
una commissione formata da Alberto Calza
Bini, Pietro Betta, Marcello Piacentini e Enrico
Agostino Griffini39, per essere quindi esposti
nella Galleria dell’architettura in una mostra
curata da Griffini e Luigi Maria Caneva.
Quantunque il problema della casa moderna,
“novecentista” o “razionalista”, fosse ancora
affrontato con connotazioni di classe e di
costume40, alcuni progetti rappresentavano
egregiamente, secondo Ponti, vere e proprie
“interpretazioni” dell’abitazione, “cioè della
nostra vita e, se vogliamo, della nostra
civiltà”41. Comodità e igiene da un lato, “agio
morale” e “ospitalità sicura e duratura” per
lo spirito dall’altro, caratterizzavano le
trentasei ville pubblicate con un chiaro intento
divulgativo nel volume curato sempre
da Griffini e Caneva42. Sennonché, riflettendo
una diffusa ricerca sulla tipologia, nello
specifico di una casa residenziale unifamiliare,
il catalogo offriva un eccezionale campionario
di sperimentazioni, e consentiva di leggere
continuità e variazioni, se non punti di vera
rottura, con i precedenti, e per certi versi
analoghi, répertoires di Ville e villini,
ampiamente diffusi tra anni dieci e anni venti
a uso e consumo dei piccoli costruttori locali.
In un ventaglio di proposte caratterizzate da
lessici più o meno “moderni”, più o meno
aggiornati, talune soluzioni compositive
si segnalavano per il rigore progettuale, e per
113112
Veduta delle case nel Parco Sempione, V Triennale di Milano, 1933 (MART).
V Triennale di Milano, 1933, planimetriadel Parco Sempione (FLTM).
L. Vietti, Progetto di villa sul lago, IV Triennale di Monza, Galleriadell’Architettura, 1930.
G. Pollini, L. Figini, Villa-studio per un artista, scultura di Fausto Melotti, V Triennale di Milano, 1933 (CPM).
G. Terragni, A. Dell’Acqua, G. Mantero,O. Ortelli, C. Ponci, M. Cereghini, P. Lingeri, G. Giussani (gruppocomasco), Casa per le vacanze di un artista sul lago, V Triennale di Milano, 1933 (FLTM).
115114
per stabilire un moderno “stile” di vita.
In verità, come risulta dai documenti rinvenuti,
nelle idee iniziali del direttorio e del
presidente, perno delle future Triennali
sarebbe dovuta essere la costruzione – in
un’area centrale messa a disposizione
dal comune di Milano, o nei giardini pubblici
del parco – di una serie di edifici, più che
di semplici case-padiglione, concepiti
organicamente in modo da costituire un
quartiere di piccole case moderne dominato
da un edificio semi-permanente “nel quale il
pubblico vedrà raccolto il repertorio completo
di quelle produzioni d’arte che avran
contribuito ad arredare le case stesse”51.
Una volta diffuso il programma della mostra,
in ogni città italiana iniziarono a costituirsi
gruppi e comitati per la raccolta dei fondi da
destinare alla costruzione delle piccole case.
Nel programma, oltre alla “Mostra
dell’abitazione”, si dava risalto anche alla più
canonica “Mostra di architettura”, da
realizzarsi con grafici, fotografie su pannelli
e plastici esemplificativi. Per l’organizzazione
di quest’ultima, Barella chiese la
partecipazione diretta di Calza Bini e del
Sindacato nazionale architetti che segnalò
due delegati, Pietro Aschieri e Alberto Alpago
Novello, quest’ultimo già sostituito nel
direttorio da Carlo Alberto Felice.
Interpretata come esemplificazione concreta
della mostra grafica dell’architettura52,
la costruzione degli edifici nel parco venne
affidata dal direttorio quasi totalmente a
giovani architetti. Sperimentazioni distributive
da un lato, applicazioni di materiali moderni
dall’altro: in sintesi erano questi i due indirizzi
prevalenti nelle proposte che andavano
realizzandosi. Che fossero case per vacanze,
per artisti o per aviatori, per sposi o
conduttori di fattoria, i prototipi erano
accomunati da una generale adesione ai
processi industriali, sia nell’organizzazione
interna, sia nelle modalità costruttive. Anche
magistrali esercizi compositivi, come la casa
del gruppo di architetti comaschi (Terragni,
Lingeri, Dell’Acqua, Mantero, Ortelli, Ponci,
Cereghini, Giussani)53, la miesiana villa studio
di Figini e Pollini – considerata da Pica il
capolavoro dell’intera Triennale – o la Casa
del sabato ideata da Portaluppi con i BBPR54,
ricorrevano – nel loro realizzarsi con materiali
più o meno costosi – ai procedimenti offerti
dalla moderna industria edilizia. Una sagace
utilizzazione di nuovi materiali che
caratterizzava, peraltro, anche la Casa
coloniale di Luigi Piccinato e la raffinata casa
di Cesare Scoccimarro e compagni55.
In taluni casi, era evidente l’applicazione
all’idea di casa pontiana dei paradigmi
tayloristi e dei concetti della moderna
organizzazione del lavoro in fabbrica: rapidità,
economia, produzione in serie. Collegandosi
alla teoria della mass production e ai principi
dell’assembly line di matrice fordiana, alcune
delle trentatré costruzioni si caratterizzavano
per la flessibilità con cui potevano essere
realizzate. Smontabili, mobili, prefabbricabili,
economiche, trasportabili e trasformabili, le
cinque villette per “fine settimana” costruite
da Eugenio Faludi, Enrico Agostino Griffini
e Piero Bottoni intorno al ruscello che
attraversa il parco56, si differenziavano anche
117
il palese tentativo di costruire un contesto
adeguato ai singoli oggetti, nella convinzione
che l’architettura, arte maggiore, potesse
presiedere e governare le manifestazioni
di arte applicata.
In un singolare accostamento, le suggestioni
tautiane e i richiami ad architetture di
Holzmeister evidenti nella “villa in collina” di
Griffini si confrontavano con le mediterranee
evocazioni suggerite da Cuzzi o da Pulitzer
Finali. E che fosse una villa da costruirsi
sulla riviera ligure di levante (Albini e Palanti),
sulla punta di Amore a Cannobio (Vietti),
o sull’ungherese lago di Balaton (Faludi),
l’immagine che comunque si offriva restava
saldamente ancorata all’idea enunciata da
Ponti “di casa come spazio integrale
dell’attrezzatura abitativa”43. Non è un caso,
che proprio in quest’ultima esposizione
monzese, si affermi con chiarezza l’aspetto
“didattico” di tale nozione pontiana. Questa
strategia divulgativa avrebbe rafforzato, dopo
la chiusura della mostra, il proposito e la
necessità di costruire case-modello.
Grazie a Ponti, nella successiva edizione
della Triennale il tema della casa assunse
indiscutibilmente un ruolo cruciale, divenendo
fine e pretesto di riflessioni più ampie su
linguaggio, industria, oggetti di serie e
condizioni di vita. Mediante la costruzione
di tante piccole case e l’esposizione
di “prodotti e riproduzioni di opere d’arte
eseguite da architetti d’oggi”, nonché
di “manifestazioni esemplari in ogni ramo
dell’edilizia moderna”, la V Triennale avrebbe
potuto costituire una grande opportunità per
Milano, un “avvenimento culminante dell’anno
XI, anche dal lato turistico”, tanto da far
auspicare che il 1933 fosse considerato
“anno della Triennale”44.
Le case della V Triennale di Milano:
la regia di Gio Ponti
Il 23 gennaio 1932, in una sala concessa
dalla Federazione fascista autonoma delle
Comunità artigiane d’Italia, si insediava il
nuovo consiglio di amministrazione della
Triennale – fino a quel momento
commissariata – presieduto da Giulio Barella,
e composto da membri illustri, quali Marcello
Piacentini, Alberto Jannitti Piromallo, Aldo
Carpi, Arturo Tosi45. Va subito rilevato come il
neocostituito consiglio dovesse tenere conto
di una struttura già funzionante nelle sue linee
programmatiche e organizzative grazie al
direttorio guidato da Ponti. La situazione
suscitò perplessità da parte di Piacentini, il
quale, nella seduta di insediamento, chiese
delucidazioni circa il proprio ruolo effettivo.
Gli venne assicurato che, per il momento,
avrebbe svolto una funzione di controllo,
ma che in seguito avrebbe avuto un compito
ben più importante; un compito che, come
vedremo, non mancherà di esercitare
nella VI Triennale.
In questa occasione Ponti presentava i criteri
fondamentali su cui si basava il programma
della “Esposizione di architettura”, già
ampiamente diffuso dall’agosto 1931
attraverso la stampa46 e altre forme di
propaganda47. Una delle manifestazioni
principali della V Triennale, da realizzarsi
a Milano nel palazzo che Muzio andava
costruendo nel Parco Sempione con
i fondi della Fondazione Bernocchi48, sarebbe
stata la “Mostra dell’abitazione”, la cui
organizzazione avrebbe richiesto “particolari
cure, trattandosi di far concorrere gruppi
di architetti dei vari centri e di far finanziare
le rispettive ‘costruzioni’ dagli Enti locali”49.
Costruzioni disseminate nell’intero parco,
e che sarebbero state “perfetti modelli di
dimore” – come scrisse Barella a Mussolini –
“organismi completi” nei quali ogni elemento
particolare doveva concorrere e partecipare
“ad una unità artistica superiore”50. Concepite
e arredate secondo i “bisogni e i costumi
d’oggi”, le case, complete di suppellettili
e ornamenti, avrebbero avuto il compito
di mostrare quanto l’insieme – dai mobili ai
quadri, dagli apparecchi di illuminazione agli
impianti e ai servizi – risultasse determinante
116
P. Portaluppi, BBPR, U. Sabbioni, L. Santarella, Casa del sabato per glisposi, veduta della scala elicoidale, V Triennale di Milano, 1933 (FPM).
L. Piccinato, Casa coloniale, V Triennaledi Milano, 1933 (FLTM).
C. Scoccimarro, P. Zanini, E. Midena,Casa dell’aviatore, veduta della scalaelicoidale, V Triennale di Milano, 1933.
L. Moretti, M. Paniconi, G. Pediconi, M. Tufaroli, I. Zanda, Casa di campagnaper un uomo di studio, V Triennale di Milano, 1933 (FLTM).
in base ai materiali costruttivi adottati.
Modello di casa edificabile nelle vicinanze
di un lago in sole quarantotto ore, la villetta
nota come la numero 1 – progettata dal solo
Faludi57 – era costituita da un’ossatura
di legno, rivestita esternamente con lastre
di eternit, e internamente con doppio strato
di pannelli di insulite e di legno compensato,
un sistema che avrebbe abolito tutti i materiali
“idraulici” con enorme risparmio di tempo e di
mano d’opera. Ideale per una famiglia
numerosa, la Casa da mezza montagna,
smontabile e trasportabile, era formata invece
da elementi standardizzati, che permettevano
una realizzazione completa in meno di otto
giorni. E se le lastre in celotex e il pavimento
in linoleum di quest’ultima casa avrebbero
garantito l’isolamento dagli agenti esterni,
il tetto spiovente in eternit ondulato della
Casa per montagna (la numero 3) avrebbe
protetto da più rigidi climi. Fabbricata in
magnesilite con solai Sap, la lecorbusiana
villetta numero 4 “per spiaggia marina”,
sostenuta da colonne tubolari Mannesmann,
poggiava su una piattaforma di laterizi
speciali, a differenza della Casa di campagna
a un solo piano, costruita in legno e rivestita
in klinker. Sottolineando i vantaggi tecnico-
economici, Sigfried Giedion scriveva:
“Queste casette per week end, presentate
in grandezze assai diverse, ma fornite
di ambienti straordinariamente grandi
nonostante il prezzo assai ridotto e costruite
in parte secondo nuovi criteri tecnici,
rappresentano la parte meglio riuscita di tutta
l’esposizione”58.
Proprio per l’applicazione di moderni prodotti
per l’edilizia, di veloci processi di messa in
opera, di nuovi impianti distributivi adattabili
e trasformabili a seconda delle esigenze,
il gruppo di cinque villette suscitò enorme
curiosità e interesse. Va ricordato come,
proprio in quegli anni, accanto all’idea
della “casa-macchina da abitare”, si andasse
diffondendo in Europa quella della “casa
crescente”, un’abitazione adattabile cioè
“ad ogni cambiamento dell’abitante,
sia cambiamento dello stato di famiglia,
sia cambiamento psicologico, sia economico
o sociale”59. Alterazioni e trasformazioni erano
118
consentite anche dalla facilità con cui si
potevano realizzare tramezzature mobili,
come era evidente nel ben congegnato
edificio a cinque piani di Daneri e Vietti
o, ancor più, nella Casa a struttura di acciaio
del gruppo Pagano, Albini, Camus, Palanti,
Mazzoleni, Minoletti. Tale idea di flessibilità
poteva applicarsi soltanto a patto di accettare
completamente il concetto di “standard”, ben
esemplificato anche dall’elegante casetta in
legno per le vacanze di Emilio Lancia, che
aveva pareti e soffitti di lastre di insulite e
pavimentazioni in linoleum, materiale tra i più
usati in mostra. Del resto, la cospicua
presenza di prodotti moderni per l’edilizia,
leggeri e di facile trasporto (dalla galatite
alla lincrusta), costituiva una novità assoluta
rispetto alle edizioni precedenti.
Utilizzando le ultime trovate dell’industria
del costruire e i più aggiornati procedimenti
operativi, i modelli “al vero” realizzati nel
parco – sebbene lontani dalle istanze di
realismo espresse dal duce – portavano con
sé un’idea di “casa per tutti” ante litteram,
quella casa singola o raggruppata che “abbia
tutti i requisiti richiesti dai progressi moderni,
in una cornice di decoro moderato e adatta
ai più ampi strati della popolazione”.
Anticipando i termini del dibattito successivo,
Piacentini scriveva a tal proposito: “Si tende
a creare la casa alla portata di tutti, a
produrre la ‘balilla’ dell’abitazione, perché
ormai il palazzo o la villa signorile sono
da considerarsi come temi d’eccezione”60.
Questa idea di casa accessibile a tutti,
si esplicitava non solo nelle raffinate
case-villette per il ceto medio, ma anche
nel Gruppo di elementi di case popolari,
un padiglione dimostrativo ideato da Griffini
e Bottoni, sulla scia delle esperienze
di Alexander Klein e di Bruno Taut.
Difatti, il tema della casa razionale per tutti
trovava applicazione in un insieme di “case
minime” sorte per interessamento dell’Icp
di Milano61. In un denso articolo pubblicato
sulle pagine di “Quadrante” a illustrazione
dell’opera realizzata con Bottoni, Griffini
indicava i problemi risolti mettendo in atto
le teorie kleiniane sullo studio planimetrico
dei vari tipi di alloggi popolari62.
119
E.A. Griffini, E. Faludi, P. Bottoni, Colonia di case per vacanza, Casa da mezza montagna, vedutaesterna, particolare costruttivo, cantierein corso d’opera, V Triennale di Milano,1933.
M. Canino, G.B. Ceas, F. Chiaromonte,Al. Sanarica, Casa sul golfo, V Triennaledi Milano, 1933 (FLTM).
La razionalizzazione e la semplificazione
del lavoro casalingo, in special modo quello
in cucina, erano affrontate con particolare
cura; in tal senso, finanche l’arredamento era
studiato avendo come principio esclusivo
la funzionalità, con la realizzazione di mobili
ad hoc per evitare ingombri inutili, e di
tinteggiature con colori adatti “a conservare
negli abitatori l’amore per la casa”63.
Il 31 ottobre 1933 la prima milanese
“Esposizione triennale delle arti decorative
e industriali moderne e dell’architettura
moderna” chiudeva i battenti64: 650.000
visitatori a pagamento avevano potuto
ammirare le case nel Parco Sempione
e le mostre tenutesi nel Palazzo dell’Arte,
garantendo all’istituzione un incasso di oltre
cinque milioni di lire, e alle ditte espositrici
vendite di prodotti per circa un milione, oltre
a ingenti ordinazioni di articoli e manufatti.
Marcello Piacentini e la Triennale:
la scomparsa delle case
Nelle pagine del fascicolo speciale della rivista
“Architettura” completamente dedicato alla
V Triennale da poco conclusa, Marcello
Piacentini osservava: “La personalità di Ponti
ha dato il tono a tutta la Triennale; egli si è
confermato in questa grande fatica il vero
maestro dell’arredamento che noi già
conoscevamo e se un rammarico possiamo
provare, è che egli non abbia potuto disporre
di una maggiore autonomia e di facoltà
di comando assoluta”65. L’affermazione
dell’accademico d’Italia acquista un
significato particolare soprattutto se si
considerano le vicende che portarono
alla realizzazione della sesta edizione.
Il 19 dicembre 1933, nella sala della
presidenza della Triennale, si riunisce
il consiglio di amministrazione dell’ente.
Condannando il sistema del fotomontaggio
ampiamente utilizzato nella V Triennale,
e proponendo una maggiore attenzione
allo sviluppo di plastici corredati da chiari
elementi tecnici con prevalenza di materiali
grafici su quelli fotografici, Piacentini –
membro sempre più influente nel consiglio –
ritiene opportuno, per l’organizzazione della
sesta edizione, limitare i temi da presentare,
120
e suggerisce, “affinché la Mostra abbia
particolare vivacità”, di illustrare soltanto taluni
edifici “di carattere eccezionale e di soggetto
attuale”66. In sostituzione della mostra delle
costruzioni nel parco, egli propone una
grande mostra di materiali, da allestire in un
solo padiglione realizzato nel parco per
l’occasione, e destinato a ospitare anche
quelle mostre che non avrebbero trovato
posto nel palazzo di Muzio.
Questioni pratiche ed economiche, sollevate
peraltro anche da Carlo Alberto Felice in una
relazione del 13 dicembre67, condussero
il consiglio ad accettare le proposte
di Piacentini68. Evidenti ostacoli economici,
nonché la difficoltà di coordinare i numerosi
architetti coinvolti, decretarono il declino della
formula delle case-prototipo, che pure tanto
successo avevano riscosso nella V Triennale.
A ciò contribuirono anche le critiche espresse
dal segretario del direttorio in merito alla
presenza in mostra di taluni progetti non
rispondenti alle vere e sentite necessità
moderne: “Abbiamo visto alla Triennale due
Case per artisti; ma la soluzione del problema
della Casa per l’artista non è così importante
e speciale da richiedere un particolare studio.
L’unico particolare bisogno di un artista è di
avere uno studio in felici condizioni di luce e
di capacità; ma la cucina, il salotto, il bagno,
la camera da letto dell’artista, sono le stesse
degli altri uomini della sua cultura e della sua
posizione sociale”69. Del resto, non era facile
convincere i potenziali finanziatori a sostenere
la costruzione di case effimere, a puro scopo
dimostrativo. In tal senso, Carlo Alberto Felice
propose da un lato, di realizzare con il
contributo di ministeri ed enti nazionali, oltre
che con la partecipazione finanziaria della
Triennale, soltanto cinque “edifici modello
veramente caratteristici, assolutamente tipici,
effettivamente rispondenti alle esigenze sociali
d’oggi”, dall’altro, di costruire con l’appoggio
della Triennale “un vero quartiere di case
moderne modello da affittare o da vendere.
Case perfettamente studiate, completamente
finite, ma non ammobiliate”70.
Insinuatosi nella gestione culturale della
Triennale, come risulta evidente dai verbali
delle sedute del consiglio di amministrazione,
E.A. Griffini, E. Faludi, P. Bottoni, Colonia di case per vacanza, Casa di montagna, veduta esterna, V Triennale di Milano, 1933 (FLTM).
E.A. Griffini, E. Faludi, P. Bottoni, Colonia di case per vacanza, Casa di campagna, veduta esterna, V Triennale di Milano, 1933 (APB).
121
G. Pagano, F. Albini, R. Camus, G. Palanti, G. Mazzoleni, G. Minoletti, Casa a struttura d’acciaio, V Triennale di Milano, 1933 (FLTM).
E.A. Griffini, E. Faludi, P. Bottoni, Colonia di case per vacanza, Casa per spiaggia marina, vedutaesterna, V Triennale di Milano, 1933 (FLTM).
Piacentini assunse via via un ruolo sempre
più determinante nella regia e nella gestione
delle iniziative. Anche nella scelta del sostituto
del dimissionario Ponti, Piacentini ebbe un
peso decisivo. In particolare, sempre nella
seduta del 19 dicembre, venne stilata una
graduatoria di architetti che comprendeva,
nell’ordine delle trattative avviate, Gustavo
Pulitzer Finali, Giuseppe Pagano, Luciano
Baldessari e Giuseppe Terragni. E quando
Pulitzer Finali – come presupposto necessario
alla sua entrata nel direttorio – dettò precise
condizioni di riforma dello statuto della
Triennale71 – che tra le altre cose
ridimensionavano il ruolo del Consiglio –
non si ebbero esitazioni – visti i “contrattempi
e ostacoli di natura tale per cui entrambe le
parti riconobbero l’opportunità di considerare
come non avvenute le trattative”72 – a
scegliere il candidato “piacentiniano”
Giuseppe Pagano, peraltro già membro
del direttorio ordinatore della mostra
dell’Aeronautica italiana organizzata
per il 1934 dalla Fondazione Bernocchi
in Triennale.
La proposta di Piacentini si concretizzò nella
“Mostra degli elementi e materiali tipici
dell’Architettura moderna”, la prima “chiara
e avvincente” esposizione della VI Triennale,
come stabilito dalle “Linee del programma”73.
Nelle sezioni dedicate all’architettura, alle arti
decorative e alle mostre retrospettive – i tre
grandi settori in cui vennero accorpate tutte
le mostre – la casa era presente solo tra gli
“edifici tipici costruiti in tutto il mondo”
o tra i progetti di “edifici tipici italiani”74.
Secondo le indicazioni formulate, la questione
dell’abitazione riappariva però tanto nei
tentativi di riaffermare la tradizione della
cosiddetta “architettura minore”, alla quale
era dedicata una mostra specifica, e nelle
rappresentazioni della “scienza urbanistica”
visibili nella rispettiva sezione, quanto
nell’esposizione speciale intitolata “La
giornata dell’uomo moderno”. Di indiscutibile
carattere didattico, quest’ultima intendeva
presentare esempi di ambienti “ideali” per
la vita, in alloggi da affitto, di tre categorie
di persone – il capo operaio, l’impiegato,
il comune professionista – non dotate di alti
redditi, “ma che egualmente, col loro tenore
di vita, devono partecipare alle conquiste
della tecnica, dell’igiene, dell’estetica,
dell’etica moderna”75. Realizzato con oggetti
“riproducibili, di facile acquisto, di costo
proporzionale agli intenti, di effettiva
rispondenza all’uso, di riconosciuta efficienza”,
l’allestimento dei singoli ambienti doveva
rispondere agli obiettivi prefissati mediante
chiare didascalie, spiegazioni grammofoniche,
statistiche figurate e animate.
Significativa per la sistemazione logistica
dell’intera mostra, è la proposta di Piacentini
di “monumentalizzare” gli spazi espositivi con
la creazione di tre corpi, collegati tra loro con
portici, a unico ingresso e in asse al palazzo
“Bernocchi”, anziché di un solo padiglione, a
parer suo “troppo grande e ingombrante”76.
I tre padiglioni – destinati alle mostre dell’arte
applicata all’architettura, dell’architettura
e dei materiali edilizi – avrebbero formato
una grande piazza centrale, adatta per feste
e altre manifestazioni “ludiche”, come appare
da uno schizzo in calce a una lettera inviata
da Piacentini a Barella77. L’accademico d’Italia
propose il nome dell’“amico” Pagano per
la progettazione dei tre padiglioni, nonché
dell’arredamento delle sale; si sarebbe
trattato, comunque, di un “incarico a sé
stante”78. La VI Triennale si configura dunque,
al di là di possibili interpretazioni critiche,
come la Triennale di Piacentini, più che
di Pagano o di Persico, come è stata
interpretata finora dalla storiografia79.
Intanto, il 20 ottobre 1935, applicando
la legge 18 aprile 1934 n. 811, si decretava
la costituzione di un nuovo consiglio di
amministrazione80. Su suggerimento del
ministro dell’interno, Barella viene confermato
presidente, e su proposta del Ministero delle
corporazioni si ratificano i nomi di Piacentini
e di Jannitti Piromallo. Rino Parenti, Antonio
122
Maraini e Alberto Calza Bini sono proposti
dai diversi sindacati di settore, mentre ad
aggiungere complessità al funzionamento
di una già di per sé complessa macchina,
burocratica e insieme di potere, il ministro
dell’educazione nazionale nomina come
propri rappresentanti Rino Valdameri,
presidente della Accademia di Belle Arti
di Milano, e Gio Ponti81.
Piccoli segni di cambiamento delle linee
direttive nell’organizzazione della VI Triennale
si possono cogliere nelle proposte, formulate
il 3 dicembre 1935, dell’ordine del giorno
da discutere nella seconda seduta del nuovo
Consiglio82: singole mostre specifiche, tra
le altre, dedicate all’architettura, ai materiali
e all’abitazione moderna sono oggetto
di riflessione. Ma in linea generale, la struttura
dell’intera manifestazione resta quella
proposta dall’accademico d’Italia, e
l’organizzazione materiale delle singole
sezioni rimane affidata al direttorio guidato
da Pagano. Quantunque si dimetta nel
gennaio 1936 (pochi mesi prima
dell’inaugurazione della Triennale, per un
“polemico battibecco” con Sommi
Picernardi83), questi costruisce il padiglione
approvato da Piacentini84, cura con Guido
Frette la mostra sui sistemi costruttivi e i
materiali edilizi, organizza con Guarniero
Daniel la celebre mostra fotografica
sull’architettura rurale nel bacino
mediterraneo.
Il tema della casa era affrontato in più sezioni,
ma di fatto in nessuna in maniera esclusiva,
come documentavano le sottosezioni della
mostra dell’abitazione affidata ai molti
architetti. La casa diveniva pretesto
ideologico per affrontare vuoi il concetto
di “coerenza fra ambiente spirituale e opera
umana”, vuoi “il lottizzamento razionale” dei
quartieri di abitazione. Spostandosi peraltro
verso riflessioni autarchiche, il baricentro
delle discussioni si allontanava dall’idea
di “casa pontiana” per fermarsi sull’intervento
dell’architetto, considerato non più un artefice
ma un mediatore tra industria e società civile,
tra ambiente e tecniche di produzione.
In tal senso, serialità, intercambiabilità,
componibilità, i principi ispiratori della mostra
dell’abitazione, vennero ritenuti obiettivi – e al
contempo strumenti – indispensabili per la
definizione di alloggi-tipo, alcuni virtuali altri
reali, in moderni quartieri popolari, come per
esempio quelli proposti dal team guidato da
Albini. Con la scomparsa dei “perfetti modelli
di dimore”, e l’apparizione dei mobili “tipici”,
di “serie”, a “moduli costanti”85, i termini
del dibattito86, articolati e complessi, quali
erano apparsi anche in seguito ai Ciam,
nella VI Triennale si stemperano, per tradursi
unicamente tanto negli appartamenti-tipo
destinati a classi sociali diverse, quanto
nelle ambiziose proposte relative
all’arredamento moderno. Riappariranno
soltanto nell’VIII Triennale, dove per
“sperimentare sul campo i problemi
dell’abitazione, da quelli della scelta
urbanistica e della pianificazione interna,
a quello degli oggetti d’uso, in una
dimensione reale, per l’utenza ‘meno
abbiente’”87 sarà necessario costruire
un intero quartiere moderno.
Lettera di Marcello Piacentini a Giulio Barella, 10 gennaio 1934(FLTM).
E.A. Griffini, E. Faludi, P. Bottoni,Gruppo di elementi di case popolari,assonometria della struttura, V Triennaledi Milano, 1933 (APB).
123
Società anonima costruzioni edilizie“Tutto acciaio”, Casa in acciaio, veduta interna, V Triennale di Milano,1933 (FLTM).
E. Lancia, Casa in legno, V Triennale di Milano, 1933 (FLTM).
1 “Nel senso che le normali prospettive cronologiche non ser-virebbero a nulla in un mondo fatto, più che di azioni, di ideee di proposte, di speranze e di suggestioni, ma – soprattutto– di anticipazioni e, perfino, di progetti non ancora giunti aessere attuali oggi mentre scriviamo”. A. Pica, Storia dellaTriennale 1918-1957, Milano 1957, p. 8. 2 A. Pica, op. cit., p. 8.3 Presentata al sindaco di Milano, Emilio Caldara, nel gennaio1918 e approvata il 2 ottobre 1919, la proposta di GuidoMarangoni, ideatore e iniziatore delle Biennali, si concretizza il23 febbraio 1922 con la costituzione del “Consorzio Milano-Monza-Umanitaria”, delegato a organizzare gli eventi nella villaReale di Monza, resasi disponibile in seguito a donazione daparte della Corona. Cfr. Prima esposizione internazionale dellearti decorative. Consorzio Milano-Monza-Umanitaria. Maggio-MCMXXIII-ottobre. Catalogo, Firenze-Venezia-Milano-Roma-Napoli 1923. Sulle origini e la nascita delle biennali monzesi,oltre a A. Pansera, Storia e cronaca della Triennale, Milano1978, pp. 13-33, si veda della medesima il recente e bendocumentato 1923-1930. Dalle arti decorative al design. Lalunga marcia verso il progetto, in Id. (a cura di), 1923-1930Monza, verso l’unità delle arti. Oggetti d’eccezione dalleEsposizioni internazionali di arti decorative, catalogo dellamostra, Cinisello Balsamo 2004, pp. 16-49. 4 G. Polin, La Triennale di Milano 1923-1947. Allestimento, astra-zione, contestualizzazione, in Allestimenti/Exhibit Design, numeromonografico di “Rassegna”, n. 10, giugno, 1982, p. 35. 5 Cfr. P. Mezzanotte, La prima mostra internazionale delle artidecorative a Monza, in “Architettura e Arti Decorative”, fasc. X,giugno, 1923, pp. 391-404. 6 “Gli espositori di Monza nel loro recente congresso hannoconcordi enunciato il desiderio assai legittimo di avere a di-sposizione degli speciali padiglioni per speciali mostre dioggetti non adattabili senza anacronismo nell’ambientazionedelle sale e dei corridoi settecenteschi. Già gli amici CesareGoldmann e Roberto Morettini, con premura cordiale e la con-sapevolezza – che li onora – dell’utilità nazionale di questanuova loro abnegazione, si sono proposti di assicurare l’unol’erezione di un padiglione lombardo col contributo degli enti edegli industriali lombardi, l’altro il padiglione destinato ad ospi-tare le creazioni di bellezza della sua bellissima Umbria nativa”.G. Marangoni, La mostra internazionale delle arti decorativenella villa reale di Monza MCMXXIII. Notizie, rilievi, risultati,Bergamo s. d. [ma 1923], p. 66. 7 Il congresso degli espositori a Monza, in “Le Arti Decorative”,6, 18 ottobre 1923. Organo ufficiale delle mostre monzesi, larivista presentò tutta la produzione esposta nella villa Reale. 8 G. Polin, La Triennale di Milano… cit., p. 35.9 Si vedano, per esempio, i diversi scritti di Raffaello Giolli e diRoberto Papini pubblicati su quotidiani e riviste. Cfr. R. DeSimone (a cura di), Cronache di architettura 1914-1957.Antologia degli scritti di Roberto Papini, Firenze 1998; R. Giolli,L’architettura razionale, a cura di C. de Seta, Roma-Bari 1972.10 “Ed ora tutte le energie debbono essere chiamate a raccol-ta intorno al dovere di assicurare la buona riuscita della secon-da Biennale che per ragioni di data verrà a svolgersi nel con-fronto immediato con quella di Parigi”. G. Marangoni, Lamostra internazionale… cit., p. 65.11 Cfr. Catalogo seconda mostra internazionale delle arti deco-rative. Villa reale di Monza. Maggio-ottobre 1925, Milano1925. 12 Sui padiglioni realizzati all’esposizione francese si rimanda aG. D’Amato, Fortuna e immagini dell’Art Déco. Parigi 1925,Roma-Bari 1991. 13 Seconda mostra internazionale delle arti decorative.Catalogo seconda edizione, Milano 1925, p. 26.14 Cfr. Catalogo ufficiale della III mostra internazionale delle artidecorative. Maggio-ottobre 1927. Villa reale Monza, Milano1927.
15 R. Papini, Le arti a Monza nel 1927, 1. Gli Italiani, in“Emporium”, n. 391, luglio, 1927, pp. 14-32; si cita da R. DeSimone (a cura di), op. cit., p. 119. 16 Cfr. E. Terragni, I viaggi di architettura di Giuseppe Terragni.Appunti e immagini dai taccuini, in G. Ciucci (a cura di),Giuseppe Terragni. Opera completa, Milano 1996, pp. 75-85;M. Talamona, Primi passi verso l’Europa (1927-1933), in V.Gregotti, G. Marzari (a cura di), Luigi Figini Gino Pollini. Operacompleta, Milano 1996, pp. 58-61. 17 A. Avon, “La casa all’italiana”: moderno, ragione e tradizio-ne nell’organizzazione dello spazio domestico dal 1927 al1930, in G. Ernesti (a cura di), La costruzione dell’utopia.Architetti e urbanisti nell’Italia fascista, Roma 1988, p. 47.Della stessa autrice si veda anche La casa all’italiana, in G.Ciucci, G. Muratore (a cura di), Storia dell’architettura italiana.Il primo novecento, Milano 2004, pp. 162-179.18 Cfr. G. Pincherle Muratori, La casa moderna e razionale.Note sulla Mostra di Stoccarda e indirizzi nuovi dell’edilizia, in“L’Organizzazione scientifica del lavoro”, 6, dicembre, 1927,pp. 436-448.19 Cfr. M. De Michelis, Roman Germans: Italian Architects Lookto Germany, in Two German Architectures 1949-1989, cata-logo della mostra, Stuttgart-Bonn 2004, pp. 6-7. 20 Cfr. F. Irace, Il Weissenhof tra storia e critica, in M. G. Sandri(a cura di), Indagini sul moderno, Milano 1987, pp. 27-48; R.Pommer, C.F. Otto, Weissenhof 1927 and the ModernMovement in Architecture, Chicago-London 1991. 21 Il testo della conferenza tenuta nel novembre 1927all’Associazione fra i Cultori di Architettura di Milano vienepubblicato l’anno seguente; cfr. E. A. Griffini, Le case econo-miche dell’esposizione di Stoccarda, in «La Casa», n. 7, luglio,1928, pp. 527-547. 22 E.A. Griffini, Esempi stranieri modernissimi di case economi-che, in “Domus”, n. 3, marzo, 1928, p. 13. 23 E.A. Griffini, Esempi stranieri… cit., pp. 14-15. Griffini ritornasull’argomento tre mesi dopo in un articolo arricchito dalleimmagini tratte da Bau und Wohnung, pubblicazione delDeutscher Werkbund; cfr. E. A. Griffini, Le case del razionali-smo moderno alla mostra di Stoccarda, in “Domus”, 6, giu-gno, 1928, pp. 17-19. 24 E.A. Griffini, Le case economiche… cit., pp. 529-530.25 Formato da Pietro Betta, Maurizio De Rege di Donato, MariaDezzutti, Gino Levi Montalcini, Armando Melis de Villa, ArturaMidana, Sandro Molli, Domenico Morelli, Ettore Pittini, PaoloPerona, Mario Passanti, Giuseppe Pagano, AntonioPogatschnig, Natale Reviglio, Gianni Ricci, Giuseppe Rosso, ilGant realizzò la “Casa degli architetti”, opera nata come riela-borazione di uno schema tautiano – come scrisse Betta,anima del gruppo – pubblicato in un articolo di Griffini sulnumero di aprile di “Domus”. Cfr. E.A. Griffini, Alcuni interni dicase modernissime, in “Domus”, 4, aprile, 1928, pp. 40-43. 26 A. Avon, “La casa all’italiana”… cit., p. 47. Sul tema si vedaaltresì M. Salvati, L’inutile salotto. L’abitazione piccolo-borghe-se nell’Italia fascista, Torino 1993.27 Cfr. V. Fraticelli, “Parva sed apta mihi”: note sulla cultura esulla politica della casa negli anni Venti in Italia, in “NuovaDWF”, n. 19-20, 1982, pp. 39-47. 28 Con lo spostamento della cadenza periodica, da biennale atriennale, si ha l’autorizzazione istituzionale a operare, condecreto legge 25 giugno 1931, come ente autonomo e per-manente, oltre all’iscrizione al Bureau International desExpositions. Si vedano i documenti in AS-FLTM. 29 Cfr. Al visitatore, in Catalogo ufficiale della IV esposizionetriennale internazionale delle arti decorative e industrialimoderne. 1930 maggio-ottobre a. VIII, Milano 1930, p. 35. 30 A. Pica, op. cit., p. 25.31 G. Ponti, La Triennale di Monza, in “Domus”, 5, maggio,1930, p. 13. Si veda anche M. C. Tonelli Michail, Il design inItalia 1925-1943, Roma-Bari 1987, p. 30.
32 Cfr. F. Irace, Gio Ponti. La casa all’italiana, Milano 1988. 33 Cfr. G. Polin, La Casa Elettrica di Figini e Pollini. 1930, Roma1982, p. 22. Si veda inoltre G. Ponti, La vicina IV esposizioneinternazionale d’arte decorativa alla villa reale di Monza, in“Domus”, 3, marzo, 1930, pp. 9-18.34 Oltre ai progetti di Ponti, si vedano anche quelli di Griffini. Cfr.E.L., Piccola dimora di campagna, progettata dall’architettoE.A. Griffini, in “Domus”, 7, luglio, 1928, pp. 14-15, 45; E.A.Griffini, Case a pianta triangolare, in “Domus”, 12, dicembre,1928, pp. 32-33. 35 A. Avon, “La casa all’italiana”… cit., p. 62. 36 G. T. [G. Tonon], I locali di servizio nella Casa elettrica alla IVEsposizione internazionale delle arti decorative e industrialimoderne di Monza 1929-30, in G. Consonni, L. Meneghetti,G. Tonon (a cura di), Piero Bottoni. Opera completa, Milano1990, pp. 168-171. 37 Cfr. F. Tajani, La casa, in “La Lettura. Rivista mensile delCorriere della Sera”, a. XXX, 2, febbraio, 1930, pp. 115-122. 38 Dalla premessa al volume 36 progetti di ville di architetti ita-liani. A cura dell’Esposizione Triennale Internazionale delle ArtiDecorative Industriali Moderne alla Villa Reale di Monza, con lapresentazione di G. Ponti, Milano-Roma 1930, s. n. p. 39 Cfr. Archivio Progetti, Venezia, Fondo Griffini (d’ora in poiAP-FG), Lettera, datata 1 ottobre 1929, inviata dal direttoriodella Triennale a Griffini. 40 A. Pansera, Storia e cronaca… cit., p. 225.41 G. Ponti, Presentazione al volume 36 progetti di ville… cit.,s. n. p. 42 Su volontà di Ponti, le ville vennero anche ordinate e scelteda Griffini e Caneva per una pubblicazione a carico dellamostra. 43 F. Irace, Gio Ponti… cit., p. 27. 44 AS-FLTM, Lettera, datata 1 settembre 1931, inviata daBarella a Mussolini. Si veda anche il Promemoria del direttorio,datato 31 agosto 1931, a firma di Carlo Alberto Felice perGiulio Barella.45 AS-FLTM, Verbale della seduta del Consiglio, dattiloscrittodatato 23 gennaio 1932. Alla riunione partecipano anche icomponenti del direttorio: Felice, Ponti, Sironi. 46 Oltre agli avvisi apparsi su riviste e quotidiani, si veda AS-FLTM, Programma, opuscolo a stampa, datato 17 agosto1931. Si veda anche Regolamento generale, opuscolo astampa, datato dicembre 1931. Cfr. inoltre Triennale di Milano.Catalogo ufficiale, Milano 1930. 47 Per la partecipazione degli architetti stranieri, si ottemperaquanto stabilito nelle precedenti esposizioni e negli accordi fir-mati nella Convenzione sulle Esposizioni Internazionali, stipu-lata a Parigi nel novembre 1928. 48 Cfr. F. Irace, Giovanni Muzio 1893-1982. Opere, Milano1994, pp. 137-148. Si veda anche M. P. Belski, Palazzodell’Arte al Parco Sempione, Milano 1931-1933, scheda in S.Boidi (a cura di), L’architettura di Giovanni Muzio, catalogodella mostra, Milano 1994, pp. 190-193.49 AS-FLTM, Relazione allegata al Verbale della seduta delConsiglio, dattiloscritto datato 23 gennaio 1932.50 AS-FLTM, Lettera, datata 15 maggio 1931, inviata daBarella a Mussolini.51 AS-FLTM, Lettera, datata 23 febbraio 1931, inviata daBarella a Mussolini.52 Cfr. R. Papini, La quinta Triennale a Milano. Ispezione allearti, in “Emporium”, 468, dicembre, 1933, pp. 331-384. 53 Cfr. da ultimo C. Baglione, Casa sul lago per artista alla VTriennale, in C. Baglione, E. Susani (a cura di), Pietro Lingeri1894-1968, Milano 2004, p. 189. 54 Cfr. L. Molinari, Casa del sabato per gli sposi alla V Triennale,in L. Molinari, Fondazione Piero Portaluppi (a cura di), PieroPortaluppi. Linea errante nell’architettura del Novecento,Milano 2003, pp. 114-115.55 Cfr. P. Scarpa, Alla V Triennale di Milano. Architettura inter-
nazionale moderna, in “Il Messaggero”, 28 agosto 1933. 56 Cfr. G. Ponti, Case per vacanza, in “Domus”, 66, giugno,1933, pp. 291-299. Per ulteriori riferimenti bibliografici sirimanda alla scheda contenuta in M. Savorra, Enrico AgostinoGriffini. La casa, il monumento, la città, Napoli 2000, pp. 184-186. 57 Figura di riferimento all’interno del gruppo per la ricerca sullaprefabbricazione, Eugenio Faludi (ungherese di nascita e tra-sferitosi a Roma nel 1925) lascerà l’Italia nel 1939 in seguitoalle leggi razziali riparando prima in Inghilterra, e poi inCanada, dove continuerà i suoi studi sulla PrefabricatedHouse. Cfr. Architetture di Eugenio Faludi, Milano 1939. Siveda inoltre R.G. Hill, Faludi, Eugenio Giacomo, in C. Olmo (acura di), Dizionario dell’architettura del XX secolo, vol. II,Torino-London 2000, p. 322. 58 S. Giedion, Uno straniero parla della Triennale, in “LavoroFascista”, 28 agosto 1933. 59 R. Rothschild, Sonne Luft und Haus für alle (Sole, aria ecasa per tutti). Esposizione a Berlino maggio-agosto 1932, in“Rassegna di Architettura”, 6, giugno, 1932, pp. 251, 254.60 M. Piacentini, V Triennale di Milano. Significato dell’esposi-zione, in “Architettura”, fascicolo speciale, 1933, pp. 4-5.61 Si veda la scheda contenuta in M. Savorra, op. cit., pp. 186-187.62 Cfr. E.A. Griffini, La casa popolare, in “Quadrante”, luglio,1933, pp. 19-25.63 G. Palanti, Gruppo di elementi di case popolari, in “Ediliziamoderna”, n. 10-11, agosto-dicembre, 1933, p. 29.64 Sei mesi di vita della Quinta Triennale. Il bilanciodell’Esposizione che si chiude, in “Corriere della Sera”, 31
ottobre 1933. I dati riportati nell’articolo sono riscontrabili inAS-FLTM, Relazione morale, dattiloscritto datato 27 ottobre1933. 65 M. Piacentini, V Triennale di Milano… cit., p. 2. 66 AS-FLTM, Verbale della seduta del Consiglio, dattiloscrittodatato 19 dicembre 1933. 67 Cfr. AS-FLTM, Relazione di C.A. Felice. Allegato A, dattilo-scritto datato 13 dicembre 1933.68 Cfr. AS-FLTM, Fascicoli Personali: M. Piacentini, Lettera,datata 10 gennaio 1934, inviata da Piacentini a Barella. Siveda anche la lettera, datata 16 gennaio 1934, inviata daBarella a Piacentini. 69 AS-FLTM, Relazione di C.A. Felice. Allegato A… cit.70 Ibidem.71 AS-FLTM, Lettera, datata 3 gennaio 1934, di GustavoPulitzer Finali al presidente Giulio Barella. 72 AS-FLTM, Verbale della seduta del Consiglio, dattiloscrittodatato 23 febbraio 1934. 73 AS-FLTM, Linee del programma della VI Triennale. Allegato4, dattiloscritto s. d.74 Cfr. la corrispondenza relativa all’argomento conservata inAP-FG. 75 AP-FG, Lettera, datata 23 gennaio 1935, inviata da Barellaa Griffini. 76 AS-FLTM, Fascicoli Personali: M. Piacentini, Lettera, datata10 gennaio 1934, inviata da Piacentini a Barella.77 Ibidem.78 Per i rapporti di fiducia tra Piacentini e Pagano si veda AS-FLTM, Fascicoli Personali: M. Piacentini, Lettera, datata 11maggio 1935, inviata da Piacentini a Barella.
79 Cfr. A. Pica, op. cit., p. 37; A. Pansera, Storia e cronaca…cit., pp. 45-49, 282. Si veda inoltre G. Ciucci, Gli architetti e ilfascismo. Architettura e città 1922-1944, Torino 1989, p. 157;e il recente Id. Casabella e Terragni, in “Casabella”, 721, apri-le, 2004, p. 9.80 AS-FLTM, Fascicoli personali, Copia Decreto, dattiloscrittodatato 20 ottobre 1935. Si veda anche AS-FLTM, FascicoliPersonali: M. Piacentini, Lettera, datata 18 novembre 1935,inviata da Barella a Piacentini. 81 Piacentini, Ponti e Michelucci facevano parte della commis-sione delegata a coadiuvare il Direttorio per la Mostra dell’ar-chitettura.82 Cfr. AS-FLTM, Fascicoli Personali: M. Piacentini, Lettera,datata 3 dicembre 1935 inviata da Barella a Piacentini. 83 A. Pansera, Storia e cronaca…cit., p. 282. “ Sul padiglione, definito da De Seta “una prova felice”, cfr. R.Giolli, VI Triennale di Milano: il nuovo padiglione, in“Casabella”, 102-103, giugno-luglio, 1936, pp. 6-7; si vedainoltre G. Pagano, Architettura e città durante il fascismo, acura di C. De Seta, Roma-Bari 1990, pp. LIII-LIV. 85 Cfr. Tecnica dell’abitazione. Quaderni della Triennale, conprefazione di G. Barella, Milano 1936. 86 Cfr. i numerosi contributi presenti in Reale società italiana diigiene, Convegno lombardo per la casa popolare nei suoiaspetti igienico-sociali. Milano 11-12 gennaio 1936.Protocollo e relazioni, Milano 1936. Si veda anche A. Uccelli,Panorama di un convegno. La casa popolare nei suoi aspettipolitico-sociali, in “Il Politecnico”, 3, marzo, 1936, pp. 105-112.87 A. Pansera, Storia e cronaca… cit., p. 63.
125124















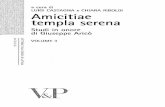



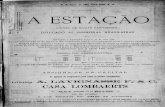



![[Salis M.] Casa aragonese](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632402435f71497ea9049a67/salis-m-casa-aragonese.jpg)












