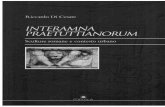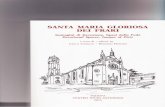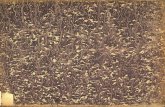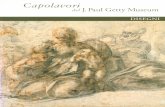Trattati e teorie dell’architettura nel Rinascimento: da Alberti a Palladio
Qualche considerazione su Palladio e Roma: una veduta topografica e i disegni dall'antico
Transcript of Qualche considerazione su Palladio e Roma: una veduta topografica e i disegni dall'antico
QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURADIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
NUOVA SERIE, FASCICOLI 57-59 / 2011-2012
SAPIENZA- UNIVERSITÀ DI ROMA
GIORNATE DI STUDIOIN ONORE DI ARNALDO BRUSCHI
VOLUME IRoma, Facoltà di Architettura, 5, 6, 7 maggio 2011
A CURA DI
FLAVIA CANTATOREFRANCESCO PAOLO FIORE
MAURIZIO RICCIAUGUSTO ROCA DE AMICIS
PAOLA ZAMPA
BONSIGNORI EDITORE2013
Francesco Paolo FiorePRESENTAZIONESCRITTI DI ARNALDO BRUSCHIStefano PittaccioSANTA MARIA IN TRASTEVERE,ASPETTI INEDITI DI UN PROGETTO ALL’ANTICA.ORIGINI E FORMAZIONE Massimo BulgarelliLA SAGRESTIA DI SANTA TRINITA A FIRENZE.ARCHITETTURA, MEMORIA, RAPPRESENTAZIONEFlavia CantatoreIL TEMPIETTO DI SANT’ANDREA A PONTE MILVIOTRA ARCHITETTURA E SCULTURANELLA ROMA DEL SECONDO QUATTROCENTOFrancesco BenelliLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SANT’AGOSTINO A ROMA:UNA NUOVA LETTURARenata SamperiIL GUSTO DELLA VARIETASNELL’ARCHITETTURA ROMANADEL SECONDO QUATTROCENTO: CAPITELLI COMPOSITI E MIXTA LINEAMENTISNELLA CHIESA DI SANT’AGOSTINOSimonetta ValtieriIL PALAZZO DI SANTE BENTIVOGLIO A BOLOGNARichard SchofieldL’ARCHITETTURA TEMPORANEACOSTRUITA PER IL MATRIMONIODI GIAN GALEAZZO SFORZA E ISABELLA D’ARAGONA (1489)Christof ThoenesPERSISTENZE, RICORRENZE E INNOVAZIONINELLA STORIA DELLA BASILICA VATICANAFrancesco P. Di TeodoroINEDITI RILIEVI DALL’ANTICOIN ALCUNI FOGLI DEL XVI SECOLOALLA BIBLIOTHÈQUE DE L’INSTITUT DE FRANCE«... DONT PLUSIEURS PARAISSENT ÊTRE DE LA MAINDE DONATO D’ANGELI LAZZARI, DIT BRAMANTE, D’URBINO»Marcello Fagiolo BRAMANTE E IL PALAZZO DELLA CANCELLERIA:LA PORTA-CITTÀ E LA LEZIONE DI GEOMETRIA
57
13
25
37
49
59
67
77
85
93
101
PAG
RIASSUNTI / ABSTRACT
113
121
129
143
151
155
167
173
183
191
199
209
223
231
SAPIENZA- UNIVERSITÀ DI ROMA
DirettoreFrancesco Paolo Fiore (responsabile)
Consiglio scientifico Daniela Esposito, Paolo Fancelli, Donatella Fiorani,Francesco Paolo Fiore, Antonella Greco, Giorgio Muratore,Augusto Roca De Amicis, Paolo Rocchi, Maria Piera Sette, Alessandro Viscogliosi.
Comitato direttivo Lia Barelli, Clementina Barucci, Calogero Bellanca, Simona Benedetti,Maurizio Caperna, Tancredi Carunchio, Annarosa Cerutti, Piero Cimbolli Spagnesi,Fabrizio De Cesaris, Daniela Esposito, Paolo Fancelli, Donatella Fiorani, Francesco Paolo Fiore,Daniela Fonti, Antonella Greco, Giorgio Muratore, Susanna Pasquali,Maurizio Ricci, Augusto Roca De Amicis, Paolo Rocchi, Maria Piera Sette,Maria Grazia Turco, Alessandro Viscogliosi, Paola Zampa.
Redazione Flavia Cantatore (coordinatore)
Ogni contributo viene sottoposto ad almeno due revisori scelti fra i membri del Dipartimentoin base alle loro specifiche competenze nel settore della Storia e Restauro dell’architettura;tali pareri sono integrati da pareri di studiosi italiani e stranieri esperti nei temi affrontati.
Traduzione in inglese Erika G. Young
Grafica e impaginazione Roberto steve Gobesso
Stampa CTS Grafica S.r.l., via Vito Vincenti 23, località Cerbara 06011 Città di Castello (PG) - telefono 075.8511555
Corrispondenza e norme editorialiDipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’ArchitetturaPiazza Borghese 9, 00186 Roma - telefono 06.49918825 - fax 06.6878169 - web w3.uniroma1.it/storiarch
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 131/87 del 06/03/1987
Il presente fascicolo è stampato con il parziale contributo di SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA
Abbonamenti e distribuzioneBonsignori Editore s.r.l., via Giuseppe Tornielli 16, 00153 Romatelefono 06.99709447 - [email protected] - www.bonsignori.it
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
© 2013Bonsignori Editore s.r.l., via Giuseppe Tornielli 16, 00153 Roma© 2013Sapienza - Università di RomaDipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, piazza Borghese 9, 00186 Roma
ISBN 978-88-7597-433-6ISSN 0485-4152
NUOVA SERIE, FASCICOLI 57-59 / 2011-2012
PAG
QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURADIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
Maurizio CapernaCONSIDERAZIONI SULLA LUNGARA DI GIULIO II E BRAMANTEBruno AdorniGIULIO ROMANO ARCHITETTO NEL PERIODO MANTOVANO:PRECISAZIONI SU QUALCHE RIPRESA DA RAFFAELLORossella OngarettoBALDASSARRE PERUZZI E I TEATINIFlaminia Bardati«DOMINICO CORTONENSI ARCHITECTANTE» A PARIGI (1530-1545):IL PROGETTO DELL’HÔTEL-DE-VILLEEnzo BentivoglioANTONIO DA SANGALLO IL GIOVANE E SIMONE MOSCA,PER LA PRIMA «INTRATA» DI PAOLO III A ORVIETOFlavia ColonnaIL FORTE SAN MICHELE A OSTIAUNA PICCOLA OPERA DI ARCHITETTURA MILITARENEL SISTEMA DIFENSIVO COSTIERO PONTIFICIOAugusto Roca De AmicisSUCCESSI E LIMITI DEGLI ‘ARCHITETTI-SCULTORI’NEL CINQUECENTO: IL CASO DI SIMONE MOSCAAmedeo BelluzziUN CASO STORIOGRAFICO:LA VILLA FIORENTINA DEI COLLAZZIAdriano Ghisetti GiavarinaQUALCHE CONSIDERAZIONE SU PALLADIO E ROMA:UNA VEDUTA TOPOGRAFICA E I DISEGNI DALL’ANTICOPaola ZampaLO IONICO MODERNOMaurizio RicciUN CARDINALE CERCA CASA. FILIPPO BONCOMPAGNIE OTTAVIANO MASCARINO TRA BOLOGNA E ROMABartolomeo AzzaroFACCIATE PULSANTI E SPAZIO URBANONELLA ROMA DEL CINQUECENTOMario CurtiNOTE SUI ‘TRACCIATI ARMONICI’NELLA STORIA DELLE TEORIE ARCHITETTONICHE
183QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 57-59/2011-2012
Ad Arnaldo Bruschi si devono alcuniimportanti saggi inerenti gli studi di
Palladio sulle architetture romane antichee moderne e le opere da lui realizzate a Ro-ma1; ed è a questo particolare aspetto dellericerche dell’illustre studioso, come al suointeresse per i disegni antichi di architettu-ra2, che si richiama il presente contributo.
A parere del più illustre biografo diGian Giorgio Trissino, il poema eroicoL’Italia liberata dai Goti, dato alle stampein tre volumi negli anni 1547-1548, venneiniziato poco prima del 15273. Come è no-
to, l’opera si ispira alle imprese compiutedal generale bizantino Belisario nel libera-re l’Italia dal dominio dei Goti per ordinedell’imperatore Giustiniano, e una sua par-te è dedicata all’assedio di Roma, che si eraofferta a Belisario, da parte dei Goti che in-tendevano riconquistare la città.Allo scopo di rendere più chiara la nar-
razione degli episodi attinenti a questo as-sedio e ai relativi luoghi citati, nel secondovolume della prima edizione del poema ècontenuta una veduta topografica che nonè stata sinora oggetto dell’attenzione deglistudiosi4. Il motivo probabile di questa
omissione potrebbe risiedere nel fatto chesolo in alcuni esemplari dell’opera essa sipresenta come una vera e propria tavola dipiù grande formato piegata e inserita alla fi-ne del suddetto volume; più di frequente, inaltre copie, la veduta non è invece comple-ta, e solo parte di essa è stampata su due pa-gine dello stesso formato del libro, conl’esclusione di una zona centrale – com-prendente la raffigurazione di una parte delPantheon – per una lunghezza di circa 11millimetri, e di una fascia inferiore per un’al-tezza di poco più di 8 millimetri5 (figg. 2, 3). Nella sua versione completa di carta
QUALCHE CONSIDERAZIONESU PALLADIO E ROMA:
UNA VEDUTA TOPOGRAFICAE I DISEGNI DALL’ANTICO
di ADRIANO GHISETTI GIAVARINA
Fig. 1 - Veduta topografica di Roma stampata su una carta piegata allegataall’opera di G.G. Trissino, L’Italia liberata dai Goti, vol. II, Venezia 1548 (foto CISA, A. Palladio, Vicenza).
cui lo stesso umanista vicentino dovette ac-cingersi a dare alle stampe la seconda par-te della sua opera, le immagini di Roma piùrecenti ed attendibili erano proprio le dueultime qui ricordate, che ritengo siano allabase della sua veduta.Dalla tavola del Marliano la veduta di
Trissino sembra riprendere, oltre alla rap-presentazione in pianta dei resti degli im-pianti termali, anche l’idea di dotare l’im-magine di una legenda, di cui una parte,unitamente a una parte dell’errata-corrigedel testo del poema, è stampata sul versodella tavola; e entrambi gli elenchi sonocompletati in due pagine in appendice alvolume10.Sia pure senza il rigore della pianta di
Roma di Leonardo Bufalini del 1551, frut-to di un accurato rilievo durato sette o for-se anche vent’anni11, anche la veduta delTrissino presenta inesattezze ed errori cherispondono «ad una precisa volontà del-l’autore», come il fuoriscala per la rappre-sentazione dei monumenti e la vista zenita-le del corso del Tevere, o le piante di alcunimonumenti antichi combinate con i prin-cipi che sono alla base di una veduta a volod’uccello, in cui «l’autore stabilisce deglielementi cardine – [come] l’orografia, iltessuto viario, i ruderi – e su di essi impostatutta l’immagine»12.
Il disegno dell’edicola contenente il tito-lo nel frontespizio della prima edizione del-l’Italia liberata dai Goti, ripetuto con l’im-presa del Trissino – il Vello d’Oro su un al-bero custodito da un serpente con il mottoadattato da Sofocle ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΝΑΛΩΤΌΝ – in chiusura del secondo volumedella stessa edizione (fig. 6), e quello dell’ac-campamento di Belisario nella tavola pie-gata contenuta nel primo volume – talvoltaritenuta la sola tavola illustrativa del poema– sono stati convincentemente attribuiti aPalladio rispettivamente sulla base di con-fronti con le edicole della facciata di unpalaz zo in un suo progetto giovanile e conaltre sue rappresentazioni dello stesso ge-nere13; sembra perciò inevitabile chiedersise anche la veduta di Roma in questionepossa essere stata disegnata dallo stesso An-drea. In assenza di documenti le sole possi-bilità di confronto sembrano essere offertedalle tavole incise all’acquaforte che quasitre decenni più tardi Palladio disegnò peril Dell’imprese de’ Greci, de gli Asiatici, de’Romani et d’altridi Polibio (Venezia 1564)e per i Commentari di Cesare (Venezia1575). Osservando le tavole per il Polibiodell’esemplare conservato presso la BritishLibrary di Londra (293.G.20) è possibiletrovare analogie con la veduta di Roma delTrissino nel modo di raffigurare e di aggre-gare le piccole case che appaiono nei peri-metri delle città o sparse nelle campagne;ma anche i caratteri a stampatello di alcune
185QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 57-59/2011-2012
piegata delle dimensioni di 19 centimetridi base per 16 centimetri di altezza, la ve-duta raffigura, per lo più in assonometria,il territorio nei dintorni di Roma e quellocompreso all’interno della cinta delle mu-ra aureliane, con il Tevere e i suoi affluen-ti, le strade e i ponti, i rilievi collinari, cam-pagne, alberi, i casali principali e, natural-mente, torri, porte, il castel Sant’Angelo, iprincipali monumenti antichi e alcunechiese (fig. 1). L’impostazione della vedutanon si presenta simile alla analoga tavola diRoma antica allegata al volume di LucioFauno, Delle antichità della città di Roma,edito a Venezia nello stesso anno 1548, lacui composizione ed il cui orientamentocorrispondono invece alla tradizione quat-trocentesca che comprende le miniature diRoma di Pietro del Massaio (1471) e l’accu-rato disegno di Alessandro Strozzi (1474)6.La tavola del libro di Trissino si mostra
decisamente più aggiornata, rifacendosi so-prattutto alla veduta topografica della
Campagna Romana di Eufrosino della Vol-paia, del 15477 (fig. 4), della quale, riducen-do di circa un quarto le dimensioni, ripren-de la parte relativa alla città di Roma e aisuoi più immediati dintorni e segue piutto-sto fedelmente l’orientamento con il nord-est in alto, l’orografia, l’idrografia e il peri-metro delle mura aureliane8; nonché, perquanto riguarda l’immagine dei principalimonumenti, riproponendo pressoché lastessa rappresentazione delle basiliche ex-tra-moenia di San Lorenzo, di San Paolo edi San Pancrazio, di San Pietro e del Pan-theon. Differenti appaiono invece le raffi-gurazioni di castel Sant’Angelo – più detta-gliata quella nella veduta del Trissino, sinoa mostrare la statua di san Michele e un’im-mensa bandiera al vento, ma del tutto fuo-ri scala – di Ponte Milvio, delle torri e delleporte della cinta muraria, in genere più ac-curate nella veduta trissiniana. Sempre riguardo ai monumenti di Ro-
ma antica – disposti all’incirca nella corret-
ta posizione topografica, ma isolati e per lopiù in veduta assonometrica, ancora secon-do la forma di rappresentazione della tra-dizione quattrocentesca – rispetto alla ve-duta di Eufrosino della Volpaia, la tavoladel Trissino presenta, tra le numerose inte-grazioni, le rappresentazioni in icnografiadelle terme di Diocleziano, di Costantinoe di Antonino, che parrebbero ispirate aquelle presenti nella veduta della Roma an-tica disegnata da Giovan Battista Palatinoper il volume di Bartolomeo Marliano, Ur-bis Romae topographia, del 15449. Anchequest’ultima veduta, infatti, sebbene inmodo più schematico, si presenta con lostesso orientamento di quella di Eufrosinodella Volpaia, e questo, oltre alla sua atten-dibilità, dovette suggerire a Trissino la pos-sibilità di riproporre nella tavola del suovolume alcuni dei più importanti monu-menti di Roma antica, sia nella stessa posi-zione che con la medesima forma di rap-presentazione. Del resto, nel momento in
184 Adriano Ghisetti Giavarina . QUALCHE CONSIDERAZIONE SU PALLADIO E ROMA: UNA VEDUTA TOPOGRAFICA E I DISEGNI DALL’ANTICO
Fig. 2 - Particolare della veduta topografica di Roma stampatasu una facciata dell’opera di G.G. Trissino, L’Italia liberata dai Goti, cit.
Fig. 3 - Particolare della veduta topografica di Roma stampatasu una facciata dell’opera di G.G. Trissino, L’Italia liberata dai Goti, cit.
Fig. 4 - Particolare della veduta topografica della Campagna Romana di Eufrosino della Volpaia(Roma 1547, da A.P. Frutaz, Le piante di Roma, vol. I, Roma 1962).
Fig. 5 - Vettorializzazioni della veduta topografica allegata al secondo volume de L’Italia liberatadai Goti del Trissino - rappresentata dalla sequenza di punti - e quella di un settore dellaveduta topografica di Eufrosino della Volpaia - rappresentata dai tratti continui - (elaborazionedi D. Palumbo, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara).
bariche e con cenni al saccheggio dei Go-ti, alla riconquista di Belisario ed al succes-sivo assedio: un’opera che doveva aver let-to anche Trissino nel momento in cui il suopoema era agli inizi; ed allo stesso umani-sta doveva essere ben nota anche l’altraopera del Fulvio, Antiquae urbis Romaecum regionibus simulachrum, stampata aRoma nello stesso 152718 con le incisioni diTolomeo Ignazio da Fossombrone, dal vi-centino Ludovico degli Arrighi, editore delTrissino negli anni immediatamente prece-denti. E, a mio parere, entrambe questeopere devono essere aggiunte ai possibilitesti di riferimento che sono alla base del-la composizione della veduta dell’Italia li-berata dai Goti.Ma, nonostante nella stessa introduzio-
ne all’Antichità di RomaPalladio scriva chei monumenti da lui descritti siano stati og-getto di suoi rilevamenti19 è da tempo asso-dato che, tra i suoi numerosi disegni, nonpochi rilievi di monumenti antichi fosserostati copiati da altri autori20; ed anche inquesto si scorge lo stesso metodo di lavoropraticato nelle occasioni già ricordate: laraccolta del maggior numero di fonti pos-sibili ed attendibili – e infatti tra i disegnipalladiani vi sono a volte raffigurazioni di-verse dello stesso monumento – al fine digiungere ad una propria personale rappre-sentazione di determinati edifici. Che è lostesso metodo di lavoro riscontrato nellaprogettazione delle opere di Andrea: attin-gere agli esempi antichi per combinarli conquelli di sua invenzione21.
A partire dalle osservazioni formulateda Wolfgang Lotz in riferimento agli studidi Gian Giorgio Zorzi sui disegni di anti-chità di Andrea Palladio, è stato giustamen-te supposto che il maestro avesse formatola sua vasta raccolta in gran parte copiandodisegni eseguiti da altri. Si trattava di unmateriale eterogeneo, riferibile talvolta al-la cerchia sangallesca, riunito da Palladioforse soprattutto negli anni Quaranta delXVI secolo o poco prima.Esaminando i rilievi di monumenti anti-
chi appartenuti ad Andrea e conservati aVicenza e a Londra, Zorzi aveva infatti os-servato che, nei fogli caratterizzati da unacalligrafia giovanile del maestro – che pre-senta un ductus diverso da quello delle no-te apposte su fogli redatti in età più maturae diverso da quello delle scritture autogra-fe – l’uso della rappresentazione in pro-spettiva, la ricchezza dei particolari deco-rativi, le fitte ombreggiature non corrispon-devano alle caratteristiche riconoscibili nel-la maggior parte del corpusdei disegni; perdi più le misure in piedi, passi e pertiche ve-ronesi rinviavano a un autore di Verona,profondo conoscitore dei monumenti diquesta città come di quelli di Roma e di Po-la, indizi che, a parere dello studioso vicen-
tino, portavano a riconoscere tale autore inGiovan Maria Falconetto22, del quale perònon sono noti scritti autografi né altre testi-monianze grafiche. A queste osservazioni,da condividere riguardo al riconoscimentodel carattere veronese di una parte dei di-segni appartenuti a Palladio, fecero segui-to gli studi di Heinz Spielmann23 e di Ho-ward Burns, il quale sostenne convincente-mente come, a proposito dei fogli attribui-ti a Falconetto, oltre alle annotazioni, an-che gli stessi disegni fossero di mano delPalladio e probabilmente copiati da origi-nali del maestro veronese24.È mia opinione che almeno la maggior
parte di tali copie furono eseguite da Palla-
dio a Vicenza, e che principale fonte dei di-segni copiati non dovessero essere i fogli diFalconetto, ma la cospicua serie di disegnieseguiti da Michele Sanmicheli sia a Vero-na che negli anni trascorsi nell’Italia centra-le25. È verosimile infatti che quest’ultimo,tornato a Verona nel 1526, ebbe presto rap-porti con Vicenza e con Girolamo Pittoni eGiovanni da Porlezza – con il quale avevaun rapporto di parentela – i maestri dellaContra’ di Pedemuro nella cui bottega Pal-ladio svolse la sua attività di scalpellino e gliesordi di quella di architetto26 e dove vero-similmente potrebbe aver eseguito le suecopie giovanili di disegni dall’antico27. Per-tanto, ancor prima di compiere i suoi viag-
187QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 57-59/2011-2012
iscrizioni e i numeri di riferimento aggiun-ti a penna su alcune delle stesse tavole, ri-conosciuti come autografi del maestro, cor-rispondono a quanto può osservarsi nellanostra veduta; tra le tavole dei Commenta-ri, è invece nella raffigurazione di Alesia edel suo territorio (fig. 7) e di Nicopoli e del-la sua edilizia (fig. 8), che si può riscontrarequalche affinità con la rappresentazionedell’Italia liberata dai Goti 14. La maggioreaccuratezza nella definizione dell’orografiae delle alberature, riscontrabile tanto nelletavole del Cesare che in quelle del Polibio,potrebbe spiegarsi sia con l’età più maturadi Palladio che, forse più verosimilmente,con la sua consapevolezza che l’incisione inrame avrebbe assicurato una definizione as-sai più dettagliata della xilografia.Non mi sembra pertanto azzardato af-
fermare che, anche nell’elaborazione diquesta tavola illustrativa della sua opera,Trissino abbia avuto accanto Palladio, alquale dovette chiedere di compilare unaveduta di Roma corredata dai riferimenti ailuoghi citati nel suo libro, eseguita sulla ba-se della cartografia in quel momento dispo-nibile, e che si riferisse il più possibile al-l’epoca (peraltro alquanto approssimativa,trattandosi di finzione letteraria15) dell’as-sedio descritto nel poema, riguardo al qua-le, nella veduta, sono sinteticamente raffi-
gurati gli accampamenti dei Goti. E il risul-tato, considerando anche il piccolo forma-to dell’esecuzione, appare alquanto felice-mente riuscito.Qualche anno dopo la morte di Trissino,
Palladio avrebbe dato alle stampe il suo pic-colo libro sull’Antichità di Roma– ispirato-gli forse proprio dalla preparazione dellaveduta della città con i suoi monumentipreparata alcuni anni prima – del quale co-nosciamo ormai il debito nei confronti del-l’analoga opera di Lucio Fauno16. Nell’in-troduzione, comunque, Palladio cita i suoiprincipali riferimenti bibliografici, tantoconsultati che combinati o semplicementecitati più o meno estesamente nel suo te-sto17. Si tratta dello stesso procedimento dalui usato, evidentemente su suggerimentodel Trissino, nel comporre la veduta sin quiesaminata; ed anche nel risultato, raggiun-to con un approccio scientifico, il contribu-to palladiano appare simile: tanto nel volu-metto dell’Antichità, come nella veduta to-pografica di Roma, è infatti ugualmenteraggiunto l’obiettivo di una sintetica e il piùpossibile attendibile descrizione.Tra gli autori moderni, citati da Palladio
nell’introduzione alla sua Antichità, com-pare anche Andrea Fulvio, autore dell’ope-ra Antiquitates Urbis, edita nel 1527, che siconclude con l’elenco delle invasioni bar-
186
Fig. 7 - A. Palladio, Battaglia di Alesia, particolare dell’incisionein rame per i Commentari di Giulio Cesare (Venezia 1575, da AndreaPalladio e l’architettura della battaglia con le illustrazioni ineditealle Storie di Polibio, a cura di G. Beltramini, Venezia 2009, p. 209).
Fig. 6Tavola con l’impresadi G.G. Trissino
da L’Italia liberata dai Goti, cit.
Fig. 8 - A. Palladio, Battaglia di Nicopoli,particolare dell’incisione in rame per iCommentari di Giulio Cesare (Venezia 1575,da Andrea Palladio e l’architettura della battaglia, cit., p. 219).
Fig. 9 - A. Palladio, particolari del teatro di Marcello in Roma (London, R.I.B.A., X/20r,da Palladio and His Legacy. A Transatlantic Journey, ed. C. Hind, I. Murray, Venice 2010, p. 26).
Adriano Ghisetti Giavarina . QUALCHE CONSIDERAZIONE SU PALLADIO E ROMA: UNA VEDUTA TOPOGRAFICA E I DISEGNI DALL’ANTICO
sebbene in una diversa resa grafica e con unallungamento dovuto alle differenti dimen-sioni della metopa, da un particolare delfregio illustrato da Palladio a margine del-lo stesso foglio vicentino. Procedimento,questo, che mi pare rappresenti ulterioreconferma del metodo di progettazione usa-to dal maestro, se egli ne è autore, anchenella organizzazione della veduta di Romache si è qui commentata.
Mi rendo conto come queste mie osser-vazioni configurino una ricerca che certa-mente non può dirsi né completa, né defi-nitiva, e ritengo pertanto che essa rappre-senti semplicemente «una proposta pro-blematica [...] da riverificare ancora, daapprofondire e controllare»: espressioni,queste, usate da Arnaldo Bruschi nell’in-troduzione alla sua grande monografia suBramante, dove egli avvertiva inoltre come
gli fosse «sembrato onesto non dare per as-sodato e per sicuro – come ancora in Italiaè spesso cattivo costume – quanto è solopossibile, verosimile, incerto o addiritturasolo basato su supposizioni e congetture.Abbondano quindi i “sembra”, i “forse”,gli “è possibile”, “è probabile”, ecc.»46.Ed è a questo atteggiamento, in cui si af-
ferma la problematicità della storia, l’inin-terrotto progredire della ricerca e il fre-quente impossibile raggiungimento diconclusioni definitive, che ci si è ispiratinell’affrontare gli argomenti di studio sinqui esposti.
189QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 57-59/2011-2012
gi a Roma in compagnia del Trissino, Palla-dio poté aver avuto il modo di disporre deidisegni del maestro veronese raffiguranti imonumenti antichi di Verona e di altri luo-ghi, come Roma, l’Umbria o Pola28, anchediversi anni prima che questi, nel 1541-1542, si fermasse qualche tempo a Vicenzaper formulare un parere riguardo alla rico-struzione delle logge della basilica29. E, ne-gli anni seguenti, Andrea poté confrontarealcuni dei soggetti di questi fogli con la re-altà dei monumenti antichi anche sulla ba-se di suoi nuovi rilevamenti.
Un foglio della raccolta londinese di di-segni di Palladio, relativo a particolari delTeatro di Marcello30 (fig. 9), a mio parererappresenterebbe verosimilmente la copiadi analoghi disegni appartenuti a Sanmi-cheli. Qui, accanto alla trabeazione ionicadel teatro, si legge questa annotazione dimano di Palladio: «largeza di dentelli le me-nuti 11 et li menuti di cavati m 5½ segondoquela cha disegnata et [?] M. michiele», co-sa che lascia supporre che Palladio abbiaavuto modo di vedere un rilievo di Sanmi-cheli della stessa cornice31. Come disegna-tore il maestro veronese doveva essere piut-tosto accurato, dal momento che egli, co-me attesta Vasari, giunto a Roma all’età disedici anni, «studiò di maniera le cose d’ar-chitettura anticha e con tanta diligenza, mi-surando e considerando minutamente ognicosa, che in poco tempo divenne, non pu-re in Roma, ma per tutti i luoghi che sonoall’intorno, nominato e famoso»32. Meno conosciuta, al riguardo, è l’attivi-
tà del legnaiolo ed architetto pistoiese Ven-tura Vitoni, al punto che non sempre si èvoluto dar credito a quanto di lui scrisse lostesso Vasari in appendice alla vita di Bra-mante. Qui si legge infatti che il grande Do-nato si servì, nelle sue opere, della collabo-razione del maestro toscano, «il quale ave-va buonissimo ingegno e disegnava assaiacconciamente. Costui si dilettò assai inRoma di misurare le cose antiche», primadi tornare nella sua città, entro il 150933.Dalle ricerche svolte sul Vitoni non sonoemersi documenti che possano suffragarel’affermazione vasariana, tuttavia si può os-servare che, tra il gennaio del 1503 e il no-vembre del 150634, non risultano a Pistoianotizie riguardanti l’architetto e, se è statadimostrata infondata l’ipotesi che egli po-tesse trovarsi nel 1504 sul cantiere dellachiesa tudertina di Santa Maria della Con-solazione35, non si può escludere che inquel torno di anni egli frequentasse a Romala cerchia di Bramante. Ipotesi, questa, chepotrebbe chiarire un’altra nota apposta daPalladio sullo stesso foglio relativo al Tea-tro di Marcello, in cui viene precisato chela trabeazione ionica «e disegnata secondola mesura de ventura ebenche la sia mesu-rata a palmi ma io lo reduta ala mesura del
brazio fiorentino et nota che la dita cornisesecondo la mesura de ventura la coronanon e inchavata soto» (ossia è priva del goc-ciolatoio).Si può supporre pertanto che Palladio
disponesse di due disegni dello stesso sog-getto e, conformemente al suo metodo dilavoro, li riunisse in un’unica copia in cuifossero combinati particolari ed informa-zioni tratti da entrambi36. In tal caso, men-tre si può considerare la nota relativa aidentelli della trabeazione disegnata da“messer Michiele”, come una integrazionedi Palladio alle misure viste sul secondo fo-glio a sua disposizione – quello con il rilie-vo di Ventura – si può spiegare il trasferi-mento in braccia fiorentine delle misure inpalmi prese forse da Vitoni, con la necessi-tà di uniformare le misure dei due disegni,dando la preferenza all’unità di misura delrilievo di Sanmicheli. Ma una seconda, piùcredibile ipotesi, può fondarsi sulla consi-derazione che Palladio non avrebbe avutomotivo di trasferire le misure in braccia fio-rentine, dal momento che egli si serviva dimisure in piedi vicentini e, ad esempio neldisegno della raccolta di Vicenza relativo alTempietto del Clitumno, è appunto in talemisura che egli trasferì le originarie misurein palmi romani37. In questo secondo casosi dovrebbe pertanto considerare la notarelativa al rilievo di Ventura come copiatada Palladio da un solo foglio in suo posses-so – e a mio parere elaborato da Sanmiche-li – e quella riguardante “messer Michiele”come un’aggiunta di Andrea alla copia,funzionale ad un ulteriore chiarimento.Il braccio fiorentino era una unità di mi-
sura in uso anche nella cerchia sangallesca,come provano i disegni del Codice Conernoti anche a Palladio38, e la conoscenza diquesto codice da parte di Sanmicheli, vici-no all’ambiente di Antonio da Sangallo ilGiovane, può spiegare quale sia stato il tra-mite attraverso il quale alcune copie di di-segni tratte da esso siano presenti tra i foglidi Palladio. Come per i disegni di alcunimonumenti antichi dell’Umbria copiati daAndrea negli anni giovanili 39, anche per uncerto numero di disegni relativi ai monu-menti di Roma da lui copiati negli stessi an-ni parrebbe perciò lecito ipotizzare la stes-sa fonte: e cioè la ricca raccolta dei disegnidi Sanmicheli, tra i quali dovevano trovar-si, oltre ai rilievi da questi eseguiti, anchecopie di disegni di altri esponenti della cer-chia bramantesca e sangallesca da lui fre-quentata negli anni trascorsi a Roma, equindi eventualmente anche qualche copiadi rilievi eseguiti dal Vitoni.Anche della rappresentazione di un
frammento di trabeazione e dei particola-ri di una semicolonna, del fregio e di unadelle mensole dell’ordine dorico di unavancorpo della Basilica Emilia, in un fo-glio della raccolta palladiana di Vicenza (D
5v – fig. 10), Burns40 ha osservato come es-sa costituisca forse la sintesi di due disegnidi mani diverse, perché sia le mensole chei triglifi appaiono nei particolari con qual-che differenza rispetto all’assonometria se-zionata d’insieme; ma è di un certo interes-se osservare che le misure riportate sono inbraccia fiorentine e che lo stesso soggetto,sia pure con misure, angolazione e dettaglipiù o meno diversi, compare tanto nel Co-dice Coner che in fogli di Antonio da San-gallo il Giovane e della sua cerchia41. E diuna certa importanza sono anche le anno-tazioni riportate da Palladio, e presumibil-mente da lui copiate insieme ai disegni,perché la principale di esse identifica il sog-getto come «Cornise del foro boario ia jnRoma», specificando che «et adeso non cese non le rieliquie che sono jn porta al pa-latio de adriano jn borgo la quale cornixele doricha». I resti dell’avancorpo della Ba-silica Emilia furono infatti demoliti ad ini-ziativa di Adriano Castellesi, probabilmen-te entro i primi mesi del 1505 – ma di cer-to non erano più in situ nel 1514 – e unaparte degli elementi dell’ordine dorico futrasportata nel cantiere del palazzo che lostesso cardinale, da alcuni anni, aveva incostruzione lungo la via Alessandrina inBorgo Nuovo, per essere destinati, verosi-milmente, ad una ricomposizione nell’ar-chitettura del portale dell’edificio, idea ab-bandonata forse alla morte di Bramante edi certo prima del 1516 circa42.L’annotazione copiata da Palladio, con
il suo riferimento alla porta del palazzo bra-mantesco e al suo committente, che lasciòRoma nel 1517 e morì quattro anni più tar-di43, parrebbe perciò rinviare probabil-mente ai primi due decenni del Cinquecen-to, gli stessi anni in cui Sanmicheli compi-va a Roma, nella cerchia di Bramante e deiSangallo, la sua vasta campagna di rileva-mento dei monumenti antichi. E sembraquesta una conferma di quanto ho potutoosservare riguardo ai disegni di Palladiodelle antichità dell’Umbria, che rivelanotalvolta anche dalle annotazioni come essisiano stati copiati da esemplari eseguiti ne-gli stessi anni che il Sanmicheli trascorsenell’Italia centrale44.Infine, una riduzione del disegno prin-
cipale di questo foglio è riconoscibile inuna incisione del Vitruvio di Daniele Bar-baro (fig.11) – opera alla quale, come è no-to, collaborò anche Palladio – che raffigu-ra l’assonometria sezionata di un frammen-to di trabeazione dorica45. L’immagine sipresenta, come poteva accadere, ribaltata,ma pur nelle ridotte dimensioni rispetto al-l’originale da cui deriva, a parte il più bas-so profilo della sima e l’assenza dei ricchiintagli visibili nel disegno, di questo con-serva proporzioni e linee delle forme; allapatera della metopa è qui efficacemente so-stituito un bucranio, tratto anch’esso però,
188
Fig. 11 - A. Palladio, «Figura de i modioni sotto la cornicenell’opera Dorica» (da I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio,trad. e commento di Daniele Barbaro, ed. Venezia 1567, lib. IV, p. 170).
Fig. 10 - A. Palladio, particolari della basilica Emilia in Roma (Vicenza, Musei Civici, G.D.S.D.5v, da L. Puppi, Palladio. Corpus dei disegni al Museo Civico di Vicenza, Milano 1989, p. 17).
Adriano Ghisetti Giavarina . QUALCHE CONSIDERAZIONE SU PALLADIO E ROMA: UNA VEDUTA TOPOGRAFICA E I DISEGNI DALL’ANTICO
NOTE
1. A. BRUSCHI, Bramante, Raffaello e Palladio,in «Bollettino del Centro Internazionale di Studidi Architettura Andrea Palladio», XV, 1973, pp.69-87; ID., Roma antica e l’ambiente romano nellaformazione del Palladio, ivi, XX, 1978, pp. 9-25;ID., Palladio architetto a Roma e la sua attività perl’ospedale di S. Spirito, in Studi in onore di RenatoCevese, a cura di G. Beltramini, A. Ghisetti Giava-rina, P. Marini, Vicenza 2000, pp. 61-81; ID., Pal-ladio e gli architetti del suo tempo. Qualche brevis-sima considerazione, in Palladio 1508-2008: il sim-posio del cinquecentenario, a cura di F. Barbieri etal., Venezia 2008, pp. 96-99.
2. Cfr., ad esempio, Alcune osservazioni sul di-segno dall’antico: colloquio con Arnaldo Bruschi, acura di C. Loi, in «Il disegno di architettura», 9,1994, pp. 3-5 (ma desidero qui ricordare che ad uninvito e ad un suggerimento dello stesso Bruschi sideve il mio: I disegni antichi come fonti per lo stu-
dio della Storia dell’architettura, in Principi e meto-di della storia dell’architettura e l’eredità della “scuo-la romana”, Atti del convegno internazionale distudi (Roma, 26-28 marzo 1992), a cura di F. Co-lonna e S. Costantini, Roma 1995, pp. 199-202).
3. B. MORSOLIN, Giangiorgio Trissino. Mono-grafia di un gentiluomo letterato nel secolo XVI, Fi-renze 1894², pp. 286 e 289.
4. Alla veduta hanno accennato B. Morsolin(Giangiorgio Trissino, cit., p. 279) e, con qualcheprecisazione, M. Daly Davis, (Andrea Palladio’s«L’Antichita di Roma» of 1554, in «Pegasus. Berli-ner Beiträge zum Nachleben der Antike», 9, 2007,p. 189, nota 39). Cfr., per la definizione e l’attendi-bilità di questo genere di vedute, G. PANE, Napoliseicentesca e la veduta di A. Baratta (I), in «Napolinobilissima», IX, 1970, pp. 118-119. Ho potutoconsultare la copia del volume di Trissino custodi-ta nella Biblioteca del Centro Internazionale di
Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza(F.A. I 31) grazie alla cortesia del direttore GuidoBeltramini e di Daniela Tovo, che ringrazio ancheper la riproduzione fotografica della veduta.
5. Così si presenta, ad esempio, l’esemplare del-la Biblioteca Civica R. Spezioli di Fermo, in basealla descrizione cortesemente fornitami dalla dot-toressa Maria Chiara Leonori, che qui ringrazio:«Prendendo in mano il nostro esemplare, ho veri-ficato che è costituito da un solo volume contenen-te più legati. Le do brevemente di seguito la com-posizione fisica del nostro esemplare in un solo vo-lume: 1. L’Italia liberata dai Goti del 1547, libri 1-9, corrispondente alla descrizione di SBN, la qua-le contiene una carta di tavola finale piegata (Ca-strametazione di Belisario); 2. libri 10-18, del 1548,che dopo l’errata corrige ha una carta di Roma sudue facciate, ma non si tratta di una carta piegata;3. libri 19-27, del 1548, senza carte piegate». An-
cora a titolo di esempio, osservo che la stessa im-paginazione della veduta di Roma si riscontra nel-la copia della stessa edizione appartenente alla Bi-blioteca Histórica dell’Universidad Complutensedi Madrid, e sarebbe interessante verificare se ledue differenti impaginazioni corrispondano alledue varianti di stampa riscontrate per il secondovolume dell’opera: entrambe edite a Venezia daTolomeo Gianicolo, la variante A nel mese di otto-bre del 1548, la variante B nel mese di novembredello stesso anno.
6. Cfr., in proposito, almeno: F. CANTATORE,Piante e vedute di Roma, in La Roma di Leon Batti-sta Alberti. Umanisti, architetti e artisti alla scoper-ta dell’antico nella città del Quattrocento, a cura diF.P. Fiore e A. Nesselrath, catalogo della mostra(Roma, Palazzo Caffarelli, 24 giugno-16 ottobre2005), Milano 2005, pp. 173-175.
7. T. ASHBY, La campagna romana al tempo diPaolo III. Mappa della campagna romana del 1547di Eufrosino della Volpaia, Roma 1914.
8. L’architetto Donato Palumbo, del Diparti-mento di Architettura dell’Università degli Studidi Chieti-Pescara, ha eseguito per me l’elaborazio-ne di fig. 5: qui sono state portate alla stessa scalae sovrapposte, sulla base di punti di ancoraggio co-muni, le vettorializzazioni della tavola di Trissino(rappresentata dalla sequenza di punti) e quella diun settore della veduta di Eufrosino della Volpaia(rappresentata dai tratti continui), con il risultato,egli scrive, di «un insindacabile grado di sovrap-posizione che, in determinati casi, sfiora la coinci-denza perfetta, pur tenendo sempre in considera-zione incertezze date dalla diversa natura delle duefonti».
9. Cfr., per la mappa del Marliani, la scheda inA.P. FRUTAZ, Le piante di Roma, vol. I, Roma 1962,pp. 56-57; M. DALY DAVIS, Bartolomeo Marliani(1488-1566), in Archäologie der Antike. Aus denBeständen der Herzog August Bibliothek 1500-1700, Ausstellung im Zeughaus der Herzog Au-gust Bibliothek Wolfenbüttel vom 16. Juli bis 2.Oktober 1994, Wiesbaden 1994, pp. 42-45; A. SIE-KIERA, Delineare con le parole. Le guide di Roma nelCinquecento, in Saggi di letteratura architettonicada Vitruvio a Winckelmann, vol. II, a cura di L. Ber-tolini, Firenze 2009, pp. 156-157; J. MAIER, «Co-me se resuscitata dalla tomba»: la pianta di Roma diLeonardo Bufalini, 1551, in Rappresentare la città.Topografie urbane nell’Italia di antico regime, a cu-ra di M. Folin, Reggio Emilia 2010, pp. 160-161.
10. Negli esemplari del libro ai quali non è alle-gata la mappa piegata, la legenda e l’errata-corrigesono invece stampate di seguito su pagine conse-cutive.
11. J. MAIER, «Come se resuscitata dalla tomba»,cit., p. 164.
12. Cfr., per queste osservazioni riferite allapianta di Bufalini: D. STROFFOLINO, I tipi dell’ico-nografia urbana, in L’immagine delle città italianedal XV al XIX secolo, a cura di C. de Seta, catalogodella mostra (Napoli, Palazzo Reale, Appartamen-to storico, 30 ottobre 1998-17 gennaio 1999), Ro-ma 1998, pp. 113-114.
13. Cfr., per il frontespizio,H. BURNS, Giangior-gio Trissino. La Italia liberata da Gotthi, in AndreaPalladio 1508-1580. The portico and the farmyard,catalogue by H. Burns, L. Fairbairn, B. Boucher,London 1975, pp. 81-82; e, per la tavola della ca-strametatio, G. BELTRAMINI, Andrea Palladio (?).Castrametatione di Belisario, in Andrea Palladio ela villa veneta da Palladio a Carlo Scarpa, a cura diG. Beltramini e H. Burns, catalogo della mostra
(Vicenza, Palazzo Barbaran da Porto, 5 marzo-3luglio 2005), Venezia 2005, pp. 295-296; ID., Pal-ladio e le Storie di Polibio, in Andrea Palladio e l’ar-chitettura della battaglia con le illustrazioni ineditealle Storie di Polibio, a cura di G. Beltramini, Ve-nezia 2009, p. 17.
14. Cfr., riguardo ai Commentari di Cesare, ri-spettivamente le tavv. 25-26 e la tav. 36 in AndreaPalladio e l’architettura della battaglia, cit., pp. 208-209 e 219.
15. B. MORSOLIN, Giangiorgio Trissino, cit., p. 286.16. M. DALY DAVIS, Andrea Palladio’s «L’Anti-
chita di Roma», cit., pp. 179-181.17. ANDREAPALLADIO, L’antichità di Roma 1567,
presentazione di F.P. Fiore, Milano 2006, p. 3.18. M. DALYDAVIS, Andrea Fulvio (1470-1527),
in Archäologie der Antike, cit., p. 40.Sebbene, come ha osservato M. Daly Davis
(Andrea Palladio’s «L’Antichita di Roma», cit., p.162), tra i disegni quotati di Palladio non compa-iano i monumenti di cui egli fornisce le misure nelvolumetto sull’Antichità.
20. W. LOTZ, Osservazioni intorno ai disegni pal-ladiani, in «Bollettino del Centro Internazionale diStudi di Architettura Andrea Palladio», IV, 1962,pp. 61-68 (dove l’autore scrive che, copiando ma-teriali eterogenei, Palladio mise insieme «una do-cumentazione il più possibile completa e rappre-sentativa»).
21. H. BURNS, Disegno e progetto, in Palladio, acura di G. Beltramini e H. Burns, Venezia 2008, p.300. Più in generale, specie riguardo agli ordini ar-chitettonici, A.A. PAYNE, Creativity and bricolagein architectural literature of the Renaissance, in«Res», 34, 1998, pp. 20-38.
22. G. ZORZI, I disegni delle antichità di AndreaPalladio, Venezia 1959, pp. 34-39.
23. H. SPIELMANN, Andrea Palladio und die An-tike. Untersuchung und Katalog der Zeichnungenaus seinem Nachlaß, München-Berlin 1966, p. 12e passim.
24. H. BURNS, I disegni del Palladio, in «Bollet-tino del Centro Internazionale di Studi di Archi-tettura Andrea Palladio», XV, 1973, pp. 170-171;ID., Nota sui disegni cinquecenteschi dei monumen-ti antichi veronesi, in Palladio e Verona, catalogodella mostra a cura di Paola Marini, Venezia 1980,p. 84.
25. A. GHISETTI GIAVARINA, Disegni di MicheleSanmicheli e della sua cerchia. Osservazioni e propo-ste, Crocetta del Montello (TV) 2013, pp. 11-12.
26. L. PUPPI, Palladio. Introduzione alle Archi-tetture e al Pensiero teorico, San Giovanni Lupato-to (VR) 2005, pp. 9 e 26.
27. H. BURNS, I disegni del Palladio, cit., p. 173.28. Come suggerito da H. Burns (Nota sui dise-
gni cinquecenteschi, cit., p. 83) riguardo a Verona,da L. Puppi (Michele Sanmicheli. Opera completa,Roma 1986, p. 190) e da chi scrive (A. GHISETTIGIAVARINA, Palladio e le antichità dell’Umbria, in«Annali di architettura. Rivista del Centro Inter-nazionale di Studi di Architettura Andrea Palla-dio», 18-19, 2006-2007, pp. 125-126) riguardo al-l’Umbria, e ancora da L. Puppi (Schede storico-ar-tistiche, in Gabinetto Disegni e Stampe dei MuseiCivici di Vicenza. I disegni di Andrea Palladio, a cu-ra di M.E. Avagnina e G.C.F. Villa, Milano 2007,p. 140) e da P. Davies e D. Hemsoll (Michele San-micheli, Milano 2004, p. 289) riguardo a Pola.
29. G.G. ZORZI, Contributo alla storia dell’artevicentina dei secoli XV e XVI. Il preclassicismo e iprepalladiani, Venezia 1937, p. 52.
30. London, R.I.B.A., X/20r, per il quale cfr.
G.G. ZORZI, I disegni delle antichità, cit., pp. 91-92; W. LOTZ, Osservazioni, cit., pp. 61-63; H. SPI -EL MANN, Andrea Palladio und die Antike, cit., pp.155-156; G. BELTRAMINI, Andrea Palladio. Eleva-tion, section and details of the Theatre of Marcellus,Rome, in Palladio and His Legacy. A TransatlanticJourney, ed. by C. Hind and I. Murray, Venice2010, pp. 26-28.
31. Ipotesi già espressa da G. Zorzi (I disegnidelle antichità, cit., p. 92) e da W. Lotz (Osservazio-ni, cit., p. 63).
32. G. VASARI, Le vite de’ più eccellenti pittori,scultori ed architettori con nuove annotazioni e com-menti, ed. a cura di G. Milanesi, Firenze 1906, vol.VI, p. 341.
33. Ibidem, vol. IV, p. 165. G. Milanesi (ibidem,p. 168), in una nota di commento, afferma che il Vi-toni non uscì mai dalla Toscana e che poté conosce-re le opere di Bramante soltanto attraverso i dise-gni; e, in genere, anche negli studi successivi, pocoo nessun credito è stato dato alla notizia vasariana.
34. F. QUINTERIO, Regesto e documenti, in Ven-tura Vitoni e il Rinascimento a Pistoia, catalogodella mostra a cura di M.C. Buscioni, Pistoia 1977,p. 72; A. BELLUZZI, Giuliano da Sangallo e la chie-sa della Madonna dell’Umiltà a Pistoia, Firenze1993, p. 43.
35. G. DE ANGELIS D’OSSAT, Sul Tempio dellaConsolazione a Todi, in «Bollettino d’Arte», XLI,1956, pp. 207-213; U. NOFRINI, Il Tempio del Bra-mante a Todi, Introduzione di A. Bruschi, Todi1970, pp. 59-62.
36. W. LOTZ, Osservazioni, cit., p. 63.37. H. BURNS, I disegni, in Mostra del Palladio.
Vicenza/basilica Palladiana, direttore della mostraR. Cevese, s.l.n.d. (ma Milano 1973), p. 153. Cfr.,per una scheda aggiornata su questo foglio, L. PUP-PI, Schede storico-artistiche, cit., pp. 129-130.
38. W. LOTZ, Osservazioni, cit., pp. 61-63.39. A. GHISETTI GIAVARINA, Palladio e le anti-
chità dell’Umbria, cit., pp. 125-126.40. H. BURNS, I disegni, cit., p. 136. Su questo
foglio v. anche: L. PUPPI, Schede storico-artistiche,cit., p. 133.
41. Tuttavia non si può dire che il disegno diPalladio sia in stretto rapporto con quello del Co-dice Coner – che il Lotz (Osservazioni, cit., p. 66)ha messo invece in relazione con una tavola deiQuattro libri relativa all’ordine dorico – dal mo-mento che essi si differenziano per l’impostazionedell’assonometria sezionata, per la scelta di raffi-gurare elementi della semicolonna o della parasta,per i particolari della rappresentazione dei triglifi,dei mutuli, delle mensole e dei bucrani.
42. A. GHISETTI GIAVARINA, La Basilica Emiliae la rivalutazione del Dorico nel Rinascimento, in«Bollettino del Centro di Studi per la Storia del-l’Architettura», 29, 1983, pp. 17-18; A. BRUSCHI,L’architettura dei palazzi romani della prima metàdel Cinquecento, in Palazzo Mattei di Paganica el’Enciclopedia Italiana, Roma 1996, pp. 9-14.
43. Ibidem, p. 12.44. A. GHISETTI GIAVARINA, Palladio e le anti-
chità dell’Umbria, cit., pp. 124-125.45. I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio,
traduzione e commento di Daniele Barbaro, ed.Venezia 1567, lib. IV, p. 170. V. in proposito, L.CELLAURO, Palladio e le illustrazioni delle edizionidel 1556 e del 1567 di Vitruvio, in «Saggi e memo-rie di storia dell’arte», 22, 1998, pp. 96-97 (senzariferimento al foglio D 5v di Vicenza).
46. A. BRUSCHI, Bramante architetto, Bari 1969,p. XVIII.
190 Adriano Ghisetti Giavarina . QUALCHE CONSIDERAZIONE SU PALLADIO E ROMA: UNA VEDUTA TOPOGRAFICA E I DISEGNI DALL’ANTICO
RIASSUNTO /ABSTRACT
QUALCHECONSIDERAZIONESU PALLADIO E ROMA: UNAVEDUTATOPOGRAFICA E I DISEGNI DALL’ANTICOSoltanto ad alcuni esemplari del secon-
do volume della prima edizione del poemaeroico di Gian Giorgio Trissino, L’Italia li-berata dai Goti (1548), risulta allegata unaveduta topografica di Roma che, sino adoggi, è stata quasi del tutto trascurata daglistudiosi. Essa raffigura la città e i suoi im-mediati dintorni secondo la stessa imposta-zione della veduta topografica della Cam-pagna Romana di Eufrosino della Volpaiadel 1547, con integrazioni ispirate talvoltaalla veduta disegnata da Giovan BattistaPalatino per il volume di Bartolomeo Mar-liano, Urbis Romae Topographiae del 1544.Nella stessa edizione dell’opera di Trissinoaltre due illustrazioni, l’edicola che inqua-dra il frontespizio e la tavola con il disegnodell’accampamento di Belisario, sono sta-te convincentemente attribuite a Palladioe, in base al confronto della veduta di Ro-ma con le incisioni del Polibio edito a Ve-nezia nel 1564 e dei Commentari di Cesaredel 1575 – di cui lo stesso Andrea disegnò isoggetti –, sembra lecito attribuire allo stes-so autore anche la terza delle tavole in que-stione. Ma anche dall’analisi di alcuni fogliin cui sono riuniti diversi disegni di antichi-tà di Roma, copiati da Palladio verosimil-mente da originali di Michele Sanmicheli,si evince lo stesso metodo di lavoro, per cuifonti diverse confluiscono nella definizio-ne di un nuovo contesto, seguendo un pro-cedimento simile a quello riscontrato nellagenesi della tavola trissiniana.
CONSIDERATIONS ABOUT PALLADIOANDROME: A TOPOGRAPHIC VIEWANDDRAWINGS OF ANTIQUITYOnly a few copies of the second volume of
the first edition of the heroic poem by GianGiorgio Trissino, L’Italia liberata dai Goti(1548), included a topographical view of Ro-me; this view has so far been almost comple-tely neglected by scholars. It illustrates thecity and immediate surroundings using thesame topographical viewpoint of the romancountryside by Eufrosino della Volpaia(1547) with additions inspired by the viewdrawn by Giovan Battista Palatino for thebook by Bartolomeo Marliano, Urbis Ro-mae Topographiae (1544). Two more illu-strations in the same edition of Trissino’s bo-ok were convincingly attributed to Palladio:the aedicule framing the front cover and thetable with the drawing of the encampmentby Belisario. A comparison of the view of Ro-me with the engravings by Polybius publi-shed in Venice in 1564, and the Commenta-riby Cesare in 1575 – in which Andrea him-self drew the main features – show that thethird table is very probably by the same au-thor. An analysis of several sheets represen-ting drawings of antiquities in Rome, whichPalladio probably copied from the originalsby Michele Sanmicheli, shows that the samework method was used in both. As a result,several sources elaborate a new context ba-sed on a procedure similar to the one used byTrissino to create his table.
Adriano Ghisetti Giavarina[[email protected]]
QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 57-59/2011-2012