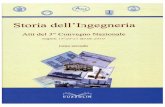Dal gotico oltre la maniera, gli architetti di Ognissanti a Firenze
Transcript of Dal gotico oltre la maniera, gli architetti di Ognissanti a Firenze
Maria Teresa Bartoli
DAL GOTICO OLTRE LA MANIERAGLI ARCHITETTI DI OGNISSANTI
A FIRENZE
IntroduzioneAlessandro Salucci
contributiStefano Giannetti e Nevena Radojevic
© 2011 Edifir-Edizioni Firenze s.r.l.
Realizzazione editorialeEdifir-Edizioni Firenze
Via Fiume, 8 - 50123 FirenzeTel. 055289639 - Fax 055289478http://www.edifir.it - [email protected]
Responsabile del progetto editorialeSimone Gismondi
Responsabile editorialeElena Mariotti
StampaPacini Editore Industrie Grafiche - Ospedaletto (Pisa)
ISBN 978-88-7970-545-5
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, ConfArtigianato, CASA, CLAAI, ConfCommercio, ConfEsercenti il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale sopracitato potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall’editore.Photocopies for reader’s personal use are limited to 15% of every book/issue of periodical and with payment to SIAE of the compensation foreseen in art. 68, codicil 4, of Law 22 April 1941 no. 633 and by the agreement of December 18, 2000 between SIAE, AIE, SNS and CNA, ConfArtigianato, CASA, CLAAI, ConfCommercio, ConfEsercenti. Reproductions for purposes different from the previously mentioned one may be made only after specific authorization by those holding copyright/the Publisher.
Finanziato con fondi di ricerca Miur per progetti di ricerca scientifica d’Ateneo (ex quota 60%) e fondi residui da convenzioni con enti diversi.
INDICE
Natura, ars, logos. Epistemologia di una città medioevaleAlessandro Salucci pag. 5
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a FirenzeMaria Teresa Bartoli » 15
Rilievo, stimoli, sensazioni, conoscenza » 17L’origine di Ognissanti e il disegno di Firenze » 21La chiesa tra Gotico e Maniera » 33
Contributi
La chiesa basso-medievale: il tramezzo di OgnissantiStefano Giannetti » 49
La quadratura di Ognissanti.Concezione dello spazio tra Barocco e IlluminismoNevena Radojevic » 59
Tavolea cura di Nevena Radojevic » 65
— 5 —
«Cosa è oggi la città, per noi?» si chiedeva, lontano da ogni retorica, Italo Calvino ne Le città invisibili, l’ammaliante libro
composto come «un ultimo poema d’amore alle cit-tà, nel momento in cui – affermava Calvino – diventa sempre più difficile viverle come città» 1. Nel suo sim-bolismo la città è intesa come l’espressione della palpi-tante tensione «tra razionalità geometrica e groviglio delle esistenze umane», quasi come se unificasse in sé i contrasti più profondi che abitano l’individuo.
Sviluppate in età comunale, le città ben presto si or-ganizzarono per porre fine al disordine sociale seguito alle dissoluzione dell’impero romano, prima e di quello carolingio, poi. Senza ordine sociale frutto e al contem-po fondamento dell’ordine interiore, non è possibile per l’uomo vivere e progredire sviluppando le sue potenzia-lità, mentre resta da capire se esista un ordine interiore senza il riferimento a un ordine posto oltre l’individuo stesso. Nel medioevo l’ordo fu eretto a fondamento della convivenza tra gli uomini e lo si poteva rintracciare negli ordinamenti di giustizia e nell’organizzazione generale dell’attività cittadina. Ma la nozione di ordine fece da ar-bitro anche alla costruzione della connessione, vitale per l’uomo di quel periodo, tra Creatore e creatura, tra ope-ra di Dio e opera dell’uomo. La città fu anche questo. La trama è allora chiara e mostra un disegno della città che intreccia l’ordine divino espresso nella creazione, con un ordine sociale comprensivo di ogni agire dell’uomo, per unirlo infine a un ordine interiore. Se è dunque vero che la città ha il valore simbolico a cui rimanda, allora ne va compreso a fondo il significato perché è di una città che parla questo libro di Maria Teresa Bartoli. Va infine detto che come ogni simbolo anche quello della città si gioca nella dualità di segno e significato che è unità di soggettivo e oggettivo, di razionale e irrazionale, di sacro e profano, di etico e di ingiusto, di santità e di peccato.
Non è facile comprendere cosa intenda Calvino quando fa intravedere la “crisi” delle città odierne, ma si può ragionevolmente supporre che intendesse ren-dere coscienti i suoi lettori che nelle città del nostro
contemporaneo viene sfumandosi qualcosa di necessa-rio, un’entità di cui non possiamo privarci, come se en-trando in crisi la città venisse a mancare una storia vis-suta, una forma sociale di narrazione che è al contempo identità e idioma. È invece del tutto evidente che Cal-vino compone un canto di speranza raccontando la sua nostalgia per un modello reale, concreto, perché esisti-to di città. Le città invisibili sono infatti un racconto di viaggio che il veneziano Marco Polo fa all’imperatore mongolo Kublai Kan per cui con questa mirabile nar-razione siamo come riportati al Duecento, ossia al se-colo che vide sorgere l’idea moderna di città. Ai giorni nostri, grazie a studi sempre più raffinati che mostra-no la creatività nelle arti nell’epoca medioevale e che evidenziano come dominasse il coraggio della ragione, compresa la mirabile sintesi stabilitasi tra razionalità e credenza in Dio, questo importante periodo storico sta riprendendo vigore. È pertanto imperdonabile lasciarsi sfuggire l’occasione di cercare di comprendere quanto lo studio di Maria Teresa Bartoli ci mette a disposizio-ne. Studio complesso e affascinante, in cui il particolare aspetto architettonico e strutturale di un singolo edi-ficio viene interpretato nel suo contesto urbanistico a giustificare l’assunto di un “progetto” di città.
Le città moderne, a ben guardare, sono l’opposto speculare delle città medioevali. Le odierne metropoli non sono più il centro e il coagulo delle identità, non rappresentano il cerchio del cosmo, né si identificano con l’ombelico mistico che collega la terra al cielo. Sono luoghi senza forma, in cui la tecnologia ha an-nullato la natura, dove l’uomo abita come consumato-re, ma non come “artista”, imprigionato com’è nelle maglie di una parola che non “comunica”, ma semmai informa. I sociologi per descrivere l’essenza delle città odierne ricorrono volentieri al termine di Città Globa-le, a significare una città continua e uniforme, una città che è estesa quanto il mondo. Perdere l’identità delle città significa però perdere la memoria degli uomini, è spogliarli dei desideri e delle speranze, impoverirli dei segni e dei linguaggi che li hanno fatti crescere in
Natura, ars, logos.Epistemologia di una città medioevale
— 6 —
Alessandro Salucci
scienza e sapienza. Perdere l’idea di città è, insomma, come trasformare in un’immagine sfocata e opaca l’i-dentità dell’Occidente. «Le città – infatti – sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell’e-conomia, ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi» 2.
Le città nel XIII secolo erano sorte come spazi recin-tati per necessità di difesa, al cui interno uomini e donne si impegnavano a vivere in pienezza combattendo con al-trettanto eroismo l’indigenza materiale e il peccato con-tro Dio. Prima che nucleo abitativo, centro di scambio commerciale e luogo della vita sociale, la città era uno «spazio consacrato entro cui l’uomo vive[va] in armo-nia con le leggi dell’universo» 3. Non è dato pensare e interpretare il Medioevo senza questa continua connes-sione tra finito e infinito, tra immanente e trascenden-te, tra umano e divino, tra peccato e grazia. Per questo la “forma” della città era espressa in figure geometriche che celavano rimandi cosmogonici, gli unici atti a rende-re presente il legame, antropologicamente e teologica-mente inteso, tra città terrestre e città celeste. Il sistema semantico medioevale era per massima parte giocato in riferimento alle città, le quali si trovavano così caricate di un senso che spingeva all’idealizzazione, da cui la classica contrapposizione tra Gerusalemme e Babilonia. L’una centro cosmico della fede cristiana, luogo dove Cristo, sacrificandosi sulla croce aveva ristabilito il primato della giustizia divina su quella umana. L’altra, Babilonia, de-scritta sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento come sentina di ogni male. Se Gerusalemme è la “città di Dio”, Babilonia è la città dove Dio è assente e nei cui templi si celebra un uomo che si sforza inutilmente di elevarsi verso il cielo, al pari del racconto babilonese della Torre di Babele (Genesi 11,1-9). Narrazione a cui è significa-tivamente contrapposta la Gerusalemme celeste, città che invece, secondo il racconto dell’Apocalisse, «scende dal cielo» (Ap 21,2). La storia della Bibbia è compresa, come si vede, tra l’immagine di due città, tanto che la possiamo intendere come la progressiva trasformazione di Babilonia dove domina l’orgoglio umano, nella Geru-salemme nuova dove a regnare è Dio in comunione con gli uomini. Alimentato di racconti biblici drammatizzati fino all’estremo dai tanti predicatori che si muovevano da una città all’altra, l’uomo medioevale sapeva quale era il suo compito di onesto e giusto cittadino e di fervente e devoto cristiano: contribuire a costruire la Gerusalem-
me celeste e respingere da se stesso la tentazione dell’e-rezione della Torre di Babele.
Definite così le città “ideali” più significative di ogni tempo, va detto che «la strutturazione dello spazio me-dioevale era strettamente legata alla definizione dei fini spirituali dell’umanità come di ciascun individuo». Il medioevo pensava, viveva e agiva in modo cristiano, per cui all’organizzazione “carnale” della città il cristianesi-mo cercava di affiancare una forma “spirituale” che fun-gesse da fine. Un fine che non poteva che essere Dio. Il principale ispiratore di tale condotta fu sant’Agostino, la cui influenza fu determinante nel periodo medioevale. Egli lasciò in eredità all’Occidente una visione del cosmo che stava racchiusa tra Creazione e Giudizio, che è come dire tra Peccato Originale e Incarnazione. La visione di Agostino era tutta giocata sulla categoria del tempo e non dello spazio. Tuttavia l’Ipponiense non desiderava umiliare lo spazio in sé, gli edifici e le costruzioni su cui i romani avevano insistito la loro pietas, quanto la conce-zione pagana di esso. Il messaggio intendeva significare che i templi pagani non erano la dimora del divino, Dio abitava piuttosto nei cuori di ogni uomo. La vera dimo-ra di Dio era la comunità dei credenti, vere e proprie “pietre viventi” fabbricanti l’edificio mistico della Chiesa (1 Pietro 2,4-5). Prima che alla costruzione degli edifici sacri era necessario, richiamava Agostino, lavorare all’e-dificazione dei fedeli, perché non vi sarebbe stata una Gerusalemme celeste fino a quando non si fosse attuata una comunità di veri e sinceri cristiani.
Una lettura del De civitate Dei, l’opera che Agostino scrisse intuendo la fine dell’Impero Romano, mostra la sua insistenza nel separare i piani terreni da quelli celesti e il continuo invito a iniziare un pellegrinaggio interiore che conduca alla conversione del cuore. L’uo-mo però difficilmente riesce a salvarsi da solo e quindi gli è necessario l’innesto in una società che, non più multitudo, è ormai civitas, è una città in cui regnano con-cordia e unitas 4. Questa visione agostiniana che forza il primato dello spirituale sul carnale, o se si preferisce del temporale sullo spaziale, permeò di sé l’Occidente latino fino al sorgere della modernità. Tuttavia, quando l’Impero Romano d’Occidente crollò sotto il peso dei suoi fallimenti, si disfece anche della struttura sociale che era riuscito con pazienza a edificare. L’agostinia-na gestione della dimensione del tempo lasciò allora il posto alla figura complementare dello spazio. Al posto
— 7 —
Natura, ars, logos. Epistemologia di una città medioevale
dell’Imperatore o dei poteri consolari adesso erano i vescovi ad avere il controllo del territorio e della vita sociale e spirituale dei fedeli, e i vescovi esercitavano il loro ruolo in edifici architettonici ben definiti: batti-steri e cattedrali. Il centro della vita interiore non era più articolato e strutturato su concetti astratti come Creazione e Incarnazione, ma poggiava su qualcosa di concreto come gli edifici sacri. I misteri della fede, come l’espressione del credo interiore e della Chie-sa universale, adesso erano “mostrati” nelle opere ar-chitettoniche, le quali a loro volta erano pensate per assumere forme plastiche che fossero un’indefettibile espressione della propria fede, ormai da non più vivere nell’intimità, ma da rendere pubblica ovvero cittadina. Nascono così i differenti stili che tempesteranno di ro-manico e gotico il paesaggio dell’Europa medioevale, con le città che faranno a gara per erigere la chiesa più maestosa e architettonicamente “creativa”.
A partire dal X secolo in Europa, a causa della crisi dei poteri centrali e per merito dell’inizio dello svilup-po economico, andarono sviluppandosi numerosi po-teri locali sempre più liberi dal potere centrale 5. Alla trasformazione dell’espressione del culto si aggiungeva quella della vita civile. In Italia le città si svilupparono col favore di due elementi, entrambi ereditati dalla ci-viltà tardo-antica: l’origine cittadina della civiltà roma-na, quindi l’importanza che la città rivestiva nell’eco-nomia e nella cultura dell’età imperiale, e la base epi-scopale dell’ordinamento cristiano, grazie alla quale si riusciva a raggruppare attorno alla sede del vescovo la comunità dei fedeli. Il Medioevo carolingio assegnò al termine Ecclesia il significato di res publica christianorum, per cui «l’Ecclesia [.,..] costituiva l’armatura istituzio-nale atta a garantire l’efficacia del sistema dominante di rappresentazione del mondo» 6. L’Ecclesia veniva così a indicare una societas intesa a raccogliere la comunità dei battezzati, avente il suo parallelo nel Comune che costituisce invece la società dei cittadini. Nell’alveo di questo contesto, la pace di Costanza del 1183 segnò un cambiamento epocale. In essa l’imperatore riconosceva ai cittadini dei Comuni una base di uguaglianza, abolen-do di diritto le odiate servitù. Si veniva così a preparare il contesto storico che avrebbe visto nel XIII secolo ve-nire a sintesi il mondo laico e il mondo cristiano in una reciproca accettazione che rimarrà salda fino all’epoca moderna.
Verso il 1250 la rete cittadina dell’Europa era trac-ciata e tale rimarrà fino al periodo dell’industrializza-zione. Nel contesto storico di allora: «la città è il cen-tro di sviluppo di una società complessa che si adatta al sistema signorile e alla sua ideologia, ma elabora le proprie gerarchie» 7. La città era adesso intesa come lo specchio terreno di un cosmo non separato in catego-rie, ma gerarchizzato in strutture a valenza antropo-logica e geometrica, dove non erano le opposizioni a dominare, ma le entità complementari. La tipica città del medioevo, sia nel suo tessuto urbanistico, sia nel suo insieme comunitario di soggetti diversificati, veni-va a significare una specie di cosmo terreno del tutto ordinato, con una propria gerarchia di simboli che a loro volta identificavano la gerarchia della fede e dei valori civili. Il centro aggregante, l’elemento unifica-tore capace di dare senso al tutto ordinato, era la real-tà effettuale della giustizia: quella divina nei confronti dell’uomo peccatore, ma redento da Cristo, e quella civile, che si traduceva in pace e libertà cittadine. La città microcosmo, dove lo spazio è forma del cosmo creato e il tempo è quello della creazione, è il centro vivo della fusione tra fede in Dio e fiducia nell’uomo.
Tradotto nei termini propri della teologia il centro non poteva essere che Cristo, colui che si era immola-to sulla croce affinché fosse ristabilita la pace tra cie-lo e terra e fosse finalmente restituita la giustizia, col suo carico di liberalità. Se con Adamo erano giunte nel mondo le tenebre e si era diffusa l’ingiustizia (Genesi 3, 1-20) con Cristo, nuovo Adamo, l’equilibrio turbato era ripristinato (Romani 3,21-26). L’evento dell’Incar-nazione, che trova il suo apice nella Croce, diventa così l’attimo dove visibile e invisibile si congiungono, pro-prio là dove l’umano e il divino si fondono in perfetta simbiosi di intenti e di fini. Incarnazione vuol dire sì la croce, di cui gli edifici cristiani assumeranno architet-tonicamente la forma, ma anche rito del battesimo, ini-ziazione alla vita in Cristo. Piace allora supporre che il centro geografico della Firenze medioevale, di un cen-tro urbano ormai affiancato dalla romanità pagana, sia il “bel San Giovanni” di dantesca memoria (Inferno XIX, 17). Al centro geografico della città romana, il punto di incontro tra cardo e decumano, si sostituisce il Bat-tistero, il “centro cristologico” dove gli abitanti della città terrena si impegnano a diventare cittadini del re-gno di Dio. Da Babilonia a Gerusalemme. A un centro
— 8 —
Alessandro Salucci
geometrico si sostituisce un centro al contempo umano e divino, forse la migliore simbolizzazione della città medioevale. Come la Pasqua è il fulcro attorno a cui si organizza il tempo liturgico, il Battistero è il fulcro attorno a cui si organizza la spazialità della città.
«L’uomo medioevale [...] vive in una foresta di sim-boli», ci ricorda lo storico Jacques Le Goff 8. Sant’Ago-stino era stato chiaro nell’argomentare che il mondo si compone di signa e res. Purtroppo molte res, soprattut-to quelle che avevano attinenza al sacro o al divino, re-stavano nascoste alla comprensione immediata e c’era bisogno di ricorrere ai simboli per renderle evidenti. L’opera dell’artista aveva questa funzione. Doveva, at-traverso specifici giochi simbolici, far percepire l’im-pronta del divino nel mondo creato attraverso la sua riproduzione in forma artistica. I chierici, gli unici a possedere le conoscenze necessarie per accedere all’in-terpretazione allegorica della Bibbia, erano i decifratori competenti di questo universo simbolico. E fu in effetti il simbolismo biblico a essere, sotto la diligente direzio-ne di questi “epistemologi” del sacro, la fonte ispiratri-ce dell’arte in genere e dell’architettura in particolare. Non era il gusto estetico o la semplice funzionalità a guidare l’artista medioevale in questa scelta, ma un motivo radicato nella connessione tra fede e vita, ossia di quella potente chiave interpretativa per tutto ciò che il XIII secolo produsse in ogni campo del sapere. Per connettere il visibile all’invisibile, per fondere sacro e profano in un’unica entità significante, si ricorreva alla gerarchia dei simboli, insomma alle figure iconiche, le quali, e questo è l’essenziale, avevano nella geometria il loro nucleo tematico ed epistemologico. Nel Medioevo è il simbolo la chiave che permetteva anche agli anal-fabeti di decifrare il mondo. E quale migliore simbolo di quello geometrico, così innato all’uomo, ma pure usato da Dio nella costruzione del suo universo?
La magia del numero difficilmente lascia indifferenti e non attrae nelle sue maglie le mente dell’uomo, ma mai come nel Medioevo questo fascino esercitò la sua influenza. I monaci medioevali leggevano e commenta-vano la Bibbia ma anche, certamente a partire dal XII se-colo, il Timeo di Platone. Un esercizio dal quale intuivano che la simbologia del numero e delle figure geometri-che era immessa in ogni pagina e ne costituiva il tessuto interpretativo. Moltissimi dei significati spirituali usati nella vita di ogni giorno erano chiosati nel Medioevo at-
traverso i numeri. Tre era il segno visibile dell’essenza invisibile di Dio, la SS. Trinità. Quattro erano non solo gli elementi di cui era composta la materia corruttibile, sorta da una diversa miscelazione di aria, terra, acqua e fuoco, ma anche il numero degli evangelisti, dei fiumi del paradiso terrestre, delle virtù cardinali. Sette erano i doni concessi dallo Spirito Santo, i sacramenti e i pec-cati capitali. Dieci erano i comandamenti del Decalogo e della Chiesa. Dodici era il numero degli Apostoli, delle porte della Gerusalemme celeste, dei mesi dell’anno e dei segni zodiacali. Numeri che univano sacro e profano, celeste e terrestre, virtù umane e doni divini.
Considerato che «ai procedimenti numerici corri-sponde regolarmente una figura geometrica che contiene al suo interno una copia di se stessa», i pitagorici avevano intuito «che questa immagine poteva anche rappresen-tare il rapporto tra “conoscente” e “conosciuto”» 9. Tra soggetto e oggetto si evidenzia perciò una forte identità e nello schema di una mente medioevale questa evidenza si traduceva immediatamente nel rapporto tra Creatore e creatura. Il numero rimandava dunque a qualcosa di altro da sé. La geometria, la scienza architettonica per definizione, applicherà con correttezza questo assun-to riuscendo a fare delle figure geometriche il simbolo che lega il finito all’infinito, l’umano al divino, il sacro al profano. Non è facile per chi si è formato in una cul-tura post-illuminista partecipare allo spazio mentale dell’uomo medioevale, per cui è arduo entrare in queste dinamiche di pensiero, ma nei secoli di mezzo nessuno si sarebbe mai permesso di intendere come distinti natura e sopra-natura, essendo la creazione il prodotto diretto e mirabile della potenza di Dio. Nella creazione il Som-mo artefice aveva lasciato le sue impronte e ad esse ci si rivolgeva per riuscire ad essere “artisti” perfetti come Lui lo era stato. Lo schema simbolico dei numeri e del-le figure era usato quindi con un doppio fine: rendere l’opera artistica un continuo rimando a Dio e imparare da Dio creatore l’arte perfetta del costruire.
Tra Creature e creatore si iniziava però così una sot-tile distinzione che non voleva ancora indicare una netta separazione. Fedeli al concetto latino di religio, che sottin-tende una fedele reciprocità tra il vassus e il senior e tra il sacerdote e il fedele, la religio istituisce un vincolo basato sulla “fede”, vale a dire su una reciproca fiducia 10. Una fede intesa non solo nel suo significato teologico, col suo carico di dogmi e dottrine, ma anche come un patto che legava
— 9 —
Natura, ars, logos. Epistemologia di una città medioevale
in un rapporto di fedeltà i contraenti. Come il battesimo legava alla Chiesa, così la residenza all’interno di una cinta muraria legava alla città. Città che erano abitate da per-sone che non intendevano la loro fede religiosa come di-staccata dagli «altri ambiti discorsivi e organizzativi della società» 11, ma che facevano di essa la motivazione del loro essere cittadini. È bene infatti ricordare che la religione intesa come esperienza soggettiva e individuale, nonché separata dalle altre sfere di vita collettiva, è un retaggio della modernità post-illuminista e dell’idea napoleonica della laicità dello stato. L’uomo medioevale non possede-va tali distinzioni e non erano certo queste a organizzare la sua esperienza del mondo.
Un diverso uso del termine religio era quello re-lativo al voto religioso, ovvero l’impegno solenne che legava i monaci e i frati ai voti evangelici e alla regola dell’Ordine di appartenenza. In effetti nel XII-XIII se-colo grazie al costituirsi dell’ordine cistercense, la ca-tegoria di religio passerà a identificare un’appartenenza a un Ordo, di cui i tessuti sociali e amministrativi del-le città non potranno fare a meno, rimanendone anzi fortemente condizionati fino a poter ipotizzare un’in-fluenza nell’organizzazione urbanistica. Inoltre il com-piuto passaggio dal paganesimo al cristianesimo com-portò che all’idea di religio si associassero due entità concettuali che diverranno essenziali, quella di verità e quella di giustizia. Mentre nel mondo antico, sia greco che romano, esse erano proprie della speculazione fi-losofica, nell’Italia dei Comuni saranno le aggregazioni urbane che dovranno garantire al loro interno, in forza di propri statuti, giustizia e accordo con le leggi divine.
Per Agostino la conoscenza del vero coincideva col possesso della felicità ed è facile intuire il valore che egli assegnava al sapere, se solo si ricorda che il messag-gio di Cristo è tutto teso alla realizzazione della felicità del singolo. Eppure le conoscenze teoriche non erano mai fini a se stesse, ma comprese come autentici stru-menti di contemplazione del creato, che tuttavia non poteva essere sufficientemente indagato senza l’ausilio delle sette “arti liberali”. Se ai teologi e ai religiosi era-no consone le scienze del trivio (grammatica, retorica e dialettica), per i laici lo erano quelle del quadrivio (arit-metica, geometria, musica e astronomia). Il termine di arte liberale rimanda al sapere proprio dell’uomo libe-ro. Vitruvio, il grande architetto romano, comprendeva tra esse anche la medicina e l’architettura stranamente
escluse da Marziano Capella nel suo De nuptiis Philolo-giae et Mercurii, che tanto influì sulla definizione medio-evale di arti liberali. Isidoro di Siviglia nelle Etimologie annette le arti liberali nel novero della tripartizione della filosofia in fisica, logica e etica, iniziando così ad ammettere un principio di razionalità nell’esercizio dell’attività umana. La “tecnica” si inizia a inserire nel contesto cristiano, mettendosi in certo modo a servizio dell’espressione teologica, e dunque razionale, della fede. Scorrendo i trattati del XIII secolo che si interes-sano alla funzione dei saperi e alla loro classificazione, iniziamo a riscontrare la necessità non solo di dividere al loro interno le singole discipline, ma di anteporvi una distinzione più ampia, quella tra scienze divine e scienze umane 12. «Questi testi sembrano cercare non soltanto una divisione delle scienze nel quadro offer-to dal corpus aristotelico e dai suoi commentatori, ma una ragion d’essere alle relazioni di dipendenza e di su-balternazione fra i saperi che lo schema classico non è più capace di soddisfare» 13. La soluzione si troverà con il sorgere, già con il De ortu scientiarum di Robert Kilwardby, di scienze estranee alla tipica classificazione propria delle sette arti liberali.
La città del Duecento aveva l’aspetto di un immenso antro di Vulcano in cui vengano forgiate nuove leghe per resistere all’usura del tempo. Natura, tecnica e ragione ne erano gli ingredienti. Il grembo del tessuto cittadino, fecondo di nuovi bisogni e desideri, accoglieva in sé gli edifici delle Università al pari delle botteghe degli arti-giani. Grazie a questa coincidenza spaziale era come se la ragione e l’arte si mettessero a servizio della Natura. Per noi figli della modernità non è facile comprendere ciò che queste tre parole significavano per l’uomo me-dioevale. Ars, ratio e natura non avevano infatti la stessa accezione semantica che noi contemporanei assegniamo ai relativi termini. Nel Didascalicon di Ugo di san Vitto-re, l’arte riguardava la materia che viene elaborata e tra-sformata, mentre la scienza aveva come oggetto la spe-culazione, agiva cioè attraverso la ratio. Inizia da questa distinzione il formarsi di un’interdipendenza tra saperi teorici e tecnici e la città, il luogo della produzione ma-nifatturiera, il centro vitale dove al sapere tecnico e te-orico corrisponde un fare. Per capire al meglio ciò che l’urbanistica fiorentina riuscirà a comporre a partire da questi elementi, diamo una breve occhiata al diverso si-gnificato dei tre termini.
— 10 —
Alessandro Salucci
Gli uomini medioevali erano persuasi, al pari dei moderni, che il mondo naturale fosse organizzato secon-do leggi razionali e come tali conoscibili. Opera di Dio, la Natura sarà l’esempio medioevale dell’ordine raziona-le e diverrà il modello a cui l’artista/artigiano attinge-rà i riferimenti per la sua produzione. Dio aveva creato l’uomo a propria immagine e somiglianza, lo aveva cioè dotato di una ragione che nel linguaggio filosofico me-dioevale sottintendeva una virtù conoscitiva e pratica. L’una per conoscere il vero, l’altra per attuare il bene e stabilire un definitivo rapporto tra verità e giustizia. L’agire umano in ogni sua attività doveva essere guidato da un’ars, da un saper fare che coniugasse la ragione con la natura. Nel Roman de la Rose, almeno nell’ampliamen-to che ne farà di Jean de Meung, la Natura ha Dio come maestro. Solo l’Essere supremo, la cui bellezza non ha limiti, riesce a esprimere la bellezza della natura. È così che essa, che Alano di Lilla ebbe l’ardire di definire vi-caria Dei, inizia a essere «considerata come un ministro e un luogotenente, cui Dio ha conferito pieni poteri sul mondo» 14. Per Natura dunque si intendeva essenzial-mente l’opera di Dio, donata all’uomo affinché nella sua contemplazione potesse ritrovare la strada che condu-ceva al Creatore. Vivere nella natura voleva dire abbeve-rarsi del linguaggio divino, perciò i monaci costruivano le loro abbazie là dove la natura creata splendeva in tut-ta la sua bellezza. Sapendolo, i maestri dell’urbanistica medioevale, come i mastri costruttori che presiedevano alla costruzione degli edifici sacri cittadini, vollero che l’identico codice con cui Dio aveva creato il mondo fos-se replicato nel costruire le città. La fede nella potenza ordinatrice del Creatore si esprimeva col modellare la pietra, il legno e ogni altro materiale che fosse utile a celebrare l’onore della città e dei suoi abitanti. In pratica il mastro costruttore edificava imitando la Natura, a sua volta espressione dell’“arte” del Creatore.
Ars, in latino, è una parola dalle molte sfumature. Il termine latino traduce la parola greca techne, che a sua volta rimanda al termine episteme, il sapere fondato su solide e possenti basi. Un intreccio di significati che fa intuire come per l’uomo antico e medioevale non fosse possibile concepire una separazione dei saperi, tipica in-vece della modernità, che della specializzazione ha fatto il suo vanto. Per i greci al termine techne corrispondeva ogni attività umana che procedesse con metodo e rigore critico, da qui il rimando all’episteme. Analogamente l’ars
latina e quindi medioevale, era considerata come una forma umana di creazione, un generare secondo un ordi-ne, allo stesso modo in cui Dio, stando al primo capitolo del Genesi, aveva creato il mondo 15. Aristotele attribu-iva all’arte una funzione positiva, supponendo che: «l’i-mitare è un istinto di natura, comune a tutti gli uomini fino dalla fanciullezza», attribuendo all’artista il compito di emulare la natura 16. Mentre per Giambattista Vico è nel secondo stadio dell’umanità, quello in cui gli uomini avvertono le cose che accadono attorno a sé con l’animo perturbato e commosso dei bambini, che si esprime la creazione artistica, per i medioevali l’esercizio dell’ar-te è specifico dell’età adulta. L’imitazione della natura richiede maturità di pensiero e proprietà tecnica. L’ar-te nasce infatti dall’incontro tra ragione e natura ed è necessario che entrambe siano ben conosciute da chi le esercita. L’artista doveva perciò essere in possesso delle arti “liberali”, comprensive della logica e delle discipline atte alla conoscenza della natura, per poter meglio espri-mere il suo ingegno.
La ragione aveva ormai fatto il suo irreversibile in-gresso. Il termine greco logos, corrispondente del latino ratio, è dotato di molteplici significati, tanto che in nes-suna lingua moderna ne esiste uno analogo. Fondamen-talmente esso indica la razionalità insita in un qualsiasi linguaggio, sia esso parlato o figurato, come può essere quello della matematica o della geometria. Il latino ra-tio accentuerà maggiormente, rispetto al corrispettivo greco, la facoltà discorsiva dell’uomo e per questo vorrà distinguersi dal termine intellectus, che indica piuttosto la capacità intuitiva della mente umana. Il cristianesimo indicherà nel logos, nella parola razionale, il principio di tutto, tanto che l’evangelista Giovanni lo identifica con la seconda persona della SS. Trinità (Giovanni 1, 1). Non potendo allargare la nostra riflessione episte-mologica oltre questi ristretti termini lessicografici, vale invece ricordare che il comparire della Scolastica, che fu il primo tentativo di armonizzare fede e ragione, coincise con il sorgere dei primi edifici gotici. Erwin Panofsky è puntuale nel ricordarci che nel gotico ma-turo «l’anima umana, benché riconosciuta immortale, veniva considerata come principio organizzatore e uni-ficatore del corpo piuttosto che una sostanza da esso indipendente» 17. Iniziava il trionfo dell’aristotelismo sul platonismo, il trionfo del razionale sillogistico sul mito e la dialettica, che avrebbe ben presto trasformato
— 11 —
Natura, ars, logos. Epistemologia di una città medioevale
i rapporti tra uomo e natura, fino a rendere credibile l’idea che l’esistenza di Dio potesse essere dimostrata attraverso il creato piuttosto che a priori.
Come noto, nel pensiero medioevale la ratio tende-va a essere intesa anche nel senso di una virtù morale che guidava al retto agire. La ragione pratica era in-somma a servizio della giustizia, se la giustizia è intesa nell’accezione di “giusto rapporto”. Mentre questi mu-tamenti concettuali si consolidavano, l’uomo iniziava a essere il centro prospettico dello spazio divino e socia-le, come la pittura di Duccio e Giotto iniziavano a far intendere. Pittura che – come conferma Panofsky – co-minciò a essere accettata ovunque tra il 1330 e il 1340, ossia negli anni in cui Firenze andava consolidando la sua fortuna artistica. Era, insomma, come se la ragione “gotica” fosse chiamata ad adattarsi alla ragione biblica e liturgica, che è come dire adattare il pensare umano al sapere divino. Ma siccome «né le scienze naturali né le discipline umanistiche avevano sviluppato loro spe-ciali metodi e terminologie esoteriche l’insieme delle conoscenze umane restava accessibile all’intelletto [...] non specializzato», e «l’intero sistema sociale andava rapidamente evolvendo verso un professionalismo ur-bano» 18. Fu questo, almeno nella sua fase iniziale, un processo sociale abbastanza elastico, tanto da consen-tire al religioso e al laico, al letterato come all’esperto di codici giuridici, al maestro in sacra pagina piuttosto che all’artigiano, di entrare in diretto contatto tra loro stabilendo relazioni reciproche su una base di perfetta uguaglianza. Eccoci allora davanti la città del Duecen-to, un ambiente protetto e garantito al suo interno da uno scambio sociale di conformi uguaglianze, dove i differenti saperi convergono verso un’unità di fini.
In un tale contesto di specifiche competenze, che già lascia intravedere gli anni in cui la razionalità verrà usata come principio da contrapporre all’autorità, aveva una speciale posizione l’architetto. Liberamente scelto propter sagacitatem ingenii, questo mastro costruttore ini-ziava allora a salire la scala sociale arrivando ben presto a guadagnare quel tanto da fare invidia alle classi borghesi minori, sino a comparire in cantiere indossando i guanti e impugnando il bastone, coprendosi le spalle col man-tello, fino a godere del privilegio di essere immortalato in uno dei capitelli che facevano da corona alle colonne della “sua” chiesa. In questa figura di “costruttore artista” l’arte si fondeva con la ragione per essere capace di imi-
tare la natura. Un’abilità asservita dunque alla bellezza, a quel trascendentale che anima in profondità il messaggio cristiano, essendo la bellezza inseparabile dall’amore. Bella è anzitutto la natura uscita dalle mani del Creatore e bella sarà l’opera dell’artigiano se riuscirà a imitarne l’opera. Gli storici ci ricordano che «nell’Italia medio-evale, e in Toscana in particolare, a differenza di quanto generalmente avvenne più tardi in Europa nelle fasi di forzata “industrializzazione”, le comunità manifatturie-re e commerciali più ricche furono quelle che in quel periodo seppero orientare gli investimenti in pulchritudo rendendo “splendidi” i centri urbani» 19. Alla richiamata bellezza delle città toscane, Firenze su tutte, non con-tribuì soltanto il raffinato splendore dei singoli edifici, ma fecero la loro parte pure gli imponenti e innovativi riassetti urbanistici. Firenze, ad esempio, nella seconda metà del XIII secolo rinnova completamente la sua strut-tura diventando uno dei maggiori centri urbani del con-tinente ed iniziando a elevare edifici civili e per il culto di incomparabile fascino. Non furono estranei a questi riassetti gli ordini religiosi, che con la loro conoscenza della teologia e del simbolismo biblico, giocarono un contributo non facilmente quantificabile nel processo di arricchimento urbanistico e artistico. L’assetto urbani-stico e architettonico degli edifici doveva essere lo spec-chio dell’ordine divino, e quindi doveva essere necessa-riamente “bello”.
Già i teologi del XII secolo avevano iniziato a riflet-tere sull’identità del linguaggio biblico con quello della Natura e accanto ai testi sacri si commentava il Timeo di Platone fino a percepire che la «natura è inserita nel-la storia della salvezza» 20. Il Creatore in effetti decretò buona l’opera uscita dalle sue mani (Genesi 1, 31), anche se subito dopo essa fu alterata dal peccato originale. Ep-pure la natura era pur sempre creazione di Dio e dunque espressione della sua gloria, dello splendore della sua bellezza. Lentamente venne così a formarsi un diverso approccio alla natura e un diverso modo di rapportarsi dell’uomo ad essa. «L’uomo, diceva il cristianesimo, non è situato nella Natura come un elemento che fa parte di un insieme; non ha un suo posto come le cose hanno il loro; egli non appartiene alla natura, ma alla grazia che è soprannaturale, e di conseguenza se vogliamo, per forza, assegnargli un posto ce n’è uno solo, il primo» 21. Fu solo nel XIII secolo che si venne coscientemente a te-matizzare il concetto di soprannaturale, così importante
— 12 —
Alessandro Salucci
nella storia successiva della teologia cristiana. La Natura si distingueva dalla Grazia e l’ordine delle cause seconde venne separato dalla Causa Prima, che era Dio. La presa in carico di questa coscienza fu una vera novità per l’uo-mo medioevale, che per la prima volta iniziava a sentirsi responsabile della libertà che aveva ricevuto da Dio, la quale lo eleggeva a suo con-creatore. Fu nel secolo di Giotto infatti che trovò forma quello spirito borghese che in poco tempo dette un volto nuovo alla società cit-tadina italiana. La grande svolta dello spirito occidentale prese l’aspetto del «ritorno di Dio alla natura, dalle cose ultime alle prossime, dai tremendi misteri escatologici ai problemi più innocui del mondo delle creature» 22. Ogni aspetto presente nel mondo era adesso compreso come in perenne armonia con il suo Creatore.
Contestualizzato quell’aspetto del pensiero medio-evale utile a dare risalto al libro che serve presentare, siamo giunti al momento di ricordare che queste brevi note, che certo meriterebbero ben altre premesse, han-no lo scopo di fare da apripista ad un prezioso studio che la prof.ssa Maria Teresa Bartoli ha dedicato alla Chiesa fiorentina di Ognissanti. Da tempo la studiosa dedica la sua ricerca, supportata da un’acuta intelligenza e una consona professionalità interdisciplinare, alla decifrazio-ne del tessuto urbanistico fiorentino nel tentativo di in-dividuare con rigore scientifico un intuito progetto d’in-sieme che avrebbe presieduto alla costruzione della città di Firenze. A tal proposito sono di supporto i suo studi su palazzo Vecchio e Santa Maria Novella, usciti per i tipi dello stesso editore. Non è nelle mie competenze entrare nel dibattito circa un giudizio strettamente tecnico sullo studio qui presentato. Mi è però lecito argomentare sulla forza dell’intuizione che lo sostiene e la presente nota introduttiva ne vuole essere la conferma. Leggere questo libro costringe infatti a chiedersi come ragionavano gli architetti e i capomastri del XIII secolo e la risposta non può essere che quella espressa da Maria Teresa Bartoli. A essere sinceri due sono gli spunti che sarebbe interessan-te raccogliere da questo preziosissimo libro.
Il primo è già stato introdotto ed è volto alla con-ferma architettonica circa il valore epistemologico della geometria. Il secondo riguarda ciò che il testo che pre-sentiamo lascia intravedere, vale a dire la necessità di ini-ziarsi a un nuovo approccio di ricerca che, pur contan-do su una severa specializzazione disciplinare, apra alla collaborazione tra materie tra loro diverse per metodo
e oggetto di studio. Il “costruttore” di Chiese in epoca medioevale non agiva mai senza la stretta collaborazio-ne del consulente teologico, generalmente un maestro esperto nelle discipline proprie della Scolastica. Un mo-dus operandi frutto di uno specifico modus essendi, che aveva la sua ragione d’essere nello «stabilire l’unità del-la verità» 23. A questa stretta interdipendenza rimanda continuamente, ad esempio, uno dei maestri più ferrati del periodo scolastico, il domenicano Tommaso d’Aqui-no. Egli ricorda che: «la virtù intellettiva presente nelle sostanze intellettuali si deve a una partecipazione della luce divina. Questa luce, dunque, è una e semplice nel primo principio; ma quanto più le creature intellettuali sono distanti da esso, tanto maggiormente quella luce si suddivide e si diversifica, come accade per le linee che si allontanano dal centro» 24. L’artista, fosse esso un urba-nista, un mastro costruttore, un orafo, un pittore, uno scrittore di Summe o di poemi, aveva l’obbligo non solo di esporre il suo sentire artistico seguendo i canoni del-la sua arte e comporre seguendo un sistema di divisioni e suddivisioni, ma era nella necessità di pacificare ogni supposta opposizione tra ragione e fede, che era come dire ridurre tutto all’unica verità. Un processo, questo del congiungimento delle parti nell’unica verità, che non era lecito ricercare con l’ausilio di schematizzazio-ni artificiali, ma piuttosto ricorrendo all’ordine natura-le e ancor più all’ordine soprannaturale. Non sfugge a tal proposito che il maggior “artista” medioevale, quale fu Dante Alighieri, nello scrivere la Divina Commedia, vera e propria Summa dei saperi raccolti e custoditi nella “città”, ricorresse nel contenuto e nel metodo espositivo, ad una forma legata al numero tre e quindi trinitaria.
La città, fulcro e cuore pulsante dell’Occidente me-dioevale, era tutto ciò e molto altro. Era composizione delle differenze sociali attraverso un’idea alta e nobile di giustizia, unità pacificata delle opposizioni, composizio-ne “razionale” di fede arte e scienza, unità del fine a cui si accordavano i differenti saperi. È però essenziale ricorda-re che molto di tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’apporto dei diversi Ordini religiosi che, decisi ad abbandonare la categoria feudale del monachesimo, scel-sero di “abitare” la città. Differenti i colori dei loro abiti e i loro carismi. Alcuni erano infatti dediti allo studio, altri alla contemplazione, altri ancora al lavoro manuale o all’assistenza dei poveri e degli ammalati. Il giungere massiccio nel tessuto fiorentino di nuove formazioni re-
— 13 —
Natura, ars, logos. Epistemologia di una città medioevale
ligiose, ognuna delle quali aveva un suo annesso edificio sacro, indurrà l’ avverarsi di una nuova mentalità urba-nistica. Sarà compito degli storici dell’arte come della Chiesa, argomentare circa il ruolo svolto nella vita citta-dina dagli Ordini religiosi, mendicanti in primis, ma sarà difficile confutare la tesi che il fenomeno fu veramente decisivo anche per la nuova politica urbanistica, come la-scia ben intendere questo bel testo della prof.ssa Bartoli. I conventi dei frati si sostituirono almeno a partire dal XIII, in parte o del tutto, al sistema parrocchiale spin-gendo così verso una progressiva razionalizzazione della città che trovò negli edifici ecclesiali un proprio punto gravitazionale 25. Ciò che Firenze ottenne fu il concorso del tutto nuovo alla vita cittadina di un corpo armato di pensiero scolastico che ebbe l’ardire di razionalizza-re ogni aspetto del tessuto civile e spirituale della città. Non sorprenderà allora leggere nelle pagine di questo li-bro che il tessuto spaziale di una chiesa venga scomposto nelle sue parti geometriche e che si cerchi proprio nella geometria la chiave interpretativa non solo di un singolo edificio, ma di una intera città. L’uso della ragione, che per gli scolastici non degenerò mai in un arido razionali-smo, era un modo per decriptare la fede in Dio creatore e redentore, ma pure la maniera per decifrare l’ordine della natura, anch’esso vero e proprio linguaggio divino. L’architettura, la pittura, la poesia, la composizione di trattati teologici, avevano questo di caratteristico. Niente da eccepire dunque se si sceglie, come il libro che pre-sentiamo, di rileggere la storia urbanistica di Firenze se-guendo questo schema ermeneutico.
Il razionalismo scolastico che abbiamo cercato di delineare non desiderava esprime nessun senso estetico in senso moderno, ma rendere conto dell’ordine che legava natura e cultura, attività divina e sapere umano. Eppure, imitare l’armonia di Dio non poteva che pro-durre il “bello”. E quale altra disciplina poteva meglio mostrare questa relazione se non la geometria? La ca-pacità “geometrica”, in fondo, è comprensibile come il segno della scintilla divina messa in noi all’atto della creazione della nostra anima, quindi una scienza che unifica il nostro linguaggio a quello divino. In una so-cietà cristiana, come quella che abbiamo di riferimento, tutto era orientato a questo senso delle proporzioni, al “giusto” rapporto tra le cose, ed era facile per un me-dioevale intendere la geometria nel modo accennato. Questa idea del bello come rapporto di equilibri fusi in
esatte proporzioni era espressa politicamente col senso di giustizia sociale e civile, liturgicamente con lo scan-dire il tempo del lavoro dei mercanti col tempo divino della festa, architettonicamente con l’uso sapiente del numero e delle figure. E la città era il luogo dove queste differenti espressioni di una medesima realtà trovavano espressione nell’arte. La città medioevale insomma era come un complesso sistema dove la parte aveva senso nel tutto e il tutto giustificava il perché della parte.
Per capire tutto questo e molto altro lascio adesso la parola all’autrice che con il linguaggio proprio della ge-ometria saprà raccontarci un mondo nascosto che final-mente viene messo in luce. Quello che però vorrei sotto-lineare è che l’autrice conferma una volta di più che non si può intendere una città come Firenze accontentandosi di un approccio con saperi parziali. Un messaggio questo di alto valore epistemologico. Per essere decifrata una città deve essere aiutata ad abbandonare i suoi pudori lasciando che si mettano sotto la lente di ingrandimento “tutte” le componenti che partecipano alla sua vita. Non si può ca-pire la Firenze medioevale senza farsi medioevali, perché se c’è una ermeneutica del testo ce n’è una anche del con-testo e l’humus medioevale era quello di una cultura non ancora frammentata in saperi parziali. Perciò per attivare uno studio che voglia essere significativo di un particolare, quale può essere una singola chiesa, non si può tralasciare di comprendere criticamente il tessuto sociale, culturale, politico e artistico, in cui questo singolo si trova a essere inserito. Fino a quando non si riuscirà a connettere nuova-mente i saperi non sarà insomma possibile comprendere l’evolversi di un organismo vivo e pensante come una città. La perfezione geometrica del disegno d’insieme, la ricerca di un raffinato realismo, l’imponenza di osare una costru-zione che fosse lasciata in testimonianza ai secoli a venire, danno a pensare che mai un singolo avrebbe potuto tanto. Il lavoro era corale, polifonico, come in un’orchestra dove anche il trillo fugace di oboe contribuisce a rendere “pie-na” l’esecuzione. Italo Calvino racconta che: «Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. – Ma qual’è la pietra che sostiene il ponte? – chiede Kublai Kan? – Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, – risponde Marco Polo, – ma dalla linea dell’arco che esse formano. Kublai Kan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse: – Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che m’importa. Polo risponde: – Senza pietre non c’è arco» 26.
Alessandro Salucci
— 14 —
Alessandro Salucci
1 Calvino 2002, p. IX.2 Calvino 2002, p. X. 3 Nuti 2002, vol. I, pp. 241-282, citaz. p. 243.4 Cfr. Agostino d’Ippona, De Civitate Dei, XIX, 11.5 Cfr. Milani 2006, pp. 629-664.6 Canetti 2006, pp. 535-580, citaz. p. 538. 7 Rossiaud 1987, pp. 155-200, citaz. p. 158. 8 Le Goff 1987, p. 34.9 Zellini 1999, p. 15.10 Canetti 2006, pp. 535-580, citaz. pp. 550-551.11 Ivi, p. 549.12 Per tutti si veda il Divisio scientiae di Giovanni di Dacia, attri-
buibile al 1280 circa. 13 Capezzone 2006, p. 653.14 Barbero 2006, vol. IX, p. 689.15 Davy 1980, p. 42.
16 Aristotele, Poetica, I, 4 e 9. 17 Panofsky 1986, p. 3.18 Ivi, p. 12.19 Francovich 2004, pp. 33-49, citaz. p. 33. 20 Davy 1980, p. 136.21 Lenoble 1974, p. 261.22 Hauser 1956, vol. I, p. 255.23 Panofsky 1986, p. 14.24 «In omnibus enim substantiis intellectualibus invenitur vir-
tus intellectiva per influentiam divini luminis. Quod quidem in primo principio est unum et simplex; et quanto magis creaturae intellectuales distant a primo principio, tanto magis dividitur illud lumen et diversificatur, sicut accidit in lineis a centro ingredienti-bus», Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 89, a. 1.
25 Francovich-Scampoli 2004, p. 36.26 Calvino 2002, p. 83.
Note
Agostino d’Ippona, De Civitate Dei, XIX, 11
Aristotele, Poetica, I, 4 e 9
Arti e storiA 2002Arti e storia nel Medioevo, 4 voll., a cura di E. Castelnuovo-G. Sergi, Torino, Einaudi
Barbero 2006A. Barbero, Ragione e natura nel basso Medioevo, in storiA d’europA 2006, volume IX, pp. 683-723
Calvino 2002I. Calvino, Le città invisibili, Milano, Mondadori
Canetti 2006L. Canetti, Discorsi e pratiche del sacro, in storiA d’europA 2006, pp. 535-580
Capezzone 2006L. Capezzone, Scienza e tecnologia nello spazio mediterraneo medioe-vale, in storiA d’europA 2006, volume IX, pp. 457-505
Davy 1980M.-M. Davy, Iniziazione al medioevo. La filosofia nei secolo XII, Milano, Jaca Book
Francovich-Scampoli 2004R. Francovich-E. Scampoli, Firenze al tempo di Dante, in Tartuferi-Scalini 2004, pp. 33-49
HauserA. Hauser, Storia sociale dell’arte, 2 voll., Torino, Einaudi, 1956, vol. I
Le Goff 1987J. Le Goff, L’uomo medioevale, in L’uomo medioevALe 1987
Lenoble 1974R. Lenoble, Storia dell’idea di natura, Napoli, Guida Editori
Milani 2006G. Milani, Il potere delle città, in storiA d’europA 2006, pp. 629-664
Nuti 2002L. Nuti, Lo spazio urbano. Realtà e rappresentazione, in Arti e storiA 2002, vol. I, pp. 241-282
Panofsky 1986E. Panofsky, Architettura gotica e filosofia scolastica, Napoli, Liguori Editore
Rossiaud 1987J. Rossiaud, Il cittadino e la vita di città, in L’uomo medioevALe 1987, pp. 155-200
storiA d’europA 2006Storia d’Europa e del Mediterraneo, (direttore A. Barbero), Parte II: Dal medioevo alla globalizzazione, Sezione IV, (a cura di S. Carocci), Il Medioevo (Secoli V-XV), Volume VIII, Popoli, poteri e dinamiche, Roma, Salerno Editrice
Tartuferi-Scalini 2004A. Tartuferi-M. Scalini, L’arte a Firenze nell’età di Dante (1250-1300), Firenze, Giunti,
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 89, a. 1.
Zellini 1999P. Zellini, Gnomon. Una indagine sul numero, Milano, Adelphi
BiBliografia
— 17 —
«Se due persone si trovano nello stesso luogo e guardano nella stessa direzione, dobbiamo trar-re la conclusione […] che esse ricevono stimoli
molto simili. Ma la gente non vede stimoli …Quelle due persone, invece, […] hanno sensazioni, e nulla ci costringe a supporre che le sensazioni dei due osservatori siano le stesse […] Ciò che […] trasforma gli stimoli in sensazioni […] è stato trasmesso mediante l’educazione; si è dimostrato, alla prova, più efficace dei suoi avversari storici nelle abituali condizioni ambientali di un gruppo; e, infine, è suscettibile di cambiamento sia mediante ulteriore educazione, sia me-diante la scoperta di elementi che non si adattano all’am-biente. Queste sono le caratteristiche della conoscenza […] Ma […] un’altra caratteristica è assente […] la conoscenza radicata nel percorso che va dallo stimolo alla sensazione resta tacita»
da Tacita conoscenza e intuizione (Kuhn 19786, pp. 232-236).
Il compito di ricerca del rilievo, nella concezione dell’autrice di questo studio, è evocare il maggior nu-mero possibile di parole dalla tacita conoscenza annidata nel percorso tra stimoli e sensazioni, quando l’oggetto della conoscenza è architettura, allo scopo di avvicina-re l’inizio e la fine di un percorso, le cui tappe non ci saranno mai completamente note.
Nel corso degli ultimi due decenni, l’innovazione tecnologica e l’informatica hanno attribuito al rilievo dell’architettura storica, valenze conoscitive ulteriori rispetto al passato, per l’accresciuta attitudine a descri-vere sia le quantità che le qualità degli oggetti cui si rivolge. Le nuove descrizioni ci consentono non solo di integrare, ma a volte anche di modificare o ribaltare giudizi storici precostituiti.
L’architettura medievale fiorentina, moderatamen-te interessata alla perfezione dell’angolo retto, alla re-golarità di membrature, alla evidenza leggibile del mo-dulo, è stata considerata, dal Vasari in poi, come arte incompiuta, tendente ad una regola che non raggiunge, per carenza di strumenti di scienza. Il culmine conqui-stato dal Rinascimento fiorentino ha imposto alla sto-
riografia il disegno di una cultura in progressiva ma-turazione, in cui l’architettura passa gradualmente da una visione disorganica e frammentaria (la cui felicità di risultato è considerata indizio di uno speciale istinto locale) ad una concezione organica unitaria.
Il rilievo puntuale di esempi medievali fiorentini, condotto con le attuali metodiche, permette, una volta che se ne studino i risultati con criteri adeguati, una descrizione diversa, in cui l’apparente frammentarietà si rivela come una forma di unità conquistata attraverso la complessità, riducendo ad armonia istanze e posizio-ni diverse, in un processo particolarmente interessante oggi, per la sua attualità.
Le architetture si propongono attraverso figure di-segnate; da alcuni millenni, questo disegno è stato prima tracciato in piccolo, con precisione geometrica, e poi tradotto nel vero con le tecniche e le abilità per le quali è stato pensato. Il disegno dell’architetto anticipa e spiega i modi per realizzare la figura disegnata della fabbrica. Esso è dunque un pensiero rivolto al costruire, articolato in maniera complessa, che, come ogni forma di pensiero, ha modi di espressione e contenuti che in parte appar-tengono alla singola mente pensante, in parte (la mag-giore) sono mutuati dalla cultura cui essa appartiene. L’aspetto immateriale del disegno emerge dalle parole con cui Antonio Manetti, il biografo di Brunelleschi, ne descrive il progetto di Santo Spirito:
«Filippo fece un disegno, in sul quale erano e fonda-menti solo dello edificio, e con quello a bocca disse loro com’egli riuscirebbe rilevato» (Manetti 1976, p. 122).
Dunque il disegno si risolve anche nel concorso di “grafico” e “discorso”; e quest’ultimo, come ogni discor-so ben fatto, per ricevere consenso e condivisione, deve avere coerenza interna e logica operativa. Queste qualità del disegno, quando esistono, si possono riconoscere nelle architetture, attraverso il loro puntuale rilievo, il quale, se condotto e analizzato a questo scopo, può divenire lo stru-
Rilievo, stimoli, sensazioni, conoscenza
— 18 —
Maria Teresa Bartoli
mento che porta alla luce anche la sostanza descrivibile “a bocca” (con parole) delle idee pensate. In esse trova-no sviluppo e articolazione contenuti tecnici (strutturali, funzionali, formali), ma anche assiomatici, simbolici, ide-ologici, religiosi, scientifici ecc., la cui rappresentazione richiede comunque di essere svolta dall’architettura con creatività e congruenza, quindi con arte e scienza.
Le idee del disegno sono idee mediate dalla geome-tria. La geometria costruisce le figure dell’architettura, come insostituibile garanzia che la loro descrizione è certa, univoca e replicabile. La geometria dà luogo ad un sistema di linee, superfici e volumi che definiscono le ca-ratteristiche di un’immagine densa di significati. L’orga-nicità del risultato consiste nel suo discendere da un nu-cleo unitario e pregnante di percorsi geometrici dotati di significato simbolico e congruenza logica. Perché questa organicità emerga, ne va svelata la presenza nei processi che realizzano le figure che delineano la forma. Le figure illustrano il significante (le ragioni profonde) del dise-gno dell’opera e permettono di risalire agli obbiettivi, ai motori ideali, ai valori simbolici ricercati dagli ideatori.
Questo scritto descrive i risultati dello studio del rilievo di Ognissanti, alla ricerca del nucleo organico del suo disegno, attraverso grafici e parole. La descri-zione ragionata delle consequenziali operazioni di di-segno geometrico illumina l’idea maturata dagli autori succedutisi nella fabbrica di questa chiesa. Se il rac-conto dello storico è risultato sempre utile, anzi ne-cessario, allo studio condotto sul disegno, i risultati di quest’ultimo però non si allineano esattamente con le conclusioni degli studiosi che prescindono dall’analisi grafica. La misura attentamente valutata, all’interno di una configurazione spaziale assunta senza pregiudizio, facendo emergere la vera natura delle strategie geome-triche messe in opera, può avere una forza di rottu-ra analoga a quella delle misure delle effemeridi che smontarono la teoria tolemaica, divenuta strumento di conservazione ideologica.
La ricerca svolta su Ognissanti fa emergere un singo-lare comportamento progettuale che evidenzia un modo speciale di ricorrere alla geometria, associata all’algorit-mo, quindi assunta con specifiche intenzioni di scienza.
1. Ognissanti e la sua piazza oggi, dalla sponda opposta del fiume. Foto di Gisella Mannino
— 19 —
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze
In questa chiesa si può constatare che un procedimento che poi diverrà caratteristico dell’architettura fiorentina gotica viene sperimentato in maniera “esemplare”.
Alexander Murray, in Ragione e società nel Medioevo (Murray 2002), descrive il progressivo crescere, nel corso del Medioevo, del dominio della ragione, attraver-so il rafforzamento e la diffusione del sapere scientifi-co, avvenuti con graduale accelerazione dall’età di Car-lo Magno e culmine nei secoli XIII e XIV. Nel passato, questo argomento era stato misconosciuto per la relativa scarsità di fonti letterarie che ne dessero testimonianza, conseguenza da un lato dello scarso prestigio goduto dai numeri, in epoca medievale, presso i cultori delle lette-re, dall’altro delle difficoltà della loro scrittura nel pas-saggio dalla numerazione romana a quella introdotta dal pisano Fibonacci. Nella ben documentata ricostruzione dello studioso, tre campi d’azione avevano concorso a dare risalto sociale al sapere scientifico, permettendo-ne la diffusione: la ricerca illuminata e feconda di alcuni personaggi di spicco (fra tutti emerge il Fibonacci), che dettero una nuova autorità a questo ambito del pensie-
ro, decaduto da secoli; le esigenze del commercio, che divennero il campo di verifica della attitudine del sapere matematico a produrre soluzioni utili; le nuove forme di governo, che richiedevano, per avere successo, di speri-mentare l’applicazione di metodi razionali, che proprio i matematici furono chiamati a mettere a punto.
Molto documentate sono le azioni compiute dai matematici a vantaggio del commercio; quelle com-piute a vantaggio dei governi affiorano in fonti quali le cronache di alcuni autori (ad esempio, in Italia, Bon-vesin dela Riva a Milano, Giovanni Villani a Firenze). Le azioni menzionate in queste fonti riguardano la ge-stione economica del paese, gli approvvigionamenti alimentari, i censimenti della popolazione, anche per categorie, i calcoli necessari per sostenere la guerra, per la conoscenza del territorio, della rete idrica e dei relativi manufatti tecnologici, ecc.
Osserva Murray:
«Se l’architettura gotica meriti un posto in connessione con il governo è un’altra questione. Per molti aspetti direi di no,
2. Ognissanti e la sua piazza alla metà del sec. XVIII, da G. Richa, «Notizie istoriche delle chiese fiorentine»
— 20 —
Maria Teresa Bartoli
ma per uno in particolare la risposta diventa positiva; e il fatto è ancor più degno di essere sottolineato, perché non è sempre il primo ad essere riconosciuto dagli storici dell’architettura».
L’aspetto cui si riferisce l’autore è quello che ri-guarda il modo di finanziamento delle cattedrali da parte dell’autorità pubblica, attraverso entrate di cui si hanno, in alcuni casi, notizie dettagliate.
«I governi costruivano grandi edifici. La sofisticata arte della muratura rendeva bene a coloro che la praticavano, e di conseguenza finì per dare vita a una setta di professionisti più o meno ben difesa. E questo frenò la sua diretta influenza sulla mente di altri […] ma ciò non escluse essa contribuisse indirettamente a formare il pensiero. Per costruire grandi edifici che si reggessero e apparissero dritti, gli artisti dovet-tero aprire una pagina del libro della matematica della natu-ra, e così facendo finirono per renderne i misteri accessibili ad altri» (Murray 2002, pp. 211-212).
L’analisi condotta su Ognissanti come su altri edifici fiorentini coevi può rendere più concreto e positivo il giudizio sull’architettura gotica e mostrare come essa, a Firenze, fosse in realtà connessa al governo, esempla-
re nello stabilire un chiaro rapporto con la matematica (che in quel momento veniva offerta alla cittadinanza dalle scuole dell’Abaco, informate all’insegnamento del Fibonacci), interessata a dare evidenza al corretto agire, tanto più rilevante in relazione alla gestione della cosa pubblica. Se il giudizio del Murray è giustificato dalla povertà di informazioni derivanti da documenti letterari sul disegno dell’architettura gotica e dalla difficoltà di attingerle in maniera diretta dal documento costruito, il rilievo con le potenzialità attuali è lo strumento che, ben usato, può sanare la carenza delle fonti.
I risultati che andiamo a illustrare mostrano come matematica e geometria insieme siano divenute il nodo centrale del contenuto dell’idea architettonica, in sé semplicissima (semplicità come essenzialità), ma certa-mente non povera, anzi, dotata di un particolare fasci-no enigmatico. Questo carattere enigmatico permane nella fabbrica anche nelle sue successive trasformazio-ni, come un carattere primario che condiziona tutti gli interventi successivi. Senza un racconto «a bocca» sarebbe impossibile darne conto. Senza un rilievo ben condotto e restituito in modo opportuno questo rac-conto sarebbe impossibile.
— 21 —
Il convento di Ognissanti è uno dei più antichi di Firenze e, insieme alla sua chiesa, nonostante le trasformazioni avvenute tra la fine del XVI e il XVII secolo, documen-
ta un momento speciale e problematico dell’architettura gotica fiorentina, il decennio tra il 1250 e 1260.
L’architettura di quel momento storico, epico per l’avvio dell’avventura economica, politica e culturale della società fiorentina (gli Ordinamenti del primo popolo sono del 1250, anno di inizio del Palazzo del Bargello; la costru-zione di Ognissanti prende le mosse nel 1251), è soprat-tutto impegnata nella definizione delle logiche del disegno di una città in rapida espansione e non offre ancora nei suoi edifici caratteri formali fuori dell’ordinario, limitandosi a replicare modi costruttivi della tradizione precedente.
Nella prima metà del XIII secolo l’insediamento dei conventi degli ordini religiosi nel territorio intorno a Fi-renze segue strategie ben definite, che, superata la metà del secolo, giungono a costruire idealmente intorno alla cinta muraria una serie di anelli concentrici (corone cir-colari ciascuna di superficie equivalente a quella del cer-chio interno), presidiati ognuno da un certo numero di istituzioni religiose, concepite come strutture sociali di sostegno alla vita religiosa, economica e civile della città (che ad esse provvede), mettendo in opera attitudini to-pografiche assai sofisticate, basate su conoscenze geome-triche alla portata di saperi specialistici (Bartoli 2009, pp. 142-155 e 2011) (Figg. 3, 4). L’immagine proposta verrà restituita da Dante, alla fine del suo viaggio nel Pa-
L’origine di Ognissanti e il disegno di Firenze
3. Le corone circolari di area equivalente per la distribuzione dei conventi goticiPunti notevoli:A Santa Croce; B Santa Maria Novella; C Canto alla Croce Rossa; D Santa Felicita; T Torre Reale; O Domenicane in via della Scala; P Santa Caterina d’Alessandria; E Sant’Ambrogio; F Santo Spirito; M Carmine; N Cestello; H San Domenico al maglio; L Santa Teresa; R chiesa dei Camaldolesi; S San Leonardo
— 22 —
Maria Teresa Bartoli
radiso, con la descrizione dell’Empireo, sorta di anfitea-tro a scalee appoggiato a verdi colline, attraversato nella sua vallata da un fiume che si trasforma in un lago di luce 1; nell’iconografia coeva altre rappresentazioni allu-dono alla concezione circolare 2 (Fig. 5).
Non è irrilevante il dato che la sequenza di anelli, tutti commisurati ad un modulo (il cerchio interno di
raggio 1000 braccia) avrebbe reso facilmente misura-bile la città. Una raggiera di 60 raggi (alcuni effetti-vamente impressi e ancora leggibili nelle maglie delle strade) avrebbe disegnato lotti della stessa superficie in tutto il circuito e in ogni corona. I trapezi isosceli dei lotti avrebbero avuto apertura angolare di 6°. I metodi di calcolo necessari per mettere in opera utilmente lo schema ideato non erano banali, ma gli uomini di cul-tura scientifica più aggiornata ne conoscevano i princi-pi e sapevano che la misura associata al calcolo poteva dare sostegno alle tecniche del bene amministrare; che il buon governo era rafforzato dal ricorso alla ragione, soprattutto se questa sapeva riconoscere che il bene sta nell’operare con giustizia 3. Non era forse stata la giu-stizia del far parti eque la grande ispiratrice della geo-metria (scienza della misura), fin dal racconto di Ero-doto (sec. V a.C.) sulla nascita di quest’ultima lungo le sponde del Nilo? 4
In questa fase prende l’avvio il programma delle grandi piazze urbane conventuali, destinate alle predi-che, concepite come ammaestramenti di massa, occa-sioni di promozione civile e stimolo sociale, diffusione della conoscenza. Il disegno dei grandi spazi collettivi fu tra gli obbiettivi della città del primo popolo.
I programmi urbani richiedono tempi molto lunghi per essere elaborati e ancor più per essere attuati. Se dunque verso la fine degli anni Settanta del XIII secolo le fonti testimoniano la realizzazione di interventi ur-bani molto estesi, essi potevano essere stati discussi e concordati molto prima.
Qui ci interessa un programma specifico, relativo alla bonifica e allo sfruttamento dei terreni a ovest della città, lungo il fiume immediatamente al di là del ponte alla Carraia (il Ponte Nuovo, 1218-20), dove gli Umilia-ti, presenti nelle vicinanze di Firenze dal 1239, vengono a insediarsi fin dal 1250, per promuovere l’attività ma-nifatturiera loro propria (la tessitura della lana), cui la città affida la sua volontà di crescita economica (Sznura 1975, pp. 78-84, Benvenuti 2006, pp. 41-52). Questo programma, oggetto di autorizzazioni specifiche che lo descrivono minutamente, negli anni 1278-79, va ben ol-tre le esigenze dell’ordine religioso e implica intenzioni di disegno urbano che potevano stare solo nella visione di chi governava la città 5. Esso comprende la previsione di un Prato, sfogo igienico e area a disposizione per esi-
4. Genesi geometrica dei cerchi dei conventi. Raggio del cerchio interno (A-C, C-B della 3) 1000 braccia; raggi successivi 1000√2, 1000√3, 1000√4, 1000√5
5. Gli emblemi delle istituzioni cittadine nel cerchio delle mura urbane, affresco nel Palazzo dei Giudici e Notai, Firenze, IIª metà del sec. XIV
— 23 —
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze
genze di vario ordine, la realizzazione di strade larghe orientate verso un polo che sembra essere già nelle men-ti, anche se nelle fonti appare più tardi: Porta a Prato, punto nodale del tracciato murario deliberato, secondo Giovanni Villani, nel 1284 (Fig. 6).
Il programma disegna sul terreno rurale extramu-rario grandi isolati, destinati agli ordini e alle loro in-traprese economiche e sociali di diversa natura, sotto-mettendoli però a irrinunciabili intenzioni della città.
Il linguaggio asciutto delle autorizzazioni descrive solo i risultati in termini di strade e larghezze, e non spie-ga le intenzioni e i criteri delle decisioni: ma i tracciati descritti, ben leggibili sul reale, ci sembrano autorizzare alcune deduzioni, che illuminano in maniera almeno in parte nuova l’urbanistica fiorentina di quel tempo.
Per la loro comprensione è necessario introdurre alcuni dati della cultura scientifico-tecnica coeva. Essa si è evoluta, come è noto, sotto l’impulso dell’insegna-mento di Leonardo Fibonacci, matematico innovatore nel suo tempo, la cui influenza promuove il diffondersi della scienza e delle scuole dell’abaco, numerosissime in Firenze. Fibonacci è matematico preoccupato di porgere la sua scienza come strumento utile a risolvere i problemi della vita reale, affinché possa diffondersi superando l’ostilità della cultura dominante, di genere letterario, legata al latino e alla educazione religiosa. Dunque, i problemi delle eredità, del commercio, delle rendite di capitale ecc. sono le occasioni per sviluppa-re, suscitando interesse, gli algoritmi più complessi. Tra gli altri è presente anche il tema della compravendita
6. Le figure geometriche dei lotti urbani autorizzati dalla Repubblica nel 1279, relativi a Ognissanti; il triangolo lungo via della Scala; il quadrato attraversato dalla via della Vigna Nuova, il trapezio della piazza di S. Maria Novella
— 24 —
Maria Teresa Bartoli
dei campi. Essa richiede certezza nella definizione del-le superficie, attraverso moduli ben definiti, e dunque questi vanno sistematizzati.
Fibonacci definisce (all’interno di un sistema me-trico di cui dà conto ragionato) lo staioro come unità di riferimento a Pisa (1 staioro = 66 pertiche quadrate, la pertica pisana lunga 6 piedi) (Boncompagni, 1862, pp. 3-4). A Firenze la canna agrimensoria (equivalente alla pertica pisana) è di 5 braccia e lo staioro vale 66 canne quadrate, ovvero 1650 braccia quadrate 6 (Fig. 7).
In maniera sorprendente, le imprese architettoni-che della Repubblica fiorentina nel XIII e XIV secolo, analizzate sulle attuali planimetrie digitali della Regione, rivelano impianti planimetrici commisurati allo staioro e ai suoi multipli secondo numeri interi, sia nelle figure semplici che in quelle più complesse, secondo modalità che rispecchiano l’intenzione di definire tracciati adatti a semplificare i computi della gestione, sia nella realiz-zazione che nella lottizzazione successiva (Fig. 8). Tutto ciò va visto non nell’ottica di una mera finalità contabile, ma nella volontà di rendere manifesta ed esemplare la straordinaria attitudine della nuova scienza (Fig. 9).
I grandi complessi religiosi e civili furono le occasio-ni di dare applicazione e testimonianza delle nuove idee.
Nel convento di Santa Maria Novella, il complesso più antico intorno ai Chiostri Grande e Verde permette di riconoscere il grande rettangolo del nucleo primario del convento di misure (200 x 165) brq = 20 staiora (iterazione dello staioro elementare di (165 x 10) brq). Il rettangolo della chiesa, tolte le sporgenze dell’abside e del transetto, copre la superficie di (165 x 50) brq, pari a 5 staiora. La piazza di S. Maria Novella prende le mosse da un trapezio alto 200 braccia, semisomma delle basi 165, area 20 staiora, cha assembla 16 triangoli isosceli di altezza 100 e base 165/4 (Bartoli 2009) (Fig. 10).
Il Palazzo della Signoria è definito a partire da un triangolo isoscele di base 165/2 e altezza 200, di area 5 staiora, diviso in due parti di proporzioni 2:3. La prima (dedicata al palazzo), costituita dal trapezio appoggiato alla base, di altezza 45, associata al rettangolo aureo di 45 x 73, forma il nucleo di Arnolfo; la porzione del nu-cleo della Dogana è determinata all’interno di un qua-drato di 110 braccia di lato in cui è disegnabile il tra-pezio che prolunga quello di partenza (Bartoli 2007). A questa figura, di area di poco inferiore a 6 staiora
(= 5,92), si addossa poi la figura composta della parte terminale del palazzo, che, assemblando una serie di triangoli di proporzioni vincolate, chiude nel suo stra-no perimetro 5 staiora esatte. Intorno, la grande piazza del Comune replica gli stilemi grafici della planimetria della fabbrica, costruita per raggiungere (entro la metà del sec. XIV), con figura complessa, la superficie di 15 staiora esatte (Friedman 2003) (Fig. 11). Due campi sono individuabili; il primo, a Ovest del palazzo, rag-giunge l’estensione di 10 staiora con figura assimilabile ad un trapezio scaleno sormontato da un triangolo; il secondo, definito nella seconda metà del XIV secolo, si estende per 5 staiora, raggiunte mediante tre triangoli di proporzioni predeterminate: un triangolo 3, 4, 5, una squadra a 45° ed una squadra a 60°. Figure analo-ghe erano già state messe in opera nel blocco che con-tiene il cortile dell’anagrafe, di ugual superficie, e nel cortile stesso (su questa parte di Palazzo Vecchio vedi Bartoli 2007).
I tracciati urbani conseguenti alle autorizzazioni concesse a Ognissanti negli anni Settanta del sec. XIII generano due triangoli, che hanno in comune la di-rettrice di via Palazzuolo (allora via San Paolo). Bor-go Ognissanti e via della Scala risultano tra loro quasi parallele. Disponendo, nello schema, Borgo Ognissanti in maniera perfettamente parallela alla via della Scala, otteniamo due triangoli di uguale apertura angolare, pari alla metà dell’apertura del triangolo di Palazzo della Signoria (triangolo di base 165/2 e altezza 200), ovvero quella del triangolo di base 165/2 e altezza 400 (l’area di questo triangolo misura 10 staiora).
L’isolato relativo a Ognissanti, realizzato alla fine del Duecento, da via dei Fossi fino all’inizio del Prato, tra via Palazzuolo e Borgo Ognissanti (comprendente quindi a Est l’area di S. Paolino e a Ovest le costru-zioni di fronte a S. Lucia), ha la forma di un trapezio appartenente ad un triangolo alto 1600 braccia e di base 330. La sua area misura 160 staiora, la cui pun-ta esterna all’isolato stesso è di 30 staiora; nelle 120 staiora dell’isolato, la porzione dedicata a Ognissanti, dal margine del Prato fino a via del Porcellana, è di 90 staiora, le residue 40 staiora appartengono all’isolato di San Paolino (Fig. 12)
Di fronte, verso Nord, l’isolato tra via della Scala, fino a via del Sole, e via Palazzuolo forma un triangolo
— 25 —
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze
7. La misura delle aree a Firenze in età gotica, sul modello delle aree di Pisa, secondo la «Practica Geometriae» del Fibonacci
8. Esempi di genesi di moduli fondiari di disegno urbano in età gotica a Firenze: lotti di 10 staiora = 165 x 100; = 82,5 x 200; lotti di 5 staiora = triangoli alti 200, base di 82,5; lotti di 2,5 staiora = triangoli alti 200, base 41,25.
9. Definizione geometrica del lotto relativo a Ognissanti
Lo staiorodeL braccio fiorentino
braccio: m 0,5836; pertica: m 2,918
iL modioro = 24 staiora
— 26 —
Maria Teresa Bartoli
rettangolo con lo stesso angolo al vertice del precedente, alto 1200 braccia fino alla via degli Orti Oricellari, di base 247,5 braccia, di area 90 staiora. Il disegno mostra lo schema assunto e la sua prosecuzione verso la città. I due triangoli, accostati, lasciano vuoto uno spazio qua-drato di 351 braccia di lato e area 75 staiora, il cui lato occidentale infila il ponte alla Carraia, mentre la diago-
nale, via della Vigna Nuova, taglia due isolati a squadra. Il triangolo occidentale è dedicato a San Pancrazio, quel-lo orientale si allarga ruotando un cateto dell’angolo di 360°/16, e proseguendo verso il fiume secondo l’angolo al centro del lato del pentagono (Fig. 12). Si trovano così l’ingresso al ponte a Santa Trinita (realizzato nel 1252), nonché il fronte del Palazzo Spini. Lo scostamento del lato del quadrato dalla via dei Fossi sembra cristallizzato nel bastione curvilineo di Piazza Goldoni. Sono stati così trovati il lotto di pertinenza di Santa Trinita e l’esatta ge-ometria del tratto iniziale di via Tornabuoni, all’imbocco del ponte a S. Trinita.
Quello che può essere apparso un insolito disegno legato a logiche di proprietà privata e di percorsi pre-esistenti si rivela frutto di un calcolo accuratissimo, applicato da una mente creativa, capace di costruire in terra figure di metrica predeterminata, affascinanti negli accadimenti che generano, condotte con sapienza a esiti urbani ben risolti. Tutto questo fu ottenuto con
strumenti ottici elementari, contando esclusivamente sul ragionamento geometrico, sulla similitudine dei triangoli, e sull’uso rigoroso dei raggi visivi, supportati da strumenti topografici derivati dall’astronomia (cer-chio graduato con mire mobili, quadrante geometri-co, bastone di Giacobbe). Possiamo intravedere quale obbiettivo fosse perseguito con gli schemi triangolari delle strade, osservando le relazioni che essi costrui-scono tra i poli rappresentati dalle chiese e dalle teste dei ponti. Essi vanno considerati come rettangoli, in cui le diagonali avvicinano gli estremi opposti. Forse questo aspetto di invito direzionale fu anche l’origi-
10. I moduli compositivi del convento e della piazza di S. Maria Novella
I Domenicani sono insediati nell’area a Ovest della città, fuori le mura, presso la porta San Pancrazio. Nel 1278 è fondata la chiesa definitiva, quando il convento è già in parte costruito.
Nel 1288 la Repubblica riorganizza i lotti intorno, disegnando la figura della piazza.
— 27 —
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze
ne dell’adozione del triangolo nel disegno di Palazzo Vecchio, con un fianco quasi parallelo al fiume, pres-so Ponte Vecchio, e l’altro, divergente, rivolto verso il precedente palazzo del Comune.
Se non l’iniziativa, almeno la condivisione e l’e-secuzione di questo programma sembrano affidate in buona parte agli Umiliati di Ognissanti. Nell’isolato,
la chiesa, di cui si hanno notizie che fanno supporre che sia ultimata nel 1258, è sul filo della strada cui dà il nome (compresa nel progetto del 1279) e normale ad essa. Il piano era già approntato e steso sul terreno più di vent’anni prima della delibera che lo riguarda?
Il ragionamento fin qui svolto ha preso le mosse da una evidente, strana circostanza, resa quantificabile
11. I moduli compositivi delle aree di Palazzo Vecchio e della sua piazza
1 Il triangolo di 5 staiora viene diviso in due parti di 2 e 3 staiora. 5 : (200 x 200) – 3 : (h x h)
2 Il trapezio di 2 staiora viene modificato in rettangolo, per avvicinarlo alla figura condivisa
3 Il trapezio viene allungato fino a inscriverlo in un quadrato, risolvendo l’algoritmo:155 : 64 = (155 + x) : x x = 109.109 è misura del muro interno.
4 L’area del nuovo trapezio è divisa in parti di area prefissata a partire dal fondo, con algoritmi.
5 L’area terminale, fissata in 5 staiora, risulta da una combinazione di triangoli, di cui due di proporzioni note, a partire dalla base di 108 braccia. Più equazioni risolvono la determinazione dei lati. I due triangoli maggiori hanno la stessa superficie, di 3575 braccia quadre.
proporzioni del cortile dell’Anagrafe
Il disegno della Piazza della Signoria
Somma aree = 24859 brq15 staiora = 24750 brq
— 28 —
Maria Teresa Bartoli
con esattezza dal rilievo: il cambiamento di direzione tra la chiesa e il suo chiostro. La chiesa presenta l’asse longitudinale ortogonale alla strada, mentre il chiostro non lo è. La storia stessa dell’insediamento del conven-to impedisce di porre grande distanza temporale tra i due manufatti, realizzati su un terreno non costruito 7. Perché nello stesso momento si affiancano due direzio-ni diverse? La misura dell’angolo formato da esse, poco meno di 6 gradi (misurato da Autocad = 5° 49’), si rivela ben compatibile con quello della bisettrice tra le direzioni di via Palazzuolo (nel tratto realizzato se-condo la delibera del 1279) e Borgo Ognissanti, il cui angolo è di 11° 38’ (Fig. 13). Questo è interessante, perché all’interno dell’isolato la mappa mostra che le direzioni dei lotti o sono ortogonali alle due strade che lo delimitano o hanno una direzione intermedia, ap-punto quella della bisettrice. La presenza di questa di-rezione significa che essa aveva dovuto essere definita, e
la geometria insegna che, se si deve trovare la bisettrice tra due rette che si incontrano fuori del foglio, la so-luzione si trova mandando per un punto di una di esse le ortogonali ad ciascuna delle due rette, e trovando la
bisettrice dell’angolo tra queste ultime. L’ortogonale a questo segmento nel suo punto di mezzo è la bisettrice cercata. La bisettrice ebbe probabilmente un ruolo nel tracciamento dell’isolato e dei lotti al suo interno e fu materializzata nel modo descritto; forse la chiesa e il cortile furono collocati in uno dei punti in cui fu defi-nita, e le loro figure planimetriche ebbero il compito di renderla emblematicamente manifesta.
Dunque, l’impianto urbano del convento di Ognis-santi svela con chiarezza, in alcuni aspetti peculiari, il carattere sofisticato di una progettazione il cui vanto maggiore era il metodo scientifico, inteso come ricorso a numero e geometria, attraverso un discorso formu-lato da algoritmi, secondo i più aggiornati strumenti di calcolo offerti in quel tempo dai maestri di Abaco, secondo l’insegnamento di Leonardo Fibonacci.
L’orientamento della chiesa discende dall’isolato, ed è legato alla definizione della strada, con il prospetto
rivolto genericamente verso sud e parallelo all’Arno. Anche il suo disegno, pur nella sua semplicità, doveva essere emblematico dei temi della società urbana del tempo, che, necessitando di strutture che ne promuo-
12. Schema geometrico dei lotti urbani intorno ad Ognissanti
Nel 1250 gli Umiliati si insediano lungo il fiume, alla sua uscita dalla città, e cominciano a costruire una chiesa (Ognissanti). Negli anni 1278-79 viene definito il trapezio tra via Palazzuolo, Borgo Ognissanti e via de’ Fossi.
Via della Scala viene realizzata verso il 1299
Per la individuazione delle aree sul triangolo le equazioni utili sono del tipo:
1600 br : 160 staiora = x : 30 staiora x2 : 692 braccia
1600 br = 160 staiora = x2 : 120 staiora x : 1384 braccia
La soluzione richiede che si calcolino, con buona approssima-zione, le radici di numeri che non sono quadrati perfetti
— 29 —
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze
vessero le attività e favorissero regole di convivenza atte a generare una meritevole mobilità sociale, stava trovando nella nuova scienza introdotta dalle scuole dell’abaco il metodo che l’avvicinava all’obbiettivo.
È noto che i conventi svolsero un ruolo di servizio fondamentale per lo sviluppo della vita urbana, non solo negli aspetti religiosi e sociali, ma anche in quelli econo-mici, che richiedevano rigore di metodo. L’Ordine de-gli Umiliati (quello che costruì Ognissanti) non era tra quelli “mendicanti”, anzi, i suoi membri si erano dati il compito di svolgere da imprenditori un’attività remune-rativa coinvolgendo la popolazione presso la quale vive-vano. A Firenze essi si dedicarono alla tessitura, specializ-zandosi nel lavaggio e nella coloritura dei panni, attività che richiedevano la prossimità del fiume. Dettero vita a un’industria che divenne, grazie alla loro presenza, il motore economico di quella parte della città. Il presti-gio raggiunto dagli Umiliati è provato dal fatto che essi
divennero i camerlenghi del Comune fiorentino, ovvero gli economi, coloro che tenevano la cassa e effettuavano i pagamenti; sappiamo che a loro fu affidato il compito di gestire le somme cospicue destinate a pagare i lavori delle mura di Firenze. Il compito assegnato è indizio di reputazione: si può pensare che competenza e affidabili-tà dovessero essere i titoli per ottenerlo. La competen-za doveva essere nel campo della contabilità applicata alla costruzione; quindi possiamo pensare che l’Ordine avesse dato buone prove di sé nella edificazione del suo convento e della sua chiesa, che fu una delle prime ad arrivare a compimento (si ritiene nel 1258).
Le misure delle mura di Firenze sono riferite dal Vil-lani in due significativi capitoli (CCLVI e CCLVII) del libro decimo della Cronaca, che sono considerati tra le non numerose testimonianze scritte dell’ingresso del controllo dei numeri nel governo delle città. Avendo trascritto la misura dei singoli tratti della poligonale del
13. Ragione geometrica della deviazione tra la direzione dell’asse della navata (ortogonale a Borgo Ognissanti) e la direzione dei loggiati del chiostro (ortogonale alla bisettrice del triangolo dell’isolato
Dal triangolo di altezza 200 braccia, base 82,5/2 braccia, area 2,5 staiora, angolo al vertice 11°39’, la cui bisettrice biseca l’angolo in due di 5°49’ < 6°
— 30 —
Maria Teresa Bartoli
tracciato, egli è in grado di indicare la lunghezza delle mura a nord del fiume (braccia 7700), che, sommata a quella delle mura a sud (riferita nel dettaglio delle par-ti, ma senza che sia indicato il totale), aggiunta due vol-te la larghezza del fiume (350 + 300), dà la somma di 14250 braccia per l’intero circuito. Il numero indicato è abbastanza compatibile con il perimetro che possiamo dedurre dalle cartografie preunitarie; ed è evidente che solo la decisa caratterizzazione geometrica della figu-ra poteva consentire di svolgere con esattezza i calcoli necessari per ottenere questi risultati. In dettaglio, ab-biamo analizzato il tratto tra la Torre Reale (sul fiume, a oriente) e la Porta a Prato a occidente. Il primo trat-to, fino alla Torre Pentagonale, è disposto secondo un arco di apertura 54°, raggio 2177 braccia, ed è lungo 2050 braccia; nel computo del Villani esso è la somma di (90 +442 +384+630)= 1546. Il secondo tratto, dalla Torre Pentagonale alla Porta Sangallo, lato dell’esagono iscritto nel cerchio di raggio = 2177, è lungo 2177; nel computo del Villani esso è la somma di (925+600+842)
= 2367. Il terzo tratto, dalla Porta Sangallo alla Porta a Prato, diagonale del quadrato di lato 2177 (è notevole il fatto che la spezzatura della Porta a Faenza divide questo tratto in due parti che stanno tra loro come 1: √2), è lungo 3078 braccia; nel computo del Villani la somma è (1848+320+1070)=3238. A quest’ultima somma va probabilmente aggiunta la lunghezza delle 6 grandi porte o torri, che il Villani avverte essere di 22 braccia: 22x6 =132; quindi 3238 + 132= 3370. Le due somme pro-pongono 7305 (dalla geometria) e 7283 (Villani), sostan-zialmente equivalenti, anche se la loro distribuzione non sembra sovrapponibile. Non sono invece compatibili con i nostri tracciati cartografici le misure dalla Porta a Prato all’Arno, e poi alla Torre di Verzaia di là d’Arno, percorso non più definito dalla regola, e quindi deciso in funzio-ne dei luoghi. Possiamo supporre che la misurazione del Villani sia il risultato della verifica (in una sorta di collau-do) di un progetto topografico messo in opera, in cui le parziali non sono state correttamente associate ai tratti reali, ma sono tutte presenti. Egli dunque non conosce
14. Il modello geometrico delle mura di Firenze
— 31 —
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze
la logica del disegno, ma ha ricevuto le misure di tutti i tratti, con qualche confusione sulla loro collocazione.
Le grandi mura disegnavano sul terreno, con la geo-metria, una figura “apotropaica”, simboleggiante le ambi-zioni regali della città e la sua concreta aspirazione a do-minare un vasto territorio (Fig. 14). L’allusione al leone, implicita nel tracciato, è il riferimento chiave che offre la struttura logica (modello e memoria) che ne tiene insie-me le linee. La cifra è conservata nelle mille immagini di profili di leone che a Firenze (e non solo) furono disegnate in quegli anni (Bartoli 2003, pp. 17-54) (Figg. 15, 16).
Questa fu tra le più prestigiose imprese in cui fu coinvolto l’Ordine degli Umiliati. L’esame di questo come di altri monumenti ideati a Firenze negli ultimi decenni del XIII secolo dà evidenza al fatto che l’atti-tudine degli ideatori non consisteva nel saper condurre calcoli a posteriori, ma nel costruire con creatività for-me e figure di misura conosciuta, sia perché prestabilita con giustizia (congruenza con la funzione e con le forze disponibili per la realizzazione), sia perché determinata con forma adatta al calcolo ulteriore 8.
Dunque, tra le caratteristiche salienti di queste ar-chitetture è quella di presentare un disegno che, anche se non difforme dagli schemi in circolazione nell’Europa gotica, è concepito per essere espresso con moduli me-trici adatti a favorire una giusta gestione del suolo 9.
A questo scopo vengono studiati schemi planimetrici di area predeterminata, e corrispondenti a proporzioni geometriche in uso nel disegno sia dell’architettura, sia della città. Tali aree sono selezionate con il criterio della facilità del computo: quindi il numero che le esprime sarà o multiplo delle potenze del 10 o in rapporto sem-plice con lo staioro, principale unità di misura delle aree in quel tempo, stabilita per convenzione in una quantità multipla del 10 10. La varietà di proporzioni delle figure
(rettangolari, triangolari o a trapezio, generalmente ri-cavate da poligoni regolari o da terne pitagoriche), mes-se in opera dall’architettura, impone il ricorso a calcoli semplici, ma non banali, con algoritmi che implicano la soluzione di equazioni di secondo grado e l’estrazione di radici di numeri non quadrati.
A quali raffinatezze di calcolo gli architetti fiorentini seppero giungere, trasferendo l’eleganza intellettuale del loro pensiero geometrico nell’eleganza delle membrature delle loro fabbriche, è stato già messo in evidenza (Barto-li 2007 e 2009). Nelle vestigia del primo gotico fiorenti-no della chiesa di Ognissanti andremo ora in cerca delle premesse di questo particolare carattere dell’architettura, le prime esperienze in cui il metodo seppe dar prova di efficienza e proporre i primi modelli di riferimento.
La successiva chiesa “manierista”, quella che noi oggi vediamo, testimonia, col suo rifacimento rispet-toso delle vecchie mura e delle vecchie misure, la con-sapevolezza del ruolo svolto dal monumento nella sto-ria urbana. Il modo particolare di trasformare in sala accogliente la severa aula medievale, con il ricorso al repertorio degli elementi e delle figure in uso al tem-po, presenta alcune sorprendenti anomalie che fanno dell’interno un evento “fuori dal coro”. Tale è la qualità del lavoro però che nessun dubbio sorge sulla presenza di un metodo in questo apparente difetto di regola. Di tale metodo siamo andati in cerca.15. Giotto, Leoni, Cappella degli Scrovegni, Padova
16. Leone di una delle formelle interne della porta nord del battistero, periodo gotico. In rosso il profilo delle mura fiorentine
— 32 —
Maria Teresa Bartoli
1 La piana di Firenze, nel passaggio dal corso regolare del fiu-me al suo esondare nell’alluvione, offre un’immagine molto vicina a quella proposta da Dante, anche se di valenza contraria. I gradoni dell’anfiteatro dantesco sono collegati da scale presidiate da perso-naggi dell’antico testamento e da Santi scelti tra i fondatori degli ordini religiosi.
2 Vedi l’affresco sulla volta della sala del Palazzo dei Giudici e Notai in via del Proconsolo, degli anni 60 del sec. XIV, che descri-ve l’organizzazione degli istituti di governo della città di Firenze, attraverso i loro emblemi all’interno di uno schema circolare.
3 Vedi (Arrighi 1964, ragione 130). In questo paragrafo si tratta di come si può dividere il raggio di un cerchio per ottenere un cerchio di area ridotta alla metà, a un terzo, a un quarto ecc.
4 (Erodoto 2000, II, p. 109). In una conferenza tenuta nell’Aula Magna dell’Università di Firenze, nel 1992, Michel Ser-res dedicò a questo passo un prezioso e luminoso commento, che evidenziava l’istanza etico-sociale insieme a quella metrica nella nascita della geometria: «prima della proporzione la partizione non ha accesso né all’esattezza né alla giustizia».
5 Vedi (Sznura 1975, pp. 78-84); sulla vicenda dell’ordine de-gli Umiliati a Firenze, vedi (Benvenuti 2006, pp. 41-52).
6 Lo staioro è nel medioevo il modulo di riferimento per la vendita dei terreni. Esso a Firenze è legato al sistema metrico del braccio da panno, lungo cm 58,36, il cui multiplo superiore, in agrimensura, è la canna di 5 braccia, lunga m 2.918,. L’estensione dello staioro nei documenti scritti considerati autorevoli è con-troversa. Gino Arrighi, storico della matematica, tra i maggiori conoscitori dei testi toscani del periodo gotico, ipotizza lo staioro come equivalente a 1600 braccia quadre. Le fonti di questa notizia sono però in trattati di matematica della seconda metà del XV secolo. La definizione scientifica dello staioro in epoca gotica è offerta da Leonardo Fibonacci, nella sua Practica geometriae (primi decenni del XIII secolo), nella quale lo indica pari a 66 pertiche quadrate, in riferimento alla pertica pisana di 6 piedi (un piede pisano poco più di cm 48). Se a Firenze i matematici eredi del Pisano adoperarono lo stesso criterio (staioro = 1/6 del quadrato di 20 pertiche di lato = 400/6 = 66,666, di cui 66 è l’intero), essendo la pertica agrimensoria a Firenze lunga 5 braccia (= 6 piedi pisani, = cm 58,36 x 5 = m 2.918), lo staioro era 66 x 25
braccia quadre = 1650 braccia quadre. Alla fine del Quattrocento, il matematico Luca Pacioli attribuirà un altro valore allo staioro di Firenze (1541 braccia quadre), dedotto con calcoli dallo staioro del braccio a terra (1728 braccia quadre da terra, braccio da terra = 17/18 del braccio da panno), e si rammaricherà che non venga adottato al suo posto il valore di 1600 braccia quadre da panno, che sarebbe più conveniente nel calcolo. Il valore 1728 è la terza potenza del 12; dodici rettangoli di 48 x 36 fanno l’area di un qua-drato di 144 x 144 e questa è l’origine matematica dello staioro di 1728 braccia da terra, relativo ad un sistema arcaico di numera-zione in base 12, difforme per questo dal criterio di misurazione introdotto da Fibonacci, che, pur partendo dalla pertica di 6 piedi, fa lo staioro uguale a 66 pertiche quadrate, ottenute da numeri in base 10. Luca Pacioli auspica che Firenze assuma il valore di 1600 braccia quadre per lo staioro, e questo suo auspicio è condiviso da altri matematici rinascimentali, ma non indica un dato normativo, bensì un ragionamento scientifico.
7 Il chiostro attuale è posteriore, ma sostituisce un chiostro go-tico di cui esistono ancora le due campate sulle quali era appoggiata la cappella con cui termina il braccio occidentale del transetto. Esse dimostrano che il chiostro gotico era orientato come l’attuale.
8 Forma adatta al calcolo significa che la superficie e la figura planimetrica sono adatte a essere scompartite in campi definiti da numeri facili da moltiplicare e da dividere, secondo le abilità di calcolo sviluppate in quel tempo.
9 Il termine “giustizia” ha un significato sociale esteso: le rego-le di Paolo dell’Abbaco, che riguardano l’applicazione del calcolo di radici nella divisione in parti uguali di una ruota di pietra da finire, dimostrano che la matematica è considerata strumento di giustizia per ripartire il lavoro, e successivamente il compenso, tra più operatori, e che questo è il senso largo della giustizia che si vuole mettere in atto.
10 Vedi sul computo elementare in età gotica (Arrighi 1966, pp. 29-30). Moltiplicazioni e divisioni per le potenze del 10 e i loro multipli secondo numeri interi sono introdotte come esempi di computo speditivo. L’enfasi posta in questo tipo di calcolo è in evi-dente relazione con l’ingresso della base dieci nel sistema numerale, della nuova grafia per i numeri e l’introduzione dello zero.
Note
— 33 —
L’istituzione dell’Ordine degli Umilia-ti, fondatore del convento fiorentino di Ognissanti, fu concessa nel 1201 da papa
Innocenzo III, e corrispondeva alla volontà di ripor-tare nell’alveo dell’ortodossia uno dei numerosi mo-vimenti nati, alla fine del sec. XII, dall’aspirazione ad una vita dedita alla perfezione evangelica, alla povertà e all’umiltà, e pericolosamente avviati verso l’eresia. Gli Umiliati di Firenze, lasciata la prima sede presso San Donato in polverosa, edificarono il nuovo conven-to in prossimità della città, vicino al fiume, nel decen-nio1250-1260, al tempo del primo popolo 1 (Tav. I). Impegnati a vivere del loro lavoro e non di elemosine, affidarono il loro prestigio al credito acquisito presso il governo cittadino, che attribuì loro compiti rile-vanti nell’amministrazione economica della repubbli-ca. Essi si conservarono nella prima chiesa costruita, limitandosi a modesti ampliamenti, senza ambizioni monumentali.
La chiesa gotica, a tau con una sola navata, breve transetto e campanile, era preceduta dalla stessa piazza
che ancora oggi vediamo, una delle prime realizzate a Firenze come piazza di convento, in questo caso con-nessa con l’attività più caratteristica dell’ordine (la co-loritura e la tiratura delle lane), che necessitava della vicinanza e del libero accesso al fiume 2 (Figg. 17, 18).
Gli Umiliati, decaduti dal prestigio originario, fu-rono costretti, per decisione del Granduca Cosimo, ad abbandonare il convento nel 1561, sostituiti dai Minori Osservanti, provenienti da San Salvatore al Monte, che ne avviarono la ristrutturazione. Da tale anno iniziò l’adeguamento al nuovo stile, al quale si sottrasse soltanto il campanile, rimasto quale era stato ultimato nel 1258.
Attraverso un lungo lavoro di trasformazione, le cui tappe si avvicendarono fino ai primi del XIX secolo, la semplice aula medievale (abbellita da arredi artistici di alta qualità) fu trasformata in una ornata sala barocca, accogliente, rasserenante, ricca di episodi decorativi di cultura artistica sapiente (Tav. III).
La trasformazione della navata gotica iniziò con l’abbattimento del tramezzo che delimitava il coro dei
La chiesa tra Gotico e Maniera
17. L’importanza dell’arte della lana nella vita sociale fiorentina è manifestata anche dalla formella di Andrea Pisano, Lanificium, nel campanile di Giotto
18. Giotto, Annunciazione a Sant’Anna, Cappella degli Scrovegni, Padova. Il carattere di normale intimità della scena conferma il ruolo sociale della lavorazione della lana, che l’ancella compie sotto la tettoia
— 34 —
Maria Teresa Bartoli
monaci (1565) e l’erezione di 10 edicole (5 per lato), sorta di cappelle “schiacciate”, costituite da un arco profondo a tutto sesto, sorretto da colonne dell’or-dine composito, che accoglie un altare (Tavv. IV, V). Tra le edicole, tutte quasi identiche di misure e dise-gno (come anche gli altari, con i sovrastanti riquadri), larghe lesene di ordine dorico salgono a sostenere una trabeazione con fregio di triglifi e metope, la cui cornice, fortemente aggettante, diventa uno stretto ballatoio, in aggetto lungo i tre lati della navata, che dà accesso anche alle finestre, poste in corrisponden-za degli altari, anch’esse separate da lesene di ordine ionico. Le precedenti monofore gotiche, riconoscibili in alcune tracce della muratura delle pareti esterne, erano state chiuse. Questi lavori furono compiuti en-tro il 1627. Nel 1637 fu terminata la nuova facciata, su progetto del Nigetti. Essa era in pietraforte, ma-teriale non adatto alla piena esposizione a Sud, alla quale è soggetta. Il suo degrado fu risolto alla fine dell’Ottocento con il totale rifacimento in traverti-
no, ma conservando sostanzialmente inalterato il di-segno, tranne poche modifiche (l’attuale nicchia al centro sostituisce una finestra con timpano spezzato) (Tavv. XI, XII).
La trasformazione della navata della chiesa fu com-pletata con la quadratura che ricopre tutta la navata centrale, dalla facciata interna fino all’arco che intro-duce la cappella dell’altare maggiore (ultimata, tra il 1769 e i primi anni della decade successiva, da Giusep-pe Benucci per la prospettiva d’architettura e Giuseppe Romei per lo sfondato e le figure (Tav. XV).
Il braccio orientale del transetto, di figure baroc-che, fu realizzato occupando parte dell’antico cimitero (Cappella di San Pietro d’Alcantara, Tav. X) e trasfor-mando una precedente cappella della fine del secolo XIV, già dedicata, come l’attuale, al Santissimo nome di Gesù. Quello occidentale ha conservato in gran parte le forme tardo gotiche, che traggono indubbia ispira-zione da quelle del transetto di Santa Maria Novella (Tavv. V, VI).
19. L’interno della chiesa, stato attuale (foto di Elena Fossi)
— 35 —
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze
La chiesa gotica: la nuova scienza nel disegno dell’architet-tura conventuale
Nella volumetria complessiva della chiesa domina il grande rettangolo coperto dal tetto a due falde, co-stituito dalla navata e dalla parte centrale dell’incro-cio col transetto, ben riconoscibile nella vista dall’al-to Fig. 19. Tutte le altre parti della chiesa (cappella maggiore, coro, transetto oltre il corpo principale) hanno coperture differenziate e più basse, con varie altimetrie. Le strutture gotiche sono riconoscibili nella chiesa attuale (incluso il campanile), se si im-magina di togliere il coro dei monaci dietro l’altar maggiore, la parete finale della cappella di quest’ul-timo e l’estensione del braccio destro del transetto nell’ultima campata, con le relative cappelle, aggiun-te con interventi rinascimentali, manieristi e barocchi sull’antico oratorio degli Umiliati 3 (Fig. 20).
La pianta risultante non è del tutto regolare: il braccio occidentale del transetto, con le sue appendici della sacrestia a Nord e l’ufficio parrocchiale a Sud, si
adatta alla direzione del chiostro, anomala, come abbia-mo già visto, rispetto ai fili della chiesa. La cappella che conclude la testa del braccio occidentale del transetto,
della fine del Trecento, situata al piano rialzato sopra le volte del cortile gotico (le relative campate sono le uni-che conservate inalterate nelle modifiche rinascimen-tali), accoglie pienamente le direzioni di quest’ultimo.
Il grande rettangolo della navata, allungato nell’in-crocio col transetto dagli arconi che ne proseguono le pareti divergendo lievemente verso l’esterno, appare, nel rilievo, composto da un rettangolo (la navata) più un trapezio isoscele (per la divergenza degli arconi verso l’altare, la larghezza passa, negli ultimi 6 metri dell’in-crocio, da m 14 a m 14.24). Questi fatti obbligano a pensare a fasi diverse di realizzazione di un progetto, che viene anche nel tempo modificato, per adattarlo a situazioni in evoluzione (la forte deformazione del brac-cio sinistro del transetto è conseguenza della necessità di avvicinarlo con gradualità al cortile). Dal rilievo pos-siamo dedurre ancora altre informazioni: la lunghezza della navata, prima dell’incrocio col muro del transet-to, escluso questo muro, misura 62 braccia, compreso il muro di facciata. La larghezza della chiesa, mura laterali
comprese, è di 26,6 braccia (l’interno è di 24 braccia esatte); la superficie coperta dalla navata, sotto il muro del transetto, misurava quindi 1650 (= 26,6 x 62) brq,
20. Fili planimetrici della chiesa gotica 21. Schema dei successivi ampliamenti della pianta gotica
A = 1 staioro 1650 brq
B = 360 brq
C = 270 brq
Dimensionamento dei muri:facciata 24 x 2 = 48+muro posteriore 24 x 1,5 36 = 84
muro laterale272 - 84 = 188 brq188 : 2 = 94 brq94 : 75 = 1,256 br
area degli spessorimurari
2000-1728 = 272
spessori muraridel corpo absidale:
272 - 188 = 84
— 36 —
Maria Teresa Bartoli
ovvero uno staioro 4. La superficie interna misurava 24 x 60 = 1440 brq, numero che dà risalto ai multipli del 12 (uguale a 12x12x10) 5. Questa circostanza suggerisce un’ipotesi: una chiesa di queste misure potrebbe essere stata realizzata come prima fase di un disegno più esteso in lunghezza. L’inizio insolito dalla parte della facciata potrebbe essere da mettere in relazione con il disegno dell’isolato, che dette la direzione della strada realizzata poco dopo. La torre, aggiunta entro il 1258, incorporava il muro orientale, ma con il muro nord indicava l’inten-zione di andare oltre. Il successivo ampliamento, se aves-se conservato la figura rettangolare, avrebbe aggiunto al precedente 350 brq, portando la figura alla superficie di 2000 brq, con i lati in proporzione quasi esatta di 1: 2√2 (braccia 26,6: 75,5). Per questo risultato era necessa-ria la soluzione di un’equazione in un’incognita, nota la radice di 2; l’interno di questo maggior rettangolo (di proporzioni 1: 3) avrebbe misurato 24 x 72 = 1728 brq, pari a 12 al cubo. Però la figura aggiunta realizzata è un trapezio, con la base maggiore (davanti al corpo absidale) lunga 24,40 braccia e la minore lunga 24 braccia. L’al-tezza di 13,43 attribuisce al trapezio l’area totale di 358 brq, dando allo spessore murario il valore di 68 brq e al vuoto la misura di 290 brq. La superficie coperta tota-le è divenuta 2002 brq, la superficie interna 1730 brq, la differenza è di 272 brq: le differenze dalla superficie teorica sopra descritta sono minime. Ricordo che, nel-la definizione di Luca Pacioli, lo staioro della tradizione fiorentina antica misurava 1728 braccia quadre da terra (un braccio da terra lungo 17/18 del braccio da panno). Dunque questo numero era significativo come numero di misura di superficie.
Una prima fase della terminazione absidale, ben leggibile nel muro posteriore delle cappelle, era limita-ta alla cappella maggiore (meno profonda dell’attuale, chiusa da un muro all’altezza delle aperture che oggi la collegano con le sacrestie) e alle prime ai suoi fianchi; a sinistra, forse già si avviava il raccordo con la direzione del chiostro. Il perimetro del corpo absidale che abbia-mo disegnato (la cui base misura 28 braccia) chiude la superficie di 272 braccia quadre, uguale quindi a quella impegnata dai muri della navata (Fig. 21).
Dunque, il requisito che ha guidato il progetto go-tico, nelle sue successive fasi, sembra essere stato la preventiva definizione delle superfici delle varie parti
della chiesa, superfici da cui poi sono state dedotte le lunghezze, determinando quindi le misure del perime-tro. Le aree predefinite sono misurate da numeri adatti a rendere facile, quindi più sicuro, il computo, come è desiderabile che sia quando si voglia attribuire cer-tezza e trasparenza alla gestione di imprese pubbliche. Ognissanti non è una grande chiesa, la sua superficie è circa un quarto di quella di Santa Maria Novella: ma forse fu lei a indicare in maniera semplice ed essenziale la strada da intraprendere: un laboratorio di discussio-ne su definizioni scientifiche di pubblica utilità. Santa Maria Novella su quel metodo costruirà un capolavoro.
In elevato, la sezione trasversale dell’edificio, sot-to la catena delle capriate che sostengono il tetto, rag-giungendo l’altezza di m 19,5, è quadrata (26,6 braccia di lato) (Fig. 22). La copertura a capanna giunge fino alle arcate che delimitano le cappelle dell’altare mag-giore e del transetto a fianco di questo. La volumetria di queste parti, più basse della navata, ha regola discon-tinua e frammentaria 6.
Il modo di scompartire che abbiamo descritto, mol-to efficiente nella conduzione della costruzione, creativo nell’idea di ribaltare la sequenza tra forma e superficie
22. Il quadrato nella sezione trasversale
— 37 —
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze
(prima si fissa la misura della superficie, poi si determi-nano le misure lineari della figura geometrica di propor-zioni volute), genera uno spazio piacevole, in cui si sosta con singolare riposo, sentendosi bene accolti. Manca il modulo generatore, spesso caratteristico dell’architettu-ra ben risolta, eppure, in una maniera singolare, Ognis-santi possiede una sua eleganza speciale e gradevole, che nasce proprio dalle meditate proporzioni date da un ma-estro d’abaco gotico. Oggi le rileggiamo attraverso l’in-terpretazione dell’architetto manierista, ma il significato che dette ragione al loro disegno, la ricerca, fiduciosa e attiva, di basi di scienza per un giusto operare, è ancora in qualche modo trasmesso dalla serenità che infondono.
La chiesa riformataL’autore del ridisegno manierista della chiesa, in-
trapreso dai Minori di San Salvatore al Monte a partire dal 1561, non è noto con certezza. Il Richa riferisce l’attribuzione al Caccini da parte del Del Migliore, mettendola però in dubbio, essendo il Caccini morto nel 1612, e la chiesa consacrata nel 1627 (Richa 1755, pp. 251-265). Egli quindi ne suggerisce la paternità del Pettirossi. In realtà, il tabernacolo dell’altare maggio-re di S. Spirito, del Caccini, appare in stretto rapporto con l’arco di ingresso all’altare maggiore di Ognissanti, mentre il tempo di durata dei lavori fu così lungo da far supporre il succedersi di più architetti alla direzione dei lavori. La navata però lascia pensare che, pur sotto guide diverse, i lavori nelle diverse fasi temporali siano stati condotti avendo come riferimento un primo dise-gno di progetto. Soluzioni più autonome si dispiegano nel transetto, nella cappella dell’altar maggiore e nel coro retrostante, tipico delle chiese tardo-barocche.
Una peculiarità del ridisegno della navata è rappresen-tata dalle varie anomalie che si riscontrano nei suoi partiti architettonici. A prima vista, il “disordine” con cui si succe-dono lesene e altari sui prospetti laterali appare stravagan-te e privo di regola, frutto di interventi moderatamente coordinati (vedi in particolare il modo in cui le colonne dei primi altari si attaccano alle prime lesene, verso l’en-trata). Un’attenta lettura può mettere però in evidenza un’ideazione articolata con logica dotata di ordine, anche se non facile da leggere nelle contraddizioni della realiz-zazione, apparentemente frammentaria, anche se unitaria nelle figure e nelle misure degli elementi.
La parete è ritmata da due ordini di lesene, di cui quello inferiore, dorico, è sovrastato da un’alta trabe-azione con fregio di triglifi e metope, conclusa da un aggettante cornicione “praticabile”; l’ordine superiore, ionico, sostiene la cornice che riquadra il soffitto piano, decorato da uno sfondato architettonico dipinto, esteso in figura continua dall’ingresso all’altare.
L’ideazione di questo interno presenta chiari rife-rimenti ai suoi modelli. I frati dell’Ordine dei Minori che ne condussero la trasformazione venivano dal con-vento di San Salvatore al Monte, la cui chiesa era stata realizzata dal Cronaca (su probabile progetto di Giulia-no da Sangallo) alla fine del secolo XV (Fig. 23). San Salvatore presenta un’unica navata, fiancheggiata sui due lati da una sequenza di 8 arcate, di cui le prime cin-que (dall’ingresso) introducono in altrettante cappelle, mentre le ottave si aprono su una sorta di transetto. Sulle pareti della navata, lunga 64 (=8 x 8), larga 24 (=8 x 3) braccia, le 8 regolarissime arcate sono inter-vallate da alte lesene (interasse di 8 braccia), che reg-gono un aggettante cornicione-ballatoio che dà accesso alle finestre con timpano (alternatamente triangolare e circolare) (Fig. 24). Questo modello definisce un dise-gno di interno che fu assunto come paradigmatico dalla Controriforma e vediamo replicato con voluta inten-zione in Ognissanti 7.
La quadratura sul soffitto piano indica senza pos-sibile dubbio l’altro modello: la chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi in Borgo Pinti, di origine gotica (1257), riordinata da Giuliano da Sangallo per i Cister-censi, nelle prime decadi del sec. XVI, con un disegno (navata unica affiancata da cappelle) non dissimile da quello di San Salvatore. Lo straordinario soffitto pia-no fu affrescato dal Chiavistelli con una quadratura di architettura, intorno agli anni Settanta del XVII seco-lo, quando vi furono portate le spoglie di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi (Fossi 2006). Il soffitto di Ognis-santi, circa cento anni dopo, trasse ispirazione da quel-lo di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi (Fig 25).
La navata della chiesa di Borgo Pinti è costituita da un rettangolo largo 20 braccia, lungo 65. Sulle due pa-reti laterali il tema architettonico presenta il succedersi di cinque arcate su lesene, aperte su altrettante cappelle, poi un tratto di muro pieno, su cui si apre una porta, se-guito da una ulteriore arcata, simile alle precedenti, che
— 38 —
Maria Teresa Bartoli
introduce in una sorta di cappella–transetto (Fig 26). Le prime 5 cappelle impegnano col loro prospetto 50 delle 65 braccia, in maniera uniforme (ogni cappella impegna 10 braccia del prospetto del fianco); le residue 15 braccia sono ripartite tra il tratto di muro e l’arcata della cappel-la finale, in misura prossima a 5 + 10 braccia 8.
I prospetti interni delle pareti laterali di Ognissan-ti, messi a confronto con quelli delle due chiese, mo-strano in modo evidente il rapporto di discendenza dai progetti del Sangallo; in particolare, la sequenza sulle pareti, costituita dal tema di 5 arcate – superficie con-tinua – arcata conclusiva, è comune a S. Maria Madda-lena e alla nostra (dove l’ultima diventa l’arcone che scavalca il transetto). Le arcate sorrette da colonne di Ognissanti, che accolgono gli altari, alludono alle cap-pelle delle chiese precedenti, senza però realizzarle 9. Come in S. Salvatore, tra le cappelle alte lesene sosten-gono il cornicione-ballatoio, che dà accesso alle fine-stre timpanate, collocate sopra gli altari, proseguendo poi, mutato l’ordine, verso il soffitto.
Le pareti dell’attico presentano, nelle porzioni di muro ai lati delle finestre, una originale decorazione, con medaglioni dalle cornici in stucco (1687) in cui sono rappresentati i busti di Santi e Sante francesca-ni. Ne deriva l’immagine dell’interno come “galleria dei ritratti degli antenati” (quasi sala di palazzo avito), messa in risalto dalla Gloria dei Santi Francesco e Bay-lon, (come l’eroe romano e l’avo più recente dei trionfi
affrescati dei palazzi nobiliari), rappresentata sulla qua-dratura del soffitto (1769-79).
Nella soluzione architettonica di Ognissanti, a dif-ferenza di quanto avviene nei modelli, la sequenza delle 5 cappelle non si svolge in maniera regolare (Tavv. IV, V), e non c’è piena specularità tra le due pareti: I due prospetti interni non sono identici, e presentano delle differenze, sia pur lievi, il cui esame può gettare luce sui criteri di disegno assunti dall’architetto.
Entrambi sono articolati in tre campi di due campate ciascuno: dalla parete d’ingresso della chiesa, un primo campo comprende i primi due altari, delimitati da due lesene integre, mentre la lesena interposta, presente nell’attico, è rappresentata nell’ordine inferiore dal solo capitello-cherubino; il secondo campo, leggermente più lungo, è costituito dagli stessi elementi, due altari tra lesene, con capitello-cherubino interposto; il terzo campo, minore, è occupato dal quinto altare, tra due lesene (sovrastato, a ovest, dall’organo), e da un tratto di parete continua, fino alla lesena con cui terminale la navata. Nella porzione superiore di questo ultimo tratto è collocato un grande disco (orologio a est, disco solare a ovest). Sulle due pareti i tre campi, di misure diverse tra loro, non sono esattamente speculari, ma rivelano lievi differenze sia di figure che di misure, che non intac-cano la somiglianza, ma producono però conseguenze. Nell’insieme, la serie di differenze, di per sé non imme-diatamente evidente, è resa non dissimulabile dal partito
23. San Salvatore al Monte, interno
24. Elaborazione su disegno tratto da L. Bartoli, “L’unità di misura e il modulo proporzionale nel Rinascimento”, in Quaderno numero 6 dell’Ist. di Elementi di Arch e Rilievo dei Monumenti, Genova 1971
I Minori Osservanti di San Salvatore al Monte si trasferirono in Ognissanti nel 1561, per le cattive condizioni del loro convento. La loro chiesa era stata costruita tra il 1499 e il 1504 dal Cronaca, su progetto di Giuliano da Sangallo.
— 39 —
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze
di stucchi e ritratti dipinti entro tondi dell’attico, che, anzi, le sottolineano con enfasi, trasformando il modello circolare di base delle cornici in ellissi con asse maggiore ora verticale, ora orizzontale 10.
Una attenta riflessione sulla pianta e l’elevato del-la navata, restituiti con minuzioso rilievo, ha permesso di rendere esplicito il percorso logico che, a partire dai modelli sopra descritti (S. Salvatore e S. Maria Maddale-na de’ Pazzi), definisce la regola degli interassi di altari e lesene, sulle due pareti. Nel vano rettangolare di 72 x 24 braccia (rapporto 3:1), da articolare in una sequenza ordinata di 5 elementi del tipo “cappella”, il tratto gotico di parete continua è lungo poco meno di 61,5 braccia. Su questo tratto devono essere organizzate le 5 campate de-gli altari-cappella e il tratto pieno di lunghezza inferiore. Il vuoto del transetto è dato dalle restanti 10,5 braccia
circa. Il disegno richiede che si individui un modulo che possa esprimere sia la lunghezza totale di 72, sia la lun-ghezza parziale prossima a (e minore di) 61,5, attraver-so numeri interi e non troppo grandi, adatti a generare un’articolazione simile a quella delle chiese modello.
Tale ricerca individua come soluzione 72/20, = 3,6; 3,6 x 17 = 61,20, < 61,5 11. Essa può offrire il co-mune divisore di 72 br e di 61,2 br, come elemento di riferimento della articolazione della parete (Fig. 27).
Il disegno mostra come il modulo costruisca i 5 campi degli altari, di 3 moduli ciascuno (10,8 braccia), con gli altari collocati sull’asse di ogni campo (lunghez-za totale 54 braccia); 7,2 braccia (2 moduli) sono la-sciate al tratto pieno prima del transetto. A sua volta il transetto misura anch’esso 3 moduli (Fig. 28). Il ritmo è quasi identico a quello di S. Maria Maddalena.
25. Quadratura sul soffitto di Santa maria Maddalena de’ Pazzi, Iacopo Chiavistelli, 1669
26. S. Maria Maddalena de’ Pazzi, ridisegno di Giuliano da Sangallo, entro il 1516 (rilievi messi a disposizione da E. Mandelli e A. Merlo, vedi nota 8)
Antonio da Sangallo, rifacimento di Santa Maria Maddalena in Borgo Pinti
una maglia di 10 x 10 braccia evidenzia le proporzioni dell’interno larghezza 20, lunghezza 65, altezza 20
— 40 —
Maria Teresa Bartoli
Queste misure definiscono le scansioni delle diverse parti. Però entro le 54 braccia il tema chiede che siano composte 6 lesene + 5 intervalli tra di esse, e, forse non prevista fin dall’inizio, la quantità da dedicare all’aggetto del tema delle lesene con la loro base (1/4 di braccio) dal muro della controfacciata. La scelta dell’architetto, ben chiara sul prospetto orientale, è stata quella di collocare gli altari nel centro dei rispettivi campi (tranne il primo vicino alla controfacciata), con le lesene (o i cherubini che le sostituiscono) a cavallo dei fili dei moduli, tranne la pri-ma e l’ultima. Nel primo campo, la lesena e l’altare sono spinti in avanti dall’ordine della controfacciata (1/4 di braccio è la profondità della base della lesena; quasi 1/3 l’aggetto laterale della lesena dalla base); nel quinto cam-po si intravede che l’interasse è diminuito dalla necessità di tenere tutta la lesena entro il filo delle 54 braccia; anzi, sul fianco est, anche la base della lesena è tenuta entro le 54 braccia, probabilmente per porre la lesena in corri-spondenza del muro sud del campanile. Quindi, il filo ul-timo del tema delle 5 campate è spostato indietro di circa 1/2 braccio rispetto alla ripartizione descritta (Fig. 29).
Prima di descrivere la parete ovest, è opportuno analizzare il tema architettonico della controfacciata. Il soffitto dipinto, a 26,6 braccia da terra (misura ugua-le alla larghezza della navata), definisce la proporzione quadrata della sezione trasversale (Fig. 30). La porta, al centro tra due lesene, è fiancheggiata da due campi deli-mitati ancora da lesene, che inquadrano due specchiatu-re a tabernacolo. La larghezza interna di 24 braccia è or-ganizzata da una griglia (basata su un modulo m di 11/8 di braccio = cm 80,2, corrispondente alla larghezza di tutte le lesene) di 17 m, di cui 7 m sono dati al campo tra le lesene centrali che inquadrano la porta, e 5 per i campi laterali (definendo con numeri interi uno sche-ma ottagonale, i cui lati inclinati organizzano le finestre della parte alta) 12. Il disegno mostra come il quadrato centrale di lato 5 m (dentro quello di lato 7m) scandisce la sequenza dei livelli di cornicione, capitello, architrave delle cornici dei riquadri. Il limite del tema della facciata interna, entro i basamenti delle lesene delle pareti late-rali, sporgenti ½ braccio dal muro, misura 23 (= 24 – 1) braccia esatte.
Si può supporre che questo modo di comporre sia parso felice all’architetto che affrontò la parete ovest. Egli vi introdusse una variante, rispetto alla parete di
fronte, significativa anche se non rilevabile a vista e ri-conoscibile solo attraverso le misure (Fig. 31). Potendo egli mantenere fede alle 54 braccia di lunghezza totale del tratto delle 5 “cappelle”, decide però di allargare i due campi “centrali” del prospetto, a cavallo del secondo cherubino (centro percettivo della sequenza completa), che vengono dimensionati sulla base del modulo. Se gli interassi tra le lesene delle due campate sono esatta-mente 8m (8 x 11/8braccia = 11 braccia esatte, pari quindi all’altezza dell’ordine), la sequenza complessiva lesena-vuoto-lesena-vuoto-lesena misura 1-7-1-7-1 = 17m, uguale al lato del quadrato messo in evidenza nella controfacciata (Fig. 32). Questa scelta altera, sia pure di poco, le misure di tutti i campi successivi al primo. Resta ferma solo la posizione del secondo cherubino, perno e centro emotivo dell’articolazione. L’ultima delle 5 campate (quella dell’organo), già spinta in avanti dalle 11 braccia della precedente, è inoltre di poco maggiore rispetto al modulo M, per la particolare complessità del suo disegno, e le 54 braccia risultano quindi lievemente superate. Dunque la penultima lesena della serie avanza sul fianco ovest, mentre retrocede sul fianco est.
Se questa interpretazione dà conto di regole e in-frazioni, scelte con libertà e insieme necessità, dall’ar-chitetto del Seicento, quello che più interessa è leggere i modelli di pensiero che hanno guidato tali scelte. Ri-spetto a S. Maria Maddalena de’ Pazzi, Ognissanti replica la sequenza di 5 archi d’ingresso a cappelle, tratto con-tinuo, arco di transetto. La sequenza (5x10)+10/2+10 è implementata in (5x10,8)+(10,8x2/3)+10,8. All’interno dei campi però non vediamo sempre la stessa cosa, ma il primo e l’ultimo della sequenza subi-scono delle variazioni, rispetto al caso tipo, dovute alla loro posizione agli estremi (il problema dell’angolo nel tempio dorico). Mentre le lesene sono in generale ap-poggiate sui fili che individuano le campate, la prima e l’ultima risultano completamente interne al loro cam-po; inoltre, nel caso del campo contiguo alla controfac-ciata, la lesena estrema deve anche lasciare lo spazio per le lesene di quest’ultima. Questo riduce ulteriormente l’interasse tra le lesene. Sulla parete ovest, il proget-tista sovrappone al tema descritto un altro tema, che proporziona in maniera più compiuta le due campate intorno al cherubino centrale. Questo fatto scardina la regola, sia pure in maniera discreta, (appena segnala-
— 41 —
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze
27. Schema di divisione dell’interno
28. I moduli di 10,8 braccia nella parete orientale
— 42 —
Maria Teresa Bartoli
29. I moduli di 11/8 di braccio nel disegno della controfacciata
30. I moduli di 11/8 sovrapposti ai moduli di 10,8 braccia nella parete occidentale
— 43 —
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze
ta dalla decorazione a tondi dell’attico), allungando il tema di circa un quarto di braccio. Questa particolare composizione assegna alle due campate binate il ruolo di zona centrale della navata, e il cherubino che le sepa-ra viene a segnalare un punto speciale. Il quadraturista Benucci, nel secolo successivo, farà passare per esso il piano verticale di simmetria del finto loggiato affaccia-to sull’interno della chiesa, al di sopra della cornice dell’attico.
Con grande abilità l’architetto della maniera assorbe le misure gotiche, assume il modello rinascimentale e rielabora un’ immagine originale di armonia, ordinan-do le membrature in maniera nuova, non più statica, ma dinamica, in cui le lesene si muovono come i personaggi di una coreografia, avanzando o retrocedendo rispetto alle posizioni canoniche, per adattarsi a vincoli specifici.
Per questo modo di ordinare possono valere le pa-role che mutuiamo da altro scritto:
«[…] l’ordo implica sì sempre una complessità, ma ri-condotta armonicamente ad unità, giacché l’ordo non è mai una somma slegata di tante unità insulari, ma un reticolato di rapporti, un tessuto relazionale dove contano assai più le connessioni colleganti che non i singoli punti collegati».
Così Paolo Grossi (2008, pp. 6-7) descrive la con-cezione del diritto nella civiltà medievale, come un «sustrato latente» che dà unità al «pluralismo giuridi-co» che caratterizza il Medioevo. Quelle stesse parole
paiono cogliere con sintesi efficace anche i caratte-ri dell’architettura che abbiamo descritto, in cui la rete che tiene insieme la struttura complessiva nelle sue variazioni temporali è costruita con trame che mutano, ma conservando, con minimi scostamenti, alcune relazioni fondamentali. Nel confronto tra le parole autorevoli dello storico del diritto e gli acca-dimenti rivelati dal rilievo di Ognissanti leggiamo il filo conduttore che unisce saperi diversi di una cul-tura storica cui vengono riconosciuti esiti di speciale felicità, e dietro queste intravediamo la dimensione profonda da cui quella felicità ha origine: la fiducia che quell’ordine non è frutto di una libera e mutabile scelta dell’uomo, ma è essenziale, insito nella stessa natura dell’uomo e attingibile con la ragione.
L’equilibrio problematico degli ordini disegnati sui fianchi della chiesa apre però una discussione sulle atti-tudini dell’ordo a risolvere in unità ogni tessuto relazio-nale. Essa è portata avanti dal quadraturista che illustra la straordinaria cornice architettonica del Trionfo dedicato a S. Francesco sul soffitto della chiesa. Nel suo lavoro affiora un relativismo che comincia a mettere in dubbio l’assoluta certezza delle regole definite dalla tradizione.
Oltre la Maniera: la quadraturaNel decennio a partire dal 1768, il tetto a due fal-
de, sostenute da grandi capriate, fino ad allora in vista sulla navata, venne coperto da un unico grande soffitto piano, costituito da una stuoia di canniccio intonaca-
31 Dettaglio delle campate centrali della parete ovest
— 44 —
Maria Teresa Bartoli
ta, retta da una orditura di travi e correnti appesa alle catene delle capriate. Su di essa fu dipinta dal Benucci una prospettiva d’architettura, di metri 41 per 13 circa (Tav. XV).
Nella parte della scena che precede il transetto, un loggiato a colonne si affaccia sulla chiesa, come questa fosse una corte a cielo aperto. Nella zona centrale, cor-rispondente alle campate binate maggiori dei prospetti laterali, la loggia arretra, allargando l’area della corte e la porzione di cielo visibile, nella quale si svolge il trionfo dei Santi Francesco e Baylon. In entrambe le testate dei lati corti, un portale monumentale, sovra-stato da un timpano con frontone curvilineo spezzato, sorretto da colonne, si affaccia sulla chiesa, lasciando intravedere l’interno delle campate del loggiato retro-stante. Il disegno d’architettura ha un’asse di simmetria speculare, il cui piano verticale passa per i cherubini che interrompono le lesene delle campate binate cen-trali. Su tale asse, secondo la regola, sta il punto princi-pale. Sul transetto, conclude lo spazio a disposizione un cassettonato piano, che porta al centro un medaglione che spiega il tema del dipinto.
La grande scenografia dipinta, che simula il loggia-to affacciato sull’interno, di metri 37 x 12 circa, co-stituisce un’impresa pittorica monumentale, una con-cezione imponente non facile da definire come idea, né da realizzare. Il limite architettonico tra il vuoto dello sfondato e il finto costruito è rappresentato da un loggiato architravato sorretto da colonne, i cui sti-lobati sono collocati su grandi mensole, poste in corri-spondenza delle lesene delle pareti. Le colonne accom-
pagnano il movimento del loggiato, che sporge verso l’interno della chiesa sui lati corti, se ne ritrae nella zona centrale dei lati lunghi. Tra gli stilobati, balaustre fungono da parapetto. Il movimento degli stilobati e degli architravi, assai complesso, rende difficile seguire in maniera compiuta il disegno dell’architettura, mani-festando alle cantonate alcune incongruenze composi-tive, che non compromettono comunque la plausibilità visiva dell’immagine dipinta.
Nella Fig. 32 sono rappresentati in sequenza i ret-tangoli simili disegnati ai diversi livelli di profondità. La proporzione tra lato lungo e lato corto è di 2,86:1 (molto vicina alla proporzione 1:2√2 della navata; la proporzione complessiva della scena, includendo nella lunghezza anche le travi trasversali da cui nascono le mensole dei lati corti, è di 3:1). Gli spigoli di profondi-tà ai diversi piani del loggiato, che concorrono nel cen-tro del rettangolo, punto di fuga delle rette verticali, sono tutti appoggiati sulle diagonali del rettangolo, pur appartenendo a elementi dell’ordine architettonico non sempre appartenenti esattamente allo stesso piano verticale; e questo rivela la qualità prospettica del di-pinto, fortemente allusiva in alcuni dettagli, moderata-mente rigorosa nell’applicazione della regola.
Eppure questa prospettiva era stata preceduta da uno studio preparatorio impegnato anche sotto il profilo della geometria: il bozzetto, conservato alla National Gallery of Art (Washington), disegnato forse per mettere a confronto possibili alternative, è do-cumento pregevole sia per la qualità grafica che per le singolari caratteristiche del contenuto, che entro il
32. Progressione di rettangoli di ugual forma nella quadratura
— 45 —
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze
rettangolo della chiesa presenta quattro diverse solu-zioni, nei quattro quadranti in cui esso è diviso (Tav. XIV). Nel saggio di Nevena Radojevic, che ha rintrac-ciato e studiato il bozzetto, esso è discusso in maniera puntuale. Qui si vogliono condurre alcune osserva-zioni che meglio illuminano i requisiti della quadratu-ra, indicando le differenze tra i due svolgimenti. Nel disegno, il rettangolo complessivo della prospettiva entro la cornice misura 72 x 21 braccia. Al suo inter-no, nelle quattro soluzioni, il rettangolo del vuoto del cortile virtuale è diversamente proporzionato: nelle due soluzioni della metà superiore il vuoto ha pro-porzioni 60 a 20, lasciando al soffitto cassettonato il rettangolo di 12 x 20; nelle due soluzioni della metà inferiore il vuoto misura 20 x 66, e il cassettonato 20 x 6. Queste seconde soluzioni sono scartate. Nelle prime due, la differenza è solo nel fatto che a destra, nella metà che viene dall’altare, il loggiato è continuo in tutta la sua lunghezza, mentre a sinistra, nella metà che viene dall’entrata, è disegnato l’arretramento della loggia nella parte centrale. Questa è la soluzione prescelta, anche se poi alcuni dettagli vengono presi dalle altre: l’angolo retto, dissimulato dal quarto di circonferenza, che ritroviamo nel dipinto, è presente solo nella metà inferiore del bozzetto. I dubbi sulla congruenza dei diversi piani della scatola prospettica non sono pienamente risolti dal bozzetto (ma la ra-pidità dello scorcio e, nel grafico su carta come nel dipinto su canniccio, le deformazioni del supporto, rendono difficile una valutazione esatta): comunque, nel grafico cartaceo la regola base del concorso di tut-
te le verticali in un unico punto (il punto principale della prospettiva) è rispettata, anche se nelle coppie di soluzioni è diversa la posizione dell’asse trasversale che lo contiene, rispetto all’interno della chiesa.
Sull’affresco invece vediamo succedere cose di-verse, e tali da suscitare interrogativi sulle intenzioni dell’ideatore (Fig. 33). Infatti, mentre gli spigoli del-la scatola rettangolare prospettica e le colonne ad essi prossime concorrono tutte nello stesso punto di fuga, posto sul centro dell’asse di simmetria della prospet-tiva, invece, nella parte centrale, le coppie di colon-ne degli angoli del “quadrato” che allarga l’estensione visibile di cielo hanno un diverso punto di concorso, sempre sull’asse di simmetria, ma più lontano del centro, spostato verso la parete opposta; e le due co-lonne che tripartiscono i lati del “quadrato” sopra i cherubini si incontrano ancora più lontano, ovvero più vicino alla parete opposta. L’asse trasversale, lun-go 24 braccia (m 14) è quindi diviso dalla sequenza dei punti di fuga in 6 parti uguali di 4 braccia ciascuna (m 2,33) (Fig. 34).
Se quindi dal centro della quadratura andiamo a guardare le colonne della parte centrale, le vediamo di-vergere stranamente verso l’esterno (Fig. 35). Questo espediente, interrompendo la monotonia di una scena prospettica assai lunga, obbliga a uscire dall’asse longitu-dinale e a cercare sull’asse trasversale i nuovi centri visi-vi; propone quindi delle alternative, ma senza interrom-pere l’unità della visione. La scena nella quale si svolge il trionfo, tema focale della scenografia, vuole essere vista con un movimento circolare che gira intorno al centro
33. Direzioni delle colonne sul quadro e convergenze su 5 punti di fuga
— 46 —
Maria Teresa Bartoli
per la completa osservazione, e le incoerenze prospetti-che rispetto alla regola-madre sollecitano l’osservatore al movimento, perché vada a cercare i volti dei perso-naggi che conducono l’azione sui quattro vertici di una sorta di mandorla: la Trinità (il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo), la Vergine, S. Francesco, S. Baylon.
La presenza del punto di fuga intermedio tra i due più lontani, sull’asse trasversale, è probabilmente ne-cessaria, per mediare un passaggio che, se troppo bru-sco, creerebbe disagio visivo in chi osserva il disegno delle colonne d’angolo. La prospettiva è fissa, ma guida il movimento intorno allo spazio dedicato alla trionfale azione scenica di cui è la grandiosa cornice.
Queste considerazioni fanno intravedere la trasfor-mazione profonda che la prospettiva come forma simbolica sta subendo, cercando di sfuggire alla unicità della rap-presentazione frontale per rappresentare la maggiore ricchezza dell’esperienza sensibile. La sua mediazione tra stimolo e sensazione, esaurita con successo l’in-vestigazione sulle proprietà geometriche, si rivolge all’influenza del movimento e del tempo, e cerca nei contenuti della scenografia teatrale i paradigmi utili a svolgere la sua rappresentazione: non la ricerca del vero ideale, ma il verosimile reale; non la fissità della scena in cui l’azione è colta nella sua sostanza di verità assoluta, ma il suo movimento per dare senso all’azio-ne. Il teatro è il paradigma che genera le figure anche dell’architettura. Esso testimonia la consapevolezza che non si può conoscere veramente il mondo esterno, ma solo farne una rappresentazione.
34. Le convergenze delle colonne nella parte centrale
36 Immagine fotografica della scarsa convergenza delle colonne centrali viste dal centro della prospettiva
1 Le notizie storiche sulla chiesa sono desunte da: (Batazzi-Giusti 1992) e da (Richa 1755)
2 vedi (Sznura 1975, p. 81).Vi si legge che nel 1278 i frati presentarono un accurato progetto di urbanizzazione della loro proprietà, che includeva anche la realizzazione della piazza di 100 braccia di terra davanti alla loro chiesa. Batazzi e Giusti menziona-no una delibera del Comune di Firenze, riportata dal Tognocchi, che faceva divieto di costruire, per la misura di 100 braccia in quadro, davanti alla chiesa. La notizia è interessante, perché la su-perficie di 10.000 brq è quella cui fa riferimento il modello dello staioro, che rappresenta, approssimato all’intero più utile per il calcolo, 1/6 di 10.000. La piazza di Ognissanti materializza, dal punto di visto metrico, il modulo da cui nasce il campione di rife-
rimento. Ancora oggi, il trapezio della piazza, al netto dell’attuale lungarno, misura (come trapezio di altezza 90 e semisomma delle basi 110) esattamente 9.900 brq (approssimazione di 10.000), ov-vero 6 staiora di 1650 brq.
3 Queste vicende sono descritte, per quello che è possibile ricostruire, in (Batazzi-Giusti 1992), nei capitoli dedicati alle singole cappelle. La cappella che conclude il braccio orientale del transetto è sul luogo dove stava l’oratorio gotico del convento, esterno alla chiesa.
4 La chiesa attuale è larga 24 braccia esatte (14 metri). Chiamo braccio quadro, per analogia con il metro quadro, la misura di super-ficie di un quadrato di lato pari a 1 braccio = cm 58,36. Non è detto che questa fosse la denominazione antica: Fibonacci definisce pertica
Note
— 47 —
Dal Gotico oltre la Maniera. Gli architetti di Ognissanti a Firenze
superficiale un quadrato di (6 x 6) piedi lineali, e piede superficiale un rettangolo di 1 piede x 6piedi; e chiama denaro il quadrato di un piede di lato. Non ho trovato in fonti letterarie gli equivalenti fiorentine di queste definizioni, che però è indubbio che venissero adoperate.
5 Il ricorso al 12 e alla sua potenza, che nel proseguo dello studio vedremo ritornare, propone un forte richiamo al tema del-la Gerusalemme celeste dell’Apocalisse giovannea, nella quale i numeri menzionati come misure della città sono il 12 (più volte), il 144, il 12.000.
6 La situazione dei luoghi non permette la restituzione me-trica della completa volumetria, risultando molte delle parti alte inaccessibili anche alla vista. Sarebbe necessario, per un compiuto rilievo, disporre di elevatori mobili.
7 Per la lettura delle proporzioni di S. Salvatore al Monte, vedi (Bartoli 1971) da cui è tratta la figura 25.
8 I disegni in figura sono elaborati di seminari di rilievo dei corsi di Rilievo dell’Architettura della Prof. Emma Mandelli, co-ordinati dal Prof. Alessandro Merlo. A loro va il mio ringrazia-mento per la concessione a studiare e a pubblicare alcuni degli esiti finali nella fig 27.
9 La carta del Magnelli e dello Zocchi, datata 1783 (Mori-Boffito 1973), mostra la navata fiancheggiata da tre cappelle a pianta quadrata sul lato est ed una cappella sul lato ovest; forse vi si conserva traccia o di intenzioni o di parziali realizzazioni. Del re-
sto, una osservazione fa ritenere che qualcosa di simile a cappelle laterali sia stato in qualche forma proposto: la larghezza interna di 24 braccia è misurata tra i due muri laterali a terra, all’altezza del ballatoio, tra i muri di appoggio delle capriate: è quindi di tutto il muro di elevazione. Ma dietro i grandi quadri sopra gli altari la parete è arretrata di più di 10 cm. Quindi su di essa si è lavorato per diminuire. Questo non è un fatto facilissimo da accettare, pen-sando alla struttura dei muri “a madonna” del tempo gotico. Forse si cominciò a tagliare per aprire i varchi delle cappelle e si dovette rinunciare e ricucire, per non rendere instabile il muro.
10 Nella decorazione dell’attico, i tondi con ritratti di santi sono cerchi, ellissi con asse maggiore orizzontale o verticale, a seconda del variare degli interassi delle lesene.
11 Una strada verosimile per giungere a tale risultato può es-sere la seguente: 720: 615 = 117: 100; 117: 100 = 200: x; x = 170,9. Se voglio che x sia un intero, ovvero 170, devo avere come secondo numero 612. Dunque, dividendo tutto per 10, i divisori utili sono 20 e 17, e il modulo è 3,6 braccia. Ringrazio il prof. Giuseppe Conti che mi ha fatto intravedere questo percorso come possibile soluzione, suggerendomi di seguire il metodo antico di usare i numeri grandi per trovare sottomultipli comuni.
12 Come il rettangolo 1: √2 è approssimato in epoca rinasci-mentale dai numeri 5: 7, così l’ottagono può essere disegnato in un reticolo di maglie 5-7-5 in orizzontale e in verticale.
Bartoli 1971L. Bartoli, L’unità di misura e il modulo proporzionale nell’architettu-ra del Rinascimento in «Quaderno n. 6 » Ed. Istituto d’Architettura e Rilievo dei monumenti della Facoltà di Architettura di Genova, Genova, pp. 129-137
Bartoli 2003M.T. Bartoli, Un laboratorio dell’architettura gotica: Firenze, la città, le mura, il palazzo in Città e ArChitetturA 2003, pp. 17-54.
Bartoli 2007M.T. Bartoli, Musso e non quadro, la strana figura di Palazzo Vecchio dal suo rilievo, Firenze, Edifir
Bartoli 2009M.T. Bartoli, Santa Maria Novella a Firenze, Edifir, Firenze
Bartoli 2011M.T. Bartoli, Vedi nostra città quanto ella gira, in sAntA CroCe 2011, pp. 142-155
Batazzi-Giusti 1992F. Batazzi- A. Giusti, Ognissanti, Roma, Fratelli Palombi Ed.
Benvenuti 2006A. Benvenuti, Una storia in sordina: gli Umiliati a Firenze, in ubi neque Aerugo 2006, pp. 41-52
Città e ArChitetturA 2003Città e architettura, le matrici di Arnolfo, a cura di M.T. Bartoli-S. Bertocci, Firenze, Edifir
Erodoto 2000Erodoto, Storie, Milano, Rizzoli
Fossi 2006E. Fossi, La graticola di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi a Firenze, in reALtà 2006
Friedman 2003D. Friedman, The Residence of the Mercanzia and the Piazza della Signoria in Florence in imAgo urbis 2003, pp. 371-388
Grossi 2008P. Grossi, Il sistema giuridico medievale e la civiltà comunale, in LA CiviLtà ComunALe 2008, pp. 1-18
imAgo urbis 2003Imago Urbis, L’immagine della città nella storia d’Italia, a cura di F. Bocchi- R. Smura, Roma, Viella
Kuhn 19786Th. Kuhn, Struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Einaudi
LA CiviLtà ComunALe 2008La civiltà comunale italiana nella storiografia internazionale, a cura A. Zorzi, Firenze, Florence University Press
BiBliografia
— 48 —
Maria Teresa Bartoli
Manetti 1976A. Manetti, Vita di Filippo Brunelleschi, Milano, edizione critica Il Polifilo
Mori-Boffito 1973A. Mori-G. Boffito, Firenze nelle vedute e nelle piante, Giunti, Fi-renze: ed. orig. 1929, ristampa anastatica Roma
Murray 2002A. Murray, Ragione e società nel Medioevo, Roma, Editori riuniti
pAoLo deLL’AbbACo 1964Paolo dell’Abbaco, Trattato d’Aritmetica, a cura di G. Arrighi, Pisa, Domus Galileiana
pAoLo deLL’AbbACo 1966Paolo Dell’Abbaco, Regoluzze secondo la lezione del codice 2522 della Bi-blioteca Riccardiana di Firenze, a cura di G. Arrighi, Prato, Azienda Autonoma di Turismo di Prato
reALtà 2006Realtà e illusione nell’architettura dipinta, a cura di F. Farneti-D. Lenzi, Firenze, Alinea
Richa 1755P. Richa, Notizie istoriche delle chiese fiorentine, Firenze, t. III
sAntA CroCe 2011Santa Croce, oltre le apparenze, a cura di A. De Marchi-G. Piraz, Pi-stoia, Gli Ori
sCritti 1862Scritti di Leonardo Fibonacci, a cura di B. Boncompagni, Roma, vol. 2
Sznura 1975F. Sznura, L’espansione urbana di Firenze nel dugento, Firenze, La Nuova Italia
ubi neque Aerugo 2006Ubi neque aerugo neque tinea demolitur, Studi in onore di Luigi Pellegrini per i suoi settanta anni, a cura di M.G. Del Fuoco, Napoli, Liguori
— 49 —
Il tramezzo nella liturgia basso-medioevaleIn un celebre affresco di Giotto, conservato nella
basilica superiore di Assisi, è rappresentato il presepe di Greccio. Sullo sfondo della raffigurazione della nati-vità di Gesù si vede una folla assiepata dietro una pic-cola porta per assistere alla rappresentazione. La porta in questione è quella del tramezzo che distingueva la parte della chiesa destinata ai frati da quella destinata all’assemblea.
Con il termine “tramezzo” se ne definisce la natura fisica di separazione, ma, oltre a questo dato e a qualche affresco, poco si sa di questo elemento architettonico sistematicamente demolito nelle chiese medioevali dopo il Concilio di Trento. Sappiamo, per gli studi ef-fettuati, che il crocifisso della “bottega di Giotto” (L’of-fiCinA di giotto 2010) e probabilmente la Maestà dello stesso autore, poggiavano su un tramezzo anche nella chiesa di Ognissanti (Hueck 1992). L’opera del pittore ci invita ad un paragone con le chiese coeve fiorenti-ne e in particolare con la vicina Santa Maria Novella, la quale, sul cosiddetto “ponte” (Borghigiani 1760; Hall 1974)
1 ospitava il più grande crocifisso ligneo
mai realizzato, opera certa di Giotto (giotto 2002; De Marchi 2009).
Per comprendere meglio la relazione del tramez-zo con la chiesa, è sicuramente di notevole interesse il disegno di progetto per la chiesa e il convento di San Francesco ad Arezzo 2
. La scelta di questo documen-to, per l’analisi della chiesa oggetto di questo studio, è stata incentivata da osservazioni di pari valore: la pros-simità territoriale e storica del progetto con la chiesa fiorentina; la congruenza delle misure e della tipologia; la rarità di un disegno di progetto originale di una chie-sa basso-medioevale minuziosamente disegnato.
Per completare questa premessa è utile ricordare la funzione di questo elemento architettonico. Nel bas-so medioevo, da elemento divisorio partecipante alla scansione degli spazi della chiesa, dal sagrato all’altare maggiore, il tramezzo era divenuto sempre più il luo-
go intorno al quale gli ordini mendicanti, molto at-tenti all’evangelizzazione, svolgevano rappresentazioni di testi sacri. Oltre all’affresco di Giotto descritto in apertura di questo studio esistono altri documenti che testimoniano l’utilizzo teatrale del tramezzo. In parti-colare, anche se tarda, è interessante la descrizione di una sacra rappresentazione scritta dal Vescovo Abramo di Souzdal, il quale, giunto a Firenze nel 1439, descrive minuziosamente una rievocazione dell’Annunciazione alla quale assiste:
«[...] Nel mezzo poi della chiesa, centosettantacinque piedi dalla porta d’entrata, da una parete all’altra va un pon-te o tramezzo di pietra, su quattro colonne di pietra, alto ventun piedi e largo diciassette e mezzo, parato di stoffe rosse: a sinistra v’è un letto di legno, ornato anch’esso di magnifiche stoffe, e a lato a guanciale un seggio riccamen-te coperto. Vi sedeva sopra un bel giovane, vestito di ricchi abiti femminili, con corona in capo e nelle mani un libro che
La chiesa basso-medioevale: il tramezzo di OgnissantiStefano Giannetti
1. Presepe di Greccio, affresco di Giotto, Basilica superiore di Assisi. Da notare il tramezzo sullo sfondo sul quale è collocata la Crux de medio ecclesiae
— 50 —
Stefano Giannetti
leggeva in silenzio, e rassomigliava benissimo alla Vergine Maria. […] Da cotesto palco di pietra nel mezzo della chiesa vanno alla tribuna alta [endonartece, ndr] ch’è di fronte cin-que canapi fini ma forti. Due di essi sono attaccati non lungi dal giovane che fa da Vergine, ed è qua che per mezzo d’un terzo canapo finissimo, l’angelo inviato da Dio, discende e ritorna poi in alto giubilando, dopo l’Annunziazione. I tre altri canapi vanno appunto nel mezzo del palco.
Venuto il momento del grande e meraviglioso spettaco-lo, molta gente si raccoglie nella chiesa, silenziosa, cogli oc-chi fissi al palco del tramezzo. Dopo poco cadono le cortine co’ drappi, e sul magnifico seggio presso il lettuccio si vede colui che rappresenta la Vergine. Tutto ciò è bello, meravi-glioso, pieno di grazia» (Todarello 2006, p. 184).
La descrizione di questa rappresentazione, avvenu-ta nella chiesa della Santissima Annunziata a Firenze, è utile per capire come il tramezzo, ormai nel XV secolo, era divenuto il fulcro principale della chiesa e ormai lontano dalla funzione di divisorio si era trasformato in un vero e proprio palcoscenico.
Altra evidenza che ci perviene dai documenti è l’impegno profuso nell’allestimento e nella progetta-zione di questi luoghi liturgici, sempre più ricchi nel basso medioevo di opere d’arte.
«Grazie alle grandi tavole della seconda metà del Due-cento e del primo Trecento i tramezzi delle chiese centro-italiane, soprattutto di quelle degli ordini mendicanti, ma non solo, vennero qualificati come una sorta di facciata in-terna, con la medesima organizzazione dogmatica e struttu-rale […]» (De Marchi 2009).
La ricchezza con la quale era ornato il tramezzo di Ognissanti induce ad ipotizzare che, anche nel caso de-gli Umiliati, le sacre rappresentazioni e molti momenti importanti della liturgia ruotassero attorno a questo elemento architettonico.
Il tramezzo in pianta: il disegno di progetto di San Francesco ad Arezzo
Del tramezzo di Ognissanti non abbiamo molti do-cumenti che ne descrivano le dimensioni e la colloca-zione. Irene Hueck attraverso alcune osservazioni e la lettura di alcuni documenti descrittivi del manufatto, ricolloca il tramezzo in relazione alle due porte, or-mai tamponate, che dalla chiesa permettevano di uscire verso il convento ad est e verso il cimitero ad ovest.
Secondo il Tognocchi di Terrinca il tramezzo «doveva arrivare alla dirittura delle Porte di fianco» le quali, a suo parere, erano più o meno in mezzo alle pareti laterali. Nell’interpretazione del testo data dal Razzoli, il coro si sarebbe allungato fino all’odierno altare di Sant’Anto-nio da Padova, visibile «[…] sulla parete sinistra prima dell’organo. L’argomento a sostegno di tale ipotesi è la collocazione ben documentata di tre opere trasferite dal transetto alle pareti laterali» (Hueck 1992).
Queste porte, seppur tamponate, sono tutt’oggi visibili e in occasione del recente rilievo del complesso di Ognissanti sono state inserite correttamente nella pianta della chiesa.
Come già accennato, per comprendere con mag-giore accuratezza il processo ideativo alla base del-
2. Ricostruzione in pianta e in alzato del tramezzo di Ognissanti, con inserimento delle opere d’arte (Hueck 1992)
— 51 —
La chiesa basso-medioevale: il tramezzo di Ognissanti
la progettazione e del posizionamento del tramezzo all’interno della pianta della chiesa, questo studio si è avvalso del disegno di progetto del Convento di San Francesco di Arezzo.
In questa pergamena sono presenti molte misure dell’architettura, tuttavia gli studi precedenti effettuati sul documento hanno preso poco in considerazione tali numeri (Franchetti Pardo 1986). Infatti, analizzando il disegno 3
e confrontandolo con le misure delle chie-se aretine coeve a San Francesco, e quelle della chiesa stessa, si può affermare che l’unità di misura utilizzata in quel periodo ad Arezzo era il braccio fiorentino 4. An-dando a ricostruire la pianta del convento, sulla base del-le misure riportate sulla pergamena, è possibile dedurre molte informazioni riguardo alla chiesa e il tramezzo. La chiesa è larga al lordo dei muri precisamente 29 brac-cia e 8/12 5
e il filo del muro del tramezzo che guar-da la controfacciata dista dal filo esterno della facciata 55 braccia e 8/12. L’area che si ottiene è precisamente di 1650 braccia quadre che equivalgono ad uno staioro (Bartoli 2007; Høyrup 1995). L’area destinata ai frati, invece, presa dallo stesso filo del tramezzo fino al filo esterno del muro della chiesa escluse le absidi, è di 1000 braccia esatte. Questo fa intendere che la posizione del tramezzo crea due aree in rapporto di 1,65 tra loro. Le
absidi coprono un’area, al lordo dei muri, di 650/2, ov-vero di 325 braccia quadre. Al netto dei muri la chiesa ha una superficie di 2500 braccia quadre totali, di cui 1400 braccia destinate all’assemblea, 850 al coro e 250 al pre-sbiterio. Non si possono trovare nella pergamena altre misure espresse con numeri interi che possano spiegare in modo migliore la collocazione del tramezzo.
Altro paragone che si può effettuare, al fine di com-prendere la posizione del tramezzo, è con la chiesa di Santa Maria Novella. Il “ponte” nella ricostruzione che ne fa la Hall si trovava all’altezza della seconda coppia di pilastri della navata a partire dall’altare, nei pressi degli scalini tutt’ora esistenti (Hall 1974). La Hall ri-costruisce questa posizione basandosi sul testo del Bor-ghigiani
6 che lo descrive così:
«Il ponte da petto a rene si stendeva per braccia 14 cir-ca, le di cui volte erano raccomandate ai due pilastroni ove adesso sono i quadri di san Pietro Martire e di san Giacinto. Sopra aveva da una parte e l’altra una sponda andante alta a mezz’uomo, per cui veniva a denominarsi ponte, e per es-sere da levante e ponente lungo, e da mezzodì a tramontana assai più stretto. Lungo era quanto è larga la chiesa, e stretto quanto è dagli scalini alla fine delle prime file de’ sepolchri di marmo stesi sul suolo, cioè fino al principio del mattonato che non ha sepolture» (Borghigiani 1757-1761).
3. Pianta della chiesa disegnata sulla pergamena di Arezzo. Si può notare la posizione del tramezzo e le superfici delle tre aree destinate al culto
4. Pianta della chiesa disegnata sulla pergamena di Arezzo sulla quale è stato aggiunto il transetto al fine di eguagliare l’area destinata all’assemblea a quella destinata ai consacrati
— 52 —
Stefano Giannetti
Andando a sovrapporre la pianta della chiesa areti-na, opportunamente ingrandita, con quella fiorentina si nota come la posizione del tramezzo coincida perfet-tamente. Infatti a Santa Maria Novella, l’interasse della coppia di pilastri individuata come sede del ponte, dista dal filo esterno della facciata 95 braccia 7
e dal muro di fondo, escluso l’abside e le cappelle, 59 braccia. Molti-plicando queste distanze per la larghezza della chiesa al lordo dei muri, che equivale a 50 braccia, si ottengono rispettivamente le misure di 4750 e di 2950 braccia quadre. Il rapporto fra le dimensioni in questo caso è di 1.61 circa 8
. Inoltre è interessante notare come, al netto dei
muri, le campate della «prima fase» di Santa Maria Novella (Bartoli 2009) coprono un’area di circa uno staioro. L’interasse di 18 braccia moltiplicato per la distanza, misurata tra le paraste, di 46 braccia e per il numero di campate (in questo caso due), da’ come risultato 1656 braccia quadre. Poiché l’attuale corpo longitudinale della chiesa, anziché dalle sei differenti
campate dalle quali è costituito, potrebbe essere coper-to da sette campate equivalenti alle due più prossime all’altare (Bartoli 2009, pp. 25-28)
9, allora la misura
dell’area della chiesa fino al transetto equivale a 5800 braccia quadre esatte (18 x 46 x 7). A queste si aggiun-gono le 2450 braccia quadre del transetto portando l’intera misura alla cifra di 8250 braccia quadre: 5 sta-iora esatte. Il tramezzo, nella posizione descritta sopra, distando dalla controfacciata 91 braccia, divide quasi perfettamente a metà la superficie netta della chiesa: 8250/2 = 4125; 4125/46 = 90 circa.
Al lordo dei muri, invece, la parte presbiteriale della chiesa copre un’area di circa 1350 braccia qua-dre, che, sommata allo staioro del transetto e alle 1750 braccia quadre delle navate fino alla posizione del pon-te, portano l’area della chiesa destinata ai consacrati a 4750 braccia quadre compresi i muri. Questa, come calcolato in precedenza, è la stessa misura della super-ficie della chiesa destinata all’assemblea.
Tornando alla pergamena di Arezzo, sulla base delle
5. Pianta della chiesa di Santa Maria Novella con evidenziata la posizione del tramezzo e le superfici delle varie aree
6. Pianta della chiesa di Santa Maria Novella con sovrapposta la pianta modificata della pergamena di Arezzo
— 53 —
La chiesa basso-medioevale: il tramezzo di Ognissanti
osservazioni fatte sulla chiesa di Santa Maria Novella, è facile notare come, per eguagliare le due superfici al lordo dei muri, è necessario aggiungere alla parte destinata ai consacrati le 325 braccia quadre mancanti per raggiungere lo staioro. Queste si possono ottenere creando un transetto che, raddoppiando le cappelle di fondo, ricalca precisamente il modello e i rapporti del-la chiesa di Santa Maria Novella.
Gli studi effettuati dalla Bartoli e pubblicati in que-sta monografia evidenziano che la superficie al lordo dei muri della chiesa di Ognissanti è di 2000 braccia quadre. Andando a cercare due numeri interi, il cui rapporto sia il più vicino possibile a 1.6, si è osservato che la distanza più congrua tra la facciata della chiesa e quella del tramezzo è quella di 47 braccia, le quali, moltiplicate per le 26.6 braccia della larghezza al lordo dei muri, individuano un’area destinata all’assemblea di 1250 braccia quadre e un’area destinata ai frati di 750 braccia quadre. Inoltre le superfici nette create dal tra-mezzo sarebbero rispettivamente di 1080 e 648 braccia
quadre esatte. Questa posizione coincide, precisandone la misura, con la ricostruzione fatta dalla Hueck che colloca il tramezzo all’altezza circa dell’attuale pulpito (Hueck 1992). Va specificato che l’attuale posizione del pulpito può essere stata influenzata dal tramezzo, ma, sicuramente, la quota di questo non è confronta-bile con quella dell’originale; inoltre, la costruzione dell’attuale scala di accesso, poiché esterna alla chiesa, è da considerarsi sicuramente posteriore alla demoli-zione del tramezzo stesso.
L’alzato del tramezzo: il “ponte” di Santa Maria NovellaPer ricostruire l’alzato del “ponte” di Santa Maria
Novella, come già visto per la pianta, un’ottima fonte è sicuramente il Borghigiani, il quale descrive accurata-mente la conformazione di questo prima della demoli-zione Vasariana:
«Sopra aveva da una parte e l’altra una sponda andante alta a mezz’uomo, per cui veniva a denominarsi ponte, e per
7. Pianta della chiesa di Ognissanti nella probabile configurazione medioevale con sovrapposto lo schema delle aree
8. Pianta della chiesa di Ognissanti nella probabile configurazione medioevale sovrapposta alla pianta della chiesa attuale
— 54 —
Stefano Giannetti
essere da levante e ponente lungo, e da mezzodì a tramon-tana assai più stretto. Lungo era quanto è larga la chiesa, e stretto quanto è dagli scalini alla fine delle prime file de’ sepolchri di marmo stesi sul suolo, cioè fino al principio del mattonato che non ha sepolture; quali lapidi sepolcrali tor-navano sotto al ponte. Il piano di sopra era postato circa un braccio sopra la porta che scende nel chiostro verde, il di cui solare era tutto mattonato» (Borghigiani 1757-1761).
La Hall parla di un’altezza complessiva del ponte di 4,5 metri (Hall 1974). Ripercorrendo i suoi calcoli e le descrizioni del Borghigiani si possono descrivere più pre-cisamente le altezze in questo modo. A partire dalla quo-ta dell’architrave della porta dei frati che si apre verso il chiostro verde, misurata a partire dal livello inferiore della chiesa, si ha una misura di 5 braccia e mezzo: aggiungendo a questa misura quella di un braccio si ottiene l’imposta del solaio del ponte che si attesta all’altezza di 6 braccia e mezzo. Il Borghigiani descrive il parapetto alto mezz’uo-mo, quindi un braccio e mezzo, che, aggiunto al ponte, porta la sua altezza complessiva dal livello inferiore della chiesa a 8 braccia (4,4 metri dal livello superiore, 10 cen-timetri in meno dell’ipotesi formulata dalla Hall).
Sulla base del rilievo della chiesa, eseguito da questo gruppo di ricerca 10
, e seguendo la descrizio-
ne dell’autore, è stato possibile ricollocare il ponte in alzato e collocare su questo il crocifisso. Si è potuto notare che il crocifisso è in rapporto preciso con l’al-zato della chiesa. L’arco principale della chiesa, lar-ga 46 braccia al netto delle paraste, ha l’altezza della chiave pari all’altezza del triangolo equilatero di lato 46. Il crocifisso di Giotto, sistemato sopra il ponte, si troverebbe circa all’altezza dell’attuale ricollocazione e avrebbe l’ombelico al centro dello stesso triangolo equilatero. Per calcolare la quota di questo punto basta moltiplicare 46 per √3 /6 ottenendo così la misura di 13 braccia e 3/12 circa.
Si è notato che in questo crocifisso l’ombelico, oltre a giacere sull’asse mediano della tavola, è un elemen-to fondante della costruzione geometrica necessaria a descrivere le proporzioni del Cristo 11
. Questa, infatti, coincide con quella descritta da Vitruvio:
«Il centro del corpo è l’ombelico; infatti se si collocasse un uomo supino con le mani e i piedi aperti e si mettesse il centro del compasso nell’ombelico, descrivendo una cir-conferenza si toccherebbero tangenzialmente le dita delle mani e dei piedi. Ma non basta, oltre lo schema del cerchio nel corpo si troverà anche la figura del quadrato. Infatti se si misura dal piano di posa dei piedi al vertice del capo e poi si trasporta questa misura alle mani distese si troverà una
9. Genesi geometrica del crocifisso di Giotto
10. Sezione della chiesa di Santa Maria Novella con sovrapposta la sagoma del tramezzo e il cro-cifisso di Giotto
— 55 —
La chiesa basso-medioevale: il tramezzo di Ognissanti
lunghezza uguale all’altezza come accade nel quadrato tirato a squadra» (Vitruvio).
Il centro del cerchio che passa per i tre chiodi è proprio l’ombelico e la larghezza delle braccia distese è pari all’altezza del corpo dalla testa ai piedi. Inoltre l’ombelico nello schema ad quadratum divide l’altezza del Cristo secondo il rapporto aureo 12
.Nel collocare il crocifisso di Ognissanti
13 si è po-
tuto osservare che questo, escluso il trapezio di base, era alto 8 braccia (altezza equivalente al corrispettivo di Santa Maria Novella). Tuttavia, mentre la figura del Cristo di Ognissanti ha le stesse identiche proporzioni di quello di Santa Maria Novella 14
, il supporto ligneo cambia molto, ridimensionando il soggetto e collocan-dolo in un posizione inferiore della croce. Il supporto ligneo è stato ampiamente studiato in occasione del recente restauro: si è notato che la costruzione fisica e geometrica è basata sulla ripetizione di un modulo quadrato di 50 cm (circa 10/12 di braccio), distribuito uniformemente lungo tutta la tavola e, in particolare, ripetuto in numeri uguali lungo le braccia e la testa della
croce (L’offiCinA di giotto 2010). Da questa ripetizione deriva la possibilità di descrivere gran parte della croce come un quadrato il cui centro giace all’altezza della testa del Cristo. Collocando il crocifisso sul tramezzo, si è osservato che la quota (13 braccia e 4/12) di que-sto punto, centro del quadrato del supporto ligneo, era molto simile a quella dell’ombelico del Cristo, centro dell’esagono, di Santa Maria Novella, e che, anche nel caso di Ognissanti, rappresentava il centro della costru-zione quadrata della sezione della chiesa nel quale era ospitata (lato di 26,5 braccia).
In medio EcclesiaeNella presente ricerca, l’utilizzo della misura, otte-
nuta attraverso il rilievo architettonico dell’oggetto, ha permesso di precisare l’origine del processo creativo che colloca il tramezzo al centro della chiesa basso-me-dioevale. Sulla base degli studi già effettuati sul tema, è utile evidenziare il cambiamento di funzione e di posizione di questo elemento all’interno dell’edificio basso-medioevale. Da muro di recinzione dello spazio sacro, presso l’altare maggiore delle chiese dell’alto medioevo, il tramezzo nel Trecento “scende” in medio Ecclesiae e, al centro della Chiesa, tempio e comunità, sopra questo elemento architettonico viene collocato il Cristo: la Crux de medio ecclesiae (De Marchi 2009). Da elemento divisorio perciò diviene sempre più materia-lizzazione del legame della Chiesa, proporzionata nei suoi elementi costituenti secondo la natura fisica del corpo. Come sintetizza ottimamente Alessandro Saluc-ci nella prefazione a questa monografia.
Come noto, nel pensiero medioevale la ratio ten-deva a essere intesa anche nel senso di una virtù mo-rale che guidava al retto agire. La ragione pratica era insomma a servizio della giustizia, se la giustizia è in-tesa nell’accezione di “giusto rapporto”. Mentre questi mutamenti concettuali si consolidavano, l’uomo inizia-va a essere il centro prospettico dello spazio divino e sociale, come la pittura di Duccio e Giotto iniziavano a far intendere.
Perciò, porre il Cristo al centro della Chiesa, per il progettista medioevale non è un’intenzione vaga, ma un obiettivo da perseguire con strumenti scientifici, siano essi quelli classici delle lunghezze che quelli inno-vativi delle superfici.
11. Sezione della chiesa di Ognissanti nella probabile configurazione medioevale, con sovrapposta la costruzione geometrica basata sul quadrato
— 56 —
Stefano Giannetti
1 Nei casi delle due chiese maggiori fiorentine non si trattava solo di una parete, ma di un vero e proprio ponte o jubè.
2 Il documento in questione si tratta di una pergamena con-servata presso l’Archivio Capitolare di Arezzo, fondo Ex Archivis Variis, capsa V, n°873. La datazione del XIV secolo è postuma e incerta, mentre l’attribuzione a Fra Giovanni da Pistoia e l’attri-buzione quale progetto di San Francesco ad Arezzo sono leggibili nel “verso” della pergamena.
3 Nel disegno, nello spessore del muro longitudinale della chiesa, l’unità di misura è definita per esteso con il termine brachia (braccia in latino). Nelle altre misure invece l’unità di misura è riportata median-te una b. minuscola con una linea perpendicolare alla lettera.
4 Sono stati rilevati speditamente la chiesa di San Domenico e quella di San Francesco in Arezzo entrambe della fine del XIII secolo. La prima, più piccola della seconda, è larga esattamente 14,60 metri (25 braccia fiorentine) e lunga 52,21 metri (89,5 braccia). La seconda invece è larga 16,93 metri (29 braccia) e lun-ga 53,4 metri (91,5 braccia).
5 La misura della larghezza della chiesa riportata è di 26,5 braccia al netto dei muri. Mettendo in scala il disegno sulla base di questa misura si è notato come tutte le altre quote coincidono perfettamente con le numerose misure. Inoltre è stato possibile osservare come il progetto della chiesa differisca dalla chiesa re-alizzata, avvalorando la tesi di un progetto non realizzato, da col-locare, quindi, negli anni antecedenti la costruzione della chiesa: almeno negli ultimi del XIII secolo.
6 La ricchezza del documento risiede nelle fonti, oggi perdu-te, sulla base delle quali l’autore ricostruisce minuziosamente la chiesa pre-vasariana.
7 La facciata della chiesa di Santa Maria Novella, alla quota della pianta del rilievo, risale all’epoca medioevale ed è stata lasciata intat-ta dagli interventi di Leon Battista Alberti (Wittkower 1962).
8 Questo numero è molto simile al rapporto aureo che vale precisamente 1,618.
9 Nel testo l’autore ipotizza che sussistano per Santa Maria Novella due fasi di costruzione, individuabili da scelte progettuali diverse. In particolare, la Bartoli mette in evidenza come la diffe-
renza di interasse che sussiste tra le prime due campate, uguali fra di loro, e le ultime quattro verso la facciata, irregolari in maniera non proporzionale, non sia imputabile ad una prematura volontà prospettica, ma piuttosto ad una variante del progetto nella fase di realizzazione. Tuttavia l’autore nota che moltiplicando per sette (numero di campate molto utilizzato nell’architettura gotica ita-liana) l’interasse delle prime due, la posizione della facciata non si modificherebbe, ipotizzando, così, un primo progetto di chiesa costituita da campate tutte con le stesse dimensioni.
10 Il rilievo della chiesa e del convento di Santa Maria Novella è stato realizzato dal gruppo di ricerca di Maria Teresa Bartoli ed è pubblicato in Bartoli 2009.
11 Lo studio della sezione della chiesa di Santa Maria Novella e del crocifisso di Giotto, si è avvalso, come base dati, della nuvola di punti ottenuta durante il rilievo della chiesa. Questa base dati, data la sua accuratezza, ha permesso un’analisi dettagliata dell’ar-chitettura, del dipinto e del supporto ligneo.
12 Le proporzioni così descritte coincidono perfettamente con l’interpretazione operata da Leonardo da Vinci sul testo vitruvia-no. La differenza sta nell’utilizzo, da parte di Giotto, dei chiodi e dell’ombelico come punti nodali per il proporzionamento della figura. Giotto così, utilizzando gli strumenti della scuola di Giunta Pisano e di Cimabue, che ponevano i chiodi secondo lo schema del triangolo equilatero, innova il metodo, accentuando, in questo modo, la dimensione umana del Cristo su quella divina. In ultimo va notato come Giotto, per far questo, è costretto a porre in asse l’ombelico del Cristo forzando la figura umana nell’innaturale po-sizione già notata nella critica al crocifisso.
13 In questo caso, a differenza di Santa Maria Novella, le mi-sure del dipinto non sono state prese direttamente, ma lo studio si è avvalso della pubblicazione seguita al restauro del crocifisso: L’offiCinA di giotto 2010.
14 Le proporzioni si discostano solo nella posizione dell’om-belico. Infatti la quota di questo è la stessa di quello di Santa Maria Novella, ma per evitare la posizione innaturale di cui alla nota 12, è possibile che l’artista abbia ritenuto opportuno spostare il cen-tro del corpo fuori dall’asse della croce.
Bartoli 2007M.T. Bartoli «Musso e non quadro». La strana figura di Palazzo Vecchio dal suo rilievo, Firenze, Edifir
Bartoli 2009M.T. Bartoli, Santa Maria Novella a Firenze, Algoritmi della scolastica per l’architettura, Firenze, Edifir
Benvenuti 1992A. Benvenuti, Vangelo e tiratoi, in La ‘Madonna d’Ognissanti’ di Giot-to restaurata, in «Gli Uffizi», 8, pp. 75-84
Borghigiani 1757V. Borghigiani, Cronica annalistica di SMN, 1757-61, in «ASMN I.A.30», III, pp. 330-341
giotto 2002Giotto. La croce di Santa Maria Novella, a cura di M. Ciatti- M. Sei-del, Firenze, Edifir
L’offiCinA di giotto 2010L’officina di Giotto, il restauro della Croce di Ognissanti, a cura di M. Ciatti, Firenze, Edifir
Note
BiBliografia
— 57 —
La chiesa basso-medioevale: il tramezzo di Ognissanti
De Marchi 2009A. De Marchi, “Cum dictum opus si magnum”. Il documento pistoie-se del 1274 e l’allestimento trionfale dei tramezzi in Umbria e Toscana fra Due e Trecento, in Medioevo: immagine e memoria, a cura di A.C. Quintavalle, Milano, Electa
Arredi LiturgiCi 2007Arredi liturgici e architettura, a cura di A.C. Quintavalle, Milano, Electa
Franchetti Pardo 1986V. Franchetti Pardo, Arezzo, Bari, Laterza
Høyrup 1995J. Høyrup, Linee larghe, un’ambiguità geometrica dimenticata, in «Bol-lettino di Storia delle Scienze Matematiche» 15, pp. 3-14
Hall 1974M.B. Hall, The ponte in S. Maria Novella: the problem of the rood screen in Italy, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes» 37
Hueck 1992I. Hueck, Le opere di Giotto per la chiesa di Ognissanti, in La ‘Madon-na d’Ognissanti’ di Giotto restaurata, in «Gli Uffizi», 8, pp. 37-49, Firenze, Centro Di
Todarello 2006N.L. Todarello, Le arti della scena: lo spettacolo teatrale in occidente da Eschilo al trionfo dell’opera, Latorre
Vitruvio 1997M.P. Vitruvio (orig. 25 a.C.), De architectura, Einaudi
Wittkower 1994R. Wittkower (orig. 1962), Principii architettonici nell’età dell’U-manesimo, Torino, Einaudi
Pergamena del progetto del convento di San Francesco ad Arez-zo, Archivio Capitolare di Arezzo, fondo Ex Archivis Variis, capsa V, n°873
— 59 —
Nel 1769 i Carmelitani del convento di Ognissanti decisero di sostituire la copertura della chiesa di San Salvatore “rozza e disadorna” e di far costruire una stuo-ia di «canne grosse, bene stagionate, e tutta d’un pezzo, consistente in braccia millequattrocentosettant’una e tre quarti»; la decorazione del soffitto fu commissio-nata a Giuseppe Romei e a Giuseppe Benucci «uomo molto valente nel architettura» 1.
La quadratura è organizzata in due parti. La pri-ma, corrispondente grosso modo alla navata compresa tra i muri laterali, organizza un vertiginoso sfondato architettonico che simula le pareti di un cortile come cornice di un “trionfo” celeste, in cui appaiono i San-ti Francesco e Baylon, con il Padre eterno, la Vergine e Gesù Cristo; la seconda, che completa il soffitto sul vuoto dell’incrocio col transetto, rappresenta un reali-stico cassettonato, al cui centro un medaglione porta la spiegazione di ciò che si vede.
Osservando la quadratura si notano alcune evidenti irregolarità: le colonne della parte centrale sembrano cadere su di noi, le balaustre girano in maniera scorretta sugli angoli, le mezze colonne che delimitano, sui lati corti, le balconate in aggetto, sono concluse da capitelli interi (vedi Tav. XIV). La lunghezza del soffitto è circa tre volte più grande della distanza dell’osservatore, e quindi sarebbe fortemente fuori da quello che oggi si considera il cono visivo, però le parti che creano l’illu-
sione più forte sono proprio quelle lontane dal punto principale, mentre quelle prossime al centro, e quindi interne al cono, risultano incongruenti sia a livello ge-ometrico, sia a quello percettivo.
Tra l’elegante congruenza architettonica, prospetti-ca e percettiva delle rappresentazioni rinascimentali 2 e le finzioni ottiche dell’illusionismo barocco, la quadratu-ra di Ognissanti sembra avere un concetto dello spazio diverso, e questo studio si propone di metterlo in luce.
Analisi della quadraturaLe dimensioni della navata della chiesa sono 24x72
braccia fiorentine e formano un rettangolo del rapporto 1:3; togliendo la cornice, si arriva alle dimensioni della stuoia di 21 1/3 x 70, la cui superficie misura esattamente 1471.75 br2 come riporta la fonte. Analizzando il disegno dal punto di vista architettonico-compositivo è possibile individuare una serie di piani orizzontali e verticali (o in-clinati) i quali compongono lo spazio dipinto (Fig. 1).
Ragionando sugli ordini architettonici che com-pongono lo spazio illusorio, si possono riconoscere due possibili scatole che racchiudono l’architettura dipinta (Fig. 2). Togliendo il cassettonato dipinto di 8 braccia dalla parte dell’altare e la parte omologa di 2 braccia dalla parte dell’ingresso, si definisce la scatola, la cui base misura sul piano del quadro 3 21 1/3 x 60 braccia (vera grandezza), mentre l’immagine della corrispon-
La quadratura di OgnissantiConcezione dello spazio tra barocco e IlluminismoNevena Radojevic
1. Individuazione dei piani che “compongono” lo spazio illusorio
— 60 —
Nevena Radojevic
dente superiore misura 12 1/2 x 35, quando raggiunge l’altezza massima. Evidente è il filo della trave che ap-partiene a questo piano (Fig. 3).
Il rapporto tra lunghezza e larghezza di questa scato-la sarebbe circa 1:2√2 , poco conveniente alle esigenze di speditezza della costruzione prospettica, che predilige rap-porti tra numeri piccoli e interi, e inoltre molto vicino a 1:3. Come arrivare ad avere una scatola di tali proporzioni?
Con una serie di accorgimenti pratici, da virtuoso, il prospettico raggiunge l’obbiettivo, spostandosi di un braccio 4 su tutti i lati sul piano orizzontale, definendo un rettangolo di 19 1/3 x 58 braccia, di rapporto di 1:3, che rappresenta il filo esterno della cornice sopra le men-sole e di quella del fregio. (Fig. 2) Così abbiamo creato il secondo cannocchiale prospettico su quale è molto più semplice muoversi, come vedremo in seguito (Fig. 4).
Se si osservano bene i fili contenenti gli estremi delle due cornici, si nota una cosa molto particolare. Le loro misure sono rispettivamente 17x51, e 11 1/3 x34, e quindi sono legate anche tra di loro dal comune rapporto di 2/3 (34/51) che agevola l’esecuzione ope-rativa della quadratura (Fig. 5).2. Ipotesi sui ordini compositivi con 2 fili particolari messi in evidenza
3. “Cannocchiale prospettico” esterno che parte dal piano del quadro
4. Cannocchiale prospettico “interno”, di rapporto 1:3
— 61 —
La Quadratura di Ognissanti
Punti di Fuga e Cono VisivoPrima ancora di affrontare i problemi legati agli
elementi principali per la costruzione prospettica, use-remo il metodo filologico, che ci suggerisce di esplo-rare le conoscenze geometriche del periodo. Il tema della prospettiva di sotto in su sui vani lunghi e stretti richiedeva che si prendesse una posizione intorno al rapporto tra la distanza e l’apertura del cono visivo, che come vedremmo in seguito, varia tra gli autori.
Il concetto del cono visivo, nella storia, è stretta-mente legato alla definizione della prospettiva 5. Per il Vignola; «Sotto vocabolo di Prospettiva s’intende comunemente quel prospetto, che si rappresenta in un’occhiata qual si voglia cosa, senza muovere la testa o girare l’occhio». L’angolo visivo, secondo lui, dipende dall’apertura della pupilla, e in condizioni ottimali è di 60⁰, ma può essere anche retto o addirittura ottu-so, quando si «apre l’occhio per mirare in confuso». Per fare le prospettive sui soffitti, Vignola suggerisce di mettere il punto principale nel mezzo della stanza, e tenere conto della distanza dell’osservatore – «non po-tendosi vedere, nè più di presso, nè più di lontano, che stando in piedi nel mezzo della stanza» (Danti 1583).
Secondo il Vignola però, per i soffitti lunghi e bassi, bisogna comunque ricorrere ad una serie di accorgi-menti (mantenendo il punto di concorso nel centro, ma adattando quello della distanza, che dovrà essere au-mentata) tali da permettere la visione in un’occhiata di più prospettive che compongono quella unica. Nel trattato di Giulio Trioli, detto il Paradosso, si trova lo stesso ragionamento (detto con le stesse esatte parole di Vignola) che fa capire che tale opinione era la più diffusa e radicata nel tempo. Un ulteriore sviluppo di
questi concetti si vede nelle quadrature dei bolognesi, Mitelli e Colonna, teorizzati poi dal trattatista spagnolo Palomino da Castro y Velasco nel suo trattato El Museo Pictorico (Fig. 6).
5. Alcuni punti principali per l’individuazione degli elementi architettonici
6. El Museo Pictorico, Lam.10; In alto a destra si vede il disegno che spiega come usare più punti di fuga negli spazi lunghi, per ridurre le aberrazioni marginali e permettere una visione più ampia. Lo schema risolve il problema d’angolo, dove vengono a contatto 2 prospettive diverse
— 62 —
Nevena Radojevic
L’attuale storiografia dei sistemi di rappresentazione considera la quadratura un fenomeno di prassi, grandio-sa ma non originale (Argan 1983). La domanda che si pone è: la quadratura è veramente estranea al processo di allargamento dei corollari della prospettiva o le può es-sere riconosciuto un ruolo attivo di creatività artistica?
Mentre nelle prospettive dipinte su quadri nessun elemento è in vera grandezza e l’asse visivo è sempre rigorosamente orizzontale, nelle quadrature molti ele-menti sono in vera grandezza e l’asse visivo è verticale. Date le dimensioni in genere grandiose, l’osservatore, che deve osservare a testa in su, è spesso obbligato a cercare muovendosi il punto di vista giusto; una vol-ta trovato, la testa e gli occhi sono liberi di esplora-re lo spazio illusorio, uscendo anche dal campo della rappresentazione prospettica, spaziando in quello della rappresentazione anamorfica 6. Se Vignola si preoccupa dell’osservatore fermo e agisce sul punto di distanza per consentire un’accettabile prospettiva, Padre Poz-zo, con diversa opinione, ritiene che il problema delle aberrazioni eccessive sia un falso problema:
« […] Essendo il punto di distanza poco lontano da quello dell’occhio, il disegno si stende assai, e non ha bella apparenza. Nondimeno provatevi a guardarlo dalla sua di-stanza EO, e sarà svanita ogni deformità. Se volete gabbare la gente semplice, havendo a dipingere Opere con distanza troppo corta, farete due disegni; uno per mostrare a tutti; e in questo il punto della distanza mettetelo lontano da quello dell’occhio quanto è necessario per fuggire ogni deformità. Dell’altro disegno servitevene di nascosto nel fare il vostro lavoro...» (Pozzo 2003).
Essendo l’osservatore nel punto di vista quando guarda la quadratura, le deformità svaniscono, come dice Pozzo e dimostrano anche gli studi recenti 7, ma affiorano quando si guarda il bozzetto, essendo diffi-cile trovarsi esattamente nel punto 8. Anche Benucci considera ininfluente il movimento degli occhi e della testa, il che ci dimostra dipingendo le testate usando la distanza reale (quella dell’osservatore in piedi), ma per lui il cono visivo assume un’altra valenza nella parte centrale, innovativa rispetto alle precedenti. Per capire meglio le sue intenzioni, di grande aiuto si è rivelato il disegno preparatorio per la quadratura.
Analisi del disegnoIl disegno preparatorio 9 è fatto in una scala 1:30,
in cui 2 soldi corrispondono a 3 braccia, e fa capire che la misura ha un ruolo importante nella costruzione prospettica. Anche se le misure in prospettiva sono de-gradate, avendo il canocchiale dei rapporti già descritti prima (1:3 e 2:3), si possono facilmente disegnare gli elementi in prospettiva senza ricorrere ai punti di fuga. I numeri che formano le scatole nel disegno sono an-cora più puliti di quelli rintracciabili nella quadratura, e sono 9x27 e 6x18 braccia al vero, corrispondenti a 6x18 e 4x12 soldi in scala (Figg. 7-9).
Il bozzetto è diviso in quattro parti con quattro solu-zioni diverse (Tav. XIV). La quadratura usa elementi di ognuna, ma lo schema geometrico adottato è quello della parte superiore sinistra del disegno. Nella parte centrale del bozzetto, in corrispondenza dell’asse trasversale, è visibile una colonna; invece nella quadratura, un grande stemma occupa lo spazio centrale, che si allarga per fa-vorire la scena sul fondo. Nel bozzetto tutti gli elementi verticali convergono nel centro; nella quadratura le co-lonne prossime al centro, traslate con la loro forma geo-metrica dal bozzetto, risulterebbero incongrue. Questa parte diventa una prospettiva a sé stante (Figg. 5, 10), da guardare da diverso punto di vista.
Le prospettive della zona centrale
L’analisi comparativa tra il disegno e il bozzetto, fa vedere che le parti fuori dal cono visivo, quali le balco-nate con i timpani sui lati corti, corrispondono a quel-le del bozzetto, mentre quelle sui bordi dei lati lunghi, vicine all’osservatore, non corrispondono. L’artista non cerca gli accorgimenti per gli elementi che stanno fuori dal cono visivo, perchè sa che questi non creano inconve-nienti stando l’osservatore nel punto di vista e inclinando la testa (e, più lontani siamo, più è comoda la posizione della testa); invece quelli dentro il cono ci costringono a stare con la testa eccessivamente in su (posizione scomo-da). È li che incontriamo una cosa veramente innovativa, perché arretrando la parte centrale anche del primo li-vello del loggiato, le colonne diventano meno nascoste e, viste dal centro, sembrano venirci adosso.
Quindi invitando lo spettatore ad allontanarsi, a non stare in questa posizione scomoda, e ora anche sgradevo-le, l’autore ci racconta il suo concetto dello spazio. Esso
— 63 —
La Quadratura di Ognissanti
7. I cannocchiali prospettici individuati sul disegno (i cerchi rappresentano i rapporti particolari tra vari elementi)
8. (A sinistra) Lo schema geometrico per la costruzione del cannocchiale, la base sul quadro misura 9 x 27, quando raggiunge l’altezza massima di 12 (metà della distanza dell’osservatore) digrada in 6 x 18
9. (A destra) Griglia in scala 1:30 e in vera grandezza (2 soldi in scala sono 3 braccia dal vero)
10. L’analisi comparativa tra il disegno e la quadratura. In basso: la quadratura con lo suo schema geometrico, In alto: Il bozzetto con lo
— 64 —
Nevena Radojevic
non è la semplice riproduzione su un piano dell’ambien-te tridimensionale immaginario, secondo le leggi della prospettiva scientifica, che permettono di riprodurre in modo illusorio la terza dimensione sul piano bidimen-sionale. Il tema è sviluppato sulla base di accorgimenti geometrici che vanno a cercare le situazioni limite nelle
quali la percezione dello spazio è incerta, ambigua, e gli elementi che lo popolano sono oggetti impossibili. Lo spa-zio assume un valore scenografico, e l’architettura, cor-nice parlante di un’azione drammatica, invita il pubblico a girare intorno al tema centrale del trionfo, per vedere i volti degli eroi rivolti in varia direzione.
1 Archivio Ognissanti, Ricordi del convento. Memoria della nuova stoia fatta in questa nostra chiesa d’Ognissanti di Firenze l’Anno 1769, parte I, cap. XIII.
2 Per gli approfondimenti sugli schemi geometrici di apparati illusionistici Rinascimentali si veda L. Carlevaris, La Sala Clemen-tina: La costruzione pittorica delle pareti dallo schema compositivo alla griglia prospettica, in «Bollettino dei Musei Vaticani», XXI, Tipogra-fia Vaticana, Vaticano, 2001, pp. 319-362.
3 Il piano della stuoia rappresenta il quadro prospettico.4 Un braccio è la misura dell’aggetto massimo dell’ordine ar-
chitettonico dal piano del muro.5 Ancora oggi, con il termine prospettiva si intende la parte
di una proiezione centrale limitata dal cono visivo di 60⁰.6 La rappresentazione anamorfica piana è una proiezione cen-
trale (in questo caso il centro è proprio) con l’asse visivo in po-
sizione generica rispetto al quadro. Una proiezione centrale (con
l’asse perpendicolare al quadro), quando esce dal cono visivo di-
venta una proiezione anamorfica e l’osservatore deve inclinare la
testa per vederla. 7 Vedi il saggio di R. Migliari, Ha la prospettiva un futuro (Has
man a future?), Iknos – Analisi grafica e storia della rappresentazio-
ne, Siracusa, Lombardi editori, 2005, pp. 153-156.8 Essendo il bozzetto un disegno in scala, la posizione che l’os-
servatore prende istintivamente è quella che gli permette di com-
prenderlo tutto, la quale e diversa dal punto di vista privilegiato. 9 La scansione del disegno preparatorio, che fa parte di una
collezione privata, e stato messo a disposizione dalla National Ga-
lery di Washington, dove ha fatto la parte della mostra Six Centuries
of prints and drawings: Recent aquisitions nel 2005.
Note
Argan 1983D.C. Argan, Storia dell’Arte Italiana, Sansoni, Firenze, vol. 3
Bartoli-Fossi 2006M.T. Bartoli-E. Fossi, Quadraturismo: le tre graticole di Padre Pozzo e il soffitto di Santa Maria Maddalena dei Pazzi a Firenze, in F. Farneti-D. Lenzi 2006, pp. 61-74
Carlevaris 2001L. Carlevaris, La Sala Clementina: La costruzione pittorica delle pareti dallo schema compositivo alla griglia prospettica, in «Bollettino dei Musei Vaticani», XXI, Tipografia Vaticana, Vaticano, pp. 319-362
Pozzo 2003A. Pozzo, Prospettiva de’ Pittori e Architetti, a cura di M.W. Casotti, Trieste, Italo Svevo, 2003, t. I
Danti 1583E. Danti, Le due regole di prospettiva pratica da Vignola, Roma
Farneti-Lenzi 2006F. Farneti-D. Lenzi, Realtà e illusione nell’architettura dipinta – Quadraturismo e grande decorazione nella pittura di età barocca, Firenze, Allinea editrice
Migliari 2005R. Migliari, Ha la prospettiva un futuro (Has man a future?), Iknos – Analisi grafica e storia della rappresentazione, Siracusa, Lombardi editori
LA Costruzione 1999La costruzione dell’architettura illusoria, a cura di R. Migliari, con i contributi di L. Carlevaris, A. Casale, L. De Carlo, M. Docci et al., Roma, Gangemi editore
De Castro Y Velasco 1797P. De Castro Y Velasco, El Museo pictórico y escala óptica : práctica de la pintura, en que se trata del modo de pintar a el olio, Madrid, t. II, LAM. 10
Troili 1683G. Troili, Paradossi per praticare la prospettiva senza saperla, fiori, per facilitare l’intelligenza, frutti per non operare alla cieca, Bologna, Gioseffo Longhi
BiBliografia
Il rilievo della chiesa di Ognissanti è stato compiuto come esercitazione didattica nei Corsi di Rilievo dell’Architettura da me tenuti, negli anni dal 2008 al 2011. Il lavoro è stato condotto secondo i metodi del rilievo integrato, ovvero con gli strumenti e le metodiche che le attuali tecnologie hanno messo a disposizione e consacrato, sia per la fase di prelievo metrico che per la restituzione, in formato digitale.
Oltre che dalla titolare del corso, gli studenti sono stati seguiti con particolare continuità e autorevole e fattiva collaborazione dai cultori architetti Marilena Fanigliulo e Marco Nardini (2008) e dai dottorandi Erica Ganghereti e Stefano Giannetti (2011). L’architetto Alessandra Bossi ha offerto nel tempo il suo esperto consiglio. Agli studenti va riconosciuta una speciale generosità d’impegno, anche oltre la richiesta meramente didattica, la cui ragione è da attribuire anche ad una sorta di empatia scaturita nel rapporto con la Chiesa e con i Padri che con pazienza ne hanno sopportato negli anni le esuberanze.
Un particolare ruolo ha avuto l’arch. Mauro Giannini, responsabile, al tempo in cui si è svolto il lavoro, del laboratorio di rilievo del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura. Egli ha introdotto sia gli studenti che i collaboratori nelle logiche del rilievo strumen-tale con stazione totale, che ha permesso di definire con certezza figure e misure anche delle parti inaccessibili (esterni del campanile e della facciata) e di coordinare i lavori dei gruppi; in particolare ha permesso alla dottoranda Nevena Radojevic di ricostruire dalle foto di Stefano Giannetti il fotopiano della quadratura, e di metterla in relazione con la pianta della chiesa, rendendone possibile lo studio e le conclusioni descritte nel testo.
Considero questa esperienza come una esemplare occasione didattica, svoltasi attraverso una esercitazione che ha impegnato stu-denti, collaboratori e docente nella produzione di un risultato la cui validità e utilità sono state sottoposte a verifica. Nel corso del rilie-vo, hanno preso avvio nella chiesa lavori di straordinaria manutenzione (condotti dall’impresa Fagioli e Cappelli, tecnico degli impianti il Sig. Ferruccio Dall’Armi). Il progettista e direttore dei lavori, architetto Ugo Muccini, avendo visto il nostro rilievo e ritenendolo utile integrazione dei dati di riferimento del progetto, ce lo ha richiesto e volentieri ne abbiamo dato copia, ritenendo tale richiesta un segno di apprezzamento e la nostra consegna un dovere verso il convento che ci ha pazientemente sopportato nel corso degli anni 1. (M.T.B.)
1 Si ringrazia Padre Serafino Lanzetta, parroco di Ognissanti, per il contributo offerto al Dipartimento di Architettura d.s.p., di uno strumento Disto 3D, che porterà vantaggi futuri alla didattica dei corsi di Rilievo.
A chiesaB torre campanariaC chiostroD refettorioE sacrestiaF convento attualeG ex chiesa dei terziariH cappella di S. Pietro D’Alcantara
Piazza Ognissanti
Cappella dei caduti
Tav. I. Foto satellitare, planimetria dell’area
Tav. II. Pianta del convento attuale, scala 1:500
Tav. III. Pianta della chiesa, scala 1:275
Tav. IV. Sezione longitudinale verso Ovest, scala 1:250
Tav. V. Sezione longitudinale verso Est, scala 1:250
Tav. VI. Sezione trasversale verso Nord, scala 1:275
Tav. VII. Sezione trasversale verso Sud, scala 1:275
Tav. VIII. Controfacciata, scala 1:100
Tav. IX. Controfacciata, fotopiano, scala 1:100
Tav. X. Cappella di San Pietro d’Alcantara, scala 1:1,333
Tav. XI. Prospetto sulla piazza, scala 1:200
Tav. XII. Ortofotopiano del prospetto, scala 1:100
Tav. XIII. Prospetto con la torre campanaria e gli edifici contigui, scala 1:300
Tav. XIV. Giuseppe Benucci, disegno preparatorio per la quadratura (National Gallery of Washington), scala 1:6,666
Tav. XV. Fotopiano della quadratura, scala 1:200
Tavolea cura di Nevena Radojevic
Sezione sul transetto laterale destro con vista della cappella di San Pietro d’AlcantaraB-B’, rapp.: 1:1,333
Sezione sul transetto laterale destro con vista della cappella di San Pietro d’AlcantaraB-B’
Tav. X. Cappella di San Pietro d’Alcantara, scala 1:1,333
Pianta e sezione, rapp. 1:200
Tav.
XIV
. Giu
sepp
e Be
nucc
i, di
segn
o pr
epar
ator
io p
er la
qua
drat
ura
(rip
rodu
zion
e co
nsen
tita
da N
atio
nal G
alle
ry o
f W
ashi
ngto
n, c
ontr
atto
CT
11-0
677
del 1
0/06
/201
1), s
cala
1:6
,666