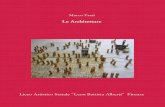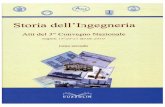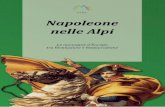Nuove acquisizioni sulla chiesa di San Francesco di Paola: Pietro Bianchi e gli architetti...
Transcript of Nuove acquisizioni sulla chiesa di San Francesco di Paola: Pietro Bianchi e gli architetti...
architetture e territorionell’Italia meridionale tra XVI e XX secoloScritti in onore di Giancarlo Alisio
electa napoli
Un omaggio doveroso a Giancarlo Alisio,protagonista militante e autore, nel corso di circa quarant’anni, di ricerche fondamentaliper l’interpretazione delle vicendearchitettoniche e urbanistiche non solonapoletane, collezionista appassionato e generoso di una raccolta di testimonianzeinestimabili, cartografia, vedute, stampe,donate infine alla sua città di adozione.Traendo spunto dai suoi interessi scientifici, un concerto a più voci di docenti della Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II delinea un percorso articolato, denso, lungo tutto il fronte della storiadell'architettura del Mezzogiorno in etàmoderna e contemporanea, con particolareriferimento a Napoli e alla Campania.Tre sezioni – i luoghi, le architetture, i protagonisti – indagano a fondo letrasformazioni del territorio e della cultura di progetto, senza trascurare problematicheessenziali quali le metodologie dellaconservazione, della valorizzazione e delrestauro dei beni architettonici.
ISBN 88-510-0234-7
9 7 8 8 8 5 1 0 0 2 3 4 3 €25
,00
BB
architetturee
territorionell’Italia
meridionale
traX
VI
eX
Xsecolo
a cura di Maria Raffaela Pessolano e Alfredo Buccaro
electa napoli
architetture e territorionell’Italia meridionale tra XVI e XX secoloScritti in onore di Giancarlo Alisio
a cura di Maria Raffaela Pessolano e Alfredo Buccaro
9 PresentazioneStella Casiello
11 Un simbolico omaggioBenedetto Gravagnuolo
Luoghi
15 Priorità delle difese e problemi di Napoli nel XVI secoloMaria Raffaela Pessolano
25 Aspetti del vedutismo nella collezione AlisioCesare de Seta
29 Scorci di architettura e urbanistica napoletana nella raccolta AlisioGiulio Pane
42 «Napoli d’oggi» (1900)Renato De Fusco
49 Il «Real Passeggio» di Chiaia in una planimetria inedita del 1905Francesco Starace
65 Grandi e piccole storie sulla GaiolaGabriella D’Amato
73 Un inedito disegno dell’isola di ProcidaFrancesco Divenuto
80 Capri nella raffigurazione pittorica dell’OttocentoAntonella Basilico Pisaturo
Sommario
Electa Napoli
redazioneAngela Catello
graphic designPaolo Altieri
art directorEnrica D’Aguanno
graficaRosalba Pagliocca
in copertinaKarl Wilhelm Götzloff,Veduta di Napoli da una masseriasita lungo la Salita del Vomero,anni Trenta del XIX secolo.Particolare. Roma,collezione privata
Stampato in Italia© copyright 2004 byelecta napoli srlGruppo Mondadori Electa s.p.a.Tutti i diritti riservati
Referenze fotograficheMelo Minella, pp. 103, 124Massimo Velo, pp. 210, 213 (a sinistra)
Il volume è stato stampato con il contributo del Dipartimentodi Storia dell’architettura e Restauro dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
256 L’edizione napoletana di Del modo tenuto in trasferire l’obelisco vaticano…e Domenico Fontana a NapoliVincenzo Fontana
264 Un diario napoletanoMaria Luisa Scalvini
271 I ‘ritratti di città’ di Johannes Wilhelm Baur nelle incisioni di Melchior KüsellLuciana Di Lernia
285 Roma e Napoli nella formazione degli architetti siciliani tra XVIII e XIX secoloMaria Giuffrè
299 Vincenzo Ruffo e le teorie dell’architettura nella Napoli del XVIII secoloBenedetto Gravagnuolo
306 L’architetto del Risanamento: Piero Paolo QuagliaFabio Mangone
314 Il Politecnico di Milano e i ponti in ferro di Alfredo CottrauOrnella Selvafolta
329 Contributi al dibattito sul restauro negli anni TrentaAldo Aveta
345 Giancarlo Alisio: profilo bio-bibliograficoSalvatore Di Liello, Fabrizio Mautone, Pasquale Rossi
7
85 Da «meschina città» a città «numerosa e culta». Salerno nella prima metà del XIX secoloMaria Perone
113 Inediti disegni calabresi della prima metà dell’OttocentoGregorio E. Rubino
Architetture
125 I palazzi del potere nella prima metà del Seicento a SiracusaMarco Rosario Nobile
134 La pianta del Castello d’Ischia di Michelangelo del GaizoIlia Delizia
147 Il tempio di Carlo: la chiesa dei SS. Giovanni e Teresa all’Arco MirelliGiosi Amirante
165 Nuove acquisizioni sulla chiesa di San Francesco di Paola: Pietro Bianchi e gli architetti napoletani della RestaurazioneAlfredo Buccaro
177 La villa Pietracatella al VomeroLeonardo Di Mauro
191 Lo spettacolo dell’‘Architettura’Anna Giannetti
201 Restauri dell’Ottocento nella Cappella PontanoStella Casiello
211 L’eliminazione del ‘barocco mantello’ in chiese medievali: il caso di San Pietro a Maiella in NapoliRenata Picone
229 Il ponte di Atrani e la metamorfosi ottocentesca del litorale urbanoGiuseppe Fiengo
Protagonisti
241 «Intención y motivos»: l’opera di Pyrrus Aloysius Scrivà, architetto militare di Carlo V negli anni Trenta del XVI secoloDaniela del Pesco
6
I rapporti tra Pietro Bianchi, progettista della fabbrica di San Francesco di Paola, e l’am-biente napoletano si rivelarono, sin da principio, assai difficili e condizionati dal modostesso in cui fu attribuito l’incarico di una delle più importanti opere di architettura pro-mosse nella città preunitaria. In questo contributo tenteremo innanzitutto di porre inevidenza lo smacco subìto dalle istituzioni e dalla classe professionale della capitale nel-l’epilogo della vicenda relativa al tempio, per poi analizzarne le conseguenze; il che vale adire da un lato far luce sull’esclusione di Bianchi da qualunque incarico nel campo delleopere pubbliche che non fosse di diretta pertinenza di Corte, dall’altro comprendere lediversità ‘linguistiche’ tra il luganese e i protagonisti dei programmi architettonici deiBorbone nel successivo ventennio.Le specifiche competenze affidate al Bianchi come architetto di Casa Reale a partire dal1822 e poi come architetto archeologo direttore degli scavi di Pompei1 non giustificanola sua assoluta assenza dagli altri ambiti della produzione architettonica: ad esempio ilNiccolini, toscano e anch’egli architetto di Corte, non solo parteciperà attivamente allaprogrammazione degli interventi da eseguirsi in città, entrando a far parte nel 1839 dellamassima istituzione napoletana in materia di architettura e urbanistica, ma sarà autore dinumerose opere di committenza privata2. Inoltre, dal punto di vista strettamente archi-tettonico, la chiesa eseguita dal Bianchi, oltre ad essere oggetto di accese critiche, risultòsin dal suo concepimento in aperto contrasto con le scelte formali e compositive che an-davano maturando a Napoli nell’ambito del dibattito – tra i più vivi e interessanti del pa-norama italiano – sulle nuove architetture della città.Le vicende del primo e del secondo concorso per la sistemazione del Largo di Palazzo so-no, in generale, ben note3: in questa sede, sulla base di nuovi elementi, porremo in eviden-za alcuni aspetti relativi al ruolo svolto nell’occasione dalle istituzioni operanti nel settoredelle opere pubbliche, a partire dall’avvio dei lavori per il Foro Murat nel 1810 sino all’e-sito delle discussioni per l’attribuzione dell’incarico della chiesa; vicende, queste, che tra-valicano l’opera specifica per riflettersi sull’intera esperienza napoletana di Bianchi.A norma del decreto del 28 febbraio 1809 e del bando di concorso del 14 marzo succes-sivo, l’esame dei progetti per la costruzione del «Foro San Gioacchino» – un edificio daintendersi, a dispetto del nome, in chiave esclusivamente laica, per la cui esecuzione eraprevista la demolizione delle chiese esistenti nel Largo di Palazzo – e il controllo stessodella sua realizzazione erano stati affidati al sindaco Filangieri, «Commissario» dell’opera,
165
Nuove acquisizioni sulla chiesa di San Francesco di Paola:Pietro Bianchi e gli architetti napoletani della RestaurazioneAlfredo Buccaro
164
Giuliano de FazioSchizzo di progetto per la chiesa di San Francesco di Paola, 1816.Napoli, Archivio di Stato
Giuliano de FazioProgetto di concorso per la chiesa di San Francesco di Paola, 1816.Pianta.Lugano, Archivio Comunale
167
nonché ad una commissione di esperti del Consiglio degli Edifici Civili4. Fu decisivo ilgiudizio del Consiglio nella scelta e successiva modifica del progetto vincitore di Leopol-do Laperuta, venendo ordinato nel 1810 che «il primo Architetto di Corte Sig.r Antoniode Simone sia primo Direttore ed Ispettore, e l’autore del miglior progetto Sig.r Leopol-do Laperuta sia anche Egli Direttore di quest’opera insieme con de Simone»5. Dunqueappare chiaro come l’incarico affidato al de Simone, che era anche autorevole membrodel Consiglio, rappresentasse il suggello di una politica che vedeva quest’ultimo organoimpegnato sin dalla sua istituzione nella diretta gestione di tutte le opere promosse daifrancesi nella capitale6.Nelle varie soluzioni presentate al Murat gli architetti incaricati prospettarono la possibi-lità di realizzare un portico semicircolare con colonnato dorico e botteghe superiori e, alcentro, un edificio pubblico dalla destinazione non ancora specificata7. Due dei tre mem-bri della commissione all’uopo nominata dal sovrano – Luigi Malesci e Francesco Maresca– furono ancora una volta scelti in seno al Consiglio8: nelle considerazioni finali, pubbli-cate a stampa nel 18129, i commissari prospettarono la creazione di una piazza definitasul fronte occidentale da un emiciclo colonnato e ornata con le statue di Napoleone e diMurat; per la prima volta, inoltre, fu deciso che al centro dell’esedra trovasse posto unPantheon da destinare alle assemblee pubbliche, mentre nelle ali si sarebbero ricavate saleper un museo di arti, scienze e tecnica, nonché per l’esposizione temporanea dei prodottidell’industria nazionale10. Con decreto del 17 settembre 1812 Murat approvò il progettodefinitivo di de Simone e Laperuta11, modificato sulla base delle suddette disposizioni,mentre con il «Regolamento per la costruzione della Gran Piazza San Gioacchino» del 29ottobre successivo furono confermati quali «ingegneri direttori» gli stessi architetti12.Con la caduta di Murat i lavori furono sospesi e nel giugno 1815, come sappiamo, il pro-gramma fu trasformato da Ferdinando I nell’edificazione di un tempio da dedicarsi a SanFrancesco di Paola: il Consiglio ribadì anche in questo caso la propria preferenza per ilmodello del Pantheon, del diametro maggiore che fosse possibile, incaricando di nuovoLaperuta e de Simone di elaborare un disegno che servisse come base per un ulterioreconcorso d’idee13; le tavole di progetto furono incise in rame e allegate al bando del 6 set-tembre 181514.La commissione incaricata dal Consiglio dell’esame delle proposte fu la stessa che si eraoccupata del primo concorso: da ciò si comprende come, inizialmente, il mutamento delprogramma non escludesse per il sovrano la conferma dei funzionari già preposti al con-trollo dell’intervento. Nel marzo 1816 questi ultimi individuarono i tre migliori elaboratinei disegni di Giuliano de Fazio, di Laperuta e di de Simone-Laperuta, stilandone uncompendio e apportandovi alcune modifiche; il de Simone si affrettò allora a correggereil proprio progetto sulla base di tali osservazioni, ma non sortì altro effetto che quello diporsi in contrasto con la commissione15. Due mesi più tardi il Consiglio rese nota la pro-pria scelta definitiva del progetto di de Fazio16: ciò rappresentò un segno di scarsa consi-derazione nei riguardi di de Simone e Laperuta, che sino ad allora avevano diligentemen-te condotto i lavori per le fondazioni dell’esedra e per il nuovo palazzo sul lato setten-trionale della piazza17. Ma, oltre agli ostacoli posti dall’ostruzionismo del ministro Tom-masi nei confronti delle scelte del Consiglio18, una svolta fu data alla vicenda dal coinvol-
166
Giuliano de FazioProgetto di concorso per la chiesa di San Francesco di Paola, 1816.Prospetto.Lugano, Archivio Comunale
Antonio NiccoliniProgetto di concorso per la chiesa di San Francesco di Paola, 1816.Sezione longitudinale.Napoli, Museo Nazionale di San Martino
169
gimento del Canova da parte del sovrano: nell’agosto 1816 giunse a Napoli il Bianchi,raccomandato dallo scultore19. Nello stesso tempo Ferdinando decise di escludere il Con-siglio da ogni ulteriore ingerenza nel controllo dell’opera, che venne invece affidato aduna commissione significativamente priva di tecnici, presieduta dal duca d’Ascoli, mentrede Simone restò incaricato del solo completamento del palazzo della Foresteria e di alcu-ni lavori di consolidamento delle fabbriche eseguite; va peraltro sottolineato come a talidecisioni si accompagnasse addirittura lo scioglimento del Consiglio20. Un forte sospettoviene avanzato dal Sasso proprio riguardo alla concomitanza di ciò con la chiamata diBianchi: «non conosco – osserva lo storico filoborbonico – per quale motivo venisse ritar-dato il rapporto [della commissione] al Re, e per qual motivo venisse sciolto il Consigliodegli Edifizi Civili, di modo che la M.S. di moto proprio ne domandava conto al ministroTommasi, al quale pe’ Regi comandi fu forza presentare i disegni, ma non la decisione»21.Nel gennaio 1817 il collegio verrà effettivamente sostituito dalla Giunta di Fortifica-zione22: al di là della specifica contingenza, per cui l’iniziativa si tradusse in un autenticocolpo di mano, essa è da inquadrare nell’ambito della politica della Restaurazione, allor-ché furono sciolte le principali istituzioni introdotte dai francesi, per poi essere ricompo-ste sotto diverso nome; la stessa sorte toccò, ad esempio, al Corpo di Ponti e Strade23.Abbiamo già notato come l’intervento di Bianchi si ponesse in contrasto con l’ambientelocale anche riguardo alle scelte architettoniche: ciò si rileva, ad esempio, da un confron-to tra le considerazioni espresse da de Fazio nelle relazioni che egli presentò al Consiglioin aggiunta al proprio progetto24 e i principi sostenuti dal luganese. De Fazio, architetto-ingegnere, anch’egli membro del Consiglio degli Edifici Civili e ingegnere in capo delCorpo di Ponti e Strade25, nei suoi scritti mostra di aderire con decisione agli idealidell’«architettura rivoluzionaria», scegliendo come tema ispiratore il concetto di ‘sublime’e riferendosi per esso agli scritti di Burke26. Così egli ‘purifica’, per così dire, i ‘difetti’ delmodello del Pantheon introducendo all’interno dell’aula una peristasi ininterrotta e ricor-rendo ad una controvolta per fare a meno dei piloni; il colonnato è per de Fazio simbolodi bellezza e di varietà: il ‘sublime’ è infatti basato, oltre che sulla ‘vastità’ (o grandezzareale), sulla ‘successione’ e ‘uniformità’ di parti semplici ed eleganti, che diano impressio-ne di continuare al di là dei loro limiti effettivi, con un adeguato uso del colore27. E anco-ra: «Il sublime in Architettura non si ottiene che per l’accozzamento di parti di grandi di-mensioni, disposte in modo che ne risulti un tutto, la cui vastità, e grandezza apparentesuperi di gran lunga la reale; per cui l’immaginazione dello spettatore resti distolta dalravvisarne i limiti, e si trovi quasi trasportata nell’infinito»28. Vengono subito in mente learchitetture ideate da Boullée: non solo l’insieme deve avere dimensioni enormi, ma an-che le singole parti, che devono essere disposte «in modo che ne risulti un tutto, che illu-da»29. Interessante lo schizzo che de Fazio allega ad una di queste memorie30, in cui si no-ta come egli esasperi l’accostamento della concavità dell’esedra con la convessità della ro-tonda, senza più alcun elemento di mediazione.Le considerazioni di de Fazio dimostrano quanto l’ambiente napoletano fosse aggiornatocirca le tendenze che da alcuni decenni si andavano diffondendo nel più ampio dibattitoeuropeo; come vedremo, si trattava di principî destinati a dar vita a uno stile maturo nelleopere della Restaurazione. Se ora esaminiamo le «Osservazioni» di Bianchi sui progetti fi-
168
Giuseppe GiordanoProgetto per la chiesa di SanFrancesco di Paola, 1816. Piantadel tempio con la sistemazionedelle strade adiacenti.Napoli, Museo Nazionale di San Martino
Giuseppe GiordanoProgetto per la chiesa di San Francesco di Paola, 1816.Prospetto generale.Napoli, Museo Nazionale di San Martino
171
nalisti del concorso31, esse ci appariranno retrograde e, per così dire, ‘reazionarie’: a di-spetto di una tendenza all’autonomia e alla giustapposizione di puri volumi che chiara-mente emergeva in quegli elaborati, per Bianchi era invece da individuarsi in essi una ca-sualità nell’accostamento delle parti, che risultavano tra loro slegate, contro i concetti tra-dizionali di unità, concatenazione e armonia. A suo parere, seguendosi il verdetto dellacommissione, la chiesa sarebbe risultata subordinata alle ali dell’esedra, che invece avreb-bero dovuto essere secondarie e segnare un mero accesso al tempio; sarebbe stato inoltreindispensabile, secondo l’architetto, un «antitempio» come elemento di mediazione attoad annunziare la chiesa. La tangenza tra portico e rotonda, proposta da de Fazio, era con-traria alle regole della buona architettura, mentre le cappelle da lui previste nel muro ci-lindrico avrebbero deformato la chiesa sia in pianta che in alzato. Il colonnato, infine, siopponeva al criterio della solidità ed era troppo basso rispetto al diametro del cilindro.Nel «Rapporto» allegato al proprio progetto32, Bianchi passa quindi ad indicare come rag-giungere l’unità con una molteplicità di elementi (chiesa, congregazioni, sagrestia, coro):in alzato la cupola, dotata dall’architetto di maggiore altezza rispetto agli altri progettisti,nonché di estradosso a gradoni, avrebbe dato vita, con le cupolette delle congregazioni,ad una «scala di degradazione» atta ad esaltare la gerarchia e l’unione delle parti33. Taleconcezione classicistica dell’architettura è rafforzata dalla scelta della successione oriz-zontale degli ordini – dal dorico del colonnato al corinzio della chiesa – e dall’adozione dirapporti proporzionali tra i vari elementi del complesso, sia in pianta che in alzato. Dun-que, se da un lato Bianchi mostra di rinunciare all’integrazione fisica delle parti e all’usodel linguaggio degli ordini come sintassi o grammatica dell’architettura, dall’altro optaancora per una combinazione «graduata» – per dirla con Kaufmann34 – degli elementi les-sicali e tipologici tratti dal mondo classico: i colonnati dell’esedra, da considerarsi ‘acces-sori’, l’imponente pronao, quale ‘invito’ al tempio, infine le cupolette, più alte del portica-to ma più basse della rotonda. In tal senso l’architetto non coglie la lezione di Valadier (dicui era stato stretto collaboratore a Roma), indiscusso maestro nel libero accostamento diforme spaziali semplici e nella scomposizione piranesiana dell’oggetto architettonico.Vale la pena qui di osservare per inciso che, se tanto premeva a Bianchi il principio del-l’unità, e soprattutto la gradazione tipica del ‘sistema’ rinascimentale e barocco, non sicomprende perché egli non abbandonasse del tutto l’idea della rotonda. Nel bando diconcorso, del resto, si prevedeva la possibilità che i concorrenti si discostassero dalla pro-posta-base, come fecero ad esempio Niccolini e Valente, optando per schemi neorinasci-mentali, nella fattispecie michelangioleschi o palladiani35: insomma Bianchi, nel momen-to stesso in cui criticava la cattiva interpretazione del modello romano, non sapeva farmeglio che proporne la fredda imitazione e, soprattutto, l’inserimento in un contesto taleda mortificarne la purezza.Tra i molti giudizi negativi espressi sulla fabbrica, particolarmente interessante è quello diSchinkel. Nel suo Reisen nach Italien36, l’architetto tedesco descrive la propria visita all’o-pera di San Francesco di Paola nel 1824: «Il signor Bianchi mi condusse in giro per la suanuova chiesa ove c’era qualche bella costruzione; l’impalcatura della cupola è costruita inmodo lieve e ingegnoso, con una larga apertura interna in cui i materiali vengono tirati inalto. Per il resto, nel progetto egli oscilla continuamente tra l’antico e il moderno, dando
170
Pietro BianchiVeduta prospettica della chiesa di San Francesco di Paola, 1824 ca.Lugano, Archivio privato Guidini
vitelli e Fuga. Viceversa, se il sovrano avesse mostrato un minimo di avversione nei con-fronti degli architetti che avevano lavorato con Murat, non li avrebbe certo confermati, dilì a poco, quali membri dei riformati organi di amministrazione e controllo delle operepubbliche, permettendo loro di partecipare alla formulazione ed attuazione dei cospicuiprogrammi per la capitale e per l’intero regno; né, di conseguenza, sarebbero stati confe-riti a Giuliano de Fazio e a Stefano Gasse, i più ‘rivoluzionari’ di essi, praticamente tutti igli incarichi pubblici fino all’inizio del regno di Ferdinando II46.Così a Bianchi, per il quale l’incarico della chiesa sarebbe presto divenuto pesante comeun macigno, non rimasero che committenze di Corte e, dal ’31 in poi, la direzione degliscavi pompeiani: da architetto di Casa Reale egli non riuscirà mai a divenire architetto diregime e resterà sostanzialmente estraneo alle opere pubbliche nell’età della Restaurazio-ne, pur vivendo a Napoli e operando presso la Corte. Ciò spiega come, nell’ambito dell’e-dilizia pubblica nel regno borbonico tra il 1820 ed il ’40, si ritrovi il nome di Bianchi sol-tanto due volte, cioè in occasione dei pareri richiestigli da Ferdinando I, rispettivamentenel 1822 e nel ’23, riguardo al carcere da costruirsi ad Avellino su progetto di de Fazio47 eper la nuova cattedrale di Caserta48. Con particolare riferimento al primo incarico, è dadire che anche in questa occasione il sovrano approvò la variante proposta dal luganese,che sarebbe stata quindi eseguita, se la commissione del Corpo di Ponti e Strade all’uoponominata, ‘sfortunatamente’ composta dallo stesso de Fazio con Malesci e Giordano, nonsi fosse affrettata a far notare la maggiore spesa e gli inconvenienti di carattere funzionaleinsiti nell’idea di Bianchi: il re, onde evitare altri scandali, non poté far altro che ratificareil parere dei commissari.
173
in molti casi l’impressione di una mancanza di carattere». Risulta evidente come Schin-kel, che proprio a quell’epoca adottava il modello romano nell’Altes Museum di Berlino,si riferisca qui non solo alla nozione di caractère diffusa in Francia a partire dalla secondametà del Settecento, intesa come capacità dell’edificio di produrre nell’osservatore un ef-fetto corrispondente al significato e alla funzione architettonica37, ma anche alla mancan-za di coerenza dell’opera e all’evidente compromesso tra l’uso di forme ‘moderne’ eistanze classicistiche.Nulla hanno a che fare i limiti compositivi di Bianchi con l’ottica reazionaria della restau-razione borbonica: anche dopo il 1815 architetti napoletani ‘di regime’ sapranno produr-re opere ‘moderne’, ben dotate di ‘carattere’ ed espressive di tutto il loro significato.Tra gli altri progetti per la chiesa di cui si conoscono gli elaborati un cenno merita quellopresentato da Giuseppe Giordano38 al Tommasi tra la fine del 1816 e il marzo del ’1739.Con chiaro riferimento al progetto finale redatto poco prima dal Bianchi40, ormai in ese-cuzione, il Giordano interpreta in chiave di purezza ‘rivoluzionaria’, senza nulla concede-re alla gradazione e alla concatenazione delle parti, elementi intesi dal luganese in sensoclassicistico: il nudo emisfero della calotta sull’aula cilindrica, il diretto accostamento diquesta con la curva dell’esedra – con chiaro riferimento all’idea di de Fazio –, le due cupo-lette e persino il pronao «antitempio» perderanno nell’opera realizzata la propria autono-mia per divenire parti di un amalgama.I disegni del Giordano furono sottoposti all’esame del ministro in un momento in cui eraancor vivo il clima di polemiche suscitato dalla scelta del Bianchi come progettista dell’o-pera. Lo stesso Giordano criticò il disegno approvato, poiché in esso non era previsto ilcollegamento della piazza con le zone adiacenti e in particolare con Pizzofalcone, che sipoteva raggiungere solo attraverso l’incomoda salita del Grottone: invece, secondo la pro-posta del professionista napoletano, la piazza sarebbe stata messa in comunicazione conla collina mediante due nuove strade che avrebbero rasentato la curva del colonnato, di-scendendo scenograficamente nella piazza; l’esedra, poi, «senza gli avancorpi va a corri-spondere agli angoli de’ due palazzi ed è per questo tutta scoperta alle loro facciate»41.Ma il 19 marzo fu comunicato al Giordano che «S.M. non intende, che sia fatta la meno-ma alterazione al progetto, o disegno di Bianchi»: nel contempo, comunque, il re ordinòall’architetto di Corte di eseguire sollecitamente il collegamento carrozzabile con la stra-da della Solitaria secondo l’idea del Giordano42; inoltre a partire dalla fine dello stesso an-no Bianchi dirigerà i lavori per il nuovo tronco stradale di raccordo tra l’estremità setten-trionale dell’esedra e l’antica strada del Grottone43.Nell’ambiente napoletano qualcosa si doveva certo sapere su come Bianchi avesse otte-nuto da Napoleone il «Gran Pensionato» di Francia nel 1810, se Sasso parla di disegni dalui acquistati a Roma, con cui riuscì ad ottenere il riconoscimento, o su come, ancora conforti raccomandazioni, avesse ottenuto da Pio VII, nel 1814, la nomina a direttore delleAntichità di Roma44. Comunque sia, la maniera in cui Bianchi fu chiamato a dirigere l’o-pera di San Francesco di Paola dovette destare una seria indignazione, non soltanto tra iconcorrenti45. Del resto Ferdinando I avrebbe dovuto aspettarsi una simile reazione,avendo già sperimentato, nella fase settecentesca del suo regno, il difficile rapporto in-stauratosi tra i professionisti locali e la ‘tendenza’ romana già introdotta a Napoli da Van-
172
1 N. Ossanna Cavadini, Pietro Bian-chi: la formazione e le opere e M.Pagano, Pietro Bianchi archeologo:da architetto fiscale a direttore degliscavi di Pompei, contributi inAA.VV., Pietro Bianchi 1787-1849architetto e archeologo, a cura di N.Ossanna Cavadini, Milano 1995.2 A. Venditti, Architettura neoclassi-ca a Napoli, ivi 1961, pp. 235-299.3 C.N. Sasso, Storia dei monumentidi Napoli e degli architetti che liedificavano, Napoli 1856-58, pp.123-146, 217-220; A. Venditti, op.cit., pp. 160-174; E. Catello, Archi-tettura neoclassica a Napoli. La ba-silica di S. Francesco di Paola, in«Napoli nobilissima», XVII, 1977,f.lo III; A. Buccaro, Architetture espazi urbani: i tre Fori napoletani,in «Agorà», n. 4, giugno-luglio 1989,pp. 29-30; S. Villari, La piazza e imercati. Equipement urbano e spa-zio pubblico a Napoli nel decennionapoleonico, in La piazza, la chiesa,il parco. Saggi di storia dell’architet-tura (XV-XIX secolo), a cura di M.Tafuri, Milano 1991, pp. 219-233;
Id., Tra neoclassicismo e restaura-zione: la Chiesa di San Francesco diPaola, in AA.VV., Pietro Bianchi…,cit., pp. 129-137.4 Archivio Storico Municipale diNapoli (d’ora in avanti ASMUN),Opere pubbliche, «Piazza del RealPalazzo», fsc. II (1810-17), docc.vari del 1809. Si veda pure S. Vil-lari, La piazza e i mercati… cit.,pp. 225-226. Il Consiglio degli Edi-fici Civili era stato istituito nel 1806sul modello del Conseil des Bâti-ments parigino, con compiti nel-l’ambito della cura delle operepubbliche e dell’ambiente urbanoanaloghi a quelli della Commissio-ne di Ornato esistente a Milano edella Commissione degli Abbelli-menti di Roma. Il Consiglio avevain effetti sostituito il secolare Tri-bunale della Fortificazione, Acquae Mattonata, venendo ad espletarele funzioni richieste dal nuovo ap-parato tecnico-burocratico intro-dotto, anche in questo campo, daifrancesi: presieduto dall’intenden-te della provincia e formato da die-
ci membri, di cui almeno cinquearchitetti, esso aveva il compito di«discutere tutti gli affari relativi ailavori pubblici, alla costruzione de’mercati, de’ cimiteri, alla forma-zione delle piazze, strade, e tuttociò, che riguarda l’abbellimentodella città, alla costruzione, rifazio-ne, o riattazione di pubblici edi-fizj, ponti o altri pubblici monu-menti». A. Buccaro, Istituzioni e tra-sformazioni urbane nella Napoli del-l’Ottocento, Napoli 1985, pp. 55-58.5 ASMUN, Opere pubbliche, «Piaz-za del Real Palazzo», fsc. II (1810-17), lettera del Ministro dell’Inter-no Zurlo all’Intendente Macedo-nio del 17 maggio 1810.6 Il Laperuta fu, a partire dal1811, docente di Architettura Ci-vile presso la Scuola di Applica-zione degli ingegneri di Ponti eStrade. A. Buccaro, Opere pubbli-che e tipologie urbane nel Mezzo-giorno preunitario, Napoli 1992,pp. 26, 29.7 Laperuta e de Simone prospet-tarono quattro diverse soluzioni,
avrebbero dovuto presentare i pro-pri progetti, corredati di una me-moria esplicativa; il premio sareb-be stato tanto maggiore quantopiù originali ed innovative le pro-poste rispetto al progetto Laperu-ta-de Simone. Si veda pure C.N.Sasso, op. cit., pp. 125-127, e E. Ca-tello, op. cit., pp. 82-83.15 E. Catello, op. cit., pp. 83-88, eS. Villari, Tra neoclassicismo e re-staurazione…, cit., p. 133.16 N. Ossanna Cavadini, op. cit., p.28, e S. Villari, Tra neoclassicismo erestaurazione…, cit., p. 133.17 La costruzione di questo edifi-cio, in principio destinato a sededel Ministero degli Esteri, poi del-la Foresteria, era stata decretatadal Murat con decreto del 4 ago-sto 1812, venendone approvato ilprogetto di Laperuta e de Simoneil 6 ottobre successivo; la fabbricaera stata completata nel 1815.ASMUN, Opere pubbliche, «Piaz-za del Real Palazzo», fsc. III (1810-17), docc. vari degli anni 1812-15;ASNa, Ministero dell’Interno, App.II, fsc. 230, docc. vari; U. Carughi,L. Martorelli, A. Porzio, Il Palazzodella Prefettura, Napoli 1989; S. Vil-lari, La piazza e i mercati…, cit., p.238 (n. 97) e figg. 25-26. A pro-posito del de Simone, all’epoca an-cora unico architetto di Casa Rea-le (N. Ossanna Cavadini, op. cit., p.38, n. 64), citeremo un interessan-te episodio: quando, il 17 giugno1816, si pose la prima pietra dellachiesa, invano si cercò il cassettinodi medaglie commemorative ivideposto all’atto di inaugurare i la-vori del Foro Murat, «non ostantel’aver cavato quel largo in più siti,e che siano i stessi architetti ed ar-tefici che allora vi travagliarono»(C. De Nicola, Diario Napoletano.1798-1825, Napoli 1906, p. 121).In realtà, come si evince da un al-tro documento (ASMUN, Operepubbliche, «Piazza del Real Palaz-zo», fsc. IV [1811-16], lettera delsindaco Filangieri al de Simonedel 12 dicembre 1811), l’architet-to di Corte doveva ben sapere ovefosse finito il cassettino, visto chegli era stato affidato sin dal 1811dal sindaco Filangieri perché lo cu-stodisse quale primo architetto di-rettore (oltre che membro del Con-siglio) in attesa di trovare per essouna definitiva sistemazione al ter-mine delle opere. Il silenzio del de
Simone conferma la lacerazione inatto in seno alle istituzioni prepo-ste, destinata a favorire il repenti-no esito della vicenda.18 S. Villari, Tra neoclassicismo erestaurazione…, cit., p. 133.19 N. Ossanna Cavadini, op. cit.,pp. 28-29, e S. Villari, Tra neoclassi-cismo e restaurazione…, cit., p. 133.20 ASMUN, Opere pubbliche, «Piaz-za del Real Palazzo», fsc. III (1810-17), lettera del ministro Tommasiall’intendente Colaianni del 27 lu-glio 1816 e ivi, fsc. V (1811-16), let-tere dell’intendente al sindaco del16 dicembre 1816 e dell’8 gennaio1817; si veda inoltre ASN, Ministe-ro dell’Interno, App. II, fsc. 1098,doc. del 20 novembre 1816, e fsc.1365, fol. 192.21 C.N. Sasso, op. cit., p. 127.22 A. Buccaro, Istituzioni e trasfor-mazioni urbane…, cit., pp. 57-58.23 Ivi, pp. 27-28.24 ASNa, Ministero dell’Interno,App. II, fsc. 1365, foll. 107-110(s.d.), 111-114 (3 aprile 1816), 130-135 (3 maggio 1816); le relazioni,ovviamente non firmate, si riferi-scono tutte all’elaborato n. 13 delconcorso, che era quello di de Fa-zio. Si veda pure E. Catello, op.cit., p. 86.25 Giuliano de Fazio (1773-1835)sarà membro della Giunta di For-tificazione della città di Napoli dal1817 fino alla morte ed ispettoregenerale del Corpo di Acque eStrade a partire dal ’26. Sulla figu-ra di questo professionista cfr. A.Buccaro, Istituzioni e trasformazioniurbane…, cit., passim, e Id., Operepubbliche e tipologie urbane…, cit.,pp. 27 (nota 23) e passim.26 E. Burke, Ricerca filosofica sul-l’origine delle nostre idee intorno alSublime e al Bello con un discorsosopra il gusto e diverse altre aggiun-te, Milano 1804.27 ASNa, Ministero dell’Interno,App. II, fsc. 1365, foll. 107-110 e113-114. «Il grande, il vasto, il ma-gnifico, fregi principalissimi delbello architettonico, hanno non soqual diritto, anzi un vero dispoticoimpero sull’immaginazione dell’uo-mo» (ivi, fol. 108). Secondo de Fa-zio, gli architetti Laperuta e de Si-mone avevano ben operato nellascelta del modello del Pantheon,che era stato da essi «purgato» deiprincipali difetti, sebbene la ridu-zione del diametro della rotonda
da 178 a 100 palmi venisse a mor-tificare il carattere ‘sublime’ del-l’opera romana.28 Ivi, fol. 130.29 Ivi, fol. 131. Secondo l’architet-to, ricorrendo al peristilio conti-nuo e collocando l’altare al centrodell’aula, si sarebbe assicurata lapercorribilità di quest’ultima sen-za compromettere la continuitàspaziale ed il senso di silenzio esacra solitudine richiesti dalla fun-zione liturgica.30 Ivi, fol. 129.31 Ivi, foll. 167-168, «Osservazionisopra li due Progetti della Chiesada costruirsi in onore di S. France-sco di Paola», cit. in E. Catello, op.cit., p. 85; N. Ossanna Cavadini,op. cit., pp. 28-29; S. Villari, Traneoclassicismo e restaurazione…, cit.,pp. 133-134.32 ASNa, Ministero dell’Interno,App. II, fsc. 1365, foll. 162-166,rapporto di Bianchi al ministroTommasi (22 ottobre 1816), cit.in E. Catello, op. cit., p. 86 e n. 14.33 Per il Bianchi anche la luce, fat-ta penetrare dall’«occhio» centraledella cupola («chiuso con finestro-ni come si è fatto nelle Rotondedei Musei di Roma, Milano e Pari-gi»), avrebbe prodotto «una lucemeravigliosamente degradata».34 E. Kaufmann, L’architettura dell’Il-luminismo, Torino 1981, pp. 93-106.35 C.N. Sasso, op. cit., pp. 135-146e tav. XXVII; A. Venditti, op. cit.,pp. 273-274; E. Catello, op. cit.,pp. 84-85, 87; A. Buccaro, Archi-tetture e spazi urbani…, cit., p. 29;Id., Architettura e urbanistica del-l’Ottocento, in AA.VV., Storia e ci-viltà della Campania. L’Ottocento,a cura di G. Pugliese Carratelli,Napoli 1996, pp. 119, 125.36 K.F. Schinkel, Reisen nach Ita-lien, a cura di G. Riemann, Berlin1979, p. 192; H.-W. Kruft, Storiadelle teorie architettoniche. Dall’Ot-tocento a oggi, Bari 1987, p. 40.37 H.-W. Kruft, Storia delle teoriearchitettoniche. Da Vitruvio al Set-tecento, Bari 1987, p. 186 e sgg.38 Giuseppe Giordano, architettoe ingegnere, fu ispettore del Cor-po di Ponti e Strade e, negli anniTrenta, anche architetto decurionedella città di Napoli. A. Buccaro,Istituzioni e trasformazioni urba-ne…, cit., pp. 100, 178; Id., CarloAfan de Rivera ingegnere e pubblicoamministratore nello Stato borboni-
175
di cui furono realizzati i modelliin legno, così descritti dal sindacoFilangieri: «Il primo rappresentaun foro semicircolare con portico,botteghe al fondo con ammezzatial di sopra, e con salone nel mezzocoverto di un copolino: due rampene’ lati, e la strada rotabile, checonduce al Grottone, tagliata nellaparte sinistra della strada di Chiaia.Il secondo rappresenta un simil fo-ro (…) con due strade carrozzabi-li, dietro il perimetro del portica-to, che al di sopra si uniscono aquella del Grottone. Il terzo figuraun edifizio a due piani per avereun’altezza maggiore, onde masche-rare le case di dietro, irregolari, edi pessima veduta, che ad un di-presso si uguaglia al primo. Il quar-to contiene due rampe carrozzabi-li, che conducono alla strada supe-riore, e con questa idea si ottieneuno spiazzo maggiore avanti il RealPalazzo, dovendosi però costruirenel piano superiore un edificio dibuona forma, adattandosi a quel-l’uso che si stimerà», ASMUN,Opere pubbliche, «Piazza del RealPalazzo», fsc. IV (1811-16), letteraall’intendente del 20 settembre1811. Il 28 dicembre successivo (ivi,rapporto di Laperuta e de Simoneal sindaco) gli architetti, sulla basedelle disposizioni del Consiglio, pre-sentarono un nuovo modello, incui si prevedeva un portico privodi botteghe e di ammezzati, «persemplice passeggio, ornato da nic-chie con statue, e bassorilievi nellaparte superiore, e sostenuto da n.46 colonne di pietra travertino diordine Dorico, ciascuna delle qualiavrà il diametro di pal. 8, e l’altez-za di pal. 60; compresovi il capi-tello, giacché non hanno basi e ciòoltre del corrispondente cornicio-ne; il quale anderà ad uguagliarein altezza la cornice del palazzoabitato da S.A. il Principe Achil-le». Si veda pure sull’argomento S.Villari, La piazza e i mercati…,cit., p. 228.8 Il terzo membro era GioacchinoAvellino, che si dissociò dal giudi-zio della commissione: S. Villari,La piazza e i mercati…, cit., p. 228e sgg. Si veda inoltre ASMUN,Opere pubbliche, «Piazza del RealPalazzo», fsc. IV (1811-16), rap-porto di Malesci e Maresca al Mi-nistro dell’Interno del 25 febbraio1812. I commissari ratificarono l’i-
dea di un’esedra porticata, stabi-lendo però che la struttura non sisarebbe congiunta agli edifici ret-tilinei a nord e a sud della piazza(ossia il palazzo Salerno e il futuropalazzo della Foresteria), onde evi-tare l’eccessiva altezza del basa-mento del colonnato che sarebbederivato dal rispetto del fronte delpalazzo dei Principi.9 Archivio di Stato di Napoli (d’o-ra in avanti ASNa), Ministero del-l’Interno, App. II, fsc. 1087, doc. astampa dal titolo Rapporti relativialla costruzione del foro San Gioac-chino presentati a S.E. il signor mi-nistro dell’interno, Napoli 1812, cit.in S. Villari, La piazza e i merca-ti…, cit., p. 237n.10 ASMUN, Opere pubbliche, «Piaz-za del Real Palazzo», fsc. IV (1811-16), rapporto cit. del 25 febbraio1812.11 Ivi, fsc. II (1810-17), lettera del-l’intendente Canzana al sindacoPrincipe di Belvedere del 6 otto-bre 1812, e ivi, fsc. IV (1811-16),testo del decreto, che agli artt. 1 e2 così recita: «Sarà costrutto nellato occidentale della Gran PiazzaS. Gioacchino un Edifizio semmi-circolare distaccato per palmi cin-quanta da ciascuno degli Edifizi la-terali della piazza, secondo le pian-te annesse al presente decreto. L’e-difizio (…) sarà preceduto da unportico di un solo Ordine corintio,con intercolunio vestito posto sudi una scalinata, il quale si elevi al-la medesima altezza della cornicedell’ultimo piano nobile del Palaz-zo de’ Principi. Le colonne saran-no di pietra travertino della Cavadi Bellona, con basi, e capitelli diMarmo bianco ordinario; sarannoaltresì della stessa pietra travertinoil cornicione, la scalinata sopra cuipoggia questo Edifizio, i pilastri,ed altre parti del medesimo». L’o-pera sarebbe stata finanziata dal-la Real Casa con una somma di264.000 lire mensili.12 Il testo del Regolamento è inASNa, Ministero degli Interni, App.II, fsc. 230. Il cantiere, affidato al-l’appaltatore Bozzaotra, andò avantiassai lentamente, specie per le pa-stoie burocratiche dovute all’intri-cata corrispondenza tra il Consi-glio degli Edifici Civili, la commis-sione suddetta, il sindaco e gli ar-chitetti: ASMUN, Opere pubbli-che, «Piazza del Real Palazzo», fsc.
I (1810-14), docc. vari del 1813,tra cui segnaliamo un’istanza delBozzaotra al sindaco s.d. (maggio1813).13 ASMUN, Opere pubbliche, «Piaz-za del Real Palazzo», fsc. III (1810-17), verbale della sessione del Con-siglio del 12 giugno 1815, e letteradell’intendente Filangieri al sinda-co Principe di Belvedere (27 giu-gno 1815), in cui si legge che il 20giugno il Consiglio aveva deciso di«potersi serbare lo stesso disegnodel porticato adattandovi la roton-da d’un diametro maggiore che siapossibile, anche occupando, se bi-sogna, il Palazzo che trovasi dadietro; che il porticato medesimopuò essere tutto addetto alla chie-sa ed adornato co’ bassi rilievi opitture corrispondenti, escludendole botteghe».14 ASMUN, Opere pubbliche, «Piaz-za del Real Palazzo», fsc. III (1810-17), lettera dell’intendente Filan-gieri al sindaco Principe di Belve-dere del 1 agosto 1815: «S.M. hagradita l’attenzione del Consiglioe la prontezza degli Architetti Si-mone e Laperuta nel formare ilprogetto del Sagro Tempio (…).Vuole nondimeno che prima diadottarlo gli si presentino altreidee sulle seguenti basi: 1°. Che laforma della piazza rimanga giustail disegno attuale. 2°. Che sullefondamenta già costrutte in formadi Semicerchio verso Occidentes’innalzi un edifizio di bella formacon colonne di quell’ordine chemeglio convenga all’idea di ergersinel fondo fuori del Semicerchiomedesimo il Sagro Tempio. 3°. Chele Architetture del Semicerchio edel Tempio sieno del gusto il piùpuro, evitando quelle assurdità al-le quali ripugnino la ragione, e’lbuon senso. L’idea dev’essere gran-diosa fuori ogni meschinità che di-sconvenga alla dignità del SagroArgomento, cui vuol degnamentesoddisfare la pietà del Sovrano».Dunque nessun accenno, stavolta,all’idea del Pantheon. Il sovranostabilì di darsi alle stampe il pro-gramma del concorso e i grafici dirilievo della piazza, con le fabbri-che già esistenti; tali elaborati sa-rebbero stati inviati anche a Ro-ma, «affinché i Professori di quelladominante, e di altre Città d’Italiapossano profittarne (…)». Entro iltermine di due mesi i concorrenti
174
A partire dal 1886 a Roma, con la distruzione e la lottizzazione della splendida villa Lu-dovisi1, ha origine l’omonimo rione il cui asse principale, via Vittorio Veneto – aperto trail 1886 e il 1889 –, si snoda in discesa da Porta Pinciana a piazza Barberini. Ovviamente anulla valgono le proteste e lo sdegno di tanti e di Gregorovius in testa.In quegli stessi anni, a Napoli dalla lottizzazione di una villa meno illustre, ma non menoestesa e paesaggisticamente rilevante, ha origine il nucleo centrale del quartiere Vomero.Si tratta della villa dei Ceva Grimaldi, marchesi di Pietracatella, oggi istituto scolastico«Maria SS. Ausiliatrice». Se però della villa Ludovisi è ben nota la storia e la struttura ar-chitettonica, di quella dei Pietracatella manca una compiuta analisi.Nella storiografia urbana napoletana è frequente il caso che vede intere parti della cittàdiventare oggetto di studio solo quando ha inizio la loro trasformazione moderna; l’inte-resse degli studi è stato tanto concentrato sul nucleo antico del centro storico che solo dapochi anni si è cominciato a indagare sullo sviluppo dei quartieri periferici, mentre intereporzioni e momenti della storia cittadina sono ancora tutti da indagare.Il Vomero, quindi, sembra entrare nella ‘storia’ nel momento in cui ha inizio la lottizza-zione della collina2. A metà del secolo, la grande area pianeggiante alla sommità dell’altu-ra è definita da un numero assai ristretto di grandi ville: quelle del principe di Belvedere,la Floridiana, villa Haas e l’assai meno nota villa Pietracatella3.Grazie al rinvenimento di una inedita perizia del 1884 nell’Archivio di Stato di Napoli,è ora possibile ricostruire lo stato originario precedente la nascita del nuovo rione. L’i-nedito documento è accompagnato da una ‘piantolina’ particolare per ogni singolo pia-no dei quattro fabbricati e da una dettagliata Pianta topografica ed icnografica de’ fondirustici ed urbani del signor Francesco Ceva Grimaldi marchese di Pietracatella4, che resti-tuisce con la minuziosa precisione di un atto giudiziario l’ultima descrizione dell’anticofondo.Il contesto storico-ambientale scaturito dal dilagare del colera nel 1884 e lo stato di con-servata salubrità che condizionano la scelta d’insediare i nuovi quartieri d’espansione suiterreni agricoli circostanti i casali del Vomero e dell’Arenella, com’è noto, sono stati par-ticolarmente approfonditi da Giancarlo Alisio. Lo studio puntuale dei singoli elementiche componevano il fondo antico, unitamente alle conoscenze acquisite sull’interventodel Risanamento, aiutano a mettere in rilievo le emergenze storiche all’interno del tessu-to normalizzato con la lottizzazione, a recuperare l’immagine pre-unitaria della sistema-
177
La villa Pietracatella al VomeroLeonardo Di Mauro
co, in «Rassegna ANIAI», n. 4, ot-tobre-dicembre 1988, p. 17.39 Museo Nazionale di San Marti-no, Piante e Disegni, invv. 6781-6782, s.d., a firma del Giordano,pubbl. in A. Buccaro, Architetture espazi urbani…, cit., pp. 30-31. Igrafici sono così intitolati: «Piantadel Tempio e Portico di San Fran-cesco di Paola colle due grandistrade che circondano la piazza»;«Tempio e Portico di San France-sco di Paola progettato dall’Archi-tetto Giuseppe Giordano». La da-tazione proposta deriva dal fattoche ad essi fa chiaro riferimentoun’istanza rivolta dal Giordano alministro Tommasi nel marzo 1817,allorché l’opera era ormai in ese-cuzione: ASNa, Ministero degli In-terni, App. II, fsc. 1098.40 AA.VV., Pietro Bianchi…, cit.,tav. 19, datata novembre 1816.41 ASNa, Ministero degli Interni,App. II, fsc. 1098, istanza cit. (mar-zo 1817). La chiesa ideata dal Gior-dano avrebbe avuto un diametrodi pal. 125 (15 più del Pantheon).L’architetto faceva notare, tra l’al-tro, «qual effetto meraviglioso, eTeatrale produrrà la varietà deltraffico di dette due strade, ed unatruppa, che dai quartieri di Pizzo-falcone calerà nella Piazza».42 Ivi, appunto sull’istanza del Gior-dano, datata 19 marzo 1817.43 ASMUN, Opere pubbliche, «Piaz-za del Real Palazzo», fsc. III (1810-17), lettera dell’intendente Co-
laianni al sindaco principe di Bel-vedere (9 dicembre 1817). Da unrapporto della commissione inca-ricata della costruzione della chie-sa al ministro dell’Interno del 13gennaio 1818 (ASNa, Ministerodegli Interni, App. II, fsc. 845) sievince che il Bianchi aveva già re-datto, a quella data, il progetto del-la nuova strada carrozzabile versola Solitaria, oltre al disegno dellebotteghe che avrebbero trovatoposto all’interno del portico. Per ilprosieguo dei lavori della chiesacfr. pure ASNa, Ministero degli In-terni, App. II, fsc. 293, docc. vari.44 C.N. Sasso, op. cit., p. 125. LaOssanna Cavadini (op. cit., p. 24 esgg.) non concorda col giudizio ne-gativo del Sasso, proponendo unarivalutazione della figura profes-sionale e della carriera di Bianchi.45 È significativo come nel 1821ancora non si fosse diluito il climadi tensione tra i professionisti ed ilgoverno borbonico: la datazione almaggio di quell’anno presente suigrafici di Niccolini e di Cocciola(cfr. per quest’ultimo elaborato A.Venditti, op. cit., fig. 49) si spiegadunque col fatto che a quell’epocagli autori dovettero chiederne larestituzione al ministro degli In-terni. Non fu ritrovato, però, il pro-getto richiesto dall’ingegnere Mel-lini, che probabilmente era tra quel-li trattenuti dal Bianchi sin dal1816: ASNa Ministero degli Inter-ni, App. II, fsc. 1041, doc. del 10
luglio 1822. Ricordiamo, infine, cheancora nel ’21 de Fazio chiese coninsistenza, ma senza esito, il pre-mio dovutogli quale vincitore delconcorso: ivi, fsc. 359, docc. vari,cit. in E. Catello, op. cit., p. 92, n. 15.46 Sulla figura e l’attività di Stefa-no Gasse (1778-1840) si veda A.Buccaro, Opere pubbliche e tipolo-gie urbane…, cit., introduzione epassim. I gemelli Stefano e LuigiGasse studiarono a Parigi dal 1785al 1802, ove appresero l’architet-tura dallo Chalgrin, già allievo diBlondel e di Boullée. Se Luigi siaggiudicò il Grand Prix nel 1799,a Stefano spettarono numerosipremi minori offerti dall’Acàde-mie. Dopo il pensionato romano,essi tornarono a Napoli nel 1806:qui, in effetti, solo Stefano avreb-be ricoperto cariche pubbliche ericevuto incarichi ufficiali fino allamorte; il fratello, oltre a collabora-re alla progettazione di alcuneopere private, tra il 1816 e il ’18lavorò con Bianchi, e fu l’unico ar-chitetto napoletano coinvolto dalluganese, forse proprio per i co-muni trascorsi parigini. E. Catello,op. cit., p. 88.47 A. Buccaro, Opere pubbliche e ti-pologie urbane…, cit., pp. 119, 185.48 N. Ossanna Cavadini, La sala deltrono presso la Reggia di Caserta, ilReal Museo Borbonico, alcune opereminori, in AA.VV., Pietro Bianchi…,cit., p. 143 e A. Buccaro, Architettu-ra e urbanistica…, cit., p. 172.
176