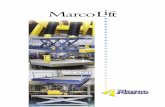Marco FRATI, La città di Dante. Le architetture, in Con gli occhi di Dante, a cura di Sergio...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Marco FRATI, La città di Dante. Le architetture, in Con gli occhi di Dante, a cura di Sergio...
83
Marco Frati
Le architetture
1. Le mura (schede 7-8).Dante mette in bocca all’antenato Cacciaguida lafamosa nostalgica descrizione della città dei bei tempiandati, “Fiorenza dentro da la cerchia antica” (Par.XV, 97), individuando nella quarta cinta il confine frai fiorentini autentici e gli uomini nuovi (Par. XVI,49) secondo una coscienza popolare ormai consolida-ta1. I due Alighieri, però, furono entrambi testimoni(se non protagonisti) di tempi che stavano cambiandoe che richiedevano la costruzione di nuove mura, aincludere i borghi degl’inurbati.Cacciaguida forse non visse abbastanza2 per poterassistere alla realizzazione della quinta cinta, quellacomunale del 1172-1175, mentre Dante vide solo iltracciamento della settima e ultima cerchia (1284)con la costruzione di tutte le porte (1299) ma non ilsuo completamento, avvenuto ben dopo il suo esilio ela sua morte (1321).La realizzazione delle mura intorno a una città non èmai un fatto neutrale: è, sostanzialmente, la difesa diqualcosa dalla minaccia di qualcuno3. Per toglierebanalità e genericità a questa osservazione è necessariocircostanziare il fenomeno, individuandone attori emotivazioni.La prima cerchia (fig. 1) è da ritenere coeva con lastessa fondazione di Florentia in età augustea (intornoal 25 a.C.), una colonia romana in piena regola, ecome tale un insediamento volto a polarizzare il terri-torio intorno a un nodo strategico: costituito nel casospecifico dal passaggio sull’Arno della strada che col-lega Fiesole a Volterra e Pisa.
A un passo dalla pacificazione augustea della penisolae dell’Impero, i costruttori di Florentia concepirono lemura prima di tutto come una necessaria premessaall’urbanizzazione dell’accampamento4.Due secoli dopo, il successo della città era ormai evi-dente: la sua favorevole posizione rispetto alla viabili-tà l’aveva resa un polo commerciale di grande impor-tanza nell’Etruria settentrionale con il conseguenteaumento della popolazione, la saturazione degli spaziinterni e la formazione di borghi extramurali. Lacostruzione della seconda cerchia fece parte di un pro-gramma di riconfigurazione della città, dotata di piùgrandi e aggiornate infrastrutture: la via Cassia nova,un foro più vasto, il teatro, l’anfiteatro, e pertanto lenuove mura5.
Fig. 1 - Plastico ricostruttivo delle cerchie murarie di Firenze:ciascuna corrisponde a un’idea di città da proteggere.
1 Cfr. Franek SZNURA, L’espansione urbana di Firenze nel Dugento, La nuova Italia, Firenze 1975, p. 41; Giovanni FANELLI, Le città nella storia d’Italia. Firenze, Laterza,Roma-Bari 1980, p. 18.2 Cacciaguida compare vivo in un documento del 1131 e già morto in uno del 1189, quindi potè forse essere testimone di quegli avvenimenti. Enciclopedia dante-sca, 6 voll., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1970-1976 (d’ora in poi: ED), vol. I, p. 128.3 Cfr. Jacques LE GOFF, Costruzione e distruzione della città murata. Un programma di riflessione e ricerca, in La città e le mura, Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 1-10,con le riflessioni di carattere antropologico di Silvia MANTINI, Un recinto di identificazione: le mura sacre della città. Riflessioni su Firenze dall’età classica al Medioevo,“Archivio storico italiano”, CLIII, 1995, pp. 211-261.4 Guglielmo MAETZKE, Testimonianze romane e medievali negli scavi degli anni Cinquanta, in Gli antichi chiassi tra Ponte Vecchio e Santa Trinita: storia del rione deiSanti Apostoli, dai primi insediamenti romani alle ricostruzioni postbelliche, a cura di Giampaolo Trotta, Comune di Firenze 1992, pp. 100-110; Massimo BECATTINI,Giuliano DE MARINIS, Firenze ritrovata, “Archeologia Viva”, XIII, 1994, 48, pp. 42-57.5 Giuliano DE MARINIS, Firenze: archeologia e storia dell’insediamento urbano. I: Un profilo di sviluppo, in Alle origini di Firenze. Dalla preistoria alla città romana, acura di Gabriella Capecchi, Polistampa, Firenze 1996, pp. 36-42.
Non si trattava tanto di difendere l’insediamento daimprobabili aggressori, quanto, piuttosto, di segnarnela grandiosità e la diversità dal resto del territorio, dal-l’ager: il virus della superbia era già stato inoculato neifiorentini.In età bizantina Firenze appariva come una tipica città‘retratta’, arroccata intorno alle sue emergenze monu-mentali, ormai spogliate delle funzioni (e del fasto)originarie. Durante la guerra greco-gotica (541-544) si collegaro-no i capisaldi di un sistema che potremmo definire,nella logica del labile limes bizantino, più di ‘resisten-za’ che di difesa. Il fatto che la città murata rientrassepoi nel più vasto programma di riorganizzazione econsolidamento del regno d’Italia sotto Giustiniano,non ebbe altre conseguenze note.La cosiddetta terza cerchia ‘carolingia’ fu invece pro-babilmente realizzata tra la fine del IX e gli inizi del Xsecolo, in piena crisi dell’Impero, quando il poterepubblico era vacante e veniva generalmente assuntodai vescovi come forma di servizio alla popolazionedelle città6. La temuta invasione degli Ungari offrì ai presuli fio-rentini l’occasione di raccogliere le migliori forze cit-tadine per organizzare la difesa ma anche per definiree ampliare l’ambito del proprio potere, prima eroso aiconti ma poi compresso dai marchesi, che stabilironola propria dimora nel complesso episcopale che, nona caso, viene lasciato al di fuori delle mura7.La collocazione della sede del potere pubblico a caval-lo delle mura era piuttosto consueta nell’alto medioe-vo e risultava ancora adeguata nell’XI secolo, quandola marchesa Beatrice trasferì la capitale della Tuscia aFirenze e la figlia Matilde stabilì un rapporto privile-giato con le città italiane e il papa, a dannodell’Impero. Per proteggere convenientemente la con-tessa di Canossa dalle truppe di Enrico IV, la quartacinta (1078), che in realtà fu solo un ampliamentodella terza, inglobò il quartiere religioso a Nord dellacittà (col palazzo episcopale ancora a controllo dellaporta settentrionale).
Questa cerchia venne sentita propria dalla comunitàurbana, che si assunse direttamente il costo del suomantenimento8 avocando a sè una prerogativa regia,cioè la manutenzione delle mura, e stabilendo unprincipio identitario: l’appartenenza al territorio inframuros.Solo col regime comunale, figlio della benevolenza diMatilde, la città raggiunse una dimensione confronta-bile con quella tardoantica: le nuove mura della quin-ta cerchia dovettero contenere una superficie tripladella precedente inglobando i borghi sorti lungo lequattro strade principali, compreso quello oltr’Arno.La fretta con cui si realizzarono dipese ancora unavolta dalla minaccia imperiale: la discesa di FedericoBarbarossa, conclusasi (fortunatamente per i comuniitaliani) con la disfatta di Legnano (1174).L’ampliamento dello spazio urbano ne comportòanche una riorganizzazione: dai quartieri si passò alladivisione in sestieri (a loro volta divisi in venti gonfa-loni), ancora vigente nella gioventù di Dante.Completarono la fortificazione i ponti sull’Arno:quello Vecchio, ricostruito in pietra dopo l’alluvionedel 1178, il Nuovo (o alla Carraia) gettato nel 1218-1220 in continuità con le cortine occidentali, e quel-lo di Rubaconte (poi alle Grazie) realizzato dalla parteopposta nel 1237.Nel 1250, morto Federico II, a Firenze un’insurrezio-ne portò al potere i guelfi, che tendevano ad allargarela partecipazione popolare al governo. Il sestod’Oltrarno, assai cresciuto nella prima metà del seco-lo e collegato al centro antico da tre ponti, venne pre-sto (1252) dotato di un quarto passaggio sul fiumepresso la chiesa di Santa Trinita. Le fortificazioni inmateriali deperibili dei borghi meridionali vennerosostituite nel 1258 da una cortina merlata realizzatacon i materiali delle torri ghibelline demolite nellostesso anno9. Fu così ottenuto un triplice scopo: reim-piegare immediatamente le macerie, difendere il latoSud (pericolosamente esposto verso il nemico delmomento: la ghibellina Siena) e premiare il quartierepiù popolare della città.
Marco Frati - Le architetture
84
6 Eugenio DUPRÈ THESEIDER, Vescovi e città nell’Italia precomunale, in Vescovi e città in Italia nel Medioevo (secoli IX-XIII), atti del II Convegno di Storia della Chiesain Italia (Roma, 5-9 settembre 1961), Antenore, Padova 1964, pp. 55-109.7 Nell’897 il marchese teneva giudizio davanti alla cattedrale fuori dalle mura; nel 901 la loggia maggiore del palazzo arcivescovile si trovava presso il campo regio,ancora fuori dalle mura. Mario LOPES PEGNA, Firenze dalle origini al Medioevo, Del Re, Firenze 1962, p. 331.8 Antonio PANELLA, Storia di Firenze, Sansoni, Firenze 1949 (rist. an. Le Lettere, Firenze 1984), p. 15.9 Marco FRATI, “de bonis lapidibus conciis”. La costruzione di Firenze ai tempi di Arnolfo di Cambio: strumenti, tecniche e maestranze nei cantieri fra XIII e XIV secolo,Firenze University Press, Firenze 2006, pp. 12, 66, 112, 131, 135n, 153n, 169, tav. IV. Una più limitata esperienza di analisi stratigrafica è stata compiuta dagli alun-ni autori della scheda n° 7.
Nel Duecento l’espansione urbana10 doveva apparirea tutti inarrestabile, con il raggiungimento dell’eleva-to numero di 100.000 abitanti stimati, che Dantedice essere cinque volte superiore (Par. XVI, 48) aquello di un secolo prima. L’ulteriore allargamentodella base popolare portò nel 1283 al ‘secondo popo-lo’, un regime di parte guelfa connotato da provvedi-menti ancor più marcatamente antimagnatizi. L’annoseguente, con il probabile coinvolgimento dell’artistacolligiano Arnolfo di Cambio, vennero progettate lenuove mura11, destinate a contenere la città finoall’età contemporanea. La cinta venne appena impo-stata, con il tracciamento della cortina e la simbolicacostruzione delle prime quattro porte corrispondentiai principali percorsi alla destra dell’Arno (al Pratoverso Pistoia a Nord-Ovest, a San Gallo verso Bolognae Faenza a Nord, a Pinti verso Fiesole a Nord-Est, allaCroce verso Arezzo a Est). Nel 1292, in contempora-nea con i nuovi statuti popolari, la città murata torna-va ad essere suddivisa in quartieri, stavolta imperniatiintorno al battistero (San Giovanni) e ai grandi con-venti degli ordini mendicanti (domenicano di SantaMaria Novella, francescano di Santa Croce, agostinia-no di Santo Spirito). I lavori ripresero nel 1299, sottola minaccia dei ghibellini di Arezzo (giunti fino a SanDonato in Collina), con la realizzazione di molte altreporte nella parte settentrionale, seguendo il modelloarnolfiano. La discesa in Italia di Enrico VII nel 1310,in cui Dante ripone vanamente tutte le sue residuesperanze di pace e giustizia (Par. XXX, 137-138), ful’occasione per la costruzione delle cortine a Nord edelle porte a Sud, i cui contratti di appalto venneroregolarmente registrati in un libro ancora inedito12. Ad esempio, nel contratto del 15 agosto 1314 per la
porta “presso la chiesa di San Frediano nella stradapubblica per la quale si va a Pisa”, affidata a Naldinodi Geronimo, “il suddetto maestro deve costruire lacoscia della suddetta porta larga da entrambi i latidodici braccia, ampia dal lato anteriore quattro brac-cia e mezzo, e da quello posteriore tre braccia e mezzo;deve costruire i pilastrini larghi sette ottavi; deve con-ciare la pietra per un’altezza di dodici braccia fino allacornice; deve costruire il sottarco (l’architrave) dellospessore di sei ottavi e della lunghezza di un braccio eun terzo in chiave, e di un braccio all’imposta; devecostruire il magistero, ovvero l’arco maggiore impo-stato sulla cornice, un braccio e mezzo all’imposta,davvero un braccio e due terzi (parti di un altro brac-cio) in chiave; deve costruire dal lato interno dellaporta un arco di pietre tagliate della grandezza a rego-lo di due braccia con le facce quadre dell’altezza di unbraccio e due terzi (parti di un altro) in chiave, davve-ro di un braccio e un terzo all’imposta; dovrà con-giungere gli archi di conci subbiati con un filare disopra per un’altezza di diciannove braccia; devecostruire il muro dalla cornice in su della grandezza didue braccia e fare in modo che le pietre commesse,naturalmente, siano di tre quarti di braccio; deve col-locare i beccatelli sul muro a sostegno dei ballatoi”13. Provando a ricostruire congetturalmente la strutturasecondo le puntigliose indicazioni del contratto,molto poco sembra lasciato al caso: restano da quan-tificare solo la quota della piattabanda, l’altezza delmuro sopra la seconda cornice e la forma del corona-mento dai beccatelli in sù. Anche la finitura superfi-ciale è precisamente indicata, con pochissime lacune(l’arco e la piattabanda esterni, le cosce verso l’internoe sotto il fornice). Una descrizione così precisa per-
Marco Frati - Le architetture
85
10 Antonio MOTTA, Firenze ai tempi di Dante, Edizioni Athena, Milano 1929; Robert DAVIDSOHN, Firenze ai tempi di Dante, Bemporad, Firenze 1929; Firenze aitempi di Dante, catalogo della mostra (Firenze, 1965-1966), Barbera, Firenze 1966; Ugo PROCACCI, L’aspetto urbano di Firenze dai tempi di Cacciaguida a quelli diDante, in ED, II, 913-920; Firenze ai tempi di Dante. Documenti sull’urbanistica fiorentina, a cura di Guido Pampaloni, Il Cenacolo, Firenze 1973; SZNURA 1975;FANELLI 1980, pp. 23-68; Pierre ANTONETTI, Firenze ai tempi di Dante, CDE, Milano 1987; Giovanni CHERUBINI, Le città italiane dell’età di Dante, Ospedaletto1991; Riccardo FRANCOVICH, Emiliano SCAMPOLI, Firenze al tempo di Dante, in L’arte a Firenze nell’età di Dante (1250-1300), a cura di Angelo Tartuferi, Giunti,Firenze 2004, pp. 32-49; Franek SZNURA, Appunti sull'urbanistica fiorentina tra XIII e XIV secolo, in Arnolfo: alle origini del Rinascimento fiorentino, catalogo dellamostra (Firenze, 21 dicembre 2005-21 aprile 2006) a cura di Enrica Neri Lusanna, Polistampa, Firenze 2005, pp. 86-97; FRATI 2006.11 Ancora fondamentale resta il volume di Renzo MANETTI, Maria Chiara POZZANA, Firenze: le porte dell’ultima cerchia di mura, CLUSF, Firenze 1979. Cfr. poigl’ineguali contributi di Francesco BANDINI, Su e giù per le antiche mura. Analisi storica per il recupero della cinta muraria di Firenze e progetto di percorso attrezzato,Alinari, Firenze 1983; Lucia BOZZA, Angelica DEGASPERI, Una torre trecentesca delle mura di Firenze: analisi stratigrafica delle strutture e stato di conservazione dei mate-riali, “Bollettino della Società di Studi fiorentini”, II, 1998, pp. 21-37; Maria Teresa BARTOLI, Quadrante geometrico e bastone di Giacobbe: un’ipotesi indiziaria per lemura trecentesche di Firenze, “Disegnare - idee: immagini”, XII, 2001, 22, pp. 39-50; Luciano ARTUSI, Le antiche porte di Firenze: alla scoperta delle mura che cir-condavano la città, Semper, Firenze 2005. 12 Sull’inedito e fondamentale registro dei contratti di appalto dal 1313 al 1330, ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Capitani di Parte Guelfa, Numeri rossi, 103; IVI,Manoscritti, 180; MANETTI-POZZANA, 1979, App. II; Marco FRATI, L’ultima cerchia dopo Arnolfo: un progetto di ricerca, “Milliarium”, IX, in corso di stampa.13 ASF, Capitani di Parte Guelfa, Numeri rossi, reg. 103, cc. 7v-8r, edito in FRATI 2006, n° 2, qui tradotto dal collega prof. Massimo Seriacopi, che ringrazio.
mette una ricostruzione grafica molto dettagliata (fig. 2),la cui distanza dall’edificio attuale appare evidente: sitratta infatti di un progetto sostanzialmente diversoda quanto poi realizzato, come già supposto da RenzoManetti14. Se anche Dante fosse rientrato in città, non avrebbepotuto vedere concludere le mura, perché la costru-zione delle fortificazioni riprese proprio l’anno dellasua morte (1321), sotto la pressione militare diCastruccio Castracani. Stando alla testimonianzadiretta del Villani (confermata dai documenti)15, sidotò la cortina Nord delle torri e dei barbacani, e sicominciò finalmente a recingere anche il quartiered’Oltrarno. Le grandi porte monumentali (fig. 3) aSan Frediano e a San Niccolò furono le ultime realiz-zazioni a suggello dell’immane cantiere.
2. Le abbazie (schede 9-11).L’opinione generalmente negativa che Dante dimostradi avere nei confronti dei monaci e dei monasteri(Par. XXII, 81, religiosi avidi; Purg. XVIII, 122,abati indegni; Inf. XXIII, 63, monaci frivoli) è frutto
della grande distanza che lo separa da uno stile di vitasostanzialmente antiurbano, ma anche dell’allontana-mento apparentemente irreversibile (e imperdonabileai severi occhi del Poeta) dei religiosi dalla coerenzaoriginaria.In particolare, il più colpito dalla decadenza moralesembra essere l’ordine più antico, quello benedettino,che tanto successo aveva avuto fra l’alto e il bassomedioevo, contribuendo alla sopravvivenza della cul-tura latina e allo sviluppo del territorio. Se i primicenobi si erano dislocati il più lontano possibile dallecittà per consentire ai monaci una vita di stampo ere-mitico, al tempo di Dante le fondazioni religiose s’in-trecciavano indissolubilmente con lo sviluppo dellacittà: i nuovi quartieri assorbivano i vecchi monasterisuburbani e da questi veniva orientata la proprietàimmobiliare e la nuova viabilità.Entro il 1300, al tempo delle due grandi rationes deci-marum (1274-1280 e 1295-1304)16, che fotografanola situazione degli enti religiosi nel territorio italiano,quella dei monasteri fiorentini era la seguente: entrole mura si trovavano San Salvatore di Camaldoli, SanPancrazio, Santa Maria del Carmine, Santa Trinita,Santa Maria Assunta (la Badia Fiorentina), San Felicein Piazza, San Pier maggiore, Santa Felicita eSant’Ambrogio; nel suburbio, a San Salvi, SanMichele a Monteripaldi, San Miniato al Monte, SanMartino a Mensola; nella prima fascia di pivieri, aCandeli, Ripoli, Settimo e Mantignano; nel contado,
Marco Frati - Le architetture
86
Fig. 2 - Prospetti (esterno, interno, laterale), pianta e sezionelongitudinale ricostruttivi della scomparsa porta urbica “perla quale si va a Pisa” (Frati). Molto poco sembra lasciato alcaso: sia la forma che la consistenza degli elementi architetto-nici è precisamente indicata nel contratto di appalto, fin nellafinitura superficiale.
14 Cfr. MANETTI-POZZANA 1979, pp. 74-76, 352-361 (per il rilievo della porta attuale).15 Giovanni VILLANI, Nuova Cronica, 3 voll, a cura di Giacomo Porta, Parma, Guanda, 1990-1991, libro X, capp. 137, 256-257. Per la documentazione, si vedanole note precedenti.16 Rationes Decimarum Italiae. Tuscia, vol. I: La decima degli anni 1274-1280, a cura di Pietro Guidi, Biblioteca Apostolica, Città del Vaticano 1932; RationesDecimarum Italiae. Tuscia, vol. II: Le decime degli anni 1295-1304, a cura di Martino Giusti e Pietro Guidi, Biblioteca Apostolica, Città del Vaticano 1942.
Fig. 3 - Plastici delle porte urbiche a San Niccolò, a SanFrediano, a San Pier Gattolino (Romana) e alla Croce (dasinistra verso destra): a confronto le più grandi e tarde ported’Oltrarno con una delle prime quattro cardinali di età arnol-fiana.
a Poggibonsi, Moscheta, Gualdo, Razzuolo, Luco,Ricesari, Buonsollazzo e Bovino.Tralasciando i cenobi più periferici – che si trovanoalle pendici del Monte Morello, in Valdelsa e soprat-tutto nel Mugello – quelli nelle vicinanze della cittàoffrono ancora ben visibili le loro strutture medieva-li17. In particolare, Dante mostra di conoscerne eapprezzarne due: la Badia fiorentina18, costruita “den-tro da la cerchia antica / ond’ella toglie ancora e terzae nona” (Par. XV, 98), e San Miniato19 “al monte /dove siede la chiesa che soggioga / la ben guidatasopra Rubaconte” (Purg. XII, 100-102). La cono-scenza dantesca dei benedettini cluniacensi (Inf.XXIII, 63) sembra poter condurre anche all’abbaziadi San Salvatore a Settimo20, ritenuta (impropriamen-te, in realtà) appartenente alla potente congregazione.Santa Maria, San Miniato e San Salvatore sono acco-munate da vicende simili, che si riflettono nell’orga-nizzazione architettonica.Innanzitutto, la comune fondazione in età ottoniana:la Badia da Ugo marchese di Toscana fra il 969 e il978, Settimo dal conte Lotario I dei Cadolingi fra il998 e il 1011, San Miniato dal vescovo Ildebrando nel1018. Ugo, il “gran barone” di cui Dante ha ancoramemoria (Par. XVI, 128) e che nella Badia si feceseppellire, fu promotore dell’istituzione nella marca dialtri importanti monasteri privati, con lo scopo diconservare unito e incrementare il patrimonio fami-gliare, altrimenti soggetto alla dispersione ereditaria21.Anche Lotario, imparentato con il marchese e investi-to di territori strategici nella marca, istituì a Fucecchioun altro monastero con la finalità di controllare ilmedio corso dell’Arno.L’età ottoniana in campo architettonico fu unmomento di grande sperimentazione in tuttol’Impero, preliminare allo sviluppo locale dei linguag-gi romanici. Le tre chiese abbaziali in realtà non pre-sentano novità sostanziali rispetto alla tradizionaleimpostazione basilicale a tre navate. Ciò è dovuto inparte allo sfasamento del periodo di costruzione delle
chiese rispetto a quello di fondazione dei monasteri.La Badia fiorentina, assai trasformata nel tempo, fuprobabilmente costruita nell’ultimo quarto del Xsecolo, inaugurando, insieme a pochi altri edificimonastici (Sant’Antimo, Farneta, …), la stagionedella rinascita ottoniana in Toscana.Meglio conservata si presenta l’abbazia di Settimo,databile entro il primo quarto del secolo successivo(realizzato per ultimo, il campanile è datato daun’iscrizione al 1049). Essa presenta ancora una crip-ta a oratorio (fig. 4) sotto il presbiterio, mentre lenavate erano separate da rozzi pilastri a base rettango-lare che non possono ancora risentire delle novità
introdotte nella cattedrale di Santa Reparata pochianni dopo; la decorazione absidale a lesene e archettipensili richiama le coeve ricerche lombarde.San Miniato è, com’è noto, un testo fondamentale delromanico fiorentino aulico che ha pochi raffinatissimiepisodi architettonici: il Battistero, la pieve di Empoli,la Badia Fiesolana, la canonica dei Santi Apostoli, lachiesa palatina di San Salvatore, il distrutto conventodi San Donato in Scopeto. L’altro filone del romanico
Marco Frati - Le architetture
87
18 Maurilio ADRIANI, Alessandro GUIDOTTI, Ernesto SESTAN, La Badia fiorentina, Cassa di risparmio di Firenze, 1981.19 Luciano BERTI, Francesco GURRIERI, Claudio LEONARDI, La basilica di San Miniato al Monte di Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, 1988; Le carte del mona-stero di San Miniato al Monte (secoli IX-XII), a cura di Luciana Mosiici, Olschki, Firenze 1990. 20 Dalle abbazie l’Europa. I nuovi germogli del seme benedettino nel passaggio tra primo e secondo millennio (secc. X-XII), atti del convegno (Badia a Settimo, 22-24 apri-le 1999) a cura di Alessandro Guidotti e Graziella Cirri, m&m, Firenze 2006.21 Gli altri monasteri voluti da Ugo di Toscana sono quelli di Buonsollazzo (FI), Capolona (AR), Marturi (SI), Verruca (PI) e Città di Castello (PG): Antonio FALCE,Il marchese Ugo di Tuscia: ricerche, Bemporad, Firenze 1921; Andrea CALAMAI, Ugo di Toscana: realtà e leggenda di un diplomatico alla fine del primo millennio, Semper,Firenze 2001. Sul fenomeno dei monasteri privati, Wilhelm KURZE, Monasteri e Nobiltà nel Senese e nella Toscana medievale. Studi diplomatici, archeologici, genealo-gici, giuridici e sociali, Accademia Senese degli Intronati, Siena 1989.
Fig. 4 - Modello tridimensionale della cripta a oratorio diBadia a Settimo (Barbanti). La semplicità dei capitelli e lapresenza di sottarchi permettono di riferirla all’età ottoniana.
locale è costituito dalla cattedrale con le sue innume-revoli semplificate filiazioni fino a tutto il XII secolo.La cronologia dei principali edifici monumentali inopus sectile è stata di recente messa in discussione daGuido Tigler che ne ha convincentemente ricostruitole ragioni e le relazioni22. La costruzione della cripta edel presbiterio di San Miniato risalirebbe dunque allametà dell’XI secolo, mentre quella delle navate e delladecorazione bicroma della facciata occuperebbe tuttoil seguente. La scelta del ritmo sassone dei sostegni frale navate (due colonne ogni pilastro) e della divisionedello spazio in campate (nonostante la coperturalignea) risale forse al progetto iniziale, ma la costruzio-ne della chiesa romanica matura (fig. 5) fu diretta daun valentissimo architetto, forse lo stesso “eximiusmagister” del Battistero e di Empoli. Nel corso dei secoli tutte e tre le abbazie benedettineebbero bisogno di una riforma della vita monastica,decaduta spiritualmente dopo i primi tempi, comeanche Dante sottolinea indignato (Par. XXII, 76-77).Quasi sempre le nuove comunità operarono modifi-che architettoniche nelle chiese e nei monasteri intro-ducendovi nuovi linguaggi, anche per segnare inmodo evidente l’avvenuto cambiamento dello stile divita nel cenobio.Per Settimo si è spesso ipotizzata un’alternanza diregole d’ispirazione benedettina fin dal suo primosecolo di vita: ma in realtà mai vi s’insediarono i clu-niacensi23, mentre la presenza dei vallombrosani èancora assai discussa24. In ogni caso, non si ebbe nes-suna conseguenza sul cantiere romanico, del restoconcluso da pochi anni. Furono i cistercensi (insedia-tisi nel 1236) a promuovere nel 1290, cioè in pienaetà dantesca, il rifacimento della chiesa, ottenendouno spazio più unitario (sostegni più radi, navate late-rali rialzate) e più illuminato (rosone in facciata, fine-stre ampie) secondo i più aggiornati canoni gotici.A San Miniato, il cui imprinting vescovile non aiuta-va certo i monaci a resistere alle tentazioni secolari, lariforma giunse soltanto nel 1373 con gli olivetani. Ilcantiere, che si era protratto oltre il XII secolo pur con
l’istituzione dell’Opera e l’aiuto dell’arte di Calimala,si arricchì nel 1387 per volontà testamentaria dell’esi-liato Benedetto degli Alberti della monumentalesacrestia affrescata da Spinello Aretino con storie disan Benedetto che appare già vestito con il saio bian-co degli olivetani (fig. 6). Ai tempi di Dante inveceera stata realizzata la decorazione dell’abside con ilgrande mosaico (datato 1297: fig. 7) e il palazzo deiVescovi sul lato occidentale del chiostro (iniziato nel1295) nell’ambito della committenza del vescovoAndrea de’ Mozzi.Alla Badia le trasformazioni gotiche (fig. 8)25 noncorrisposero tanto a cambiamenti spirituali all’internodel monastero, quanto piuttosto a profonde modifi-che urbanistiche al suo esterno, dovute alla costruzio-ne sul suo retro del Bargello (1255). Il cantiere, pro-babilmente affidato congiuntamente ad Arnolfo e aGiotto26, fu iniziato nel 1284-1285 (secondo le diver-
Marco Frati - Le architetture
88
Fig. 5 - Plastico della chiesa abbaziale di San Miniato alMonte. Il completamento dell’edificio con un linguaggioromanico maturo si ispira al Battistero.
22 Guido TIGLER, Toscana Romanica, Jaca Book, Milano 2006, pp. 154-165.23 Cfr. Joan EVANS, Romanesque Architecture of the Order of Cluny, University Press, Cambridge 1938. 24 L’episodio della prova del fuoco del 1068 non può essere considerato più di un indizio dell’appartenenza di Settimo all’ordine vallombrosano, la quale comunquenel 1090 non risulterebbe già più. 25 Ulrich MIDDELDORF, Walter PAATZ, Die gotische Badia zu Florenz und ihr Erbauer Arnolfo di Cambio, “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes Florenz”,vol. III, 1919-1932, pp. 492-517.26 Giuseppe ROCCHI COOPMANS DE YOLDI, Il doppio cantiere giottesco nella Badia Fiorentina e nell’antistante Palazzo del Podestà, in La storia del Bargello. 100 capo-lavori da scoprire, a cura di Beatrice Paolozzi Strozzi, Silvana, Cinisello Balsamo 2004, pp. 87-94.
se datazioni offerte da Villani e Vasari, ma certamen-te entro il 1286, data di un privilegio di Onorio IV aibenedettini, che “monasterium suum de novo edificarecoeperunt”), e verosimilmente concluso nelle struttureprima del 1307, anno della distruzione del campanile(ricostruito nel 1330), e negli arredi entro il 1310,anno di consacrazione dell’altare. L’innovativo uso diprincipi progettuali (moduli geometrici), partiti deco-rativi (finestre archiacute, coronamento a dentelli) etecniche costruttive (l’impiego della martellina denta-ta per spianare le superfici lapidee) pertinenti alla cul-tura gotica – fino ad allora assente a Firenze (fattasalva la chiesa domenicana di Santa Maria Novella) –dovette richiedere la presenza di un maestro di gran-dissima personalità e dalla consolidata esperienza
internazionale come Arnolfo27, al quale il comune diFirenze tributò il primo d’aprile del 1300 (con Dantemembro del consiglio autore del provvedimento) unambitissimo riconoscimento: l’esenzione fiscale totale!Il complesso di Badia venne ulteriormente riconfigu-rato a seguito dell’assorbimento dei monaci nella con-gregazione di Santa Giustina da Padova (1419): ilnuovo priore Gomezio Ferreira da Silva (in carica finoal 1439) commissionò a Bernardo Rossellino la realiz-zazione del chiostro degli Aranci (1432-1438), di unelegante e aggiornatissimo ordine ionico. Più tardi, aiprimi del Cinquecento, Giovan Battista Pandolfinifece trasformare a Benedetto da Rovezzano in cappel-la gentilizia la vecchia chiesetta parrocchiale di SantoStefano del popolo, dove fin dal 1373 per iniziativa diGiovanni Boccaccio si teneva la lectura Dantis.
3. Le chiese mendicanti (schede 12-13).Il movimento ‘mendicante’ nacque all’inizio delDuecento con la predicazione e l’esempio dei grandisanti Francesco d’Assisi e Domenico di Guzman, nona caso esaltati insieme da Dante (Par. XI, 37-42). Illoro fulmineo successo dipese dall’aver risposto inmodo originale e adeguato alle urgenze del lorotempo (e di ogni tempo: la pace, la giustizia, il rispet-to del creato), mediando forme di vita derivanti dalla
Marco Frati - Le architetture
89
Fig. 6 - Spinello Aretino, storie di san Benedetto (sacrestia diSan Miniato al Monte). I monaci vengono raffigurati con ilsaio bianco degli olivetani.
Fig. 7 - Il catino absidale di San Miniato al Monte. La deco-razione architettonica riprende quella della facciata.
Fig. 8 - Rilievo del coro della Badia Fiorentina (Joutz). Le tra-sformazioni gotiche corrisposero alle profonde modificheurbanistiche innescate dalla costruzione del Bargello.
27 Cfr. Arnolfo di Cambio e la sua epoca: costruire, scolpire, dipingere, decorare, atti del convegno internazionale di studi (Firenze-Colle di Val d’Elsa, 7-10 marzo 2006)a cura di Vittorio Franchetti Pardo, Viella, Roma 2006: in particolare si vedano i contributi di Valerio Ascani e Marco Frati.
tradizione monastica (i francescani come eremiti laici,i domenicani come canonici regolari) con atteggia-menti del tutto nuovi28. In particolare, entrambi gliordini rinunciavano al possesso formale dei beni, sot-toponendoli e sottoponendosi direttamente all’autori-tà del Papa, evitando così dipendenze locali. La loroprincipale fonte di sostentamento era dunque la que-stua, praticata capillarmente insieme alla predicazionedel Vangelo. Per la loro coerenza col dettato evangeli-co della Povertà (Par. XI, 73-75), i frati ‘mendicanti’apparivano molto più credibili dei confratelli secolarie regolari, suscitando infinite vocazioni e donazioni. Illoro prestigio spirituale fu sfruttato dalla Chiesa diRoma nella lotta contro le molte eresie pauperistichesorte nel XII secolo in reazione alla scandalosa ric-chezza degli uomini e degli enti religiosi (Inf. VI, 46-48). Alla fine del secolo la presenza degli ordini mendican-ti nelle città era ormai una solida realtà29. A Firenzeavevano stabilito una propria comunità frati domeni-cani o ‘predicatori’ (Santa Maria Novella, 1221), fran-cescani o ‘minori’ (Santa Croce, 1226), servi di Mariao ‘serviti’ (Santissima Annunziata, 1248), agostinianio ‘eremitani’ (Santo Spirito, 1250) e carmelitani(Santa Maria del Carmine, 1268); sul finire del seco-lo e in forma più ridotta, anche le suore agostiniane(Santa Maria e San Giuseppe sul Prato, 1289; SantaLucia di Camporeggi, 1293) e domenicane (SanDomenico al Maglio, 1292; San Jacopo di Ripoli,1295) ebbero i loro conventi in città30.Come richiesto dalla bolla di Clemente IV del 1265,con la quale si vietava la costruzione di conventi men-dicanti a una distanza reciproca inferiore a 300 canne(oltre 600 metri) “mensurandarum per aerem, etiamubi alias recte mensurari loci dispositio non permit-tit”31, quelli fiorentini si trovano ben distribuiti nella
città, tanto da dare il nome ai nuovi quartieri stabilitidal Secondo Popolo: Santa Maria Novella con i dome-nicani a Ovest, San Giovanni con i serviti a Nord,Santa Croce con i francescani a Est, Santo Spirito congli agostiniani e i carmelitani a Sud.All’inizio del secolo alle nascenti comunità dei mino-ri di Francesco e dei predicatori di Domenico venne-ro affidate chiesette periferiche dove i frati potesseroofficiare e predicare e intorno alle quali potessero riu-nirsi e mendicare. In questa prima fase eroica (Inf.XXIII, 1-3) l’attività edilizia si limitò al restauro e allamanutenzione degli immobili, sull’esempio del ‘pove-rello d’Assisi’ a San Damiano32.Tra il 1230 e 1250 si ebbero i primi ampliamenti e leprime trasformazioni di chiese donate agli ordini. Dal1237 domenicani e francescani furono assimilati nel-l’esercizio della predicazione e della confessione (Inf.XIX, 49-50). Il clero locale fu sempre meno dispostoa ospitare i frati, entrati ormai in chiara competizionecon loro per la cura delle anime, e così le chiese seco-lari e regolari non furono più tanto spesso accessibili,né furono più adatte. Fu dunque allora che s’incomin-ciarono a elaborare nuovi princìpi per un’architetturafunzionale all’attività predicatoria ma allo stessotempo ossequiente al voto di povertà dei frati. Giànelle costituzioni domenicane del 1228 si vietava lacopertura a volta, concessa solo sopra il coro e la sacre-stia33: modello, a cui s’ispirarono anche gli ordini diorigine eremitica dei servi di Maria, nato a Firenzenella prima metà del Duecento34 e sviluppato piùlocalmente e meno capillarmente, e degli agostinia-ni35, che nacquero nel 1256 dalla fusione di varie con-gregazioni eremitiche e che non si dedicarono subitoalla predicazione.Soltanto nella seconda metà del secolo si cominciaro-no a costruire grandi complessi su terreni ai margini
Marco Frati - Le architetture
90
28 André VAUCHEZ, Ordini mendicanti e società italiana (XIII-XV secolo), Il Saggiatore, Milano 1990. 29 Enrico GUIDONI, Città e ordini mendicanti, “Quaderni Medievali”, IV, 1977, 4, pagg. 69-106; Luigi PELLEGRINI, Insediamenti francescani nell’Italia del Duecento,2 voll., Laurentianum, Roma 1984; Enrico GUIDONI, Storia dell’urbanistica. Il Duecento, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 306-328; Gli ordini mendicanti e la città:aspetti architettonici, a cura di Joselita Raspi Serra, Guerini, Milano 1990.30 FANELLI 1980, p. 48.31 Cit. GUIDONI 1989, p. 306 n. 2.32 Marcello SALVATORI, Le prime sedi francescane, in Lo spazio dell’umiltà, atti del Convegno di studi sull’edilizia dell’Ordine dei Minori (Fara Sabina, 3-6 novem-bre 1982), Centro Francescano Santa Maria in Castello, Fara Sabina 1984, pp. 77-106; Angiola Maria ROMANINI, L’architettura dei primi insediamenti francescani,“Storia della Città”, 26-27, VIII, 1983, pp. 9-20; Indagini archeologiche nella chiesa di San Damiano in Assisi, a cura di Letizia Ermini Pani, Maria Grazia Fichera eMaria Letizia Mancinelli, Edizioni Porziuncola, Assisi 2005.33 Gabriella VILLETTI, Legislazione e prassi edilizia degli Ordini mendicanti nei secoli XIII e XIV, in Francesco d’Assisi. Chiese e conventi, a cura di Renato Bonelli, Electa,Milano 1982, pp. 23-31.34 L’Ordine dei Servi di Maria nel primo secolo di vita, atti del Convegno storico (Firenze, 23-24 maggio 1986), Convento della SS. Annunziata, Firenze 1988.35 Kees VAN DER PLOEG, Appunti sugli insediamenti urbani degli Agostiniani in Toscana, in Per corporalia ad incorporalia: spiritualità, agiografia, iconografia e architet-tura nel medioevo agostiniano, atti del convegno (Tolentino, 22-25 settembre 1999), Biblioteca Egidiana, Tolentino 2000, pp. 63-76.
delle città o in luogo delle chiese ricevute. Non poten-do applicare i modelli conventuali del monachesimo,rispetto al quale il movimento mendicante si ponevaradicalmente in alternativa, le comunità furonocostrette a cercare tipologie e apparati decorativi adat-ti alle nuove esigenze. Nelle spoglie e luminose navate cistercensi, aderentialle precise indicazioni di san Bernardo (Par. XXXI)36,trovarono così un modello ideale di ambiente per lapredicazione, subito interpretato in chiave pauperisti-ca nel tipo della ‘chiesa a fienile’ (anche ‘a granaio’ o ‘acapannone’)37 che ebbe larghissimo sviluppo e diffu-sione in tutta Europa. Le costituzioni narbonensi francescane del 1260 con-fermarono quest’orientamento, prescrivendo l’usodelle volte soltanto sulla cappella maggiore e, inoltre,la conformità degli edifici al contesto. Quest’ultimaindicazione fece sì che nella costruzione delle chiesefrancescane, ma anche in quelle degli altri ordini, ci siservisse preferibilmente di maestranze, materiali, tec-niche e linguaggi locali.Alla fine del XIII secolo, acquisito un notevole presti-gio ed esaurita la carica eroica dei primi tempi (Inf.XXIII, 103-109), gli ordini mendicanti si fecerointerpreti delle scelte culturali dei gruppi dominantirappresentando interessi e orientamenti delle comuni-tà urbane che li ospitavano. A San Gimignano il Comune elargiva nel 1280 deci-ne di migliaia di mattoni ai frati agostiniani e france-scani perchè trasferissero nei pressi delle mura i loroconventi, già fondati all’interno del distretto comuna-le38. Il 18 febbraio 1278 la Contessa Beatrice, figlia evedova di membri delle due più grandi famiglie comi-tali fiorentine (gli Alberti di Capraia e i Guidi diDovadola), scriveva il proprio testamento in favore dimolti conventi francescani39.Non si può quindi genericamente parlare di architet-
tura mendicante40, proprio per le diverse selte tipolo-giche che distinguevano gli ordini e per la grandeimportanza che essi dettero alla tradizione locale. Idomenicani, assunto il ruolo di defensores fidei o‘domini canes’ (illustrato da Andrea di Buonaiuto nellasala capitolare del convento fiorentino), furono gliunici a concedersi spesso la ricca soluzione della ‘chie-sa a sala’ o Hallenkirche41, basilica a tre navate diuguale altezza dall’acustica e dall’introspezione perfet-te, adattissima quindi all’intensa attività predicatoriadell’ordine. I francescani, su posizioni dottrinalmentemeno stabili (si pensi al dibattito fra ‘spirituali’ e ‘con-ventuali’) e più vicini al popolo, preferirono la chiesaa capannone con coro rettilineo (soluzione che antici-pa alcuni temi del Rinascimento toscano) persistendonel rifiuto della tradizione basilicale romana. Gli ago-stiniani, attestati soprattutto nei centri minori neipressi dei loro primitivi romitori, non avendo partico-lari esigenze in campo architettonico, costruirono siachiese a fienile che a sala.Lo schema più diffuso in Toscana è comunque quelloa copertura mista: a volte a crociera costolonate sullecappelle del coro, dove si trovano gli altari per la quo-tidiana celebrazione sacerdotale (resa obbligatoriadalla Regola), a tetto ligneo a capriate sulla sala adibi-ta alla predicazione e destinata al popolo; i dueambienti – presbiterio e aula – sono solitamente pureseparati da pochi gradini che stabiliscono una gerar-chia tra le parti dell’edificio: verticale la prima (dovesi concentrano i significati e le funzioni spirituali),orizzontale la seconda (riservata al popolo e all’incar-nazione della Parola).Nelle chiese ogni elemento ha funzione sia pratica siasimbolica, essendo finalizzato alla liturgia e alla cate-chesi. Minori e predicatori, sottoponendosi diretta-mente al Papa, avevano abbracciato la liturgia roma-na, che prevedeva l’altare collocato vicino all’abside42;
Marco Frati - Le architetture
91
36 Architettura cistercense, a cura di Goffredo Viti, Certosa, Firenze 1994.37 Kurt BIEBRACH, Die holzgedeckten Franziskaner- und Dominikanerkirchen in Umbrien und Toskana, Wasmuth, Berlin 1908.38 Luigi PECORI, Storia della Terra di San Gimignano, Cellini, Firenze 1853, pp. 414-415. Sulla consacrazione (1298) di Sant’Agostino, Emanuele REPETTI,Dizionario geografico, fisico, storico del Granducato di Toscana, vol. V, Repetti, Firenze 1843, p. 45. Sul convento, Stanislao BELLANDI, Gli agostiniani in S. Gimignanoe il tempio monumentale di S. Agostino, “Bollettino Storico Agostiniano”, IV, 1927, pp. 39 Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento, a cura di Alfredo Schiaffini, Sansoni, Firenze 1954, p. 238.40 Angiola Maria ROMANINI, L'architettura degli ordini mendicanti: nuove prospettive d'interpretazione, “Storia della Città”, 9, III 1978, pp. 5-15; Antonio CADEI,Architettura mendicante: il problema di una definizione tipologica, ivi, 26-27, VIII, 1983, pp. 21-38.41 Renate WAGNER-RIEGER, Zur Typologie italienischer Bettelordenskirchen, “Römische historische Mitteilungen”, II, 1957-1958, pp. 266-298; Gerard GillesMEERSSEMAN, Origini del tipo di chiesa umbro-toscana degli ordini mendicanti, in Il gotico a Pistoia nei suoi rapporti con l’arte gotica italiana, atti del 2° Convegno inter-nazionale di Studi di Storia e di Arte (Pistoia, 24-30 aprile 1966), EPT, Pistoia 1972, pp. 63-77. 42 Le grandi basiliche romane (Laterano, Vaticano, ecc.) erano e sono occidentate, in modo che i fedeli, uscendo dalla chiesa su invito del celebrante con la formu-la ite, missa est (ecclesia), si dirigessero contemporaneamente verso la città e a Oriente, emblema di Cristo, sole che sorge. L’abside, come nelle antiche basiliche impe-riali (ad esempio quella Ulpia), conteneva la cattedra vescovile.
in genere, come in Santa Maria Novella43, una corti-na (‘iconostasi’) separava il presbiterio (occupato daifrati e utilizzato anche per la preghiera comune) dallospazio assembleare, in modo da aumentare il senso delmistero del sacrificio eucaristico impedendone la vista(fig. 9). La liturgia della parola, che richiedeva inveceun forte coinvolgimento del popolo, veniva svolta dal-l’alto dell’ambone (anche ‘pergamo’ o ‘pulpito’), spes-so collocato a cavallo dell’iconostasi in modo da esse-re visibile tanto dal presbiterio quanto dal resto del-l’aula.L’azione scenica della predicazione necessitava di alle-gorie e storie che trovarono puntuale riferimento nellemembrature degli edifici e negli affreschi parietali.L’intonaco tornò a smaterializzare le murature cheassunsero una funzione a-tettonica. Se la plasticitàromanica necessitava di luce radente per essere valo-rizzata, la linearità gotica ebbe bisogno di una lumi-nosità diffusa che le assicuravano i finestroni archiacuti.Il principale elemento di novità introdotto dagli ordi-ni mendicanti è la concezione dello spazio, corrispon-dente alle nuove esigenze liturgiche, composto secon-do linee guida e contenuto dalle superfici illuminatepiuttosto che ottenuto per sottrazione dalle massemurarie scavate.Prototipo della chiesa a fienile è San Francesco aCortona (voluta dal cortonese frate Elia, generaledell’Ordine, nel 1240-1245), che presenta un’aulaunica sulla cui estremità orientale si innestano diretta-mente tre cappelle, senz’altra mediazione tra presbite-rio e spazio per la predicazione che un lieve cambio dilivello. Questo tipo, preferito da francescani (anche aLucca, metà del Duecento; Prato e Volterra, fine delsecolo) e domenicani (Cortona, metà del Duecento;Arezzo, seconda metà del secolo; Prato, 1322; SanMiniato, metà del XIV secolo), trovò applicazione pertutto il secolo con variazioni soprattutto nella profon-dità della navata.Una prima derivazione dallo schema cortonese è l’au-la a capriate con unica scarsella voltata. L’assolutaessenzialità del tipo incontrò il favore delle primecomunità domenicane (Santa Maria Novella, impian-to del 1246) e di quelle francescane insediate nei cen-tri minori, che l’adottarono più tardi (Colle Vald’Elsa, seconda metà del Duecento; Borgo San
Lorenzo, fine secolo; Santa Lucia al Borghetto, 1327-30).L’impianto spaziale complesso più diffuso tra i france-scani è la nave unica coperta a capriate con transetto,variamente ottenuto. L’esempio più antico (SantaCroce a Firenze, primitiva chiesa del 1252-67)mostrava a levante della navata principale innestarsiun corpo longitudinale di uguali dimensioni dotato disette cappelle voltate disposte lungo tutto il lato orien-tale, a formare un Tau; in particolare, a Siena (SanDomenico, ampliamento del 1293; Santa Maria deiServi, primitiva chiesa del 1292-1309; San Francesco,ampliamento del 1326) questo schema venne adotta-to da tutti gli ordini. La semplificazione del modellosi riscontra in due chiese della metà del XIII secolodedicate a San Francesco in centri minori: il transettodi Sarzana e Pescia, separato dall’aula principale, con-sta di un breve corpo rettilineo con tre cappelle volta-te sul lato orientale, mentre quello di Figline era costi-tuito da due semplici scarselle. Più tardi, a Pistoia(San Francesco, 1294; San Domenico, seconda metà
Marco Frati - Le architetture
92
Fig. 9 - Giotto, il presepe di Greccio (Basilica Superiore di SanFrancesco, Assisi). Un muro separa il presbiterio dal popolo, alquale appaiono visibili soltanto l’ambone, il ciborio e la crocedipinta.
43 Marcia BROWN HALL, The “Ponte” in S. Maria Novella: the problem of the rood screen in Italy, “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, XXXVII, 1974,pp. 157-173; Gabriella VILLETTI, Descrizione delle fasi costruttive e dell’assetto architettonico interno della chiesa di S. Maria Novella in Firenze nei secoli XIII e XIV,“Bollettino della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma”, XXVIII, 1981, pp. 5-20.
del secolo) e Poggibonsi (San Lucchese, aggiunte del1300-46), i bracci del corpo orientale erano costituitida cappelle voltate a crociera con costoloni, come lescarselle della tribuna; a Pisa (San Francesco, rifaci-mento del 1261-86) e San Miniato (San Francesco,rifacimento del 1343) il transetto era invece costitui-to da due specie di navate laterali, separate dalla prin-cipale da due arconi.Il tipo più diffuso nei centri minori si dimostra essereil coro con due cappelle sporgenti dalla navata, sem-plificazione dello schema con transetto, ma forse piut-tosto evoluzione del primitivo impianto rettilineoprivo di sporgenze. Inizialmente preferito da domeni-cani (Pisa, 1252-54) e francescani (Asciano, metà delsecolo; San Lucchese, 1252; Figline, ampliamentodella seconda metà del secolo; San Miniato, 1276;Massa Marittima, fine secolo; Castelfiorentino, iniziodel Trecento), s’impose intorno al 1300 anche fra gliagostiniani (San Gimignano, 1280-98; MassaMarittima, 1299-1313; Colle Val d’Elsa, 1305).L’icnografia basilicale, generalmente rifiutata dagliordini mendicanti, trovò applicazione soltanto aFirenze e in tarde chiese agostiniane del contado. Icasi fiorentini di Santa Maria Novella (chiesa a sala,ricostruita a partire dal 1279: fig. 10) e Santa Croce(basilica coperta a tetto, ricostruita dal 1295: fig. 11)sono universalmente noti44 e restano un’eccezione nelpanorama toscano per la presenza in città di persona-lità uniche tra committenti e maestri. A Poggibonsi(San Lorenzo, prima metà del XIV secolo) ed Empoli(Santo Stefano, 1367) i frati agostinani sperimentaro-no lo schema a tre navate con tetto ligneo divise daampi arconi ogivali (che definiscono grandi campate)e concluse da altrettante cappelle voltate a crociera;eccezionalmente, a Empoli le navate laterali venneropure invase da cappelle laterali, ad uso dei frati e dellenumerose compagnie laicali che vi avevano sede.L’aggiunta di cappelle laterali coperte a volta in chiesedomenicane (aperte direttamente sulla navata:Firenze, 1246; Siena, 1293) e francescane (Volterra, acostoloni radiali del 1315; Prato, XIV secolo) si pro-pone come una complicazione dello schema a fienile.Semplificazione del tipo basilicale, ma evoluzione di
quello primitivo ad aula unica, ad Arezzo (SanFrancesco, chiesa superiore del 1322) e Pisa (SantaCaterina, ampliamento del 1336) si apre nell’aulaprincipale coperta a capriate una serie di cappelle late-rali coperte a volta e collegate fra loro, quasi a forma-re una navata laterale (tipo peraltro assai diffuso nellepievi del contado pisano). Delle primitive chiese mendicanti fiorentine non restatraccia alcuna. Le fasi medievali visibili mostranoorganismi molto sviluppati, ormai pienamente parte-cipanti al linguaggio gotico, con poche concessionialla tradizione romanica locale45. I capitelli di SantaMaria Novella e di Santa Croce (a cui si possonoaggiungere quelli della vallombrosana Santa Trinita,evidentemente ispirata all’architettura mendicante
Marco Frati - Le architetture
93
Fig. 10 - L’interno della chiesa conventuale di Santa MariaNovella a Firenze. Il particolare ruolo giocato da questa chie-sa giustifica l’eccezionale impiego dell’impianto basilicale edella copertura a volte.
44 Santa Maria Novella: la basilica, il convento, i chiostri monumentali, a cura di Umberto Baldini, Banca Toscana, Firenze 1981; Arte e storia in Santa Maria Novella,catalogo a cura di Roberto Lunardi, Salani, Firenze 1983; Umberto BALDINI, Bruno NARDINI, Il complesso monumentale di Santa Croce, Nardini, Firenze 1983.45 Sul tema, La tradizione medievale nell’architettura italiana dal XV al XVIII secolo, a cura di Giorgio Simoncini, Olschki, Firenze 1992; Marco FRATI, La resistenzadella tradizione romanica in Toscana (secc. XIII-XIV), dispense del corso di Storia dell’architettura 1, prof. Giuseppina Carla Romby, Università degli studi di Firenze,a.a. 1995-1996.
fiorentina) aderiscono al tipo a foglie d’acqua, giàcomparso nella cultura romanica fiorentina, ma dalleforme ormai sganciate dai modelli classicisti corin-zieggianti e ammiccanti alle più recenti esperienzecistercensi e francesi (chapiteau à crochet).A Firenze, decisamente influenzate dai modelli archi-tettonici mendicanti appaiono le chiese di nuovi ordi-ni, come quelle degli umiliati di Santa Lucia sul Prato(1239, poi Ognissanti, 1251) e dei silvestrini di SanMarco (1299), o di benedettini riformati – i vallom-brosani di Santa Trinita e i cistercensi di Badia aSettimo – tentavano di affermare la purezza del pro-prio stile di vita imitando le prestigiose formule dellenuove comunità.
4. Gli ospedali (scheda 17)Bisogna ricordare che per tutta l’età medievale la solu-zione dei problemi sociali venne perlopiù lasciataall’iniziativa delle più varie istituzioni religiose da unpotere pubblico raramente in grado di fornire assi-stenza agli individui più deboli. La sensibilità nei con-fronti dei poveri, degli ammalati, degli orfani, deglistranieri, dei carcerati, degli anziani, e degli emargina-ti in genere, si basava sul modello di carità offerto dalVangelo nella Visione del giudizio finale (Mt 25,31-40) speculare al Discorso della montagna (Mt 5,1-12). Impulso all’accoglienza fu di conseguenza forni-to soprattutto da eventi e movimenti religiosi che siispiravano esplicitamente e radicalmente allo stile divita evangelico apostolico.Fin dall’epoca di Costantino, a occuparsi dell’assisten-za in tutto l’Impero furono le città (concilio di Nicea,325). Con la diffusione del monachesimo benedetti-no (dal VI, e soprattutto dall’VIII secolo in poi) furo-no anche i cenobi a dotarsi di infermerie, in ossequioalla regola del fondatore (cap. XXXVI)46. Sul model-lo monastico, anche le diocesi furono obbligate aprovvedere da Ludovico il Pio nel concilio di Aachen-Inden (816-817)47. Lo scarso progresso delle discipli-ne mediche rendeva però gli ospedali poco efficientisul piano sanitario facendone luogo di cure soprattut-to spirituali, tanto che le sale furono concepite comechiese o perlomeno furono sempre dotate di un alta-re. Nell’XI secolo, su impulso della riforma gregoria-na, dell’accoglienza si occuparono anche i laici, inqua-drati in confraternite, e i canonici, sacerdoti che ave-vano scelto la vita comune sotto la regola agostiniana(capp. III, V)48. Nel Duecento, la nuova spiritualitàmendicante, diffusa attraverso la predicazione, spinse
Marco Frati - Le architetture
94
Fig. 11 - Plastico della chiesa conventuale di Santa Croce aFirenze. La copertura a capriate lignee si appoggia su paretimolto sottili e sostegni piuttosto rarefatti.
46 “Capitolo XXXVI. I fratelli infermi. L'assistenza agli infermi deve avere la precedenza e la superiorità su tutto, in modo che essi siano serviti veramente come Cristoin persona, il quale ha detto di sé: «Sono stato malato e mi avete visitato», e: «Quello che avete fatto a uno di questi piccoli, lo avete fatto a me». I malati però riflet-tano, a loro volta, che sono serviti per amore di Dio e non opprimano con eccessive pretese i fratelli che li assistono, ma comunque bisogna sopportarli con grandepazienza, poiché per mezzo loro si acquista un merito più grande. Quindi l'abate vigili con la massima attenzione perché non siano trascurati sotto alcun riguardo.Per i monaci ammalati ci sia un locale apposito e un infermiere timorato di Dio, diligente e premuroso. Si conceda loro l'uso dei bagni, tutte le volte che ciò si ren-derà necessario a scopo terapeutico; ai sani, invece, e specialmente ai più giovani venga consentito più raramente. I malati più deboli avranno anche il permesso dimangiare carne per potersi rimettere in forze; però, appena ristabiliti, si astengano tutti dalla carne come al solito. Ma la più grande preoccupazione dell'abate deveessere che gli infermi non siano trascurati dal cellerario e dai fratelli che li assistono, perché tutte le negligenze commesse dai suoi discepoli ricadono su di lui”.<<www.ora-et-labora.net/RSB_itlat.html>>.47 Fedor SCHNEIDER, Die Reichsverwaltung in Toskana von der Gründung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer (568-1268), Loescher, Regenberg 1914[trad. it. L’ordinamento pubblico della Toscana medievale: i fondamenti dell’amministrazione regia in Toscana dalla fondazione del regno longobardo alla estinzione degliSvevi (568-1268), a cura di Federico Barbolani di Montauto, Federazione delle Casse di Risparmio della Toscana, Firenze 1975].48 “18. D'altra parte, siccome gli ammalati devono mangiar meno per non aggravarsi, durante la loro convalescenza dovranno esser trattati in modo da potersi rista-bilire al più presto, anche se provenissero da una povertà estrema; infatti la recente malattia ha loro procurato quello stato di debolezza che il precedente tenore divita aveva lasciato nei ricchi. Ma appena si siano ristabiliti, tornino alla loro vita normale, che è certamente più felice, poiché è tanto più consona ai servi di Dio quan-to meno è esigente. Ormai guariti, il piacere non li trattenga in quella vita comoda a cui li avevano sollevati le esigenze della malattia. Si considerino anzi più ricchise saranno più forti nel sopportare la frugalità, perché è meglio aver meno bisogni che possedere più cose. […] 37. La cura degli ammalati, dei convalescenti e deglialtri che anche senza febbre soffrano qualche indisposizione, sia affidata ad uno solo, che ritiri personalmente dalla dispensa quel che avrà giudicato necessario a cia-scuno”. << http://www.ora-et-labora.net/agostino_regola_testo.html>>.
Marco Frati - Le architetture
95
ancora i laici a fondare e gestire luoghi di cura. Anchedopo la peste nera del 1348 un nuovo ciclo di fonda-zioni investì l’Europa. Non appena gli effetti di una di queste ondate dientusiasmo caritativo stava per spegnersi, l’emergenzadell’indigenza imponeva un immediato risveglio dellecoscienze e una soluzione operativa: gli ospedali49. Sese ne osserva la distribuzione nello spazio urbano diFirenze50, appare evidente la dislocazione soprattuttoai margini della città, presso le porte urbiche dellaquinta e della sesta-settima cerchia e lungo le princi-pali strade di collegamento con il contado, per l’ovvianecessità di rendersi facilmente visibili e raggiungibilidai viaggiatori e per la convenienza di allontanare ilpericolo (contagio, tumulti) dalle più prestigiose areecentrali della città.Ai tempi di Dante (che li descrive come luoghi malsa-ni: Inf. XXIX, 46-49), Firenze aveva già sviluppatouna fortissima sensibilità pubblica nei confronti degliospedali, che risultano essere tutelati fin dagli statuticittadini del 1255. Intorno al 1300 risultavano fonda-ti ben 24 enti assistenziali51 ma delle loro sedi quasinulla è giunto fino a noi. Per avere un’idea della con-sistenza degli ospedali medievali fiorentini, bisognaosservare le strutture trecentesche superstiti, apparte-nenti perlopiù a enti specializzati. La chiesa, il chio-stro e il portico di San Jacopo in Campo Corbolini(fig. 12), realizzati per l’ordine monastico-militare deitemplari entro il 1317, si mostrano ancora in buone
condizioni52; di Santa Maria della Scala, costruita nel1313, resta una piccola parte del portico murato (fig.13).Gli ospedali tardomedievali urbani, finalmente ten-denti a specializzarsi in xenodochi per pellegrini (poisuperati dalle locande per i viandanti, gestiti da alber-gatori organizzatisi in una corporazione)53, lazzerettiper infetti, orfanotrofi per gettatelli, nosocomi permalati cronici, infermerie per feriti e malati, manico-mi per matti, ospizi per anziani e vedove, presero tuttiuna struttura organizzata in una parte introversa (ilchiostro) per la cura continua, e in una estroversa (ilportico) per l’elemosina e la prima accoglienza. Cosìfurono concepiti gli ospedali monumentali di San Matteo per gl’infermi54, di Santa Maria
Fig. 12 - Il portico dell’ospedale di San Jacopo in CampoCorbolini a Firenze. Uno spazio coperto di accoglienza eraessenziale negli ospedali medievali.
49 Sulla questione delle strutture materiali degli ospedali, Germain BAZIN, L’architecture hospitalière, “L’Oeil”, C, 1963, pp. 26-33, e Dankwart LEISTIKOW, Diecisecoli di storia degli edifici ospedalieri, Boehringer, Ingelheim am Rhein 1967; Italo MORETTI, Ospedale, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, vol. VIII, Roma 1997, pp.906-917; Epifanio LI CALZI, Stefano FONTANA, Alessandra SANDOLO, Per una storia dell’architettura ospedaliera, CLUP, Milano 2002.50 FANELLI 1980, fig. 17, app. 10; Renato STOPANI, Ospedali e xenodochi a Firenze e lungo el vie maestre del suburbio fiorentino nei secoli XIII e XIV, in Storia dellasolidarietà a Firenze, atti del ciclo di conferenze (Firenze, primavera 1984), LEF, Firenze 1985, pp. 5-22.51 Badia Fiorentina nel 1031, San Niccolò nel 1031, San Paolo in Pinti nel 1065, San Miniato del Ponte entro il 1068, San Giovanni Evangelista entro l’XI secolo,San Lorenzo entro il 1117, Sant’Eusebio entro il 1192, San Gallo nel 1218, San Pancrazio entro il 1219, Buonamico entro il 1252, Santa Trinita entro il 1256, SantaMaria Novella entro il 1258, San Giorgio entro il 1273, San Piero Gattolino entro il 1273, Santa Lucia de’ Magnoli nel 1283, Santa Candida entro il 1284, SantaMaria Nuova entro il 1286, San Sebastiano dei Bini nel 1228, Santo Sepolcro entro il 1292, Giamboni entro il 1293, Servanti entro il 1295, Misericordia entro il1298, Santissima Annunziata entro il 1300, San Giovanni Battista Decollato entro il 1308. Cfr. Rationes Decimarum 1932, pp. 10-15; II, pp. 3-10; RobertDAVIDSOHN, Storia di Firenze, 8 voll., Sansoni, Firenze 1956-1968, vol. VII, p. 87; FANELLI 1980, fig. 17, app. 10; STOPANI 1985.52 Bartolommeo GALILEI, Cabreo della commenda di S. Jacopo in Campo Corbolini, s.l. 1651; Siegrid DÜLL, Das Grabmal des Johanniters Pietro da Imola in S. Jacopoin Campo Corbolini in Florenz : zur Renaissance-Kapitalis in erneuerten Inschriften des Trecento, “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, XXXIV,1990, 1-2, pp. 101-122, sulla lapide sepolcrale del 1330; Valerio ASCANI, L’architettura religiosa degli Ordini militari in Toscana, in Monaci in armi. L’architettura sacradei templari attraverso il Mediterraneo, atti del I Convegno “I Templari e San Bernardo di Chiaravalle” (Certosa di Firenze, 23-24 ottobre 1992), tip. Bertelli, Certosadi Firenze 1996, pp. 187-245: 235-245, sull’architettura; Paolo PIRILLO, Terra Santa e ordini militari attraverso i testamenti fiorentini prima e dopo la caduta di SanGiovanni d’Acri, in Acri 1292. La fine della presenza degli ordini militari in Terra Santa e i nuovi orientamenti nel XIV secolo, a cura di Francesco Tommasi,Quattroemme, Perugia 1996, pp. 121-135: 128-135, sulla presenza templare a Firenze; Ludovica SEBREGONDI, San Jacopo in Campo Corbolini a Firenze: percorsi sto-rici dai templari all’ordine di Malta all’era moderna, Edifir Edizioni, Firenze 2005.53 Cfr. Charles-Marie DE LA RONCIÈRE, Florence centre économique regional au XIVe siecle, 5 voll., s.o.d.e.b., Aix-en Provence 1976 (trad. it. Firenze e le sue campa-gne nel Trecento: mercanti, produzione, traffici, Olschki, Firenze 2005).54 Alfredo BARBACCI, Cronache d'arte: la Loggia di San Matteo a Firenze e la sua liberazione, “Bollettino d'arte”, 3.Ser., XXXII, 1938, pp. 65-73; Amedeo ORLANDINI,Descrizione dei lavori di ripristino, consolidamento e restauro nella Loggia di San Matteo a Firenze, Bertieri, Milano 1940; Angela RENSI, L'ospedale di San Matteo aFirenze: un cantiere della fine del Trecento, “Rivista d'arte”, XLIX, 1987, pp. 83-145; Esther DIANA, San Matteo e San Giovanni di Dio: due ospedali nella storia fioren-tina; struttura nosocomiale, patrimonio fondiario e assistenza nella Firenze dei secoli XV-XVIII, Le Lettere, Firenze 1999.
degl’Innocenti55 e di San Paolo dei convalescenti56.Il più vasto e complesso ospedale di Santa MariaNuova57, destinato a diventare l’unico nosocomiodella città, fornisce il prototipo del doppio impiantocruciforme (uno per le donne, uno per gli uomini),con l’altare posto all’incrocio di due grandi corsie58. Numerosi ospedali si trovavano naturalmente anchetutto intorno alla città e lungo le strade principali. Adesempio, sulla via per Pisa59, già all’inizio del suo per-corso, in prossimità della Porta a San Frediano, sorge-va un ospedale “in populo Sanctae Mariae de Verzariaiuxta stratam qua itur Florentia Pisas”. Ospedali si tro-vavano anche “in burgo Sancti Fridiani”, a Legnaia(del Cappone), a Ponte a Greve e a Casellina.Proseguendo, s’incontravano a Lastra a Signa l’ospe-dale di Sant’Antonio, fondato nel 1411 per incaricodei consoli fiorentini dell’Arte della Seta, con il pro-babile contributo progettuale di Brunelleschi; aGangalandi (sopra Ponte a Signa) un ospedale posto“prope fossatum Rimagii et prope stratam publicam”; aSigna l’ospedale di San Francesco e quello della pieve.Altre istituzioni che servivano a ospitare i pellegrinierano poi a Montelupo (l’“Hospitale Virginis Mariesive della Tagliata” e uno tenuto dai domenicani),intorno a Pontorme (Santa Maria Maddalena a Est,
Marco Frati - Le architetture
96
55 Notizie storiche dell’Ospedale degli Innocenti di Firenze dall’epoca della sua fondazione a quella dell’anno 1882, cioè dal sec. XIV al sec. XIX, Le Monnier, Firenze 1853;Gaetano BRUSCOLI, Lo spedale di Santa Maria degl’Innocenti di Firenze: dalla sua fondazione ai giorni nostri, Tip. Ariani, Firenze 1900; Ugo CHERICI, Guida storicoartistica del R. Spedale di S. Maria degli Innocenti di Firenze, Tip. Bandettini, Firenze 1926; Giovanni DALLAI, Manuel CORDOSSO MENDES ATANASIC, Nuove inda-gini sullo Spedale degli Innocenti a Firenze, “Commentari”, XVII, 1966, pp. 83-106; Il museo dello Spedale degli Innocenti a Firenze, a cura di Luciano Bellosi, Electa,Milano 1977; Daniele LOMBARDI, Incanti clandestini: musei e meraviglie di una insolita Firenze, vol I: Galleria Spedale degli Innocenti, Giuntina, Firenze 1984; GliInnocenti e Firenze nei secoli: un ospedale, un archivio, una città, a cura di Lucia Sandri, Studio per Edizioni Scelte, Firenze 1996; 56 Marco BINI, Daniele MASSARIA, Gabriella OREFICE, Sabrina PANETTERI, L’ospedale di San Paolo a Firenze tra storia e rilievo, Alinea, Firenze 2002. 57 Il patrimonio artistico dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Episodi di committenza, a cura di Cristina De Benedictis, Polistampa, Firenze 2002, con nume-rosi contributi di studiosi che si sono misurati con il complesso e poco accessibile monumento cittadino, offre lo spunto per una riflessione sul tema dell’architettu-ra ospedaliera medievale e per alcune integrazioni documentarie alle conclusioni del libro, che si propone molto ben fornito sotto il profilo storico-artistico. Sul pianoarchitettonico, le considerazioni degli studiosi, che ben inseriscono il processo di sviluppo dell’ospedale nella storia della città, rischiano, in mancanza dell’analisiarcheometrica delle strutture e di un rilievo architettonico sufficientemente preciso, di non individuare chiaramente le fasi costruttive, difficilmente distinguibili sottol’intonaco che le copre, o di proporre datazioni incongruenti fra loro. I recenti scavi nel chiostro trecentesco, eseguiti in emergenza, hanno contribuito solo in mini-ma parte alla ricostruzione delle strutture medievali, mentre l’analisi della documentazione d’archivio riguardante i lavori edilizi, facilmente rintracciabili attraversole utili indicazioni di Richard A. GOLDTHWAITE, The Building of the Reinassance Florence. An Economic and Social History, The John Hopkins University Press,Baltimore-London 1980 (trad. it. La costruzione della Firenze rinascimentale. Una storia economica e sociale, il Mulino, Bologna 1984), potrebbe servire a precisarealmeno qualcuno degli importanti interventi trecenteschi: ASF, Santa Maria Nuova, 4390, 4392, 4403-4404, 4408, 4416-4417, 4420-4421, 4426-4428; cfr. AntonioCOCCHI, Relazione dello Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze, a cura di Maria Mannelli Goggioli, Le Lettere, Firenze 2000; Santa Maria Nuova e gli Uffizi: vicen-de di un patrimonio nascosto, catalogo della mostra (Firenze, 28 giugno-27 settembre 2006) a cura di Alessandro Coppellotti, Cristina De Benedictis ed Esther Diana,Edizioni Polistampa, Firenze 2006, che tralascia le vicende trecentesche.58 Adriano PERONI, Il modello dell'Ospedale Cruciforme: il problema del rapporto tra l’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze e gli Ospedali lombardi, in Florence andMilan: Comparisons and Relations, Acts of two Conferences (Villa I Tatti, 1982-1984), a cura di Sergio Bertelli, Nicholas Rubinstein e Craigh Hugh Smith, La NuovaItalia, Firenze 1989, vol. II, pp. 53-65. 59 La via Pisana medievale, rispetto a quella attuale, è probabile si caratterizzasse per un percorso dallo svolgimento più pedecollinare, discostandosi maggiormentedal corso dell’Arno, non sempre transitabile a causa delle frequenti esondazioni e degli acquitrini. Nel tempo non devono essere mancati correzioni, aggiustamenti emodificazioni del tracciato: già nel 1285, nel Consiglio del Capitano del Popolo, si discuteva di riparare la strada da Empoli per Pisa, e nello Statuto del 1322-1325si parla della “stratam novam et carrarecciam confectam a Ponte de Signe ad Pontem Pese de Monte Lupo” che, abbandonando il percorso collinare per Malmantile,si sarebbe spostata lungo il fiume passando per la Gonfolina. Cfr. Le Consulte della Repubblica Fiorentina dall’anno 1280 al 1298, a cura di Alessandro Gherardi, vol.I, Sansoni, Firenze 1896, p. 269; Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25, a cura di Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi, Olschki, Firenze1999, L. IV, cap. 10.
Fig. 13 - L’ospedale di Santa Maria della Scala a Firenze. Apiano terra si apriva un ampio porticato e i piloni angolarierano articolati da tabernacoli a nicchia come più tardi quellidi Orsanmichele.
Santa Lucia a Pietrafitta a Ovest), a Cerbaiola (il gui-dingo “Hospitale Sancti Leonardi de Cerbaiola”) esoprattutto ad Empoli, dove nel Trecento è documen-tata l’esistenza di ben tre ospedali: la “Domus paupe-rum hospitalis”, l’“Hospitale Ecclesiae Sancti Augustini”e l’“Hospitale Societas Annunciate plebis”. Accanto aquesti enti assistenziali esistevano le strutture com-merciali di carattere ricettivo, croce e delizia dei viag-giatori (Purg. XXVII, 109-111), che si addensavanonei principali centri attraversati dalla via. Ve ne eranosoprattutto a Empoli, a Lastra a Signa e a Gangalandima, come risulta dallo Statuto dell’Arte degliAlbergatori del 1334, “hospitatores” privati si trovava-no anche a Legnaia, Scandicci, Ponte a Greve, nelPiano di Settimo, Ugnano, Malmantile, Montelupo ePontorme60.
5. I luoghi del potere (schede 18-20).Le sedi delle istituzioni sono nella storia delle cittàsempre strettamente legate a chi detiene il potere, chene determina la scelta e il successo. Per Firenze mancaancora uno studio specifico che ci guidi attraverso iluoghi dell’esercizio del potere comunale da partedegli organi collegiali (assemblea, consiglio) e dei sin-goli esecutori (consoli, podestà, capitano del popolo,priori, gonfaloniere di giustizia)61. Conviene dunqueseguire, intrecciandole, le notizie riguardanti le istitu-zioni e gli spazi pubblici della città62. Abbiamo già visto una prima forma di partecipazionecomunitaria all’amministrazione al tempo di Matildedi Canossa (che confermò a Firenze il ruolo di capita-le della marca e della riforma gregoriana) con la con-tribuzione alla manutenzione delle mura alla finedell’XI secolo. A quel tempo il centro politico era ilpalazzo marchionale, già vescovile, dotato di una log-gia, di un atrio e di una scala monumentale. Nel XII secolo, morta Matilde (alla quale si deveanche altrove il sorgere dell’autonomia delle comuni-tà urbane, come a Modena), vescovo e comune con-
dussero insieme la città, in assenza di un’altra figura(un conte ad esempio, come in altre realtà toscane) acontendere loro il potere. Era la cattedrale, simbolodell’identità cittadina, ad accogliere le assemblee pub-bliche (dei boni homines e della concione). Quandopoi nel 1207 venne chiamato a Firenze il primo pode-stà straniero, lo si fece risiedere proprio nell’episcopio. Ma il comune, possiamo pensare dopo il 1183 (pacedi Costanza), si dotò presto di una propria sede stabi-le: già nel 1208 esisteva infatti nella “placza commu-nis” (presso la chiesa di San Pier Scheraggio, ove sorgePalazzo Vecchio) un “palatium communis”, distruttoperò nel 1235 durante una sommossa popolare. Entroil 1240, ancora in età federiciana, quando i comuniitaliani erano sottoposti al severo controllo dei vicariimperiali, un nuovo palazzo del comune fu prestocostruito (o allestito) presso San Michele in Orto,chiesetta demolita almeno un anno prima (non sap-piamo se apposta).I ghibellini fiorentini, pur essendo al governo conl’appoggio imperiale, concedettero nel 1244 la forma-zione di una nuova istituzione, che affiancava ilcomune: il cosiddetto ‘Primo Popolo’ (Par. XVI, 151-152), che raccoglieva l’emergente ceto borghese ed eraretto da un capitano. Con la morte di Federico II nel1250, i guelfi, che si riconoscevano nell’organizzazio-ne popolare, insorsero prendendo il potere. Subito sipensò di dotare il capitano del popolo di una propriasede (fig. 14), realizzata cinque anni dopo fra la BadiaFiorentina e Sant’Apollinare (chiese dove già si eranotenute riunioni assembleari) com’è orgogliosamentedichiarato nella lapide in facciata63.L’edificio64, noto dall’età medicea in poi come‘Bargello’ perché divenuto sede del capo della polizia,si proponeva in origine come un parallelepipedo stret-to fra le case (la piazza San Firenze non esisteva anco-ra), munito di una slanciata torre angolare (preesisten-te), privo di aperture a piano terra ma con una scalamonumentale esterna: una vera e propria fortezza,
Marco Frati - Le architetture
97
60 Cfr. DE LA RONCIÉRE 1976.61 Sul tema generale, cfr. Marco FRATI, I luoghi del potere nella città medievale: il Piemonte orientale fra ripresa urbana e regime visconteo, tesi di dottorato diricerca in Storia e critica dei beni architettonici e ambientali, XIII ciclo, tutors Vera Comoli e Claudia Bonardi, Politecnico di Torino, 2001.62 Robert DAVIDSOHN, Forschungen zur Geschichte von Florenz, 4 voll., Mittler, Berlin 1896-1908; IDEM, Geschichte von Florenz, 4 voll., Mittler, Berlin 1896-1925.63 Jane MAC CRACKEN, The Dedication Inscription of the Palazzo del Podestà Dating from the Period of the First Democracy (1250-1260) Probably Composed byBrunetto Latini, “Rivista d’Arte”, vol. XXX, 1955, pp. 182-205.64 Walter PAATZ, Zur Baugeschichte des Palazzo del Podestà (Bargello) in Florenz, “Mitteilungen des Kunsthistorischen Istitutes in Florenz”, III, 1932, pp. 287-321; Mostra documentaria e iconografica del Palazzo del Podestà (Bargello), catalogo della mostra (Firenze, aprile-giugno 1963), Tipografia Giuntina, Firenze1963; La storia del Bargello 2004; S. Maria del Fiore: teorie e storie dell’archeologia e del restauro nella città delle fabbriche arnolfiane, a cura di Giuseppe Rocchi,Alinea Editrice, Firenze 2006.
assai diversa dai ‘broletti’ lombardi costruiti intorno al1200 (semplici e vasti spazi dall’aspetto di piazzecoperte e sopraelevate)65, ma simile al palazzo pubbli-co di Volterra, realizzato pochi anni prima. I rappre-sentanti delle istituzioni, non più emanazione dell’in-tera comunità urbana ma della sola parte al potere,erano costretti a vivere asserragliati nelle loro sedi,sempre sotto la minaccia di sommosse e attacchi mili-tari. Nel 1260, rovesciato il governo guelfo e pure l’armedel comune (il giglio, ora bianco in campo rosso, orarosso in campo bianco: Par. XVI, 152-154), il PrimoPopolo fu abolito e il podestà (che aveva sempredimorato in case private) si trasferì nel Bargello66. Lafunzione di sede del podestà era attiva anche al tempo
di Dante, quando il palazzo subì continue trasforma-zioni, che riflettono la turbolenza della lotta politicadi allora. Nel 1282-1283 al comune vennero affiancati i prioridelle arti, nuovi organi che rappresentano le compo-nenti professionali della società, inaugurando il regi-me borghese e corporativo conosciuto come ‘SecondoPopolo’ destinato a inquadrare tutta la vita politica diFirenze fino alla fine del Quattrocento. Subito vennerealizzata una loggia terrazzata in corrispondenza del-l’arrivo della scala alla sala del primo piano, dove siteneva pubblicamente il consiglio del secondo popo-lo, e nel 1292 furono deliberati i primi restauri (alcortile?). Inizialmente i priori, che restavano in carica sei mesi,abitavano la torre della Castagna (fig. 15)67, vicinaalla Badia e alle case dei Della Bella (in piazza deiTavolini) e di Dante, che ricorda come Giano dellaBella, di una delle prime cinque famiglie nobili diFirenze (onorate dal marchese Ugo di portare la suastessa ‘bella’ insegna), si fosse unito al popolo (Par.XVI, 131-132) contro il suo stesso ceto: fu lui l’ispi-ratore degli Ordinamenti di giustizia, provvedimentilegislativi assai duri nei confronti dei nobili e dei ric-chi che vennero promulgati nel 1293. La tensione chene derivò fu tale che già l’anno successivo apparvenecessaria la costruzione di un “palatium dominorumpriorum artium” che però non fu attuata subito.Nel 1295 il popolo, deluso per la mancata condannaa morte dell’omicida Corso Donati (ricchissimouomo e futuro capo dei guelfi neri), assalì il palazzodel podestà, incendiandone le porte: per isolare il tri-bunale dal resto del palazzo l’anno successivo si deli-berò l’apertura di una nuova porta di accesso al corti-le su via della Vigna Vecchia (a mio parere con il con-corso di Arnolfo di Cambio: fig. 16) e la costruzionein fondo al cortile di tre sale per i giudici dei sestieri.Nel 1297 si progetta di collegare il palazzo alla loggiadel grano in Orsanmichele attraverso i terreni dellaBadia ma i monaci ottengono la restituzione dei beniespropriati lasciando incompiuta l’iniziativa. Finalmente, come ricorda il Villani, “Nel detto annoMCCLXXXXVIII si cominciò a fondare il palagio de’
Marco Frati - Le architetture
98
Fig. 14 - Il Palazzo del Bargello a Firenze, costruito come sededel Capitano del Popolo poco dopo l’affermazione politica delpartito guelfo in città.
65 Pier Francesco PISTILLI, Broletto, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1991-2000, vol. III, pp. 765-767; GiancarloANDENNA, La simbologia del potere nelle città comunali lombarde: i palazzi pubblici, in Le forme della propaganda politica nel due e trecento, atti del Convegnointernazionale (Trieste, 2-5 marzo 1993), a cura di Paolo Cammarosano, École Française de Rome, Roma 1994, pp. 369-393; Carlo TOSCO, Potere civile earchitettura. La nascita dei palazzi comunali nell’Italia nord-occidentale, “Bollettino Storico Bibliografico Subalpino”, XCVII, 1999, pp. 513-545.66 Il ghibellino conte Guido Novello “tenea ragione nel palagio vecchio del popolo a San Pulinari, ed era la scala di fuori”: VILLANI, VI, 80.67 Dino COMPAGNI, Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi, a cura di Guido Bezzola, Rizzoli, Milano 1982, libro I, cap. 4.
priori per lo Comune e popolo di Firenze, per le novi-tà cominciate tra ‘l popolo e’ grandi, che ispesso era laterra in gelosia e in commozione, a la riformazione delpriorato di due in due mesi, per le sette già comincia-te, e i priori che reggeano il popolo e tutta la repub-blica non parea loro essere sicuri ove abitavano innan-zi, ch’era ne la casa de’ Cerchi bianchi dietro a la chie-sa di San Brocolo. E colà dove puosono il detto palaz-zo furono anticamente le case degli Uberti, ribelli diFirenze e Ghibellini; e di que’ loro casolari fecionopiazza, acciò che mai non si rifacessono. E perché ildetto palazzo non si ponesse in sul terreno de’ dettiUberti coloro chell’ebbono a far fare il puosonomusso, che fu grande difalta a lasciare però di nonfarlo quadro, e più discostato da la chiesa di San PieroScheraggio”68. Esautorato Giano e sfiorata la guerra civile nel 1295,la residenza dei priori si era spostata dunque nell’am-bito territoriale della parte al potere (i guelfi bianchi)
ma la generale insicurezza consigliò di tornare al sitodel primo palazzo comunale. Il palazzo dei Priori (fig.17) o della Signoria (dall’età medicea in poi PalazzoVecchio) fu dunque realizzato sul sito della fantoma-tica torre longobarda del ‘Guardingo’ (Inf. XXIII,108) e vicino alla chiesa di San Pier Scheraggio, doveanche Dante parlò ai concittadini dall’ambone cheora si trova in San Leonardo ad Arcetri69. Nel 1300 siaccese la lotta fra bianchi (capeggiati dai Cerchi) eneri, sopita due anni dopo con l’intervento del legatopapale e il conseguente esilio dei bianchi, compresol’Alighieri. La necessità di difendere le istituzioni cit-tadine dalla minaccia dell’uno o dell’altro partito fecesì che il cantiere del nuovo palazzo venisse rapidamen-
Marco Frati - Le architetture
99
Fig. 15 - La torre della Castagna a Firenze: prima sede deipriori delle arti, espressione politica delle corporazioni e dellasocietà borghese.
Fig. 16 - Il fianco del Bargello a Firenze. L’ingresso al cortiledove si trovava il tribunale, aperto dopo i disordini antima-gnatizi.
68 VILLANI, IX, 26.69 TIGLER 2006, pp. 146-153.
te concluso: nel fatale (per Dante) anno 1302 i priorie il gonfaloniere vi risultavano già insediati e nel 1306se ne completò la copertura70. Anche il cantiere del Bargello riflette le vicende poli-tico-militari: nel 1304 un incendio scoppiato durantela guerra civile raggiunse la torre dalla quale precipitòla campana. Con la dedizione di Firenze a Robertod’Angiò, il vecchio palazzo podestarile diventò sededel vicario regio: fra il 1317 (prime delibere e stanzia-menti) e il 1320 (ultimo appalto) si realizzarono lasede del camerario (una vera e propria cassaforte), ilquartiere del vicario e la nuova loggia fra il vecchio
nucleo e il nuovo ampliamento. L’esercizio della giustizia, uno dei più importantiambiti del potere comunale, si svolgeva nel Bargello,eletto, come si è visto, a sede del podestà e del capita-no del popolo: qui le sentenze venivano proclamate e,se corporali, eseguite. Nel caso, invece, di pene deten-tive, la città si era dotata di carceri la cui tetraggine èspesso richiamata dal Poeta, che insiste sulla loro scar-sità di luce e aria (Inf. X, 58-59; XXXIII, 55-56;Purg. XXIII, 103). Le più antiche prigioni vennero allestite nelle “burel-la” (Inf. XXXIV, 98) del “Parlascio”, cioè nelle voltedella cavea dell’anfiteatro romano retrostante il sito diPalazzo Vecchio (fig. 18): luoghi sotterranei e chiusi,molto adatti ad ‘accogliere’ anche i prigionieri politicicome i ghibellini della battaglia di Campaldino(1289)71.Nel 1303, in piena lotta fra bianchi e neri, il comunedecise di costruire un nuovo carcere (fig. 19) sui ter-reni e con le pietre delle case degli Uberti presso lachiesa dei Santi Simone e Giuda (sito dell’attualeTeatro Verdi). L’edificio costituisce un prototipo deimoderni penitenziari: un alto recinto privo di merliche comprende un intero isolato e racchiude padiglio-ni e spazi aperti72. Il carcere venne immediatamente
Marco Frati - Le architetture
100
Fig. 17 - Plastico di Palazzo Vecchio a Firenze. Le sue struttu-re, compresa la torre della Vacca, vennero fondate sfiorandol’area maledetta degli edifici demoliti ai ghibellini Uberti.
Fig. 18 - I resti della cavea del teatro romano, situati sotto ilPalazzo Vecchio di Firenze. Le cosiddette ‘burella’ furono alungo utilizzate come prigioni.
70 Sulle fasi iniziali del palazzo, cfr. Gargano GARGANI, Dell’antico Palazzo della Signoria Fiorentina durante la Repubblica. Discorso storico artistico, tip. Ricci,Firenze 1872; Alfredo LENSI, Palazzo Vecchio, Bestetti e Tumminelli, Milano-Roma 1929; Mostra documentaria e iconografica di Palazzo Vecchio, catalogo dellamostra (Firenze, giugno-luglio 1957), tip. Giuntina, Firenze 1957; Marvin TRACHTENBERG, What Brunelleschi saw: Monument and Site at the Palazzo Vecchioat Florence, “Journal of the Society of Architectural Historians”, vol. XLVII, 1988, pp. 14-44; Nicolai RUBINSTEIN, The Palazzo Vecchio, 1298-1532: gover-nment, and imagery in the civic palace of the Florentine Republic, Clarendon, Oxford 1995; Marvin TRACHTENBERG, Founding the Palazzo Vecchio in 1299: theCorso Donati Paradox, “Renaissance Quarterly”, vol. LII, 1999, pp. 967-993; Maria Teresa BARTOLI, “Musso e non quadro”: la strana figura di Palazzo Vecchiodal suo rilievo, Alinea, Firenze 2007; Simonetta FIAMMINGHI, Da quartiere medievale a palazzo, in <<http://www.archeofirenze.unisi.it/scavi_elevatiPV.htm>>;Marco FRATI, «mura maternali, testimoni a tante grandi cose». Una lettura archeologica del rivestimento lapideo di Palazzo Vecchio, «Bollettino della Società distudi fiorentini», vol. II-XIII, in corso di stampa.71 Riccardo FRANCOVICH, Federico CANTINI, Emiliano SCAMPOLI, Jacopo BRUTTINI, La storia di Firenze tra tarda antichità e medioevo. Nuovi dati dallo scavodi via de’ Castellani, “Annali di Storia di Firenze”, II, 2007, pp. 9-48.72 Fruttuoso BECCHI, Sulle Stinche di Firenze e su’ nuovi edifizi eretti in quel luogo, Le Monnier, Firenze 1839.
utilizzato dopo l’assedio del castello delle Stinche deiCavalcanti in val di Greve, ove erano asserragliati ibianchi e i ghibellini, che furono rinchiusi in quelloche d’allora in avanti fu appunto ricordato come ‘leStinche’.
6. Le infrastrutture (schede 21-22).Rispetto alle città contemporanee postindustriali, lospazio costruito di quelle medievali appare certamen-te di gran lunga più povero di servizi tecnologici.Fogne, fonti, sistemi d’illuminazione notturna eranoassai rari e, quando esistevano, venivano largamentecelebrati dai loro responsabili che se ne fregiavanocome titolo di prestigio73. Non manca nellaCommedia un riferimento alla Fonte Branda nelcastello di Romena (Inf. XXX,78)74 ma della cittàsono altri gli edifici pubblici di carattere utilitaristicoche Dante dimostra di ricordare: i ponti, il mercato e,come si è già visto, le mura. Il Ponte Vecchio (fig. 20), guardato ancora dalla sta-
tua equestre di Marte (Par. XVI, 145-146), al tempodi Dante era a cinque arcate e largo la metà dell’attua-le. Spazzato via dall’alluvione del 1333 insieme “aquella pietra scema che guarda ’l ponte”, esso fu pro-gettato come una ‘piazza’: uno spazio aperto sospesosul fiume e circondato, come si esprime il cronista
Goro Dati, da “bellissime botteghe d’artieri lavoratedi pietra concia”75. Il ponte fu concepito anche comefortezza il cui carattere militare è denunciato dallamerlatura che proteggeva la strada e le botteghe sullesponde76. I lavori furono rallentati dagli eventi politi-ci che coinvolsero la città: nel 1342 le pietre conce eil legname per il ponte Vecchio vennero assegnati allafortificazione di Palazzo Vecchio per il Duca diAtene77. L’anno dopo “ancora era di legname”78 efinalmente nel 1345 il cantiere venne eseguito secon-do le dimensioni previste79, come si può verificareattraverso il rilievo80.L’altro ponte ricordato da Dante è il terzo costruito incittà: quello di Rubaconte (Purg. XII, 102), poi ‘alleGrazie’. Il ponte venne realizzato nel 1237 a chiusuradelle mura a Est, presso il porto fluviale sull’Arno, dalpodestà milanese Rubaconte da Mandello, al quale icronisti Villani e Malispini riconoscono grandeimportanza nel dare avvio alla sistemazione degli spazi
Marco Frati - Le architetture
101
Fig. 19 - Fabio Bartoloni, Il carcere delle Stinche a Firenze(Collezione della Cassa di Risparmio di Firenze). L’edificiocostituiva un prototipo dei moderni penitenziari.
73 Duccio BALESTRACCI, Gli edifici di pubblica utilità nella Toscana medievale, in L’architettura civile in Toscana: il Medioevo, a cura di Amerigo Restucci,Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 1995, pp. 225-267.74 Si veda il saggio di Marco Frati, Luoghi danteschi. Temi e significati: dinamiche del popolamento, dialettica territoriale, modelli insediativi, in questo stessovolume.75 Gregorio DATI, L’Historia di Firenze dal 1380 al 1405, a cura di Luigi Pratesi, Tonti, Norcia 1904, p. 115. 76 Sull’architettura del ponte, Mostra documentaria e iconografica degli antichi ponti di Firenze, catalogo della mostra (Firenze, aprile-giugno 1961) a cura diGiulia Camerani Marri, Tipografia Giuntina, Firenze 1961; Giuseppina Carla ROMBY, Un ponte, una città: il Ponte Vecchio di Firenze, in Un ponte, una città:il Ponte Vecchio di Firenze, Il Sedicesimo, Firenze 1988, pp. 5-16; Alessandro GUIDOTTI, Il Ponte Vecchio dalle origini al 1593, in Un ponte dalle botteghe d’oro.Le botteghe degli orafi sul Ponte Vecchio. Quattro secoli di storia, a cura di Dora Liscia Bemporad, de Montemayor, Firenze 1993, pp. 51-62.77 “E il detto compreso fece cominciare e fondare di grosse mura e torri e barbacani per farne col palagio insieme uno grande e forte castello, lasciando illavorio di deficare il ponte Vecchio, ch’era di tanta necessità al comune di Firenze, togliendo di quello le pietre conce e legname”. VILLANI, XIII, 8.78 Ivi, 21.79 “Questo anno [1345] fu rifatto il Ponte Vecchio di pietre ed archi tre e riccamente. Lo quale ponte rimase largo 16 braccia, oltre alle botteghe, che vi sifeciono suso d’ogni lato, che furono 43, delle quali s’ebbe di pigione tanto che in meno di 20 anni francarono la spesa che gostò il ponte, e furono in voltale botteghe per più sicurtà”. MARCHIONNE DI COPPO STEFANI, Cronaca fiorentina, a cura di Niccolò Rodolico, in Antonio Ludovico MURATORI, RerumItalicarum Scriptores, a cura di Giosuè Carducci e Vittorio Fiorini, vol. XXX, t. 1, Lapi, Città di Castello 1903, p. 224.80 Danilo SCACARONI, Il Ponte Vecchio: storia e rilevamento, in Facoltà di architettura: tesi di laurea “con dignità di pubblicazione”. A.A. 1997/98, Universitàdegli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, a cura di Domenico Taddei, Alinea, Firenze 1999, pp. 17-32. Una più limitata esperienza di rilievo e verificadimensionale è stata compiuta anche dagli alunni autori della scheda n° 22.
Fig. 20 - Il Ponte Vecchio a Firenze.
pubblici della città81. Il cuore commerciale della città era, come in tutte lecittà medievali, il mercato (Par. XVI, 121). Non dob-biamo pensare a un’area precisamente delimitata:tutta la zona circostante la piazza del mercato eraoccupata da botteghe e banchi più o meno stabili. AFirenze tre erano i luoghi a questo deputati: il vecchioforo romano (piazza della Repubblica, completamen-te trasformata alla fine dell’Ottocento), il mercatonuovo in Por Santa Maria (coperto dalla loggia allametà del Cinquecento) e la loggia del grano nel popo-lo di San Michele in Orto. Quest’ultima era una strut-tura “di mattoni e con un semplice tetto di sopra”,come si esprime il Vasari che è incerto se attribuirla alfantomatico Lapo o ad Arnolfo di Cambio, e che rac-conta come un’immagine della Madonna dipintasopra uno dei pilastri da Ugolino da Siena avesse com-piuto tali miracoli, da trasformare il mercato copertoin luogo di devozione82. Quei pilastri, però, anche se“fù tenuto nobile lavoro a quel tempo”83, per il Villani“erano prima sottili, e di mattoni, mal fondati” e nonressero all’incendio del 1304; nella ricostruzione fuforse coinvolto Giotto ma la vecchia struttura di mat-toni venne definitivamente demolita nel 1337, quan-do “si cominciò a fondare i pilastri della loggia d’OrtoSammichele di pietre conce, grossi e ben formati […]che di sopra fosse un grande e magnifico palazzo condue volte […] E ordinossi che ciascuna arte di Firenzeprendesse il suo pilastro, e in quello facesse fare lafigura di quel santo in cui l’arte ha riverenza”84.Dunque, dando corpo alle intenzioni dei fiorentini,Orsanmichele (fig. 21) riassume genialmente tutte lefunzioni pubbliche pacifiche del medioevo, già ospi-tate sul suo terreno: religiose (l’antico oratorio di SanMichele in Orto e le nuove nicchie nei pilastri delleArti), commerciali (la loggia del mercato) e politico-
amministrative (l’antico palazzo del vicario federicia-no e i nuovi uffici del grano) in un solo straordinarioedificio.7. L’abitare (schede 23-24).La città che Dante descrive attraverso le parole diCacciaguida (Par. XV-XVI) è nostalgicamente idealiz-zata: saudade per la patria lontana, Sehnsucht per unmondo scomparso. Dando prova di grande senso sto-rico (Par. XVI, 73-87), il Poeta mostra la situazione di
Marco Frati - Le architetture
102
Fig. 21 - Orsanmichele a Firenze. L’originale edificio riassumegenialmente tutte le funzioni pubbliche pacifiche medievali.
81 Cfr. Ricordano MALISPINI, Storia fiorentina, ed. Vincenzo Follini, Carli, Firenze 1816, cap. 129; VILLANI, VII, 26. Il ruolo dei podestà nel far circolaremodelli urbanistici e architettonici fra una città e l’altra è ampiamente riconosciuto: Antonio Ivan PINI, Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano,CLUEB, Bologna 1986, p. 86. Sul tema in generale, cfr. I podestà dell’Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec), a cura di Jean-Claude Maire Vigueur, Ecole Française de Rome-Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 2000.82 Giorgio VASARI, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori ed architettori, 9 voll. a cura di Gaetano Milanesi, Sansoni, Firenze 1878-1881.83 ASF, Manoscritti, 167, c. 24r.84 “E nel detto anno [MCCCXXXVII], a dì XXVIIII di luglio, si cominciò a fondare i pilastri della loggia d’Orto Sammichele di pietre conce, grossi e benformati, ch’erano prima sottili, e di mattoni, mal fondati. Furonvi a·cciò cominciare i priori e podestà e capitano con tutto l’ordine delle signorie di Firenzecon grande solennità; e ordinarono che di sopra fosse un grande e magnifico palazzo con due volte, ove si governasse e guardasse la provisione del granoogn’anno per lo detto popolo. E·lla detta opera e fabrica si diè in guardia all’arte di porta Santa Maria, e diputossi al lavorio la gabella della piazza e mercatodel grano e altre gabellette di piccole entrate a tale impresa, a volerla tosto compiere. E ordinossi che ciascuna arte di Firenze prendesse il suo pilastro, e inquello facesse fare la figura di quel santo in cui l’arte ha riverenza; e ogni anno per la festa del detto santo i consoli della detta arte facessono co’ suoi arteficiofferta, e quella fosse della compagnia di Santa Maria d’Orto San Michele per dispensare a’ poveri d’Iddio; che·ffu bello ordine e divoto e onorevole a tuttala città”. VILLANI, XII, 67.
Firenze nel XII secolo, compressa all’interno dellemura matildine e organizzata intorno alle chiese par-rocchiali e alle residenze nobiliari. Ma alla fine delDuecento la città fra le mura comunali e quelle arnol-fiane appariva polarizzata dalle grandi chiese degliordini mendicanti che lottizzavano i terreni intorno ailoro conventi: così all’edilizia intensiva delle torri e deicampanili si affiancava e contrapponeva quella esten-siva delle casette e dei chiostri.L’organizzazione sociale in clan famigliari resistevacomunque ancora nell’età di Dante, “poeta e profetache si è innalzato immensamente al di sopra di quellevicende” (Sapegno)85: all’interno della cerchia anticapermanevano nuclei nobiliari caratterizzati dallacomune appartenenza di torre, palazzo, loggia, piazzae chiesa parrocchiale86. Delle relazioni fra le famiglie,le consorterie e le loro clientele sembra essere consa-pevole Dante nella descrizione, ai mitici tempi diCacciaguida, del sesto di Porta San Piero (Par. XVI,94-96) ove si collocano le prime case degli Alighieri(40-42), fra via dei Calzaioli e via degli Speziali.Preitenitto e Alighiero, figli di Cacciaguida, possede-vano case nel popolo di San Martino al Vescovo nel1189: è probabile che già loro padre e il nonnoAdamo le abitassero nel 1131, quando comparverocome testimoni ad un atto presso la stessa chiesa.Secondo Francesco Bruni, Cacciaguida aveva abitatonelle case degli Elisei (nome usato in famiglia: Par.
XV, 136) “in sul canto di Porta San Piero, dove primas’entra da Mercato Vecchio”87. I Donati (Par. XVI, 115-120), facoltosa famiglia diaspirazioni aristocratiche88, avevano non distante illoro quartier generale (Purg. XXIV, 79) composto dapalazzo, piazza e chiesa (Santa Margherita, di cui con-dividevano il patronato con Cerchi e Adimari e oveDante ebbe modo di frequentare BeatricePortinari)89. Una simile organizzazione può essereravvisata anche nel complesso residenziale deiTolomei a Siena, evocato dalla vicenda della Pia(Purg. VI, 133), formato da case, un palazzo e torrinella piazza omonima di fronte alla chiesa di SanCristoforo di cui furono patroni90.La consorteria donatesca era formata da Giandonati,Uccellini e Calfucci91 ma ad essa fu legato anche ildestino privato di Dante (che, in quanto Alighieri,afferiva ai Cerchi, capi della parte bianca), fatto spo-sare a Gemma Donati e poi esiliato dalla parte nera,capeggiata da Corso92. È particolarmente istruttivoleggere quanto scrive il Villani a proposito della resi-stenza opposta dal Donati al podestà venuto ad arre-starlo nel 1300: “s’era aserragliato nel borgo di SanPiero Maggiore a piè de le torri del Cicino, e inTorcicoda, e a la bocca che va verso le Stinche, e a lavia di San Brocolo con forti isbarre, e con genti assaisuoi consorti e amici armati, e con balestra, i quali
Marco Frati - Le architetture
103
85 Continua il Sapegno: “Il particolareggiato elenco di queste casate […] si riduce per il lettore moderno a un lungo elenco di nomi, appena ricordati nelleantiche cronache; diventa in qualche modo vivo solo se noi lo riportiamo alla passione cittadinesca di Dante, al suo orgoglio fiorentino, al suo bisogno dirivendicare l’attività politica che si concluse nell’esilio ricollegandola a una tradizione, al culto di un passato idealizzato”. Dante ALIGHIERI, La DivinaCommedia, a cura di Natalino Sapegno, La Nuova Italia, Firenze 1984, vol. III: Paradiso, p. 204.86 Jacques HEERS, Le clan familial au Moyen Âge, Presses Universitaire de France, Paris 1974 (trad. it. Il clan familiare nel Medioevo. Studi sulle strutture poli-tiche e sociali degli ambienti urbani, Liguori, Napoli 1976); IDEM, La ville au Moyen Age. Paysages, puvoirs et conflits, Fayard, Paris 1990 (trad. it. La città nelMedioevo in Occidente. Paesaggi, poteri e conflitti, a cura di Marco Tangheroni, Jaca Book, Milano 1995); Sergio RAVEGGI, Gli aristocratici in città: considera-zioni sul caso di Firenze (secc. XIII-XV), in D’une ville a l’autre: structures matérielles et organisation de l’espace dans les villes européennes (XIII-XVI siécles), actesdu Colloque de Rome (Rome, 1-4 december 1986) a cura di Jean-Claude Maire Vigueur, École Française de Rome, Roma 1989, pp. 69-86.87 ED, I, 128.88 I Donati avevano beni anche a Pinti e Montelatico da prima del 1065, acquistarono case presso San Procolo nel 1061, poi a San Martino al Vescovo e aBadia Fiorentina, possedevano poderi a monte di Firenze dove sono vicini dei Cerchi e a causa dei quali (secondo il VILLANI, IX, 39) ebbe origine la lite cheporta alla contrapposizione fra guelfi bianchi e neri a Firenze. ED, II, 555-557. 89 I Donati ottennero il patronato dopo aver restaurato la chiesa. ED, II, 555. cfr. Roberto TASSI, Giovangualberto CERI, Chiesa di Santa Margherita detta“Chiesa di Dante”, XI secolo, a cura del Centro Culturale Dantesco, M.I.R. Edizioni, Montespertoli 1996; EIDEM, Santa Margherita: la chiesa di Dante eBeatrice, Bandecchi & Vivaldi, Pontedera 2004.90 ED, IV, 462-467; V, 235-238, 618-619. Roberta MUCCIARELLI, I Tolomei banchieri di Siena: la parabola di un casato nel XIII e XIV secolo, Protagon, Firenze1995.91 ED, II, 555-557.92 Corso Donati dominò la scena politica e militare di Firenze per più di vent’anni: nel 1287 mosse la propria consorteria contro il podestà per fermareun’esecuzione capitale; come podestà di Pistoia fu artefice della vittoria dei guelfi contro aretini e ghibellini a Certomondo in Casentino nel 1289; nel 1291fu alla guida dell’assedio di Pisa senza ottenere successo; nel 1294 fu ingiustamente assolto dall’accusa di omicidio e passò al contrattacco provocando la cac-ciata di Giano della Bella; nel 1300 si mise a capo della parte nera rovesciando la maggioranza bianca al governo costretta all’esilio; nel 1303 si alleò coi guel-fi bianchi per ottenere la signoria della città, provocando guerra civile e incendio della città l’anno seguente; la sua funesta parabola si concluse nel 1308,quando si alleò con Uguccione della Faggiuola e i ghibellini toscani, dando logica conclusione alla sua ascesa signorile; la città si ribellò però al suo proponi-mento costringendolo alla fuga e alla morte nei pressi del monastero di San Salvi.
erano rinchiusi nel serraglio al suo servigio”93.Chiudendo l’accesso ad alcune vie, la consorteriapoteva dunque difendersi militarmente come in uncastello entro le mura della città. Se si osserva la dispo-sizione delle famiglie aderenti rispettivamente allaparte bianca e a quella nera (secondo il Villani)94,appare evidente come i primi (eredi della nobiltà ghi-bellina) occupassero il centro mentre i secondi (popo-lani in irresistibile ascesa economica) una coronaintorno alle mura matildine. La posizione esterna deiDonati, asserragliati ai margini della cerchia comuna-le, e dei loro alleati fornì ai neri il vantaggio tattico dipoter accerchiare i Bianchi e le sedi del potere comu-nale. E a tutti appariva evidente come fosse impossi-bile la convivenza fra nemici, tutti dotati di formida-bili macchine da guerra come le torri, spesso moltovicine le une alle altre (per esempio proprio quelle diCerchi e Donati lungo il Corso).Al tempo di Dante le città erano davvero irte di torri(fig. 22): a Firenze esse ammontavano a circa 25095.Benchè quello delle torri urbane fosse un fenomeno dinatura cittadina96, esse erano messe in relazione con leorigini rurali delle famiglie aristocratiche che ne eranoi principali committenti e proprietari. A tutti comun-que appariva chiara la funzione strategica (Purg. XVI,95-96), prim’ancora che abitativa97, delle torri,costruite per controllare gli snodi stradali e le piazze eper proteggere gli agglomerati residenziali: la loro stra-grande maggioranza risulta infatti all’interno dellemura matildine e lungo i borghi più importanti.
Spesso la loro proprietà si frammentava col passaredelle generazioni e si rendeva necessaria la fondazionedi ‘società per azioni’98 per la loro gestione: esse forni-vano però anche un’occasione di alleanza tra i diversirami delle famiglie, non sempre coese politicamente. Il grandioso affresco della “Fiorenza dentro da la cer-chia antica” (Par. XV, 97) e l’acuta veduta a volo d’uc-cello “de l’ovil di San Giovanni” (Par. XVI, 25),dipinte da Dante con grande senso della realtà, adimostrazione che “le schiatte si disfanno / […] /poscia che le cittadi termine hanno” (Par. XVI, 76-78), presentano famiglie ormai in declino o già scom-parse (Par. XVI, 88-114) il cui segno nella città restaindelebile: le torri. Solo per pochissime schiatte nonne risultano: proprio per quelle più antiche ormaiestinte (dell’Arca, Calfucci e Filippi), a dimostrazionedel generale successo del tipo edilizio.Per quanto riguarda “la cittadinanza, ch’è or mista”(Par. XVI, 49), invece, quasi tutte le famiglie cospicuecitate da Dante erano dotate di una o più torri, adimostrazione che anche per i gruppi dominanti eraormai impensabile non disporre di una macchina daguerra. E i primi edifici a fare le spese della disgraziadei loro padroni erano proprio le torri: come nel casodegli Uberti99, “quei che son disfatti / per lor super-bia” (Par. XVI, 109-110).Il Duecento vide la nascita a Firenze del palazzo pri-vato100. Dante nella Commedia prende solo un picco-lo spunto da questo tipo edilizio (Purg. X, 68) peroffrire una scena a uno dei suoi personaggi. Già alla
Marco Frati - Le architetture
104
93 VILLANI, IX, 96.94 “E’ detti Cerchi furono in Firenze capo della parte bianca, e co·lloro tennero della casa degli Adimari quasi tutti, se non se il lato de’ Cavicciuli; tutta lacasa degli Abati, la quale era allora molto possente, e parte di loro erano Guelfi e parte Ghibellini; grande parte de’ Tosinghi, ispezialmente il lato del Baschiera;parte di casa i Bardi, e parte de’ Rossi, e così de’ Frescobaldi, e parte de’ Nerli e de’ Mannelli, e tutti i Mozzi, ch’allora erano molto possenti di ricchezza e distato, tutti quegli della casa degli Scali, e la maggiore parte de’ Gherardini, tutti i Malispini, e gran parte de’ Bostichi, e Giandonati, de’ Pigli, e de’ Vecchietti,e Arrigucci, e quasi tutti i Cavalcanti, ch’erano una grande possente casa, e tutti i Falconieri, ch’erano una possente casa di popolo. E co·lloro s’accostaronomolte case e schiatte di popolani e artefici minuti, e tutti i grandi e popolani ghibellini; e per lo séguito grande ch’aveano i Cerchi il reggimento della cittàera quasi tutto in loro podere. De la parte nera furono tutti quegli della casa de’ Pazzi quasi principali co’ Donati, e tutti i Visdomini, e tutti i Manieri, e’Bagnesi, e tutti i Tornaquinci, e gli Spini, e’ Bondelmonti, e’ Gianfigliazzi, Agli, e Brunelleschi, e Cavicciuoli, e l’altra parte de’ Tosinghi, e tutto il rimanen-te; e parte di tutte le case guelfe nominate di sopra, ché quegli che non furono co’ Bianchi per contrario furono co’ Neri”. VILLANI, IX, 39.95 DAVIDSOHN 1929, p. 452. Cfr. Piero BARGELLINI, Ennio GUARNIERI, Firenze delle torri, Bonechi, Firenze 1973; Loris MACCI, Valeria ORGERA, Architetturae civiltà delle torri. Torri e famiglie nella Firenze medievale, Edifir, Firenze 1994. Lara MERCANTI, Giovanni STRAFFI, Le torri di Firenze e del suo territorio,Alinea, Firenze 2003; Fortunato GRIMALDI, Le «case-torri» di Firenze, Tassinari, Firenze 2005. Sul tema, cfr. l’aggiornamento fornito da Case e torri medieva-li, atti del II Convegno di studi La città e le case. Tessuti urbani, domus e case-torri nell’Italia comunale (secc. XI-XV) (Città della Pieve, 11-12 dicembre 1992)a cura di Elisabetta De Minicis ed Enrico Guidoni, Kappa, Roma 1996.96 Aldo Angelo SETTIA, L’esportazione di un modello urbano: torri e case forti nelle campagne del nord Italia, “Società e Storia”, IV, 1981, 12, pp. 273-299.97 Sul tema, cfr le analisi tipologiche di Fabio REDI, Edilizia medievale in Toscana, Edifir, Firenze 1989.98 Pietro SANTINI, La società delle torri in Firenze, “Archivio storico italiano”, LV, 1887, pp. 25-58, 178-204.99 ED, V, 776-781. Cfr. Guglielmo MAETZKE, Gli scavi di Piazza della Signoria a Firenze, “Prospettiva”, III, 1975, pp. 64-66. 100 Attilio SCHIAPARELLI, La casa fiorentina e i suoi arredi nei secoli XIV e XV, 2 voll. a cura di Maria Sframeli e Laura Pagnotta, Le lettere, Firenze 19832;Emma MANDELLI, Palazzi del Rinascimento: dal rilievo al confronto, Alinea, Firenze 1989; Gian Luigi MAFFEI, La casa fiorentina nella storia della città dalleorigini all’Ottocento, Marsilio, Venezia 1990; Anja ECKERT, Die Rustika in Florenz. Mittelalterliche Mauerwerks- und Steinbearbeitungstechniken in der Toskana,Deutsche Burgenvereinigung, Hannover 2000; Carlo TOSCO, Il castello, la casa, la chiesa. Architettura e società nel medioevo, Einaudi, Torino 2003, pp. 176-184.
Marco Frati - Le architetture
105
Fig. 22 - La distribuzione delle torri nella città (da Macci). Quelle numerate appartennero a famiglie citate da Dante nellaCommedia. Legenda:
metà del secolo, però, gli edifici privati che si potreb-bero definire tali a Firenze sono alcune decine, fraguelfi e ghibellini101. In particolare, il Villani ci dànotizia di quello “de’ Tosinghi in su MercatoVecchio”, semplicemente (ed eloquentemente) chia-mato ‘il Palazzo’, “alto LXXXX braccia [circa cinquan-ta metri], fatto a colonnelli di marmo, e una torre conesso alta CXXX braccia [più di settanta metri]”distrutto dai ghibellini nel 1248102: null’altro peròsappiamo degli edifici di quell’epoca, tanto più che iguasti reciproci si susseguirono ancora (ai ghibellininel 1258, ai guelfi dal 1260 al 1266).Di dimensioni più modeste, ma dai caratteri forte-mente innovativi, è il palazzo dei Mozzi (fig. 23), lacui prima fase, databile fra il 1266 e il 1273, mostrasuperfici perfettamente spianate a picconcello forateda regolari e ampie aperture archivoltate; le fasi suc-cessive, databili entro il 1309 e caratterizzate dal timi-do impiego della martellina dentata sugli stipiti delleaperture, appaiono perfettamente esemplate sulnucleo primitivo103. Date le frequentazioni romanedei Mozzi, banchieri del papa, è ipotizzabile attraver-so di loro l’ingresso a Firenze di un modello composi-tivo tardoantico come la successione regolare di aper-ture curve del Colosseo che si può riscontrare anchenel coevo palazzo senese dei Tolomei104, evocato dallavicenda della Pia (Purg. VI, 133).I Cerchi, di origini mugellane (Par. XVI, 65) e capidella fazione bianca, possedevano a Firenze nel sestodi San Piero un’antica torre, un palazzo e una loggia,tutti realizzati quando Dante era ancora in città, efurono compatroni della chiesa di SantaMargherita105. “I Cerchi acquistarono nel 1280, dopola morte della contessa Beatrice vedova di Marcovaldo
di Dovadola, il palazzo di fronte alla Badia (sesto diPorta San Piero, popolo di San Martino in Campo)che i Guidi possedevano dal tempo della buonaGualdrada”106 ma poco dopo ne realizzarono un altroall’incrocio fra via de’ Cimatori e vicolo de’ Cerchi,secondo il Fanelli “esempio di palazzo medievale fra imeglio conservati” ma evidentemente debitore almodello ampio e regolare del palazzo Mozzi a cui siispirò anche il palazzo Spini (dal 1289)107. La torre,
Marco Frati - Le architetture
106
Fig. 23 - Il palazzo dei Mozzi a Firenze. La ricca famiglia guel-fa, fra i principali finanziatori del papa, ne importò il model-lo di abitazione da Roma.
101 Per l’elenco dei guelfi (1260-1266), cfr. Liber Extimationum (Il libro degli Estimi An. MCCLXIX), a cura di Olof Brattö, Elanders Boktryckeri Artiebolag,Göteborg 1956; per quello dei ghibellini (1267), cfr. Il Libro del Chiodo, a cura di Francesca Klein, Polistampa, Firenze 2004.102 VILLANI, VII, 33; cfr. FANELLI 1980, p. 29.103 Distrutte le loro case dai ghibellini nel 1260, i guelfi Mozzi non rientrarono nel pieno controllo dei loro beni in città prima del 1266; nel 1273 alcunicomponenti della famiglia strinsero un patto di solidarietà intorno a case e terreni da loro già acquistati al Comune “in capite pontis Rubacontis in populoSancte Lucie de Magnolis”, forse sul sito dell’antica ‘Porta a Roma’, divenuta inutile con la costruzione oltrarno della sesta cerchia (1258); nello stesso annoil palazzo risultava già costruito e poteva ospitare degnamente il papa in soggiorno a Firenze, mentre nel 1279 le case sono palatium. Il documento che descri-veva la residenza urbana al momento del fallimento della compagnia, è oggi irreperibile: ASF Diplomatico, Riformagioni, atti pubblici, 6 novembre 1309, cit.in DAVIDSOHN 1929, p. 456 n. 4. Sul palazzo, che meriterebbe miglior fortuna, la bibliografia è ancora piuttosto limitata: cfr. SZNURA 1975, pp. 106-108,110; Firenze. Guida di architettura, Allemandi, Torino 1992, p. 45.104 Il palazzo venne costruito a partire dal 1267. Il Palazzo Tolomei a Siena, a cura di Giulio Prunai, Guido Pampaloni e Nello Bemporad, Cassa di Risparmio,Firenze 1971.105 Francesco MAGGINI, Frammenti d’una cronica dei Cerchi, “Archivio storico italiano”, LXXVI, 1918, pp. 97-109; Luigi STEFANI, Dante e la sua chiesa, Tip.Merciai, Firenze 1979; Brenda PREYER, Two Cerchi palaces in Florence, in Renaissance studies in honor of Craig Hugh Smyth, a cura di Andrew Morrogh, GiuntiBarbèra, Firenze 1985, vol. II, pp. 613-630; Valeria ORGERA, Recupero della torre dei Cerchi e del Teatro Nazionale a Firenze, “Firenze architettura”, III, 1999, 2, pp. 28-31.106 ED, I, 915.107 Palazzo Spini Feroni e il suo museo, a cura di Stefania Ricci, Mondadori, Milano 1995.
all’incrocio fra via de’ Cerchi e via del canto allaQuarconia, fu costruita negli anni 1292-1298 a pro-tezione del vasto complesso, che comprendeva ancheuna loggia, realizzata intorno al 1300 e oggi riconosci-bile per l’arme gentilizia che ne decora le grosse mensole.Le grandi aperture concluse da un arco a tutto sestonotevolmente ribassato ebbero grande successo aFirenze e caratterizzano l’edilizia civile di tutto il XIVsecolo. Anche nell’enorme complesso dei Peruzzi,sovrapposto all’antico anfiteatro compreso fra viaTorta e borgo dei Greci, se ne fece uso: presumibil-mente ben dopo il 1286, quando “Pacino di Arnolfocomprò dal comune una porzione delle vecchie muradella seconda cinta, la porta civica detta dei Peruzzi,una strada, una piazza e un palazzo che reca ancora lostemma della consorteria” e prima del 1345, quando ibeni di famiglia sono ben descritti nelle ricordanze108.Anche i Peruzzi in pieno Trecento realizzarono uncomplesso chiuso su se stesso che all’occorrenza pote-va essere isolato e protetto da torri e porte: la sua con-formazione ha indotto qualche studioso a datarlo aitempi di Cacciaguida, al quale è fatto ricordare che“nel picciol cerchio s’entrava per porta / che si noma-va da quei de la Pera” (Par. XVI, 125-126)109.Il modello duecentesco ebbe un successo così duratu-ro che nel secolo successivo lo si impiegò anche a scalaurbana: prima (1388) l’Opera di Santa Maria delFiore, per la sistemazione della piazza di SantaReparata dietro il coro della cattedrale appena costrui-to110; poi (1389) la Signoria, per la piazza dei Priori ele strade adiacenti111, fra cui l’importante asse di viade’ Calzaiuoli che collega duomo e palazzo pubblico.Uno degli edifici che furono interessati da questaeccezionale (per i tempi e i modi) operazione di riqua-lificazione urbana è il palazzo de’ Cavalcanti, famiglia
alla quale Dante è affettivamente assai legato (Inf. X,52-72). Alle vecchie strutture tagliate dall’allargamen-to delle strade fu sovrapposta una facciata uniformecostituita al piano terreno da fornici e porticine dallemostre di pietra bugnata, al piano mezzanino da pic-cole finestre quadrate inserite nel paramento bugnato,ai piani superiori ampie finestre archivoltate apertenel paramento liscio.Altrettanto importante nell’età di Dante ma menoduratura del palazzo fiorentino, la loggia era diffusa,soprattutto nel cuore della città, in numerosi esempla-ri, uno dei quali (la loggia de’ Pigli)112 è ricordato dalPoeta per una sua nota caratteristica: la colonna chereggeva le due sue arcate con il capitello ornato conl’arme della famiglia (Par. XVI, 103).La casa natale di Dante offre lo spunto per una rifles-sione sul medioevo fantastico e sul ripristino113. Il VICentenario della nascita (1265) e il VI Centenariodella morte (1321) hanno fornito due importantioccasioni di studio e restauro dello spazio medievale aFirenze e gli estremi cronologici di un’intensissimastagione di manipolazione dei testi architettonici114.Negli anni intorno al 1865, in concomitanza con iltrasferimento della capitale da Torino a Firenze115, fuindividuata e acquistata la supposta casa natale diDante (Inf. XXXIII, 94-95)116 e fu ripristinato ilBargello, trasformato da carcere (fino al 1858) inMuseo Nazionale da Francesco Mazzei117. Ancora nel1904 il torrione dei Compiobbesi (dal 1308 sededell’Arte della Lana), acquistato fin dal 1890 dalComune per la Commissione Storico Archeologicacomunale (coi resti architettonici e decorativi prove-nienti dal centro distrutto nel 1892), e ceduto nel1903 alla Società Dantesca Italiana per le PubblicheLettere ad Illustrazione della Divina Commedia,
Marco Frati - Le architetture
107
108 Francesca CARRARA, Palazzo Peruzzi: note storiche sulla sede della Camera del Lavoro (secoli II-XIX), Tip. Giuntina, Firenze 1995.109 ED, IV, 395-396, che esclude parentela con i famosi banchieri.110 Margareth HAINES, Attorno a Santa Maria del Fiore: la conquista dello spazio per una cattedrale, in La Piazza del Duomo nella città medievale (nord e mediaItalia, secoli XII- XVI), atti della Giornata di studio (Orvieto, 4 giugno 1994) a cura di Lucio Riccetti, “Bollettino dell’Istituto storico artistico orvietano”,XLVI-XLVII, 1997, pp. 301-332.111 FANELLI 1980, p. 45; Per approfondire, Carl FREY, Die Loggia dei Lanzi zu Florenz. Eine quellenkritische Untersuchung, Hertz, Berlin 1885.112 Gabriella OREFICE, Rilievi e memorie dell’antico centro di Firenze 1885-1895, Alinea, Firenze 1986, pp. 24, 143.113 Il Medioevo al passato e al presente, in Arti e storia nel Medioevo, a cura di Enrico Castelnuovo e Giuseppe Sergi, vol. IV, Einaudi, Torino 2004.114 Marco DEZZI BARDESCHI, Il monumento e il suo doppio: Firenze, Fratelli Alinari, Firenze 1981.115 Ugo PESCI, Firenze Capitale (1865-1870): dagli appunti di un ex cronista, Firenze, Bemporad, 1904; Carlo CRESTI, Cultura e architettura nella Firenzecapitale, “Necropoli”, 1969-70, 6-7, pp. 27-37; Osanna FANTOZZI MICALI, Brunella RAGONI, Piero ROSELLI, Elisa SPILOTROS, Nascita di una capitale: Firenze,settembre 1864-giugno 1865, Alinea, Firenze 1985.116 Della casa di Dante: relazione con documenti al Consiglio Generale del Comune di Firenze, tip. Le Monnier, Firenze 1865.117 Cfr. Luigi PASSERINI, Del Pretorio di Firenze, tip. delle Murate, Firenze 1858; Giovan Battista UCCELLI, Il Palazzo del Potestà. Illustrazione storica, tip. delleMurate, Firenze 1865; Massimo D’AZEGLIO, Intorno al restauro del Palazzo del Podestà, Carnesecchi, Firenze 1870.
venne isolato dalle case contigue e collegato aOrsanmichele da Enrico Lusini118.Dante nacque da Alighiero (II) di Bellincione diAlighiero (I) di Cacciaguida di Adamo. Il nonnoaveva acquistato da Geri del Bello una casa su via SanMartino (ora via Dante Alighieri), nella piazzetta difronte alla torre della Castagna dietro alla chiesa diSan Martino al Vescovo e vicina alla torre dei DellaBella e dei Donati, coi quali gli Alighieri condivideva-no un muro portante119. Una serie di documentidescrivono l’edificio nei suoi confini: nel 1327 un cre-ditore di Cione di Brunetto di Bellincione Alighieri(cugino di Dante) ne chiedeva l’espropriazione; noveanni più tardi i figli di Dante e loro zio Francesco (fra-tello del Poeta) si accordavano sulle rispettive proprie-tà, compromesso confermato nel 1341; nel 1344 ilfiglio di Dante Piero lasciava la sua parte di casa allaCompagnia d’Orsanmichele, con la conseguentedispersione del patrimonio familiare. Nel 1865-1868furono svolte ricerche storiche e artistiche per indivi-duare con precisione gli edifici facenti parte delle pro-
prietà Alighieri, e per poi acquistarli, ma la propostadell’ingegner Mariano Falcini di liberare gli edificidalle case vicine per mostrarne le strutture non fusubito attuata120. Nonostante una serie di precise considerazioni stori-che avessero nel frattempo suggerito che la casa nata-le del Poeta fosse probabilmente andata distrutta ecollocata nell’attuale piazza di San Martino121, nel1910-1911 Giuseppe Castellucci ripristinò gli edificiormai acquistati demolendo le costruzioni adiacentiritenute successive e ricostruendone quasi integral-mente le superfici per restituire loro un aspetto più‘medievale’, secondo il gusto purista dell’epoca122.Così, ciò in cui oggi consiste il Museo (fig. 24) non èveramente la Casa di Dante, ma la torre con le casedei Giuochi: al loro interno trovarono posto mobilid’epoca e in stile, un telaio ricostruito; oggi – supera-to l’equivoco – il museo conserva numerose riprodu-zioni di documenti sul poeta e materiale didattico chemettono in luce alcuni aspetti della sua vita e degliavvenimenti storici trattati nella Divina Commedia123.
Marco Frati - Le architetture
108
118 Cesira POZZOLINI SICILIANI, Ricordo della inaugarazione del Palagio dell’Arte della Lana in Firenze (9 maggio 1905), tip. Passerini, Prato 1905; CesareSPIGHI, Il restauro del torrione dei consoli dell’arte della lana, Firenze 1905; Igino Benedetto SUPINO, Il Palagio dell’arte della Lana in Firenze, “L’arte”, VIII,1905, pp. 266-270. Sulla storia dell’edificio, Walter BOMBE, Il Palagio dell’Arte della Lana in Firenze, “Archivio Storico Italiano”, LXXXVIII, 1930, pp. 263-278.119 ED, I, 128; II, 555-557.120 La casa di Dante Alighieri in Firenze. Relazione della Commissione istituita dalla Giunta Municipale de’ 17 marzo 1866 per compimento delle ricerche stori-che sulla medesima, tip. Le Monnier, Firenze 1869.121 Giorgio PIRANESI, Le case degli Alighieri, Lumachi, Firenze 1905.122 DEZZI BARDESCHI 1981, pp. 46-50; Cristina SANGUINETI, Giuseppe Castellucci, in Guida agli archivi di architetti e ingegneri del Novecento in Toscana, acura di Elisabetta Insabato e Cecilia Ghelli, Edifir, Firenze 2007, pp. 113-119. Sul purismo a Firenze, cfr. le giornate di studio e la mostra bibliografica-docu-mentaria dedicate a Cesare Spighi (1854-1929) e la fortuna dell'arte e dell'architettura dei "primitivi" toscani (Firenze, 3-4 ottobre 2008) organizzate dallaBiblioteca Nazionale Centrale di Firenze e dalla Società di Studi Fiorentini, e curate da Ferruccio Canali.123 La Casa di Dante: guida del museo, a cura di Silvia Meloni e Armando Nocentini, Stiav, Firenze 1965.
Fig. 24 - La casa di Dante a Firenze. In verità, si tratta delle casedei Giuochi, invece che di quelle degli Alighieri, ma l’immagine diquesto edificio è ormai entrato nella coscienza collettiva.