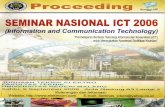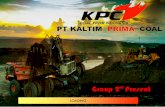Prima Industrial Holdings - Atmospheric Impact Report - zitholele
Prima di Francesco: i santi in cammino
Transcript of Prima di Francesco: i santi in cammino
Compostella
Rivista del Centro Italiano di Studi Compostellani n. 36 - 2015 ISSN 2282-6092
Direttore editoriale
Giuseppe Arlotta
Direttore responsabile Laura Marozzi
Comitato scientifico
PRESIDENTE: Paolo Caucci von Saucken (Università degli Studi di Perugia); MEMBRI: Franco Car-dini (Istituto Italiano di Scienze U-mane, Firenze); Brunello De Cusatis (Università degli Studi di Perugia); Antonietta Fucelli (Università degli Studi di Perugia); Fernando López Alsina (Universidade de Santiago de Compostela); Giorgio Otranto (Uni-versità degli Studi di Bari); Marco Piccat (Università degli Studi di Trieste); Robert Plötz (Universität Würzburg); Adeline Rucquoi (Centre de Recherches Historiques, CNRS-EHESS, Parigi); Miguel Taín Gu-zmán (Universidade de Santiago de Compostela)
Comitato di Redazione
Lucia Arcifa (Università degli Studi di Catania); Paolo Asolan (Pontificia Università Lateranense, Roma); Fa-brizio Benente (Università degli Studi di Genova); Rosanna Bianco (Università degli Studi di Bari); An-na Sulai Capponi (Università degli Studi di Perugia); Jacopo Caucci von Saucken (Università degli Studi di Firenze); Franco Cinti (Università degli Studi di Bologna); Luisa D’A-rienzo (Università degli Studi di Ca-gliari); Carla Del Zotto (Sapienza Università di Roma); Carlo Donato (Università degli Studi di Trieste); Laura Esposito (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napo-li); Dolores Fraga Sampedro (Uni-versidade de Santiago de Composte-la); Mariny Guttilla (Università degli Studi di Palermo); Marco Lazzari (Università degli Studi di Bergamo); Anne Marie Lievens (Università degli Studi di Perugia); Alfredo Lu-cioni (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano); Carmen Pugliese (Centro Italiano di Studi Compostel-lani); Laura Ramello (Università degli Studi di Torino); Guido Tam-burlini (Centro Italiano di Studi Compostellani); Anna Trono (Uni-versità del Salento)
Sommario 2 EDITORIALE: PAOLO CAUCCI VON SAUCKEN
Molteplicità di interessi nel mondo scientifico compostellano 4 COPERTINA: CARMINE ZARRA ‘Itinera peregrinorum’ negli affreschi del complesso monastico di Sant’Anna a Nocera Inferiore 15 MAURIZIO CARLO ALBERTO GORRA Riflessioni araldiche sullo stemma di S.E.R. mons. Paolo Giulietti 19 NATALIA CONDE CONDE Laurentius Hispanus o la materializzazione del concetto di Penitenza nella cattedrale di Orense (Galizia) 26 JACOPO CAUCCI VON SAUCKEN Una nuova acquisizione alla letteratura odeporica compostellana: il diario di Don Silvino Pérez Alonso, carlista e pellegrino 34 VALENTINA VARIO Storie di pellegrinaggi lungo il camino de Santiago e la ruta ignasiana Esempi di iconografia jacopea e ignaziana tra XVI e XVII secolo 43 LAURA RAMELLO Prima di Francesco: i santi in cammino 53 ANNA SPIEZIA Viaggiatori e pellegrini inglesi a Roma. L’avventura del viaggio (secc. VII-XIV) 63 EVENTI & RECENSIONI
Registrazione presso il Tribunale di Perugia n. 3/78 del 30 gennaio 1998
Finito di stampare nel mese di Novembre 2014 c/o La Buona Stampa srl di Napoli
Il Codice etico della rivista è depositato presso Istituto del Codice Etico Via Visconti di Modrone 18 - 20122 Milano [email protected] ; www.codiceetico.org
Direzione e Redazione Centro Italiano di Studi Compostellani - Università degli Studi di Perugia Via del Verzaro, 49 - 06123 Perugia Tel 075.5736381; Fax 075.5854607 [email protected] ; www.unipg.it/sdf/link/compos/santiago.htm
Progettazione editoriale Edizioni Compostellane via Grosseto - Parco Mimose, 1/A - 80038 Pomigliano d’Arco tel. 081.884.3606 [email protected] ; www.edizionicompostellane.com
LAURA RAMELLO, Prima di Francesco: i santi in cammino 43
1 F. SCARSATO, Introduzione, in On the road: pellegrinare tra antico e moderno, Atti del Convegno (San-zeno, 5-6-settembre 2008), p. 6, online: goo.gl/MuehHp (copiare il codice azzurro nella barra degli indirizzi del browser).
2 Ibidem 3 F. VANNI, Santi connessi col
pellegrinaggio. La santa famiglia di san Riccardo, in Percorsi francigeni nel Basso Vercellese e valorizzazione degli aspetti artistici, Atti del convegno La Via Francigena nel Vercellese: pluralità di percorsi, dimensione storica e valorizza-zione degli aspetti culturali (Crescenti-no, 7-8 Novembre 2008), a cura di Magda Balboni, Vercelli 2010, p. 1, online: goo.gl/vFzFWv
4 C. VAIANI, Il “cavallo di san Francesco”. L’itineranza francescana, in On the road cit., p. 66.
LAURA RAMELLO Università degli Studi di Torino
rima di Francesco: i santi in cammino
La categoria dei santi pellegrini rappresenta forse la tipologia in cui metafore, moventi e sensibilità connesse al tema dell’itineranza trovano il più evidente punto di sintesi; l’immagine dell’essere umano come homo viator e della vita come un lungo cammino appare talmente connaturata alle più diverse culture da rischia-re di scadere nel più banale dei clichés: “Probabilmente, infatti, quella del viaggio, delle migrazio-ni e della strada… è una delle in-quadrature preferite per narrare della vita, quella almeno che me-glio ne dice tutta la complessità e dinamicità. E la definizione di uo-mo quale viaggiatore e nomade, è quella che, trasversalmente una volta tanto, dall’antropologia al-l’etnologia passando per sociolo-gia e storiografia, mitologia e let-teratura, trova d’accordo tutti gli studiosi”1.
Quell’esigenza di viaggiare che sembra connaturata alla stessa essenza umana pare divenire ancor più pressante per l’uomo religioso, là dove il viaggio intreccia e confonde “il pellegrinaggio a qualche luogo san-to … e quell’itinerario tutto interiore che l’uomo di fede è chiamato a per-correre dentro di sé”2.
In questa prospettiva “i santi pellegrini non sono né un genere né una specie, semmai una categoria trasversale, un incrocio, perché non dovreb-bero esistere santi divenuti tali in quanto pellegrini, anche se talvolta si ha l’impressione che, per santi pellegrini di cui non sappiamo assolutamente nulla, si sia trattato di una sorta di attribuzione carismatica di santità”; “in quanto categoria trasversale, i santi pellegrini (o pellegrini santi)… [inducono] a chiedersi sempre se e in che misura il loro peregrinare abbia influito, in vita o post mortem, alla formazione dell’aura di santità che li circonda”3.
Nelle agiografie santità ed itineranza appaiono non di rado intimamente connesse, e non è un caso che Francesco d’Assisi usi spesso nei suoi scritti “un linguaggio che evoca il viaggio, il movimento e il cammino”4.
Prima di lui altri santi avevano deciso di percorrere le vie di pellegri-naggio verso Roma, Bari, S. Michele del Gargano, Gerusalemme e, natu-ralmente, Compostela.
P GIOTTO, Francesco dona il
suo mantello ad un cavaliere po-vero e decaduto (part.), 1295-1299, Assisi, Basilica superiore
44 COMPOSTELLA n. 36
CRONOLOGIA
Focalizzando l’attenzione sul pellegrinaggio jacopeo, e fissando come terminus ante quem il 12145, troviamo almeno una decina di figure che, secondo le fonti agiografiche, effettuarono il cammino fra il secolo IX e gli albori del XIII6:
IX SEC.: Sant’Eldrado di Novalesa XI SEC.: San Guglielmo di Vercelli, San Teobaldo Roggeri, Santa Paolina XII SEC.: San Godrico, San Morando, Santa Bona da Pisa, Sant’Alberto di
Pontida XIII SEC.: Santa Verdiana, Beato Egidio d’Assisi
Con Verdiana ed Egidio il cerchio si stringe intorno a Francesco: Ver-
diana è sua coetanea, e la tradizione vuole che nel 1221 Francesco abbia fatto visita alla santa, ormai reclusa da tredici anni nella sua cella, ammet-tendola al Terz’ordine francescano7; con Egidio entriamo a diretto contatto con lui, nella cerchia dei seguaci della prima ora del Poverello d’Assisi.
Nell’analisi delle modalità e del significato dell’esperienza di pellegri-ni jacopei di queste sante e santi si privilegerà non tanto la linea meramen-te biografica, quanto un esame comparativo delle singole esperienze, inda-gate sotto la lente di aspetti particolari, funzionali, a mio avviso, a far e-mergere le condizioni del peregrinare medievale attraverso l’individuazio-ne di eventuali costanti.
LUOGHI D’ORIGINE
Nel campione selezionato, i santi di origine italica paiono prevalere: Guglielmo e Teobaldo sono piemontesi, Alberto è lombardo, Bona e Ver-diana toscane, Egidio umbro; fra gli ‘stranieri’ contiamo un provenzale (sant’Eldrado), due tedeschi (san Morando e santa Paolina) e un inglese (san Godrico)8.
Riguardo a Guglielmo, noto anche con l’appellativo “da Montevergi-ne” dal luogo in Irpinia in cui fondò l’omonima congregazione benedetti-na9, non si conoscono con precisione né la data – fissata tradizionalmente al 1085 – né il luogo di nascita; tuttavia, poiché le fonti medievali10 lo desi-gnano sempre con l’appellativo “da Vercelli”, si può ragionevolmente rite-nere che fosse originario di questa città o del suo territorio.
Sui luoghi di origine di Teobaldo le fonti paiono assai particolareggia-te, descrivendo un territorio “in ea Liguriae parte” che, da pianeggiante nell’area fra Tanaro e Stura, si fa collinoso nei pressi del corso del fiume Ellero (“…qua ex planitie inter Tanarum et Sturiam posita, subter fluente fluvio Ellero in colles assurgit…”); in questa zona “extat oppidum Vicus dictum”11; ci troviamo dunque in Piemonte, nell’area monregalese, sul luo-go in cui sorge l’odierna Vicoforte; l’appellativo “albensis” con cui le bio-grafie qualificano spesso il santo dipende dalle vicissitudini che contraddi-stinsero la sua infanzia: rimasto orfano, a dodici anni Teobaldo andò ad Alba dove trovò lavoro presso la bottega di un ciabattino che lo accolse in casa sua.
Alberto è nativo di Pontida, mentre Pisa e Castelfiorentino12 sono ri-spettivamente i luoghi di origine di Bona e di Verdiana: riguardo alla pri-ma le fonti13 non si limitano ad indicare la città di nascita (“Igitur S. Bona
5 Data indicata per il pellegri-naggio di Francesco a Compostela; secondo Luis Vasquez de Parga l’evento andrebbe collocato fra il 1213 e la fine del 1215, cfr. L. VA-
SQUEZ DE PARGA, La peregrinación en los siglos XIII y XIV, in L. VA-
SQUEZ DE PARGA, J. M.A LACAR-
RA, J. URÍA RÍU, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, I, Madrid, Gobierno de Navarra, 1948, pp. 76-77).
6 Per alcune di esse, cfr. Ibid., p. 69.
7 Martirologio romano, Venezia, Baglioni, 1702, p. 241. Sulla santa, cfr. anche O. POGNI, Vita di Santa Verdiana d’incognito autore, estratta dal codice latino trecentesco esistente nella Biblioteca mediceo-laurenziana di Firen-ze, Empoli 1936; S. NOCENTINI (a c. di), Verdiana da Castelfiorentino: Contesto storico, tradizione agiografica e iconografia, Firenze, SISMEL Edizio-ni del Galluzzo, 2011.
8 Per le prime notizie di un pellegrino inglese a Compostela, cfr. L. VASQUEZ DE PARGA, Peregri-nos jacobitas de los siglos XI y XII, in VASQUEZ DE PARGA, LACARRA, URÍA RÍU, Las peregrinaciones cit., I, p. 51.
9 G. PENCO, Storia del monache-simo in Italia dalle origini alla fine del Medioevo, Milano, Jaka Book, 1983, p. 231 sgg.
10 La fonte principale è la Le-genda de vita et obitu sancti Guilielmi confessoris et heremitae, contenuta in un manoscritto della prima metà del secolo XIII conservato nell’Ar-chivio dell’Abbazia di Montevergi-ne, cfr. G. ANDENNA, Guglielmo da Vercelli, santo, in R. ROMANELLI (dir.), Dizionario biografico degli Italia-ni, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 61 (2004), s.v. e la ricca bibliografia ivi citata. Si vedano anche gli AASS Junii VII, col. 99 sgg.
11 AASS Junii I, col. 134. 12 “…Castelli-Florentini, quod
oppidum est in territorio ac diocesi Florentina…”, cfr. AASS Februarii I, col. 259.
13 Le biografie più antiche di Bona, scritte da due anonimi a cin-quant’anni circa dalla morte della santa, sono contenute nel codice C181 della Biblioteca Capitolare di
LAURA RAMELLO, Prima di Francesco: i santi in cammino 45
nata est in civitate pisana…”) ma ne precisano addirittura il quartiere (“…parte quae Chincitha dicitur, juxta Arnum fluvium…”) e la parrocchia (“in parochia S. Martini”)14; assisano è invece Egidio15.
Eldrado è originario dell’antica Provincia Narbonensis (“…ex Gallica-na patria, que dicitur Provincia…”); le biografie informano che nacque in una località bagnata dal “Dederadus flumen”, l’odierna Durance, affluente di sinistra del Rodano. Di questa località, che le fonti chiamano “locus Ambillis, Amboliacensis oppidum, Ambelliacensis oppidum, castellum Ambelli”16, si ignora tuttavia l’esatta ubicazione.
In Renania, e in particolare nella città di Worms, vede la luce Morando, mentre Paolina è originaria della Turingia; Godrico “erat enim de terra An-glorum oriundius”17: nasce infatti a Walpole, nel Norfolk18.
STATUS SOCIALE
La disamina della condizione sociale di questi santi pellegrini mette in gioco un’altra questione: quella del rapporto fra nobiltà e santità. Come osserva Fabrizio Vanni, “nell’alto medioevo, specialmente nei regni d’oltre Alpe, essere nobile era condizione quasi necessaria, anche se non sufficien-te, per aspirare alla santità…”; non solo, ma “una volta accertata la santità indiscussa di un personaggio di cui non si sapeva granché, veniva presso-ché spontaneo attribuirgli, con pietas agiografica assai classista, genitori nobili o addirittura regnanti”19.
Di elevata estrazione sociale sono senz’altro Paolina, Morando e Al-berto: le origini di Paolina vengono qualificate con l’espressione “ex illu-strissimis orta natalibus”; il padre Morico, “in curia Heinrici quarti impera-toris enutritus”20, frequentava assiduamente gli ambienti della corte impe-riale, ottenendone privilegi e benefici; di pari rango era anche la madre21. Morando nasce intorno al 1050 da nobilissima famiglia; le biografie insi-stono su quest’aspetto, qualificando i suoi genitori “inter potentum catervas primates praeclari, tam in religione Christiana, quam rerum temporalium affluentia plenius fuerant locupletati”22; La famiglia dei Prezzati, nella qua-le Alberto viene alla luce intorno al 1125, apparteneva all’aristocrazia mili-tare di antica origine longobarda ed era vicina alla corte imperiale; l’am-biente e l’agiatezza familiare consentirono al giovane Alberto di ricevere una buona istruzione, favorendone l’avviamento alla carriera militare. An-che Eldrado, nato nella seconda metà dell’VIII secolo, pare essere di condi-zione alquanto elevata (“non infimis parentibus ortus” 23).
Al rango della piccola nobiltà locale pare invece appartenere la fami-glia dei Ruggieri (“Rugeriorum honesta familia”24) da cui discende Teobal-do; egli è dunque benestante, benché i rovesci di fortuna che caratterizzaro-no la sua vita con la morte dei genitori lo riducano ben presto in condizioni di estrema povertà.
Per alcuni versi analogo a quello di Teobaldo è lo status di Verdiana; sebbene inequivocabili riguardo alla sua povertà (“…pauperibus quidem, sed Catholicis, nata parentibus est…”), le fonti osservano come, all’età di dodici anni, Verdiana sia entrata a servizio di un parente, “vir opulentus ac nobilis, ex illustri Attavantorum ortus familia”25; imparentata con la nobile famiglia degli Attavanti, Verdiana può dunque essere considerata un’espo-nente della nobiltà decaduta.
Riguardo a Guglielmo, nonostante la tradizione gli riconosca nobili
Pisa, alle cc. 38r-48v (versione B) e 107r-121v (versione A); la versione A è pubblicata negli AASS Maii VII, col. 143 sgg., mentre la versio-ne B è tutt’ora inedita, cfr. E. MAS-
SA, Bona da Pisa, santa, in Dizionario biografico degli Italiani, in R. ROMA-
NELLI (dir.), Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclo-pedia Italiana, 11 (1969), s.v.
14 AASS Maii VII, col. 144. 15 S. VECCHIO, Egidio di Assisi,
in Dizionario biografico degli Italiani, in R. ROMANELLI (dir.), Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 42 (1993), s.v.
16 AASS Martii II, col. 328. 17 J. STEVENSON (ed.), Libellus
de Vita et Miraculis S. Godrici, Here-mitae de Finchale, auctore Reginaldo monacho Dunelmense (Surtees Society 20), London 1847, p. 21.
18 I. GOBRY, Cavalieri e pellegri-ni. Ordini monastici e canonici regolari nel XII secolo, Roma, Città Nuova Editrice, 2000, p. 264.
19 VANNI, Santi connessi col pelle-grinaggio cit., p. 2.
20 P. MITZSCHKE (ed.), Sigebo-tos, Vita Paulinae. Ein Beitrag zur ältesten Geschichte des schwarzburgischen Landes und Fürstenhauses (Thürin-gisch sächsische Geschichtsbiblio-thek 1), Gotha, F.A. Perthes, 1889, p. 31.
21 « …cuius …genus et etas libertasque cum marito fere conve-niebant… », cfr. Ibidem
22 AASS Junii I, col. 341. 23 AASS Martii II, col. 328. 24 AASS Junii I, col. 134. 25 AASS Februarii I, col. 259. 26 “…nobili progenie, morum
ejusdem nobilitate longe plae-clarior…”, cfr. AASS Junii VII, coll. 99-100.
27 ANDENNA, Guglielmo da Vercelli cit.
28 “Pater eius Pisanus natione, Bernardus nomine fuit; mater vero Corsicana, vocabatur Berta”, cfr. AASS Maii VII, col. 146.
29 “Huius pater uxorem simul et filiam, cum trium esset annorum effecta, relinquens, profectus est ultra mare, nec ad ipsas ulterius est reversus”, cfr. Ibidem
30 STEVENSON (ed.), Libellus de Vita et Miraculis S. Godrici cit., p. 21.
46 COMPOSTELLA n. 36
natali26, si deve rilevare che le attribuzioni a nobili famiglie ver-cellesi sono molto tarde e prive di ogni riscontro storico27. L’ambiente familiare in cui vede la luce, intorno alla metà del seco-lo XII (la data tradizionale è il 1156) Bona da Pisa parrebbe riconduci-bile alla borghesia mercantile; il padre Bernardo è pisano, la madre Berta è corsa28; la condizione di apparente tranquillità economica viene tuttavia sovvertita da una separazione: quando Bona ha tre anni il padre abbandona lei e la madre per partire oltremare, da dove non farà mai più ritorno29. Di umili origini paiono essere Go-drico e Egidio: il primo, i cui ge-
nitori “vitam pauperem ducebant”30, nasce in una miserrima casa e diviene mercante ambulante per contribuire al sostentamento dei poveri genitori31; riguardo al secondo, sebbene le fonti nulla ci dicano della sua vita fino al momento della decisione, nel 1209, di porsi alla sequela di Francesco, gli studiosi32 paiono concordi nell’attribuirgli lo status di illitterato, probabil-mente appartenente alla categoria dei braccianti agricoli.
Dal campione qui esaminato si nota come le fonti agiografiche sembri-no convergere nel delineare un quadro in cui la nobiltà di sangue costitui-sce di per sé un fattore predisponente alla santità, mentre il potenziale sfa-vorente delle umili origini parrebbe corretto dal radicamento nella fede dell’ambiente familiare, una sorta di ‘nobiltà di fede’: emblematica sotto questo aspetto è la definizione dei genitori di Verdiana “poveri sì, ma cat-tolici”.
MOTIVAZIONI
La santità entra dunque a far parte di diritto nell’insieme delle poten-zialità di chi decide di mettersi in viaggio verso i loca sancta. Anche se non apertamente dichiarato, essa è uno degli obiettivi che “spingono la per-sona a mettersi in gioco nel complesso e mutevole processo di ascesi e di straniamento … che è il pellegrinaggio medievale”33.
Dall’analisi delle biografie emerge come estremamente variegato e multiforme sia il quadro delle situazioni che accompagnano o motivano l’esperienza del pellegrinaggio; spesso è possibile identificare, come ‘tempo del cammino’, un ‘prima’ e un ‘dopo’, che non di rado ruotano in-torno al momento cruciale di una conversione.
Da questo punto di vista emblematica è l’esperienza di Alberto: fra un ‘prima’, fatto di una vita dedita all’esercizio delle armi, e un ‘dopo’ di vita monastica vi è un avvenimento drammatico – una grave ferita in combatti-mento – che lo spinge dapprima all’abbandono della professione militare e poi alla scelta di una vita consacrata, che passa attraverso la fondamentale esperienza del pellegrinaggio.
31 “…per rura et villanos cir-cumquaque positos coepit cum mercibus minutis pervagando cir-cuire…”, cfr. Ibid., p. 25.
32 VECCHIO, Egidio di Assisi cit. 33 VANNI, Santi connessi col pelle-
grinaggio cit., p. 1. 34 “…factus sacerdos Dei di-
gnissimus…”, cfr. AASS Junii I, col. 342.
35 D. IOGNA-PRAT, Order & exclusion. Cluny and Christendom face heresy, judaism and islam (1000-1150), London and Ithaca, Cornell Uni-versity Press, 2002, p. 36.
36 A. BENVENUTI PAPI, In castro poenitentiae: Santità e società fem-minile nell’Italia medievale, Roma, Herder, 1990, pp. 263-303.
37 AASS Martii II, col. 328. 38 STEVENSON (ed.), Libellus de
Vita et Miraculis S. Godrici cit., p. 29. 39 “…herae suae quadraginta
Astenses libras quas habebat in pauperes erogandas tradidit…”, cfr. AASS Junii I, col. 134.
40 Ibidem 41 MITZSCHKE (ed.), Sigebotos,
Vita Paulinae cit., p. 36. 42 Ibid., p. 39. 43 Ibid., p. 43: “…beata Pauli-
na regressa domumque reversa solito more familiaris rei negociis instat…”.
44 Ibid., p. 58. 45 AASS Junii V, col. 115;
VASQUEZ DE PARGA, Peregrinos cit., p. 50. L’usanza di camminare scalzi in occasione di alcune situazioni de- vozionali non era affatto ecceziona-le nel Medioevo: anche san Teobal-do effettua il pellegrinaggio a piedi nudi, cfr. Ibid.; J. URÍA RÍU, De Por-tomarín a Santiago, in VASQUEZ DE PARGA, LACARRA, URÍA RÍU, Las peregrinaciones cit., II, p. 354, no. 57).
S. Guilielmus, arazzo, sec. XVIII, Perugia, Palazzo vescovile
LAURA RAMELLO, Prima di Francesco: i santi in cammino 47
46 ANDENNA, Guglielmo da Vercelli cit.
47 Per l’intricata situazione che contraddistingue le biografie egidiane, cfr. VECCHIO, Egidio di Assisi cit.
48 THOMAE DE CELANO, Vita prima sancti Francisci, in Analecta Franciscana, X, Ad Claras Aquas prope Florentiam, 1941, cap. XII.
49 VECCHIO, Egidio di Assisi cit. 50 « …cum septem esset anno-
rum, …in lectulo de paleis aut stra-mine artus teneros reclinabat… Jejuniis quoque et abstinentia illo jam in tempore corpus affligebat in tantum…», cfr. AASS Maii VII, col. 144.
51 Ibid., col. 147. In queste frequenti apparizioni compaiono talora la Vergine Maria e lo stesso San Giacomo, con la particolare funzione di rassicurare la fanciulla, spaventata da quanto le sta acca-dendo: “Et ecce ipsi devote, et instanter oranti, apparuit juxta can-cellos Dominus Jesus Christus, cum Matre sua gloriosa semperque Virgine Maria, aliisque duabus Ma-riis et Sororibus ejus, nec non et cum B. Jacobo Apostolo, cujus limina in Galicia, quae a totius mundi hominibus visitantur. Illa, visionis magnitudine ac visorum gloria stupefacta, quia nondum assueta erat talibus, fugiebat: quam B. Jacobus insecutus, confortando eam, dixit ei: Filia, noli timere, quia qui tibi dignatus est apparere est Dominus Jesus Christus, cum Ma-tre sua benedicta et duabus Sorori-bus ejus”, cfr. Ibid., col. 145.
52 Ibid., col. 147. 53 “Inter alia vero sancta et
Deo accepta ejus opera, peregrina-tio frequens fuit. Novem etenim vicibus B. Jacobi limina…”, cfr. Ibidem
54 “Cum autem annum tertium decimum attigisset, et quadam die venisset ad eam mater sua, apparuit eis in peregrinorum specie Domi-nus Jesus Christus, cum societate predicta; dixitque Christus matri S. Bonae: …Volumusque quod…tuam filiam tradas nobis, ut eam …ultra mare ducamus”, Ibid., col. 145. Altre fonti biografiche indicano un’età di undici o dodici anni, cfr. MASSA, Bona da Pisa cit.
Anche nel caso di Morando e Verdiana il pellegrinaggio funge da spar-tiacque fra un ‘prima’ e un ‘dopo’: per Morando esso consegue ad una pri-ma vocazione al sacerdozio34, ma è proprio peregrinando e venendo in con-tatto con la spiritualità di Cluny che Morando decide, al suo ritorno, di ab-bracciare definitivamente la vita monastica35.
Per Verdiana il pellegrinaggio è il decisivo punto di svolta fra le due fasi della sua vita: quella secolare del ‘prima’ e quella eremitica del ‘dopo’; come ben nota Anna Benvenuti36, Verdiana incarna un particolare modello medievale di santità femminile costituito dalle cosiddette ‘serve-sante’, gruppo che annovera anche Zita da Lucca, Giovanna da Signa e Cristiana di Santa Croce; con esse condivide le origini contadine, l’assunzione in giovane età come serva presso una famiglia cittadina, la vocazione all’ausi-lio dei poveri e infine, dopo la svolta, la vita da ‘mulier incarcerata’.
Il peregrinare di Eldrado è piuttosto una ricerca che anticipa la scelta decisiva; egli viaggia alla volta di un luogo nel quale vigessero “monachorum regula et arctior custodia”37, che trova infine, al di qua delle Alpi, nell’abbazia della Novalesa.
Godrico è un viaggiatore di professione; abituato agli spostamenti, per ragioni di mercatura va in Scozia, Bretagna, Fiandre, Dacia e giunge fino a Roma, scampando a pericoli vari, compreso un naufragio38; proprio questa consuetudine al viaggio fa nascere ad un certo punto in lui il desiderio di visitare i luoghi santi: comincia a frequentare con assiduità il santuario di Sant’Andrea in Scozia e, dopo una sosta ai luoghi di san Cutberto, decide di partire pellegrino, esperienza a seguito della quale si ritirerà in una fore-sta e diverrà eremita.
Per Teobaldo il pellegrinaggio non prelude ad una scelta di vita consa-crata, se mai ad una radicalizzazione di opzioni precedenti: già dedito al servizio dei più poveri, alla morte del suo benefattore, affida alla moglie e alla figlia di costui il denaro che possedeva perché fosse distribuito ai biso-gnosi39 e va in pellegrinaggio; ritornato ad Alba, “diversum modum viven-di tenere sibi praefixit”40, scegliendo di dormire sulla nuda terra e di eserci-tare il mestiere da lui ritenuto più umile, quello di facchino, distribuendo ai poveri il poco che guadagnava, modus vivendi che proseguirà fino alla morte.
Per Paolina potremmo parlare di una sorta di ‘vocazione differita’: da-ma di alto rango andata in sposa ad un nobile cavaliere41, Paolina va in pel-legrinaggio, per scelta condivisa con il marito, per il più classico e scontato dei motivi, la salvezza della sua anima (“ob redempcionem anime sue”)42; il pellegrinaggio non prelude ad un cambio immediato di vita, tant’è vero che al ritorno riprende il consueto ménage familiare43; solo dopo un lungo percorso, punteggiato da lutti per la morte del marito e dei genitori, altri pellegrinaggi e la scelta delle figlie di abbracciare la vita religiosa, deciderà di ritirarsi nella solitudine, povertà e preghiera in una foresta della Turingia dove sorgerà il monastero di Paulinzelle44.
Di vero e proprio pellegrinaggio penitenziale si deve parlare per quanto riguarda Gugliemo da Vercelli: egli parte “una contentus clamide, nudis etiam pedibus”, con il proposito di vivere solo a pane e acqua, di dormire sulla nuda terra, di mantenere il silenzio durante le ore notturne come i mo-naci45. Anche la più antica iconografia del santo lo raffigura con in mano il bastone ricurvo dei pellegrini e con la veste nera segnata da croci rosse, distintivo peculiare di coloro che appartenevano all’ordo poenitentium, la
48 COMPOSTELLA n. 36
cui religio si esprimeva con una perfetta humilitas46. Viaggiare, predicare, lavorare: questo potrebbe essere il motto di Egi-
dio; tutte le biografie47 sottolineano come la prima parte della sua vita sia scandita da una sorta di attivismo frenetico, in cui l’esigenza del lavoro manuale si associa alla continua peregrinazione verso luoghi di devozione o terre di missione; per Egidio pellegrinare è consubstanziale alla vita e in perfetta sintonia con il comando ricevuto da Francesco:
« Tunc beatus Franciscus omnes ad se convocavit, et plura eis de
regno Dei, de contemptu mundi, de abnegatione propriae voluntatis et proprii corporis subiectione pronuntians, binos illos in partes quattuor segregavit, et ait ad eos: « Ite, charissimi, bini et bini per diversas partes orbis, annuntiantes hominibus pacem et poenitentiam in remis-sionem peccatorum et estote patientes in tribulatione, securi quia pro-positum et promissum suum Dominus adimplebit. … At illi, cum gaudio et laetitia multa, suscipientes obedientiae sanctae mandatum, coram sancto Francisco supplices se prosternebant in terram. Ipse vero amplexans eos, dulciter et devote dicebat singulis: « Iacta cogi-tatum tuum in Domino, et ipse te enutriet ». Hoc verbum dicebat quoties ad obedientiam fratres aliquos transmittebat.
Tunc frater Bernardus cum fratre Aegidio versus Sanctum Iaco-bum iter arripuit, sanctus Franciscus vero cum uno socio alia mundi elegit partem, reliqui quatuor incedentes bini partes reliquas tenue-runt »48.
Questo modus vivendi prosegue fino al 1215; tutte le biografie segnala-
no a questo punto un mutamento: la predicazione itinerante lascia il posto ad una vita di penitenza e di preghiera in cui si verifica per la prima volta l’esperienza dell’estasi mistica. Dopo ciò, le peregrinazioni di Egidio ces-sano quasi completamente49.
Figura al di fuori dagli schemi è quella di Bona da Pisa, ‘professio-nista’ se non ‘stakanovista del pellegrinaggio’; sul modulo agiografico del-la santa bambina, che fin da piccina avrebbe dormito in un letto di paglia come Gesù nel presepe e a sette anni avrebbe usato il cilicio e praticato digiuni e altre austerità50, si innesta un movente al pellegrinaggio jacopeo che rappresenta un eccezionale unicum fra le figure qui analizzate: l’appa-rizione di Cristo stesso che la esorta ad andare a Compostela:
“Post aliquantum tempus… apparuit ei Christus… dixitque ad
eam: Volo te huius B. Jacobi limina in Hispania visitare”51. La devozione di Bona a san Giacomo la porta al suo ritorno a dedicarsi
alla costruzione della chiesa e del monastero di S. Iacopo al Poggio, sulla via che congiunge Pisa con Ponte a Serchio, da cui i pellegrini raggiunge-vano la via Francigena52. Quello fu soltanto il primo di una lunga serie di pellegrinaggi di Bona in Galizia, dove, secondo le fonti, si recò ben nove volte53.
La sua esperienza di ‘santa pellegrina’, che dal 1962 le valse il patrona-to delle hostess, induce a riflettere su altri aspetti: quello della fase della vita in cui il pellegrinaggio viene affrontato e quello del ‘peso specifico’ del pellegrinaggio jacopeo nelle biografie di questi santi.
Per alcuni di essi colpisce infatti la giovane età in cui decidono di farsi pellegrini: riguardo a Bona le fonti agiografiche indicano un’età compresa
55 “Quartum decimum igitur, haec salutaria meditans, annum ingressus …relicta patria… ad B. Jacobi …est iter aggressus”, cfr. AASS Junii VII, col. 100; cfr. an-che ANDENNA, Guglielmo da Vercelli cit.
56 “…et saepe B. Petri ac San-cti Angeli… visitavit”, cfr. AASS Maii VII, col. 147.
57 AASS Junii VII, col. 100. 58 “Interea, quoniam circuli,
quos ad carnis macerationem in-duerat, frequentius rumpebantur: eosque ferrariis ostendere, et simi-les fieri, ab ipsis quaerere oporte-bat ; plausum hominum metuens, vir prudentioris consilii Salarnum proficiscitur ; sperans ibi aliquem invenire, a quo ferream loricam… acciperet… postquam Salarnum fuit ingressus, quidam Miles occur-rens… quotquot habuit loricas ostendit… ut quam vellet meliorem acciperet. Majorem quidem pon-deris vestem indutus… ad modum sui capitis ferreum tegumen fieri jussit, quod vulgo Cophia dicitur; quam postquam… in capite sump-sit, eam ulterius non removit…”, cfr. AASS Junii VII, coll. 101-102; cfr. anche ANDENNA, Guglielmo da Vercelli cit.; PENCO, Storia del monachesimo in Italia cit., p. 231.
59 “Visitavit etiam causa devo-tionis sanctum Angelum et san-ctum Nicolaum de Bari”, cfr. Vita Aegidii, in Chronica XXIV generalium Ordinis minorum. Cum pluribus appen-dicibus inter quas excellit hucusque inedi-tus “Liber de laudibus S. Francisci”, Fr. Bernardi a Bessa / ed. a patribus collegii S. Bonaventurae, Roma 1897, p. 77.
60 VECCHIO, Egidio di Assisi cit. 61 AASS Februarii I, col. 258. 62 MITZSCHKE (ed.), Sigebotos,
Vita Paulinae cit., p. 39. Concentra-re in un unico viaggio i pellegrinag-gi a Compostela e alle altre destina-zioni maggiori (Roma o Gerusa-lemme) non era affatto un caso eccezionale: cfr. J. M. LACARRA, Los caminos de Santiago a través de Francia, in VASQUEZ DE PARGA, LACARRA, URÍA RÍU, Las peregrina-ciones cit., II, p. 43.
63 AASS Maii VII, col. 145. 64 “…sed ne laborem peregri-
nationis citius terminasse videretur,
LAURA RAMELLO, Prima di Francesco: i santi in cammino 49
fra gli undici e i tredici anni per il primo pellegrinaggio in Terrasanta54; Guglielmo ha solo quattordici anni quando decide di partire alla volta di Compostela55; per entrambi inoltre, quella jacopea non rappresenta l’unica
dimisso patre et matre eorumque comitatu, cum maritu versus Hi-spaniam ad Sanctum Jacobum iter cum paucis arripuit…”, cfr. MI-
TZSCHKE (ed.), Sigebotos, Vita Pauli-nae cit., p. 39; cfr. anche VASQUEZ DE PARGA, Peregrinos cit., p. 51.
65 AASS Februarii I, col. 260; A. BENVENUTI PAPI, Mendicant Friars and Female Pinzochere in Tus-cany: From Social Marginality to Models of Sanctity, in D. BORNSTEIN, R. RUSCONI, a cura di, Women and Religion in Medieval and Renaissance Italy, Chicago, University of Chi-cago Press, 1996, p. 88.
66 VASQUEZ DE PARGA, Pere-grinos cit., p. 51.
67 “…cibo contenta modico, ferreoque semper succincta cingu-lo…”, cfr. AASS Maii VII, col. 147.
68 Ospitato lungo il cammino nella casa di un fabbro, Guglielmo gli chiede: “Duos ergo mihi circu-los ferreos ad hunc modum facias, ut eorum unus ventrum, pectus alter circumdet, a quorum superiori brachia duo ferrea porrigantur u-num a dextero latere, alterum a sinistro, quae per humeros, ad alte-ram inferioris circuli partem perve-nientia, utrimque praedictis circulis fortiter clavis colligentur”, cfr. AASS Junii VII, col. 100; cfr. anche ANDENNA, Guglielmo da Vercelli cit.
69 Riguardo a Guglielmo le agiografie sottolineano come fin dall’inizio del viaggio avesse stabili-to di nutrirsi esclusivamente di pane e acqua, “…sicut a prima die suae peregrinationis statuerat, solo pane et aqua refectus…”, cfr.
ANTONIO FASCETTI, Santa Bona, 1995, Pisa, Chiesa di San Martino.
50 COMPOSTELLA n. 36
esperienza di pellegrinaggio nell’arco della loro esistenza: nonostante le precarie condizioni fisiche, Bona si recò più volte in Terrasanta, a Roma, nonché a San Michele del Gargano56.
Tornato dalla Galizia, Guglielmo, intenzionato ad andare a Gerusalem-me, si dirige verso la Puglia per imbarcarsi; consigliato da Giovanni da Matera di desistere per dedicarsi piuttosto alla predicazione nel sud Italia, abbandona definitivamente il suo proposito solo dopo aver subito, lungo il cammino, un’aggressione dai briganti (“… a latronibus detentus, crudis est affectus verberibus…”)57. Egli volge così i suoi passi verso l’Irpinia per cercare un luogo consono in cui ritirarsi in preghiera; prima però fa sosti-tuire i cerchi di ferro di cui si era cinto a scopo penitenziale, poiché si rom-pevano con frequenza ed era costretto a farli riparare dai fabbri; a tal scopo si reca a Salerno da un miles, che gli mostra le sue corazze e lo invita a scegliere quella più adatta. Coperto da una veste di ferro, ritorna ad Atri-palda e qui si fa forgiare una cuffia di maglia di ferro, che decide di portare sempre sul capo58.
Anche Egidio è un ‘pluri-pellegrino’59: “le fonti più antiche non con-sentono di stabilire con precisione la cronologia e la successione dei suoi viaggi, ma ne indicano quantomeno le tappe: dopo Compostela, che rag-giunge probabilmente nell’autunno del 1209, si reca a S. Michele del Gar-gano e a S. Nicola di Bari (prima del 1212); immediatamente prima o dopo di questi pellegrinaggi si colloca un viaggio in Terrasanta”60.
Tecnicamente anche Godrico visitò le tre destinazioni maggiori; si de-ve però rilevare che in realtà solo Compostela costituì meta di autentico pellegrinaggio, essendo i viaggi a Roma e Gerusalemme legati a ragioni di mercatura.
Dopo aver visitato la tomba di san Giacomo, anche Verdiana compì un secondo pellegrinaggio, questa volta a Roma61; inverso fu l’itinerario di Paolina, che tuttavia inglobò le due destinazioni in un unico viaggio62.
Il pellegrinaggio in Spagna rappresentò invece l’unica esperienza per Eldrado, Morando, Teobaldo e Alberto; per quest’ultimo Compostela fu una sorta di destinazione di ripiego, essendo la meta originariamente prescelta (la Terrasanta) sconsigliata in quel momento per ragioni di sicurezza.
MODALITÀ DEL VIAGGIO
Da questo punto di vista le differenze fra uomini e donne sono eviden-ti; per ovvie ragioni, il pellegrinaggio solitario era escluso per le donne: Bona si reca in Terrasanta con due compagne, una “Domina Gaitana” e una fanciulla “nomine Massaja”63, la cui presenza – specie della prima – pare costante nelle peregrinazioni successive; Paolina va a Roma con la sua famiglia e relativo seguito, proseguendo poi per Compostela con il solo marito e pochi accompagnatori64; Verdiana va in pellegrinaggio “cum ho-norato piarum matronarum comitato”65.
Fra gli uomini, Eldrado, Guglielmo e Alberto paiono prediligere il pel-legrinaggio solitario; Teobaldo invece parte con un solo compagno66, così come Egidio, che va a Compostela con Bernardo da Quintavalle, secondo lo schema ‘a coppie’ stabilito da Francesco.
Alle oggettive condizioni di disagio del pellegrinaggio, spesso questi santi pellegrini ne aggiungono volontariamente altre: pur peregrinando,
AASS Junii VII, col. 100. 70 VECCHIO, Egidio di Assisi cit. 71 “Unde quadam die vadens
pro eleemosyna et nihil inveniens, devenit ad quandam aream, in qua aliqua grana fabarum remanserant; colligens illa comedit et ibidem nocte illa dormivit et fuit tantum a Domino recreatus, quasi si habuis-set diversa genera pulmentorum”, cfr.Vita Aegidii cit., p. 76.
72 « Semper enim libentius hospitabatur in locis solitariis et desertis quam inter gentes, ut libe-rius vigiliis et orationi vacaret », cfr. Ibidem
73 AASS Februarii I, col. 260. 74 «Cum vero in itinere quidam
pauperi obviaret, pietate motus, caputium a tunica dissuens illi pau-peri dedit, et sic sine caputio viginti diebus continuis ambulavit», cfr. Vita Aegidii cit., p. 76.
75 AASS Maii VII, coll. 147-8. 76 AASS Februarii I, col. 260. 77 AASS Martii II, col. 328. 78 “…et illi ac filii valedicens,
cum ipso Salvatore egenus factus, arrepto baculo, ad S. Jacobi Galiciae peregrinationem, eleemosynam o-stiatim corrogaturus, aggreditur”, cfr. AASS Junii I, col. 134.
79 “…Et convocatis suis homi-nibus, domesticis et parentibus, eorum se commendans orationibus, ad memoriam S. Jacobi perrexit, cum pluribus eiusdem viae sponso-ribus”, cfr. AASS Junii I, col. 342.
80 AASS Februarii I, col. 260. 81 “…peragravit Provinciam,
translatus Aquitanias devenit ad Hispanias”, cfr. AASS Martii II, col. 328.
82 “In eisdem vero partibus habetur vicus formosissimus qui dicitur Cluniacus, a… venitate ha-bilis, fertilitate foecundus…”, cfr. AASS Junii I, col. 342.
83 “…se monachum futurum diceret si peregrinatione peracta Dominus sibi redire concederet. Benedictione itaque pii Patris ac Fratrum oratione munitus, exul egregius, cum suis comitibus itine-rare coepit ocius; ac Domino du-cente, quo proposuerat, Galliciae invehitur partibus: et B. Jacobi pi-gnore adorato, concite rediit, ac Cluniacum pervenit: moxque suis valedicens comitibus, laetantibus
LAURA RAMELLO, Prima di Francesco: i santi in cammino 51
Bona non abbandona mai il cilicio67; Guglielmo si fa cingere il petto e il ventre con due cerchi di ferro, costume tipico dei penitenti coatti, ma pure accettato dai penitenti volontari68. A questa mortificazione fisica entrambi accompagnano la quasi totale astinenza dal cibo69.
Il viaggio compiuto da Egidio fu assai duro, sia per i disagi materiali, sia per l’incomprensione e lo scherno di cui i pellegrini erano oggetto; egli si guadagna da vivere svolgendo lavori di piccolo artigianato o umili servi-zi70. Durante il cammino gli capita spesso di soffrire la fame; un giorno, non avendo ottenuto nulla dalle elemosine e giunto in un luogo di sosta per la notte, trova alcune fave; dopo averle mangiate, si addormenta profonda-mente e, per intervento divino, si risveglia il mattino dopo completamente rinfrancato, come se si fosse nutrito dei cibi migliori71; le fonti sottolineano inoltre come preferisse sostare nei luoghi solitari, al fine di poter libera-mente trascorrere la notte vegliando in preghiera72; anche Verdiana in viag-gio non abbandona le sue pratiche di veglie, preghiere e digiuni73.
L’ausilio agli altri pellegrini pare essere una costante per molte delle figure qui analizzate: le fonti raccontano di un gesto di generosità compiuto da Egidio durante il pellegrinaggio, quando, incontrato un povero, gli dona il suo cappuccio, proseguendo senza di esso il cammino per venti giorni74; anche Bona interpreta come autentica missione quella di supportare i pelle-grini nelle difficoltà, incoraggiarli nei momenti più difficili, prestare soc-corso sanitario ed invitare tutti alla preghiera e alla penitenza75. Come lei anche Verdiana, ovunque le si presenti l’occasione, visita gli infermi esor-tandoli a sopportare pazientemente le loro pene; con un perenne sorriso sulle labbra, si presta ad alleviare le loro sofferenze, lavando ed asciugando amorevolmente i loro piedi76.
Anche riguardo ad Eldrado le biografie ci informano che mostrò solle-cita attenzione verso i pellegrini per i quali fece costruire “nonnulla habita-cula” e “pulcherrimum viridarium” nel suo paese d’origine77.
PERCORSI E INCIDENTI DI PERCORSO
Seppur sporadicamente, le fonti forniscono informazioni riguardo al momento della partenza: Teobaldo, benedicendo la sua famiglia di adozio-ne, “arrepto baculo” parte alla volta di Compostela78; di fronte a parenti, amici e servitori che assistono alla sua partenza, Morando, prima di intra-prendere il cammino, si raccomanda invece alle loro preghiere79; Verdiana si confessa e comunica prima di partire80.
Le fonti appaiono per contro piuttosto avare nel citare luoghi, diversi dalla meta, che permettano di ricostruire il percorso effettuato; riguardo ad Eldrado, esse narrano di un suo peregrinare attraverso la Gallia, la Proven-za, l’Aquitania e la Spagna81; praticamente nulla esse dicono dell’itinerario di Morando, se si eccettua il riferimento ad una tappa che si rivelerà fonda-mentale82: a Cluny, Morando promette che, se Dio gli concederà di ritorna-re sano e salvo da Compostela, egli si farà monaco83, come poi accadrà. Riguardo a Guglielmo, le agiografie paiono alludere alla visita di altri luo-ghi santi lungo il tragitto verso Compostela (“…ad B. Jacobi aliorumque Sanctorum sacra visendum limina…”)84, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni.
Nella relativa scarsità di dati toponomastici, non di rado è il ricordo di incidenti o di scampati pericoli a fornire l’occasione per riferimenti più
omnibus, rite consecratur mona-chus”, cfr. AASS Junii I, col. 342.
84 AASS Junii VII, col. 100. 85 “Contigit eam in ipso itinere
venire ad fluvium quendam Gerun-dam Hispaniae citerioris. Quem cum navigio trasmeare properaret et navis onusta gravi multitudine promiscui sexus remis impulsa in medium fluminis fere jam proces-sisset, infirmioris tabule sue navis fracturam ictibus tremefacta pertu-lit et intrante per scissure hujus hyatum abysso cunctis, qui aderant, materiam mortis et presenciam ostendit. Tremefacti omnes, qui in navi erant, cum nauclero navis ar-mamenta desperatis rebus proi-ciunt, manus et mentes et voces ad sydera tollunt et, quod ultimum desperate vite est, se suaque omnium creatori communi confu-soque clamore commiserunt… Paulina vero intrepida fide et con-stancia in deum directa licet parum de morte sollicita, …veste, qua erat induta, in unum ex parte collecta et convoluta os ebullientis putei flexis genibus obturavit et super ingesta sedendo intrans pelagus virili re-pressit fiducia… Exemplo itaque fortis femine virtutis viri fractos mortis pavore animos recolligunt, vires exerunt, certatim flumen ei-ciunt vectoremque suum egrum et dissolutum procedere collecto ro-bore cogunt et salvatore omnium corremigante omnes ad portum incolumes perveniunt”, cfr. MI-
TZSCHKE (ed.), Sigebotos, Vita Pauli-nae cit., pp. 39-40.
86 “Passet Girunde a mult granz nefs qu’i sunt”, cfr. J. BÉ-
DIER, La Chanson de Roland, Paris, L’Edition d’Art, 1922, v. 3688); cfr. anche J. M. LACARRA, Los caminos cit., p. 54.
87 “Cum quadam vice S. Bona B. Jacobi limina in Galicia visitaret, ad quemdam fluvium pervenit cum aliis peregrinis, quem quidem per pontem, propter ejus excrescen-tiam, nemo poterat pertransire. Aderant ibi cum asinis pueri, pere-grinos pretio transportantes. Cum ergo B. Bona, iter volens persequi inchoatum, dato pretio unum pro transito ascendisset, ac post se in eodem asino portans puerum, flu-vium pertransiret, asino cespitante,
52 COMPOSTELLA n. 36
precisi; è il caso ad esempio di Paolina: durante l’attraversamento della Gironda, nella barca su cui si trova si apre improvvisamente una grossa falla; fra i passeggeri atterriti Paolina non esita a sfilarsi la veste e a turare con essa la falla, consentendo così all’imbarcazione di giungere a riva85. Il riferimento all’idronimo ci induce a pensare che Paolina stesse percorrendo un tratto della via Turonense fra Blaye e Bordeaux, che comportava appun-to l’attraversamento dell’estuario della Garonna, percorso che anche Carlo-magno, di ritorno da Roncisvalle, avrebbe compiuto86. Anche Bona, in cammino verso Compostela, ha a che fare con il guado pericoloso di un non meglio specificato fiume: nell’attraversarlo a dorso d’asino, cade in acqua insieme al ragazzo che lo conduce; entrambi ne escono sani e salvi, con le vesti prodigiosamente asciutte87; sempre sulla strada verso Compo-stela, in un altro caso ella assiste alla rapina e al ferimento di un pellegrino, cui sana la ferita e procura la restituzione del maltolto, con relativa conver-sione del malandrino88.
Di incidenti di percorso come questi Bona ne dovette affrontare parec-chi durante la sua vita di pellegrina; il più grave fu forse durante il suo pri-mo pellegrinaggio in Terrasanta, quando venne ferita e fatta prigioniera dai Saraceni; resterà in carcere insieme alle sue compagne di viaggio fino a quando dei mercanti Pisani, dietro il pagamento di un riscatto, la libereran-no e la ricondurrano in patria89.
Al di là dei clichés agiografici, le biografie ci restituiscono l’immagine
di persone che, a prescindere dalla loro santità, sono prima di tutto uomini e donne che hanno affrontato e condiviso con i più umili la dura esperienza del pellegrinaggio medievale; come Francesco, e prima di lui, vivono lo spirito dell’itineranza, sia che esso costituisca una fase dell’esistenza, pre-ludio a scelte più radicali, sia che assurga a stile di un’intera vita.
Alcuni hanno trovato le risposte che cercavano nella loro meta, altri lungo la strada: per Morando, Alberto, Eldrado saranno piuttosto Cluny e Novalesa a rispondere ai loro bisogni interiori, ma senza il cammino, pro-babilmente ciò non sarebbe accaduto.
Come osserva Cesare Vaiani90 a proposito dell’itineranza francescana:
Il legame interiore … che tiene saldamente legati al Signore e dunque ai fratelli … trasforma le sofferenze del cammino in una e-sperienza di pace e di gioia misteriosa, come mostra il testo famoso del Dialogo della vera letizia (FF 278), che viene ambientato da Francesco sulla strada da Perugia alla Porziuncola, nel racconto di un difficile ritorno a casa e di un tormentato rapporto coi suoi fratelli… In questo testo si raggiunge una grande descrizione delle difficoltà del cammino, con quella “notte profonda” e quell’”inverno fangoso e così rigido che, all’estremità della tonaca, si formano dei ghiacciuoli d’acqua congelata, che percuotono continuamente le gambe fino a far uscire il sangue da siffatte ferite”: due tratti che, da soli, formano una potente evocazione del camminare nelle condizioni di un pellegrino medievale. Con un notevole talento narrativo, la strada è contrapposta alla casa, soprattutto alla porta, che è chiusa, e alla quale compare poi uno scorbutico portinaio: e la porta resterà chiusa, lasciando France-sco sulla strada, che sembra diventare il suo luogo naturale, quello in cui è possibile per lui provare la “vera letizia”. Sembra essere l’icona di “Francesco per strada”.
in aquam impetuose currentem asinus, puer et ipsa pariter cecide-runt. Sancta vero Bona, nec mem-bris madida nec vestibus, pertransi-vit, puerum pannos ejius pertinaci-ter retinentem, post se attrahens super aquam. Inde homines, aqua plenum puerum existimantes, ip-sum pedibus suspendere, ac aquam evomere cogitabant. Quod puer in-telligens, Nolite, ait, quia non sum aqua plenus, ut creditis, sed indici-bili gratia fruitus, et immensa sum jocunditate perfusus, quamdiu in aqua extiti cum ista Domina glorio-sa”, cfr. AASS Maii VII, col. 147.
88 “Alia vice et tempore, dum eadem iterum B. Jacobi limina visi-taret …peregrinus etenim quidam …quemdam incidit in latronem, qui ait ad peregrinum: Extrahe pe-cuniam et da mihi. Quo non dante, sed ne sibi tolleret suppliciter de-precante, dixit iterum ei latro: Da mihi quod habes, alioquin tibi fa-ciam quod proposueram ulteriun non facere alicui peregrino: notu etenim divino correptus spoliare quidem, sed non occidere propo-suerat peregrinos. Cum ergo Jaco-bipeta nullatenus latroni pecuniam exhiberet, latro evaginato gladio ipsum in sinistro ubere sic percus-sit, quod quasi mortuus cecidit super terram. Tunc B. Bona, eo-dem pergens itinere, facta sibi reve-latione totum negotium intellexit, et festinanter approperans, clamavit a longe fugienti latroni: Noli fugere, sed me aliquantum praestolare. Qui volens fugere, sed non valens, prope peregrinum immobilis et trepidus expectabat. Quibus appro-pians Sancta, jacere vidit Jacobipe-tam semivivum… Porro vulnus ejus sanctis digitis suis tangens…salutiferae Crucis ei signum impres-sit, quod statim est adeo solida-tum… ipseque sanus surrexit et fortis. Et cum ei pecuniam suam fecisset restitui a latrone… », cfr. Ibid., col. 148. Su furti e rapine ai danni dei pellegrini, cfr. J. M. LA-
CARRA, Protección jurídica del peregrino, in VASQUEZ DE PARGA, LACARRA, URÍA RÍU, Las peregrinaciones cit., I, pp. 267-270.
89 AASS Maii VII, col. 146. 90 VAIANI, Il “cavallo di san
Francesco” cit., pp. 69-70.