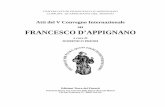Laudatio Francesco Mastroberti 2013 & Ascheri, Discontinuità di Codici e Costituzioni?
Marcello Aragona, Francesco Aragona FISIOPATOLOGIA ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Marcello Aragona, Francesco Aragona FISIOPATOLOGIA ...
Marcello Aragona, Francesco Aragona
FISIOPATOLOGIA DELLO STRESSAspetti Istopatologici del Comportamento Emozionale Umano
Proprietà letteraria riservata © 2009Melino Nerella Edizioni
ISBN 978-88-96311-00-4
Direttore Editoriale: Silvio Aparo
www.melinonerella.it
finito di stampare nel mese di Dicembreda Mora Artigrafiche (Rg)
INDICE
Premessa............................................................................................................pagIntroduzione..............................................................................................................Bibliografia................................................................................................................
Parte I
Capitolo I: Lo stress: aspetti fisiologici.........................................................................Nozione di emozione e di stress..............................................................................Bibliografia...................................................................................................................
Capitolo II: Le modificazioni biologiche, di significato schiettamente fisiologico, nello stress.I primi approcci teorici.....................................................................................................1. Gli effetti biologici diretti......................................................................................2. Le vie di attivazione ipotalamo-ipofisaria...........................................................2.1. La via degli stimoli sensoriali visivi, uditivi, gustativi, olfattivi....................2.2. La via del dolore fisico.......................................................................................2.3. La via delle citochine e dell’ossido d’azoto.....................................................3. Gli effetti biologici indiretti..................................................................................Bibliografia...................................................................................................................
Capitolo III: Le emozioni e le loro manifestazioni espressive e biologiche......................Bibliografia...................................................................................................................
Capitolo IV: Istofisiologia dello stress...........................................................................1. La casistica di studio...............................................................................................2. Descrizione ed interpretazione dei reperti istologici osservati........................2.1. Le ghiandole surrenali.........................................................................................2.1.1. La midollare surrenale......................................................................................2.1.2. La corticale surrenale.......................................................................................2.2. L’encefalo (compreso l’ipotalamo, l’ipofisi, la tiroide)..................................2.2.1. Ipotalamo ed ipofisi.........................................................................................2.2.2. Tiroide...............................................................................................................2.3. Aspetti istofisiologici di altri organi: fegato, pancreas, milza, reni...............Bibliografia...................................................................................................................
3
7820
232343
4545464649525455
5969
7373767678818687899292
Parte II
Capitolo I: Lo stress: aspetti patologici. Aspetti introduttivi........................................
Capitolo II: Stress cronici e danni del sistema nervoso centrale.....................................1. Disordine post traumatico da stress (DPTS)....................................................2. Problemi psicologici in fanciulli esposti ad azioni di guerra...........................3. Nanismo da deprivazione....................................................................................4. Burnout (Esaurimento emozionale)...................................................................5. La sindrome di Stendhal......................................................................................Bibliografia..................................................................................................................
Capitolo III: Sulle modificazioni biologiche encefaliche nelle sindromi neurologiche da stresscronici............................................................................................................................1. Il ruolo delle catecolamine...................................................................................2. Il ruolo del CRH e dell’asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene......................Bibliografia..................................................................................................................
Capitolo IV: Le alterazioni anatomiche encefaliche negli stress cronici..........................1. Indagini sul vivente e sperimentali su animali di laboratorio..........................2. Indagini su cadaveri...............................................................................................Bibliografia..................................................................................................................
Capitolo V: Stress cronici e danni immunitari.............................................................1. Organi linfoidi........................................................................................................2. Stress cronici e tumori..........................................................................................Bibliografia..................................................................................................................
Capitolo VI: Lesioni cardiache negli stress. Risultati...................................................1. Miocitolisi coagulativa...........................................................................................2. Fibrosi.....................................................................................................................3. Le ghiandole surrenali..........................................................................................Bibliografia..................................................................................................................
Capitolo VII: Le lesioni da stress di altri organi.........................................................1. Fegato, reni.............................................................................................................2. Esofago, stomaco, intestino.................................................................................3. Ghiandole genitali.................................................................................................Bibliografia.................................................................................................................
Marcello Aragona, Francesco Aragona
4
99
103103107108111113115
121121123128
133133138141
145149151153
159162165166172
177177177181182
Capitolo VIII: La morte come conseguenza di stress acuti e cronici..............................1. La morte improvvisa cardiaca da stress..............................................................2. La morte improvvisa cerebrale da stress............................................................3. La morte da ulcerazioni gastro-intestinali..........................................................4. La morte da stress cronici....................................................................................Bibliografia..................................................................................................................
Capitolo IX: Il suicidio. L’omicidio-suicidio................................................................1. Il suicidio: anche sul ruolo patogenetico del bullismo nei fanciulli e dell’usoprolungato di farmaci antidepressivi......................................................................2. L’omicidio-suicidio................................................................................................Bibliografia..................................................................................................................
Capitolo X: Utilità dello studio clinico e medico-legale in situazioni di stress compreso anchequello psichico ed esistenziale risarcibile. Note diagnostiche e terapeutiche.........................1. Note di terapia.......................................................................................................Bibliografia.................................................................................................................
Appendice.................................................................................................................La via transpersonale nella gestione dello stress in oncologia............................(di Marcello Aragona)·Il disagio in oncologia..............................................................................................·Incontro con Joules Grossman..............................................................................·Corso sulla Comunicazione....................................................................................·La via transpersonale...............................................................................................·Vivere e Morire.........................................................................................................Bibliografia..................................................................................................................
Figure.........................................................................................................................
5
Fisiopatologia dello stress
185185194195196196
199
199212220
225226230
233233
233234235236246257
263
����
Fisiopatologia dello stress: aspetti istopatologici delcomportamento emozionale umano
Aragona Marcello1, Aragona Francesco2(1. Prof. Aggregato di Oncologia Medica. Dipartimento di Patologia Umana, UOC di On-cologia Medica e Hospice - Policlinico Universitario di Messina2. già Prof. Ordinario di Medicina Legale e libero docente di Anatomia e Istologia Patologica- Università di Messina)
PremessaLorand Bertok, componente del comitato organizzatore del congresso inter-
nazionale “Stress of Life” svoltosi a Budapest dall’1 a 5 luglio 1997 ha introdottoil congresso stesso con la seguente breve biografia di Hans Selye:
“Hans Selye, ideatore della nozione di stress e facente parte di coloro chehanno contribuito maggiormente alla conoscenza della moderna endocrinolo-gia, era nato a Komarno, Slovacchia (a quel tempo Komaron, Ungheria) nel 1907,figlio di Ugo Selye, colonnello chirurgo nell’esercito monarchico austro-unga-rico. Hans Selye fu educato in un monastero benedettino e dopo nella scuola me-dica di Charles (tedesca) dell’Università di Praga (a quel tempo capitale dellaCecoslovacchia). Egli parlava l’ungherese, il tedesco, lo slovacco, il ceco, il fran-cesce, l’inglese, e poi lo spagnolo,l’italiano, il portoghese ed il russo. Trascorsemolta parte della sua vita in Ungheria, in Cecoslovacchia, negli USA ed in Canadà:egli era un “cittadino del mondo”. Tuttavia era stato sempre orgoglioso della suaorigine ungherese. Era appassionato dei cibi e dei vini ungheresi; era uomo so-cievole e possedeva uno speciale senso dell’umorismo”.
“Selye, quando era studente nell’Università Charles di Praga, aveva osservatoche pazienti affetti da malattie diverse mostravano spesso sensazioni e sintomiidentici. Egli era un corretto osservatore delle malattie. Forse questa osservazioneera la prima tappa per l’identificazione dello stress. Più tardi scoprì e descrisse lasindrone generale di adattamento: lo stress. Le sue intuizioni ed i suoi concetti eb-bero una grande influenza sia nel mondo scientifico che nella nostra vita quoti-diana. Le sue idee furono utilizzate in medicina ed in quasi tutte le disciplinebiologiche dall’endocrinologia alla riproduzione animale e alla psicologia sociale.
7
Le sue pubblicazioni divennero “bestsellers” in tutto il mondo. Il suo laboratorio,l’Istituto di medicina e chirurgia sperimentale, McGill Università di Montreal, eraun centro internazionale di ricerca medica. Attualmente i suoi studenti e colla-boratori sono leaders di varie istituzioni scientifiche in tutto il mondo. Egli pro-babilmente ebbe maggiori riconoscimenti di ogni altro medico (inclusi i più altiordini del Canadà), ma non il premio Nobel, sebbene egli fosse stato segnalatovarie volte. Selye era internazionalmente considerato come uno delle più emi-nenti autorità nella medicina sperimentale. Egli morì in Montreal, Canadà, nel1982, ma la sua grandezza rimane inalterata e la sua influenza nella comunitàscientifica non è affatto diminuita. Sulle basi delle sue brillanti intuizioni i suoi stu-denti e collaboratori hanno aperte nuove strade di ricerca scientifica, come èanche dimostrato dall’attuale congresso”.
IntroduzioneLa constatazione che praticamente in tutte le numerose pubblicazioni dedicate
allo stress gli aspetti morfologici, sia fisiologici che anatomo-patologici, siano li-mitati a studi condotti su animali di laboratorio, mentre mancano indagini siste-matiche di questo genere sull’uomo, ed il rilievo che nei trattati di istologianormale non figurino descritte le modificazioni istofisiologiche degli organi inrapporto alla loro attività funzionale, neppure quelle verificabili sugli animali dilaboratorio, modificazioni che sono costantemente presenti nello stress, soprat-tutto a livello neuroendocrino, ci hanno indotti a raccogliere nel presente volumei risultati della nostra esperienza su questo tema, fondata sulle necroscopie ese-guite nel corso di circa quarant’anni (1958-1997), non trascurando la vasta lette-ratura, antica e recente, sia di ordine fisiologico che patologico, soprattutto dicarattere clinico, esistente sull’argomento. A proposito dell’istofisiologia, dobbiamoricordare che tale metodo d’indagine fu ideato nel secolo XVII da Marcello Mal-pighi (Bologna 1628-Roma 1694), il quale insegnò anche nell’Università di Mes-sina (1662-1669). Il Malpighi, grande medico e biologo, fu infatti il primoricercatore ad interpretare fisiologicamente gli aspetti istologici dei tessuti, cre-ando una nuova branca della biologia, appunto l’istofisiologia, applicandola nonsolo agli apparati a secrezione esterna, ma anche agli organi endocrini, quali leghiandole surrenali (allora indicate come reni succenturiati): ciò con l’uso d’un mi-croscopio rudimentale realizzato da Galileo, il quale aveva adottato per l’esamedi piccoli oggetti uno strumento costituito da un oculare concavo e di un obiet-tivo convesso, da Lui definito occhialino (1).
In un primo tempo ci siamo limitati allo studio di organi di individui venuti amorte dopo vari giorni di degenza ospedaliera a causa di traumatismi, specie e li-vello cranico, da ustioni ed anche di soggetti venuti a morte per processi patolo-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
8
gici da causa naturale, soggetti nei quali lo stress era implicito nella condizionemorbosa e nello stesso ricovero ospedaliero, nonché emergente dai dati di labo-ratorio riportati nelle cartelle cliniche. In questo studio sono stati compresi i casidi suicidio, nei quali, per effetto dell’azione violenta impiegata, la morte era av-venuta in modo istantaneo o molto rapido: ciò per evitare l’interferenza dellostato agonico, i cui effetti sui tessuti organici non sono dissimili da quelli dellostress. Ci siamo soprattutto serviti dei casi di impiccamento, di annegamento inmare o in acqua dolce, di quelli eseguiti con armi da sparo o da punte e taglio, omediante precipitazione dall’alto o investimento ferroviario. Nell’ambito delleforme venefiche sono stati in particolare studiati i casi connessi a composti adazione inibente la risposta ipotalamo-ipofisaria, come ci risultava da nostre pre-cedenti indagini sperimentali (2) ed è stato anche utilizzato un episodio di omi-cidio-suicidio da veneficio per i motivi che saranno successivamente specificati.Nella ricerca sono stati compresi pure i casi di morte rapida da overdose in tos-sicodipendenti, tenuto conto del fatto che la dipendenza dalla droga, essendo abi-tualmente parossistica, genera condizioni di stress cronico in rapporto allanecessità di reperire la dose quotidiana per evitare la crisi di astinenza, i mezzi eco-nomici indispensabili, non di rado col ricorso al reato, per il suo acquisto da fontiillecite, e spesso all’esigenza di dissimulare il proprio stato nell’ambito familiaree sociale.
Nella conduzione delle suddette indagini si era ritenuta necessaria, come re-gola inderogabile in qualsiasi ricerca scientifica, la raccolta di una casistica di con-trollo, la quale, in linea di massima, doveva consistere in soggetti normali venutia morte in modo istantaneo o molto rapido per fatti violenti accidentali (inci-denti stradali, precipitazione dall’alto, cadute sul piano, annegamento in mare oin acqua dolce), nei quali erano assenti segni morfologici di stress. In questogruppo sono compresi anche quattro soggetti vittime innocenti di omicidio: unodei quali ucciso proditoriamente con un colpo di pistola da collega d’ufficio psi-chicamente disturbato; due coinvolti casualmente nell’aggressione omicida con-tro altri: il fratello di una delle vittime designate; un soggetto che trovavasicasualmente in compagnia della vittima designata; il marito inconsapevole uccisocon la stricnina mescolata al caffè dalla moglie che poi si uccise con lo stessomezzo (questi ultimi casi saranno illustrati in seguito nel capitolo dedicato al-l’omicidio-suicidio).
Per quanto riguarda i controlli con segni morfologici di stress ci siamo servitidello studio di altri 71 soggetti, descritti nel cap. 4.1. della parte I.
Inoltre, sulla scorta delle conoscenze sulla personalità dei suicidi desunta dallemodificazioni morfologiche da stress in essi osservate in rapporto alla particolaresituazione psicologica connessa alla maturazione e all’attuazione del proposito
9
Fisiopatologia dello stress
suicida, si ebbe l’autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria ad eseguire ana-loghe ricerche istologiche e istochimiche anche sugli organi interni delle vittimedi omicidio per valutarne compiutamente la personalità, nonchè la dinamica delfatto: in particolare se la vittima stessa avesse avuto contezza di quanto stava peraccadergli o se fosse stata colta di sorpresa, nonché se la medesima presentassesegni di stress e di che grado. I relativi dati istologici ed istochimici sono ripor-tati nelle singole relazioni di perizia con i dati interpretativi dei medesimi. Al ri-guardo ricordiamo che nella prefazione di una monografia sulla “ ’Ndrangheta”,pubblicata da uno di noi con la collaborazione del giornalista S.P. Putortì (In-chiesta, Reggio Calabria, 1991), l’alto magistrato reggino, dott. Saverio Mannino,fra l’altro affermava: “Su questo piano il rinvenimento all’esame autoptico dellelesioni da stress costituisce un elemento oggettivo d’importanza non trascura-bile, ad esempio, nei casi non infrequenti in cui l’omicidio si vuole frutto di er-rore o commesso in danno di una vittima innocente o, anche di un teste scomodoe non, invece, nei confronti di un affiliato... “Il suddetto magistrato concludeva:“il medico, che anche la scienza, senza venire meno alla sua funzione universaleed anzi esaltandola, non può che essere al servizio della giustizia e della società”.Lesioni cardiache da stress, su cui ci soffermeremo nel capitolo V della secondaparte, erano state segnalate da altri Autori (3) in soggetti deceduti nel corso diazioni criminose pur senza aver subito violenza fisica.
Per la notevole frequenza di questi atti di violenza omicida nelle nostre regioni(Province di Reggio Calabria e di Messina), specie fra gli anni 1970-90 del 1900,è stato possibile verificare che in quasi tutti i soggetti vittime di omicidio gli or-gani non erano affatto normali, ma mostravano segni indubbi di stress cronico,con la sovrapposizione o meno di segni di stress acuto. Questi ultimi quando lavittima aveva vissuto attimi di terrore prima di essere uccisa senza potersi difen-dere. In questo gruppo vi era stato qualche soggetto rientrante nella norma, masi trattava di evenienza molto rara connessa all’uccisione di individui testimoni in-volontari dell’atto delittuoso diretto contro la vittima designata. Questa casisticariguardava per lo più latitanti o vittime di faide interfamiliari, molto frequentinelle organizzazioni criminali. Nelle condizioni suddette lo stress era connesso allanecessità di sfuggire alle forze dell’ordine, ai competitori nell’ambito criminale oalle vendette in ambito interfamiliare. Tra le faide vi sono state uccisioni di dete-nuti in carceri, ed anche di soggetti viventi in abitazioni fortificate, senza chefosse stato possibile identificare i responsabili. Nella maggior parte di questi ul-timi casi sono state usate armi di precisione e di elevata potenza, tanto che i sud-detti omicidi furono effettuati dall’alto e da notevole distanza, per lo più con unsolo colpo alla testa o in altre parti vitali del corpo.
Alle medesime conclusioni sulle condizioni psicologiche degli affiliati alla mafia
Marcello Aragona, Francesco Aragona
10
siciliana era pervenuto, per altra via, Paolo Borsellino. Egli, nel 1992 poco primadi essere ucciso, in una intervista al Corriere della Sera, affermava: “Il pugno diferro, la dittatura di Totò Riina sulla mafia produce un terrore costante all’in-terno dell’organizzazione di Cosa Nostra. I membri vivono un’ossessione conti-nua, quotidiana: si chiedono esclusivamente chi potrebbe ucciderli, e quando.Questa situazione ha prodotto un’incredibile fioritura di pentiti, quasi una tren-tina. Una cosa assolutamente straordinaria”. Perciò le vittime di omicidio costi-tuiscono indiscutibile proficua fonte di ricerca e consentono di meglio identificarele modificazioni organiche di carattere funzionale connesse agli stati emozionaliintensi, brevi o protratti nel tempo, mai in alcun modo riproducibili negli animalida esperimento.
In complesso sono stati studiati 713 casi, di cui sarà detto nel capitolo 4.1 dellaprima parte per quanto attiene agli aspetti istofisiologici, dopo avere premesso idati della letteratura relativi alle risposte fisiologiche alle emozioni e agli altri stress,e nella seconda parte per quanto attiene agli aspetti patologici, previa disamina,la più ampia possibile, della vastissima letteratura internaziona- le esistente sul-l’argomento. Va precisato che nel capitolo attinente alle lesioni cardiache da stresssono stati studiati per controllo altri 23 casi: 18 di morte per elettrocuzione acci-dentale, 3 casi di morte per ipoglicemia, 2 casi di morte in conseguenza di inie-zioni di atropina in preanestesia; ed ancora che nella parte attinente al dannoimmunologico sono stati studiati altri 12 casi di soggetti affetti da processi mor-bosi di natura batterica. In complesso i casi studiati ammontano a 748.
Lo studio della suddetta casistica, nell’ambito delle modificazioni istofisiolo-giche da stress, ha consentito anche di valutare post-mortem la condizione psi-cologica della vittima, sia pregressa che al momento della morte.
Fra la letteratura che oggi esiste sulle emozioni e sui vari aspetti degli stress,spicca il volume di Joseph Le Doux dal titolo Il Cervello Emotivo (4), ove a pagina177 l’Autore, illustrando le funzioni dell’amigdala, conferma quanto da tempo danoi sostenuto (5,6,7,8), con l’aforisma: “In altre parole, l’anatomia può illuminare lapsicologia”.
Nel nostro elaborato, come apparirà chiaro sia nella parte che attiene alle ri-sposte fisiologiche allo stress ed ancor più nella parte che attiene agli aspetti pa-tologici dello stress, emerge lo stretto rapporto esistente fra l’attività fisica e quellamentale: entità della vita dell’uomo che in nessun modo possono essere scisse. Aparte i suddetti aspetti, attraverso gli innumerevoli studi esistenti nella letteraturaemergono indiscutibili elementi che confermano l’inscindibilità tra mente e corpo,essendo la prima dipendente dalle condizioni del secondo. A questo riguardohanno avuto valore assoluto le opinioni di autorevoli autori, antichi e recenti:Ramon y Cajàl (9), premio Nobel per la medicina nel 1909 insieme con Camillo
11
Fisiopatologia dello stress
Golgi, aveva per primo sostenuto che l’esercizio cerebrale non può accompa-gnarsi a produzione di nuove cellule nervose dato che queste non si riproduconoma dovesse condizionare uno sviluppo più intenso dell’usuale delle espansioniprotoplasmatiche e delle collaterali neurali, tale da stabilire nuove e più esteseconnessioni intercorticali (cosiddetta plasticità sinaptica). A questo specifico ri-guardo è necessario però osservare che recentemente si è scoperto che l’ence-falo, specie a livello dell’ippocampo, è ricco di cellule staminali che possonodifferenziarsi nelle cellule proprie del tessuto nervoso centrale e perciò anche inneuroni migliorandone notevolmente le capacità mnemoniche. (10).
Carrel (11), premio Nobel 1912 per la medicina, si esprimeva nei termini se-guenti: “mediante i nostri metodi abbiamo separato due parti da un tutto che èinscindibile”. Voltaire (12), col suo spirito severamente critico, si era perfetta-mente adeguato a questa verità, tanto che alla voce Carattere del suo DizionarioFilosofico scriveva: “E’ possibile cambiare carattere? Si, se si cambia il fisico. Puòdarsi che un uomo nato turbolento, inflessibile e violento, divenendo malato si ri-duca piagnucolone, timido e queto. Ma il suo corpo non è più il medesimo. Per-ché se i suoi nervi, il suo sangue e il suo midollo spinale fossero ancora quelli diprima, non sarebbe cambiata neppure la sua natura psichica, come non cambial’istinto d’un lupo o d’una faina”. Damasio (13), ai fini di illustrare gli intimi rap-porti tra funzione cerebrale e pensiero, ha preso lo spunto da un caso di infor-tunio sul lavoro verificatosi nel 1848, assai significativo dal punto di vistapsichiatrico, ottimamente studiato per molti anni dal medico di famiglia. Il casoriguardava un giovane di 25 anni, che svolgeva il ruolo di caposquadra in un’im-presa di costruzioni impegnata nella collocazione dei binari di una nuova linea fer-rata attraverso il Vermont. Il soggetto mentre stava preparando l’occorrente peraprire un varco nella roccia mediante esplosione di polvere da sparo, nel pressareintempestivamente con una barra metallica la carica esplosiva introdotta sul fondod’un incavo nella roccia, provocò in anticipo l’esplosione della carica, che gli pro-iettò sulla guancia sinistra, al di sotto del processo zigomatico, una delle estremitàdella barra metallica, la quale, dopo essere penetrata con estrema violenza nellascatola cranica per il cavo orbitario dello stesso lato, ledendo in modo irreversi-bile il globo oculare, e dopo avere attraversato l’encefalo uscì dalla volta cranica,avendo perciò descritto un tramite emorragico diretto dal basso in alto. Sor-prendentemente la sintomatologia conseguita non apparve proporzionata allagravità delle lesioni traumatiche, tenuto conto che la barra metallica che attra-versò violentemente la scatola cranica era lunga 110 cm, aveva un diametro dilievemente superiore a 3 cm e pesava 6 Kg. Damasio così descrisse l’episo-dio:”Tutti si sorpresero che Gage (tale era il nome dell’infortunato) non fosse ri-masto ucciso all’istante; l’articolo medico della rivista di Boston (Boston Medical
Marcello Aragona, Francesco Aragona
12
and Surgical Journal) riporta che subito dopo l’esplosione il paziente fu rivoltatosulla schiena; che poco dopo egli mostrò alcuni movimenti convulsi delle estre-mità e nel giro di pochi minuti parlò; che i suoi uomini lo sollevarono e a brac-cio lo trasportarono fino alla strada, che distava solo poche pertiche (una perticaessendo pari a circa 5 metri) e lo posero a sedere su un carro trainato da buoi, sulquale egli, seduto con la schiena eretta, percorse più di un chilometro, fino all’al-bergo di Joseph Adams; e che Gage scese dal carro da solo, con un piccolo aiutoda parte dei suoi operai”. Al medico, sopraggiunto dopo circa un’ora, Gage, cheera seduto su una sedia, disse: “dottore, qui c’è lavoro per voi”. Le ferite dellafaccia e del cuoio capelluto furono pulite e medicate con cura, ma in assenza difarmaci chemioterapici ed antibiotici, allora inesistenti, le ferite andarono lenta-mente a guarigione in circa due mesi. Ma il soggetto non era più quello di prima,aveva cambiato carattere, era divenuto “bizzarro, insolente, capace a volte dellepiù grossolane imprecazioni, da cui in precedenza era stato del tutto alieno; pocoriguardoso nei confronti dei compagni, insofferente di vincoli o consigli che con-trastassero i suoi desideri; a volte tenacemente ostinato, e più capriccioso e oscil-lante, sempre pronto a elaborare molti programmi di attività future cheabbandonava non appena li aveva delineati...” - “Il linguaggio è talmente oscenoe degradato che alle donne si consiglia di non rimanere a lungo in sua presenza,o la loro sensibilità sarà turbata...”. Questi nuovi aspetti della personalità di Gageerano in palese contrasto con “le abitudini moderate e con la grande forza di ca-rattere che gli erano state proprie prima dell’incidente”, quando egli era assai va-lido nel suo lavoro ed in specie nei compiti di controllo degli operai a luisottoposti. Perse il lavoro, ottenne altri incarichi lavorativi di diversa natura, senzariuscire a manterne alcuno per la sua incostanza e incoerenza. Egli “perdette qual-cosa di peculiarmente umano e cioè la capacità di mantenere i rapporti socialicome un tempo”, pur non avendo mai manifestato alcun sintomo schiettamenteneurologico, come disturbi della motilità artuale, della parola, dei sensi, tranne laperdita della vista a sinistra per lo sfacelo traumatico del globo oculare compresonel tramite traumatico. Morì nel 1861 in seguito ad una grave crisi di male epi-lettico, che durò poco più di una giornata:aveva 38 anni. Purtroppo non fu ese-guita l’autopsia: sarebbe stato utilissimo conoscere la sede esatta e l’estensionedei postumi delle lesioni cerebrali riportate, anche se indirettamente fu successi-vamente possibile, dopo esumazione del cadavere e prelievo del cranio, calcolare,in base alle vestigia delle lesioni qui esistenti e alla loro sede (come riprodottenelle relative fotografie riportate nel testo di Damasio), le aree cerebrali attraver-sate dalla barra metallica: base del lobo frontale sinistro, convessità dello stessolobo, alquanto arretrata rispetto alla base, con verosimili lesioni da succussione ditutta la massa encefalica, pure controlaterali, tenuto anche conto che il meccani-
13
Fisiopatologia dello stress
smo espansivo impresso dalla violenza del trauma al cervello doveva aver pro-dotto nel medesimo un urto contro la dura madre della volta cranica e la pareteossea del cranio e contro la falce cerebrale. Damasio nella sua pratica clinica os-servò altri casi, in parte simili, per processi patologici dei lobi frontali, tra i qualiquello di un uomo trentenne affetto da un tumore meningeo che comprimeva labase dei suddetti lobi spingendoli verso l’alto contro la volta cranica. Il tumorefu asportato, ma la personalità del soggetto era profondamente cambiata pur es-sendo rimaste intatte le sue doti intellettuali. Nel suo lavoro concettuale non erapiù costante e diligente come prima, né si poteva più fare affidamento su di luiper compiti delicati ancorchè egli non avesse perduta la propria preparazione tec-nica. Perse il lavoro, fu abbandonato dai figli e dalla moglie, dalla quale divorziò.Egli era perfettamente consapevole della tragedia della sua vita e la raccontavasenza alcuna emozione: come se quei fatti non lo riguardassero: aveva perciò per-duto la capacità di soffrire emotivamente per la sua vicenda.
I casi descritti da Damasio consentono alcune riflessioni in rapporto al signi-ficato funzionale della superficie ventrale dei lobi frontali. Tale superficie riceve,infatti, impulsi diretti provenienti dall’amigdala (Reischies, 14), per effetto deiquali quest’area corticoventrale, insieme con l’area ventro-mediale degli stessilobi, regolerebbe il rapporto ansietà/controllo comportamentale. Per cui a lesioni diquesta regione conseguirebbero comportamenti euforici e disinibiti, cioè sintomiopposti a quelli che si osservano nelle depressioni. In effetti detta opinione con-corda con le precedenti osservazioni di Gerstenbrand e Hoff (15), i quali hannodescritto due sindromi ritenute caratteristiche di lesioni della corteccia frontale:la sindrome fronto-basale o fronto-ventrale e la sindrome fronto-convessa. La prima caratte-rizzata da spiccata inibizione emozionale con umore permanentemente euforico,restringimento critico e della facoltà di giudizio, fuga di idee e nello stadio acutoda intensa agitazione psicomotoria; la seconda caratterizzata da aspontaneità, apa-tia, umore depresso. I casi descritti da Damasio rientrano, perciò, nella formafronto-basale o fronto-ventrale.
Le Doux (4), fondandosi sulle conoscenze attinenti alla memoria, ha fatto os-servazioni simili. La memoria, infatti, costituisce l’elemento fondamentale nellosviluppo della personalità, come d’altra parte è dimostrato da vari processi mor-bosi che colpiscono irreversibilmente l’encefalo, il prototipo dei quali è il morbodi Alzheimer. I soggetti affetti da questa malattia, avendo perduto del tutto lamemoria, anche della loro identità personale, divengono completamente diso-rientati nel tempo e nello spazio. Detta malattia, che afflige l’umanità da tempi re-moti, colpisce in primo luogo i lobi temporali, essenzialmente nella loro parteinterna, denominata ippocampo che costituisce la sede più importante nelle acqui-sizioni mnemoniche (come si vedrà questa formazione encefalica è la sede pre-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
14
diletta delle lesioni di particolari stress cronici). Il processo morboso si diffondepoi alla neocorteccia, che rappresenta la parte più nobile dell’encefalo umano. Inquesti studi sulla memoria si sono cimentati numerosissimi ricercatori. Si parla dimemoria a breve termine in riferimento a fatti appresi e memorizzati di recente, laquale si mantiene per pochi secondi, e di memoria a lungo termine, che dura da pochiminuti a tutta la vita: la prima può trasformarsi nella seconda quando si tratta difatti appresi, radicalmente e stabilmente trattenuti nella memoria. In questo se-condo tipo di acquisizione mnemonica assume un ruolo fontamentale il coloritoemotivo del fatto appreso, essendo la qualità dell’emozione (negativa come lapaura, la tristezza, l’ira; positiva come la gioia, la delizia) essenziale per il mante-nimento del ricordo. Gli studi moderni hanno dimostrato che le suddette dueforme fondamentali di memoria si fondano su meccanismi differenti. Si è, infatti,constatato che il ricordo può essere cosciente in quanto connesso a un’esperienzavissuta in passato, ovvero di natura riflessa, cioè non passante per il livello di co-scienza: i ricordi coscienti sono definiti con i termini di dichiarativi o espliciti, men-tre i secondi con i termini di procedurali o impliciti. Le Doux commenta questadistinzione sulla base di un’osservazione clinica di Claparede, medico franceseche esercitò la sua professione nella prima decade del 1900. Detto sanitario avevain cura una paziente che, a causa di lesioni cerebrali acquisite, sembrava avereperduta la capacità di creare nuovi ricordi, al punto che ogni volta che egli stessoentrava nella stanza dell’inferma questa non lo riconosceva perché non ricordavadi averlo mai visto. Un giorno Claparede, nel tendere la mano alla paziente, co-m’era sua abitudine, questa la ritrasse immediatamente perché il medico avevamesso nella sua mano una puntina. Nei giorni successivi la paziente continuò anon riconoscerlo, ma rifiutò di stringergli la mano, anche se non sapesse spie-garne il motivo. Claparede intuì che il comportamento della sua paziente dovessespiegarsi con l’esistenza di due sistemi per la memoria: uno deputato a contri-buire alla fissazione della memoria delle esperienze, da mettere poi a disposizionedei ricordi coscienti; l’altro, invece, operante fuori dalla coscienza, capace di con-trollare il comportamento, senza consapevolezza esplicita dell’apprendimento ac-quisito. Le Doux asserisce, perciò, che la paziente di Claparede aveva perduta lacapacità di possedere ricordi coscienti, ma manteneva quella inconscia di evitareil pericolo della puntura. La quale più propriamente si avvicina ad un riflesso con-dizionato. Altre successive osservazioni cliniche confermarono la suddetta intui-zione. Di indubbio interesse fu lo studio di un giovane soggetto affetto da unagravissima forma di epilessia, che non rispondeva alla terapia farmacologica. Perquesto motivo si ritenne indispensabile ricorrere all’intervento chirurgico per ri-muovere i focolai epilettogeni cerebrali: gli vennero asportati entrambi i lobi tem-porali. L’epilessia divenne così controllabile farmacologicamente, ma il soggetto
15
Fisiopatologia dello stress
perse del tutto la memoria: in particolare da quel momento fu incapace di formarericordi coscienti espliciti o dichiarativi e a lungo termine. Questo soggetto, esa-minato più volte e da più studiosi nel corso degli anni successivi, fino a dopo 40anni dall’intervento, non sapeva la sua età, non aveva nozione del tempo, non ri-cordava nulla di sé e dei suoi genitori, non riusciva ad apprendere nulla di nuovo,non riconosceva la sua immagine fotografica, dimenticava qualsiasi fatto dellavita quotidiana.
Riguardo alla indivisibilità tra corpo e mente, Edelman (16), premio Nobel1972 per la fisiologia e la medicina, afferma: “Vi sono prove di una relazione (purse non lineare) fra le dimensioni e la complessità del cervello e la complessità delcomportamento; ve ne sono molte dell’associazione tra parti specifiche del cer-vello e specifiche abilità. Prove cliniche sulle lesioni cerebrali rivelano una corri-spondenza precisa tra le aree cerebrali danneggiate e la perdita di funzioni mentali,specifiche e identificabili. Questi risultati, della più varia provenienza, suggeri-scono che, per comprendere l’evoluzione della mente e il comportamento, biso-gna dapprima comprendere le basi dell’evoluzione morfologica.”
Blum e Lagerson (17) scrivono: “Dal punto di vista storico, le ricerche sullamente restarono separate dagli studi effettuati sull’organo cerebrale e sul com-portamento. Il primo approccio, il metodo introspettivo, ignorò completamenteil comportamento e cercò di individuare delle tecniche scientifiche per l’analisi deicontenuti della coscienza, cioè della mente. La mente restava un concetto astrattoche, a seconda delle personali convinzioni, includeva la personalità, l’Io e l’anima.Alcuni studiosi contemporanei ritengono addirittura che la mancanza di unachiara comprensione delle basi fisiologiche delle azioni mentali stia a significareche l’esperienza conscia può sussistere indipendentemente dal cervello, ritenendoche il mondo mentale costituisca una sfera a parte non connessa all’entità fisicadell’encefalo. Altri, compresi gli Autori di questo libro, ritengono che qualsiasiapproccio esauriente alla funzione mentale debba basarsi necessariamente su unavalutazione scientifica del cervello.”
Crick (18), premio Nobel 1962 per la fisiologia e la medicina, insieme conWatson e Wilkins, studiando il problema della coscienza, fa le seguenti osserva-zioni circa le posizioni della filosofia sullo stesso argomento: “Un’altra cosa sullaquale intendo richiamare l’attenzione è che lo studio della coscienza è un pro-blema scientifico. Non esiste alcuna barriera insormontabile che tenga la scienzalontana da esso. Se da questo libro si può trarre un insegnamento, si tratta pro-prio del fatto che oggi possiamo comprendere in che modo affrontare la que-stione sperimentalmente. La concezione secondo la quale solo i filosofipotrebbero affrontare il problema della coscienza non trova più giustificazione al-cuna. I traguardi conseguiti dai filosofi negli ultimi duemila anni sono stati tal-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
16
mente scarsi che essi farebbero meglio a mostrare una certa modestia, invece del-l’altezzosa superiorità che esibiscono di solito. Le nostre ipotesi sul funziona-mento del cervello dovranno sicuramente essere chiarite ed estese. Spero che unnumero sempre maggiore di filosofi acquisisca un sufficiente bagaglio di cono-scenze sul cervello da essere in grado di avanzare delle ipotesi sul suo funziona-mento; ritengo però che essi dovrebbero anche imparare a rinunciare alle loroteorie predilette quando le prove scientifiche si scontrano con esse dimostrandonel’infondatezza; in caso contrario, non faranno altro che esporsi al ridicolo”.
Le osservazioni di Crick hanno trovato riscontro in quanto affermato da Mau-rice Merleau-Ponty (19), eminente filosofo contemporaneo riguardo al valore uni-versale della biologia, nella quale sono pure comprese l’anatomia e la fisiologia,circa la sua influenza sul pensiero filosofico, prevalentemente sulle orme del pen-siero cartesiano. I concetti espressi da Merleau-Ponty si riferiscono anche all’ideadi Heidegger circa un’esistenza che non è mai avulsa dal mondo, anche se con mo-tivazioni diverse e più aderenti alla realtà umana. L’essere viene concepito inchiave soprattutto biologica legata alla vita nella sua dimensione organica piutto-sto che alla storia e alle responsabilità che essa ci impone.
Egli scrive: “Naturalmente abbiamo sempre un a priori biologico a partire dal-l’uomo: qui abbiamo l’a priori degli istinti corporei, degli impulsi originari, il cuisoddisfacimento (il mangiare, l’accoppiamento, ecc.) comporta interiormente l’apriori”... ...Così mi sembra che la biologia, la quale apparentemente è inferiore allamatematica e alla fisica e che per tanto tempo è stata considerata dal fisicalismoquasi con commiserazione, come una fase preliminare, imperfetta e meramentedescrittiva della successiva spiegazione fisica, è sempre stata in grado sin dall’inizio, direstare più vicina alla filosofia e alla vera conoscenza, perchè non è stata mai minacciatadalle ammirevoli tecniche (Kunste) simboliche di una costruzione logica delle sueverità e delle sue teorie, una costruzione che nella fisica e nella matematica haprodotto un miracolo di effettive operazioni, ma, appunto, come tutti i miracoliincomprensibili.”. ...La biologia è una psicofisica concreta e autentica. Ad essa incombonodovunque e necessariamente compiti universali, e solo apparentemente essa è in svantaggio ri-spetto alla fisica, la quale si estende anche alle infinità astronomiche e giunge a leggiche intendono conseguire il senso di generalità incondizionate. Solo apparente-mente essa si limita alla nostra terra, piccola e irrilevante e, in quanto antropologia,a questo trascurabile essere vivente che si chiama uomo. Se si risale alle fonti ultime di evi-denza, in base alle quali il mondo significa per noi, nel suo senso e nel suo essere,ciò che significa, e a tutte le necessità essenziali che su questa base si rivelano, ri-sulta come la biologia non sia una disciplina contingente che si occupa di una terra irrilevante,come la zoologia della Germania, la botanica del Baden, ma, in quanto biologia generale ha lastessa generalità mondiale della fisica. Qualsiasi nesso possa avere una biologia di Ve-
17
Fisiopatologia dello stress
nere, di cui noi potremmo parlare come di una possibilità, essa lo deve alla for-mazione originaria di senso del nostro mondo vissuto e, su questa base, all’ulte-riore elaborazione teoretica di questa formazione di senso da parte della nostrabiologia. Essa ha, certo, insieme col suo compito universale, un orizzonte infinito, il quale ar-ticolato a sua volta in altri orizzonti, non le assegna, quale compito pensabile, una conoscenzadi leggi, conclusa nello stesso senso, che, su questa base, possa abbracciare e si estenda a tutte leinfinità. Ma in compenso essa non è meramente formale come la matematica e come la fisica,non si riferisce ad una mera struttura astratta del mondo. Piuttosto, in quanto Biologia real-mente universale, abbraccia l’intero mondo creato, e quindi implicitamente anche la fisica, e at-traverso la considerazione dei correlati (soggettivi) diventa una filosofia del tutto universale”.
Infine, l’unità fra corpo e mente non è soltanto dimostrata dai danni psichicie comportamentali connessi a lesioni cerebrali o di altri organi (ipofisi, tiroide, sur-reni, fegato, reni, ecc.), come si dirà più specificamente in seguito, ma anche dallacosiddetta psicofarmacologia, disciplina creata da Kraepelin (20) nell’ultima decadedel 1800, la quale, con l’ausilio di farmaci psicotropi, che agiscono a livello del si-stema nervoso centrale, consentì di approfondire le conoscenze sullo psichismoumano e chiarire specialmente la genesi di manifestazioni psichiche elementari:il terrore, l’angoscia, l’ira, l’indifferenza, il negativismo, le allucinazioni, ecc.inquanto sperimentalmente riproducibili con l’uso di farmaci (amfetamina, dietila-mina dell’acido lisergico o LSD, mescalina, cloropromazina, reserpina, mepro-bamato ed altri tranquillanti come benactizina, iproniazide, imipramina, ecc.). Talifarmaci vengono definiti psicotropi in quanto capaci di modificare l’attività men-tale, genericamente intesa, senza tener conto, cioè, del tipo di detta modifica-zione. A seconda del tipo di effetto psichico, i farmaci psicotropi vengono distintiin: psicolettici, psicoanalettici, psicodislettici. Fra quest’ultimi particolarmente gliallucinogeni, come la LSD e la mescalina. Un cenno qui sarà fatto solo sugli ef-fetti di questi due ultimi composti. La mescalina produce nei soggetti normaliansietà, iperreflessia, tremori statici e vivide allucinazioni generalmente visive (lucicolorate, disegni geometrici, animali, persone). La LSD agisce a dosi molto piùbasse della mescalina; causa allucinazioni prevalentemente visive con ricchezza diparticolari, in forma di sprazzi di luce, di figure geometriche, di scene plastichein movimento, in sensazioni di allungamento degli arti, in modificazioni dellasfera dell’io (depersonalizzazione somato-psichica), in disturbi del pensiero e dellinguaggio (rallentamento, indecisione, difficoltà del pensiero astratto, difficoltàdi ricordare eventi recenti, rievocazione chiara di eventi passati, verbalizzazioneframmentaria).
In psicopatologia sperimentale gli effetti prodotti dai predetti farmaci psico-tropi nel loro complesso, vengono definite psicosi modello in quanto le alterazionipsichiche prodotte artificialmente riproducono quadri osservabili in psichiatria.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
18
Infatti, dato che le funzioni psichiche compromesse in tali psicosi sono la co-scienza, la percezione, l’umore, si hanno sindromi mentali più o meno complessea seconda se l’alterazione delle funzioni suddette sia simultanea o meno. Perquanto attiene alla coscienza si può avere una più o meno profonda alterazionedell’orientamento nel tempo e nello spazio, o, al contrario, un’accentuazione ditale funzione psichica per cui i soggetti appaiono più vigili (stati di ipervigilanza).Relativamente alla percezione si ha una prevalenza delle allucinazioni visive (ditipo elementare o di tipo scenico: come accennato per la mescalina e per la LSD),mentre più rare sono le allucinazioni acustiche, olfattive, gustative e tattili. Perquanto riguarda le alterazioni dell’umore, possono aversi: stati di stimolazione(maggiore interesse per la propria persona e per l’ambiente esterno); stati di eu-foria (annullamento delle preoccupazioni e delle sensazioni somatiche spiacevoli);stati di sedazione (eliminazione delle reazioni affettive); stati d’animo abnormi(sensazioni abnormi di felicità, stati di estasi, orientamenti paranoidi, sindromimaniacali).
L’uso sperimentale di questi farmaci in psicoterapia ha aperto nuovi orizzontisulle possibilità di espansione degli stati di coscienza, verso una prospettiva tran-spersonale, una potente efficacia psicoterapeutica ed una graduale rimodulazionedei confini della psichiatria, psicologia, psicoterapia (Grof 1997). Oggi numerosetecniche non farmacologiche possono essere usate per ottenere gli stessi effettifisiologici e terapeutici di dette sostanze (21), (vedi Appendice).
Per concludere, è attuale e pienamente condivisibile quanto nel 1990 affer-mava A.Ferrara (22) nella sua relazione, dal titolo: “La nostra Società nella tradi-zione e nel futuro della anatomia patologica italiana”, esposta in occasione delconvegno per il cinquantenario della fondazione della SIAP (Società Italiana diAnatomia Patologica).
Riportiamo integralmente parte delle conclusioni di quella relazione:“Di decadenza e di eclisse della nostra materia si parla da molto tempo, ma nulla, allo
stato dei fatti, le fa prevedere come imminenti. E noi ci troviamo ad ogni convegno a ripeterci lestesse cose con la stessa preoccutata insistenza, fors’anche per esorcizzare il pericolo, se non dellafine, quanto meno dello stravolgimento della disciplina.Ma non esistono alternative alla impostazione originaria del problema. Quanto più l’Ana-
tomia patologica si distacca dalle caratteristiche originarie di “medicina dei morti”, tanto piùentra in crisi di identità, viene insidiata da più parti, perde di autorità e di rispetto. Quel-l’esclusivo privilegio –triste fin che si vuole- di accostarsi al cadavere, le conferisce la dignità diun rito sacrificale; non per nulla essa indaga sul mistero della morte, mistero che conserva, oggicome ieri, carattere di trascendenza.“Ed io ne feci Notomia, per iscoprire il segreto di così dolce morte”, scrisse il grande Leo-
nardo a proposito della morte di un vegliardo, sopravvenuta insensibilmente, senza penare, quasi
19
Fisiopatologia dello stress
come lo spegnersi di una candela.La curiosità e l’ansia di sapere, che assale lo studioso di fronte alla morte di cui non riesce
a darsi ragione, non sono mutate per nulla e distanza di cinque secoli. Si pensi al dramma re-cente ed attuale dell’Aids e delle sindroni correlate.Se vi sono della cause oscure da scoprire (cause in senso morgagnano, cioè alterazioni orga-
niche da individuare), sarà ancora la vecchia Anatomia patologica a soccorrere il clinico. “Mor-tui vivos docent”, il motto che von Rokitansky volle inciso alto sulle sue sale di autopsia, valeancora e tutto lascia credere che varrà per sempre.”
Bibliografia1. Ciaccio C., L’opera di Marcello Malpighi. Annuario della Università di Messina,
Anni 1928-1929, 1929-1930. Ateneo Messina 1996, 237-257.2. Aragona F., Anatomo-Istologia delle Ghiandole a Secrezione Interna in Tossicologia Fo-rense Atti XX Congr. Naz. Soc. Ital. Med. Leg., Trieste. 8-11 sett. 1966,99-260.
3. Cebelin M.S., Hirsch C.S., Myocardial lesions in victims of homicidial assault withoutinternal injures. Human Pathol. 11, 123, 1980.
4. Le Doux J., Il cervello emotivo. Baldini e Castoldi, Milano, 1998, pagg. 177, 187-220.
5. Aragona F., L’immagine istologica delle surrenali quale test psicologico post-mortale. Riv.It. Med. Leg. 12, 125, 1990.
6. Aragona F., La miocitolisi coagulativa ed i suoi esiti nelle vittime di omicidio. Riflessionisul relativo significato psicologico. Pathologica 83, 259, 1991.
7. Aragona M., Aragona F., Chronic stress and histological effects on the human central ner-vous system and other organs. Functional Neurology 9, 121, 1994.
8. Aragona M., Aragona F., Histologic evaluation of chronic stress in human cadavers.Atti Congr. Intern. “Stress of Life: Stress and Adaptation from molecules toman”. Budapest 1-5 luglio 1997, R.15, 129.
9. Ramon y Cajal S., Les nouvelles idées sur la structures du système nerveus chez l’Hommeet chez les Vertébrés. Reinwald, Paris, 1895.
10. Bottaccioli T.F., Psiconeuroendocrinoimmunologia. Ed. Red, Milano, 2005.11. Carrel A., L’uomo questo sconosciuto. Bompiani, Milano, 1952.12. Voltaire: Dizionario Filosofico. V ed., Mondadori, Milano, 1970. 13. Damasio A., L’errore di Cartesio. Adelphi,Milano, 1995.14. Reischies F.M., Pattern of disturbance of different ventral frontal functions in organicdepression. Ann. New York Acad. Sci. 877, 775-780, 1999.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
20
15. Gestenbrand F., Hoff H., Rehabilitation bei organische Hirnschädigung, psychiatri-sche Aspekte. Wien. Med. Wschr., 118, 754, 1968.
16. Edelman G.M., Sulla materia della mente. Adelphi, Milano, 1993, p.85.17. Bloom F.E., Lazerson A., Il cervello, la mente e il comportamento. Ed. Ciba-Geigy,
Milano 1990, p.5. 18. Crick F., La scienza e l’anima. Rizzoli, Milano, 1994, p.307.19. Merleau-Ponty M., E’ possibile oggi la filosofia? Cortina, Milano, 2003, p.137-
141.20. Kraepelin E., Über die Beinflusse einfache Psychischer Vorgange einige Arzneinmittel.
Jena, 1892. 21. Grof S., Oltre il cervello. L’esplorazione transpersonale delle possibilità della coscienzaumana. Cittadella Ed. Assisi. 1997.
22. Ferrara A., La nostra società nella tradizione e nel futuro della anatomia patologica ita-liana. Riv. Anat. Patol. e Oncol. 49,75, 1990.
21
Fisiopatologia dello stress
Parte Prima
Capitolo I
Lo stress: aspetti fisiologici
Nozione di emozione e di stressPer emozione s’intende ogni agitazione o turbamento della mente, dei senti-
menti: agitazione o turbamento intensi, ma transitori, costantemente associati adevidenti manifestazioni somatiche. Le emozioni, che sono parte integrante dellavita psichica di ogni individuo e quasi sempre sono alla base del suo comporta-mento in famiglia e nella società, costituiscono la base sentimentale di ogni com-portamento umano: non vi è persona che nello svolgimento delle sue mansioniquotidiane, lavorative o meno, non mostri senso di piacere o, al contrario, di ma-lessere psichico, talora senso di angoscia o di paura, ecc.: emozioni che condi-zionano, pertanto, il modo di essere di qualsiasi individuo nella vita quotidiana,sia nel bene che nel male. E’ anormale chi rimane indifferente di fronte ai fattiemozionali che ricorrono nella sua vita, laddove, secondo i criminologi, si confi-gura la cosiddetta “sindrome anetica”, cioè la sindrome caratterizzata dalla perditadel senso morale, che talora si osserva nei traumatizzati cranici (1,2). Tale sin-drome è stata descritta compiutamente da Damasio (3) ed avvalorata recente-mente da Lacroix (4).
Le Doux (5) asserisce che l’opinione secondo la quale le emozioni consistes-sero in sei forme fondamentali (sorpresa, felicità, paura, disgusto, tristezza, ira)oggi è sostituita dalla concezione che le emozioni fondamentali siano in effettiotto: sorpresa, tristezza, disgusto, ira, anticipazione (in senso comportamentisticoin riferimento al meccanismo stimolo-risposta), gioia, accettazione (nel senso didisponibilità), paura. Ognuna di queste forme emotive fondamentali si può som-mare ad altre emozioni della stessa classe o di altra natura e dar luogo a feno-meni emotivi più complessi.
A questo proposito appare più completa la classificazione proposta da Gole-man (6), il quale distingue le seguenti otto emozioni fondamentali:
23
Le prime quattro forme, come aveva già osservato Darwin (7), sono facil-mente riconoscibili dall’espressione del viso in ogni cultura del mondo.
Goleman (6) fa inoltre presente che devono essere considerate altre emozioni,cosiddette miste, come la gelosia, variante della collera che si combina con la tri-stezza e la paura; le virtù, quali la speranza, e la fede, il coraggio ed il pudore, la certezzae l’equanimità; ed alcuni vizi più classici, quali il dubbio, il compiacimento, la pigrizia, il tor-pore e la noia. E qui non si possono trascurare le passioni solitamente di segnoamoroso (8).
La noia e la fatica mentale sono fatti emozionali che affliggono molti indivi-dui e Bertrand Russell (9), riguardo alla noia, osservava: “Alla noia, quale uno deifattori del comportamento umano, è stata data, a parer mio, molto meno atten-zione di quanto essa ne meriti. Essa è stata, credo, una delle grandi forze motriciattraverso la storia, e tale è più che mai ai nostri tempi... Una delle condizioni es-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
24
Emozioni
Collera Comprende furia, sdegno, risentimento, ira, esasperazione, indigna-zione, acrimonia, animosistà, fastidio, irritabilità, ostilità, ed in gradoestremo: odio e violenza patologica
Comprende pena, dolore, mancanza d’allegria, cupezza, malinconia, au-tocommiserazione, solitudine, abbattimento, disperazione e, in casi pa-tologici, grave depressione
Comprende ansia, timore, nervosismo, preoccupazione, apprensione,cautela, esitazione, tensione, spavento, terrore e, come stati patologici,fobia, panico
Comprende shock, stupore, meraviglia, trasecolamento
Comprende disprezzo, sdegno, aborrimento, avversione, ripugnanza,schifo
Comprende senso di colpa, imbarazzo, rammarico, rimorso, umiliazione,rimpianto, mortificazione, contrizione
Comprende accettazione, benevolenza, fiducia, gentilezza, affinità, de-vozione, infatuazione, carità
Comprende felicità, godimento, sollievo, contentezza, beatitudine, diletto,divertimento, fierezza, piacere sensuale, esaltazione, estasi, gratifica-zione, soddisfazione, euforia, capriccio ed, al limite estremo, entusiasmomaniacale
Tristezza
Paura
Gioia
Amore
Sorpresa
Disgusto
Vergogna
senziali della noia consiste nel contrasto tra le circostanze presenti e qualche altracircostanza più gradevole che si impone irresistibilmente all’immaginazione. E’condizione essenziale anche che le facoltà d’un individuo non siano completa-mente occupate. Sfuggire ad un nemico che cerca di togliervi la vita è cosa, im-magino, spiacevole, ma certamente non noiosa. Un uomo in procinto d’esseregiustiziato non sarà certamente in preda alla noia, a meno che non sia dotato d’uncoraggio sovrumano...”. In precedenza (1857), Baudelaire (10) aveva dedicato al-cuni versi allo stato di noia:
“Ma in mezzo agli sciacalli, le pantere, le cagne, le scimmie, gli scorpioni, gliavvoltoi, i serpenti, fra i mostri che guaiscono, urlano, grugniscono entro il ser-raglio infame dei nostri vizi, uno ven’è, più laido, più cattivo, più immondo. Seb-bene non faccia grandi gesti, né acute strida, ridurrebbe volentieri la terra a unarovina e in un solo sbadiglio ingoierebbe il mondo. E’ la Noia!... ...”.
Nel romanzo di Alberto Moravia (11) il benessere economico della famiglia delprotagonista doveva considerarsi alla base della noia che lo aveva afflitto sin dal-l’infanzia, tanto che neppure lo studio di qualsiasi materia scolastica riusciva a li-berarne la mente. Egli afferma: “Più ci pensavo e più mi pareva difficile precisarea me stesso il senso di determinazione e di predestinazione che mi ispirava la ric-chezza. S’intende che questo sentimento non ci sarebbe stato, se fossi riuscito aliberarmi della mia originaria ossessione che la noia dipendeva dalla ricchezza, ela sterilità dell’arte dalla noia. Ma tutte le nostre riflessioni, anche le più razionali,sono originate da un dato oscuro del sentimento. E dei sentimenti non è così fa-cile liberarsi come delle idee: queste vanno e vengono, ma i sentimenti riman-gono...... Ora, in fondo, io avevo cominciato a dipingere per sfuggire alla noia. Secontinuavo ad annoiarmi, perché allora dipingere? Andai via, se ben ricordo, dallavilla di mia madre nel marzo del 1947; poco più di dieci anni dopo presi a coltel-late il mio ultimo quadro, e decisi di non dipingere più. Subito, la noia, che l’eser-cizio della pittura aveva fino allora in certo modo tenuto a bada, mi riassalì conviolenza inaudita. Ho già notato come la noia fosse in fondo mancanza di rap-porti con le cose; in quei giorni, oltre che con le cose, mi parve che fosse anchemancanza di rapporti con me stesso. So che sono cose difficili da spiegarsi; mi li-miterò ad alludervi con una metafora: durante le giornate che seguirono la miadecisione di abbandonare la pittura, io fui per me stesso qualcosa di molto similead un individuo per varie ragioni insopportabile, che un viaggiatore trovi nel suoscompartimento all’inizio di un lungo viaggio. Lo scompartimento è di quelli al-l’antica, senza comunicazioni con gli altri scompartimenti; il treno non si fermeràche alla fine del viaggio; il viaggiatore è dunque costretto a stare con l’odiosocompagno fino alla fine del percorso. In realtà e fuori di metafora, la noia, durantequegli anni, pur sotto la superficie del mio mestiere di pittore, aveva corroso a
25
Fisiopatologia dello stress
fondo la mia vita, non lasciandovi niente in piedi; così che, una volta abbando-nata la pittura, io sentii che, senza accorgemene, mi ero trasformato in una spe-cie di rottame o moncone informe. Ora, come ho detto, l’aspetto principale dellanoia era l’impossibilità pratica di stare con me stesso, la sola persona al mondo,d’altra parte, della quale non potevo disfarmi in alcun modo... Ciò che mi colpiva,soprattutto, era che non volevo fare assolutamente niente, pur desiderando ar-dentemente fare qualche cosa. Qualsiasi cosa volessi fare mi si presentava ac-coppiata come un fratello siamese al suo fratello, al suo contrario che, parimenti,non voleva fare. Dunque, io sentivo che non volevo vedere gente ma neppure ri-manere solo; che non volevo restare in casa ma neppure uscire; che non volevoviaggiare ma neppure continuare a vivere a Roma; che non volevo dipingere maneppure non dipingere; che non volevo stare sveglio ma neppure dormire; chenon volevo fare l’amore ma neppure non farlo; e così via. Dico sentivo, ma do-vrei dire piuttosto che provavo ripugnanza, ribrezzo, orrore. Ogni tanto, tra que-ste frenesie della noia, mi domandavo se per caso non desiderassi morire; era unadomanda ragionevole, visto che vivere mi dispiaceva tanto. Ma allora, con stupore,mi accorgevo che sebbene non mi piacesse vivere, non volevo neppure morire.Così, le alternative accoppiate che, come in un funesto balletto, mi sfilavano nellamente, non si fermavano neppure di fronte alla scelta estrema fra la vita e lamorte. In realtà, come pensavo qualche volta, io non volevo tanto morire quantonon continuare a vivere in questo modo”. Ed, ancora, il protagonista de “LaNoia” di Moravia: “Ma non è facile, quando ci si annoia, pensare con continuitàqualche cosa. La noia, per me, era simile ad una specie di nebbia nella quale il miopensiero si smarriva continuamente, intravedendo soltanto a intervalli qualcheparticolare della realtà; proprio come chi si trovi in un denso nebbione e intravedaora un angolo di casa, ora la figura di un passante, ora qualche altro oggetto, masolo per un istante e l’istante dopo sono già scomparsi...” La noia del 1937 di Vi-taliano Brancati (12) fondava le sue basi sulla società di quel tempo, “noiosa epetulante” alla quale il protagonista del racconto desiderava ardentemente sot-trarsi senza riuscirvi, tanto che alla fine, inquisito per aver definito noioso quel pe-riodo storico, con chiara allusione al regime fascista, non trovò altra soluzione chequella di suicidarsi con un colpo di pistola alla gola.
Per quanto attiene alla fatica mentale, Russell (9) affermava: “Troppa poca at-tenzione è stata data a ciò che si può chiamare l’igiene dei nervi. La psicologia in-dustriale, è vero, ha svolto elaborate investigazioni sulla fatica e, con accuratestatistiche, ha provato che se si continua a fare una cosa per un periodo di tempoabbastanza lungo, alla fine ci si stanca, risultato che avrebbe potuto essere intuitosenza tanto apparato scientifico. Lo studio che gli psicologi fanno sulla fatica ri-guarda principalmente la fatica muscolare, sebbene esista anche un dato numero
Marcello Aragona, Francesco Aragona
26
di studi sulla fatica dei bambini che frequentano la scuola. Ma nessuno di questitocca il problema centrale. La specie di fatica che è importante è sempre di ca-rattere emotivo, nella vita moderna; la fatica puramente intellettuale, come la fa-tica puramente muscolare, trovano il loro rimedio nel sonno. Qualunque personacostretta a svolgere un intenso lavoro intellettuale privo di possibilità emotive,diciamo, per esempio, dei calcoli complessi, alla fine di ogni giornata annullerà nelsonno la fatica arrecatagli da quel lavoro. Difficilmente le nocive conseguenze at-tribuite ad un eccesso di lavoro non sono dovute a questa causa, bensì a preoc-cupazione o ad ansietà. Il guaio della fatica emotiva è che impedisce il riposo. Piùstanco un uomo è, e più impossibile diventa per lui fermarsi. Uno dei sintomi diun prossimo collasso nervoso è la convinzione che il proprio lavoro sia tremen-damente importante, e che concedersi un po’ di vacanza sarebbe causa di chissàquali disastri...”. “Non di rado, per sfuggire alle inquietudini di carattere emotivomolti soggetti s’immergono in lavoro quasi ossessivo, persuasi che il medesimoli allontani dai pensieri che li turbano: quali, ad esempio, il fallimento finanziario.In tali casi, si può dire che la causa del collasso nervoso è l’inquietudine emotiva,piuttosto che il lavoro”.
A proposito del lavoro moderno, manuale e ripetitivo, in stabilimenti indu-striali è sicuramente la sua monotonia a produrre noia conducente a disatten-zione e non di rado al verificarsi di infortuni sul lavoro: perché qui viene amancare l’autonomia, l’inventiva e l’interesse emotivo che caratterizzavano il la-voro degli artigiani d’un tempo!
Emozione di carattere negativo, ma non sempre, è l’invidia. Non di segno ne-gativo quando essa sollecita l’individuo a migliorarsi con l’emulazione. Non al-trettanto può dirsi per la gelosia. Infatti, il geloso soffre di un senso eccessivo diproprietà, sospetta continuamente che altri voglia impadronirsi della sua donna,l’ossessione di questo sospetto gli ispira immaginazioni stravaganti e può anchespingerlo fino al delitto (Moravia, 11). Il che vale anche per il sesso femminilequale soggetto attivo di delitto. Un caso esemplare di omicidio-suicidio da gelo-sia da noi osservato sarà commentato in seguito, con soggetto attivo identificatonella donna e soggetto passivo identificato nell’uomo, del tutto inconsapevoledel proposito omicida della donna. Nell’ambito delle emozioni notevole rilievospettano alla paura ed alle voci ad essa affini, le quali, secondo Canestrelli (13)sono: allarme, angoscia, ansia, apprensione, fobia, incubo, inquietudine, orrore,panico, sbigottimento, sgomento, spavento, terrore.
La paura, condizione emozionale non sempre controllabile nei suoi effetti no-civi sullo stato mentale e fisico, fu magistralmente descritta dal Montaigne (14) neisuoi “Essais”, nell’ultimo decennio del 1500. Egli a questo proposito, fra l’altro,scriveva: “Non sono un buon naturalista (come si dice) e non so per quali impulsi
27
Fisiopatologia dello stress
la paura agisca in noi; fatto sta, però, che è proprio una strana passione; e diconoi medici che non ve n’è un’altra che trasporti più rapidamente il nostro intellettofuori dal suo assetto naturale. In verità, ho visto molte persone divenute folli perla paura; ed anche alle persone più equilibrate è certo che, finché dura il suo ac-cesso, essa procura terribili offuscamenti. Lascio da parte il volgo al quale essa favedere ora i bisavoli usciti dalla tomba, avviluppati nel loro sudario, ora lupi man-nari, folletti e chimere. Ma perfino nei soldati, dove essa non dovrebbe trovarposto, quante volte ha fatto scambiare una mandria di pecore in uno squadronedi corazzieri? Giunchi e canne in uomini d’arme e lancieri? Gli amici in nemici?E la croce bianca in croce rossa?” ...“Talvolta essa ci mette le ali ai piedi... ....tal-volta ci blocca le gambe e le braccia”... ”Coloro che si sentono incalzati dal timoredi perdere i propri beni, di essere esiliati, di essere assoggettati, vivono in conti-nua angoscia e perdono la voglia di bere, di mangiare e di riposare”... “E tutti co-loro che, per non saper sopportare l’assillo della paura, si sono impiccati, annegatio precipitati, ci hanno ben insegnato che essa è ancora più fastidiosa e insop-portabile della morte”. Il Montaigne, insigne storico e latinista qual era, ricordavaancora che Ennio Quinto, poeta del periodo arcaico della letteratura latina, cen-turione dell’esercito romano (citato da Cicerone nelle Tuscolanae Disputationes),affermava: “Allora la paura mi strappa dall’animo il senno”.
Detti effetti distruttivi della paura sullo stato mentale ebbero successivamentenumerose conferme, specie in occasione di eventi catastrofici naturali (incendi,naufragi, terremoti, cicloni, ecc.) o di gravi situazioni conflittuali causate dal-l’uomo (guerre, rivoluzioni, competizioni in ambito criminale; ecc.) laddove oltreil 70% delle persone rientranti nella norma mostra vari gradi di disorganizzazionedel comportamento. Tyhurst (15) aveva osservato che fra gli individui sorpresi daun incendio in una nave o in una colonia estiva solo il 15% mostrava comporta-mento organizzato ed efficace, il 70% mostrava vari gradi di disorganizzazione,e il rimanente 15% aveva comportamento del tutto inefficace, caratterizzato daconfusione, incapacità di movimento o movimenti del tutto disordinati. Analo-ghe osservazioni fece Marshall (16) fra soldati di fanteria durante il combatti-mento.
Secondo quanto scrive Canestrelli (13), la paura è un’emozione soggettiva-mente vissuta dall’Io come spiacevole, penosa ed anche atroce, la quale coinvolgel’intera persona umana in tutte le sue dimensioni (esperenziali, biologico-organi-che, espressive, comportamentali in un’unitaria e attuale globalità); insorge comereazione motivata, spesso d’emergenza, di fronte ad un evento reale esterno, spa-zialmente e temporalmente prossimo e circoscritto, che, inaspettatamente o pre-vedibilmente, o vivacemente percepito o prefigurato come immediato e/oincombente pericolo o minaccia di danno o di sofferenza, più o meno grave, per
Marcello Aragona, Francesco Aragona
28
la persona stessa e/o per tutto ciò che rispettivamente la integra (persone o cosecare; esistenza, ecc.). Si scatena, perciò, nel soggetto la reazione soggettiva di“paura vissuta” (esperienza della paura) con comportamenti reattivi finalizzati,quali incoercibile reazione di attacco, di fuga, di difesa, di richiesta di aiuto, se-condo i casi; ovvero comportamenti reattivi non finalizzati, da quelli autoinibitori(irrigidimento, tremore, abbattimento, stramazzamento al suolo, deliquio, ecc.) aquelli autodistruttivi, come, ad esempio, gli pseudosuicidi di chi, per sfuggire alfuoco di un incendio, corre verso una finestra e si getta nel vuoto: queste disa-strose conseguenze, già sopra ricordate, hanno avuto conferma nei fatti avvenutil’11 settembre 2001 in occasione della tragedia delle torri gemelle di New Yorkcon le numerose persone che si sono precipitate nel vuoto anche dai piani altidelle torri; e successivamente (20.2.2002) dalle persone terrorizzate da un incen-dio sviluppatosi in sette delle undici carrozze di un treno in corsa (fra il Cairo eLuxor), le quali si sono gettate dai finestrini a fianco della strada ferrata con con-seguenze mortali o gravemente traumatiche ossee e viscerali.
Da tenere in debito conto anche i comportamenti espressivi (verbali, mimici,pantomimici) e le modificazioni più o meno intense nel funzionamento di variecostanti biologiche, le quali sono sotto il controllo del sistema nervoso centrale,del sistema nervoso autonomo, del sistema neuro-endocrino e metabolico; ecc.,di cui dettagliatamente si dirà in seguito.
Canestrelli (13) ricorda che laddove vi è violenza ricorre più frequentementeil terrore e ciò soprattutto ove la violenza è più o meno organizzata, in cui l’azioneintimidatrice su altri e l’incutere terrore e paura non sono il fine, ma, certo, un in-grediente essenziale, sebbene non l’unico. Vi rientrano: “le persecuzioni moti-vate da pregiudizi o intolleranze sociali di vario tipo (razziale, etnico, religioso opseudoreligioso, ecc.); 2) certi fenomeni di delinquenza organizzata di alcune sot-toculture regionali della violenza (quali, nel nostro paese, la camorra, la mafia, landrangheta), che mentre favoriscono e sollecitano una diffusa paura di parlare e,addirittura, di sentire e di vedere, di essere chiamati a testimoniare, costituisconouna sorta di trama tattica, da cui emerge, in una apparente meccanicità ripetitiva,una tradizione di minacce, sequestri, estorsioni, vendette, brutalità, omicidi tra igruppi rivali e/o di generazione in generazione (ad esempio le faide interfamiliari);3) il terrorismo politico o più semplicemente terrorismo, in cui, come è ovvio, vadistinto un terrorismo di Stato (cioè a difesa di una certa struttura dello Statocontro gli oppositori: ad es. tirannie e dittature dispotiche, di cui è piena la sto-ria) dal terrorismo politico “dal basso”, terrorismo eversivo, cioè contro i poteridello Stato... ...Non va omessa menzione della paura e terrore in rapporto con laviolenza della guerra, che coinvolge, a un tempo, eserciti e popolazioni inermi”.
Come già accennato, la capacità di ragionare non è mai scindibile dalla condi-
29
Fisiopatologia dello stress
zione emozionale di fondo, come autorevolmente sostenuto da Damasio (3), il cuiparere è stato efficacemente sintetizzato da Goleman (6) come segue: “Sebbenei sentimenti forti possano disturbare il ragionamento creandovi il caos, la man-canza di consapevolezza sui sentimenti può anch’essa rivelarsi disastrosa, so-prattuto quando si devono soppesare decisioni dalle quali dipende in larga misurail nostro destino: quale carriera intraprendere, se conservare un posto di lavorosicuro o passare a un altro, più a rischio ma anche più interessante, con chi avereuna relazione, chi eventualmente sposare, dove vivere, quale appartamento affit-tare o quale casa acquistare - e così via, per tutta la vita. Queste decisioni nonpossono essere prese servendosi della sola razionalità, nuda e cruda; esse richie-dono anche il contributo che ci viene dai sentimenti viscerali e quella saggezzaemozionale che scaturisce dalle esperienze del passato. La logica formale da solanon potrà mai servire come base per decidere chi sposare o in quale persona ri-porre la fiducia, e nemmeno quale lavoro scegliere; questi sono tutti campi neiquali la ragione, se non è coadiuvata dal sentimento, è cieca.”
I fatti emozionali in precedenza accennati generano nell’organismo complessifenomeni biologici, su cui ci si soffermerà in seguito e che sono conformi a quelleconseguenti allo “stress”, termine utilizzato dal Selye (17) per indicare situazioniemozionali stabili, e non già transitorie, di carattere essenzialmente negativo, ca-paci di turbare profondamente l’omeostasi biologica sia nell’uomo che nell’ani-male da esperimento (turbamento peraltro qualitativamente analogo, mapuramente fisiologico, a quello tipico delle emozioni) e che, se non rimosse, evol-vono in quadri patologici coinvolgenti il sistema nervoso centrale, il sistema en-docrino, l’apparato cardio-circolatorio, l’apparato digerente, il sistemaimmunitario, ecc.
Secondo Cameron e Magaret (18), lo stress costituisce “quella situazione in cuiil comportamento in atto di un individuo viene modificato nel suo schema abi-tuale da una pressione costante sia da parte di altri che da parte di reazioni per-sonali”. Vi rientrano, perciò, anche le “frustrazioni”, le quali, secondo i suddettiAutori (18) comprendono ogni situazione in cui il comportamento intenzionalee motivato di un individuo viene impedito temporaneamente o definitivamentedal raggiungere la conclusione desiderata. Si distinguono le seguenti varietà difrustrazione: a) frustrazione da semplice dilazione, che risulta dal ritardo più o meno lungo
nell’ottenimento di un determinato obiettivo;b) frustrazione da impedimento, che si realizza attraverso ostacoli fisici, reazioni
altrui o reazioni proprie, idonei ad impedire la soddisfazione di un bisogno; c) frustrazione da conflitto, realizzata allorquando ci si trova di fronte alla neces-
sità di fare una scelta fra situazioni fra loro soggettivamente egualmente van-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
30
taggiose, col sacrificio di una. Holmes e Rahe (19) hanno proposto nel 1967 una scala a punteggi che elenca
43 condizioni stressanti, che riportiamo qui di seguito:
31
Fisiopatologia dello stress
Morte del congiunto
Divorzio
Separazione dal coniuge
Carcerazione
Morte di un familiare vicino
Malattia o incidente grave
Matrimonio
Licenziamento
Ripresa della vita in comune
Pensionamento
Grave cambiamento della salute
Gravidanza
Difficoltà sessuali
Riadattamento professionale consistente (fusioni, reinserimenti, fallimenti)
Arrivo in famiglia di un nuovo membro
Cambiamento nelle finanze (in peggio o in meglio)
Decesso di un amico intimo
Cambiamento del genere di lavoro
Cambiamento notevole nel numero di discussioni col partner (sull’educazione dei figli,sulle abitudini, ecc.)
Accensione di un mutuo ipotecario (o acquisto di un’abitazione, avvio di un affare, ecc)
100
73
65
63
63
53
50
47
45
45
44
40
39
39
39
38
37
36
35
31
Pignoramento di un bene ipotecato o sottoposto a mutuo
Allontanamento da casa di un figlio
Difficoltà con la famiglia del coniuge
Cambiamento di responsabilità nel lavoro
Eccezionale riuscita personale
Moglie che inizia o lascia un lavoro fuori casa
Inizio o fine di un ciclo scolastico
30
29
29
29
28
28
26
Come osservano Kagan e Levi (20), la società del nostro tempo è fonte dicontinui stimoli stressanti, i quali, particolarmente nel periodo infantile, si pos-sono compendiare come segue: 1) privazione o eccesso di cura dei genitori: padre, madre, entrambi, sostituti; an-
tagonismo col figlio, antagonismo reciproco fra i genitori, separati o divor-ziati, favoritismo in relazione ai giochi, alle opinioni, all’alimentazione;
2) privazione o eccesso sociale ed economico: membro del gruppo a scuola o allavoro e durante il riposo (amici, gruppi, clubs); contatto interpersonale (adot-tato, ricoverato in istituto, bambino solo, fratelli e sorelle); comunicazione nel-l’ambito familiare, con estranei; situazione di privilegio, condizione sociale,ricchezza-povertà; senso di vantaggio, senso di sicurezza; situazioni ambigue;desiderio d’agire senza poterlo fare;
3) libertà d’azione, privazione o eccesso: possibilità o restrizione dell’azione; 4) la stessa cattiva salute. Kagan e Levi sottolineano che quanto più elevate sono
le dimensioni, la durata, l’imprevedibilità e la subitaneità degli stimoli suddetti,tanto più elevate sono le reazioni emozionali e biologiche.
Le reazioni di insicurezza, di risentimento e di ostilità verso i genitori o verso
Marcello Aragona, Francesco Aragona
32
Grande cambiamento di ambiente
Cambiamento delle abitudini personali
Difficoltà con il proprio datore di lavoro
Cambiamento di orari o condizioni di lavoro
Cambio di domicilio
Cambio di edificio scolastico
Cambio di lavoro o della durata del tempo libero
Cambiamento nelle attività parrocchiali
Cambiamento nelle attività sociali
Comprare qualcosa a credito (televisore, automobile)
Cambiamento della durata del sonno
Cambiamento del numero di partecipanti alle riunioni di famiglia
Cambiamento notevole delle abitudini alimentari
Vacanze
Natale
Piccole violazioni della legge
25
24
23
20
20
20
19
19
18
17
16
15
15
13
12
12
tutta la società possono sfociare in turbe comportamentali e condurre all’antiso-cialità.
Inoltre, Carlestam e Levi (21) rilevano che l’industrializzazione, l’urbanizza-zione, la vita cittadina con tutti i suoi inconvenienti (sopraffollamento, mesco-lanza di popolazioni di diversa origine, disoccupazione o sottoccupazione,inquinamento atmosferico, rumori, sovrastimolazione sensoriale attraverso i massmedia, ecc.) hanno radicalmente mutato le condizioni di vita dell’uomo e sono dariguardare come possibili fattori di stress.
Al che va confermato che nell’ambito delle forti emozioni generatrici di stresssono anche da annoverare le sofferenze psicologiche connesse al dolore fisicoderivante da traumi o a processi patologici da causa naturale specie se a prognosiinfausta come le neoplasie, al freddo, al caldo, ai rumori come già accennato, alleustioni, alle emorragie, alle anossie, a gravi alterazioni del ricambio, come l’ipo-glicemia, alle sostanze tossiche esogene ed endogene, al lavoro muscolare pro-tratto, alla privazione di sonno, all’obbligata immobilità come accade durante leospedalizzazioni, ai periodi d’attesa per accertamenti sanitari o per ricoveri ospe-dalieri o per interventi chirurgici, alla monotonia del lavoro, all’isolamento so-ciale, alla detenzione specie se immeritata e soprattutto quando viene effettuatain isolamento, alla reclusione in campi di concentramento, alla tossicodipendenza,all’alcolismo. Attualmente si registra anche lo stress “da fila” (che è più propria-mente uno stress da frustrazione) nelle autostrade in particolare nei giorni festivi,negli uffici postali ed in altri uffici pubblici. Nel quotidiano “La Repubblica” del10.1.2002 è stato riportato il caso di una anziana signora romana che, dopo un’orad’attesa davanti ad un istituto di credito, ha dovuto rinunziare per la troppa stan-chezza ed ha richiesto per via legale un risarcimento per un importo di due mi-lioni di lire, pari ad oltre mille euro, per il “danno biologico e lo stress da fila”.Inoltre, come già ricordato, sono situazioni stressanti la latitanza, di soggetti ap-partenenti a bande criminali, le estorsioni, le rapine ed i furti, le documentate pre-visioni di imminenti cicloni nei paesi che ne sono soggetti, il terrorismo nelle suevarie forme, l’espatrio obbligato, specie per le popolazioni africane che affrontanoviaggi per mare in natanti sopraffollati, non di rado conclusi in disastri. Va ancoraosservato, a proposito del divorzio, correttamente considerato fra gli stress piùgravi nella scala di Holmes e Rahe sopra riportata, che nelle cronache italiane ri-sulta che l’azione stressante non è limitata al danno psicologico connesso alla se-parazione ma anche al rilevante danno economico, in particolare per l’italianomedio che non riesce a far fronte alle spese del costo della vita, perché “uscire dacasa e andare a vivere da soli o pagare una casa per l’ex moglie e i figli può di-ventare un vero capestro: tanti mariti sono costretti a lasciare l’allogio, pagandol’affitto del nuovo appartamento ed il mutuo di quello vecchio, le bollette rad-
33
Fisiopatologia dello stress
doppiate, spesso l'acquisto di una nuova automobile. Per cui numerosi individuidecidono di vivere separati in casa”; sì chè, secondo gli psicologi, il risultato deldivorzio è un vero e proprio massacro emotivo.
Si deve ancora considerare la cosiddetta deprivazione affettiva, il cui miglioreesempio consiste nel nanismo da deprivazione, il quale, secondo Gardner (22), puòdefinirsi un esperimento di natura e su cui si ritornerà nella Parte Seconda.
Fra i fattori di stress, nella società moderna, non bisogna trascurare il mobbing,il bullismo, il nonnismo, i quali possono definirsi come segue: il primo (mobbing),persecuzione ed emarginazione, sistematiche e durature nel tempo, in ambienti dilavoro o in comunità, di singoli individui da parte dei gruppi nei quali sono inse-riti, essendo le vittime per lo più in ambito femminile; il secondo (bullismo), at-teggiamenti, comportamenti da bulli (giovani arroganti, spavaldi, gradassi); il terzo(nonnismo), comportamento autoritario e prepotente che i soldati anziani assu-mono nei confronti delle reclute, sottoponendole a pesanti scherzi pretendendoparticolari favori. Per quanto riguarda il mobbing, attualmente vi sono compresianche i dissidi in ambito coniugale: nei confronti della moglie soprattutto conapprezzamenti negativi circa le sue capacità organizzative domestiche, specie sein presenza di estranei; nei confronti del marito soprattutto circa le sue capacitàprofessionali e lucrative. Analoghe considerazioni valgono per lo standing (per-secuzione con molestie, minacce, pedinamenti, telefonate) specie a danno delledonne, ma eccezionalmente anche a danno di uomini. Situazioni stressanti sonoanche il pilotaggio di aerei, i voli interplanetari, gli incarichi di notevole respon-sabilità quali sono quelli connessi ai programmi di voli spaziali, come osservatonel Centro Spaziale Kennedy (23).
In un’indagine ISTAT, effettuata nel 2002 relativamente alle molestie e vio-lenze sessuali subite dalle donne nel corso della vita e nei tre anni precedenti al-l’indagine su un campione di 60.000 famiglie, comprendente 22.759 donne di etàcompresa fra i 18 e i 59 anni, è emerso che nel 24.2% delle donne vittime di abusisessuali nel corso della vita e nel 29,4% di quelli negli ultimi tre anni la violenzaera stata effettuata dalla stessa persona. Le molestie fisiche furono effettuate piùdi frequente nei mezzi di trasporto pubblici (31,6%), per strada (19%), sul postodi lavoro (12,1%), in discoteche, pub, bar, ristoranti (10,5%); più raramente incasa propria o di amici. Nel posto di lavoro le donne sono state sottoposte a ri-catti sessuali per essere assunte, per mantenere il posto di lavoro o per avanza-menti di carriera. I responsabili sono spesso anche familiari, o amici di famiglia,nonché, come accennato, datori e colleghi di lavoro, o fidanzati o ex fidanzati. Leetà più colpite sono fra i 25 e i 44 anni. Il 90% delle donne non denuncia la vio-lenza, per lo più per evitare lo scandalo in Tribunale o per paura che il violenta-tore, se familiare, finisca in carcere, ed anche per la propria incolumità. Raramente
Marcello Aragona, Francesco Aragona
34
si ricorre alle forze dell’ordine, ai servizi sociali, a psicologi o a medici. Il mobbinginfatti causa astenia, depressione, panico, disturbi del sonno, uso improprio difarmaci. Non mancano cefalea, vertigini, eruzioni cutanee, tachicardia, senso diambascia precordiale, ipertensione arteriosa, disturbi dell’apparato gastro-enterico(ulcera gastro-duodenale, colite spastica), sindromi psichiche di tipo depressivo.
Relativamente al bullismo bisogna ricordare che si tratta di fenomeno non raroin ambito scolastico, ove gli autori sono gli studenti, sia maschi che femmine, cheagiscono isolatamente od in gruppi: maschili, femminili, o misti. Le prepotenzepossono essere fisiche, psicologiche più frequentemente verbali, con isolamentodelle vittime alle quali nessuno rivolge la parola; si verificano furti, minacce, mal-dicenze, prese in giro: i relativi turbamenti psicologici possono condurre nell’etàinfantile addirittura al suicidio (vedi cap. 9.1 della parte seconda). Talora le vittimesono anche gli insegnanti quando per mancanza in questi di autorità, ma soprat-tutto di autorevolezza, i medesimi docenti non riescono a controllare l’aggressivitàdei discepoli.
Per quanto gli studi sullo stress rivelino una sua maggiore incidenza nelle po-polazioni economicamente più evolute, non bisogna dimenticare le tragedie,anche di stress cronico, delle popolazioni povere soprattutto dell’Africa centrale,ed il notevole numero di profughi, che quasi quotidianamente tenta di raggiun-gere condizioni di benessere specie in Europa: sono noti i rischi ed i disagi di co-loro che tentano di attraversare il canale di Sicilia su barconi affollatissimi edinsicuri, particolarmente quando le condizioni del mare non sono favorevoli.
Selye (17) postulò negli animali da esperimento tre fasi di reazione allo stress,che egli definì “sindrone generale di adattamento”. Le fasi sono le seguenti: allarme,resistenza, esaurimento.
Nella fase di allarme, secondo anche i precedenti studi di Cannon (24, 25), siverifica l’attivazione del sistema nervoso simpatico e della midollare surrenalecon una scarica di catecolamine, a livello delle terminazioni simpatiche periferi-che e nel circolo ematico. Come si vedrà, i nostri studi istologici sull’uomo con-fermano questo assunto. Da rilevare che nella fase di resistenza, a seconda dellacostituzione del soggetto, possono aversi effetti nocivi sul comportamento orien-tati verso aggressività, ansia, depressione, isolamento, ecc. Il comportamento ag-gressivo può assumere forme diverse: contro l’agente responsabile dello stesso;altre volte è diretto contro se stessi o contro spettatori innocenti; alcune formedi aggressività sono energiche e palesi, altre volte deboli o subdole e indirette.Ciò in rapporto alla qualità dello stress, specie se frustrante, alla sua intensità, allamodalità come esso viene recepito e fronteggiato dal sistema nervoso centrale.
Come rilevato da Dalla Volta (26) a proposito delle frustrazioni, queste,quando non sono accompagnate da tensione eccessiva, possono essere seguite da
35
Fisiopatologia dello stress
effetti aggiustivi, caratterizzati da sostituzione delle mete originarie con altre piùconformi alle capacità individuali. Gli effetti costruttivi da situazioni frustrantisono chiaramente dimostrati dalla storia del pensiero. Innumerevoli sono, infatti,nella storia casi di filosofi, poeti, scienziati, artisti, che subirono nella loro vitafrequenti e pesanti frustrazioni, e ciò nonostante offrirono all’umanità opere in-tramontabili. Per cui sembra sostenibile l’ipotesi che l’azione frustrante negli in-dividui suddetti non solo non causò alcun effetto disorganizzante, ma, al contrariosi concretò in effetti benefici, avendo fatto affiorare quelle qualità di pensiero edi capacità artistiche, geneticamente presenti ma fenotipicamente ancora ine-spresse o quasi, le quali successivamente li resero famosi. In sostanza, in questisoggetti si evidenziò l’accettazione del proprio essere, che coincise con l’essere sestessi. Solo accettando la realtà, così com’essa è, diviene possibile, secondo OscarWilde essere ciò che si è. In tal modo emerge la capacità di accettare gioia e do-lore, male e bene, senza distinzioni o condanne.
A questo fine, secondo Binswanger (27) occorre un perspicuo approfondi-mento della vita interiore che conduca “al nucleo proprio e più individuale del-l’individuo, alla sua autentica essenza”, in maniera tale da riconoscere esattamentela sofferenza ed evidenziare le conseguenze di una sua erronea interpretazione.Binswanger, per chiarire il proprio pensiero, riporta il comportamento di S.Ago-stino, quando nel pieno della sua attività di brillante oratore fu colpito da unagrave “malattia di petto”. In riferimento a questo elemento nuovo della sua “sto-ria esteriore”, che gli procurava non solo profonde sofferenze fisiche, ma tur-bava in modo irreversibile l’esercizio della sua professione, S.Agostino non solonon cercò di eluderne il contenuto motivazionale, non impedì che questo pene-trasse in lui, ma, dopo averne intravisto il significato inibente nei riguardi della suaattività, che gli arrecava fama ed onori, impose alla sua vita un altro corso, dedi-candosi pienamente allo spirito. La scoperta della malattia fu dunque per S.Ago-stino motivazione decisiva per orientarlo verso la vita spirituale, che rappresentavaper lui “l’unica possibilità di attingere ancora una felicità”. Egli, così, attraversola conoscenza della natura e delle conseguenze della sua malattia, scopre la nul-lità dello splendore e della fama del mondo intravedendo nello spirito i veri va-lori della vita. “Pensiamo come un altro individuo - scrive Binswanger - nonsarebbe affatto riuscito a riconoscere correttamente la sofferenza e ad interpre-tarne le conseguenze e si sarebbe abbandonato a una psicosi isterica, alla nega-zione e alla rimozione della situazione reale; un altro si sarebbe estenuato in unalotta infeconda, in inutili sforzi contro il destino; un altro ancora dalla scopertadella sofferenza si sarebbe lasciato indurre al disprezzo del mondo, all’odio perDio e all’irrisione degli uomini, un quarto al suicidio, un quinto oggigiorno sa-rebbe motivato alla caccia di indennizzi o a una serie di procedimenti giudiziari;
Marcello Aragona, Francesco Aragona
36
vedremo allora come storia della vita interiore ed essenza spirituale siano concetticorrelativi. Questi concetti possono essere applicati a qualsiasi uomo, anche se èpiù facile applicarli a pochi eletti che non alle persone medie. Per queste ultime èpossibile cogliere solo decifrando, con la lente d’ingrandimento dello spirito, unoscritto indistinto, lacero, sbiadito, ciò che per gli eletti dello spirito si può leggerein un testo che scorre pressochè ininterrotto, a lettere cubitali”.
Fra i pochi eletti vi sono tuttavia altri personaggi. Ferrucci (28) scrive a pagina53 del suo ottimo elaborato: “L’importante è proprio l’accettazione. Se al doloresi resiste, lo si rafforza, ma accettandolo, lo si trascende”. L’accettazione del do-lore la troviamo anche in Beethoven. All’inizio è un’accettazione amara e ambi-gua. Nel 1801 scrive in una lettera: “Già ho spesso maledetto il mio Creatore e lamia esistenza. Plutarco mi ha mostrato la via della rassegnazione. Nel 1802, nel“testamento di Heiliganstad” scrive: “Pazienza... quella è la virtù che devo sce-gliere come guida”. Il dolore per la sordità, per lui che di suoni vive, è tremendo,lo costringe a isolarsi in un universo muto, a sentirsi in esilio dalla società, lospinge a desiderare la morte. Col passare degli anni viene una trasformazione piùprofonda. Nel 1818 Beethoven scrive in una lettera: “Noi, creature finite con unospirito infinito, siamo nate per soffrire e per gioire, e si potrebbe quasi dire chegli eletti ricevono la gioia attraverso il dolore”. Ferrucci (28) ricorda ancora:“Schubert seguì un cammino simile. Alcune delle sue più belle composizioni sonoallegre e spensierate, eppure egli scrisse nel suo diario, pochi anni prima di mo-rire: “Le mie emozioni sono state prodotte dalla mia comprensione della musicae dal mio dolore.” Simili esempi contemporanei sono: il tenore Andrea Bocelli,nel quale la totale cecità non impedì il manifestarsi di notevoli capacità musicali,strumentali (pianoforte, flauto) e canore; l’affermato baritono Thomas Quasthoff,portatore di gravi anomalie fisiche (è alto quanto un bambino ed è praticamenteprivo di braccia: focomelico). Le condizioni di isolamento sociale, quando non pro-vengano da una propria scelta di vita (ascetica, filosofica, del navigatore solitarioo di ricercatori in ambito scientifico), e siano di natura coercitiva, come accadenella detenzione in carcere in regime di isolamento, sono fonte di profonda fru-strazione con possibili riflessi d’ordine psicopatologico, specie in soggetti predi-sposti, talora sfocianti in vere e proprie psicosi: l’individuo, oltre a sentirsi soloqual è in effetti, ha senso di vuoto insopportabile, con profonda angoscia e tor-menti, ha la sensazione di essere abbandonato da tutti, di sentirsi fuori dal mondo.Nell’isolamento in carcere svolge un ruolo importante anche la deprivazione senso-riale, cioè la mancanza dei rumori che oggi caratterizzano la vita nei centri abitati,l’impossibilità di dialogare con altre persone, di avere contatti affettivi con altri es-seri viventi, e tra questi anche gli animali domestici, di non poter vedere nullaoltre le quattro mura ove si è rinchiusi. La capacità di sopportare il prolungato iso-
37
Fisiopatologia dello stress
lamento coatto non è uguale per tutti gli individui, né dal punto sensoriale nè daquello dello stato dell’umore. Vi sono persone le quali non sopportano l’isola-mento neppure per poche ore e sono anche capaci di suicidarsi, mentre altre nondimostrano alcuna sofferenza pur in condizioni di isolamento assai prolungate.Ma queste ultime trovano grandi risorse di equilibrio soprattutto all’interno delproprio Io, pur se si tratti di doti intellettuali e morali di non facile riscontro nel-l’epoca consumistica attuale. Ma la storia non recente è ricca di esempi del ge-nere:basti pensare ad alcuni personaggi. “La vicenda umana di TommasoCampanella (1568-1639) è fra le più aspre e drammatiche che un uomo di genioabbia vissuto, segnata di continuo da difficoltà invalicabili e patimenti crudeli, fral’avversione o l’indifferenza dei contemporanei” (Firpo, 29). Di umili origini (fi-glio di un ciabattino calabrese, analfabeta), fin dall’infanzia assetato di sapere, do-tato di una memoria prodigiosa, a 13 anni vestì il saio domenicano e nei conventitrovò l’opportunità per soddisfare il suo desiderio di approfondire le sue cono-scenze in tutti i settori delle scienze. Non sopportava le ingiustizie e per questomotivo organizzò in Calabria una congiura contro l’oppressione del governo spa-gnolo. Catturato, venne rinchiuso per 27 anni nelle carceri napoletane. Si dimo-strò capace di resistere alle più atroci torture e alla segregazione in una cella buiaed angusta con la dichiarazione che le sofferenze inferte al suo corpo, mortale,non erano idonee ad incidere sulla sua anima, immortale. Ciò non gli impedì diredigere il libro che lo rese famoso “La città del sole”, nel quale fra l’altro, soste-neva per tutti i cittadini l’obbligatorietà del lavoro e che l’unica gerarchia accet-tabile dovesse essere quella del merito che si identificava col sapere: chi più sa, cioè“chi è in grado di leggere il libro arcano della natura è giusto che comandi”. Eglifu anche strenuo sostenitore di Galileo Galilei. Morì in esilio a Parigi. Silvio Pel-lico (1789-1854), il quale, per le sue idee liberali ed indipendentiste, fu arrestatonel 1820 dagli austriaci e detenuto prima a Milano e poi nella fortezza dello Spiel-berg in Moravia. Qui si applicò nelle sue meditazioni e nella scrittura de “Le miePrigioni”, riuscendo a sopravvivere a quella dura condanna. Il libro fu pubblicatodall’editore Bocca nel 1832, ed ebbe grande successo anche all’estero.
Non bisogna qui dimenticare l’importanza dello stress persistente, sia psichicoche fisico (torture) cui furono sottoposti dalla santa inquisizione le persone so-spette di essere eretiche. Tra queste un esempio ineguagliabile è quello di Gior-dano Bruno, frate domenicano (29,30,31), il quale subì una lunga detenzione(circa 8 anni), fu sottoposto a torture, a lunghi, spesso ripetitivi, interrogatori aifini dell’accertamento delle imputazioni che gli furono contestate: in un primogruppo, gli atti di irriverenza, le bestemmie, le accuse al clero; in un secondogruppo le tesi errate su Cristo, sullo Spirito Santo, sulla Trinità (gruppi schietta-mente di natura teologica); nel terzo l’insieme delle posizioni filosofiche e astro-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
38
nomiche circa l’universo, il movimento della terra, la generazione del cosmo, innetto contrasto con la concezione tolemaica cui aderiva la Chiesa del tempo. Gior-dano Bruno, che era in possesso d’una cultura vastissima, d’una memoria prodi-giosa, per mitigare gli effetti dei suoi presunti errori ed evitare il rogo ammise diessere incorso in errate valutazioni in merito ai primi due gruppi di imputazioni,ma non abiurò mai circa i contenuti del terzo gruppo di imputazioni, per i qualisi difese con valide argomentazioni sostenendo non essere stato lui stesso in er-rore, bensì coloro, come in sostanza gli stessi giudici, i quali, non essendo a co-noscenza delle nuove concezioni copernicane sull’universo, non avrebbero potutoesprimere nel merito giudizi scientificamente validi. In questo atteggiamento di-fensivo Giordano Bruno verosimilmente si era convinto che una sua eventualeabiura anche delle imputazioni del terzo gruppo gli avrebbe evitato la condannaa morte, ma non già la morte civile come pensatore. Fu condannato e giustiziatosul rogo (1600).
Sulle suddette imputazioni del terzo gruppo fu inquisito anche Galileo Gali-lei, che fu costretto ad abiuare (1633). Ma egli, nel periodo di detenzione, con lacollaborazione di un suo allievo autorizzato a visitarlo periodicamente in prigione,continuò a divulgare le sue innovative osservazioni astronomiche redigento iltrattato sul movimento della terra. Egli, infatti, quotidianamente redigeva parte delsuo elaborato che al termine della giornata doveva obbligatoriamnete consegnareal secondino di guardia; ma segretamente riusciva a redigerne due copie, una dellequali destinata di nascosto al suddetto allievo che la portava via per la stampa.
Anche questi esempi confermano che non sempre gli stress psichici e fisicisiano idonei a determinare effetti patologici sulle qualità intellettive e comporta-mentali, ma, ripetiamo, ciò è possibile solo in casi eccezionali.
Peraltro, come già più volte ricordato, le emozioni costituiscono il fondamentodel comportamento umano e non di rado il loro ruolo prevale sulle facoltà ra-zionali. Goleman (6) a questo riguardo, a conferma di quanto già esposto, af-ferma che i sentimenti più profondi, le passioni e i desideri più intensi sono pernoi guide importantissime, alla cui influenza sulle vicende umane la nostra spe-cie deve in gran parte la propria esistenza. Egli scrive: “Si tratta di un’influenzadavvero straordinaria: solo un amore immenso – la volontà disperata di salvareun figlio molto amato - può spingere infatti un essere umano a superare il pro-prio istinto di conservazione”. Atti di questo genere possono essere in effetti di-scutibili e irrazionali, ma se li si giudicano con il cuore- asserisce Goleman - eranole sole scelte possibili. A questo riguardo è anche illuminante quanto sostenuto,nel corso dei lavori preparatori del codice penale del 1930, tuttora vigente, dal mi-nistro Rocco, insigne giurista, in merito alle passioni e alle emozioni: “Gli affetti,le emozioni, le passioni sono un modo normale di essere dell’anima umana; non
39
Fisiopatologia dello stress
vi è azione, onesta o disonesta, morale o immorale, lecita o illecita, conforme ocontraria alla legge, che non sia determinata da un motivo affettivo, da un motivoemozionale, da un motivo passionale. Se noi sopprimessimo dall’anima umanaquella che è la base sentimentale di essa, toglieremmo ogni e qualsiasi motore allavolontà e all’azione umana, perché la volontà si determina soprattutto in base alsentimento, non in base al raziocinio. L’affetto, l’emozione, la passione possonocondurre all’azione più onesta e all’azione più criminosa, anzi è precisamente allostato affettivo, emotivo e passionale, che si debbono le più nobili azioni umane,fino al sacrificio di se stessi alla Patria, il quale è determinato da quello stato di pas-sione che è la devozione alla Patria”.
“Tutta la nostra vita è intessuta di motivi sentimentali e le manifestazioni piùnobili della nostra attività sono determinate da motivi affettivi, emozionali e pas-sionali, senza che per questo venga meno il merito delle nostre azioni, che, peressi, anzi si accresce. Ed allora, perché deve venire meno il demerito delle azionidisoneste, delle azioni illecite, criminose, che sono pure determinate da emozionie da passioni?” Qui il ministro Rocco si riferiva alla necessità di introdurre nel no-stro ordinamento l’art. 90 c.p., nel quale si stabilisce che “gli stati emotivi e pas-sionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”. Tuttavia è necessario quiosservare che le emozioni e le passioni cui si riferiva il ministro Rocco riguarda-vano di fatto i loro aspetti costruttivi sulla personalità, generatrici usualmente dibenessere psichico ed intima soddisfazione e che non si accompagnano a squili-bri biologici veri e propri di carattere schiettamente patologico, che invece, sepreesistenti al fatto emozionale o passionale o da questo cagionato in quanto so-vrapposto a personalità fragili, possono incidere pesantemente sull’equilibrio psi-chico e che sono idonee a determinare disagio mentale, insoddisfazione,insicurezza, angoscia, paura, terrore, ira, ecc. D’altra parte lo stesso nostro codicepenale, in contrasto col menzionato art.90, riconosce valore attenuante quandoil fatto illecito è stato compiuto “nell’aver reagito nello stato d’ira per fatto ingiusto altrui(art.62 c.p.), nonché quando la madre uccide il proprio feto nascente o il proprioneonato immediatamente dopo il parto, essendo in condizioni di abbandono materiale emorale (art. 578 c.p.).
Nella fase di resistenza dello stress, secondo Selye, prevale l’attivazione del-l’asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene, con la terminale liberazione di cortisolo.In tale fase Selye osservò sperimentalmente una deplezione dei lipidi ormonalinello strato fascicolato della corteccia surrenale, reperto ampiamente confermatoda altri ricercatori, come egregiamente sintetizzato da Tonutti (32) e da noi os-servato nella casistica umana da noi stessi studiata (vedi capitolo IV.1 della parteprima).
Nella fase di esaurimento, che contrassegna la fine delle normali risposte fi-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
40
siologiche allo stress, si possono manifestare vari processi patologici che riguar-dano sia il comportamento sia la compromissione anatomo-clinica del sistemanervoso centrale, del sistema immunitario, dell’apparato cardio-circolatorio, deireni, del fegato, del canale digerente e dell’apparato sessuale: manifestazioni ingrande prevalenza ben dimostrabili nella casistica umana sia dal punto di vistaclinico che anatomo-patologico. Sono qui da considerare anche i rapporti frastress e tumori. Tali aspetti saranno oggetto di trattazione nel capitolo V.2 dellaparte seconda.
In sintesi, l’organismo risponde allo stress con manifestazioni di natura schiet-tamente fisiologica nelle varie fasi, concretando nell’insieme la sindrome generale diadattamento, posto che, come preconizzato dal Selye, l’organismo trova in sé mec-canismi di compenso idonei a mantenere l’omeostasi psico-biologica. Ma, a volte,per cause su cui ci si soffermerà in seguito, sfocia in quadri patologici concla-mati. Ad eccezione delle risposte comportamentali indubbiamente costruttiveche possono in casi del tutto particolari contrassegnare la fase di resistenza, cuiaccennato in precedenza e di cui, in altro senso, fu indubbiamente testimone e vit-tima anche Cartesio (33-35).
E’ noto che la Chiesa cattolica ha di recente riconosciuto che le condanne in-flitte a molti pensatori perché considerati eretici essendo state le loro opinionipalesemente divergenti dalle posizioni dogmatiche della Chiesa stessa, furono so-stanzialmente ingiuste. Le condanne spesso comminate dopo pesanti torture, ri-guardavano in particolare, vari personaggi, come già ricordato: Giordano Bruno,ucciso sul rogo (1600), Tommaso Campanella morto esule a Parigi (1639) dopoaver subito lunghissima detenzione nelle carceri napoletane (27 anni), GalileoGalilei che, in stato di detenzione, fu obbligato ad abiurare le sue scoperte scien-tifiche in ambito astronomico (1633). In questo novero rientra pure GirolamoSavonarola, condannato a morte dal potere politico, ucciso per impiccagione e poibruciato sul rogo (1598). Per suo conto Cartesio, essendosi trovato in Italia tra il1623 e il 1625, fu verosimilmente diretto testimone, nel 1624, della condanna alrogo d’un alto prelato (De Dominis), responsabile di scritti critici contro il papato.Il De Dominis morì prima che fosse pronunciata la sentenza di condanna, ma ciònon impedì che il suo cadavere venisse bruciato sul rogo con i suoi scritti in pre-senza di una folle enorme. E’ certo che Cartesio, per essere stato a conoscenzadi quelle condanne attinenti a pensatori suoi contemporanei, frustrato da tali fatti,fosse stato molto cauto nel diffondere le sue idee innovative, con le quali propu-gnava fra l’altro l’assoluto rifiuto di ogni preconcetto, anche di carattere religioso,ed avesse di proposito ritardato di pubblicare il suo “Discorso sul Metodo”, stampatosolo nel 1637 insieme con altre sue opere quand’egli era già quarantunenne: senza,tuttavia, che fosse apposto il suo nome nel frontespizio, successivamente appo-
41
Fisiopatologia dello stress
stovi nell’edizione postuma del 1650. Addirittura egli aveva ritenuto più prudenterinunciare del tutto alla divulgazione de “Il Mondo” (o Trattato sulla luce), chesarà pubblicato solo dopo la sua morte. Per quanto riguarda questo trattato egliaveva informato, in una lettera del 22.7.1633, padre Marsenne (suo compagno dicollegio presso un istituto gesuita durante l’adolescenza, cui era legato da sinceraamicizia) che la sua menzionata opera era quasi pronta per la pubblicazione, masuccessivamente in altra lettera informava l’amico della propria intenzione di darealle fiamme il manoscritto, motivata dal fatto che tutte le copie del libro di Gali-leo sul Movimento della Terra, pubblicato poco prima, erano state sequestrate ebruciate. Pertanto, è anche certo che il dualismo fra anima e corpo, pubblica-mente ritenute da Cartesio due entità distinte essendo la prima di natura spiritualeed il secondo, invece, di natura biologica, fosse connesso al suddetto timore, no-nostante il dualismo stesso fosse in palese contrasto con sue precedenti affer-mazioni. Egli, infatti, aveva sostenuto che l’anima avesse sede nella ghiandolapineale, che trovasi al centro del cervello, e fosse perciò intimamente connessa alcorpo e non già di schietta natura metafisica, ed ancora, nel suo trattato sulle pas-sioni dell’anima (Traité des passions de l’ame), pubblicato nel 1649, egli intendevaper passione la percezione causata all’anima da un movimento corporeo, conl’evidente ammissione dello stretto legame fra le due entità. Proposizioni se-mantiche pertanto nettamente in contrasto con il dichiarato dualismo cartesiano,il quale di conseguenza sembra essere stato semplice espediente per distogliere ilettori contemporanei dall’idea che il pensiero dell’autore avesse un significato diaperta critica della posizione della Chiesa cattolica sullo stesso argomento. Pur-troppo il suddetto espediente ha indotto in errore anche molti commentatori delpensiero cartesiano, i quali, pur riconoscendo la razionalità di tutta l’opera di Car-tesio, che nettamente contrasta col suddetto dualismo, continuano a ritenerlofrutto d’un errore concettuale del filosofo, al punto che un eminente neurologo,Antonio Damasio, docente presso il College of Medicine dell’Università delloJowa (USA), ha pubblicato il suo ottimo libro sulle emozioni, sulla ragione e sulcervello umano, col titolo “L’Errore di Cartesio” (3).
Per rendersi conto della realtà del pensiero estremamente razionale di Carte-sio, che esclude siffatto errore concettuale, è sufficiente leggere quanto egli scrivenel suo “Discorso sul Metodo” (Discours de la Métode, 1637), ove egli insiste sullanecessità di non trascurare mai i dati oggettivi per giungere alla soluzione di que-siti di natura scientifica; ed anche “Le Regole per la Guida dell’Intelligenza” (Regulae adDirectionem Ingenii) pubblicate dopo la morte dell’autore, per la prima volta ad Am-sterdam nel 1701.
L’espediente suddetto consentì a Cartesio di sfuggire ad eventuale processodella santa inquisizione ma non alla morte ad opera di sicari della stessa fede. In-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
42
fatti, secondo uno studio molto accurato di un ricercatore tedesco (Erike Pies),il filosofo non sarebbe morto di polmonite contratta a causa del rigore invernaledella Svezia (febbraio 1650), ove egli si trovava quale precettore della regina Cri-stina, bensì per avvelenamento da arsenico, veleno propinatogli con gli alimentiper evitare eventuali interventi di Cartesio sul proposito della regina stessa dalconvertirsi alla fede cattolica verso la quale sembrava orientata nonostante il suoPaese avesse combattuto per decenni da posizioni protestanti contro la lega cat-tolica. Per verificare la realtà della suddetta ipotesi si dovrebbe procedere alla ri-cerca dell’arsenico sul cranio di Cartesio conservato nel Musée de l’Homme diParigi, tenuto conto che l’arsenico si conserva per secoli nelle ossa delle personedefunte mediante avvelenamento con composti arsenicali.
Bibliografia1. Lattes L., Le alterazioni della personalità morale e sociale ed infortunio sul lavoro. Atti II
Congr. Med. Infort. del Lav. e Mal. Prof.- Roma, Ed. C.N.T., 1929.2. Macaggi G., Sulla sindrome anetica da infortunio sul lavoro. Riv. Dir. del Lavoro 5,
18, 1930.3. Damasio A.R., L’errore di Cartesio. Adelphi, Milano, 1995.4. Lacroix M., Il culto dell’emozione. Vita e Pensiero, Milano, 2002.5. Le Doux J., Il cervello emotivo. Baldini e Castoldi, Milano, 1998.6. Goleman D., Intelligenza emotiva. Libri&Grandi Opere. Milano, 1996.7. Darwin C., L’origine dell’uomo. UTET, Torino, 1871.8. Carotenuto A., Il gioco delle passioni. Bompiani, Milano, 2002.9. Russell B., La conquista della felicità. II ed., Longanesi, Milano, 1967.10. Baudelaire C., I fiori del male (Les fleurs du mal, 1857). La Stampa, Torino,
2003.11. Moravia A., La noia. Bompiani, Milano, XI ed., 2001.12. Brancati V., Tutti i racconti, vol. II, Mondadori, Milano, 2002.13. Canestrelli L., Paura. enc. Med. Ital. USES, Firenze, II ed. 1984, vol. XI, 1346-
1362.14.De Montaigne M., Saggi, vol. I, Adelphi, Milano, 1996.15. Tyhurst J.S. in, Bindra D., Motivation: a systematic reinterpretation. Ronald Press,
New York, 1959.16. Marshall S.L.A., in Bindra D., Motivation. a systematic reinterpretation. Ronald
Press. New York, 1959.
43
Fisiopatologia dello stress
17. Selye H., The stress of life. Lippincott, Philadelphia, 1974.18. Cameron N., Magaret A., Patologia del comportamento. Giunti-Barbèra, Firenze,
1962.19. Holmes T.H., Rahe R.H., The social readjustement rating scale. Journ. Psychosom.
Res. 11, 1967, 213.20. Kagan A., Levi L., Adaptation of the psychosocial environment to man’s abilities andneeds. in, Levi L. Society, Stress and Disease. vol. I, Oxford Un. Press, London,1971.
21. Carlestam G., Levi L., Urban conglomerates as psychosocial human stressors. Generalaspetcs, swedish trends, and psychological and medical implications. Kungl BoktryckerietP.A. Norstedt & Soner, Stoccolma, 1971.
22. Gardner L.I., Nanismo da deprivazione. in, Cesa-Bianchi M.: Psicologia del-l’Uomo. Le Scienze, Milano, 1974.
23. Eliot R.S., Buell J.C., Dembroski T.M., Biobehavioral perspectives and coronary heartdisease, hypertension and sudden cardiac death. Acta Med. Scand. 666 (Suppl.), 203,1982.
24. Cannon W.B., The emergency function of adrenal medulla in pain and the major emo-tions. Am. J. Physiol. 33, 556, 1914.
25. Cannon W.B., Bodily changes in pain, hunger, fear, and rage. Appleton-CenturyCrofts, New York, 1929.
26. Dalla Volta A., Dizionario di Psicologia. Giunti-Barbèra. Firenze, 1961.27. Binswanger L., Per un’antropologia fenomenologica. Feltrinelli, Milano, 1970. 28. Ferrucci P., Esperienze delle vette. Astrolabio, Roma, 1989.29. Firpo L., Ritratti di antenati. Ed. La Stampa, Torino, 1989.30. Firpo L., Il processo di Giordano Bruno. Ed: Salerno, Roma, 1993.31. Benazzi N., D’Amico M., Il libro nero dell’Inquisizione. Piemme, Casale Mon-
ferrato, 1998.32. Tonutti E., Normale anatomie der endokrinen drüsen und endokrine regulation. in,
Kaufmann E., Staemmler M.: Lehrbuch der speziellen pathologischen Ana-tomie. De Gruyter&Co, Berlin. B.I, H. II, 1346-1371, 1956.
33. Shea W.R., La magia dei numeri e del moto (René Descartes e la scienza del Sei-cento). Bollati-Boringhieri, Torino, 1994.
34. Geymonat L., Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. II, Garzanti, Milano,1970.
35. Descartes R., Discours de la Méthode (1637). Traduzione e note di Renzoni M.,Mondadori, Milano, 1993.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
44
Capitolo II
Le modificazioni biologiche, di significato schiettamente fisiologico, nello stress. I primi approcci teorici
1. Gli effetti biologici direttiLa teoria di Cannon-Bard (1). Come già ricordato, Cannon (2,3,4), sin dai primi
del novecento aveva dimostrato che in qualsiasi condizione di emergenza del-l’organismo si ha una scarica di adrenalina, indicando che il punto d’attacco pri-mario degli stimoli abnormi fosse il sistema simpatico-medullosurrenalico. Bard(1), confermando la suddetta ipotesi, sostenne che, quando si affronta un eventocarico emotivamente, gli impulsi passano prima attraverso il talamo, ove l’impulsonervoso si fraziona, dirigendosi sia verso la corteccia cerebrale, nella quale si iden-tifica la causa soggettiva dell’emozione, sia verso il talamo stesso e l’ipotalamo, dalquale ultimo derivano le modificazioni biologiche dell’organismo.
Il circuito di Papez. Il Papez (1) per primo avanzò l’ipotesi che gli stimoli emo-zionali non avessero una risonanza in determinate aree cerebrali, bensì in un cir-cuito interessante soprattutto il sistema limbico, che egli definì “il flusso deisentimenti”. Sostenne anche l’esistenza di un “flusso di movimenti” riferito agliimpulsi provenienti dal talamo e diretti al corpo striato, ed un “flusso di pensieri”pure provenienti dal talamo e diretti alle principali regioni della corteccia cerebrale.
Le opinioni attuali. Attualmente i numerosi studi condotti sull’argomento con-sentono di distinguere tre fondamentali vie, a carattere dicotomico, di attivazionedegli organi in risposta agli stress: due delle quali riguardano il sistema nervoso ele ghiandole a secrezione interna: 1) una con attivazione dei centri sensoriali ce-rebrali, del sistema limbico, dell’ipotalamo e della corteccia cerebrale e per via di-scendente del sistema simpatico con liberazione di neurormoni ed attivazione,per via ematica (circolo portale ipofisario), di ghiandole a secrezione interna; 2)una con attivazione, per via ascendente, delle vie spinali sensitive e successivapartecipazione del sistema limbico-ipotalamico, liberazione di neurormoni ed at-tivazione per via ematica di ghiandole a secrezione interna; 3) una terza via me-diante attivazione di funzioni paracriniche con produzione nell’encefalo, specienelle cellule gliali, di citochine ed ossido d’azoto (NO), ovvero con citochine pro-venienti da altri distretti corporei previo superamento della barriera emato-ence-falica, con pari attivazione, per contiguità, di neurormoni, e funzioni simili a quelledelle altre due vie, e precipua inibizione del sistema immunitario (5).
Le tre suddette vie di attivazione non operano alternativamente e separata-
45
mente, ma possono essere simultaneamente attive.
2. Le vie di attivazione ipotalamo-ipofisaria
2.1. La via degli stimoli sensoriali visivi, uditivi, gustativi, olfattiviLa formazione reticolare. Si deve in primo luogo ricordare che qualsiasi stimola-
zione sensoriale perde, a livello della formazione reticolare, la sua proprietà spe-cifica dell’organo di senso che l’ha trasmessa, per divenire qui stimolo aspecificoidoneo, tuttavia, ad attivare le vie di cui s’è detto, sia in senso ventrale che caudale.
Esistono, infatti, numerose connessioni fra l’ipotalamo ed il sistema vegetativo,sia di segno parasimpatico che simpatico (6, 7).
Secondo Smythies (8), le principali connessioni efferenti limbiche della for-mazione reticolare comprendono: a) tutti i nuclei ipotalamici mediante due vie, ecioè: la divisione ventrale ai corpi mammillari, ai nuclei laterali, preottico e settaleper via del peduncolo mammillare; e la divisione dorsale ai nuclei mediali me-diante il fascicolo dorsale longitudinale di Schultz; b)direttamente all’ippocampolungo diffuse connessioni decorrenti attraverso il subtalamo, ed anche attraversola via settale-fornice; c) all’amigdala attraverso la via settale e l’area interinale lungola stria terminalis; d) ai nuclei talamici intralaminari e, naturalmente, ampiamentealla corteccia cerebrale.
Qui non si può trascurare di ricordare che detti rapporti fra ipotalamo e si-stema nervoso simpatico sono noti sin dalla prima decade del novecento ad operadi Karplus e Kreidl (1909, 1910, 1912, 1914) come recentemente segnalato daBjörklund e coll. (9). Più precisamente queste correlazioni consistono in un con-trollo espletato dall’ipotalamo sul sistema simpatico attraverso una via diretta fral’ipotalamo posteriore e la colonna intermedio-laterale simpatica a livello tora-cico e lombare del midollo spinale passante attraverso il locus coeruleus e la so-stanza grigia del tronco encefalico e quindi mediante le cellule nervose dellaformazione reticolare.
In grande prevalenza i neuroni della formazione reticolare hanno un assoneche si divide in una lunga branca che decorre ventralmente in direzione del talamoed una branca caudale che si irradia lungo il midollo spinale. Ogni cellula ha ungrande numero di sinapsi, per cui qui vi è un esteso riverbero sensoriale, corticalee limbico in ogni cellula.
Le branche assoniche dei neuroni della formazione reticolare dirette in sensocaudale raggiungono le corna laterali del midollo spinale, da cui prende origine ilsistema simpatico, il quale, attraverso i gangli che fiancheggiano la colonna ver-tebrale, innerva tutti gli organi. Per cui l’attivazione della formazione reticolaremesencefalica si diffonde anche al sistema simpatico, come già detto, e quindi
Marcello Aragona, Francesco Aragona
46
pure alla midollare surrenale, la cui funzione è simile a quella dei gangli paraver-tebrali, con la differenza che le catecolamine qui secrete si riversano nella circo-lazione sanguigna, conferendo alla stessa midollare una funzione di vera e propriaghiandola a secrezione interna. Si desume che gli stimoli sensoriali, che raggiun-gono l’amigdala con estrema rapidità (vedi in seguito) raggiungano la midollaresurrenale con analoga rapidità, attivandone le specifiche funzioni: nella quale noi,dal punto di vista istologico, abbiamo riscontrato reperti di straordinario inte-resse, come sarà detto in seguito.
L’intervento della midollare surrenale è di fondamentale importanza nel man-tenimento dell’equilibrio biologico interno, cioè dell’omeostasi, in quanto, attra-verso l’iperadrenalinemia, si ha in primo luogo la mobilizzazione del glicogenoepatico, con elevazione della glicemia e rifornimento di glucosio al sistema ner-voso centrale, alla muscolatura cardiaca ed a quella scheletrica.
L’amigdala. L’amigdala, piccola sezione del proencefalo, a forma di mandorla,facente parte del sistema limbico, è oggi ritenuta avere un ruolo fondamentalenel comportamento emotivo. Essa entra in funzione mediante il ricevimento diimpulsi da una via breve, e cioè direttamente attraverso il talamo, ed una via lunga,e cioè talamo-corteccia-amigdala. La prima via implica l’insorgenza di una sen-sazione generica di allarme, cioè non idonea ad identificare la qualità e la naturadello stimolo nocivo; la seconda, invece, più tardiva consente anche il riconosci-mento della qualità dello stimolo nocivo: in entrambi i casi il risultato è general-mente un’emozione di paura o di terrore.
Le Doux (10), a proposito della via talamica breve, afferma: “Anche se il si-stema talamico non riesce a fare delle sottili distinzioni, ha un vantaggio impor-tante rispetto al percorso dei segnali corticali verso l’amigdala. E’ una semplicequestione di tempo: nel ratto occorrono circa dodici millisecondi (dodici mille-simi di secondo) perché uno stimolo acustico raggiunga l’amigdala attraverso ilpercorso talamico, mentre impiega due volte di più attraverso il percorso corti-cale. Il primo quindi è più veloce, anche se non dice che cosa stia a minacciarlo:il segnale avverte velocemente che c’è una minaccia. E’ un sistema veloce ma im-preciso”.
Circa l’estrema velocità dello stimolo, nella nostra casistica esistono dei casi checonfermano questo assunto, come sarà detto in seguito.
Qui non bisogna trascurare l’importante ruolo svolto dal locus coeruleus nelcorso degli stress, il quale notoriamente è costituito da neuroni essenzialmente no-radrenergici: ciò soprattutto per le connessioni che questa struttura nervosa ha siacon l’ippocampo che con l’amigdala.
Nell’amigdala, quindi, si trasmettono impulsi verso altri distretti amigdaloidei:
47
Fisiopatologia dello stress
gli stimoli del mondo esterno sono trasmessi al nucleo laterale della stessa, ovevengono prima elaborati e poi trasmessi alle altre regioni della stessa struttura(nuclei basale, basale accessorio e centrale). Quest’ultimo diventa poi la sede prin-cipale di connessione con le aree che controllano le risposte emotive. Nelle con-dizioni di stress, infatti, dall’amigdala partono immediati messaggi all’ipotalamoe in tal modo s’instaura tutta la sequela di modificazioni biologiche dell’asse ipo-fisi-corticosurrene. Ma dallo stesso nucleo centrale dell’amigdala si manifesta unsensibile aumento del CRH, cioè dell’ormone rilasciante la corticotropina surre-nalica mediante la liberazione dell’ormone adrenocorticotropo ipofisario (ACTH),e della beta-endorfina. Si ritiene poi che i glicocorticoidi abbiano un effetto fre-nante sulla sintesi delle catecolamine, e sul loro turnover, sia in condizioni basaliche durante lo stress. Nei ratti sani una singola somministrazione di cortisolosopprimerebbe l’attività e la reattività simpatico-surrenale. In contrasto, continuesomministrazioni di cortisolo per 7 giorni stimolerebbero l’attività e la reattivitàdel sistema simpatico-surrenale (11).
Va tenuto presente che, secondo Reischies (12), l’amigdala attraverso una viadiretta invia impulsi alla superficie ventrale del lobo frontale, la quale supportal’opinione che nella corteccia prefrontale ventrale si concreti il rapporto equili-bratore ansietà/controllo comportamentale. Su questa funzione prefrontale ven-trale ci si è già soffermati nella parte introduttiva.
Il sistema renina-angiotensina-aldosterone. Stress fisici e psicologici acuti aumen-tano l’attività della renina plasmatica. Si tratta di un effetto mediato dall’attivazionedel sistema simpatico e segnatamente dall’ischemia dei glomeruli renali determi-nata dalle catecolamine: tanto che il suddetto aumento dell’attività della reninaplasmatica in risposta a stress acuti è marcatamente ridotto dalla somministra-zione di propranololo, un antagonista beta-adrenergico. Si ritiene da parte di al-cuni (13,14,15) che lesioni del nucleo paraventricolare ipotalamico inibiscanol’aumento della renina plasmatica durante lo stress, ma il meccanismo col qualeciò si verifica non è chiaro.
Benchè la sintesi dell’aldosterone avvenga nello strato glomerulare della cor-teccia surrenale, secondo Aguilera (16), ciò deriva dalla conversione del cortico-sterone in aldosterone e si concreta in varie fasi, essendo connessa alla biosintesidei glicorticoidi nella zona fascicolata della stessa corteccia. D’altra parte egli af-ferma che, sebbene l’ACTH sia un potente fattore stimolante della secrezione dialdosterone in condizioni acute, la somministrazione protratta di ACTH nei rattie nell’uomo determina un effetto inibitore della secrezione basale e stimolata dialdosterone, connessa alla diminuzione nella surrenale dei recettori dell'angio-tensina II e dell'attività sintetasica aldosteronica. Premettiamo che il suddetto in-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
48
tervento dell’ACTH nella secrezione dell’aldosterone, secondo le nostre osser-vazioni istologiche ed istochimiche sullo strato glomerulare della corteccia sur-renale non corrisponde alla realtà dei fatti, visto che nello stress iperacuto ladeplezione lipidica dello stesso strato è pressoché immediata, precedendo perciòl’intervento dell’ACTH ipofisario ed essendo invece correlata alla primaria atti-vazione della midollare surrenale, che costantemente avviene qualche attimoprima di quella ipofisaria e dello strato fascicolato corticale.
2.2. La via del dolore fisicoIl dolore fisico, somatico e viscerale, attiva il nucleo paraventricolare ipotala-
mico (NPV) e la liberazione di CRH, attraverso segnali ascendenti decorrentilungo il midollo spinale ed il tronco encefalico, e quindi nella formazione retico-lare, per via di fibre sensoriali periferiche e craniche. Fibre sensoriali secondarieoriginano in neuroni della specifica lamina midollare o dai nuclei sensoriali spi-nali ed ascendono ai nuclei sensoriali talamici. I segnali veicolanti gli stimoli stres-santi possono raggiungere il NPV mediante assoni collaterali di queste viesensoriali trasmessi da neuroni del fascio proencefalico mediale all’ipotalamo la-terale, o attraverso i neuroni catecolaminergici ascendenti che terminano diretta-mente nelle cellule CRH del NPV. Le cellule catecolaminergiche che raggiungonoil NPV (gruppi cellulari A1, A2, A6) possono ricevere stimoli direttamente daineuroni nocicettivi spinali, o da assoni collaterali delle vie sensoriali ascendentimediante sinapsi con le suddette cellule catecolaminergiche. Fibre nervose nora-drenergiche che terminano nel NPV si dividono in tre nuclei troncoencefalici: ilgruppo cellulare A1-catecolaminergico nel bulbo caudale ventromediale, il gruppoA2-catecolaminergico nel ed attorno al complesso dorsovagale nel midollo dorso-mediale, ed in cellule del locus coeruleus. Le fibre contenenti adrenalina che in-nervano il NPV originano dal midollo ventro-laterale (C1) e dorso-mediale(C2-C3). Lesioni dei gruppi cellulari catecolaminergici del tronco encefalico odelle fibre ascendenti bloccano o riducono le modificazioni indotte dallo stressnel sistema ipotalamo-ipofisario (17).
La trasmissione sinaptica nella formazione reticolare sembra in gran parte de-voluta alla noradrenalina e alla serotonina. Secondo Frazer e Stinnett (18), unlungo fascio noradrenergico ascendente decorre lungo il tronco encefalico ed in-nerva il telencefalo e il diencefalo. La più alta densità di terminazioni noradre-nergiche si riscontra nell’ipotalamo, specie nei nuclei sopraottici, paraventricolari,dorsomediali e periventricolari, come pure nell’area retrochiasmatica. Alta con-centrazione di serotonina è stata riscontrata nel nucleo soprachiasmatico, nel nu-cleo dorsomediale e nei corpi mammillari. Nell’area settale, terminazioninoradrenergiche sono concentrate soprattutto nel nucleo laterosettale, mentre
49
Fisiopatologia dello stress
esse sono distribuite più uniformemente nell’amigdala. Nel rinencefalo esistonosolo sporadiche terminazioni serotoniniche, salvo che nell’amigdala ove la lorodensità è di entità media. Dosaggi biochimici comparativi nei vari distretti ence-falici hanno confermato che la più elevata concentrazione di noradrenalina si ri-scontra nell’ipotalamo.
Secondo Fuxe e coll. (19), che si sono occupati a lungo dello studio delle ter-minazioni noradrenergiche e dopaminergiche nel sistema nervoso centrale con latecnica dell’immunofluore- scenza, esistono nel tronco dell’encefalo due fasci no-radrenergici anatomicamente distinti: un fascio dorsale che origina nel locus coe-ruleus e che si dirige verso la corteccia cerebrale e l’ippocampo, ed un fascioventrale che origina da vari gruppi cellulari del tronco encefalico e che si dirigeverso il midollo spinale, il ponte ed il mesencefalo, l’ipotalamo e l’area settale. Se-condo Hökfelt e Fuxe (20), i neuroni dei due fasci suddetti mostrerebbero diffe-renze morfologiche nelle terminazioni, le quali avrebbero varicosità comuni nelfascio ventrale, mentre le varicosità sarebbero molto fini nel fascio dorsale.
La funzione discriminante delle afferenze sensoriali, che si svolge essenzial-mente nelle specifiche aree sensoriali della corteccia cerebrale, trova la sua utiliz-zazione, ai fini della risposta comportamentale, nei lobi frontali, i quali, secondoLuria (21), sembra “riuniscano le informazioni relative al mondo esterno perve-nute attraverso gli apparati degli esterocettori e le informazioni relative agli statiinterni dell’organismo”.
A questo riguardo, va ricordato che in effetti la corteccia frontale non ha rap-porti diretti con l’ambiente esterno, ma essa ha ricchissime connessioni con glialtri distretti encefalici e riceve da questi le relative afferenze, già elaborate, uti-lizzandole o meno per un congruo adattamento all’ambiente. Pervengono allacorteccia frontale anche le afferenze interne elaborate dalla regione limbica, dal-l’ipotalamo, dal mesencefalo e dalla corteccia basale del lobo frontale, i quali nelloro insieme, in quanto costituenti un complesso di centri che coordinano tuttala regolazione vegetativo-endocrina dell’organismo, sono definiti da Luria cervellovegetativo.
E’ ormai assodato che qualsiasi elaborazione emozionale si realizza nel cervellovegetativo e che questo trova la sua zona di riferimento nella vasta area prefron-tale: per cui si ammette che la componente emotiva di ogni atto psichico avvengaprima nel cervello vegetativo, e soprattutto nel lobo limbico, nell’ipotalamo, e poinei lobi frontali. Poiché da questa elaborazione dipendono tutti i processi di va-lutazione e di razionalizzazione, si ha da fare con il più alto livello funzionale delsistema nervoso centrale. Il che dimostra che la neocorteccia frontale è l’acquisi-zione essenziale dello sviluppo umano nel corso dell’evoluzione filogenetica.
Tuttavia, secondo Davidson (22), vi sono delle differenze nelle risposte delle
Marcello Aragona, Francesco Aragona
50
parte destra, rispetto a quella sinistra, della corteccia prefrontale ventromediale:la parte destra sembra assumere un ruolo specializzato nell’inibizione di stimoliaffettivi impulsivi: Pazienti con danni specifici di questo settore della cortecciaprefrontale del lato destro, ma non del sinistro, presentano notevoli anormalitànelle decisioni connesse ad emozioni, realizzando scelte più svantaggiose in pa-ragone con lesioni della controparte sinistra. Sembra che questo settore della cor-teccia prefrontale destra sia particolarmente sensibile a maltrattamenti cosicché,quando è danneggiata i pazienti successivamente tendono ad atti impulsivi in ri-spota a minacce ed a qualsiasi situazione di pericolo.
Si è detto che l’impulso nervoso attraverso la formazione reticolare sembra es-sere trasmesso prevalentemente lungo sinapsi noradrenergiche. Qui occorreanche accennare al fatto che l’attivazione della neocorteccia e del sistema limbicoche ne consegue sembra soprattutto connessa a sinapsi colinergiche.
Infatti, ricerche istochimiche condotte sull’attività acetilcolinesterasica ence-falica hanno dimostrato un sistema continuo di fibre colinergiche che dal troncoencefalico si proietta all’ipotalamo, ai gangli della base e alla corteccia cerebrale(Krnjevic e Silver, 23; Shute e Lewis, 24). Si è anche visto che l’acetilcolinesterasiè principalmente contenuta nelle cellule neocorticali degli strati profondi (23) eche l’attività della neocorteccia s’accompagna a liberazione dell’acetilcolina cor-ticale (25, 26, 27, 28, 29).
Si ritiene che il punto nodale nel quale l’impulso noradrenergico si converte inimpulso colinergico sia l’area settale, la quale oggi viene considerata un’importantestazione relé nella regolazione centrale dei comportamenti motivati (De Feudis,30). Gli argomenti che stanno in favore di detta ipotesi si possono riassumerecon De Feudis come segue: a) l’area settale è ricca sia di neuroni colinergici che di neuroni noradrenergici e
possibilmente di altri; b) la stimolazione elettrica dell’area settale nel gatto aumenta la liberazione di ace-
tilcolina corticale, mentre lesioni settali possono ridurre o abolire la libera-zione di acetilcolina prodotta dalla somministrazione di amfetamina o discopolamina;
c) la distruzione dell’area settale nel ratto causa diminuzione dell’aceticolina ce-rebrale, specie nella corteccia;
d) lesioni settali si sono dimostrate capaci di interferire nell’emotività, nell’attivitàmotoria, nel comportamento motivato e nell’apprendimento. E’perciò, giustificato concludere che l’area settale costituisca la sede anato-
mica nella quale si registra il collegamento delle sinapsi noradrenergiche e coli-nergiche.
Successivamente Swanson, Köhler e Björklund (31) hanno osservato che l’area
51
Fisiopatologia dello stress
settale, mediante i suoi stretti rapporti con l’ippocampo, dimostrati da estese con-nessioni bidirezionali, debba essere riguardata come parte di un unico sistema.Essa è divisibile in quattro parti, delle quali la laterale, la mediale e la posterioresono strettamente collegate con l’ippocampo, mentre la parte ventrale è soprat-tutto collegata con l’amigdala.
2.3. La via delle citochine e dell’ossido d’azotoPer quanto i primi studi abbiano dimostrato che i comuni neurotrasmettitori
(noradrenalina, acetilcolina, serotonina, ecc.) siano i più importanti mediatoridegli stress emozionali e fisici, studi più recenti hanno richiamato l’attenzione sulruolo non secondario svolto nello stesso senso da citochine e dall’ossido di azoto(NO), in quanto potenti diretti attivatori della secrezione ormonale ipofisaria, iquali non esercitano la loro azione per via sinaptica, come i comuni mediatori, mamediante specifici recettori ubicati sulla membrana dei neuroni, delle cellule glialie delle cellule endoteliali.
Scarborough e coll. (32), Hermus e Sweep (33) hanno dimostrato che l’inter-leuchina-1 attiva la secrezione della somatostatina e del CRH ipotalamico e diconseguenza dell’ACTH ipofisario. La successiva secrezione dei glicorticoidi par-tecipa in tal modo alla depressione immunitaria da stress, sulla quale ci si soffer-merà in seguito. Anche l’interleuchina-2 determina ipersecrezione dello stessoCRH ipotalamico: quest’effetto, come quello dell’interleuchina-1, è inibito dallasomministrazione di glicocorticoidi (Cambronero e coll., 34). Secondo Marguettee Coll. (35), le citochine sono anche capaci di agire direttamente sulle cellule ipo-fisarie ed influenzare la secrezione di TSH, GH, PRL, LH, oltre che di ACTH(Bernton e coll., 36). L’interleuchina-2, inoltre, sembra avere la proprietà di mi-mare, sull’ipofisi, le reazioni tipiche degli ormoni dello stress, producendo un au-mento di ACTH e PRL, nonché depressione della liberazione di FSH, LH, GH(Karanth e coll., 37).
Come accennato, gli astrociti, le cellule microgliali, le cellule nervose e le cel-lule endoteliali encefaliche sono in grado di sintetizzare citochine (38, 39, 40).Ciò compensa il fatto che in condizioni normali le citochine di produzione peri-ferica non riescono a superare la barriera emato-encefalica. In sostanza le cito-chine agiscono con meccanismo paracrinico, nel senso che i suddetti prodotti disecrezione cellulare, liberandosi dal corpo cellulare e riversandosi negli spazi in-terstiziali, esercitano direttamente, senza alcuna intermediazione, la loro azionesulle cellule viciniori. Nell’encefalo tale tipo di stimolazione avviene fra tipologiecellulari differenti: come i neuroni, le cellule gliali e le cellule endoteliali. Le cel-lule gliali assumono un ruolo trofico per i neuroni: ed è dimostrabile che esseesercitano effetti eccitatori mediante la secrezione di aminoacidi, fattori di crescita
Marcello Aragona, Francesco Aragona
52
e citochine capaci di modulare le funzioni neuronali (5). Nell’ipofisi, oltre alleben note cellule secretrici dei vari ormoni, esistono cellule capaci di secernereneuropeptidi (41). Dette cellule, note come “cellule follicolo-stellate” (41, 42) peril fatto che sono prive di granuli, sono caratterizzate da numerosi prolungamenticitoplasmatici e sono disposte attorno a cavità di tipo follicolare. Le medesime,che sembrano appartenere alla stessa linea embriologica dei macrofagi, secernonovari peptidi come la follistatina (antitesi della folliliberina) e citochine (endote-lina 1 e 3, interleuchina-2 e 6, fattori di crescita trasformanti (TGF). Queste so-stanze sembrano capaci di mediare effetti dell’interferone gamma sulla secrezionedi ormoni ipofisari (43). Queste cellule possono esprimere p75 NGFR, un re-cettore a bassa affinità per il fattore di crescita nervoso (NGF) (44). Inoltre, unadistribuzione selettiva di recettori citochimici è stata dimostrata in cellule del-l’adenoipofisi, i quali starebbero in favore della capacità di molte citochine di in-terferire nella secrezione di ormoni ipofisari (45). Le endoteline, ad esempio,stimolano la liberazione delle gonadotropine e inibiscono quella della prolattina;l’interleuchina-6 stimola le gonadotropine, la prolattina e la corticotropina (46).
Le cellule follicolo-stellate contengono anche la sintetasi dell’ossido di azoto(NOS) e possono utilizzare l’ossido di azoto (NO) come locale trasmettitore.L’inibizione della produzione di NO, mediante fattori inibenti la NOS, concretaun aumento di sensibilizzazione delle gonadotropine e dell’ormone di crescita inrisposta all’ormone rilasciante delle gonadotropine (GnRH) (47) e all’ormone ri-lasciante l’ormone della crescita (GHRH), rispettivamente (48): ciò indica chel’NO esercita un’influenza repressiva sulla secrezione di questi ormoni.
A proposito dell’NO non bisogna dimenticare che esso è secreto e liberatoanche nell’encefalo, in modo particolare dallo strato granulare del cervelletto e dalbulbo olfattivo accessorio (49), nonché in circa il 2% dei neuroni di altre regioniencefaliche. Si ritiene che l’NO potenzi i neuroni dell’ippocampo e la memoria alungo termine e che deprima le funzioni del cervelletto (49,50). Inoltre, secondoBréard e Coll. (5), in quasi tutte le cellule del locus coeruleus il mediatore chi-mico è costituito dalla noradrenalina, ma alcune cellule contengono NOS, l’en-zima indispensabile per la conversione della l-arginina in citrullina con liberazionedi una molecola di ossido d’azoto. La rimarchevole densità dei processi dendri-tici di queste cellule conferisce ad esse la capacità di interagire con quasi tutti i neu-roni del locus coeruleus. Inoltre gli assoni delle stesse cellule sono strettamentearticolati con la parete dei capillari locali, per cui essi possono stabilire comuni-cazioni fra i neuroni e la circolazione ematica. Siffatti processi sono idonei a me-diare gli effetti centrali delle citochine come IL-1, che in condizioni fisiologichenon supera la barriera emato-encefalica.
Secondo Bredt e coll. (51), l’ossido di azoto si libera anche da neuroni gangliari
53
Fisiopatologia dello stress
come quelli innervanti le cellule cromaffini della midollare surrenale, dai pituicitidell’ipofisi posteriore rilascianti vasopressina, e nel plesso mioenterico con in-fluenza sulla funzione della muscolatura liscia intestinale.
Ma oltre agli effetti favorevoli, consistenti nella protezione dei neuroni da fe-nomeni degenerativi, lo stesso NO è capace di provocare distruzione dei neu-roni circostanti quando viene rilasciato in elevate concentrazioni. Per cui vi è ildetto che questo gas a livello neuronale sia capace di comportarsi come “dr. Jekylle mister Hyde”: da un lato proteggendo i neuroni a basse concentrazioni e dall’al-tro divenendo una molecola assassina per i medesimi neuroni a concentrazionielevate (52). E’ perciò possibile che in particolari condizioni di stress l’NO faci-liti, insieme con altri fattori, l’insorgenza di sindromi psichiche e comportamen-tali di schietta natura patologica, di cui si accennerà in seguito.
3. Gli effetti biologici indirettiGli effetti biologici indiretti sono da considerare quelli mediati soprattutto
dalle catecolamine e dagli steroidi della corteccia surrenale: questi ultimi con com-piti di reintegrazione del materiale energetico bruciato dall’azione catecolaminica.Detti effetti s’instaurano in modo estremamente rapido, il che trova ragion d’es-sere nel fatto che l’organismo di tutti i mammiferi attinge esclusivamente dai gli-cidi le fonti di energia per il mantenimento di una normale omeostasi metabolicaa livello del sistema nervoso centrale. Basti por mente al fatto che l’encefalo haun’enorme rapidità metabolica e, sebbene rappresenti solamente il 2% del pesototale del corpo d’un uomo adulto, consuma almeno il 20% dell’ossigeno neces-sario per tutto il corpo (Sokoloff, 53): ciò per le esigenze del proprio ricambio gli-cidico che notoriamente si effettua per via aerobica.
In assenza di glucosio di provenienza esogena diviene inderogabile, per lastessa vita della cellula nervosa, il pronto realizzarsi di processi di sintesi glicidicada precursori non carboidrati. Tale processo, definito gliconeogenesi, avviene nel fe-gato con l’utilizzazione di precursori liberati dal tessuto adiposo (glicerolo) e daimuscoli scheletrici (lattato, piruvato) ad opera delle catecolamine e dei glicocor-ticoidi. Nel mentre detti precursori sono convertiti in glucosio, le catecolamine,gli steroidi e l’ormone somatotropo mobilizzano ulteriormente acidi grassi liberi,i quali sono deputati a fornire altro combustibile per risparmiare carboidrati e, ve-rosimilmente, anche per consentire la sintesi restauratrice di ormoni steroidi.
Ben si comprende come in mancanza o in difetto dei suddetti processi glico-neogenetici il sistema nervoso centrale debba, in rapporto a stress di notevoli in-tensità e durata, subire danni funzionali di vario grado, non sempreadeguatamente compensati, donde il possibile instaurarsi di turbe psichiche e delcomportamento. E’ evidente che siffatta carenza gliconeogenetica può aver luogo
Marcello Aragona, Francesco Aragona
54
col concorso di condizioni endogene pregresse: stati disfunzionali ipofisari, sur-renalici, epatici, tiroidei, ecc.
Altri importanti effetti fisiologici connessi alla scarica catecolaminica sono: a) aumento della frequenza cardiaca; b) aumento della forza contrattile del miocardio; c) aumento della pressione arteriosa (a questo riguardo la noradrenalina ha un
potere vasocostrittore 50 volte più elevato di quello dell’adrenalina); d) aumento della frequenza e della profondità respiratoria; e) dilatazione dei vasi dei muscoli scheletrici, ove, per effetto della glicogeno-
lisi, vi è accumulo di acido lattico, necessario ad incrementare il tasso di lattato de-stinato ad essere sintetizzato in glicogeno nel fegato;
f) rilasciamento della maggior parte della muscolatura liscia, e contrazionedelle fibre muscolari della capsula splenica, degli sfinteri del tratto gastro-enterico,degli ureteri, degli erettori del pelo, del dilatatore delle pupille;
g) acceleramento della coagulazione sanguigna. Rientra in questo novero anche l’attivazione del sistema renina-angiotensina,
di cui s’è già detto, posto che si tratta di fenomeno connesso alla vasocostrizionerenale da catecolamine.
Bibliografia1. Bloom F.E., Lazerson A., Il cervello, la mente, e il comportamento. Ciba-Geigy, Mi-
lano 1990, 215-243. 2. Cannon W.B., The emergency function of the adrenal medulla in pain and the major emo-tion. Am. J. Physiol. 33, 556, 1914.
3. Cannon W.B., The wisdom of the body. Norton&Co, New York, 1932.4. Cannon W.B., Stresses and strains homeostasis. Am. J. Med. Sci. 89, 1-14, 1935.5. Bréard J., Costa O., Kordon C., Organization and functional relevance of neuroimmunenetworks. in, Leonard B.E., Miller K.: Stress, the Immune System and Psychiatry.Wiley-Sons. Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 1995,pag.17-45.
6. Testut L., Latarjet A., Trattato di anatomia umana, vol.IV, UTET, Torino, 1963,pag.313.
7. Barr M.L., Kiernan J.A., Anatomia del sistema nervoso Umano, McGraw-Hill, Mi-lano, 1992, p. 98.
8. Smythies J.R., Brain mechanism and behaviour. II ed., Blackwell, Oxford, Edimburg,1970, pag. 39-40.
55
Fisiopatologia dello stress
9. Bjorklund A., Hokfelt T., Swanson L.W., Handbook of Chemical Neuroanatomy. El-sevier, Amsterdam, II ed. 1997, Vol.V, Cap. I: The Hypotalamus.
10. Le Doux J., Il cervello emotivo. Baldini e Castoldi, Milano, 1998, 165-185.11. Kvetnananky et al., Sympathoadrenal System in Stress. Interaction with the Hypotha-lamus-Pituitary-Adrenocortical System. Ann. New York Acad. Sci., vol. 171, 1995,p. 131-158.
12. Reischies F.M., Pattern of disturbance of different ventral frontal functions in organicdepression. Ann. New York Acad. Sci. 877, 775-780, 1999.
13. Aguilera G., Kiss A., Luo X., Akbasak B.S., The Renin-Angiotensin System and theStress Response. In, Crousos G.P. et. al.: Stress. Basic Mechanism and ClinicalImplications. Ann. New York Acad. Sci. Vol. 171, 1995, p. 173-186.
14. Richardison Morton K., Van Derkarl L.D., Brownfield M.S., Bethren C., Neu-ronal cell bodies in the hypothalamic paraventricular nucleus mediate stress-induced reninand corticosterone secretion. Neuroendocrinology 50, 75-80, 1989.
15. Gotoh E., Murakami K., Bahnsom T.D., Ganong N.F., Role of brain serotoni-nergic pathways and hypothalamus in regulation of renin secretion. Am. J. Physiol. 253,R179-R185, 1987.
16. Aguilera G., Factors controlling steroid biosynthesis in the zona glomerulosa of the adre-nal. J. Steroid Bioch. Mol. Biol. 45, 147-151, 1993.
17. Palkovits M., Baffi J.S., Dvori S., Neuronal organization of stress response. Pain in-duced c-fos expression in brain stem catecholaminergic cells groups. Ann. New York Acad.Sci. Vol.171 1995, p.313-326.
18. Frazer A., Stinnet J.L., Distribution and metabolism of norephinephrine and serotoninin the central nervous system. In Mendels J.: Biological Psychiatry. Viley & Sons,New York, 1973, p. 35.
19. Fuxe K., Hokfelt T., Jonsson G., Ungerstedt U., Fluorescence microscopy in neu-roanatomy. In: Ebbesson Nauta: Contemporary Research in Neuroanatomy.Springer, New York, 1970, p. 275.
20. Hokfelt T., Fuxe K., On the morphology and neuroendokrine role of hypothalamic ca-techolamine neurons. In: Knigge K.M., Scott D.E., Weindl A.: Brain-EndokrineInteraction. Karger, Basel, 1972, p. 181.
21. Luria A.R., Le funzioni corticali superiori nell’uomo. Giunti, Firenze, 1967. 22. Davidson R.J.: What does the prefrontal cortex “do” in affect: perspectives on frontalEEG asymmetry research. Bilogical Psychology 67, 219-233, 2004.
23. Krnjevic K., Silver A., A histochemical study of cholinergic fibres in the cerebral cor-tex. J. Anat. 99, 711, 1965.
24. Shute C.C., Lewis P.A., Cholinesterase-containing systems of the brain of the rat. Na-ture 199, 1160, 1963.
25. Celesia G.G., Jasper H.H., Acetylcholine released from the cerebral cortex in relation
Marcello Aragona, Francesco Aragona
56
to state of activation. Neurology 16, 1053, 1966.26. Kanai T., Szerb J.C., Mesencephalic reticular activating system and cortical acetylcholineoutput. Nature 205, 80, 1965.
27. Mitchell J.F., The spontaneous and evoked release of acetylcholine from the cerebral cor-tex. J. Physiol. 165, 98, 1963.
28. Mitchell J.F., Acetylcholine release from the brain. In: Mechanism of Release of Bioge-nic amine. Proc. Wenner&Gren Symp. Pergamon Press, Oxford, 1966, p. 425.
29. Szerb J.C., Cortical acetylcholine release and electroencephalographic arousal. J. Physiol.192, 329, 1967.
30. De Feudis F.V., Central Cholinergic System and Behaviour. Academic Press, Lon-don, New York, 1974.
31. Swanson L.W., Kohler C., Bjorklund A., The Limbic Region. I:The Septohippo-campal System. In: Bjorklund A., Hokfelt T., Swanson L.W.. Handbook Che-mical Neuroanatomy. Vol. V. Elsevier, Amsterdam, 1997, p. 135.
32. Scarborough D.E., Lee S.L., Dinarello C.A., Reichlin S., Interleukin 1-beta sti-mulates somatostatin in primary cultures of fetal rat brain. Endocrinology 124, 549,1989.
33. Hermus A.R., Sweep C.G., Cytokines and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis.J. Steroid Bioch. Med. Biol. 37, 867, 1990.
34. Cambronero J.C., Rivas F.J., Borell J., Guaza C., Interleukin-2 induces corticotro-pin-releasing hormone release from superfused rat hypothalamus: influence of glucorticoids.Endocrinology 131, 677, 1992.
35. Marguette C., Ban A., Fillon G., Haour F., Receptors of interleukin 1, 2 and 6(IL-1 alpha and beta, IL-2, IL-6) in mouse, rat and human pituitary. Neuroendocri-nol. 52, 48, 1990.
36. Bernton E.W., Beach J.E., Holaday J. W., Swallridge R.C., Fein H.C., Release ofmultiple hormones by a direct action of interleukin-1 on pituitary cells. Science 238, 519,1987.
37. Karanth S., McCann S.M., Anterior pituitary hormone control by interleukin-2. Proc.Nat. Acad. Sci. 88, 2961, 1991.
38. Benveniste E.N., Cytokines: influence on glial cell gene expression and function. In:Blalock J.E.: Neuroimmunoendocrinology. Chemical Immunology. Karger,Basel, 52, 106, 1992.
39. Araujo D.M., Lapshork P.A., Collier B., Localisation of interleukin-2 immunorec-tivity and interleukin-2 receptors in the rat brain: interaction with the cholinergic system.Brain Res. 498, 257, 1989.
40. Ljungdahl A., Olsson T., Van Dermeide P.H., Holmdahl R., Klareskog L.,Hojeberg B., Interpheron-gamma-like immunoreactivity in certain neurons of central andperipheral nervous system. J. Neurosci. Res. 24, 451, 1989.
57
Fisiopatologia dello stress
41. Vila Porcile E., Oliver L.: The problem of the folliculo-stellate cells in the pituitarygland in ultrastructure of endocrine cells and tissues. In: Motta P.M.: Ultrastructure ofEndocrine Cells and Tissues. Martinus Nijhoff Publishers. Boston, 1984, p.64.
42. Matsumoto H., Kuyama C., Sawada T., Koike K., Hirota K., Miyake A., Ari-mura A., Inone K., Pitutary folliculo-stellate cells line (TIF/GF) responds to novel hy-pophyseotropic peptide PACAP shoving increased AMP and interleukin-6 secretion andcell proliferation. Endocrinol. 133, 2150, 1993.
43. Vankelekom H., Audries M. Billiau A., Denef C., Evidence that folliculo-stellatecells mediate the inibitory effect of interferon-gamma on hormone secretion in rat anteriorpituitary cell cultures. Endocrinology 130, 3537, 1992.
44. Borson S., Schatteman G., Claude P., Bothwell M., Neurotrophins in the develo-ping and adult primate adenohypophysis. A new pituitary homone system? Neuroendo-crinal 59, 466, 1994.
45. Kordon C., Drouva S., Martinez de la Escalera G., Weiner R.I., Role of classicand peptide neuromediators in the neuroendocrine regulation of LH and prolactin. In:Knobil E., Neil J.: Physiology of Reproduction. Raven Press, New York, 1994,p.1621.
46. Lyson K., McCann S.M., Induction of adrenocorticotropic hormone release by inter-leukin-6 in vivo and in vitro. Ann. New York Acad. Sci., Vol. 650, 1992, p. 182.
47. Ceccatelli S., Hulting A.L., Zhang X., Gustaffson L., Villar M., Hokfelt T., Ni-tric oxide syntase in the rat anterior pituitary gland and the role of nitric oxide in regula-tion of luteinizing hormone secretion. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 90, 11292, 1993.
48. Kato M.: Involvement of nitric oxide in growth hormone (GH)-releasing hormome-inducedGH secretion in rat pituitary cells. Endocrinol. 131, 3133, 1992.
49. Snyder S.H., Nitric oxide: first in a new class of neurotrasmitters? Science 54, 171,1992.
50. Zorumski C.F., Igumi Y., Nitric oxide and hippocampal synaptic plasticity. Biochem.Pharmacol. 46, 777,1993.
51. Bredt D.S., Hwang P.M., Glatt C.E., Lowenstein C., Reed R.R., Snyder S.H.,Cloned and expressed nitric oxide synthase structurally resembles cytochrome P-450 reduc-tase. Nature 351, 714, 1991.
52. Änggard E.: Ossido di azoto: mediatore, omicida e farmaco. The Lancet (Ed.Ital.) 12,38, 1995.
53. Sokoloff L., Cerebral circulation and behavior in man: strategy and findings. In Man-dell A. e Mandell M.P.: Psycochemical research in man: Academic Press, NewYork, London, 1969, p. 237.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
58
Capitolo III
Le emozioni e le loro manifestazioni espressive e biologiche
Platone ricorda nel “Filebo” le parole di Socrate a proposito del rapporto cau-sale, in particolare cronologico, fra le emozioni e le relative conseguenze biolo-giche: “Non è stato detto nei precedenti discorsi che i piaceri e i dolori chenascono dall’anima per se stessa – (che cioè coinvolgono il sistema nervoso, se-condo le concezioni moderne) - possono generarsi prima dei piaceri e i dolori chenascono dal corpo, cosicché ci capita di godere e di addolorarci in precedenza diciò che accadrà in futuro?” (1).
E’ da sempre noto che l’uomo esprime le sue emozioni soprattutto mediantemodificazioni dell’aspetto del viso, cioè della mimica facciale, perciò visibili dachiunque (sorriso, corrugamento della fronte, contrazione dei muscoli facciali,delle labbra, delle palpebre, modificazioni delle pupille, lacrimazione, ecc.: mani-festazioni espressive ben documentate nelle immagini della pittura classica), non-ché con modificazioni biologiche di cui in parte s’è detto, ma sulle quali necessitaritornare più specificamente in seguito.
A proposito della lacrimazione Lutz (2) ricorda che dal punto di vista fisiopa-tologico le lacrime si distinguono in tre categorie: basali, riflesse e psicologiche.Le lacrime basali sono costituite dallo strato umido che lubrifica la superficie dellacornea e della mucosa palpebrale. Le lacrime riflesse, o irritanti, si identificano conquelle che sgorgano quando l’epitelio della cornea e congiuntivale è esposto a so-stanze irritanti, fra le quali, ad esempio, un corpo estraneo, anche di piccole di-mensioni che penetra negli spazi congiuntivali o quando questi sono esposti adumori irritanti, come quelli emessi dal taglio di cipolle. Le lacrime psicologiche,o emotive, sono comuni a stati di coinvolgimento psichico, e ricorrono in coin-cidenza di un aumento della secrezione di ormoni tiroidei e/o di prolattina daparte della preipofisi, e fors’anche di endorfine quale compenso dello stato emo-zionale spiacevole. Le lacrime psicologiche, inoltre, si distinguono dalle altre duecategorie anche per il fatto che contengono potassio in misura quattro volte su-periore al plasma (3), nonché una concentrazione di manganese quattro volte su-periore a quella del plasma e proteine dal 20-25% superiore a quella delle lacrimeprodotte dalle cipolle (4).
Sin dall’antichità s’è creduto che le lacrime psicologiche avessero un effetto ca-tartico: cioè la funzione di ridurre la tensione connessa allo stato emotivo.
A proposito delle lacrime determinate da forti emozioni Platone nel “Simpo-sio” (1) riferisce le parole di Alcibiade, in riferimento alle emozioni suscitate daidiscorsi di Socrate: “Cari amici, se non rischiassi di sembrare completamente
59
ubriaco, vi riferirei, con giuramento, che cosa ho provato io stesso nell’ascoltarei discorsi di quest’uomo (cioè di Socrate), e anche ora continuo a provare. Infattiquando lo ascolto, nel sentire le sue parole mi batte il cuore e mi vengono le la-crime, molto più che ai coribanti (sacerdoti della dea Cibele); e vedo che moltis-simi altri provano le stesse cose. Invece, quando ascoltavo Pericle e altri bravioratori pensavo che parlassero bene, ma non sentivo qualcosa di simile, né la miaanima veniva messa in tumulto, né si arrabbiava, come se io mi trovassi nelle con-dizioni di schiavo.” Analoghe emozioni suscitava in Alcibiade la musica di Mar-sia (satiro abilissimo suonatore di flauto, che osò sfidare in una gara Apollo chesuonava invece la cetra; sconfitto, fu, per punizione, scorticato vivo). “Ma nelsentire questo Marsia” - continuava Alcibiade - “qui più volte mi sono trovato inuna situazione di questo genere, tanto da sembrarmi che non valesse la pena divivere, comportandosi come mi comporto io” (1).
Nella mitologia dell’antica Grecia vanno ricordate le tragiche vicende di Niobe,regina di Tebe e nipote di Zeus, madre di quattordici figli (7 maschi e 7 femmine)che le furono uccisi da Artemide (Diana) e da Apollo (Febo) per un insulto fattoalla loro madre Latona, in quanto genitrice soltanto di quei due figli. Niobe nonsopportò il dolore di quello scempio ed in pianto dirotto si uccise. La sua salmafu trasformata in pietra da Zeus, pietra che, tuttavia, continuò a piangere. Di parisignificato le lacrime versate da Eos (Aurora) per l’uccisione del proprio figlioMemnone da parte di Achille durante la guerra di Troia. Le lacrime di Eos da-rebbero luogo alla rugiada che ogni mattino si stratifica su tutte le piante, com-presi i fiori.
Va ricordato anche lo sbadiglio che di solito caratterizza lo stato di noia e disonnolanza, possa pure riscontrarsi in altre condizioni come nella rapida indu-zione del rilassamentoed il cui accadimento è connesso all’attivazione dell’ipota-lamo (5).
A parte le lacrime, le medesime manifestazioni emotive, compreso lo sbadiglio,si osservano negli animali, nei quali in determinati casi (paura) si riscontra il rad-drizzamento dei peli, che corrisponde all’orripilazione (pelle d’oca) dell’uomo. Inquest’ultimo, oltre all’aumento della frequenza cardiaca e della pressione arte-riosa, si aggiunge la sudorazione specie alla fronte e sul palmo delle mani (cosid-detto sudore freddo). L’arruffamento del pelo è tipica caratteristica degli animaliin conseguenza di stimoli di allarme, il quale precede l’eventuale reazione ag-gressiva di difesa. Il comportamento emotivo degli animali era ben noto anche aDarwin. Egli, nel suo Trattato sull’origine dell’uomo (6), ne parla diffusamenteprecedendo la perspicace opera del Lorenz su questo argomento. Senza contareche le risposte emotive erano notissime sin dall’antichità per quanto attiene aicani, ai cavalli, agli uccelli ed anche agli animali feroci: gli scritti dei pensatori an-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
60
tichi, anche in epoca precristiana, sono assai numerosi: l’emozione che ucciseArgo, il vecchio cane di Ulisse al momento del ritorno del padrone ad Itaca (Odis-sea, Libro XVII); il dolore del cane Ircano alla morte del re Lisimaco, suo pa-drone, rimasto sul letto di quest’ultimo senza bere e mangiare per poi lanciarsi nelfuoco al momento della cremazione del cadavere. Analoghe storie di cani sonooccorse varie volte ai nostri giorni. Così anche il legame di familiarità che uniscecoppie di cavalli, tanto che è difficile farli vivere e viaggiare separati; l’episodio delleone ferito ad una zampa da una scheggia di legno e curato da Androclo, schiavoromano sfuggito al padrone e rifugiatosi nella grotta africana tana di quel leone,il quale, successivamente catturato e portato a Roma, risparmiò la vita di Andro-clo, anch’esso nuovamente catturato e per punizione esposto nell’arena del circoalla mercé di belve affamate. Il leone, infatti, avendo riconosciuto in Androclo lapersona che l’aveva amorevolmente curato, gli si avvicinò scodinzolando e lec-candogli le mani: ciò destò grande sorpresa fra gli spettatori e nell’imperatore. Alche Androclo raccontò l’episodio del suo incontro con quel leone, fu graziatocon l’affidamento dello stesso leone.
Ma una sostanziale differenza esiste fra l’uomo e gli animali per quanto at-tiene al comportamento aggressivo: il primo distrugge i suoi simili, non di radoper meschini interessi (guerre, eliminazione di competitori mediante omicidi odiscredito presso l’opinione pubblica con la divulgazione di false ed infamantiaccuse, ecc.), spesso devasta l’ambiente e per di più trova godimento anche qualespettatore di torture e di esecuzioni capitali (il che rientra nel sadismo) sin dal-l’antichità (esempi assai dimostrativi le folle presenti alle esecuzioni di persone ac-cusate di eresia e condannate al rogo, all’impiccamento, alla decapitazione, ecc.);mentre i secondi uccidono solo per necessità al fine di difesa e/o di garantire,con la ricerca di cibo, la sopravvivenza loro e della prole.
Ovviamente, per quanto attiene all’uomo, le menzionate modificazioni espres-sive del viso in rapporto a stimoli emozionali presuppongono l’integrità dei lobifrontali, posto che la loro comparsa è impedita da lesioni di dette sedi encefali-che, come dimostrato dai pregressi, oggi abbandonati, interventi chirurgici di lo-botomia per fini terapeutici di malattie psichiatriche, nonché da lesionitraumatiche estese (7, 8).
A completamento di quanto già detto nel capitolo precedente bisogna ag-giungere i dati da tempo acquisti in merito alle modificazioni biologiche, soprat-tutto attinenti al metabolismo delle catecolamine, determinate dagli stress. Perquanto riguarda la risposta simpatica e della midollare surrenale in condizioniemozionali di varia natura, la letteratura, specie anglosassone e scandinava, è ric-chissima di contributi. E’ merito di Von Euler e Lundberg (9) di aver dimostratonel 1954 un aumento dell’escrezione urinaria di catecolamine in piloti e passeg-
61
Fisiopatologia dello stress
geri durante il volo. Qualche anno dopo Elmadjian e coll. (10) dimostrarono con-siderevole aumento dell’escrezione catecolaminica sotto stress emozionale, rile-vando che in rapporto ad un comportamento aggressivo prevale l’escrezionenoradrenalinica, mentre negli stati ansiosi prevale l’escrezione adrenalinica.
Le indagini sul comportamento dell’escrezione catecolaminica nel corso di si-tuazioni stressanti di varia natura sono numerosissime. Kagan e Levi (11) asseri-scono che un’ampia serie di stimoli psico-sociali, piacevoli e spiacevoli, sonocapaci di stimolare l’attività simpatica e adreno-midollare: fase precedente ad in-contri di pugilato, professionistico o dilettantistico, corsa in una centrifuga, voloacrobatico supersonico e nello spazio, guida di automobili, esami universitari, vi-site mediche o cure dentarie, ricovero in ospedale, immersione in acqua, visionedi films carichi di suspense o di stimoli emotivi piacevoli. Levi (12) ha svolto lesue indagini in soggetti esposti a vari stimoli stressanti (stress industriale, lavorod’ufficio, stati emozionali piacevoli e spiacevoli, amore e sesso, stress del lavoroquotidiano) ed è giunto alle seguenti conclusioni: 1) la maggior parte degli stimoli adoperati sono stati capaci di evocare un au-
mento dell’escrezione catecolaminica, talora con livelli simili a quelli trovati incasi di feocromocitoma;
2) taluni individui eliminano catecolamine entro la norma, sia durante i periodi dicontrollo, sia durante lo stress;
3) le variazioni nell’escrezione catecolaminica fra i vari soggetti sono molto con-siderevoli, però nello stesso individuo detta escrezione è proporzionale algrado dello stato emozionale;
4) i livelli di escrezione catecolaminica di ogni individuo durante corrispondentiperiodi di differenti esperimenti sono positivamente correlati;
5) stimoli evocanti risposte di tranquillità e di moderazione riducono l’escrezionecatecolaminica a livelli sensibilmente inferiori a quelli di controllo;
6) stimoli piacevoli evocanti divertimento hanno pressappoco la stessa capacitàdi quelli spiacevoli nell’aumentare l’escrezione catecolaminica;
7) l’eccitamento sessuale sperimentalmente indotto è accompagnato da un con-siderevole aumento dell’escrezione catecolaminica: le femmine reagiscono dimeno agli stimoli usati, sia psicologicamente che fisiologicamente.Nella privazione di sonno, ricerche eseguite da Tyler e coll. nel 1946 (13) esclu-
devano un aumento del tasso ematico di sostanze adrenalino-simili. Tuttavia, ri-cerche successive, condotte con metodiche più appropriate, hanno documentatoun aumento dell’escrezione urinaria di adrenalina e di noradrenalina. Hasselmane coll. (14) rilevarono che la privazione di sonno incrementa notevolmente l’eli-minazione di catecolamine rispetto a quanto si verifica di consueto nell’eserciziomuscolare. Fröberg e coll. (15) esaminando le variazioni ritmiche circadiane del-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
62
l’escrezione urinaria di adrenalina e di noradrenalina in 63 soggetti (31 individuidi età compresa fra 24 e 44 anni, 32 individui di età compresa fra 49 e 64 anni)mantenuti in stato di veglia per 75 ore, hanno visto che i valori più elevati d’escre-zione adrenalinica si sono avuti, sia nel gruppo dei soggetti giovani che in quellodei soggetti più anziani, intorno alle ore 12-13 il primo giorno e attorno alle ore14 il secondo e terzo giorno di privazione di sonno, con una tendenza, pertanto,verso valori più alti con l’aumento della durata della privazione di sonno. Perquanto riguarda la noradrenalina, hanno visto che i valori più elevati si avevanointorno alle ore 8 nei soggetti giovani, mentre nei soggetti più anziani la curvad’escrezione era più irregolare, avendosi il massimo attorno alle ore 10-12. Nonè stato apprezzato alcun rapporto fra l’intensità d’escrezione noradrenalinica edurata della privazione di sonno. Gli AA. hanno anche correlato i suddetti daticon la capacità di esecuzione di tiri al bersaglio e con la sensazione soggettiva distanchezza durante tutto il periodo dell’esperimento. Hanno visto che il massimodella sensazione di fatica coincideva con i valori minimi d’escrezione adrenali-nica, mentre con i valori massimi di escrezione di questa amina coincidevano lemigliori prestazioni di tiro. La correlazione fra escrezione noradrenalinica e leprestazioni di tiro era del tutto negativa. A proposito delle ricerche suddette sideve ricordare che normalmente, secondo Kärki (16), la noradrenalina vieneescreta in maggiore quantità durante il giorno, rispetto alla notte, mentre l’adre-nalina non mostra simili variazioni. Al contrario, von Euler e coll. (17) riferisconoche sia l’adrenalina che la noradrenalina vengono escrete in minore concentra-zione durante la notte, mentre non vi sono significative differenze escretorie du-rante i diversi periodi del giorno. In dosaggi del tasso adrenalinico plasmaticoeffettuati su campioni di sangue mediante puntura digitale, Lehmann e Michae-lis (18) hanno visto che i valori più elevati si hanno la mattina e il pomeriggio.Questi AA. hanno anche notato che il grado di attività fisica e la sensazione di be-nessere tendono a decorrere parallelamente con la curva adrenalinica.
Si è accennato nel capitolo precedente alla conoscenza circa l’attivazione disinapsi noradrenergiche nel corso degli stress. In effetti sono da molto temponote sensibili modificazioni del contenuto in noradrenalina in varie aree encefa-liche, caratterizzate sia da riduzione nella fase di stimolazione sia da successivo in-cremento della loro sintesi. Lo shock elettrico, applicato sulle zampe di animalida esperimento, se sufficientemente severo, produce significativa riduzione dellanoradrenalina endogena nel tronco encefalico (19), in varie parti dell’encefalo delratto e della cavia (20) e nell’ipotalamo della scimmia (21). Altre modalità di stress,come la fatica muscolare (22, 23), l’immobilizzazione forzata, situazioni di com-battimento (20), l’esposizione al freddo (19) si sono dimostrate idonee a causareuna riduzione della noradrenalina encefalica. Si è visto che l’intensità di tale ef-
63
Fisiopatologia dello stress
fetto è variabile, in rapporto al tipo, all’intensità dello stress e ad altre condizionisperimentali. Come sopra accennato, gli stress producono contemporaneamenteun incremento della sintesi della noradrenalina encefalica. Ciò è stato visto nellafatica muscolare, durante l’esposizione al freddo (24) e durante la privazione disonno (25). L’acceleramento del turnover noradrenalinico è stato dimostrato inmodo evidente mediante applicazione intermittente dello shock elettrico sullezampe di ratti (26): 10’ di applicazione, 20’ di riposo; durata complessiva 3 ore.Ai ratti suddetti era stata inoculata nel liquor, due ore prima, noradrenalina mar-cata (3H-NE). Si è constatato in tal modo spiccata riduzione dell’attività nora-drenalina in varie sedi dell’encefalo e del midollo spinale: ciò indica una generaleattivazione dei neuroni noradrenergici centrali. Gli stessi AA. hanno rilevato cheshock prodotti con correnti di più alta intensità aumentano ulteriormente l’acce-leramento del turnover noradrenalinico e causano un marcato accumulo di 3H-normetanefrina nei tessuti. Il che dimostra che grandi quantità di 3H-NE sonoliberate dalle terminazioni nervose in queste condizioni sperimentali. In altra suc-cessiva indagine gli stessi A.A (27) hanno rilevato che un’aumentata sintesi nora-drenalinica è osservabile in vitro mediante dosaggio delle 3H-catecolamineformate da 3H-tirosina in fette di tronco encefalico di animali stressati.
Interessante notare che lo stress elettrico potenzia notevolmente l’accelera-mento del turnover noradrenalinico prodotto da sostanze psicotrope e partico-larmente dall’amfetamina (28).
Si è visto anche che il turnover della serotonina è accelerato dagli stress. Infatti,l’immobilizzazione degli animali produce contemporaneamente aumento dell’at-tività della triptofano-pirrolasi del fegato e nell’encelalo riduzione della concen-trazione di serotonina e di acido 5-idrossindolacetico (29); con lo stress elettricosi verifica un aumento della sintesi encefalica di serotonina: tale stress protrattoper 180 minuti s’accompagna ad un pronunciato aumento della sintesi della se-rotonina, come dimostrato dal dosaggio diretto della 3H-serotonina e dal suo ac-cumulo nel tessuto encefalico dopo l’inoculazione di 3H-triptofano (30).L’aumento della temperatura ambientale è capace pure di accelerare il turnoverdella serotonina encefalica (31, 32, 33). La privazione di sonno determina i se-guenti effetti sul ricambio della serotonina encefalica: 1) marcato accumulo della 3-H-serotonina in tutti i distretti encefalici degli ani-
mali privati di sonno, in confronto a ratti studiati dopo 45’ dalla sola inocula-zione nel liquor di 3H-triptofano, specialmente nel telencefalo-diencefalo, neltronco encefalico e nel midollo spinale;
2) l’attività specifica della serotonina, studiata in vitro su fette di tronco encefa-lico di ratti privati di sonno, dopo 30’ di incubazione con 3H-triptofano, ap-pariva marcatamente aumentata;
Marcello Aragona, Francesco Aragona
64
3) nessun effetto si è visto, sia in vivo che in vitro, in esperimenti con 3H-5-idrossitriptofano invece che con 3H-triptofano: il che indica che quest’ultimosvolge il ruolo principale come precursore della sintesi della serotonina (28).Anche la dopamina viene mobilizzata negli stati di stress (28). Vanno ricordate pure le ricerche di Anokhina e coll. (34) condotte contem-
poraneamente sul ricambio noradrenalinico e serotoninico del mesencefalo, del-l’ipotalamo e della corteccia cerebrale in animali sottoposti a stress. Sono statiprodotti due tipi di stress: nel primo, i ratti erano mantenuti in un ambiente nonfamiliare e sottoposti a stimolazioni dolorose; nel secondo, i ratti erano immersiin acqua a 15° C, ove erano lasciati nuotare per 5 minuti. Gli animali, divisi ingruppi, venivano uccisi 30 minuti, 60 minuti, e 18 ore dopo lo stress. Inoltre, perparagonare le modificazioni nel contenuto delle amine biogene sotto stress in di-verse età, hanno studiato anche un gruppo di ratti dell’età di un mese. In questocaso è stata usata l’immersione in acqua e gli animali uccisi dopo 3 e 30 minuti.Tali esperimenti hanno dimostrato che lo stress produce un’apparente riduzionenella concentrazione di noradrenalina e di serotonina in varie regioni encefaliche.Così, 30 minuti dopo la stimolazione dolorosa di breve durata, che sembra esserestato lo stress meno intenso, la noradrenalina e la serotonina diminuivano prin-cipalmente nell’ipotalamo e nel mesencefalo, mentre rimanevano immodificatenella corteccia cerebrale; 30 minuti dopo immersione in acqua fredda il contenutoin amine biogene diminuiva in modo più marcato e la concentrazione di nora-drenalina si riduceva rapidamente anche nella corteccia cerebrale. Analoghi ri-sultati ottennero 30 minuti dopo stimolazione dolorifica, ma l’ulteriore dinamicadella concentrazione delle due amine differiva sostanzialmente. La serotonina ri-cominciava a salire 60 minuti dopo lo stress ed in tal modo la sua concentrazioneera ridotta solo nell’ipotalamo; 18 ore dopo lo stress essa era rientrata nei livellinormali. Al contrario, la riduzione della concentrazione noradrenalinica persi-steva nello stesso periodo, anzi diveniva generalizzata: 60 minuti dopo lo stressla noradrenalina diminuiva nella corteccia cerebrale; 18 ore dopo lo stress essa ri-maneva considerevolmente bassa in tutti i distretti encefalici studiati.
Gli AA., tenendo conto che la riduzione della concentrazione delle amine bio-gene studiate era correlata con un’eccitazione delle corrispondenti strutture neu-rochimiche encefaliche, conclusero: a) L’intensità e la diffusione dell’eccitazionedelle strutture adrenergiche e serotoninergiche devono considerarsi proporzionalialla potenza dello stress. Nella fase iniziale sono eccitati gli elementi neurochimicidell’ipotalamo e del mesencefalo. b) In condizioni di stress, le modificazioni cheriguardano le strutture noradrenergiche durano più a lungo di quelle degli ele-menti serotoninergici e tendono a mostrare un’intensificazione ed una generaliz-zazione dopo la scomparsa degli effetti dello stress. Nei ratti immaturi le risposte
65
Fisiopatologia dello stress
erano meno evidenti rispetto ai ratti adulti.Poiché è stato dimostrato che nel sistema nervoso centrale, ed in particolare
nell’ipotalamo, è contenuta anche istamina, la quale può rappresentare altro me-diatore della trasmissione nervosa (35), sembra opportuno accennare pure allemodificazioni che tale sostanza subisce in condizioni di stress. Si è visto che inratti immobilizzati in contenitori di plastica, posti in gabbie isolate a temperaturadi 4° C, o mantenuti in gabbie anguste a 4° C, si rilevava dopo 1-2 ore (non dopo30’) riduzione della concentrazione istaminica dell’ipotalamo, del talamo-mesen-cefalo e della corteccia cerebrale, mentre nessuna variazione era apprezzabile nelponte e nel midollo spinale. La riduzione istaminica nelle regioni encefaliche sud-dette era del 35-40% (35).
Le molteplici modificazioni biochimiche prodotte dagli stress a livello ence-falico qui sopra accennate, ed in modo particolare quelle relative al turnover nora-drenalinico, che sono da considerare di primaria importanza come quelle delsistema simpatico e della midollare surrenale, si concludono con la stimolazionedell’attività neurosecretoria dei nuclei ipotalamici, cui accennato nel precedentecapitolo, con le conseguenti sequele multiormonali, per lo più limitate in ambitofisiologico, ma in vari casi sfocianti in quadri patologici su cui ci soffermeremonella parte seconda.
Relativamente alle modificazioni morfologiche dell’encefalo nelle stesse con-dizioni sperimentali, oltre all’aumento di spessore della corteccia cerebrale (36,37), sono state osservate significative modificazioni neuroniche e delle cellulegliali.
Studi al microscopio elettronico hanno dimostrato che le spine dendriticherappresentano l’apparato post-sinaptico del sistema nervoso centrale. Dette spinesono ritenute, infatti, le strutture recettive post-sinaptiche specifiche dell’impulsonervoso. Esse sono assenti nei dendriti dei neuroni corticali alla nascita e si svi-luppano lentamente nel periodo post-natale in rapporto alle situazioni ambien-tali. Numerosi studi sono stati condotti sull’influenza della deprivazione visiva edella sovrastimolazione visiva sullo sviluppo post-natale delle spine sinaptichenel corpo genicolato laterale e nella corteccia occipitale.
Per quanto attiene alla deprivazione visiva, Globus (37) afferma essere stata ri-petutamente osservata da vari AA. una riduzione numerica delle spine in animaliallevati al buio dopo la nascita. Valverde (38), studiando la corteccia visiva di topiallevati al buio fin dalla nascita, ha visto che le spine sinaptiche non si sviluppanosenza luce, e che lo sviluppo di alcune spine in qualche neurone piramidale dellacorteccia visiva può aversi dopo esposizione alla luce persino quando tale espo-sizione è ritardata più di 20 giorni dopo la nascita. Globus e Scheibel (39) hannonotato nel coniglio in analoghe condizioni sperimentali spine morfologicamente
Marcello Aragona, Francesco Aragona
66
anormali piuttosto che una riduzione del loro numero. Le spine erano partico-larmente deformate lungo il dendrite apicale delle cellule piramidali, mentre nonerano interessati i dendriti delle cellule stellate. Hubel e Wiesel (40) hanno dimo-strato che la sutura palpebrale nel gatto, effettuata per breve tempo (almeno tregiorni) fra la quarta e la sesta settimana di vita produce atrofia cellulare nel corpogenicolato laterale. Essi affermano che durante il periodo più critico per le mo-dificazioni fisiologiche della corteccia persino pochi giorni di deprivazione rea-lizzano evidenti alterazioni a livello genicolato. Anche dopo prolungataesposizione alla luce normale e parziale ripristino comportamentale i neuroni delnucleo genicolato laterale appaiono ancora ipotrofici ed ipocromici. Burke e Hay-how (41) hanno visto che se la deprivazione inizia dopo i tre mesi di età non siriscontrano significative alterazioni del nucleo genicolato laterale.
Per quanto attiene alla sovrastimolazione sensoriale, Holloway (42) ha osser-vato nel ratto un aumento delle ramificazioni dendritiche nei neuroni dello stratostellato della corteccia occipitale. Volkmar e Greenough (43) hanno eseguito unconteggio comparativo delle diramazioni dendritiche a livello delle cellule pira-midali del II strato, delle cellule piramidali del IV strato, delle cellule stellate delIV strato e delle cellule piramidali del V strato della corteccia occipitale di rattiesposti ad ambiente ricco di stimoli, di ratti di controllo della stessa nidiata man-tenuti in ambiente normale e di ratti, anch’essi della stessa nidiata, mantenuti inisolamento. Ogni singolo neurone era analizzato per il numero di diramazionidendritiche e per l’ordine delle diramazioni, essendo considerate di I ordine lediramazioni originanti direttamente dal corpo cellulare, di II ordine le dirama-zioni originanti da quelle di I ordine, e così via fino al V ordine. Hanno visto chenegli animali mantenuti in ambiente ricco di stimoli vi era, rispetto alle due seriedi controlli, una più spiccata neoformazione di ramificazioni dendritiche. La dif-ferenza era particolarmente significativa per le diramazioni di III, IV e V ordine,per cui gli AA. hanno affermato che la possibilità di comparsa di ramificazionidendritiche di alto ordine è maggiore nell’ambiente ricco di stimoli.
L’aumentata stimolazione ambientale si riflette, oltre che sulle diramazionidendritiche, anche sulle spine dendritiche, le quali sembrano aumentare di nu-mero o almeno essere stimolate ad una crescita più rapida. Schapiro e Vukovich(44) hanno visto un evidente aumento delle spine dendritiche nei neuroni dellacorteccia acustica e visiva di ratti allevati dalla nascita per otto giorni in ambientericco di stimoli. E’ interessante rilevare che l’aumento numerico delle spine ri-corre senza modificazioni delle dimensioni del corpo cellulare o della lunghezzadei dendriti apicali o laterali e che esso interessa maggiormente le ramificazionidendritiche basilari ed oblique; mentre partecipano di meno le spine delle bran-che terminali e del dendrite apicale. Secondo gli AA., tale reperto suggerisce che
67
Fisiopatologia dello stress
la stimolazione sensoriale durante il periodo della crescita delle spine accelera inmodo differenziale la maturazione dei loci sinaptici sulle formazioni dendritichedelle cellule piramidali. Globus e coll. (45), in ratti analogamente trattati per 30giorni dopo lo svezzamento, hanno rilevato che la densità delle spine aumentavalungo i dendriti basali, obliqui e terminali, per cui hanno ritenuto che il repertofosse espressione d’una aumentata “domanda d’integrazione della complessa in-formazione multisensoriale”. West e Grenough (46), misurando lo spessore post-sinaptico, hanno visto che esso nel III strato della corteccia occipitale di rattisovrastimolati sensorialmente era maggiore di circa il 10% rispetto ai valori ri-scontrati nel controlli isolati.
La sovrastimolazione sensoriale condiziona anche proliferazione gliale. Dia-mond e coll. (47) hanno osservato in ratti esposti ad ambienti ricchi di stimoli sen-soriali aumento del rapporto glia/neuroni, con un incremento del 14% dellanevroglia dovuto principalmente a proliferazione di astrociti e di oligodendro-citi. In analoghe condizioni sperimentali, Altman e Das (48) hanno constatatoreperti simili, connessi particolarmente con proliferazione di glia fibrosa nellaneocorteccia. Brazovskaya (49) ha descritto, come risultato della stimolazione vi-siva, un aumento della glia perineurale e pericapillare, nonché della densità dellarete capillare a livello del nucleo genicolato laterale e del IV strato della cortecciavisiva.
A proposito di dette modificazioni, è da condividere pienamente l’opinione diDiamond e coll. (47) quando affermano trattarsi di reperto che va messo in rela-zione con l’aumentata richiesta funzionale derivante, nelle condizioni sperimen-tali predette, da uno più esteso impegno delle connessioni sinaptiche e da più altometabolismo encefalico. Simili osservazioni sono state fatte da altri AA. (50, 51).Gli astrociti, in particolare, come già accennato nel precedente capitolo, hanno unruolo essenziale nel metabolismo encefalico e segnatamente nel trasporto degliaminoacidi, nel trasporto ionico, nell'inattivazione dei mediatori chimici (52), nelmetabolismo dei fosfolipidi (53), nella funzione escretoria essendo il sistema ner-voso centrale sprovvisto di rete linfatica. Si è anche visto che gli astrociti inter-vengono nell’elaborazione e nella dismissione di interleuchina-1, la quale in vitroè in grado di stimolare nelle cellule ipofisarie la secrezione di ACTH, STH, LH,e la liberazione di NO (54, 55) ed in vivo di agire sull’ipofisi tramite i neuroniCRF ipotalamici. Poiché la regione ipotalamica è ricca di astrociti (56), si ritieneche essi siano capaci di rilasciare localmente l’interleuchina-1 secreta, per il fattoche nell’ipotalamo è stata dimostrata la presenza di recettori per la stessa inter-leuchina (57, 58). Si è ancora visto che gli astrociti intervengono pure nella ri-sposta immunitaria (59). Gli astrociti, pertanto, come già detto nel precedentecapitolo, agiscono con meccanismo paracrinico, nel senso, cioè, che i prodotti di se-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
68
crezione cellulare, liberandosi dal corpo cellulare e riversandosi negli spazi inter-stiziali, esercitano direttamente, senza alcuna intermediazione, la loro azione bio-logica sulle cellule viciniori.
Bibliografia1. Platone: Tutti gli Scritti. Rusconi, Milano 1992.2. Lutz T., Storia delle lacrime. Aspetti naturali e culturali del pianto. Feltrinelli, Milano,
2002.3. Haeringer N.S., Clinical Biochemistry of Tears. Survey Ophthalmology 26, 84,
1981.4. Langseth M., Crying: The Mystery of Tears. Harper&Row, New York, 1985.5. Ficca G., Salarulo P., Lo sbadiglio dello struzzo (Psicologia e biologia dello sbadi-
glio). Bollati Boringhieri, Torino, 2002.6. Darwin C., L’Origine dell’Uomo. UTET, Torino, 1871.7. Tucker D.M., Lu P., Pribram K.H:, Social and Emotional Self-Regulation. In: Graf-
man J. et al., Structure and Function of the Human Prefrontal Cortex. Ann. NewYork Acad. Sci. Vol. 769, 1995.
8. Damasio A., L’Errore di Cartesio. Adelphi, Milano, 1995.9. Euler von V.S., Lundberg V., Effect of flying in the epinephrine excretion in air forcepersonnel. J. Appl. Physiol. 6, 551, 1954.
10. Elmadjian F., Hope J.M., Lamson E.T., Excretion of epinephrine under stress. Rec.Progr. Hormon Res. 14, 513, 1958.
11. Kagan A.R., Levi L., Health and environment-psychosocial stimuli. A review. The La-boratory for Clinical Stress Research. N.27, dec. 1971.
12. Levi L., Sympatho-adrenomedullary responses to emotional stimuli: methodologic, physio-logic and pathologic considerations. In: Bajusz E., Clinical Neuroendocrinology. Kar-ger, Basel, 1967.
13. Tyler D.B., Mark W., Goodman J., Effect of wakefulness on the urinary excretion of17-ketosteroids. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 62, 38, 1946.
14. Hasselman M., Schaff G., Metz B., Influence respectives du travail, de la tempéra-ture ambiant, et de la privation de sommeil sue l’excrétion urinaire de catecholamines chel’homme normal. Cmpt. Rend. des Séances de la Soc. de biol. et ses fiales 154,197, 1960.
15. Froberg J., Karlsson C.G., Levi L., Libberg L., Circadian variations in performance,psycholo-gical ratings, catecholamine excretion, and urine flow during prolonged sleep depri-
69
Fisiopatologia dello stress
vation. Symposium on effect of Diurnal Rhytm and Loss of Sleep on HumanEfficiency. Strasbourg, 13-17 luglio 1970.
16. Karki N., Excretion of noradrenaline and adrenaline in different age groups. Acta Phy-siol. Scand. Uppl. 114, 30, 1955.
17. Euler von U.S., Hellner-Bjorkman S., Orwen I., Diurnal variations in the excre-tion of free and conjugated noradrenalin in urine from healthy subjects. Acta Physiol.Scand. Suppl. 118, 10, 1955.
18. Lehman G., Michaelis H.: Adrenalin und Leistungfähigkeit. IV Mitt. Zschrf. Ar-beitsphysiol. 12, 305, 1943.
19. Maynert E.W., Levi L., Stress induced release of brain norepinephrine and its inhibi-tion by drugs. J. Pharmacol. Exper. Ther. 143, 90, 1964.
20. Bliss E.L., Zwanziger J., Brain amines and emotional stress. J. Psychiat. Res. 4, 189,1966.
21. Ordy J.M., Samorajski T., Schroeder D., Concurrent changes in hypothalamic and car-diac catecholamine levels after anesthetics, tranquillizers and stress in subhuman primate.J. Pharmacol. Exper. Ther. 152, 445, 1966.
22. Barchas J.D., Freedman D., Response to physiological stress. Biochem. Pharmacol.12, 1232, 1963.
23. Matussek M., Ruther E., Ackenheil M., Giese J., Amine metabolism in the centralnervous system during exhaustion after swimming and the influence of antidrepessants onthis syndrome. Excerpta Med. Int. Cong. Ser. 122, 70, 1967.
24. Gordon R., Spector S., Sjoerdsma A., Udenfriend S., Increased synthesis of no-repinephrine and epinephrine in the intact rat during exercise and exposure to cold. J. Phar-macol. Exp. Ther. 153, 440, 1966.
25. Pujol I. P., Mouret L., Jouvet M., Glowinski J., Increased turnover of cerebral no-rephinephrine during rebound of paradoxical sleep in the rat. Science 159, 112, 1968.
26. Thierry A.M., Javoy F., Glowinski J., Kety S.S., Effects of stress on the metabolismof norepinephrine, dopamine and serotonine in the central nervous system of the rat. I)Modifications of norepinephrine turnover. J. Pharmacol. Exper. Ther. 163, 163, 1968.
27. Thierry A.M., Blanc G., Glowinski J., Effect of stress on the disposition of catecho-lamines localized in various intraneuronal storage forms in the brain stem of the rat. J.Neurochem. 18, 449, 1971.
28. Glowinski J., Some new facts about synthesis, storage, and release processes of monoaminesin the central nervous system. In: Snyder S.H., Perspectives in Neuropharmaco-logy. Oxford Univ. Press, New York, London, Toronto, 1972.
29. Curzon G., Green A.R., Effects of immobilization on the rat liver tryptophan pyrro-lase and brain 5-hydroxytryptamine metabolism. Brit. J. Pharmacol. 37, 689, 1969.
30. Thierry A.M., Fekete M., Glowinski J., Effects of stress on the metabolism of no-radrenaline, dopamine and serotonine (5HT) in the central nervous system of the rat.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
70
II)Modifications of serotonin metabolism. Eur. J. Pharmacol. 4, 384, 1968.31. Corrodi H., Fuxe K., Hokfelt T., A possible role played by central monoamine neu-rones in thermoregulation. Acta Physiol. Scand. 71, 224, 1967.
32. Reid W:D., Volicer L., Smookler H., Rodie B.B., Brain amines and temperature re-gulation. Pharmacology 1, 329, 1968.
33. Tagliamonte A, Tagliamonte P., Perez-Cruet J., Stern S., Gessa G.L., Effect ofpsychotropic drugs on tryptophan concentration in the rat brain. J.Parmacol. Exper. Ther.177, 475, 1971.
34. Anokhina I., Zabrodin G., Svirinovsky J.A., General mechanism of developmentof psychopathological reactions under emotional stress. Clinical and experimental research.In: Levi L., Society, Stress and Disease. Vol. II., Oxford Univ. Press. New York,Toronto, 1975.
35. Snyder S.H., Taylor K.M., Histamine in the brain: a neurotrasmitter? In: SnyderS.H., Perspectives in Neuropharmacology. Oxford Un. Press, New York, Lon-don, Toronto, 1972.
36. Bennet E.L., Diamond M.C., Krech D., Rosenzweigh M.R., Chemical and ana-tomical plasticity of brain. Science 146,610, 1964.
37. Globus A., Brain morphology as a function of presynaptic morhology and activity. In:Riesen A.H., The Developmental Neuropsychology of Sensory Deprivation.Academic Press , New York, London, 1975.
38. Valverde F., Rate and extent of recovery from dark rearing in the visual cortex of themouse. Brain Research, 33, 1,1971.
39. Globus A., Scheibel A.B., The effect of visual deprivation on cortical neurons: Golgistudy. Experimental Neurolology, 19, 331, 1967.
40. Hubel D.H., Wiesel T.N., The period of susceptibility to the physiological effect of uni-lateral eye closure in kittens. J.Physiol. 206, 419, 1970.
41. Burke W., Hayow W.R., Disuse in the lateral geniculate nucleus of the cat. J. Physiol.194, 495, 1968.
42. Holloway R.L. jr., Dendrite branching: Some preliminay results of training and com-plexity in the rat visual cortex. Brain Research, 2, 393, 1966.
43. Volkmar F. R., Greenough W.T., Rearing complexity affects branching of dendrites inthe visual cortex of the rat. Science 176, 1445, 1972.
44. Schapiro S., Vukovic K.R., Early experience effects upon cortical dendrites: a proposedmodel for development. Science 167, 292,1970.
45. Globus A., Rosenzweig M.R., Bennett E.L., Diamond M.C., Effects of diffe-rential experience on dendritic spine counts in rat cerebral cortex. J. of Comparative andPhysiological Psychology . 82, 175, 1973.
46. West R.W., Greenough W.R., Effect of environmental complexity on cortical synapsesof rats. Preliminary results. Behavior Biol. 7, 1, 1972.
71
Fisiopatologia dello stress
47. Diamond M.C., Law F., Rhodes H., Lindner B., Rosenzweig M.R., Krech D.,Bennett E.L., Increases in cortical depth and glia numbers in rats subjected to enriched en-vironment. Jour. Comparative Neurology, 128, 117, 1966.
48. Altman J., Das G.D., Autoradiographic examination of the effects of enriched envi-ronment on the rate of glial moltiplication in the adult rat brain. Nature, 204, 1161,1964.
49. Brazovskaya F.A., Quantitative changes in the structure of the visual analyzer due tofunctional deafferentation. Zhurnal Wysshei Nervoi Deiatel’nosti, 17, 548, 1967.
50. Bernton E.W., Beach J.E., Holaday J.W., Smallridge R., Fein H.G., Release ofmultiple hormones by a direct action of Interleukin-1 on pitutary cells. Science 238, 519,1987.
51. McCann S.M., Karanth S., Kamat A., Dees W.L., Lyson K., Gimeno M., Ret-tori V., Induction of cytokines of the pattern of pituitary hormone secretion in infection.A review. Neuroimmuno-modulation 1, 2, 1994.
52. Farrar W.L., Kilian P. L., Ruff M.R., Hill G.M., Pert C.B., Visualization and cha-racterization of interleukin-1 receptors in the brain. J. of Immunol. 139, 459, 1987.
53. Koenig J., Presence of cytokines in the hypothalamic-pituitary axis. Progr. Neuroen-docrinim munol. 4, 143, 1991.
54. Benveniste E.N., Heneycutt B.S., Shrikant P., Ballestas M.E., Second messangersystem in the regulation of cytokines and adhesion molecules in the central nervous system.Brain Behav. Immun. 9(4), 304, 1995.
55. Lee S.C., Dickson D.W., Brosnan C.F., Interleukin-1, Nitric oxide and reactive astro-cytes. Brain Behav. Immun. 9 (4), 345, 1995.
56. Schechter G., More work for astrocytes. Prog. Neuroendocrinimmunol. 3, 153,1990.
57. Sapolsky R.M., Krey L.C., McEwen B.S., Prolonged glucorticoid exposure reduceshippo-campal neuron number: implication for aging. J. Neuroscience 5, 1222, 1985.
58. Sapolski R.M., Lewis C.K., McEven B.S., Neuroendocrinology of stress and aging:the glucocorticoid cascade hypothesis. Endocrin. Rev. 7, 285, 1986.
59. Sapolski R.M., Plotsky P.M., Hypercorticosolism and its possible neural bases. Biol.Psychiat. 27, 937, 1986.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
72
Capitolo IV
Istofisiologia dello stress
1. La casistica di studioCome accennato nella premessa, le nostre indagini sono state condotte su sog-
getti venuti a morte in conseguenza di stress di vario genere: traumatismi di di-versa natura, soprattutto da incidenti stradali, suicidio, avvelenamenti, asfissie,processi morbosi da causa patologica naturale con prolungate ospedalizzazioni,decessi durante interventi chirurgici, malattia da ustione, assideramento, tossico-dipendenze, vittime di omicidio.
Inizialmente le nostre indagini furono prevalentemente orientate allo studiodelle ghiandole surrenali, tenuto conto di quanto detto in precedenza circa il lorocostante interessamento in qualsiasi condizione di emergenza dell’organismo, se-condo le primarie ricerche di Selye (1).
Queste indagini furono condotte su 713 casi, ripartiti come segue: 1) 547 casi di omicidio (su un totale di 667 casi da noi esaminati: da notizie ri-
portate dal quotidiano “La Stampa”, pag. 18 del 21 maggio 2008, gli omicidinella guerra di Reggio Calabria tra la famiglia dei de Stefano e quella degliImerti è costata la vita a 966 persone tra il 1985 e il 1991). Nei casi da noi stu-diati il delitto fu effettuato in prevalenza con armi da sparo su soggetti di etàgiovane o media (al di sotto dei 40 anni), quasi esclusivamente di sesso ma-schile. In questo gruppo sono compresi:
a) due minori (un maschio e una femmina, rispettivamente di 10 e 11 anni, uccisidopo violenza sessuale, il primo con violento trauma cranico con un sasso; laseconda con un colpo di pistola alla testa);
b) una donna di 31 anni uccisa con un colpo di pistola dall’amante, il quale su-bito dopo si uccise con la stessa arma;
c) tre donne attempate (ultrasettantenni) decedute dopo violenza sessuale, duecolpite in più parti con arma bianca e pressoché totale dissanguamento, e l’al-tra con meccanismo inibitorio da stimolazione vagale attraverso il plesso utero-vagale di Frankenhauser;
d) due adulti uccisi con colpi di bastone alla testa durante il sonno.Solo in 6 dei suddetti 547 casi la morte non fu istantanea o molto rapida ed av-
venne rispettivamente dopo 1 ora, 4 ore, 12 ore, 24 ore, 60 ore, 7 giorni.
2) 95 casi di suicidio compiuto da soggetti di età compresa fra 14 e 84 anni (solo12 di sesso femminile) con varie dinamiche: annegamento in mare, impicca-mento, armi da sparo con unico colpo in parti corporee vitali, precipitazione
73
dall’alto, investimento ferroviario (con morte rapida o istantanea; in alcuni casidopo 1-3 giorni) e per avvelenamento (esteri fosforici, stricnina, acido muria-tico, veleni nervini ad azione depressiva centrale, digitale, cianuro di sodio, os-sido di carbonio) con morte rapida nei casi da stricnina, cianuro di sodio,ossido di carbonio, più tardiva negli altri casi (1-2 giorni); solo in un caso lamorte avvenne dopo 9 giorni.
3) Ulteriori 71 casi, di cui ai seguenti paragrafi, sono stati utilizzati come controlliperché la loro condizione di stress era stata confermata dal riscontro nei sur-reni delle modificazioni istomorfolo-giche comparenti negli stress sperimen-tali, come compiutamente descritte dal Tonutti (2) sia per la corticale che perla midollare, e per quest’ultima anche dall’Allara (3):
a) 32 casi venuti a morte per traumatismo cranico (19 da incidenti stradali, 3 dacorpi contundenti, 10 da precipitazione o caduta: in 31 di questi casi la mortesi verificò dopo 2-61 giorni dal trauma ed in uno, venuto a morte dopo 36ore, vi erano stati esiti di altro trauma cranico verificatosi 3 anni prima); sonostati esclusi i casi in cui la morte era avvenuta istantaneamente. Nella scelta diquesta casistica si era tenuto anche conto della conoscenza che nella medesimaricorrevano due gravi fattori di stress, il trauma cranico in sé e per sé e la de-genza ospedaliera, di solito protratta.
b) 33 casi di giovani tossicodipendenti, di entrambi i sessi, ma prevalentementedi sesso maschile, deceduti rapidamente per overdose (30 da eroina, 3 da co-caina): l’utilizzazione di questo gruppo è connessa alla conoscenza che la di-pendenza dalla droga, come già accennato, essendo di solito parossistica,genera condizioni di stress cronico in rapporto alla necessità di reperire la dosequotidiana per evitare le crisi di astinenza, i mezzi economici, non di rado colricorso al reato, per il suo acquisto, che è sempre illecito, e spesso all’esigenzadi dissimulare il proprio stato nell’ambito familiare e sociale, ovvero, al con-trario, di pretendere in tale contesto aiuti economici.
c) 1 caso di pilota di aereo privato (soggetto di anni 27) deceduto in modo istan-taneo per precipitazione.
d) 1 caso di morte lenta (circa tre ore) da politraumatismi (soggetto di a. 26) percaduta, durante una battuta di caccia, in terreno scosceso, accidentato ed iso-lato, in stato di grave stress psicofisico per l’impossibilità di compiere qualsiasimovimento e di chiedere aiuto.
e) 1 caso di morte istantanea per investimento ferroviario accidentale (soggettodi anni 28 rimasto incastrato con un piede in uno scambio di rotaie mentre at-traversava i binari presso una stazione ferroviaria poco prima del transito di unconvoglio che non doveva sostare in quella stazione).
Marcello Aragona, Francesco Aragona
74
f) il caso di un bambino deceduto in pochi minuti per annegamento da caduta ac-cidentale in una vasca di irrigazione.
g) il caso di un bambino di 2 anni deceduto al termine di un intervento chirur-gico correttivo di complessa malformazione cardiaca durato 14 ore: in ane-stesia generale trattato terminalmente con dosi generose di noradrenalina perprogressiva bradicardia conclusasi con l’arresto cardiaco irreversibile.
h) 1 caso di individuo di 28 anni deceduto per meningite meningococcica conmarcato edema cerebrale, particolarmente a livello della formazione retico-lare bulbo-pontina: la sindrome non era stata diagnosticata in vita perché erainiziata con uno stato confusionale associato a manifestazioni aggressive, se-guito da uno stato di coma afebbrile senza segni meningei manifesti, per laquale sindrome era stato ricoverato in ospedale ove venne a morte dopo circa1 giorno.
A proposito della casistica sopra elencata riteniamo opportuno richiamare an-cora l’attenzione sul fatto che le motivazioni che stanno alla base dello stress nellevittime di omicidio e quelle che coinvolgono i suicidi ed i responsabili di omici-dio e poi di suicidio sono sostanzialmente diverse.
Nel primo caso si tratta di motivazioni prevalentemente di origine esterna con-nesse al timore o addirittura alla paura o al terrore di essere sotto la continua mi-naccia, anche per la vita, di competitori nelle attività delinquenziali esimultaneamente anche nel mirino delle forze dell’ordine specie quando trovansinello stato di latitanza. Nei soggetti uccisi nello stato di detenzione era soprattuttoquesta la sorgente dello stress.
Nei suicidi, invece, le motivazioni sono quasi esclusivamente interne, connessea processi morbosi per lo più oligosintomatici o addirittura asintomatici, i quali,tuttavia, sono idonei a determinare un abbassamento più o meno marcato dellasoglia sensoriale al punto da accrescere la risonanza soggettiva di stimolazioni emozionaliche prendono lo spunto da fatti esteriori spiacevoli che nei soggetti normali nonsono idonei ad incidere sulla psiche e sul comportamento (vedi capitolo IX.1della parte seconda).
Per quanto riguarda lo stress dei tossicodipendenti, come già accennato, tenutoconto della distorsione della loro personalità, le fonti dello stress sono sia endo-gene, connesse alla tossicodipendenza in sé per sé, sia esogene, connesse all’am-biente sociale in cui vivono e alla impellente necessità di reperire la dosequotidiana utile per evitare l’insorgenza delle crisi di astinenza.
75
Fisiopatologia dello stress
2. Descrizione ed interpretazione dei reperti istologici osservati
2.1. Le ghiandole surrenaliCome già detto la partecipazione delle ghiandole surrenali nelle condizioni di
emergenza dell’organismo è costante nell’individuo normale ed agevolmente ap-prezzabile non solo dal punto di vista biochimico nel vivente, ma anche dal puntodi vista istologico ed istochimico nel cadavere e negli animali da esperimento,come dimostrato dalla magistrale descrizione dell’istofisiologia di queste ghian-dole redatta da Emil Tonutti nel Trattato di Anatomia Patologica del Kaufman (2),sia per quanto attiene alla corteccia, che alla midollare. Per quest’ultima è soddi-sfacente anche la descrizione redatta da Allara nel Trattato di Anatomia UmanaNormale di Testut e Latarjet (3).
Per quanto riguarda la corticale, Tonutti fa presente che la stimolazione conACTH determina nelle cellule della fascicolata una frammentazione dei lipoidicitoplasmatici (“Lipoidaufsplitterung” di Dietrich), per cui i medesimi, che costitui-scono gli ormoni steroidi, appaiono sotto forma di gocciole assai fini ed inoltreche, sebbene dosi massive di ACTH di breve durata siano idonee a determinareuna riduzione nel contenuto in acido ascorbico ed in esteri di colesterolo, i li-poidi sudanofili non mostrano riduzioni quantitative, pur se vi sia un’evidente ri-duzione dei lipoidi birifrangenti. Tali effetti si verificano anche nelle situazioni distress, appunto perché in queste situazioni vi è un aumento della secrezione diACTH da parte dell’ipofisi sotto lo stimolo neurormonale ipotalamico, come giàdetto. Quando la stimolazione preipofisaria è protratta, afferma Tonutti, i lipoidi corti-cali diminuiscono progressivamente fino a quando le cellule ghiandolari diventanocompletamente prive di sostanze sudanofile e di lipoidi birifrangenti, per cui illoro citoplasma appare compatto e scuro. Per quanto riguarda la midollare sur-renale lo stesso Tonutti, riferendosi ad osservazioni di Staemmler, asserisce cheall’esame istologico le cellule cromaffini, secretrici delle catecolamine, mostranomarcata vacuolizzazione del citoplasma come segno dell’aumentata attività secreto-ria. Allara (3) asserisce che la midollare risponde sperimentalmente in modo im-mediato agli stimoli stressanti. Egli scrive: “Anche ad una semplice esposizioneal freddo o ad un trauma psichico la ghiandola risponde immediatamente conuna scarica adrenalinica; è quindi facile studiare l’aspetto istologico della fase diescrezione, che può essere compendiato nel seguente modo: aumento delle cel-lule cilindriche e loro polarizzazione intorno a grossi sinusoidi; emissione dei lorogranuli nei capillari con comparsa di materiale cromaffine nel lume di questi; au-mento della basofilia citoplasmatica, aumento del volume del nucleo, diminu-zione della sua reattività al Feulgen, ipertrofia dell’apparato nucleolare. La finedel ciclo escretivo è segnata dalla comparsa di cellule chiare, alle quali può asse-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
76
gnarsi il significato, come agli elementi ad eguale struttura esistenti in altre ghian-dole endocrine, di cellule esaurite da intense ondate escretorie; l’assenza di ma-teriale basofilo citoplasmatico ne è appunto una prova. Durante le fasi diiperattività compaiono anche numerose cellule ipercromatiche, legate forse a fe-nomeni di secrezione olocrina, come si verifica per le cellule colloidi della tiroide,e probabilmente indicanti che la cellula, sotto lo stimolo escretore, è più o menodanneggiata nella sua vitalità. La fase di ipoattività è invece contrassegnata dallapresenza di numerose cellule poliedriche e dalla scomparsa dei tipici sinusoidi,sostituiti da esili capillari comuni. Nelle cellule poliedriche i fenomeni di sintesiormonica sono ridotti, come lo dimostrano la scarsezza dei granuli cromaffini ele caratteristiche morfologiche di scarsa attività cellulare (volume citoplasmaticoe nucleare ridotti, ergastoplasma pochissimo sviluppato, nucleolo assente….)”.
Tonutti (2) afferma che la simpaticectomia totale o il blocco farmacologicodel simpatico non impediscono la normale produzione e dismissione di ACTHda parte dell’ipofisi e di conse-guenza che non vi sono interferenze sull’attiva-zione da stress della corteccia surrenale.
Al riguardo dobbiamo ricordare che vari farmaci neurotropi, in particolarequelli che esplicano azione inibente sulla formazione reticolare e sulla cortecciacerebrale, sono idonei ad impedire la risposta surrenalica da stress. Tale azione èevidente per i barbiturici (5-10). In ricerche sperimentali su cavie e ratti condotteda uno di noi (4) si confermò l’azione inibente dei barbiturici sui nuclei ipotala-mici e sulla risposta della corteccia surrenale allo stress da immobilizzazione for-zata su assi di legno. Nella midollare surrenale, invece, si notò riduzione dei granulicromaffini, come se la medesima rispondesse allo stress medesimo e all’azionetossica dei veleni somministrati. Tale effetto inibente sull’asse ipotalamo-ipofisi-corteccia surrenale non fu osservato con altri veleni neurotropi come la morfina,la reserpina, la cloropromazina, il meprabamato, la stricnina. Inoltre un repertodi blocco funzionale dell’asse suddetto fu osservato da uno di noi in una bambinadi 18 mesi deceduta per avvelenamento accidentale da cloroprocainamide ed inratti avvelenati con la stessa sostanza, nonché su tre casi di avvelenamento acutoda esteri fosforici ad alte dosi ed in un caso di avvelenamento accidentale da cu-rarico di sintesi (Laudolissin) (11,12,13). Si è visto anche che le lesioni traumati-che od infiammatorie producenti interruzione dei rapporti ipotalamo-ipofisari olesioni necrotizzanti della preipofisi impediscono la risposta corticosurrenale allostress (v. il minore di 10 anni ucciso mediante massivo trauma cranico dopo vio-lenza sessuale: par.1, lett.a della casistica; il caso del soggetto ventottenne dece-duto per meningite acuta meningococcica con marcato edema cerebrale, speciedel tronco encefalico: par. 3, lett.h; oltre vari casi uccisi con colpi di armi da sparoalla testa con danni ipotalamici ed ipofisari).
77
Fisiopatologia dello stress
Per quanto attiene alle indagini sulla casistica in precedenza da noi elencata, aparte il gruppo dei suicidi, non sono state osservate sostanziali differenze neiquadri istologici e istochimici surrenalici attinenti ai vari gruppi della predetta ca-sistica, compresi i controlli ed esclusi i casi di impossibile trasmissione degli im-pulsi dall’ipotalamo all’ipofisi per lesioni di quest’ultima o ipotalamiche, nonchénei casi di morte inattesa ed istantanea, laddove gli effetti dello stress manca- noo sono esclusivamente limitati alla midollare, il che è possibile anche quando alblocco farmacologico ipotalamo-preipofisario e del sistema simpatico segue unasomministrazione terapeutica generosa di noradrenalina (n.3, par.g della nostra ca-sistica).
2.1.1. La midollare surrenaleImmagini di perfetta normalità del tessuto cromaffine della midollare surre-
nale umana sono oggi difficilmente reperibili rispetto a 30-40 anni fa: ciò de-v’essere attribuito al mutamento delle condizioni di vita della società moderna,propensa di più ai valori del consumismo (cioè all’avere di Fromm: 14), piutto-sto che alla cultura e ad una sana condotta morale (cioè all’essere di Fromm). Tantoche siamo costretti ad utilizzare come immagini normali della ghiandola (Fig. 1)un reperto del 1971, relativo ad un individuo di 32 anni ucciso a colpi di pistola,con morte istantanea, da un collega d’ufficio che presentava segni di alienazionementale e senza che la vittima avesse avuto il minimo sospetto di quanto stava peraccadergli. Le cellule cromaffini della ghiandola normale umana hanno citopla-sma ampio, compatto, lievemente basofilo, cosparso di granuli ben visibili anchecon i comuni metodi di colorazione, specie con la reazione al PAS, ma notoria-mente meglio apprezzabili nei pezzi fissati in liquidi contenenti sali di cromo; ilnucleo è chiaro con qualche nucleolo.
Nella casistica esaminata sono state osservate le seguenti modificazioni cito-logiche midollari:
a) Rarefazione più o meno marcata dei granuli cromaffini in gruppi cellularidelimitati ed irregolarmente sparsi. Ovvero estesa a tutto il contesto della mi-dollare, senza apprezzabili variazioni del volume cellulare: il citoplasma apparevacuolizzato o addirittura trasformato in vescicole a contorni irregolari, a limitiindistinti, a volte afflosciato sul nucleo che non appare modificato. I nucleoli sonoben riconoscibili. L’interstizio è rigonfio come da edema. Le cellule ghiandolarisono addossate ai capillari, per lo più fortemente dilatati, apparendo così meglioidentificabili rispetto alle condizioni di riposo funzionale (Fig. 2,3).
Il reperto è tipico di attivazione funzionale acuta: in tali casi, se si è accertato,sulla base complessiva dei dati necroscopici e microscopici degli altri organi o di
Marcello Aragona, Francesco Aragona
78
testimonianze attendibili, che la morte è avvenuta in modo istantaneo o molto ra-pido (qualche minuto), il reperto è da giudicare preesistente all’evento mortale edattribuibile all’accadimento di uno stress improvviso ed inatteso (paura, terrore)che ha preceduto la morte; se questa non è avvenuta in modo istantaneo o moltorapido, non si può escludere che il reperto sia invece da attribuire allo stato ago-nico che l’ha preceduta.
b) Degranulazione totale, fine vacuolizzazione e riduzione di volume delle cel-lule ghiandolari, i cui nuclei presentano cromatina addensata, assumendo aspettoipercromico con maschera-mento dei nucleoli: tali immagini sono uniformi intutto il contesto della midollare (Fig. 4).
Il reperto è tipico di attivazione funzionale subacuta: è quadro comune ai pro-cessi morbosi o traumatici o di disagio che comportano continua immissione incircolo di catecolamine (degenze protratte prima dell’evento mortale, morte perassideramento, per malattia da ustione, stati emotivi intensi e prolungati prece-denti al decesso).
c) Riduzione di volume delle cellule cromaffini, che hanno citoplasma com-patto, debolmente basofilo, povero di granuli, nucleo a cromatina più densa e piùscura fino a rendere invisibili i nucleoli; il nucleo di tali cellule non di rado appareipertrofico ed ipercromico, di forma regolare o a contorni irregolari; compaionoanche cellule binucleate, sebbene raramente, e talvolta note di lisi cellulare: anchequeste immagini sono uniformi in tutto il contesto della midollare (Fig. 5).
Il reperto è tipico di attivazione funzionale cronica: è quadro che nel suo in-sieme indica situazioni psichiche abnormi comportanti continua e prolungata im-missione in circolo di catecolamine, in relazione con stimoli ambientali odendogeni (è stato osservato anche nel soggetto di cui al par.3, lett. g della casi-stica). Al quadro funzionale qui considerato, come anche a quello del paragrafoprecedente, può sovrapporsi, in relazione alla modalità della morte, quello del-l’attivazione funzionale acuta: sovrapposizione solitamente assente nei suicidi(vedi capitolo IX.1 della parte seconda), frequente nei tossicodipendenti dece-duti per overdose e nelle vittime d’omicidio: in quest’ultimo caso di regola as-sente quando la vittima sia stata colta di sorpresa o, altrimenti, quando la rispostaacuta sia impedita da lesioni del sistema nervoso centrale, come s’è verificato nelgià menzionato caso di cui al par. 3, lett. h.
Il rilievo o meno di detta attivazione funzionale acuta, isolata ovvero sovrap-posta a quadri di preesistente attivazione funzionale subacuta o cronica, ha in-dubbio valore diagnostico al fine di stabilire se la vittima sia stata colta di sorpresa(nel qual caso mancano i segni di attivazione funzionale acuta), ovvero si sia ac-corta tempestivamente (cioè in tempo utile per il manifestarsi d’una emozione di
79
Fisiopatologia dello stress
paura o di terrore: tempo brevissimo, come già detto, per la trasmissione dello sti-molo partente dall’amigdala) dell’imminente aggressione. Comunque in entrambele condizioni deve essersi trattato di morte istantanea o rapidissima per consen-tire l’esclusione che i quadri suddetti siano connessi allo stato agonico che ha pre-ceduto la morte. Questi rilievi ci sono stati assai utili in 22 casi di omicidio neiquali l’assenza di attivazione funzionale acuta ci ha consentito di concludere chele vittime erano state colte di sorpresa. In altri casi vi fu il tempo per la comparsadi segni di attivazione acuta, anche se limitata a pochi gruppi cellulari cromaffini,riferibili allo stato di terrore connesso all’improvvisa consapevolezza di quantostava per accadere, senza avere la possibilità di opporre qualsiasi resistenza. Ciòsi è visto in un uomo di anni 50 ucciso con 16 colpi di pistola calibro 9 (Fig. 6) ein un culturista di 26 anni, fisicamente assai prestante, ucciso con un colpo di pi-stola esploso a contatto sulla fronte mentre stava per sedersi al posto di guidadella sua autovettura: in quest’ultimo caso esisteva pure attivazione funzionaleisolata dello strato glomerulare della corticale surrenale (vedi in seguito); comeanche in un giovane diciassettene incensurato, involontario testimone di un omi-cidio, ucciso con colpi di fucile a pallettoni quasi simultaneamente alla vittimadesignata; e in un ventunenne cugino di latitante, unico vero bersaglio dell’ag-gressione, ucciso con colpi di pistola immediatamente dopo l’uccisione della pre-detta vittima designata. E’ ovvio che reperti simili ai suddetti si riscontrano inqualsiasi caso di stress acuto, non solo in soggetti perfettamente normali, maanche in soggetti presentanti segni di attivazione funzionale subacuta o cronica,come già detto: nella casistica esaminata rientrano in questo gruppo il caso di cuial par. 3, lett. e dell’elenco, nonché il pilota d’aereo (par. 3, lett. c), laddove è daritenere indubbio lo stato di terrore per l’improvvisa consapevolezza della morteimminente connessa all’inevitabile investimento ferroviario e alla incapacità diimpedire la precipitazione dell’aereo.
La realtà dell’immissione in circolo di catecolamine, acuta, subacuta o cronica,correlata alle suddette modificazioni morfo-funziomali delle cellule cromaffini,può essere agevolmente verificata con la ricerca degli effetti biologici indiretticonnessi a detta immissione in circolo, cui in precedenza accennato, ed in primoluogo a livello splenico, renale e non di rado anche cardiaco ed epatico: in que-st’ultimo caso specie per le forme subacute e croniche. La milza appare macro-scopicamente raggrinzita, ridotta di volume (naturalmente se anatomicamenteintegra), molle, ischemica, con lacune prive di contenuto ematico all’esame isto-logico. I reni istologicamente mostrano le anse capillari dei glomeruli prevalen-temente ischemiche, mentre i capillari interstiziali e le vene possono apparirecongesti in relazione al ristagno ipostatico. Il fegato, all’esame istochimico (rea-zione al PAS su fette ottenute da pezzi adeguatamente fissati e con fette di con-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
80
trollo pretrattate con diastasi) può presentare rarefazione o totale scomparsa delglicogeno nelle cellule della periferia dei lobuli (vedi in seguito), talora in tutto ilcontesto dei lobuli: ciò quando gli effetti glicogenolitici delle catecolamine acu-tamente immesse in circolo non vengano tempestivamente compensati dai pro-cessi di gliconeogenesi per inadeguata e tardiva partecipazione dei meccanismi aciò preposti, o quando la morte sia sopraggiunta prima che detti meccanismiavessero potuto aver luogo o compiutamente operare. Tuttavia, come già accen-nato, per quanto attiene al fegato, bisogna tener presente che non sempre il re-perto istochimico è conforme alla realtà. Infatti, nel fegato di cadaveri, ancheesenti da fenomeni putrefattivi, il glicogeno può andare incontro a distruzione au-tolitica nell’intervallo di legge fra morte ed autopsia e cioè prima che il relativoprelievo possa essere adeguatamente fissato. Peraltro in tali casi è altamente si-gnificativa la morfologia degli epatociti, in quanto il mantenimento dell’aspettochiaro, quasi trasparente, similvegetale, del loro citoplasma, con integrità dei nu-clei, è segno inconfondibile della presenza in esso di granuli di glicogeno in quan-tità normale prima dell’accadimento della morte (ma qui bisogna escludere chedetto aspetto chiaro del citoplasma possa essere in relazione a degenerazione tor-bido-vacuolare o a steatosi). Inoltre, quando la dismissione del glicogeno avvienein vita gli epatociti diminuiscono di volume ed assumono aspetto compatto delcitoplasma, senza modificazioni nucleari. Per quanto riguarda il cuore, le lesionidelle fibre miocardiche qui riscontrabili sono qualitativamente simili a quelle pre-senti nei portatori di feocromocitoma, anche se non di pari intensità. Tuttavia, lealterazioni miocardiche da catecolamine sono di natura francamente patologica,per cui saranno trattate compiutamente nella parte seconda.
2.1.2. La corticale surrenale1) L’aspetto normale della glomerulare e della fascicolata si caratterizza per
cellule con citoplasma carico di gocciole lipidiche, spesso voluminose e forte-mente birifrangenti a luce polarizzata (Fig. 7,8); nei preparati ottenuti da pezziinclusi in paraffina il citoplasma di tali cellule appare vescicoloso, a volte chiarotanto da sembrare d’aspetto vitreo.
Il suddetto reperto è tipico della condizione di riposo funzionale, che corri-sponde alla morfologia normale della corteccia surrenale, posto che lo strato re-ticolare della stessa non è coinvolto nel corso degli stress.
2) Frammentazione delle gocciole lipidiche dei suddetti due strati corticalidella ghiandola (Lipoidaufsplitterung di Dietrich, secondo Tonutti: 2) senza loro ap-parente diminuzione quantitativa all’esame a luce normale dei preparati coloraticol Sudan III o nero, frammentazione non diffusa ma circoscritta a campi cito-
81
Fisiopatologia dello stress
logici delimitati e di ampiezza irregolare, ove non sono visibili inclusi birifran-genti a luce polarizzata.
Il suddetto reperto è indicativo di una attivazione funzionale acuta parcellare,degli strati glomerulare e fascicolato, circoscritta nel tempo.
3) Il riscontro di chiazze circoscritte, di varia ampiezza, irregolari, a cavalieredella glomerulare e della fascicolata, nelle quali le cellule ghiandolari hanno cito-plasma del tutto privo di gocciole lipidiche; tali chiazze sono ben visibili sia neipreparati al congelatore colorati col Sudan III o nero (Fig. 9,10), sia nei preparatida pezzi inclusi in paraffina.
Le cellule prive di gocciole lipidiche sono rimpicciolite, hanno citoplasma com-patto, lievemente basofilo e nucleo ipercromico: cosiddette cellule scure della no-menlatura anatomo-patologica (Fig. 11).
Il reperto corrisponde ad un’attivazione funzionale acuta sia della glomerulareche della fascicolata. Questo quadro è frequente nei suicidi ed è stato osservatoanche in cinque soggetti pluripregiudicati, quattro dei quali sorvegliati specialiagli arresti domiciliari ed uno detenuto in carcere. I quattro sorvegliati specialivivevano in abitazioni fortificate e protette da muri di cinta. Tre di essi e quellodetenuto in carcere furono uccisi da grande distanza (circa 150-200 metri) conuno o due colpi esplosi con armi di elevata potenza (il detenuto trovavasi nel cor-tile del carcere durante l’ora d’aria, gli altri nell’atto di uscire dal portone nel pro-prio cortile recintato o di affacciarsi ad una finestra o sulla terrazza della propriaabitazione). Il quinto è stato ucciso con otto colpi esplosi da mitraglietta dalla di-stanza di alcuni metri. Nella midollare surrenale di questi casi vi era il reperto del-l’attivazione funzionale cronica con note di sovrastimolazione acuta nel quintocaso sopra menzionato.
4) In casi del tutto eccezionali le condizioni morfologiche descritte nel para-grafo precedente sono limitate al solo strato glomerulare (Fig. 12,13).
Il reperto indica una condizione di attivazione funzionale acuta isolata dellostrato glomerulare, la quale si può verificare, come già detto in via del tutto ec-cezionale, attraverso il sistema renina-angiotensina stimolato dall’ischemia renaleda catecolamine, quando la morte si sia verificata prima che abbia avuto luogo lastimolazione ipotalamo-ipofisaria o quando questa non sia avvenuta a causa diblocco farmacologico o per danni traumatici o infiammatori delle strutture ner-vose che presiedono alla suddetta normale risposta neuro-ormonale allo stress:tale condizione è stata da noi osservata in due dei casi di omicidio presentanti at-tivazione iperacuta della midollare surrenale, e nel caso di cui al par. 3, lett.g del-l’elenco della casistica (Fig. 14,15).
Marcello Aragona, Francesco Aragona
82
In uno dei due suddetti casi di omicidio il reperto era connesso alla morte ra-pida del soggetto per lesioni traumatiche dell’encefalo, con sfacelo ipotalamico,determinate da un proiettile calibro 9 per un colpo esploso di sorpresa a con-tatto sulla fronte con tramite diretto dall’avanti all’indietro; nell’altro caso, invece,la morte si era verificata dopo 60 ore per una ferita d’arma da sparo simile alla pre-cedente (calibro 7.65), con colpo parimenti esploso di sorpresa, responsabile diuna tramite emorragico encefalico, coinvolgente anche l’ipotalamo e distruzioneemorragica dell’ipofisi.
5) Frammentazione delle gocciole lipidiche nelle cellule sia della glomerulareche della fascicolata (Lipoidaufsplitterung di Dietrich, secondo Tonutti,come già ri-cordato) senza apparente loro diminuzione quantitativa. Le gocciole lipidiche cosìtrasformate sono birifrangenti solo in parte ed in modo pressochè uniforme (Fig.16,17). Nei preparati ottenuti da pezzi inclusi in paraffina le stesse cellule appa-iono lievemente ridotte di volume ed hanno citoplasma assai finemente vacuolato.
Questo quadro istologico e istochimico corrisponde ad una condizione di at-tivazione funzionale subacuta o cronica di moderata intensità sia della fascicolatache della glomerulare.
6) Chiazze di deplezione lipidica assai vaste ovvero estese a tutto il contestodella glomerulare e della fascicolata; quest’ultima è anche aumentata di spessore;aspetto compatto o quasi del citoplasma, talora ipertrofia ed ipercromia nucleare:reperti comuni nei traumatizzati cranici lungodegenti (15), (Fig. 18,19).
In rari casi esistono nel tessuto adiposo perisurrenalico campi in cui gli adi-pociti perdono il loro aspetto vescicoloso, otticamente vuoto, del citoplasma edassumono la morfologia spongiosa del citoplasma stesso, simile a quella delle cel-lule ghiandolari dei due strati esterni della corteccia surrenale, con contenuto inlipidi sotto forma di piccole gocciole birifrangenti a luce polarizzata. Questo re-perto perisurrenalico è stato osservato sia in traumatizzati cranici lungodegenti,sia in alcuni suicidi ed in una donna di 30 anni uccisa con colpi d’arma da sparodopo un anno da analoga uccisione del marito per ventetta in una faida interfa-miliare.
Il reperto sopra descritto indica un’attivazione funzionale cronica sostenuta,concretatasi fino all’esaurimento funzionale, specie a livello della fascicolata. Latrasformazione morfologica degli adipociti del tessuto adiposo perisurrenalicopuò essere interpretata come conseguenza della lipolisi determinata dalle cate-colamine e/o dall’ACTH, ovvero come effetto di disordinata rigenerazione cor-ticale, simile a quella osservabile negli animali da esperimento surrenectomizzatibilateralmente e mantenuti in vita con dieta ricca di sali. Questa seconda ipotesi
83
Fisiopatologia dello stress
sembra la più probabile per il fatto che le gocciole lipidiche del suddetto tessutoadiposo divengono birifrangenti a luce polarizzata. Un simile quadro nel tessutoadiposo perisurrenalico è stato osservato da uno di noi anche in un soggetto por-tatore di carcinoma polmonare ormonosecernente a decorso silente (16), che pre-sentava aspetto necrobiotico di tutta la corticale, come descritto nel paragrafosuccessivo.
7) Campi di aspetto necrobiotico o necrotico-emorragico di varie estensioni,che a volte interessano pure lo strato reticolare e la midollare. Anche in casi diquesto genere, che non rientrano nella necrosi bilaterale dei surreni della sepsi me-ningococcica (sindrome di Waterhouse-Friderischsen), possono osservarsi mo-dificazioni del tessuto adiposo perisurrenalico simili a quelle descritte nelparagrafo precedente. Anche il presente quadro è di significato patologico ed in-dica uno stato di esaurimento funzionale da iperstimolazione cronica.
8) Reperto di normalità istologica e istochimica nonostante i dati clinici, te-stimoniali o di sopralluogo stiano ad indicare un profondo stato di sofferenza fi-sica, psicologica o psico-fisica, precedenti all’evento mortale.
Si tratta di evenienza di raro riscontro che si realizza quando l’ipotalamo ol’ipofisi, o entrambi siano impediti nelle loro funzioni di stimolo sulla cortecciasurrenale a causa di venefici (per suicidio od omicidio) che si caratterizzano perla capacità di bloccare la trasmissione nervosa a livello centrale, o di traumi o pro-cessi morbosi, produttivi di danni anatomici nelle stesse sedi, come già detto.
I vari quadri osservati nella midollare e nella corticale dei surreni, in prece-denza schematizzati, sono abitualmente contestuali, nel senso che il grado di at-tivazione funzionale dell’una coincide con quello dell’altra. Tuttavia, i medesimiquadri possono talvolta apparire dissociati, nel senso che accanto ad un repertodi semplice attivazione a carattere acuto della corticale si può riscontrare un re-perto midollare di attivazione funzionale cronica con la sovrapposizione di im-magini di stimolazione acuta. Tale fenomeno dissociativo non è osservabile insenso opposto, cioè con maggiore attivazione della corticale e minore della mi-dollare, tranne che in particolari condizioni patologiche (ad esempio, in soggettiportatori di neoplasie ACTH-secernenti:16).
A proposito delle modificazioni istofisiologiche da stress delle ghiandole sur-renali sopra esposte appare opportuno ricordare che nell’ambito dei compiti me-dicolegali del RIS (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche) figura ancheil dosaggio ematico dell’adrenalina allo scopo di stabilire se la vittima abbia avutoil tempo di spaventarsi.
Si tratta di un’indagine teoricamente e scientificamente corretta per quello ch’è
Marcello Aragona, Francesco Aragona
84
stato detto in precedenza circa le modificazioni osservate nella midollare surre-nale, ma di difficile apprezzamento nel cadavere per i seguenti motivi: a) come siavrà modo di ripetere nel capitolo VI della parte seconda va premesso che le ca-tecolamine (adrenalina e noradrenalina) hanno un’emivita assai breve: le mede-sime, dopo la loro immissione in circolo dalla midollare surrenale, rimangonoattive per 10-30 secondi, dopo di che la loro attività va decrescendo per scom-parire entro alcuni minuti. Infatti le catecolamine vengono rimosse dal circoloematico mediante due meccanismi: uptake1 o neuronale e uptake2 o extraneuronale. Ilprimo meccanismo è un processo di ricaptazione delle catecolamine attivato dallamidollare surrenale e dalle terminazioni nervose periferiche: in tal modo le me-desime o sono reimmagazzinate nei granuli cromaffini o degradate dalle MAO(monoaminossidasi) citosoliche; il secondo meccanismo avviene nei tessuti ex-traneuronali periferici, ove le catecolamine sono metabolizzate sia dagli enzimi giàmenzionati (MAO), sia delle catecol-metil-trasferasi (COMT). I principali pro-dotti del metabolismo catecolaminico si trovano nelle urine (acido vanilmande-lico, normetanefrina, metanefrina), o sono metabolizzate nel fegato.
Per la determinazione delle catecolamine plasmatiche si utilizza una metodicaradioenzimatica molto sensibile, che consente di dosare le catecolamine totali li-bere. Nel vivente, prima del prelievo ematico, il soggetto deve rimanere a riposoin posizione supina ed in ambiente tranquillo dopo che un catetere è stato posi-zionato in una vena periferica, allo scopo di evitare che lo stress emotivo legatoal prelievo o il dolore della puntura venosa possano indurre un aumento delle ca-tecolamine. Le analoghe indagini eseguite post-mortem su animali di laboratoriouccisi per morte violenta hanno dimostrato che immediatamente dopo la mortei livelli di adrenalina sono di regola più alti di quelli noradrenalinici. Quindi l’adre-nalina decresce rapidamente man mano che aumenta l’intervallo post-mortem,mentre il livello di noradrenalina tenderebbe ad aumentare (17). Per cui, ai fini diottenere risultati attendibili da indagini del genere dirette a svelare nel cadavereuno stato di stress precedente al decesso è indispensabile prelevare il sangue dallecavità cardiache immediatamente dopo la morte onde evitare l’incidenza dei fe-nomeni autolitici: ciò con l’espressa autorizzazione del magistrato inquirente, pre-vio sicuro accertamento del decesso mediante elettrocardiogramma della duratadi venti minuti tenuto conto delle norme che regolano l’accertamento della mortee la durata di osservazione dei cadaveri prima del seppellimento, previste dal re-golamento di polizia mortuaria (DPR 10 sett.1990, n.285).
Per quanto riguarda i metaboliti urinari delle catecolamine è noto che la lorodeterminazione nel cadavere è impossibile, dato che di regola tale accertamentoè attuabile solo nel vivente nelle urine delle 24 ore. Per cui nel cadavere sembramolto più agevole servirsi dell’esame istologico e istochimico delle surrenali come
85
Fisiopatologia dello stress
in precedenza descritto, col quale è possibile anche valutare l’eventuale rispostadello strato glomerulare della corticale attivata dalle catecolamine attraverso l’in-tervento del sistema renina-angiotensina-aldosterone.
2.2. L’encefalo (compreso l’ipotalamo, l’ipofisi, la tiroide)Mentre lo studio dell’ipofisi e della tiroide è stato effettuato in tutta la casistica
in precedenza menzionata, lo studio di varie parti dell’encefalo (corteccia cere-brale, cervelletto, ponte, bulbo, nuclei della base: dell’ipotalamo si dirà qui di se-guito) è stato eseguito su 165 casi:108 vittime di omicidio e 57 casi di suicidio. Levittime di omicidio (solo 10 di sesso femminile), di età compresa fra 17 e 78 anni,ma per lo più al di sotto dei 40 anni, con morte avvenuta istantaneamente o ra-pidamente (cioè in pochi minuti), ma in tre casi si è verificata più tardivamente:in un caso dopo 4 ore, in altro dopo 24 ore e nel terzo dopo 60 ore. L’uccisioneera avvenuta con armi da sparo in 105 casi, e vi sono compresi pure i due casi uc-cisi con violenti traumi cranici durante il sonno con l’uso di bastoni ed il casoper avvelenamento da stricnina. Il gruppo dei suicidi è composto da 57 casi (17di sesso femminile), di età compresa fra 14 e 84 anni, ma prevalentemente fra 20e 50 anni. Il suicidio era stato effettuato mediante armi da sparo (15 casi), im-piccamento (12 casi), annegamento in mare (7 casi), precipitazione (4 casi), armabianca (2 casi), avvelenamento (17 casi). Nel gruppo degli avvelenamenti il suici-dio è stato effettuato con esteri fosforici (5), stricnina (1), acido muriatico (2), ve-leni nervini ad azione depressiva centrale (6), digitale (1), cianuro di sodio (1),ossido di carbonio (1). L’ipotalamo anteriore è stato studiato in 52 casi di omici-dio e 9 di suicidio con i metodi comuni e con la tecnica di Gomori-Bargmann.
Secondo quanto già detto, nella reazione allo stress la partecipazione delleghiandole a secrezione interna, e segnatamente della corteccia surrenale, è mediatada neurormoni, i quali dall’ipotalamo, e segnatamente dall’eminenza mediana,sono immessi nella neuroipofisi per migrazione lungo le fibre nervose del pe-duncolo ipofisario e poi nella circolazione generale attraverso il circolo portaleipofisario.
Per quanto riguarda l’ormone rilasciante l’ACTH ipofisario (corticotropin re-leasing hormone o CRH), studi istochimici condotti con anticorpi policlonalianti-CRH hanno dimostrato che la regione più densamente popolata di cellulecontenenti detto neurormone è costituita dal gruppo parvicellulare del nucleoparaventrivolare dell’ipotalamo (18, 19, 20). Inoltre il CRH è contenuto in nu-merose cellule del nucleo centrale dell’amigdala (21) e del nucleo basale della striaterminale (22). Cellule positive ai suddetti anticorpi si riscontrano anche in altrearee ipotalamiche, nella corteccia cerebrale, nel sistema limbico. CRH è dimo-strabile pure nel liquido cefalo-rachidiano qualche minuto dopo lo stress, costi-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
86
tuito dalla stessa puntura lombare per il suo prelievo. Secondo i numerosi ed approfonditi studi istologici condotti sui nuclei para-
ventricolari e sopraotttici da Scharrer negli anni 30 (22-26), i neurormoni ipota-lamici (sotto forma di granuli) si dispongono a corona di rosario lungo le fibredel peduncolo ipotalamo-ipofisario prima di raggiungere la neuroipofisi ed im-mettersi dopo nel circolo portale ipofisario. Cavallero (27) osserva al riguardoche il neurosecreto (come detto, sotto forma di granuli), nel quale sono veicolatii neurormoni, appare depositato nei corpi di Herring della neuroipofisi, corpiche costituiscono le terminazioni delle fibre nervose del fascio ipotalamo-ipofi-sario, bene evidenziabili col metodo Gomori-Bargmann. La neuroipofisi, per-tanto, costituisce il deposito dei suddetti neuromoni.
Risultati (Le alterazioni extraipotalamiche, in quanto di natura patologica sa-ranno discusse nella parte seconda).
2.2.1. Ipotalamo ed ipofisiSia nelle vittime di omicidio che nei suicidi abbiamo osservato marcata rare-
fazione dei granuli di neurosecreto nel nucleo paraventricolare, nel nucleo so-praottico e nell’eminenza mediana con frequente loro diffusione lungo gli assoni(Fig. 20,21), con successiva migrazione attraverso le fibre del fascio ipotalamo-ipofisario (Fig. 22), con deposito nella neuroipofisi, spesso raccolti nei corpi diHerring (Fig. 23).
Rarefazione dei granuli di neurosecreto è apprezzabile anche nelle cellule ner-vose dei nuclei ipotalamici suddetti nei suicidi per avvelenamento con veleni adazione inibente la risposta allo stress, peraltro con modeste immagini di diffu-sione lungo gli assoni (Fig. 24).
Tenuto conto del fatto che in esperimenti da noi condotti (5) su cavie e rattiavvelenati con barbiturici non si è notata, fra gli animali deceduti più precoce-mente, rarefazione dei granuli di neurosecreto, rarefazione che invece era visibilenegli animali deceduti più tardivamente in associazione con fenomeni regressividelle cellule nervose ipotalamiche, il reperto di cui alla fig. 24, stante l’assenza dichiare alterazioni regressive neuroniche, sembrerebbe indicativo di una riduzionedel contenuto neuronale in granuli di neurosecrezione in rapporto ad un pro-cesso collocabile cronologicamente a momenti precedenti all’attuazione dell’attosuicida e cioè nella fase preparatoria di quell’atto, coincidendo con la tempestaemotiva che annulla l’istinto di conservazione e si conclude con l’autodistruzione.Mentre durante il periodo del vero e proprio avvelenamento il cervello vegetativoe razionale nel suo insieme non era più in grado di rispondere alle sollecitazionipatologiche. Nel caso di cui alla suddetta fig. 24 la durata della sindrome veneficada barbiturici non era nota perché la donna viveva da sola ed il momento in cui
87
Fisiopatologia dello stress
essa assunse il veleno non era testimoniato e neppure, per lo stesso motivo, eratestimoniato il momento esatto della morte. Verosimilmente si era trattato di unavvelenamento ad evoluzione rapida. E’ noto, infatti, che nell’avvelenamento dabarbiturici se ne distinguono due forme: una ad evoluzione rapida con morte chesi verifica dopo 1-2 ore dall’assunzione del veleno, talora anche in un tempo piùbreve, ed una forma ad evoluzione lenta, con morte che si verifica dopo 1-4 giornio più tardi. Come già detto, quest’ultima forma è quella più frequente. Walls (28)nella sua casistica personale di 84 casi mortali ne riscontrò soltanto uno a de-corso rapido (donna di 34 anni che morì dopo circa un’ora dall’ingestione di se-cobarbital). Pertanto, è dimostrato che nel caso qui documentato l’asseipotalamo-ipofisi-corticosurrene rimase inattivo per almeno 12 ore. Ed in effettianche la corteccia surrenale era apparsa in condizione di riposo funzionale. Inaltra casistica umana ed in condizioni sperimentali noi (11,12,13) abbiamo vistoche analogo blocco funzionale ipotalamo-ipofisario si verifica in altri avvelena-menti (cloroprocainamide, esteri fosforici ad alte dosi, curarici, orfenadrina) ed èrisaputo che analogo fenomeno ricorre nelle lesioni traumatiche ed infiammato-rie ipotalamo-ipofisarie.
Poiché, come già detto, le nostre indagini hanno dimostrato che sono del tuttosimili i dati morfologici del nucleo paraventricolare, ove si ritiene avvenga essen-zialmente la secrezione del CRH, e quelli del nucleo sopraottico, ove avviene so-prattutto la secrezione della vasopressina e della ossitocina, si deve concludere chenello stress entrambi i suddetti nuclei siano simultaneamente stimolati con libe-razione dei rispettivi neurormoni. Inoltre, studi non più recenti di Andersen eEgdahl (29) hanno dimostrato che la vasopressina possiede ad un tempo ancheattività simil-ACTH e simil-CRH. Più di recente questi studi sono stati confer-mati, in quanto è stato esaurientemente dimostrato che la vasopressina è capacedi possedere un effetto sinergico col CRH nel promuovere la liberazione diACTH dalla preipofisi (30-33). Sì che appare più agevole comprendere la prontarisposta dell’asse ipofisi-corticosurrene agli stress, vista la contemporanea attiva-zione dei nuclei paraventricolare e sopraottico da noi costantemente osservata.
La migrazione da stress del neurosecreto dall’ipotalamo al peduncolo ipofisa-rio e alla neuroipofisi da noi osservata istologicamente, coincide con quanto erastato osservato da altri Autori, mediante indagini immunologiche, circa le ridotteconcentrazioni del CRH nell’eminenza mediana (Chappell e coll., 34) e circa l’au-mento dello stesso nella circolazione portale (Plotsky e Vale, 35). In accordo colsuddetto reperto è stato anche osservato un aumento dell’utilizzazione del glu-cosio nell’eminenza mediana e nei nuclei laterali dell’ipotalamo (Björklund e coll.,36), nonché nel locus coeruleus, regione nella quale è stato notato pure un signi-ficativo aumento del CRH durante gli stress (Chappell e coll., 34).
Marcello Aragona, Francesco Aragona
88
Per quanto attiene all’ipofisi ci si deve soffermare ancora sulle modificazioni dellobo anteriore, il quale è sollecitato nella sua funzione dai predetti neurormoniprovenienti dall’ipotalamo anteriore. In tutti i suicidi, nelle vittime di omicidio(esclusi i casi coinvolti nel delitto perché involontari testimoni del medesimo) edi tutti i casi di controllo, ad eccezione dei casi in cui vi sia stato il blocco della tra-smissione nervosa nel contesto del cervello vegetativo, come nell’esempio pre-cedentemente riportato, si rileva degranulazione delle cellule basofile negli stressdi breve durata, mentre si nota anche iperplasia delle stesse cellule negli stresscronici. La rarefazione delle granulazioni specifiche delle suddette cellule confe-risce al loro citoplasma un aspetto finemente vacuolato o polverulento (Fig. 25).In qualche caso è stata riscontrata invasione di gruppi di cellule basofile nellaneuroipofisi.
Le modificazioni preipofisarie predette sono connesse alla conoscenza chenelle cellule basofile sono comprese le beta1, le beta2, le gamma e le delta, nel cuiinsieme non è secreto soltanto l’ACTH, ma anche altri ormoni e cioè TSH, FSH,LH (37).
2.2.2. TiroideI riscontri istologici nella casistica sopra elencata documentano vari gradi di at-
tivazione della ghiandola, caratterizzati inizialmente da segni di incipiente fluidi-ficazione della colloide denunciati dalla colorazione azzurra che la stessa assumecon i metodi tricromici tipo Mallory lungo i suoi margini, a ridosso dell’epiteliofollicolare, oppure soltanto in corrispondenza del polo di riassorbimento, ovepropaggini colloidee nettamente si differenziano, per il loro colore azzurro, dallarestante colloide che permane di colorito rosso mattone. Questo limitato tipo diattivazione si suole riscontrare in circa il 50% delle vittime di omicidio. In altri casi,e segnatamente nei suicidi, la colorazione azzurra si estende a tutto il contesto col-loide, che nello stesso tempo diviene più tenue, vacuolizzato, frammentato, taloraporoso o polverulento, finchè tutti i follicoli, o gran parte di essi, divengono vuotio quasi. La deplezione colloide si accompagna a riduzione di volume dei folli-coli, il cui epitelio di rivestimento diviene cilindro-cubico o cilindrico e contienenel citoplasma fini granuli colorabili in rosso porpora con la reazione al PAS. Illume follicolare va via via restringendosi fino a divenire virtuale. Tali reperti dimaggiore attivazione funzionale si sogliono osservare in circa il 95% dei suicidi.
Ad eccezione di due suicide, su cui si ritornerà nella Parte Seconda, non sisono riscontrati veri e propri quadri di morbo di Basedow in quanto nell’inter-stizio della ghiandola sono mancati gli infiltrati nodulari dello stato autoimmuneche lo caratterizzano.
Nel loro complesso le suddette immagini istologiche si accordano con i dati
89
Fisiopatologia dello stress
statistici che confermano la elevata frequenza con la quale sintomi ipertiroidei, se-condo alcuni anche di tipo basedowiano, compaiono in situazioni di varia natura,psichici e fisici, o psico-fisici.
Infatti, è stato evidenziato un incremento dei casi di gozzo iperfunzionante du-rante periodi bellici (38). Lo Stanford Research Institute, in un’indagine pubblicata nel1953, aveva rilevato fra i cittadini tedeschi un aumento del m. di Basedow du-rante i periodi di attacchi aerei della seconda guerra mondiale. Analogamente,l’incidenza dell’ipertiroidismo in Norvegia durante il primo anno della secondaguerra mondiale era aumentata del 220% rispetto agli anni precedenti, ed era ilquintuplo rispetto al 1936 (39). Un evidente aumento dell’ipertiroidismo fu os-servato anche in Danimarca negli anni 1941-1945, con un’incidenza del 300-400%più elevata rispetto agli anni precedenti (40). Fra i profughi tedeschi, che eranostati imprigionati dai nazisti per più di 4 anni, l’incidenza della tireotossicosi ap-parve quattro volte più elevata rispetto al totale dei ricoverati in una clinica diLos Angeles (41). Peraltro, anche studi statistici condotti in tempi di pace hannoconfermato che l’incidenza della tireotossicosi era più elevata in soggetti che ave-vano subito traumi psichici (42). Bram (43) su 3343 casi di gozzo esoftalmico ri-levò che in ben 2842 casi (85%) ricorreva nell’anamnesi un trauma psichico.Secondo altri dati statistici il trauma emozionale figura con una frequenza dal 20a quasi il 100% (44), ma generalmente non è superiore all’80% (45). La stimola-zione tiroidea da stress psichico è confermata dalle ricerche biochimiche di Levi(46), il quale in 31 soggetti che avevano subito uno stress psichico osservò un au-mento della iodoproteinemia (detto aumento mancò solo in un soggetto). Perquanto attiene ai traumi psichici, Starr (47) semplificò il problema causale illu-strando il caso di una giovane donna, nella quale l’esoftalmo e l’ipertiroidismocomparvero 4 ore dopo la morte del proprio bambino. Fra gli stress fisici vannoricordate soprattuto le esposizioni al freddo intenso o ad elevate altitudini e acondizioni ipossiche (4, 48-55), nonchè stress cronici ricorrenti in bambini venutia morte improvvisa (56).
Tuttavia, ricerche recenti sostengono che durante lo stress sarebbe soppressala secrezione di TSH, il che sarebbe dimostrato dalla diminuita conversione dellatiroxina (T4), relativamente inattiva, nella potente triiodotironina (T3) nei tessutiperiferici (57).
Gli AA. suddetti, in sostanza, asseriscono per via indiretta la soppressione se-cretiva del TSH da parte dell’ipofisi: il che non sembra accettabile, nel senso chela mancata conversione periferica del T4 in T3 non esclude l’iperplasia tiroidea daTSH da noi riscontrata e documentata dagli studi statistici sopra ricordati. Infatti,il quadro istologico tiroideo da stress, come osservato da Cavallero (27), sarebbeda definire “iperplasia paradossa”, in quanto non secernente ormoni, così corri-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
90
spondendo all’iperplasia tiroidea che suole riscontrarsi durante il trattamento confarmaci antitiroidei (Tiouracile, ecc.), che vengono definiti “gozzigeni” per l’iper-plasia tiroidea prodotta. La quale è da riferire ad un incremento funzionale delTSH ipofisario, a ciò stimolato dalla diminuzione dalla biosintesi ormonale a li-vello tiroideo e quindi all’abbassamento dell’ormone immesso in circolo dallaghiandola stessa, abbassamento connesso alla somministrazione dei farmaci sopramenzionati.
Peraltro quanto qui sopra detto circa l’iperplasia tiroidea paradossa appare innetto contrasto con le più non recenti conoscenze, cui riferito in precedenza, re-lative al rapido coinvolgimento funzionale della tiroide nel corso di stress psi-chici, fisici o psicofisici e particolarmente nell’assideramento (4, 48-55). Infattiin ratti perfrigerati si è visto nel siero e nelle urine aumento del contenuto in ti-reostimulina (Brolin, 54) e ridotta concentrazione di detto ormone nell’ipofisi diratti e cavie analogamente trattati (Vojtkevic, 55).
Inoltre, vi sono le forme di tipica tireotossicosi, cioè le forme caratterizzatedalla presenza di noduli linfatici nell’interstizio tiroideo di riscontro in suicidi, chepossono essere aggravate dalle condizioni di stress. Nei suicidi, in complesso,comprese le forme tipicamente autoimmuni (m.di Basedow), l’aspetto istologicoiperfunzionale della tiroide è riscontrabile in circa il 95% dei casi, come già detto.Questo reperto è connesso allo stress che ha condotto al suicidio (vedi capitoloIX.1 della parte seconda).
Secondo il nostro parere, in questa discussione non si è tenuto conto del re-perto istologico e istochimico preipofisario e dell’ipotalamo anteriore, il quale re-perto, invero, è di fondamentale importanza.
Come si è già detto, in tutta la casistica esaminata, accanto al reperto tiroideodi tipo iperfunzionante, sono stati rilevati nella preipofisi fenomeni di degranu-lazione delle cellule basofile, talora associata ad iperplasia ed ipertrofia di gruppidi dette cellule. Le cellule che mostrano tali fenomeni di degranulazione, diver-samente dalle cellule basofile normali, non si colorano col PAS (v. Fig. 25). Aproposito della reattività delle granulazioni basofile con la reazione al PAS, si devericordare che la medesima è attribuibile sia all’ACTH, sia al TSH, e sia ancora aigonadotropi (FSH, LH): ciò in quanto nelle molecole che costituiscono detti or-moni esistono gruppi ossidabili dall’acido periodico: composto essenziale nellareazione suddetta.
Per l’ACTH, in quanto di natura esclusivamente proteica, tali gruppi sono ditipo amino-alcolico (-CHOH-CH2NH2) e sono attribuibili alla presenza degliaminoacidi serina e idrossilisina nella molecola proteica di detto ormone; mentreper gli altri ormoni sopra indicati, che sono di natura glicoproteica, i gruppi re-attivi sono di tipo 1-2 glicolico (-CHOH-CHOH). Va ancora ricordato che la bio-
91
Fisiopatologia dello stress
sintesi dell’ACTH, a lungo discussa, avviene, come per gli altri ormoni sopramenzionati, proprio nelle cellule basofile, o, secondo una nomenclatura più mo-derna, nelle cellule beta (beta1 e beta2). La prova di questa localizzazione è stataottenuta attraverso ampi studi di immunofluorescenza (58).
Pertanto, poiché il processo di disgregazione dei granuli delle cellule basofileè globale, si potrebbe ipotizzare che tutti gli ormoni di cui s’è detto vengano si-multaneamente dismessi in condizioni di stress. E ciò avvalorerebbe non solo laserie di modificazioni morfofunzionali della corteccia surrenale, ma anche quelledella tiroide. Le alterazioni testicolari ed ovariche connesse allo stress saranno il-lustrate nella Parte Seconda poiché trattasi di processi di schietta natura patolo-gica. I gruppi reattivi all’acido periodico di detti ormoni sono di tipo 1-2 glicolici(-CHOH-CHOH) in quanto chimicamente glico-proteici, come già detto.
In favore della simultanea attivazione della corteccia surrenale e della tiroidesi pronuncia anche Pancheri (59).
2.3. Aspetti istofisiologici di altri organi: fegato, pancreas, milza, reni.Sono stati studiati su tutta la casistica sopra menzionata su sezioni di pezzi
fissati in formalina neutra al 10%. Pezzi di fegato sono stati anche fissati in unasoluzione satura di acido picrico in alcol assoluto per il glicogeno. Sono stati quiesclusi i reperti relativi alle forme di suicidio per avvelenamento.
Fegato. Come già accennato in precedenza, negli stress comuni si apprezza isto-logicamente ed istochimicamente congestione venosa, talora associata a dilata-zione e replezione dei capillari, con o senza edema interstiziale. Il contenuto inglicogeno può apparire diminuito o del tutto scomparso. Le cellule prive di gli-cogeno hanno citoplasma compatto, avendo perso l’aspetto chiaro, non di radovitreo, similvegetale, che caratterizza quello dell’epatocita normale, ricco di gli-cogeno (Fig. 26). I nuclei cellulari, quando lo stress è protratto, mostrano fre-quentemente variazioni del volume, della forma e della colorabilità: essi possonoapparire, infatti, ipertrofici, a contorni irregolari ed ipercromici.
La mobilizzazione del glicogeno suole verificarsi dalla periferia verso il centrodel lobulo, nel senso che la scomparsa del polisaccaride si ha inizialmente alla pe-riferia, successivamente nelle zone mediocentrali ed infine al centro del lobulo(Fig. 27).
Ciò potrebbe essere in relazione al fatto che lo stimolo, eventualmente anos-sico, stante l’anatomia della circolazione epatica, raggiunge prima le parti perife-riche del lobulo, le quali sono pertanto le zone funzionalmente più attive, siaancora al fatto che il centro del lobulo, per essere in condizioni normali relativa-mente meno ossigenato rispetto alle altre parti del lobulo, e quindi quasi assue-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
92
fatto a condizioni relativamente ipossiche, offre una maggiore resistenza al pa-tologico abbassamento della tensione d’ossigeno, o a qualsiasi altro fattore glico-genolitico. Quest’ultima considerazione trova rispondenza nella maggioreresistenza all’ipossia osservata nel fegato fetale, il quale di norma svolge notoria-mente la sua attività metabolica in condizioni di ossigenazione meno efficientirispetto a quelle postnatali. Si sa d’altra parte che la demolizione fisiologica del gli-cogeno epatico suole avvenire alla periferia del lobulo e nella stessa sede avvienela sua sintesi.
Va segnalato il fatto che nello stress da freddo, nel quale per le esigenze calo-riche dell’organismo vi è una rapidissima mobilizzazione del glicogeno epatico, èstato in alcuni casi osservata nel fegato presenza di detto polisaccaride, anche inmarcate quantità (60, 61) (aumento del glicogeno, nelle stesse condizioni speri-mentali è osservabile nel cuore, e lo stesso policcariche è dimostrabile anche neireni: 4). Secondo studi sperimentali il reperto predetto si spiegherebbe quale con-seguenza di un difetto dei processi di utilizzazione periferica dei glicidi nelle fasiavanzate dell’assideramento, essendo ancora non del tutto spenti i meccanismidi resintesi glicogenica da precursori non carboidrati (4).
Pancreas.Quest’organo nella casistica cadaverica è apparso sempre alterato daifenomeni autolitici post-mortali, tenuto conto che per legge l’autopsia non puòessere eseguita prima di 24 ore dal decesso. Sì che, per quanto attiene in partico-lare alle isole di Langerhans, le quali devono essere sicuramente coinvolte nellemodificazioni del ricambio glicidico esistenti nel corso degli stress costantementerilevate a carico del fegato, abbiamo dovuto fare riferimento a ricerche speri-mentali di altri Autori e nostre relative allo stress da assideramento. Noi abbiamoosservato in cavie assiderate riduzione di volume delle isole di Langerhans, senzaalterazioni morfologiche cellulari con le comuni colorazioni (4). Baker e Ashworth(62), in precedenza, in estratti di pancreas di ratti perfrigerati avevano osservatoriduzione del contenuto in insulina. Si deve perciò ammettere che la riduzione vo-lumetrica delle isole di Langerhans da noi rilevata debba essere correlata all’ab-norme richiesta d’insulina diretta a compensare il notevole dispendio delle riserveglicidiche, specie a livello epatico e muscolare.
Milza. Nella fase acuta dello stress si rileva esclusivamente diffusa ischemia inrelazione alla vasocostrizione correlata con l’attivazione del sistema renina-an-giotensina, per cui l’organo macroscopicamente è ridotto di volume e con cap-sula grinzosa. Le alterazioni a carico dei follicoli
linfatici, che in alcune forme di stress sono assai precoci, saranno trattate nellaparte seconda.
93
Fisiopatologia dello stress
Reni. Al pari della milza si apprezza, per lo stesso meccanismo, solo ischemiadei glomeruli. La persistenza di condizioni ischemiche glomerulari comporta fe-nomeni regressivi degli epiteli dei tubuli contorti di prim’ordine, per il fatto chela loro irrorazione ematica avviene attraverso le arteriole efferenti. Pertanto, que-sti aspetti riguardano la patologia e saranno accennati nella parte seconda, in-sieme con gli organi linfoidi, compreso il timo.
Come già detto, le nostre indagini furono condotte nel periodo 1958-1997.Successivamente ai nostri studi, che comprendevano anche 547 casi di vittime diomicidio, da notizie giornalistiche (La Repubblica del 19.3.2007) abbiamo ap-preso che negli ultimi 10 anni (1998-2007) gli omicidi mafiosi sono enormementeaumentati: si è calcolato che in detto decennio le vittime di omicidio siano state2.500: 155 sono state uccise per errore; in 37 casi si trattava di adolescenti o bam-bini.
Dei casi suddetti ne è stato studiato da noi uno soltanto nel 2005 nella pro-vincia di Reggio Calabria per le particolari peculialirità dinamiche: giovane di 20anni ucciso con 22 colpi di pistola, 8 dei quali al capo con sfacelo traumatico del-l’encefalo. Il giovane, che era alla guida di un’autovettura, era stato affiancantoda un motorino con due persone a bordo, i quali esplosero colpi di pistola versoil posto di guida, essendo chiuso il cristallo del relativo sportello. Il giovane ac-celerò la corsa dell’autovettura, subito dopo bloccò l’auto a fianco della strada,scese e tentò di sfuggire all’agguato inoltrandosi di corsa nella campagna fian-cheggiante la strada. Venne inseguito dagli aggressori che esplosero vari colpi dipistola attingendo il soggetto al dorso, alle regioni glutee e alla regione laterocer-vicale sinistra. Caduto bocconi sul terreno venne raggiunto e colpito da distanzaravvicinata con otto colpi di pistola tutti concentrati sul capo con totale sfacelotraumatico dell’encefalo. All’esame istologico e istochimico dei vari organi si ri-levarono reperti riferibili ad uno stato di stress acuto a carico dell’ipofisi e delleghiandole surrenali e nello stesso tempo, inusualmente, segni di stimolazione delparasimpatico (aspetto decontratto di fasci muscolari cardiaci, aspetto contrattodelle pareti dei bronchi intraparenchimali così fissato dalla rigidità cadaverica,normale contenuto in glicogeno del fegato, congestione delle lacune spleniche).E’ da presumere che i suddetti segni di stimolazione del parasimpatico siano staticonseguenza della contusione del nervo vago per la lesione della regione latero-cervicale sinistra, la quale presumibilmente era stata anche responsabile della ca-duta bocconi a terra della vittima, subito dopo raggiunta ed uccisa con otto colpiconcentrati alla testa da distanza ravvicinata.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
94
Bibliografia1. Selye H., Thymus and adrenals in the response of the organism to injures and intoxica-tions. Brit. J. Exper. Path. 17, 234, 1936.—Testbook of Endocrinology. ActaEndocrinologica, Montreal, 1949. -The physiol. and pathology of exposure to stress.Acta In. Med. Publ. Montreal, 1950.
2. Tonutti E., Normale Anatomie der endokrinen Diisen und endokrine Regulation. In:Kaufmann E., Lehrbuch del speziellen pathologischen Anatomie. I B., II H.De Gruyter, Berlin, 1956, 1285-1423.
3. Allara E., Ghiandole a secrezione interna, In: Testut L., Latariet A., Trattato di Ana-tomia Umana. Vol. III, p. 667, UTET, Torino, 1961.
4. Aragona F., Le sindromi decorrenti con anossia. Soc. Ed. Pavese, Pavia, 1960.5. Aragona F., Patogenesi del blocco ghiandolare endocrino in alcuni avvelenamenti. Studio
sperimentale. Atti XX Congr.Naz. Soc. Ital. Med. Leg. Trieste 8-11 sett.1966,p.99-260. – Ancora sulle alterazioni morfologiche delle ghiandole a secrezione interna negliavvelenamenti ed il significato del blocco ghiandolare in alcuni avvelenamenti. Atti X Congr.Nax. Soc. Ital. Patologia. 20-22 aprile 1967, p. 639.
6. Aragona F., Biologia del comportamento. Recenti acquisizioni e prospettive criminologi-che. Piccin, Padova, 1977.
7. Aragona F., L’immagine istologica delle surrenali quale test psicologico post-mortale. Riv.Ital. Med. Leg. 12, 125, 1990.
8. Egdahl R.H., Cerebral cortical inhibition of pituitary-adrenal function. Endocrino-logy 68, 574, 1960.
9. Munson P.L., Briggs F.N., The mechanism of stimulation of ACTH secretion. Rec.Progr. Horm. Res. 11, 83, 1955.
10. Way L.E., Van Peenen P.F.D., The effects of chemical blocking agents on hypothalamo-pituitary adrenal activation. XX Congr. Inter. Physiology. Bruxelles, 1956.
11. Aragona F., Il blocco ghiandolare endocrino nell’avvelenamento acuto mortale (umano esperimentale) da cloroprocainamide. Giorn. Med. Leg. Inf. e Toss., 13, 70, 1967.
12. Aragona F., Il criterio anatomo-patologico nella diagnosi medico-legale di morte per veleno.Zacchia, 40, 3, 1965.
13. Aragona F., Ortese G., Un caso di morte per curarico di sintesti (Laudolissin). Studioanatomo-patologico e medico-legale. Atti. XX Congr. Naz Med. Leg. Ass. Cagliari-Sassari, 14-19 ott. 1965.
14. Fromm E., Anatomia della Distruttività Umana. Mondadori, Milano, 1975.15. Cioffi F.A., Aragona F., Tomasello F., Albanese V., Rilievi istopatologici nella sin-drome apallica post-traumatica. Acta Neurologica 30, 595, 1975.
16. Aragona M., Cardia G., Morte improvvisa metabolica in soggetto portatore di carci-noma polmonare ormonosecernente a decorso silente. Riv. Ital. Med. Leg. 12, 1170, 1990.
17. Umani Ronchi G., Bolino G., Traditi F., La Diagnosi di Epoca della Morte. Giuf-
95
Fisiopatologia dello stress
frè, Milano 2002, p. 105. 18. Bloom F.E., Battenberg E., Rivier C., Vale W., Corticotropin releasing factor (CRF):immunoreactive neurons and fibers in rat hypothalamus. Regul. Peptides 4, 43, 1982.
19. Pelletier G., Desy L., Cote J., Lefevre G., Voudry H., Labrie F., Immuno-electronmicroscopic localization of corticotropin-releasing factor in the rat hypothalamus. Neuro-endocrinology 35, 402, 1982.
20. Rho J.H., Neuroendocrine CRF motoneurons: intrahypothalamic axon terminals shownwith a new retrograde-lucifer-immuno method. Brain Res. 436, 143, 1987.
21. Cassell M.D., Gray T.S., Morphology of peptide-immunoreactive neurons in the rat cen-tral nucleus of amygdala. J. Comp. Neurol. 281, 320, 1989.
22. Gray T.S., Magnuson D.J., Neuropeptide neuronal efferents from the bed nucleus of thestria terminalis and central amygdaloid nucleus to the dorsal vagal complex in the rat. J.Comp. Neurol. 262, 365, 1987.
23. Scharrer E., Die Erklarung des Scheinbar pathologischen Zellbilder im Nucleus supra-opticus und Nucleus paraventricularis. Z. Neurol. 145, 462, 1933.
24. Scharrer E., Stammt alles Kolloid im Zwischenhirn aus der Hypophyse? Frankf. Z.Path. 47, 1, 1934.
25. Scharrer E., Ueber Zwischenhirndruse des Saugetiere. Sitzgebar. Ges. Morph. U.Physiol. Munch. 42, 36, 1935.
26. Scharrer E., Bemerkungen zu den Mitteilungen von R. Gaupp und Peters ueber die Kol-loidbildung im Zwischenhirn des Menschen. Z. Neurol. 155, 743, 1936.
27. Cavallero C., Istologia Patologica, Vol. I, C.E. Ambrosiana, Milano, 1968.28. Walls H.J., Fatal barbiturate poisoning. J. For. Med. 5, 27, 1958.29. Andersen R.N., Egdahl R.H., Effect of vasopressin on pituitary-adrenal secretion inthe dog. Endocrinology 74, 538, 1964.
30. Debold C.R., Sheldon W.R., De Cherney G.S., Arginin Vasopressin potentiatesadrenocorticotropin release induced by corticotropin releasing factor. J. Clin Invest. 75,533, 1985.
31. Bilezikjian V.M., Blount A.L., Vale W.W., The cellular action of vasopressin in cor-ticotrophs of the anterior pituitary: resistance to glicocorticoid action. Mol. Endocrinol.1, 451, 1987.
32. Rondeel J.M.M., Jackson I.M.D., Molecular biology of the regulation of hypothala-mic hormones. J. Endocrinol. Invest. 16, 219, 1993.
33. Gold P.W., Licinio J., Wong M.L., Chrousos G.P., Corticotropin releasing hormonein pathophysiology of melancholic and atypical depression and in the mechanism of de-pressant drugs. Ann. New York Acad. of Sciences. Vol. 771, 716, 1995.
34. Chappel P.B., Smith M.A., Kilts C.D., Bissette G., Ritchie J., Anderson C., Ne-meroff C., Alterations in corticotropin release factor-like immunoreactivity in discrete ratbrain regions after acute and chronic stress. J. Neurosci. 6. 2908-2914, 1986.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
96
35. Plotsky P.M., Vale W.W., Hemorrhage-induced secretion of corticotropin-releasing fac-tor-like immunoreactivity into the rat hypophysial-portal circulation and its inhibition by glu-cocorticoids. Endocrinology 114, 164-169, 1984.
36. Biörkund A., Hökfelt T., Kuhar M.J., Handbook of Chemical Neuroanatomy. El-sevier, Amsterdam, Vol. II, 1992, 168-169, .
37. Rohen J.W., Lutjen-Drecoll E., Funktionelle Histologie. Schattauer, Stuttgart,New York, 1990.
38. Gattig W., Gibt es einen Kriegsbasedow? Arch. Klin. Chir. 205, 580, 1944.39. Grelland R., Thyrotoxicosis at Ulleval Hospital in the years 1934-1944 with a specialview to frequency of the disease. Acta Med. Scand. 125, 108, 1946.
40. Meulengracht E., Epidemiological aspects of thyrotoxicosis. Arch. Int. Med. 83, 118,1949.
41. Weisman S.A., Incidence of thyrotoxicosis among refugees from naziprison camps. Ann.Intern. Med. 48,747, 1958.
42. Bencini A., Montalto B., Traumi ed ipertiroidismi. Minerva Medicoleg. 89, 31,1969.
43. Bram J., Psychic trauma in pathogenesis of exophtalmic goitre. A review of 3.343cases. Endocrinology 11, 106, 1927.
44. Wittkower E.D., Mandelbrote B.M., Thyrotoxicosis. In: O’Neill D., ModernTrends in Psychosomatic Medicine. Butterworth Co., London, 1955, p. 208.
45. Lidz Th., The Thyroid. In: Wittkover E.R., Cleghorn R.A., Recent Developmentsin Psychosomatic Medicine. Pitman&Son., London, 1954, p.58.
46. Levi L., Sympatho-adrenomedullary responses to emotional stimul: methodologic, physio-logic and pathologic considerations. In: Bajusz E., Clinical Neuroendocrinology. Kar-ger, Basel, 1967, p. 58.
47. Starr P., La Tiroide. In: Grollman A., Fisiopatologia Clinica.Vallardi, Milano,1961, p. 664.
48. Rastogi G.K., Malhotra M.S., Srivastava M.C., Sawhney R.G., Dua G.L., Sri-dharan K., Hoon R.S., Singh I., Study of the pituitary-thyroid function at high alti-tude in man. J. Clin. Endocrinol. Metab. 44, 447, 1977.
49. Zenow Z.I., Über die Veränderungen im endokrinen System bei experimentelle örtlicherErfrierung. Virch.Arch. 312, 486, 1944..
50. Lesser J., Winzler R.J., Michaelson J.B., Effect of ioide on thyroid gland of rats keptat low temperature. Proc. Soc. Biol. A. Med. 70, 571, 1949.
51. Sellers E.A., You S.S., Role of the thyroid in the metabolic responses to a cold environ-ment. Amer. J. Physiol. 163, 81, 1950.
52. Rand C.G., Riggs D.S., Talbot N.B., The influence of environmental temperature onthe metabolism of the thyroid hormone in the rat. Endocrinology 51, 562, 1952.
53. Brown-Grant K., Von Euler C., Harris C., Reichlin S., The measurement and ex-
97
Fisiopatologia dello stress
perimental modification of thyroid activity in the rabbit. J. Physiol. 126, 1, 1954.54. Brolin S.E., A study of structural anf hormonal reactions of the pituitary body of therats exposed to cold. Acta Anatomica, vol. II, 3, 1946.
55. Vojtkevic A.A., Der Einfluss der Temperatur auf die thyreotrope Aktivitat der Hypo-physe. Dokl. Akad.Nauk. 69, 873, 1949.
56. Risse W., Weiler G., Benker G., Vergleichende histologische und hormonelle Untersu-chungen der Schilddruse unter besonderer Berucksichtigung des plotzlichen Kindstodes(SIDS). Z. Rechtmed. 96, 31, 1986.
57. Peeke P.M., Chrousos G.P., Hypercorticosolism and obesity. Ann. New YorkAcad.Sci. 771, 1995, p.671.
58. Boerman A.J., Antonozzi I., ACTH. Encicl. Med. Ital., II Ed. Vol. I, 1973, 391. 59. Pancheri P., Stress Emozioni Malattia. EST Mondadori, Milano, 1980.60. Muller E., Rotter W., Über histologische Veränderungen beim akuten Hohentod. Beitr.
Path. Anat. u. allg. Path. 107, 1256, 1942. 61. Muller E, Rotter W., Carow G., Kloos K.F., Über Untersuchungergbnisse bei To-desfällen nach allgemeiner Unterkuhlung des Menschen in Seenot. Beitr. Path. An. u.allg. Path. 108, 551, 1943.
62. Baker D.G., Ashworth M.A., Effect of exposure to cold on the islets of Langerhansin the rat. Am.J.Physiol. 192, 597, 1958.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
98
Parte Seconda
Capitolo I
Lo stress: aspetti patologici
Aspetti introduttivi Come già detto in precedenza, lo stress, secondo Selye (1), consiste in una sin-
drome di carattere essenzialmente fisiologico diretta a mantenere stabile l’omeo-stasi psico-biologica dell’organismo che ne è interessato, tanto che il Selyemedesimo l’ha definita “sindrone generale di adattamento”. Si è visto come nellafase iniziale dello stress si liberano catecolamine sia a livello delle terminazionisimpatiche periferiche di tutti gli organi, sia nel sangue circolante immessivi dallamidollare surrenale: il che avviene in tempi brevissimi, valutabili in frazioni di se-condo.
Gli effetti metabolici delle catecolamine, come già in parte ricordato, sonomolteplici, tanto che Tepperman (2) ha espresso un concetto sempre valido nellafrase seguente: “Gli effetti dell’adrenalina e della noradrenalina sono ubiquitari;si può dire che non esista un campo della fisiologia in cui questi ormoni non ab-biano a dire la loro. Le loro manifestazioni a livello del cervello, del cuore e delcircolo, della muscolatura liscia del tratto gastro-enterico, dell’utero, dell’occhio,dei bronchi, della muscolatura scheletrica, della coagulazione del sangue, dellamilza, delle distribuzione delle calorie immagazzinate nell’organismo, e di moltealtre funzioni fisiologiche sono così varie e così ricche che è difficile siano cono-sciute nei dettagli da una singola persona”. In altri termini, la mobilizzazione ca-tecolaminica, con i suoi effetti a livello di qualsiasi organo o apparato, ponel’organismo in una condizione ottimale per affrontare le più disparate condizionidi emergenza: basti pensare, come già ricordato, agli effetti sul ricambio glicidicoe lipidico che sono essenziali per sorreggere tempestivamente le funzioni ner-vose, cardio-circolatorie e della muscolatura scheletrica. E’ del pari di grande im-portanza l’intervento della corteccia surrenale, i cui increti sono indispensabiliper il restauro calorico connesso al dispendio energetico causato dalle calecola-
99
mine. Pertanto, le conseguenze patologiche degli stress, di cui ci si occupa in questo
capitolo, costituiscono fenomeni anomali da correlare a quelle forme di stressche, persistendo a lungo nel tempo, cagionano effetti nocivi connessi da una partealla costante azione catecolaminica e dall’altra parimenti costante azione degli ste-roidi surrenalici, con sommazione delle rispettive conseguenze patologiche, ov-vero con conseguenze patologicge dissociate e disomogenee per prevalenza degliuni o degli altri. Ad esempio, per quanto attiene al miocardio vi è netta prevalenzadegli effetti nocivi delle catecolamine, come anche per quanto attiene all’apparatoimmunitario pur se qui vi sia anche chiara incidenza degli effetti nocivi degli ste-roidi surrenalici (3,4).
Peraltro, nelle manifestazioni patologiche degli stress è anche essenziale la di-sposizione costituzionale.
Per quanto attiene ai danni miocardici da stress la psichiatria moderna dedicaampio spazio ai rapporti patogenetici fra stress e cardiopatie ischemiche richia-mando l’attenzione sul ruolo svolto dalla personalità del soggetto nella dinamicadella cardiopatia. Si parla a questo riguardo di personalità di tipo A e di tipo B: laprima caratterizzata da un particolare complesso comportamentale-emotivo im-pegnato in una lotta cronica ed eccessiva per ottenere un numero illimitato dicose nel più breve periodo di tempo, anche in contrasto con le situazioni am-bientali; la seconda da comportamento pacato, non competitivo, capace di rilas-sarsi, riflessivo, tranquillo, gioviale e soddisfatto. La personalità più esposta allamalattia coronarica sarebbe ovviamente quella di tipo A, in quanto maggiormenteresponsiva agli stress con effetti particolarmente in senso psicofisiologico e neu-roendocrino come documentato da una più spiccata attivazione della rispostaneurovegetativa-adrenergica (Biondi e Pancheri, 5) e dai conseguenti riflessi diordine metabolico e cardio-circolatorio.
A questo riguardo, tuttavia, esistono sostanziali perplessità in autorevoli Trat-tati di cardiologia. Nel trattato di Hurst (6) si asserisce quanto segue: “A propo-sito delle personalità di tipo A e di tipo B come fattori di rischio, oltre alledifficoltà, dal punto di vista pratico, di dividere gli esseri umani in personalità didiverso tipo, si dovrebbe tener presente che non è stato scientificamente dimo-strato un ruolo delle personalità, ammesso che esista, nella patogenesi dell’atero-sclerosi coronarica e, di conseguenza, la personalità non dovrebbe esserepresentata a un tribunale nell'ambito delle probabilità o di una ragionevole cer-tezza medica”.
Qui, a parer nostro, sarebbe più opportuno non trascurare gli effetti del tem-peramento nella valutazione causale fra stress e malattia, per la conoscenza cheil temperamento si riferisce alle caratteristiche dinamiche dei singoli individui, ed
Marcello Aragona, Francesco Aragona
100
in altri termini agli aspetti della personalità che risultino strettamente connessi alsubstrato biologico. Ciò tenendo conto degli apporti della Scuola costituzionali-stica italiana (De Giovanni, Castellino, Viola) e segnatamente dell’interpretazionesostenuta da Pende (7). Secondo il quale il temperamento va distinto:
1) dal lato endocrino, in varietà iper- e ipofunzionali di ogni ghiandola a se-crezione interna;
2) dal lato neurovegetativo in soggetti simpatico-stenici e parasimpatico-ste-nici, ed individui in cui
esiste labilità dell’una o dell’altra sezione del sistema neurovegetativo.
Quest’ultima concezione trova valido supporto nelle manifestazioni patologi-che delle varie disendocrinie. Qui è sufficiente far cenno di quelle più significa-tive per questo scopo: basti pensare al morbo di Basedow, per quanto attiene allatiroide, al morbo di Cushing per quanto attiene alla corteccia surrenale, ai soggettivagotonici ed a quelli simpaticotonici, per fare alcuni esempi, rimandanto ai Trat-tati di Patologia e di Clinica per maggiori dettagli.
Non è tuttavia da escludere che lo stress sia in grado di condurre a conse-guenze patologiche anche in soggetti rientranti nella normalità quando il mede-simo si ripete nel tempo ad intervalli assai brevi o, addirittura, in continuitàcronologica, e ciò per la circostanza che in tali condizioni mancano spazi tem-porali che consentano all’organismo un recupero del dispendio psicofisico veri-ficatosi nelle risposte fisiologiche, già illustrate a livello neuroendocrino emetabolico (8).
Nello stesso senso, quale prevenzione dell’evoluzione patologica dello stress,depone la sensazione di felicità, già preconizzata da Voltaire (9) come fattore fa-cilitante del benessere psicofisico, la quale è considerata fondamentale per lostesso scopo dal buddismo tibetano (10) specie in ambito lavorativo. A questo ri-guardo il Dalai Lama insiste sul ruolo essenziale della meditazione produttiva,laddove l’aggettivo “produttiva” non si riferisce all’utile economico bensì alla sod-disfazione intima nell’esercizio del lavoro, conducente alla felicità durante il lavoro,quand’esso non è usurante ma esercitato con interesse. In effetti “la soddisfa-zione per il proprio lavoro” - afferma il Dalai Lama - “tende a rendere l’indivi-duo complessivamente più felice, mentre coloro che sono felici nella vita tendonoad essere felici nel lavoro”. Queste affermazioni del monaco buddista coincidonocon quanto in passato da molti personaggi della cultura occidentale, sui quali giàsi è trattenuti nel capitolo I della Prima Parte, per i quali gli stress non solo nonavevano prodotto dei danni di carattere psicologico, ma invece avevano grande-
101
Fisiopatologia dello stress
mente migliorato le qualità intellettuali, produttive di benessere psichico (v. S.Ago-stino, Tommaso Campanella, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Beethoven, SilvioPellico, ecc.). Giordano Bruno, in particolare, che era in possesso di una cultutavastissima, di fronte al tribunale inquisitorio della confessione cattolica, per evi-tare il rogo aveva ammesso di essere incorso in errate valutazioni di natura teo-logica, ma rifiutò di ammettere suoi errori nell’ambito delle sue affermazioni dicarattere astronomico conformi a quelle innovative copernicane. In questo at-teggiamento difensivo Giordano Bruno si era verosimilmente convinto che unasua eventuale abiura anche delle suddette conoscenze scientifiche astronomicheavrebbero potuto evitare la sua morte fisica, ma non già la morte civile comepensatore. Fu tuttavia condannato a morte e giustiziato sul rogo (1600), ma lastoria non ha dimenticato la sua poliedrica personalità scientifica.
Quanto sopra detto circa l’importanza preventiva della conseguenze patolo-giche degli stress mediante temporanei intervalli durante lavori molto impegna-tivi è confermato da quanto osservato nella casistica da noi studiata nei vari organibersaglio e specialmente nel cuore, tenendo conto dell’estrema fugacità dell’atti-vità contrattile esplicata della catecolamine sulle fibre miocardiche. Infatti, perquanto riguarda la noradrenalina liberata nei tessuti a livello delle terminazionisimpatiche periferiche la sua attività rimane efficace solo per pochi secondi; men-tre la noradrenalina e l’adrenalina immesse nel circolo ematico dalle cellule cro-maffini della midollare surrenale risultano funzionalmente efficaci per 10-30secondi, dopo di che la loro attività va decrescendo fino ad estinguersi entro uno-molti minuti (11). Le lesioni cardiache riscontrate da noi in elevata frequenza nellevittime di omicidio (vedi capitolo VI di questa seconda parte) dimostrano, con-siderata la brevissima iperattività contrattile delle catecolamine, qui sopra ricor-data, che nei soggetti studiati, per lo più latitanti, gli intervalli temporali esenti dastress erano stati di assai breve durata, o addirittura assenti, tanto da non con-sentire l’annullamento dell’effetto contrattile, divenuto perciò cardiotossico, dellecatecolamine costantemente liberate negli stress, come già documentato istolo-gicamente nella midollare surrenale (vedi capitolo IV/2.1.1. della parte prima).
Marcello Aragona, Francesco Aragona
102
Capitolo II
Stress cronici e danni del sistema nervoso centrale
1. Disordine post traumatico da stress (DPTS) Dai dati della letteratura sull’argomento, soprattutto anglosassone, risulta che
un numero piuttosto rilevante di individui traumatizzati (8-12%) manifesta undisordine post-traumatico da stress (DPTS) successivamente all’esperienza trau-matica, che può essere di vario genere, ma che nella maggior parte dei casi deveessere stato protratto nel tempo ed avere coinvolto soprattutto psicologicamentechi ne è affetto. La sindrome si riscontra specialmente nei veterani di guerre, incoloro che sono stati prigionieri in campi di concentramento, in soggetti in cat-tività impossibilitati a fuggire, specie quando trovansi in condizioni di isolamento,fisico e sociale, in individui testimoni di disastri naturali, in soggetti condannati alavori forzati, in vittime di violenza sessuale ripetuta, particolarmente nell’infan-zia e nell’ambito familiare. L’importante ruolo patogenetico della violenza sessualeinfantile è stato efficacemente ribadito da Manna (12), il quale ha anche sottoli-neato che i pazienti suddetti sono predisposti all’abuso di droghe proibite, di psi-cofarmaci e di alcol.
Di recente è stato introdotto nella legislazione italiana il reato di “Salking”(art.612bis c.p.) per persistenti attenzioni persecutorie affettive: punibile con lapena fino a 4 anni di reclusione (vedi Harold Ege e Aldo Dinacci. LeadershipMedica 270 e 271, 2008).
Secondo Gold e coll. (13) negli Stati Uniti d’America le sindrome depressivenel loro complesso, nelle quali è compreso anche il DPTS, in quanto assai diffusecostituiscono un notevole problema sociale per il fatto che tendono a diminuirela produttività, incidono nelle relazioni sociali e familiari, ove producono soffe-renza psicologica, diminuiscono le aspettative di vita: per cui si tratta di uno deimaggiori problemi per la salute in quegli Stati.
In un’indagine molto accurata condotta da Herman nel 1995 (14) su quest’ul-tima sindrome, la formulazione diagnostica corrente di DPTS deriva in primoluogo da osservazioni non solo su sopravvissuti ad eventi traumatici temporal-mente relativamente circoscritti, come combattenti, disastri naturali, violenze suminori, specie sessuali, ma anche su eventi traumatici prolungati e ripetuti neltempo che si realizzano quando la vittima è in stato di cattività, incapace di fug-gire e sotto il controllo dei carcerieri in strutture pubbliche o di rapitori in ambitodelinquenziale. Esempi di questo genere comprendono le carceri, i campi di con-centramento, i campi di lavori forzati, i rifugi dei sequestri di persona. Simili con-dizioni esistono anche in alcune confessioni religiose, nelle case chiuse, in altre
103
organizzazioni di sfruttamento della prostituzione e persino in ambito familiare.La letteratura di lingua inglese è molto vasta e riguarda essenzialmente le indaginicondotte negli ultimi 50-60 anni, concernente soprattutto casistica attinente aprolungata sopraffazione domestica, sessuale, politica, a conflitti bellici, a so-pravvissuti a campi di sterminio.
Da questa vasta letteratura risulta che il DPTS comprende un quadro sinto-matologico eterogeno e complesso che comporta anche modificazioni della per-sonalità fino a deformazione dei rapporti parentali e della propria identità. Isintomi sono perciò molteplici che riguardano multiple funzioni: somatiche, co-gnitive, comportamentali e relazionali e che si concretano essenzialmente in in-sonnia, disfunzioni sessuali, dissociazione ideativa, collera, automutilazioni,tendenza al suicidio, tossicodipendenza, alcolismo. Secondo Herman, la suddettacomplessa sintomatologia si può sintetizzare in tre fondamentali categorie e cioènelle sequele somatiche, dissociative e affettive.
La somatizzazione è dimostrata nello stato di ipervigilanza, di ansietà e di agi-tazione, senza alcun momento di calma o di conforto. I soggetti si lagnano nonsolo dell’insonnia, ma manifestano anche reazioni di spavento e di agitazione,nonché di cefalea intensa, di disturbi gastro-intestinali, di dolori addominali, dor-sali e pelvici, e spesso anche di tremori, di sensazioni di soffocamento, o di nau-sea. In soggetti sopravvissuti all’olocausto nazista le reazioni psicosomaticheapparivano praticamente ininterrotte durante l’arco di tutta la giornata. Simili os-servazioni sono state osservate successivamente in deportati in campi di con-centramento nel Sud-Est asiatico nel 1989 da Krol e coll.(15) e da Kinzie e coll.nel 1990 (16), nonché in bambini esposti in azioni di guerra, come meglio saràspecificato successivamente. Secondo Briquet (17), i disordini da somatizzazionesono molto evidenti nei traumi infantili, per maltramenti domestici o abusi ses-suali. In uno studio di 87 bambini di età inferiore ai 12 anni, classificati come iste-rici, Briquet aveva notato che un terzo era
stato “abitualmente maltrattato o costantemente mantenuto in stato di terroreo che era ruvidamente trattato dai loro genitori”. In uno studio condotto su 60donne con disturbi somatici Morrison (18) osservò che il 55% era stato molestatosessualmente nell’infanzia, prevalentemente in ambito familiare.
La dissociazione ideativa riguarda soggetti in cattività, i quali divengono capacidi dissimulare e minimizzare coscientemente i disturbi connessi al trauma dellaperduta libertà. Si ritiene che questi atteggianenti siano motivati per contrastarela fame, il freddo e il dolore (Partnoy, 19; Sharansky, 20). Durante prolungati pe-riodi di isolamento alcuni prigionieri sono capaci di simulare stati di trance, or-dinariamente osservabili in soggetti in ipnosi, anche con fenomeni dissociatividella personalità. Si manifestano pure alterazioni del senso del tempo, della me-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
104
moria. Le alterazioni del senso del tempo riguardano soprattutto l’obliterazionedegli eventi passati e anche delle prospettive future, tanto che l’interruzione dellacontinuità fra passato e presente frequentemente persiste anche dopo la libera-zione del prigioniero. Quest’ultimo può dare l’impressione di ritornare al tempoordinario mentre psicologicamente rimane legato al periodo della prigionia (Jaffe,21). Nei soggetti sopravvissuti a prolungati abusi infantili, queste capacità disso-ciative sono enormemente sviluppate, tanto che Shengold (22) afferma: “le ope-razioni di frammentazione mentale” elaborate da bambini sottoposti ad abusisono finalizzate ad evitare “la delusione dei buoni genitori”. Tali fenomeni dis-sociativi sono sempre connessi a storie di abusi infantili, massivi e prolungati(Putman, 23; Ross e coll., 24). Esistono tuttavia individui con carattere moltoforte che possono resistere a dure prove di prolungati abusi, nei quali fa spiccouna fede intatta, ma si tratta di individui eccezionalmente rari. La maggior partesperimenta l’amarezza di essere abbandonata dagli uomini e da Dio (Wiesel, 25),e per questo motivo si transita in un tenace stato di depressione, che costituisceil sintomo fondamentale dei soggetti cronicamente traumatizzati (Walker, 26; Hil-berman, 27; Herman, 28; Kinzie e coll., 29; Goldstein e coll., 30). Così che l’ipe-reccitamento cronico ed i subentrati sintomi del DPTS si fondono con i sintomivegetativi della depressione, realizzando così quella che Niederland (31) definivala “triade dei sopravvissuti”: insonnia, incubi, disturbi psicosomatici. Comunquei sintomi dissociativi della sindrome si fondono con le difficoltà di concentra-zione della depressione, che costituisce il sintomo di maggiore rilevanza e checonduce all’isolamento sociale.
Per quanto riguarda i prigionieri che subiscono anche il peso della depres-sione, si è visto che spesso essi non riescono ad esprimere collera contro il car-ceriere, verosimilmente con lo scopo di evitare qualsiasi ritorsione per loroeventuale ribellione, per cui gli sforzi che essi fanno per controllare la loro rab-bia possono esarcebare ulteriormente l’introversione sociale bloccando qualsiasiiniziativa e produrre odio di sé stessi con tendenza alle automutilazioni e al sui-cidio. Frequente tendenza al suicidio è stata descritta in donne seviziate. Gayford(32) aveva riferito che su 100 donne seviziate il 42% aveva tentato il suicidio. Pur-troppo il suicidio è una comune tragica conclusione del DPTS. Esempio classicoè il suicidio di Primo Levi nel 1987 reduce dal campo di sterminio nazista di Au-schwitz, e più di recente quelli dei reduci della guerra delle Falkland :300 reduciargentini e 264 inglesi (La Stampa, 8 aprile 2002, pag.12) e quelli dei marines ame-ricani nella guerra d’Iraq: 14 casi, negli ultimi sette mesi rispetto alla data dell’ar-ticolo (La Repubblica, 14 ottobre 2003). Quest’ultimo quodiano dava anchenotizia di 478 militari americani rimandati in patria per “malattie mentali” (maleoscuro qualificato dal Pentagono statunitense), di contro ai 329 morti per gli
105
Fisiopatologia dello stress
eventi bellici. Lo stesso articolo de “La Repubblica”, firmato da A.Flores D’Ar-cais, commentava: ”Il Pentagono vuole capire se questi suicidi siano la spia di unmalessere più profondo, qualcosa che potrebbe nel giro di pochi mesi esploderein modo più grave. Per i medici è una situazione abbastanza tipica: molti eranoarrivati in Iraq convinti di essere trattati come liberatori, di non trovare una si-tuazione e una popolazione ostile, se non altro una volta che il regime di Saddamera stato abbattuto. Più passa il tempo invece e più le cose vanno peggio, le mi-lizie pro Saddam diventano più audaci e feroci, i soldati USA si sentono accer-chiati, le crisi depressive aumentano…..”.
L’eccezionale frequente incidenza della sindrome post-traumatica da stress neimilitari dislocati specie in Iraq ha avuto recentissima conferma in uno studio diHoge e coll. (33). Detti Autori hanno condotto la loro indagine su militari ope-ranti sia in Afghanistan che in Iraq ed hanno visto che in quelli operanti in Iraqla sindrome suddetta colpiva il 19.5% dei militari, che presentavano gravi pro-blemi psicologici (depressione, ansia, tendenza al suicidio, raptus di violenza finoad istinti omicidi, abuso di farmaci e di bevande alcoliche). La suddetta percen-tuale aumentava fino al 27.9% quando ai problemi psicologici di natura depres-siva si associava l’ansia. Il fattore etiopatogenetico più importante è stataconsiderata la guerriglia, che manteneva i soggetti in uno stato di allerta persi-stente per la mancanza di certezze nel riconoscere i veri nemici, nel prevedere itempi degli agguati e di individuare i luoghi ove questi sarebbero avvenuti, postoche non era possibile avere sicurezza neppure nei luoghi o strutture teoricamentepiù protetti. Lo stato di stress in tali soggetti era praticamente attuale, senza soste,in tutto l’arco delle 24 ore.
Un esempio emblematico della sindrome suddetta emerge dalla storia del “sol-dato Dwyer” di 27 anni osannato dalla stampa statunitense nel 2003 per il suoeroico comportamento durante un combattimento in Iraq: egli aveva coraggio-samente portato in salvo un bambino iracheno terrorizzato rischiando la vita. Ilsoldato suddetto, rientrato in patria, nell’ottobre 2005 dava in escandescenze im-motivate: aveva del tutto perduto il controllo di se stesso sparando all’impazzatadentro la sua abitazione in Long Island (Stato di New York). Dopo tre ore di as-sedio venne catturato dalla polizia chiamata dai vicini terrorizzati. Sembra cheper lo stress connesso alle esperienze vissute in guerra abbia fatto uso smodatodi farmaci antidepressivi (La Repubblica 12.10.2005).
Le più gravi deformazioni della personalità si sono osservate soprattutto neisopravvissuti ai campi di concentramento nazisti, molti dei quali si sono lagnati:”io sono adesso una diversa persona”; e addirittura: “io non sono una persona”.Quanto sopra è stato descritto mirabilmente da Primo Levi nel suo libro dal ti-tolo “Se questo è un uomo” (Einaudi, 1958, 1963, 1987). Primo Levi, come già
Marcello Aragona, Francesco Aragona
106
detto, concluse la sua esistenza col suicidio nel 1987 (era nato nel 1919).Le automutilazioni sono comportamenti che sembrano essere nettamente di-
stinti dai tentativi di suicidio. Queste forme compulsive di autolesionismo sareb-bero strettamente associate con storie di prolungati e ripetuti eventi traumatici esono spesso comuni sequele di protratti abusi infantili (Briere, 34; van der Kolke coll., 35).
Al contrario Victor Frankl, che ha subito la prigionia in campi di concentra-mento e lo sterminio della propria famiglia, è riuscito a sopravvivere attaversouna reinterpretazione con attribuzione di significato agli eventi traumatici. Que-sto è stato un percorso di crescita personale che si è concretizzato in un modelloterapeutico umanistico-esistenziale descritto nel libro “men’s search for meaning”(1946) e adesso ampiamente utilizzato.
2. Problemi psicologici in fanciulli esposti ad azioni di guerraIn quest’ultimo quindicennio sono stati eseguiti studi d’ordine statistico sugli
effetti nocivi espletati sul sistema nervoso centrale di bambini e fanciulli espostiad azioni di guerra: in Kuwait durante la guerra del golfo (Nader e coll., 36); inIsraele (Laor e coll., 37; Thabet e Vostanis, 38); in Iraq-Kurdistan (Ahmad e coll.,39); in Croazia (Aidukovic, 40); in Bosnia (Papegeorginu e coll., 41; Smith e coll.,42); nel Sudan del Sud (Paardekooper e coll., 43); in Palestina (Baker, 44); in Ar-menia (Goennjian e coll., 45).
In uno studio del 1999, Thabet e Vostanis (46) avevano esaminato gli effettidi un conflitto armato di vecchia data (l’Intifada fra il 1987 ed il trattato di pacedi Oslo del 1993) in bimbi palestinesi: il 41% mostrava reazioni post-traumaticheda stress da moderate a gravi e il 27% un alto grado di ansietà e disturbi com-portamentali. Nello stesso periodo Baker (44) aveva notato nei bambini e nei fan-ciulli un’elevata frequenza di problemi psicologici, come paura per l’abbandonodella casa (28%), terrore dei soldati (47%), incubi (7%) a causa della violenza po-litica e militare.
Più di recente Thabet e coll. (42) hanno esaminato 180 bambini: 91 (51.1%)dei quali erano stati esposti a bombardamenti e a demolizioni delle case, ed i ri-manenti 89 (49%) studiati come controlli. Nei bambini esposti allo stress i sud-detti Autori hanno osservato che 60 dei 91 (66%) avevano subito gli eventi comefortemente stressanti, caratterizzati nel 53.58% da difficoltà di concentrazione, nel52.57% da disturbi del sonno e nel 47.5% da rifiuto del ricordo. Queste reazionierano simili a quelle riportate in bambini esposti alla guerra Iraq-Kurdistan, inbambini iraniani profughi ed in bambini croati profughi. Thabet e Vostanis, incontrasto con l’ipotesi che tutte le forme di psicopatologia possano colpire mag-giormente i bambini direttamente esposti, sostengono l’esistenza di una dipen-
107
Fisiopatologia dello stress
denza diversa nella manifestazione dei sintomi e dei disordini ansiosi, i quali ri-sultano in modo consistente più elevati in bambini che vivono in zone sopraf-follate nella striscia di Gaza benchè non direttamente esposti ai bombardamentie alla distruzione delle abitazioni. Questi reperti si accordano con quelli di altrecircostanze riguardanti bambini esposti a minacce di guerra. Secondo Thabet eVostanis la spiegazione più plausibile è che i bambini, esposti alla violenza e alleesperienze della guerra attraverso i media e le reazioni degli adulti, manifestinoun’ansietà anticipatoria per mezzo della meditazione o della preoccupazione circaquanto possa a loro accadere.
Un resoconto vissuto in prima persona su questo argomento è quello descrittodalla regina Rania di Giordania Al Abdullan del regno ascemita di Giordania,nella sua qualità di Difensore emerito dell’Unicef per l’infanzia, pubblicato su“Repubblica” del 5.4.2008, dal titolo “Quei bambini di Gaza che sognano lascuola”, di cui qui di seguito trascriviamo alcuni tratti significativi: “…tutti i bam-bini di Gaza vedono la propria esistenza quodinianamente avvilita; un soffoca-mento lento e crudele del loro spirito e dei loro sogni. Invece di godere diprospettive migliori per il futuro, sono intrappolati in una prigione virtuale, dovele cose che ogni bambino dovrebbe avere garantite gli sono invece portate via: ildiritto a giocare, ad andare a scuola, ad avere abbastanza da mangiare, luce suffi-ciente per studiare di sera, e una casa dove sentirsi al sicuro. Il peso di uno dei piùlunghi conflitti in corso al mondo grava sulle loro esili spalle, schiacciandone l’in-fanzia e infliggendo loro cicatrici psicologiche che potrebbero non rimaginarsimai...”.
3. Nanismo da deprivazionePer quanto attiene agli effetti patologici della deprivazione affettiva la lettera-
tura scientifica moderna non ha aggiunto nulla a quanto in passato (circa un cin-quantennio fa) segnalato da vari studiosi.
Il nanismo da deprivazione è un valido esempio di un’abnorme risposta or-ganica alla carenza affettiva materna, la quale, con Gardner può definirsi un espe-rimento di natura. Si tratta di una sindrome biopsichica che insorge in bambiniche sin dalla nascita sono vissuti in ambienti emotivamente carenti per ricoveroin brefotrofi o per carenza affettiva da parte dei genitori, specie della madre. Talibambini, come dimostrato da studi di Spitz (1946- 1969: 47, 48), presentano ma-nifestazioni di ansietà e di tristezza, alternano periodi d’insonnia protratta e ditorpore, e mostrano un deficiente sviluppo staturale nonostante l’apporto diete-tico congruo e le meticolose cure mediche. L’A. notò anche un’elevata mortalità,specie fra il settimo e il dodicesimo mese di vita. I bambini che sopravvivonomostrano tutti gravi ritardi fisici. Successivi studi hanno confermato le osserva-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
108
zioni di Spitz (47, 48). Gardner asserisce che il disordine ormonale sul quale sibasa la sindrome sarebbe espresso da un difetto di ormone somatotropo e diACTH. Per quanto riguarda il somatotropo, il quale nel suo ritmo circadiano, trail V e il XV anno di vita, mostra massima concentrazione ematica dopo circaun’ora dall’inizio del sonno, si è visto che la sua secrezione è anormalmente altain bambini affetti da nanismo da deprivazione d’età inferiore ai 3 anni, mentredetta secrezione è apparsa al di sotto della norma in bambini affetti dalla stessasindrome d’età superiore ai 3 anni.
A nostro avviso possono essere avanzate altre ipotesi: 1) un asincronismo funzionale degli ormoni ipofisari, specie del somatotropo,
la cui precoce ed intempestiva ipersecrezione potrebbe non trovare ancora in pe-riferia, in corrispondenza delle cartilagini di accrescimento osseo, la disponibilitàdei relativi recettori ormonali per il naturale incremento di detto accrescimento;
2) un esaurimento funzionale a livello ipotalamo-ipofisario, o soltanto a livelloipofisario, in rapporto alla precoce e protratta stimolazione da stress associata aiprolungati periodi d’insonnia. Ai quali ultimi va anche attribuito un effetto alte-rativo dei bioritmi ormonali, posto che in condizioni di normalità se non si dormeviene a mancare la secrezione di vari ormoni, tra cui quello dell’accrescimento,dell’ACTH, degli steroidi surrenalici.
Queste opiniori sarebbero confortate dalla circostanza che, essendovi nelcorso degli stress anche liberazione di somatotropo, secondo indagini di vari AA.,il difetto di crescita non troverebbe adeguata spiegazione. A ciò si aggiunga chegli stress e la perdita di sonno aumentano sensibilmente il turnover della seroto-nina encefalica e che, a sua volta l’impoverimento di tale sostanza nel sistema ner-voso centrale, ottenibile nel corso di stress protratti e mediante il bloccofarmacologico della sua sintesi è causa di grave insonnia. Si è pure visto che l’in-sonnia è immediatamente reversibile dopo somministrazione di triptofano, pre-cursore della serotonina, il che sta a favore di un meccanismo serotoninergicoper il normale ritmo del sonno. Risulta, perciò, che l’insonnia protratta, se capacedi produrre impoverimento di serotonina a livello encefalico, possa di per se stessaimpedire la normale ripresa del ritmo del sonno e quindi della crescita.
In sostanza, si deve ammettere che la carenza emozionale e la perdita di sonno,in quanto gravi situazioni di stress psichico, condizionino in un primo tempo,come tutti gli stress, accanto ad un disordine delle amine biogene encefaliche,un’iperincrezione intempestiva ipotalamo-ipofisaria e delle ghiandole satelliti colconseguente grave dispendio energetico, alla quale, successivamente, perdurandola causa, subentra l’esaurimento funzionale. Ciò anche in relazione all’immatu-rità del sistema ipotalamo-ipofisario. Altrimenti si assisterebbe ad un accresci-
109
Fisiopatologia dello stress
mento staturale rapido. Ed in effetti, se lo stato di tensione emotiva intervienemeno precocemente e se esso non è molto intenso, si assiste ad un aumento sta-turale. Landauer e Whiting (52) e Whiting e coll. (53), in uno studio intercultu-rale d’ordine statistico ed in un altro relativo a ricerche longitudinali americanesulla crescita e sulla salute, hanno rilevato che la tensione emotiva sperimentatadurante l’infanzia era in rapporto con la statura più alta nell’età adulta. Gli AA.hanno escluso l’incidenza di altri fattori, quali gli effetti della dieta, della razza,della posizione geografica, della statura dei genitori, delle malattie e della morta-lità selettiva, degli effetti delle cure benevole assicurate dai genitori. Per cui, d’ac-cordo con Levine (54), si può affermare che un certo grado di stress durante lavita infantile è necessario per lo sviluppo di un comportamento adattativo nor-male.
Va sostanzialmente equiparata al nanismo da deprivazione la sindrome de-scritta da Carlson ed Earls (55) su bambini viventi in disagiatissime condizioni inun orfanotrofio della Romania. Gli AA.hanno visto che in quei bambini esistevaun aumento della concentrazione del cortisolo durante certi periodi del giorno,associato ad uno sviluppo mentale e motorio ritardato.
Inoltre al nanismo da deprivazione affettiva, che consegue, appunto, al sem-plice abbandono da parte della madre e che perciò si basa su un comportamentogenitoriale astensionista (stress passivo), esiste una casistica di privazioni infan-tili connessa a comportamenti sadici dei genitori con rifiuto del naturale sosten-tamento fisico e psicologico dei figli ed anche con loro segregazione in istitutiinidonei o addirittura con omissioni dolose delle cure prescritte dai sanitari perfronteggiare il conseguente difetto di crescita di questi bambini (stress attivo).Un caso del genere è stato segnalato dalla stampa quotidiana (La Stampa,22.11.2003, pag. 11), nel quale la madre quarantenne, affetta da “nevrosi osses-siva”, aveva dichiarato che la figlia di appena 5 anni non cresceva, non si alimen-tava e non assimilava quel poco che riusciva a mangiare. Si è poi scoperto che erala madre stessa ad impedire che la figlia si alimentasse, che distaccava le flebomentre la bambina dormiva e che le sommistrava di nascosto eccessive dosi di las-sativi. La donna è stata condannata a due anni di reclusione per maltrattamenti elesioni personali. La mite sentenza è connessa all’accertato stato di infermità men-tale della donna.
Va qui ricordato che, secondo il parere della letteratura medica, le suddetteprivazioni infantili possono dar luogo, nella vita adulta, alla cosiddetta “sindromedi Munchausen”, caratterizzata soprattutto da comportamenti morbosi dichia-rati come reali, ma in realtà simulati nella maggior parte dei casi.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
110
4. Burnout (Esaurimento emozionale)La definizione di burnout più comunemente usata è quella proposta da Ma-
slach (56) e da Jackson e coll. (57). Detti AA. definiscono il burnout come unasindrome da esaurimento emozionale con depersonalizzazione e ridotte capacitàdi realizzazione personale. L’esaurimento emozionale si riferisce alla sensazionedi essere fortemente impegnato emozionalmente e di avere perduto la capacità diintraprendere qualsiasi contatto con le persone con prevalenza di sentimenti diapatia e distacco emotivo nei confronti del lavoro. Il soggetto si sente svuotato,sfinito, le sue risorse emozionali sono “esaurite”. La fase di depersonalizzazioneè caratterizzata da atteggiamenti di distacco e ostilità che coinvolgono primiera-mente la relazione professionale d’aiuto, vissuta con fastidio, freddezza e cini-smo. E’ presente tendenza a sottrarsi al coinvolgimento, limitando la quantità ela qualità dei propri interventi professionali al punto da rispondere evasivamentealle richieste di aiuto e da sottovalutare e negare i problemi del richiedente. La fasedi ridotta realizzazione personale è caratterizzata dal sentimento di fallimentoprofessionale per la percezione della propria inadeguatezza al lavoro, per la con-sapevolezza del disinteresse e dell’intolleranza verso la sofferenza degli altri e peri sentimenti di colpa connessi alle modalità relazionali impersonali e disumaniz-zate che hanno ormai sostituito l’efficacia e la competenza nel trattare con altriessere umani bisognevoli di aiuto. Questo stato di iposensibilità è usualmenteconcepito come un meccanismo di lotta per fronteggiare l’esaurimento emozio-nale. Nello stesso senso si pronunciano Leiter e Maslach (58) riguardo al modellodi sviluppo del processo, in cui la priorità del medesimo spetta all’esaurimentoemozionale, rispetto alla depersonalizzazione e alla ridotta realizzazione personale.Cherniss (59) definisce il burnout come un processo transizionale in cui lo stressda lavoro evolve in tensione lavorativa ed in adattamento psicologico. Più speci-ficamente lo sviluppo del burnout, per la patogenesi del quale il suddetto Autorenon esclude anche un ruolo dello stato di noia, è concettualizzato come consi-stente parimenti in tre stadi. Il primo stadio attiene ad uno squilibrio fra la do-manda di lavoro e le risorse individuali per soddisfare questa domanda (stress).Il secondo stadio consiste in una immediata e breve risposta emozionale, carat-terizzata da senso di ansietà, fatica ed esaurimento (sforzo mentale). Il terzo sta-dio è contrassegnato da numerosi cambiamenti nelle attitudini e nelcomportamento. Compare tendenza a trattare i clienti in modo distaccato o mec-canico, o una cinica preoccupazione di gratificazione dei propri bisogni (lotta di-fensiva). Il burnout, allora, è definito come un processo nel quale il disimpegnodel lavoratore dal proprio lavoro si verifica in risposta allo stress connesso allosforzo mentale. Il processo inizia quando lo stress lavorativo e lo sforzo mentalenon possono essere alleviati dalle proprie capacità transitando in una evera e pro-
111
Fisiopatologia dello stress
pria evasione psicologica. La sindrome comporta affaticamento ed esaurimentofisico, insonnia, e specifici sintomi soggettivi, come cefalea, disturbi gastro-inte-stinali, senso di freddo, tendenza a fare uso eccessivo di farmaci, di alcool. Burkee coll. in uno studio su poliziotti di entrambi i sessi hanno osservato sintomi psi-cosomatici (scarso appetito, cefalea, dolori toracici) e sensazioni negative (ango-scia, depressione, insonnia) e minore soddisfazione nel lavoro, aumento dellapressione arteriosa. Secondo Greenglass e Burke (60) il burnout predisporrebbein modo significativo alla trasformazione in depressione sia nel sesso maschile,che in quello femminile.
E’ ovvio che la sindrome in questione incide nei lavori che comportano no-tevoli responsabilità e sul cui esito l’operatore non è in grado di fornire all’utenteargomentazioni convincenti, esenti da dubbi ed incertezze.
Il burnout riconosce una patogenesi di tipo multifattoriale, all’interno dellaquale interagiscono fattori socio-ambientali e caratteristiche personologiche (Or-lowski, 61; Lederberg, 62; Slaby, 63). Tra i primi giocano un ruolo importante lecondizioni dell’ambiente lavorativo, quali l’eccessivo carico di lavoro, la burocra-tizzazione intensa delle istituzioni, l’imprecisa definizione di ruoli e competenzein un contesto sociale comunque caratterizzato da una forte tendenza individua-listica e di motivazione al successo e alla competività (Lee, 64; Biondi, 65).
Tra i fattori di rischio individuali sono da valutare le insufficienti risorse per-sonali con carenti o assenti competenze psicologiche e relazionali, il significatopersonale attribuito al lavoro, le aspettative eccessive o irrealistiche, le scelte sot-tese non da motivazioni autentiche ma da bisogni conflittuali, da sentimenti di on-nipotenza o da idealizzazioni di tipo narcisistico (Lee, 64; Fisher, 66), uninsufficiente controllo delle emozioni, come la rabbia (Muscatello, 67). Anche lapresenza di alte capacità empatiche aumenta il rischio di andare incontro al bur-nout (Larson, 68).
La sindrome ha un’altissima prevalenza in alcuni settori della medicina e par-ticolarmente in anestesia e rianimazione, nel SERT (Servizio recupero tossicodi-pendenti) e in oncologia (Muscatello, 67) con una percentuale di circa 20-40%. E’anche alta l’incidenza del burnout in quei sanitari che si sentono non sufficiente-mente formati nella comunicazione ed in abilità manageriali,
mentre lo sviluppo di una buona relazione medico-paziente è una buona fontedi soddisfazione professionale per gli oncologi (Ramirez e coll., 69) e per i pazienti(Fallowfield e coll., 70) ed un antidoto per lo sviluppo del burnout.
Tenuto conto di quanto sopra, si potrebbe ipotizzare che dal punto di vistaanatomico al burnout corrisponda il quadro istologico della corteccia surrenaledescritto al n. 7 del capitolo IV/2.1.2 della parte prima e cioè ad un reperto diesaurimento funzionale da iperstimolazione cronica della ghiandola.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
112
5. La sindrome di StendhalLo scrittore romantico francese Henry Beyle (1783-1842), soprannominatosi
Stendhal, entusiasta dell’Italia, ove soggiornò a lungo in varie occasioni, sfrut-tando le sue conoscenze ambientali e storiche per la stesura di romanzi di ampiosuccesso (v. La Certosa di Parma), descrisse inconsueti fenomeni di tipo emo-zionale, con indebolimento della capacità di giudizio, talora con attacchi di panico,ansie e disturbi percettivi e/o psicotici nel momento in cui egli stesso ed altri sog-getti si avvicinavano ad ammirare opere d’arte nei musei. A questo riguardo Sten-dhal, dopo avere visitato la chiesa di Santa Croce in Firenze, si esprimeva neitermini seguenti: “…ero arrivato al tal punto di emozione dove s’incontrano lesensazioni celestiali date dalle belle arti e dai sentimenti appassionati. Uscendo daSanta Croce avevo una pulsazione al cuore, quelle che a Berlino chiamano nervi:la vita in me era esaurita, camminavo col timore di cadere…”.
Studi condotti a Firenze (71) hanno confermato l’esistenza di detta sindrome.Si è visto che ad essere colpiti sono in particolare turisti del nord Europa, di mediacultura ma di sensibilità elevata e inoltre che nell’ambito della sindrome possonodistinguersi tre quadri clinici: uno caratterizzato prevalentemente da disturbi delpensiero, uno da disturbi della sfera affettiva e un terzo da disturbi psicosomatici.
Secondo quanto detto nella parte prima, ed in particolare agli effetti delle ca-tecolamine, si può ritenere che la sindrone sia proprio interpretabile come con-seguenza della liberazione di adrenalina e di noradrenalina dalla midollare surenalee di noradrenalina a livello delle terminazioni simpatiche periferiche. Avendosicosì, specie nei soggetti ipersensibili: aumento del tasso glicemico, della lipemia,della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, con possibili disordini del-l’equlibrio mentale e del comportamento. Per altro verso, la sindrome di Sten-dhal testimonia che l’approccio alle opere d’arte ed ai loro Autori, di cui il nostropaese è straordinariamente ricco, come alla musica, potrebbe essere assai utile findall’età scolare per un corretto sviluppo della personatità, anche per contrastaregli stimoli sensoriali abnormi proveniente dall’ambiente sociale attuale, propensopiù all’avere che all’essere (Fromm, 72).
In un articolo del quotidiano La Repubblica, supplemento “Palermo”, del15.9.2004, dal titolo “Il malore di Stendhal a Selinunte”, il redattore Lo Forte ri-corda che Stendhal s’imbarcò a Napoli diretto a Palermo (non è specificata ladata) con lo scopo di visitare il tempio ed il teatro di Segesta e Selinunte, luoghisimbolo del genio ellenico in Sicilia. Visitò i luoghi suddetti insieme col baroneLa Lumia che l’accompagnava. Dopo aver visitato Segesta, Stendhal si diresse colsuo accompagnatore verso Selinunte, ma dopo Castelvetrano fu colto da conatidi vomito e scariche di diarrea. Il barone se ne risentì responsabile perché erastata sua l’idea di portare lo scrittore in una trattoria di frutti di mare. Stendhal era
113
Fisiopatologia dello stress
pallido, sfinito, con gli occhi infossati e la lingua arida. Non essendovi nel luogoalcun albergo, il barone accompagnò lo scrittore nell’abitazione di una signorafrancese venuta in Sicilia al seguito del marito antiquario a Palermo. Alla mortedel marito la signora si era trasferita in quel luogo di pescatori “in una casa co-struita nel verde fra agavi e fichi d’india, a stretto contatto d’una fra le più sug-gestive aree archeologiche del mondo”. La donna fu lieta di prestare soccorso algrande scrittore suo conterraneo, “gli preparò un’amaca sotto un fresco pergo-lato e gli somministrò a cucchiai due litri d’acqua con estratto di menta per rei-dratarlo. Poi in serata Stendhal fu costretto ad ingurgitare un intruglio fatto dibanane, farina di carrube e mele gialle. Fatto è che l’indomani mattina presto eragià all’Acropoli sui resti dei templi, delle vie, delle piazze e dei mercati, rapitodallo stupendo mare blu dove avevano navigato Enea, Ulisse e i Fenici”. Il baroneLa Lumia si chiese, “senza sapersi dare una risposta, se a farlo guarire così pre-sto erano stati i beveroni della Signora o queste pietre edificate seicentocinquantaanni prima di Cristo, o ai suoi sensi ancora viventi e parlanti. Di queste giornatenon vi è traccia nei suoi scritti autobiografici o nelle sue biografie, l’episodio è ri-portato in una memoria vergata con mano incerta dal barone La Lumia qualchetempo prima di morire, quando la folla dei ricordi evocati dalla mente agisce a untempo da fonte di cura e da bicchiere di cicuta”. Il quadro morboso sopra decrittorientra nella forma psicosomatica della sindrome.
Da un altro punto di vista, queste esperienze emozionali intensissime possonoessere incluse, secondo i recenti orientamenti della psicologia transpersonale, inquelle descritte come “esperienze vetta”, o “peak experiences”, o “esperienzetranspersonali” (Ferrucci, 73). Sono degli stati non ordinari di coscienza, peresempio quando ci si sente particolarmente "creativi", insolitamente "intuitivi",eccezionalmente "lucidi", profondamente "rilassati”. Rappresentano ciò in cuil’individuo crede, quello che viene definito, da chi le ha avute, come “il culminedella vita”, qualcosa di grande e molto bello, inesprimibile perché è al di là di ciòche la mente razionale può comprendere. Queste esperienze influiscono in modopotente su progetti, percezione di Sé, significato dell’esistenza. Danno la sensa-zione di completezza, sono una guida sicura e segnano i punti di svolta. Sonodelle risorse potenziali di tutti gli esseri umani. Hanno un voltaggio immensa-mente più forte dell’ordinario e carica numinosa. Possono anche causare de-strutturazione.
Infatti Ferrucci per il suo studio in questo campo ha raccolto le esperienzeculminanti di 500 persone che nella storia dell’umanità hanno manifestato capa-cità eccezionali e le ha raggruppate in base alle sei caratteristiche più comuni. Traqueste:
Marcello Aragona, Francesco Aragona
114
Tra i benefici che derivano da questi stati notiamo: risanamento di traumi pas-sati; guida saggia per le scelte di vita; integrazione dell’esperienza, dal caos all’ar-monia; rivelazione del significato e del valore della vita, anche in situazioni assurdeo dolorose; aiuto a trascendere le preoccupazioni; evocazione di solidarietà fa-cendo svanire la paura.
La comparsa improvvisa di queste esperienze può risultare anche difficile dagestire per chi è impreparato, ma gli sviluppi importanti della psicologia tran-spersonale ci mostrano come queste esperienze possano anche essere indotte,dopo opportuna preparazione e formazione nella crescita personale (Ferrucci 73,vedi anche Appendice).
Bibliografia1. Selye H., The Stress of Life. Lippincott, Philadelphia, 1974.2. Tepperman Y., Fisiologia Metabolica ed Endocrina. Il Pensiero Scientifico, Roma,
1969.3. Friedman E.M., Irwin M. R., A role for CRH and the sympathetic nervous system instressindu ced immune suppression. Ann.New York Acad. Sci., 771, 1995, 316-418.
4. Aragona F., La cardiomiopatia da necrosi focale a coronarie normali: la miocitolisi coagu-lativa da catecolamine ed i suoi esiti. Riv. It. Med. Leg. XV 601-621, 1993.
5. Biondi M., Pancheri P., Psicosomatica della malattia coronarica. In: Cassano G.M.:Psichiatria Medica, UTET, Torino, 1990, 443-459.
6. Hurst, Il cuore, arterie e vene. Vol. II, 8. ed. McGraw-Hill, Milano 1995, pag.
115
Fisiopatologia dello stress
Stupore
Giustezza
Conoscenza
Unità
Universalità
Rilevanza sociale
Sorpresa attonita, stupore di tipo estatico, con aspetti di abbagliamento, capogiro,pianto e riso, disorientamento psichico, svenimenti, paura, sgomento, sorpresa,meraviglia, aspetti di destrutturazione con vuoto mentale ed il prorompere dalSé profondo dell’ispirazione creativa.
Sensazione di non aver più bisogno di nulla, di essere tornati a casa, sicurezza.Scompare il dolore, la paura, anche della morte. È uno stato di grazia, oltre le se-parazioni di bene-male.
Illuminazione, senso di risveglio
Alleggerisce la tensione e genera gioia
Senso di trascendenza dei confini
Espansione dell’azione del Sé ad altri, carisma. Comunica creatività, serenità,trasforma
2674.7. Pende N., La Scienza Moderna della Persona Umana. Garzanti, Milano, 1947. 8. Tolja J, Speciani A, Parlare col corpo. 20059. Voltaire, Amore: In Dizionario Filosofico. Ed. Giulio Einaudi, Torino. 1969, pag.
20-22. Amor proprio: pag.26.10. Dalai Lama, Cutler H.C., L’arte della felicità sul lavoro. Saggi Mondadori. Ar-
noldo Mondadori. Milano, 2005, pag.153-179.11. Ganguly P.K., Sherwood G.R., Cardiac sympathetic system: basic aspects. In. Can-
guly P.R, Catecholamines and Heart Disease. CRC Press, Boca Randon, Ann Arbor,Boston, London, 1991, p.2-13.
12. Manno V., Abuso sessuale infantile e disturbo bordeline di personalità: considerazioni pa-togene tiche e terapeutiche. Difesa Sociale 83, 63-78, 2004.
13. Gold P.W., Licinio J.,Wong M.L., Chrousos G.P., Cortitropin releasing hormone inpatho- physiology of melancholic and atypical depression and in the mechanism of actionof depressant drugs. Ann. New York Acad. Sci. Vo. 771, 1996, p.716-729.
14. Herman J.L., Complex PTSD. A Syndrome in Survivors of Prolonged and RepeatedTrauma. In: Every G.S. Jr. Lating J.M.: Psychotraumatology. Plenum Press,New York, London, 1995, 87-100.
15. Kroll J., Habenicht M., Mackenzie T. et al., Depression and posttraumatic stress di-sorder in Southeast Asian refugees. Amer. J. Psy. 146, 1592-1597, 1989.
16. Kinzie J.D., Boehnlein J.K., Leung P.K.et al., The prevalence of posttraumatic stressdisorder and its clinical significance among Southeast Asian refugees. Amer. J. Psy. 147,913-917, 1990.
17. Briquet, cit. da Herman (14).18. Morrison J., Childhood sexual histories of women with somatization disorder. Am. J.
Psy., 146, 239-241, 1989.19. Partnoy A., The little school: tales of disappearance and survival in Argentina. Cleis,
San Francisco, 1986.20. Sharansky N., Fear no evil. New York , Randon House, 1988.21. Jaffe R., Dissociative phenomena in former concentration camp inmates. Int. J. Psy-
choanal. 49, 310-312, 1968.22. Shengold L., Soul Murder: The Effects of Childood Abuse and Deprivation. New
Haven CT, Yale University Press, 1989.23. Putnam F.W., Diagnosis and treatment of multiple personality disorder. Guilford, New
York, 1989.24. Ross C.A., Miller S.D., Reagor P. et al., Structured interwiew data on 102 cases ofmultiple personality disorder from four centers. Amer. J. Psy. 147, 596-601, 1990.
25.Wiesel E., Night Hill&Wang, New York, 1960.26. Walker L., The battered woman. Harper&Ross, New York, 1979.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
116
27. Hilberman E.: The “wife-beater’s wife” reconsidered. Amer. J. Psy. 137, 1336-1347,1980.
28. Herman J.L., Trauma and Recovery. Basic Books, New York, 1992.29. Kinzie J.D., Fredrickson R.H., Ben R. et al., PTSD among survivors of Cambo-dian concen tration camps. Am. J. Psy. 141, 645-650, 1984.
30. Goldstein G., van Kammen V., Shelley C. et al., Survivors of imprisonment in thePacific theater during World War II, Am. J. Psy. 144, 1210-1213, 1987.
31. Niederland W.G., Clinical observation on the “survivor syndrome”. Intern. J. of Psy-choanal. 49, 313-315, 1968.
32. Gayford J.J., Wife-battering. A preliminary survey of 100 cases. British Med. J.: 1,194-197, 1975.
33. Hoge C.W., Castro C.A., Messer S.C., Combat duty in Iraq and Afghanistan. Men-tal health problems, and barriers to care. New England J. Med. 351, 13-22, 2004.
34. Briere J., Long-term clinical correlates of childhood sexual victimization. Ann. NewYork Acad. Sci. , 528, 1988, 327-334.
35. Van der Kolk B.A., Compulsion to repeat the trauma: Reenactment, revictimization, andmasochism. Psych. Clin. North Am. 12, 389-411, 1989.
36. Nader E., Pynoos R., Fairbanks L., Al-Aicel M., L-Asfour A., A preliminarystudy of PTSD and grief among the children of Kuwait following the Gulf crisis. Br. J.Clin. Psychol. 32, 407-416, 1993.
37. Laor N., Wolmer L., Mayes L., Gershon A., Weizman R., Cohen D., Israeli pre-schhol children unders scuds: a 30-month follop-up. J. Am. Acad. Child Adolesc.Psych., 36, 349-356, 1997.
38. Thabet A.A., Vostanis P., Posttraumatic stress reaction in children of war. J.Child.Psychol. Psychiatry 40, 385-91, 1999.
39. Ahmad A., Sofi M., Sundelin-Wahlsten V., Von Knorring A.L., Posttraumaticstress disorder in children after the military operation “Anfal” in Iraqi Kurdistan. Eur.Child Adolesc. Psy. 9, 235-43, 2000.
40. Aidukovic M., Displaced adolescents in Croatia: sources of stress and post-traumaticstress reaction. Adolescence 33, 209-17, 1998.
41. Papageorgiu V., Frangou-Garunovic A., Iodanidou R., Yule W., Smith P., Vo-stanis P., War trauma and psychopathology in Bosnian refugee children. Eur. Child Ado-lesc. Psy. 8, 84-90, 2000.
42. Smith P., Perrin S., Yule W., Rabe-Hesketh S., War exposure and maternal reac-tion in the psychosocial adjustment of childern from Bosnia-Herzegovina. J. Child. Psy-chol.Psych. 42, 395-404, 2001.
43. Paardckoper B., De Jong J., Hermanns J., The psychological impact of war and therefugee situation on South Sudanese children in refugee camps in Northem Uganda. J.Child Psychol. Psych. 40, 385-391, 1999.
117
Fisiopatologia dello stress
44. Baker A.M., The psychological impact of the Intifada on Palestinian children in the oc-cupied West Bank and Gaza: an exploratory study. Am.J. Orthopsy. 60, 496-505,1990.
45. Goenjian A.K., Pynoos R., Steinberg A.M., Psychiatric comorbity in children afterthe 1995 carthquake in Armenia. J. Amer. Acad. Child Adolesc. Psy. 34, 1174-1184, 1998.
46. Thabet A.A., Abet Y., Vostanis P., Emotionl problem in Palestian children living inwar zone. A cross-sectional study. The Lancet 339, 1801-1804, 2002.
47. Spitz R.A., Anaclitic depression. Psychoanal. Study of the Child. 2, 313, 1946.48. Spitz R.A., Il Primo Anno di Vita del Bambino. Giunti-Barbera, Firenze, 1969.49. Brown W.A., Henninger G.: Stress-induced growth hormone release: psychologic andphysiologic correlates. Psychosom. Med. 38, 145, 1976.
50. Greene W.A., Conron G., Schalch S.D., Schreiner B.F., Psychologic correlates ofgrowth hormone and adrenal secretory responses of patients undergoing cardiac catetheri-zation. Psychosom. Med. 32, 599, 1970.
51. Kurokawa N., Suematsu H., Tamai H., Esaki M., Aoki K., Ikemi Y., Effects ofemotional stress on human growth hormone secretion. J. Psychosom. Res. 21, 231, 1977.
52. Landauer T.K, Whiting J.W.M.: Infantile stimulation and adult stature of humanmales. Amer. Anthropologist 66, 1007, 1964.
53. Whiting J.W.M., Landauer T.K., Jones T.M.: Infantile immunization and adults sta-ture. Child Development 39, 59, 1968.
54. Levine S., Comportamento e Stress. In: Cesa-Bianchi M., Psicologia dell’Uomo.Le Scienze, Milano, 1974.
55. Carlson M., Earls F., Psychological and neuroendocrinological sequelae of early social de-privation in institutional children in Romania. Ann. New York Acad. Sci. 807, 419-428, 1997.
56. Maslach C., The client role in staff burnout. J. Soc. Issues. 34, 111-124, 1978.57. Jackson S.E., Turner J.A., Brief A.P., Correlates of burnout among public service la-wyers. J. Occup. Behav. 8, 39-49, 1987.
58. Leiter M.P., Maslach C., The impact of interpersonal environment on burnout and or-ganizational commitment. J. Occup. Behav. 9, 297-308, 1988.
59. Cherniss C., Long-term consequences of burnout: an exploratory study. J. Organiz.Behav. 13, 1-11, 1992.
60. Greenglass E.R., Burke R.J., Burnout over time. J. Health Hum. Resources Admn.13, 192-204, 1990.
61. Orlowski J.P., Bulledge A.D., Critical care stress and burn-out. Critical Care Clin.2, 173-81, 1986.
62. Lederberg M., Psychological problems of staff and their management. In: HollandJ.C., Rowland J.C.: Handbook of Psychooncology, New York, Oxford Uni-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
118
versity Press, 1989.63. Slaby A.E., Cancer’s impact on caregivers. Advance in Psychosomatic Med. 18,
135-53, 1988.64.Lee R., Ashforth B., A meta-analytic examination of the correlates of three dimensionsof burnout. J. Appl. Psychol. 81, 123-33, 1996.
65. Biondi M., Costantini A., Grassi L., La mente e il cancro. Il Pensiero Scientifico,Roma, 1995.
66. Fischer H.J., A psychoanalytical view of burnout. In: Faber B.A. et al., Stress and Bur-nout in the Human Service Professional. Pergamon Press, New York, 1983.
67. Muscatello M.R., Bruno A., Carroccio C., Cedro C., La Torre D., Di RosaA.E., Zoccali R., Aragona M., La Torre F., Mattei A., Angelone A.M., Di OrioF., Association between burnout and anger in oncology versus ophthalmology health care pro-fessionals. Psychol Rep. 2006 Oct; 99(2):641-50.
68. Larson D., Seminario Università di Messina 2003 su Emozioni e relazione medico-pa-ziente (comunic. orale).
69. Ramirez A.J., Graham J., Richards M.A., Cull A., Gregory W.M., Mental healthof hospital consultants: The effects of stress and satisficaction at work. The Lancet, 347,724-28, 1996.
70. Fallowfield L., Jenkins V., Farewell V., Saul J., Duffy A., Eves R., Efficacy of aCancer Research UK communication skill training model for oncologists: a randomised con-trolled trial. The Lancet 359, 650-6, 2002.
71. Lo Russo F., Sindrome di Stendhal. Encicl. Med. Ital. II Ed. USES, Firenze 1993,6858.
72. Fromm E., Avere o Essere?Mondadori, Milano, 1977.73. Ferrucci P., Esperienze delle Vette: Creatività estasi illuminazione, le nuove frontiere dellapsicologia traspersonale. Astrolabio, Roma, 1989.
119
Fisiopatologia dello stress
Capitolo III
Sulle modificazioni biologiche encefaliche nelle sindromi neurologiche da stress cronici
La ricchissima letteratura che esiste su questo argomento è sostanzialmente in-centrata nella verifica se nel corso delle sindromi connesse a stress cronici unqualche ruolo possa essere svolto dagli ormoni che caratterizzano gli stress acuti,ed essenzialmente da una parte dalle catecolamine e dall’altra dagli ormoni del-l’asse ipofisi-corteccia surrenale.
In effetti si è constatato da più parti che sia le catecolamine encefaliche chequelle periferiche (quali mediatrici delle terminazioni simpatiche periferiche, oquali ormoni della midollare surrenale), sia gli ormoni dell’asse ipofisi-cortecciasurrenale sono simultaneamente attivi nelle sindromi neuropsichiche da stresscronici.
1. Il ruolo delle catecolamineIn una revisione della letteratura specialistica in questo settore Southwich e
coll. (1) hanno osservato che nei soggetti con disordine post-traumatico da stress,in confronto a controlli, vi è un aumento della frequenza cardiaca, della pressionearteriosa, dei valori plasmatici dell’adrenalina e della noradrenalina, e che in sud-detti soggetti esiste una esagerata responsività del sistema noradrenergico in ri-sposta a stimoli stressanti. Si è visto anche un aumento dell’attività della dopaminabetaidrossilasi, della tirosina idrossilasi e di noradrenalina a livello simpatico in ani-mali sotto shock ripetuti. Questi animali mostravano pure comportamenti tipicidella paura. Si è inoltre ipotizzato che l’aumentata responsività del sistema nora-drenergico contribuisca a mantenere sintomi di ipervigilanza, inclusi atteggia-menti di paura ed insonnia.
Appare interessante il paragone fatto in soggetti veterani di guerra con DPTSdi fronte alla visione di film di incidenti automobilistici, ipotesi non connessa aiprecedenti vissuti di combattimenti, i quali film non suscitavano risposte emo-zionali differenti rispetto a soggetti di controllo, in confronto a stimoli connessia rilevanti traumi personali. Così McFall e coll. (2) riportano più alti livelli di adre-nalina plasmatica durante e dopo un film di combattimento. Similmente Blan-chard e coll. (3) hanno visto aumenti significativamente più elevati della frequenzacardiaca e della noradrenalina plasmatica dopo esposizione a stimoli uditivi si-mulanti quelli tipici dei combattimenti.
Più interessanti sembrano gli esperimenti condotti con la joimbina, farmacorientrante fra gli afrodisiaci spinali, e che nel contempo attiva i neuroni noradre-
121
nergici (4,5) ed è capace di attraversare rapidamente la barriera emato-encefalicae di determinare un aumento della concentrazione di noradrenalina nel liquido ce-falorachidiano (6). La joimbina somministrata a pazienti con DPTS ed a controllinormali determina nel 70% dei pazienti crisi di paura e nel 40% anche fenomeniallucinatori con contenuti di eventi stressanti vissuti nel passato. La joimbina som-ministrata a gruppi di pazienti psichiatrici molto diversi non produce sensibileaumento di ansietà, in particolare in quelli affetti da schizofrenia, da depressionemaggiore, da disordine ossessivo-compulsivo e da disordine da ansietà genera-lizzata (7-10). Queste risposte nei pazienti con DPTS dimostrano che in essi esi-ste un’anormalità neurobiologica connessa ad un’alterata sensibilità del sistemanoradrenergico. Come accennato, i pazienti con DPTS, dopo infusione di joim-bina, possono presentare bruscamente sensazioni di paura, di ansietà, tremori,allucinazioni nelle quali compaiono immagini vissute di combattimenti, o addi-rittura la visione, il rumore, l’odore di elicotteri in attività. In molti casi i pensieriimportuni sono descritti come estremamente chiari e vividi come se gli eventi ri-cordati fossero accaduti “precisamente l’altro giorno”.
Lo stato di allerta è caratteristico del DPTS ed è potenziato dalla joimbina.Allo scopo di valutare la specificità delle risposte alla joimbina in combattenti ve-terani con DPTS e nello stesso tempo per svelare un eventuale contributo sero-toninergico ai sintomi del trauma, pazienti con DPTS e controlli sani sono statitrattati con joimbina e con m-clorofenilpiperazina (mCFP) (10), quest’ultimacome prova dell’attività serotoninergica. Gli AA. sono giunti alla conclusione chenell’ambito del DPTS esistono due sottogruppi: un sottogruppo che sembra avereun’aumentata reattività per il sistema noradrenergico, ed un gruppo che presentaun’aumentata reattività per il sistema serotoninergico. In sostanza, i risultati dellericerche sopra sintetizzate confermano il parere in precedenza espresso da vari ri-cercatori che hanno ritenuto i pazienti affetti da DPTS sensibilizzati neurologi-camente (ad esempio, possedendo un’ipersensibilità neurologica o unabbassamento della soglia relativa alla ricezione degli stimoli esterni). Esistereb-bero così molti meccanismi potenzialmente responsabili delle menzionata iper-sensibilità neurologica:
a) un’aumentata disponibilità di neurotrasmettotori eccitatori, come noradre-nalina (11-15); glutammato (16, 17);
b) una riduzione funzionale di inibitori neurochimici come il GABA (18-22); c) modificazioni strutturali della funzione neuronica ed interneuronica con-
ducenti i neuroni verso uno stato di ipereccitabilità, come un aumento dei recet-tori post-sinaptici e/o un’inibizione dei recettori inibitori (23-27).
Marcello Aragona, Francesco Aragona
122
2. Il ruolo del CRH e dell’asse ipotalamo-ipofisi-corticosurreneQui non si può fare a meno di ricordare il ruolo degli ormoni surrenocorti-
cali e dei relativi recettori centrali nel corso degli stress cronici di cui è stata fattaampia disamina da Gold e coll. (28).
Gli studi rivolti all’accertamento dell’incidenza di ipercorticismo nella de-pressione sono assai numerosi (Sachar e coll., 29; Carroll e coll., 30,31; Rubin ecoll., 32,34; ecc.). Si è visto che in tutti gli studi sulla secrezione basale giornalieradi cortisolo in pazienti con depressione, il test di soppressione con desametazonecostituisce il metodo standard in endocrinologia per diagnosticare i disordini bio-logici associati con ipercorticismo. I dati disponibli allo stato attuale suggerisconoche il 50% dei pazienti con depressione maggiore manca di sopprimere adegua-tamente la secrezione surrenocorticale in seguito alla somministrazione di unadose orale di 1 mg di desametazone. Si è ipotizzato che la mediazione del feed-back negativo fosse localizzata nell’ipotalamo. Tuttavia il test suddetto è apparsorelativamente insufficiente per differenziare l’ipercorticismo cronico da quelloacuto e nel distinguere l’anormalità ipofisaria da quella ipotalamica.
La scoperta del CRH nel 1981 aumentò le possibilità di distinguere il ruolodella sede nervosa rispetto a quella ipofisaria. Gold e coll. (36), Nemeroff e coll.(37,38), Fehm e coll. (39), Holsboer e coll. (40) furono i primi a studiare il CRHnella depressione e tutti giunsero a conclusioni fondamentalmente simili, che im-plicavano il CRH nell’ipercorticismo della depressione. Gold e coll. (36) per primiidentificarono il suddetto ruolo del CRH con l’utilizzazione di CRH ovino sin-tetico, mentre Nemeroff e coll. (38) per primi riscontrarono elevati livelli liquo-rali di CRH nelle depressioni. Lo stesso gruppo di studi (37) aveva riferito suindagini condotte post-mortem con varie metodiche nelle quali era emerso chenella corteccia cerebrale di vittime di suicidio esisteva una significativa riduzionenumerica dei recettori CRH. Gli AA. suddetti avanzarono l’ipotesi che il repertoosservato avesse il significato di meccanismo di compenso quale risposta all’ec-cesso di CRH endogeno. Hoesboer e coll. (40) sostennero che i pazienti con de-pressione mostrassero effetti inibenti sulle cellule corticotrope ipofisarie da partedell’ipercorticismo. Gold e coll. (30) si occuparono anche di chiarire i motivi peri quali i pazienti con depressione maggiore non sviluppassero le stigmate della sin-drome di Cushing nonostante l’ipercorticismo fosse pressochè di dimensioniequivalenti nelle due suddette condizioni morbose: nonché di chiarire il rispettivoruolo della vasopressina-angiotensina e del CRH nell’ipercorticismo della de-pressione e se quest’ultimo non rappresenti una risposta non specifica allo stressdella malattia.
Bisogna premettere che l’emivita del CRH umano (hCRH) è breve e che lasua capacità di regolare il ritmo dell’ACTH è inferiore a quello del CRH ovino
123
Fisiopatologia dello stress
(oCRH), per cui quest’ultimo appare più idoneo per indagini sperimentali. Vaanche premesso che la depressione maggiore può essere associata ad ipercortici-smo in circa il 50% dei pazienti, mentre la depressione è spesso il primo sintomodel m. di Cushing, che precede le stigmate fisiche di mesi o di anni (38). Gold ecoll. (28), con l’impiego del test OCRH, hanno visto che la stimolazione condetto ormone ovino in pazienti con ipercortisolemia e con depressione maggioresi verificava un’attenuazione della risposta dell’ACTH plasmatico, il che era attri-buibile agli alti livelli di cortisolo circolante nonostante i soggetti suddetti mo-strassero concentrazioni ematiche di ACTH nei limiti della norma. Per cui, inquesti casi, doveva di necessità esistere un’iper-responsività della corteccia surre-nale all’ACTH. Nell’ipercortisolemia della depressione sussiste la capacità diblocco degli effetti del CRH sulle cellule ipofisarie secernenti l’ACTH, per cui sideve concludere che la mancanza delle stigmate cushingoidi nella depressione siada correlare a temporanea inibizione della secrezione ipofisaria di ACTH fino aprodurre riduzione dei livelli di cortisolo plasmatico: così risultando solo episo-dica l’ipersecrezione di cortisolo e di conseguenza i pazienti depressi non mo-strano i livelli stabili di ipercorticosolismo necessari per la comparsa delle stigmatedel m.di Cushing. Questa ipotesi è avvalorata anche dal fatto che una continua in-fusione di oCRH a volontari sani con ipofisi intatta produce un ipercorticosoli-smo qualitativamente e quantitativamente simile a quello osservato nelladepressione maggiore, mentre la continua infusione di ACTH a controlli, bypas-sando a livello ipofisario il feedback glicorticoideo negativo, produce un ipercor-ticosolismo qualitativamente e quantitativamente simile a quello osservato nel m.di Cushing. Pertanto, un’ipofisi funzionalmente intatta nella depressione può aiu-tarci a spiegare come la disregolazione del sistema ipotalamo-ipofisi-corticosurrene possa essere svelato in molti di questi pazienti con una semplicemetodologia come la soppressione da desametazone. Per meglio differenziarel’ipercorticosolismo della depressione con quello del m. di Cushing è anche utileil test di stimolazione con oCRH. In contrasto con i pazienti con depressionemaggiore, i pazienti affetti da m. di Cushing mostrano un’intensa risposta del-l’ACTH plasmatico all’oCRH, nonostante il pronunciato ipercorticosolismo. Que-sto reperto indica che l’ipofisi nel m. di Cushing è sostanzialmente non responsivaal feedback glicocorticoideo negativo. Per cui il test di stimolazione con oCRHè utile per differenziare l’ipercorticosolismo della depressione da quello del m. diCushing.
Come già ricordato nel capitolo IV della parte prima, il CRH e l’AVP (arginina-vasopressina) sono i due principali ormoni ipotalamici per il rilascio di ACTH daparte della preipofisi. Tuttavia come segretagogo di ACTH l’AVP è molto menoefficace del CRH a parità di quantità basale, ma essa esercita un sinergico effetto
Marcello Aragona, Francesco Aragona
124
in combinazione con il CRH. Teoricamente la risposta dell’ACTH plasmatico al-l’AVP d’origine esogena riflette il livello ambientale di CRH nel sangue portaleipofisario (28).
Bisogna ancora tener conto del ruolo svolto dai recettori glicocorticoidei (GR)e mineralcorticoidei (MR) in questo meccanismo di disordine funzionale. Comegià detto a proposito delle modificazioni biologiche che conseguono a qualsiasistress, questi ultimi sono responsabili di una varietà di modificazioni puramentefisiologiche, compresa l’attivazione del sistema ipofisi-corticosurrene, col fine dimantenere l’omeostasi. In controlli normali questa attivazione neuroendocrina èneutralizzata dal feedback negativo mediato dai recettori glicocorticoidei cheprontamente riducono gli aumentati livelli dei glicorticoidi plasmatici. I mecca-nismi coinvolti in questa regolazione feedback negativa implicano l’intervento deirecettori glicocorticoidei non soltanto nella preipofisi ma anche nell’ipotalamo,nell’ippocampo e possibilmente anche in altre sedi all’interno e al di fuori del si-stema limbico (Holsboer e coll., 40). Secondo detti AA., le modificazioni dina-miche nelle capacità funzionali dei recettori corticosteroidei sono di notevoleimportanza per lo studio delle cause e del trattamento dei disordini psichici eneurologici. Tali capacità possono essere sintetizzate come segue: a) nei pazienti con disordini psichiatrici, in particolare in quelli con depressione,
l’alterazione funzionale del sistema ipotalamo-ipofisi-corticosurrene è il segnoprincipale neuroendocrino;
b) gli antidepressivi sembrano agire direttamente su vari elementi regolatori didetto sistema;
c) malattie neurologiche sono di frequente complicate da modificazioni di dettosistema;
d) alcune di queste modificazioni mostrano sensibili complicanze mediante il trat-tamento con corticosteroidi;
e) gli steroidi naturali o sintetici agiscono sulle cellule cerebrali in modo specifico,e si accompagnano ad alterazioni del comportamento. Questi presupposti derivano da osservazioni cliniche che comprovano disturbi
funzionali dei recettori corticosteroidei in pazienti con disordini affettivi, scle-rosi multipla e infezione da HIV, che documentano come steroidi derivati dallesurrenali o da cellule cerebrali (secondo alcuni AA. -55- sembrerebbe che le cel-lule gliali siano in grado di sintetizzare ormoni steroidi: pregnenolone, deidroe-piandrosterone) e steroidi sintetici a livello sistemico possano essere studiati conl’indagine elettroencefalografica (EEG) durante il sonno (39).
Nell’ambito dei disordini affettivi, pazienti depressi mostrano un’aumentata at-tività del sistema ipotalamo-ipofisi-corticosurrene, come documentato dall’au-mento frequente dell’ACTH e da aumento brusco del cortisolo (40). Questa
125
Fisiopatologia dello stress
iperattività neuroendocrina si riflette inizialmente su un aumento del cortisolo li-bero urinario, che sembra essere due volte più elevato nei depressi rispetto ai con-trolli normali, ma, tuttavia, più basso rispetto ai pazienti con m. di Cushing.Inoltre la concentrazione di cortisolo salivare e del liquido cerebro-spinale, cherappresenta la frazione libera (non coniugata) del cortisolo, è aumentata nelle de-pressioni. Nemeroff e coll. (38) hanno visto, infatti, che la concentrazione delCRH nel liquido cerebro-spinale è elevata nei depressi.
Per quanto attiene agli effetti dei traumi, ed in specie nel corso del DPTS, circal’attività del sistema ipotalamo-ipofisi-corticosurrene, i risultati sono pressochè so-vrapponibili a quelli delle comuni depressioni, peraltro limitati ad un modestoaumento del cortisolo plasmatico (41), riferibile ad una ipersensibilità della cor-teccia surrenale connessa ad un effetto desensibilizzante sui recettori cortico-tropi. Secondo Yehuda e coll. (42) nei soggetti con DPTS esiste un’aumentatadensità dei recettori glicocorticoidei nei linfociti, il che farebbe pensare all’esi-stenza di un aumento recettoriale anche nell’ippocampo, nell’ipotalamo e nel-l’ipofisi, che spieghebbe l’aumentata sensibilità del sistemaipotalamo-ipofisi-corticosurrene nei soggetti suddetti.
Stratakis e coll. (43) ritengono che i glicocorticoidi assumano un ruolo im-portante nella psicologia umana, in quanto capaci di influenzare la funzione diquasi tutti i tessuti del corpo umano (44). Detti ormoni sono cruciali regolatoridelle emozioni e del comportamento, del metabolismo, delle funzioni cardiova-scolari, e, secondo alcuni, anche delle funzioni immunitarie (45,46). A propositodel comportamento del sistema immunitario e dell’apparato cardiovascolare nelcorso degli stress si ritornerà più specificamente in seguito. E’comunque certo chela completa incapacità dei glicocorticoidi di esercitare i loro effetti sui tessuti ber-saglio costituisce condizione incompatibile con la vita dei primati. A questo ri-guardo è stato accertato che esistono solo sindromi di parziale o incompletaresistenza ai glicocorticoidi, che si basano su difetti degli ubiquitari classici recet-tori glicocorticoidei (GR), tipo II, che mediano la maggior parte dell’azione deiglicocorticoidi. Esistono, infatti, sindromi, a volte a carattere familiare, di resi-stenza ai glicocorticoidi (FGR), come, ad esempio, quella riguardante otto soggettinon imparentati (47) ed altra attinente a cinque analoghi casi (48). Il fenotipo cli-nico dei pazienti con resistenza al cortisolo non è univoco e non sembra esserestato ancora identificato. Sta di fatto che nelle sindromi di resistenza al cortisolodebba esistere un’incapacità del sistema di feedback, per il quale i glicocorticoidiesplicano un’inibizione sulla secrezione ipotalamica del CRH e dell’arginina-va-sopressina. Nonché sulla secrezione ipofisaria di ACTH. Nei suddetti stati di re-sistenza questo sistema è insensibile a concentrazioni di cortisolo consideratinormali per la popolazione generale (49), per cui l’asse ipotalamo-ipofisi-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
126
corticosurrene è regolato a più alti livelli mediante un aumento compensatorio diACTH e di cortisolo. Quando il difetto recettoriale è soltanto parziale, un ade-guato compenso all’insensibilità dei tessuti bersaglio può ottenersi aumentandoil cortisolo circolante. Comunque l’eccesso di secrezione di ACTH comporta unaumento produttivo di steroidi surrenalici, anche con ritenzione di sali e attivitàandrogena (50) non di rado con le relative conseguenze cliniche (ipertensionee/o alcalosi ipocalcemica; nella donna: acne, irsutismo, calvizie, irregolarità me-struali, oligo-anovulazione, amenorrea, infertilità; nei bambini pubertà precoce).
Yarowsky e coll. (51) ricordano che i glicocorticoidi influenzano lo sviluppodell’encefalo e modulano l’espressione di vari geni, inclusi quelli dei fattori di cre-scita e dei relativi recettori, di vari enzimi (glutaminsintetasi e glicerol-3-fosfatodeidrogenasi), nonché i canali ionici. In particolare gli astrociti del nervoottico neonatale, dell’ippocampo e della corteccia cerebrale esprimono numerositipi di canali del sodio. I suddetti Autori sostengono che l’idrocortisone esercitila sua influenza sui canali del sodio degli astrociti attraverso la stimolazione deirecettori glicocorticoidei. A questo riguardo va ricordato che del ruolo degli or-moni surrenocorticali e dei relativi recettori centrali nel corso di varie sindromipsichiatriche, compreso il m. di Cushing, è stata fatta ampia disamina da Hol-sboer e coll. (40). Secondo Herman e Watson (52), anche i recettori mineralcor-ticoidi, molto abbondanti nell’ippocampo, vengono attivati in animali daesperimento sottoposti a stress (ratti immobilizzati).
In complesso, gli stress possono interagire con preesistenti condizioni psico-fisiche favorenti
l’insorgenza o l’aggravamento di episodi depressivi e gli studi sull’asse ipota-lamo-ipofisi-corticosurrene condotti per oltre un trentennio hanno dimostratoche l’ipercorticosurrenalismo rimane la più documentata anormalità biologica neipazienti depressi (28, 32-36, 52).
Secondo McEwen (53) nelle malattie a carattere depressivo si verificherebbela seguente sequela di alterazioni biologiche:
1) iperattività dell’amigdala; 2) disregolazione del sistema ipotalamo-preipofisi-corticosurrene, almeno in
parte conseguente a squilibri dei normali ritmi del sonno; 3) successiva atrofia dell'ippocampo, della corteccia prefrontale, che si ac-
compagna con rarefazione minerale ossea ed abnorme obesità ed aumentato ri-schio di malattie cardiovascolari. Non è escluso che simili alterazioni siano attualianche nel disordine postraumatico da stress.
127
Fisiopatologia dello stress
Bibliografia1. Southwick S.M., Morgan C.A., Bremer A.D., Grillon C.G., Krystal J.H., Nagy
L.M., Charney D.S., Noradrenergic alterations in posttraumatic stress disorder. Ann.New York Acad. Sci. 821, 125-141, 1997.
2. McFall M. et al., Autonomic response to stress in Vietnam combat veterans with post-trau-matic stress disorder. Biol. Psych. 27, 1165-1175, 1990.
3. Blanchard E.B. et al., Changes in plasma norepinephrine to combat-related stimuli amongVietnam veterans with post-traumatic stress disorder. J. Ner. Ment. Dis. 179, 371-373,1991.
4. Scatton B. et al., Antidopamine properties of yohimbine. J. Pharmac.Exper. Ther.215, 484-489, 1980.
5. Winter J.C., Rabin R.A., Yohimbine as a serotoninergic agent: Evidence for receptor bin-ding and drug discrimination. J.Pharm.Exper.Ther. 263, 682-689, 1992.
6. Peskind E.R.et al., Yohimbine increases cerebrospinal fluid and plasma norepinephrine butnot arginine vasopressin in humans. Neuroendocrinology 50, 268-291, 1989.
7. Glazer W.M. et al., Noradrenergic function in Schizophrenia. Arch. Gen. Psych. 44,898-904, 1987.
8. Heninger G.R. et al., Alpha2-adrenergic receptor sensitivity in depression: The plasmaMNPG, behavioral, and cardiovascular responses to yohimbine. Arch. Gen. Psych. 45,718-726,1988.
9. Charney D.S. et al., Noradrenergic function in generalized anxiety disorder. Effects of yo-himbine in healthy subjects and patients with prolonged anxiety disorder. Psychol. Res.27, 173-182, 1989.
10. Rasmussen A. et al., Effects of yohimbine in obsessive-compulsive disorder. Psycho-pharmacology 93, 308-313, 1987.
11. Southwick S.M. et al., citati da Southwick e coll. (1).12. Davidson L., Braun A., Chronic stress and post-traumatic stress disorders. J. of Con-
sulting a. Clinical Psychology 54, 303-308, 1986.13. Murbus M., McFall M., Veith R., Catecholamines stress and PTSD. In: Giller E.,Biological Assessment and Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder. American Psy-chiatric Press, Washington, 1990, p.29-44.
14. Krystal J.H., Kosten T.R., Southwick S. et al., Neurobiological aspect of PTSD. Be-havior Therapy 20, 177-198, 1989.
15. Kalivas P.W., Duffy P., Similar effects of cocaine and stress on mesocorticolimbic dopa-mine neurotransmission in the rat. Biol. Psych. 25, 913-928, 1989.
16. McGeer E., McGeer P., Excitotoxins and animal models of disease. In: Galli G.,Manzo L., Spencer P., Recent Advances in Nervous System Toxicology. Plenum Press,New York, 1988.
17. Palkovits M., Lang T., Patthy A., Elekes L., Distribution and stress-induced increase
Marcello Aragona, Francesco Aragona
128
of glutamate and aspartate levels in discrete brain nuclei of rats. Brain Research 373,252-257, 1986.
18. Biggio G., The action of stress, beta carbones, diazepam, Ro15-1788 on GABA re-ceptors in the rat brain. In: Biggio G., Costa E., Benzodiazepine Recognition and SiteLigands. Raven, New York, 1983, p.105-119.
19. Drugan R.C., Murrow A.L., Weizman R. et al., Stress-induced behavioral depres-sion associated with a decrease in GABA receptor-mediated chloride ion influx and brainbenzodiazepine receptor occupancy. Brain Research 487, 45-51, 1989.
20. Gray J., The Neuropsychology of Anxiety. Oxford, New York 1982.21. Krnjevic K., GABA-mediated inhibitory mechanism in relation to epileptic discharges.
In: Jasper H., Van Gelder N.M., Basic Mechanisms of Neuronal Hyperexcitability.Liss, New York, 1983, p.249-263.
22. Van Gelder N.M., The hyperexcited brain: Glutamic acid release and failure of inhi-bition. In: Schwarz R., Ben-Ari Y., Excitatory Amino Acids and Epilepsy. PlenumPress, New York 1986, p.331-347.
23. Joy R., The effects of neurotoxicants on kindling and kindlet seizures. Fundamental andApplied Toxicology 5, 41-65, 1985.
24. Nutt D., Altered central alfa2 adrenoreceptor sensitivity in panic disorder. Arch. Gen.Psy. 46, 105-109, 1989.
25. Perry B.D., Southwick S.M., Giller E.L., Adrenergic receptor regulation in post-trau-matic stress disorder. In: Giller E., Biological Assessment and Treatment of Post-Trau-matic Stress Disorder. Am. Psy. Press, Washington 1990, p. 87-144.
26. Post R., Ballenger J., Kindling models for progressive development of psychopathology.In: Van Pragg H., Handbook of Biological Psychiatry. Dekker, New York, 1981,p. 609-651.
27. Post R., Kopanada R., Cocaine, Kindling and Psychosis. Amer. J. Psy. 133, 627,1976.
28. Gold F.W., Licinio J., Wong M.L., Chrousos G.P., Corticotropin releasing hormonein the pathophysiology of melancholic and atypical depression and in the mechanism of ac-tion depressant drugs. Ann. New York Acad. Sci. 771, 716-729, 1995
29. Sachar E.J., Hellman L., Fukushima D.K., Gallegher T.F., Cortisol production indepressive illness: a clinical and biochemical classification. Arch. Gen. Psy. 23, 289-298,1970.
30. Carroll B.J.M., Feinberg J.M., Greden J.F., A specific laboratory test for the diagno-sis of melancholia. Arch. Gen. Psychol. 38, 15-22, 1981.
31. Carroll B.J.M., Curtis G.C., Davies B.M., Mendels J., Sugarman A.A., Urinaryfree cortisol excretion in depression. Psychol. Med. 6, 43-50, 1976.
32. Poland R.E., Rubin R.T., Lesser I.M., Lane L.A., Hart P.J., Neuroendocrine aspectsof primary endogenous depression: serum dexamethasone concentrations and hypothalamic-
129
Fisiopatologia dello stress
pituitary-adrenal cortical activity as determinants of the dexamethasone suppression teste-sponse. Arch. Gen. Psy. 44, 790-795, 1987.
33. Siever L.J., Davis K.L, Overview: towards a dysregulation hypothesis of depression.Am. J. Psy. 142, 1017-1031, 1985.
34. Rubin R.T., Poland R.E., Lesser I.M., Winston R.A., Blodgett N.A.L., Neuro-endocrine aspects of primary endogenous depression: cortical secretory dynamics in patientsand mactched controls. Arch. Gen. Psy. 44, 328-336, 1987.
35. Kathol R.G., Jaeckle R.S., Lopez J.F., Meller M.H., Pathophysiology of HPA axisabnormalities in patients with major depression: an update. Am. J. Psy. 146, 311-317,1989.
36. Gold P.W., Chrousos G., Kellner C. et al., Psychiatric implications of basic and cli-nical studies with corticotropin-releasing factor. Am. J. Psy. 141, 619-627, 1984.
37. Nemeroff C.B., Owens M.J., Bissette G., Andorn A.C., Stanley M., Reduced cor-ticotropin releasing factor sites in the frontal cortex of suicide victims. Arch. Gen. Psy.45, 577-579, 1988.
38. Nemeroff C.B., Widerlove E., Bissette G. et al., Elevated concentrations of CSFcorticotropin releasing factor-like immunoreactivity in depressed patients. Science 224,1332-1334, 1984.
39. Fehm H.L, Benkowitsch R., Kern W., Fehm-Wolsdorf G., Paushinger P., BornJ., Influences of corticosteroids, dexamethasone and hydrocortisone on sleep in humans.Neuropsychobiology 16, 198-204, 1986.
40. Holsboer F., Spengler D., Heuser I., The role of corticotropin-releasing hormone inthe pathogenesis of Cushing’s disease, anorexia nervosa, alcoholism, affective disorders anddementia. Progr. Brain Res. 93, 385-417, 1992.
41. Smith M.A., Davidson J., Ritchie J.C., Kudler H., Lipper S., Chappell P., Ne-meroff C.B., The corticotropin-releasing hormone test in patients with post-traumatic di-sorder. Biol. Psychiatry 26, 349-355, 1989.
42. Yehuda R., Lowy M.T., Southwick S.M., Shaffer U., Giller E.L.jr., Lymphocyteglucocorticoid receptor number in post-traumatic stress disorder. Am.J.Psy. 148, 499-504,1991.
43. Stratakis C.A., Karl M., Schulte H..M., Chrousos G.P., Glucocorticosteroid resistencein humans. Ann.New York Acad. Sci. 746, 362-374, 1994.
44. Baxter J.D., Rousseau G.G., Glucocorticoid Hormon Action. Springer, New York,1979.
45. Orth D.N., Kovacs W.J., De Bold C.R., The Adrenal Cortex. In: Williams Text-book of Endocrinology. 8 Ed., Saunders & Co, Philadelphia, 1992, p.489-620.
46. Munck A., Guyre P.M., Glucocorticoid physiology, pharmacology and stress. In: Chrou-sos G.P., Loriaux D.L., Lipsett M.B., Steroid Hormone Resistance: Mechanisms andClinical Aspects. Advances in Experimental Medicine and Biology. Plenum Press, New
Marcello Aragona, Francesco Aragona
130
York. Vol. 196, 1986, p.81-9647. Vingerhoeds A.C.M., Thijssen J.H.H., Schwarz F.J., Clin. Endocrinol. Metab.
43,1128-1133, 1976, cit. da Stratakis e coll. (43).48. Lambert S.W.J., Koper J.W., Biemond P. et al., J. Clin. Endocr. Metab. 74, 313-
321, 1992, cit. da Stratakis e coll. (43).49. Chrousos G.P., Detera-Wadleigh S., Karl M., Ann. Intern. Med. 119, 1113-
1124, 1993, cit. da Stratakis e coll. (43).50. Vanderbilt J.N., Miesfield R., Maler B.A., Yamamoto K.R., Mol. Endocrinol.
1, 68-74, 1987, cit. da Stratakis e coll.(43). 51. Yarowsky P.J., Brougher D.S., Krueger B.K., Glucocorticoid stimulation of sodiumchannel expression in cultured astrocytes. Ann. New York. Acad. Sci. 746, 480-484,1994.
52. Herman J.P., Watson S.J., Glucocorticoid regulation of stress-induced mineralcorticoidreceptor gene transcription in vivo. Ann. New York Acad. Sci. 746, 485-488, 1994.
53. McEwen B.S., Mood disorders and allostatic load. Biol. Psychiatry 54, 200-207,2003.
131
Fisiopatologia dello stress
Capitolo IV
Le alterazioni anatomiche encefaliche negli stress cronici
Stein e coll. (1) nella loro complessa indagine hanno premesso che il disordinepost-traumatico da stress fu il primo, con il DSM III, ad essere codificato comeconseguenza di stress. Da quel momento numerosi studi hanno dimostrato, comegià detto in precedenza, che la suddetta sindrome consegue frequentemente atraumi di vario genere, come i combattimenti, la vittimizzazione, le violenze ses-suali infantili, i disastri naturali, gli incidenti stradali.
Con le moderne tecniche di neuroimmagine applicabili nel vivente: elettroen-cefalogramma (EEG), tomografia assiale computerizzata (TAC), tomografia a ri-sonanza magnetica nucleare (TRMN), tomografia a risonanza magneticafunzionale (TRMF), tomografia ad emissione di positroni (PET), tomografia dicalcolo ad emissione di positroni (SPECT), è stato possibile localizzare e qualifi-care le lesioni cerebrali da stress cronici.
In particolare, la PET consente di misurare nell’encefalo processi fisiologicispecifici, come, ad esempio, il metabolismo del glucosio e dell'ossigeno, il flussoed il volume del sangue, il metabolismo degli aminoacidi, i meccanismi di tra-sporto di membrana o indici di funzioni neurochimiche attraverso i neurotra-smettitori; la SPECT lo studio del flusso ematico cerebrale: globale (CBF globale)o regionale (rCBF): indagini utilizzate non solo per ricerche in condizioni fisio-logiche, come già detto, ma anche a scopo diagnostico in vari tipi di patologianeurologica, vascolare, degenerativa o neoformativa. La TRMN ed ancor più laTRMF sono utili anche per indagini in campo psichiatrico e negli stress sia acutiche cronici. Con quest’ultima (TRMF) è possibile identificare con estrema preci-sione le aree cerebrali che rispondono agli stimoli stressanti. Addirittura oggi sipropende a ritenere che con quest’ultimo sistema sia possibile, in campo giudi-ziario, verificare se durante l’interrogatorio l’imputato e/o i testimoni diano omeno risposte veritiere.
A questo scopo sono state pure utilizzate indagini sulla coerenza elettroencefalo-grafica.
Vari ricercatori hanno condotto indagini istologiche sull’encefalo di animalicronicamente stressati. Noi abbiamo eseguito indagini anatomo-istologiche su108 casi di omicidio e su 57 casi di suicidio di cui all’elenco riassuntivo riportatonel capitolo IV della parte prima.
1. Indagini sul vivente e sperimentali su animali di laboratorioLe menzionate indagini tecniche hanno consentito essenzialmente di valutare
133
nell’encefalo sia le condizioni di processi fisiologici specifici, in precedenza indi-cati, nonché l’esistenza di processi patologici degenerativi o espansivi.
Bremner e coll. (2) hanno dimostrato che in 26 veterani combattenti conDPTS esisteva assottigliamento volumetrico del lato destro dell’ippocampo. Gur-vits e coll. (3) hanno osservato una riduzione bilaterale del volume dell’ippo-campo in sette combattenti veterani con DPTS. Bremner e coll. in altro studio (4)hanno paragonato il volume dell’ippocampo in 17 adulti sopravvissuti ad abusisessuali infantili ed in altrettanti soggetti sani ed hanno visto nel 12% dei casi so-pravvissuti agli abusi infantili un assottigliamento del volume dell’ippocampo disinistra. Stein e coll.(5) hanno riscontrato una piccola percentuale (5%), da lororitenuta statisticamente significativa, di riduzione volumetrica dell’ippocampo disinistra in 21 donne che avevano subito abusi sessuali nell’infanzia, paragonate a21 donne normali. Teicher e coll. ( 6) ricordano che in ricerche sperimentali suroditori e nei primati (7-10) sottoposti a stress è stato possibile documentare re-perti morfologici dell’ippocampo simili a quelli umani. Tali effetti sono stati at-tribuiti ai glicocorticoidi in quanto capaci di causare, nel caso degli stress, unaccumulo extracellulare di aminoacidi eccitatori, come il glutammato (vedi anchein seguito).
A proposito del suddetto danno dell’ippocampo da stress, McEwen e Maga-rinos (11) confermano tale rapporto patogenetico e fanno presente che un re-perto sovrapponibile è osservabile nel m. di Cushing. Essi asseriscono che glisteroidi surrenalici esplicano tre sostanziali effetti sull’ippocampo: a) sono capaci di modulare l’eccitabilità dei neuroni ippocampali, influenzando
anche la memoria a lungo termine;b) partecipano, insieme con gli aminoacidi eccitatori (N=metil-D-aspartato –pro-
dotto di sintesi- ed altri aminoacidi endogeni con potenzialità neurotossiche:N-acetil-aspartil-glutammato, acido L-aspartico, acido L-cisteico, L-cisteinasulfonato, acido L-glutammico, acido L-omocisteico, acido L-piroglutammico,acido chinolinico, tetraidrofosfolati e loro congeneri) nella regolazione dellaneurogenesi dei neuroni granulari del giro dentato, che può essere coinvoltonegli stress;
c) gli steroidi surrenalici partecipano, insieme con i predetti aminoacidi eccita-tori, nel produrre l’atrofia dei dendriti indotta dagli stress nella regione CA3(regione 3 del corno d’Ammone): un processo che colpisce solo i dendriti api-cali e conduce ad indebolimento cognitivo nell’apprendimento di compiti spa-ziali e di memoria a breve termine (12).McEwen e Magarinos affermano che l’atrofia non colpisce l’intero neurone ed
è reversibile, ma non è chiaro se costituisca il primo stadio della morte neuronale,oppure rappresenti un meccanismo protettivo dei neuroni al costo del danno di
Marcello Aragona, Francesco Aragona
134
alcune funzioni cognitive. Comunque la distruzione neuronale si verifica ed è ilmotivo dell’assottigliamento dell’ippocampo, evidente anche nel m. di Cushing,nell’invecchiamento, nella demenza, nella depressione ricorrente, nella schizo-frenia e nel DPTS. I suddetti AA. (12) riportano uno schema che attiene alla fre-quenza dell’atrofia dell’ippocampo nelle sindromi encefaliche umane, come quiappresso riprodotto:
Per cui il danno dell’ippocampo nel DPTS sembra essere addirittura più fre-quente anche rispetto al m. di Cushing, in cui l’aumento plasmatico degli ormoniglicorticoidei ed il quadro depressivo sono maggiormente manifesti e costanti.
Indagini sperimentali con somministrazione prolungata di ACTH o di glicor-ticoidi ad animali di laboratorio hanno dimostrato fenomeni alterativi dei neuronidell’ippocampo. Aus der Muhlen e Ockenfels (13) hanno visto che la sommini-strazione di ACTH o di cortisolo in cavie adulte determina una colorazione scuradei neuroni dell’ippocampo, come se i medesimi stessero per andare in necrosi.Altri ricercatori hanno ottenuto analoghi risultati in ratti sottoposti a stress dafreddo (14). Si è sollevato il dubbio da parte di alcuni (15) che i reperti cromaticisuddetti possano essere artefatti connessi alla fissazione post-mortale dell’ence-falo; mentre altri (16) hanno visto che l’invecchiamento nei ratti conduce ad as-sottigliamento dello strato piramidale dell’ippocampo, fenomeno tuttavia ritardatodalla surrenectomia nella mezza età. Sapolsky (17) aveva dimostrato che iniezionigiornaliere di corticosterone in ratti giovani e in cercopitechi determinavano as-sottigliamento ed aspetto nerastro delle cellule piramidali dell’area 3 del cornod’Ammone (CA3). Le cellule in via di necrosi possono tuttavia sfuggire al ri-scontro istologico perché la loro scomparsa avviene rapidamente, per cui sarebbeopportuno procedere ad un conteggio dei neuroni delle regioni sottoposte ad in-dagine istologica (18). Inoltre Sapolsky (17), nei suoi esperimenti, condotti suratti con inizioni giornaliere di corticosterone per 12 settimane, ha sostenuto
135
Fisiopatologia dello stress
Condizione morbosa %
65
64
66,67
57,58
68
69,70
Sindrome di Cushing
Malattia depressiva ricorrente
DPTS
Vecchiaia con precedente demenza
Demenza
Schizofrenia
anche che i glicocorticoidi potenziano, a livello dell’ippocampo, sia il danno ische-mico sia quello determinato dagli aminoacidi capaci di determinare la necrosidelle cellule nervose dell’ippocampo in cultura.
A proposito dell’apprezzamento dell’entità numerica dei neuroni cerebrali innecrosi nel corso di stress cronici noi abbiamo osservato, come meglio sarà dettoin seguito, che anche al di fuori dell’ippocampo, come l’ipotalamo, la cortecciatemporale, il corpo striato, il bulbo, il ponte ed il cervelletto, si verifica un chiarospopolamento neuronale, spesso anche associato ad ipotrofia della corteccia ce-rebrale, a volte apprezzabile pure macroscopicamente, come avviene nella sene-scenza e nel m.di Cushing. Tali reperti sono particolarmente evidenti nei suicidi.
Il danno neurale suddetto nel corso degli stress si concreta inizialmente conl’atrofia dei dendriti apicali visibile sia con la tecnica messa a punto da Golgi, siacon la microscopia elettronica, la quale ultima, peraltro, non utilizzabile su or-gani cadaverici. Si è visto che gli stress ed i glicocorticoidi alterano la morfologiadelle fibre dendritiche terminali presinaptiche (18,19,20).
McEwen e coll. (12) hanno visto che l’atrofia apicale dei dendriti avviene in unaprima fase nei neuroni piramidali CA3 dopo 21 giorni di trattamento giornalierocon corticosterone e anche dopo lo stesso periodo di 21 giorni in ratti sottopo-sti a stress da immobilizzazione ripetuto ogni sei ore al giorno. Anche gli stresspsicosociali conducono ad atrofia dei dendriti apicali dei neuroni piramidali CA3(21). Ciò considerato anche che un organo plastico qual è l’encefalo, benchè pro-grammato geneticamente nelle sue forme e funzioni, può essere influenzato dallenegative esperienze infantili. Teicher e coll. (6) hanno ritenuto che nello sviluppoencefalico post-natale alcune regioni, rispetto ad altre, siano particolarmente vul-nerabili alle influenze esterne. Queste regioni comprenderebbero l’ippocampo,l’amigdala, la corteccia prefrontale e il corpo calloso. I suddetti AA. avevano pre-ventivamente rilevato che gli abusi in giovane età avevano un maggiore impattosulla personalità se effettuati prima dei 18 anni. Poiché il fine primo del loro stu-dio riguardava nell’accertare se i traumi infantili fossero associati, con rapportodi causa ed effetto, con le alterazioni delle regioni encefaliche prima menzionate,si sono serviti principalmente di una speciale tecnica elettroencefalografica: co-siddetta coerenza elettroencefalografica. Si tratta di tecnica quantitativa sofisticata chepuò fornire importanti informazioni circa lo sviluppo encefalico e circa il gradodi sincronismo fra due tracciati elettroencefalografici attraverso frazioni nellospessore della corteccia.
La coerenza EEG è determinata da due primari compartimenti (25, 26): ilprimo compartimento rappresenta le connessioni assonali brevi di cellule pira-midali viciniori, mentre il secondo compartimento rappresenta la propagazioneassonale lunga delle vie di associazione intracorticali. Questi due compartimenti
Marcello Aragona, Francesco Aragona
136
esercitano effetti opposti sulla coerenza. Le connessioni corticali locali processanoe modificano i segnali, così la coerenza decresce con la differenziazione corticale.Al contrario, la coerenza aumenta con la mielinizzazione e lo sviluppo delle vieassociative. Molti studi hanno dimostrato che il calcolo della coerenza EEG puòfornire utili informazioni circa il grado di sviluppo dell’encefalo ed in effetti ilmetodo è stato utilmente applicato allo studio dello sviluppo normale, del ritardomentale, dei disordini dell’apprendimento (27,28). Calcoli della coerenza EEGsembrano molto più utili, rispetto al comune EEG, al fine di apprezzare diffe-renze fra soggetti di controllo e pazienti affetti da schizofrenia; e particolarmenteper svelare anormalità strutturali encefaliche, anche sottili, che presumibilmenteesistono nella schizofrenia, in confronto al comune EEG (28,29). Thatcher e coll.(26) ritengono che le variazioni della coerenza EEG apprezzabili fra l’infanzia el’adolescenza siano in accordo con gli stadi di sviluppo intellettuale secondo Pia-get. Di conseguenza la coerenza EEG appare tecnica idonea anche per verificareil rapporto causale fra l’abuso infantile precoce e la maturazione della lateralitàcorticale.
Studi di Achenbach (30,31) su 15 bambini o adolescenti con una storia di abusifisici e sessuali e su 15 volontari sani hanno dimostrato differenze della coerenzaEEG fra i controlli e gli abusati connessa ad una diminuita differenziazione del-l’emisfero sinistro nelle vittime di abuso. In sostanza questi studi testimonianol’utilità delle suddette indagini per la verifica del rapporto fra abuso infantile edanno dello sviluppo corticale.
Per quanto attiene al corpo calloso Thatcher e coll. (26) hanno osservato, insoggetti sottoposti ad abuso fisico o ad abbandono, marcati effetti sul volumedelle regioni del corpo calloso, non riscontrati nei soggetti che avevano subitoabusi sessuali o abusi psicologici. Le variazioni volumetriche erano connesse alsesso. L’abuso fisico era associato con le più marcate alterazioni delle regioni delcorpo calloso; quello sesso-specifico specialmente in quattro regioni del corpo cal-loso, che largamente interconnettono la corteccia motrice, di destra e di sinistra.Nell’abuso fisico maschile vi era una riduzione del 25.5% nel relativo volume diqueste regioni, mentre nel femminile vi era un aumento del 17.41%, giudicatonon significativo. L’abbandono esercita effetti sesso-specifici nelle regioni 3,4 e6, le quali interconnettono rispettivamente le regioni premotorie, motorie e tem-porale superiore/parietale posteriore (32). Anche qui vi era correlazione col sesso:i maschi abbandonati mostravano una riduzione del 24.8% nella regione 3, e unariduszione del 25.6% nella regione 4; le femmine un aumento dell’89% nella re-gione 1, e un aumento del 51.6% nella regione 6. In sostanza l’abuso fisico e l’ab-bandono erano associati con alterazioni delle regioni del corpo calloso: nei maschicon diminuzione del volume del corpo rostrale e medio anteriore; nelle femmine
137
Fisiopatologia dello stress
con un aumento di volume del rostro e dell’istmo del corpo calloso.Gli AA. ritengono che i reperti osservati indicherebbero che l’abuso precoce
sembra essere associato con anormalità dell’emisfero sinistro e con un’asimme-tria emisferica rovesciata sinistra-destra. Questi reperti sono in armonia con quelliosservati da Stein e coll. (1), i quali hanno visto che l’ippocampo sinistro, ma nonil destro, era più sottile nelle femmine con una storia di abuso sessuale infantilerispetto ai controlli.
Queste osservazioni suggeriscono che l’abuso precoce possa esercitare mag-giori effetti deleteri nello sviluppo corticale e dell’ippocampo di sinistra e possaimpedire l’integrazione emisferica e il consolidamento della normale dominanzacorticale sinistra.
Peraltro, ricerche sulle funzioni emisferiche indicano decisamente che l’emi-sfero destro abbia un ruolo di primaria importanza nella percezione e nel-l’espressione delle emozioni (33), particolarmente di quelle negative (34-37). Aquesto riguardo vedi anche capitolo II.2 della parte prima le differenze funzionalifra la parte destra e quella sinistra della corteccia prefrontale ventromediale. Sì cheuna deficiente integrazione emisferica destra e sinistra può realizzare una condi-zione nella quale la corteccia cerebrale destra e sinistra reagiscano in modo nonintegrato, comportando l’insorgere di conflitti intrapsichici e dissociazioni (38,39).Le differenze emisferiche possono trovare una spiegazione nel fatto che l’emi-sfero che si sviluppa più rapidamente possa essere più vulnerabile in conseguenzadi stress. Durante i primi mesi di vita l’emisfero destro si sviluppa più rapida-mente del sinistro con più avanzata crescita dendritica nell’area di Broca e nellacorteccia motoria (40). Comunque dal V-VI mese di età l’accrescimento dendri-tico nell’emisfero sinistro sorpassa quello di destra e continua a rapida velocità neipochi successivi anni. Fra il III e il VI anno di età l’emisfero destro comincia adecelerare il suo sviluppo, mentre l’emisfero sinistro rimane più altamente diffe-renziato. Quindi gli abusi da 6 mesi fino a 3-6 anni di età possono avere più ele-vati effetti patologici nell’emisfero sinistro.
2. Indagini su cadaveriCome premesso, noi abbiamo condotto indagini anatomo-istologiche sull’en-
cefalo di 108 casi di omicidio e 57 casi di suicidio relativi alla nostra casistica dicui all’elenco riportato nel capitolo IV.1 della parte prima: in complesso 713 casi,di cui 547 di omicidio, 95 di suicidio, 71 casi di controllo costituiti da soggetti ve-nuti a morte in conseguenza di traumi o per overdose in tossicodipendenti.
Le vittime di omicidio (soltanto 10 di sesso femminile) erano di età compresafra 17 e 78 anni ma soprattutto al di sotto dei 40 anni, nei quali la morte era av-venuta in modo istantaneo o rapido (entro pochi minuti): ma in sei casi si veri-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
138
ficò più tardivamente ed avvenne rispettivamente dopo 1 ora, 4 ore, 12 ore, 24ore, 60 ore, 7 giorni. In 105 casi, dei 108 oggetto di questo studio, la morte erastata causata da armi da sparo, in 2 casi per traumi cranici durante il sonno ed in1 caso da avvelenamento da stricnina mescolata al caffè.
I 57 casi di suicidio compresi in questo studio (17 di sesso femminile) erano dietà compresa fra 14 e 84 anni, ma prevalentemente fra 20 e 50 anni. Il suicidioera stato effettuato con armi da sparo in 15 casi, per impiccamento in 12, per an-negamento in mare in 7, per precipitazione dall’alto in 4, con armi da punta e ta-glio in 2, per avvelenamento in 17. In quest’ultimo gruppo l’avvelenamento erastato effettuato con esteri fosforici (5 casi), stricnina (1 caso), acido muriatico (2casi), veleni nervini (6 casi), digitale (1 caso), cianuro di sodio (1 caso), ossido dicarbonio (1caso).
Sono state studiate varie aree encefaliche (corteccia cerebrale, corteccia cere-bellare, ipotalamo, ponte, bulbo, nuclei della base) su più preparati per ogni area,colorati con emallume-eosina, reazione al PAS, Mallory-Vannucci, Schulze per laglia. Come già detto nel capitolo IV/2.2 della parte prima, l’ipotalamo è stato stu-diato in 52 casi di omicidio ed in 9 casi di suicidio anche col metodo di Gomori-Bargmann per il neurosecreto nei nuclei paraventricolare e sopraottico enell’eminenza mediana. Questo stesso metodo è stato applicato anche nel pe-duncolo ipofisario e nella neuroipofisi (vedi casistica, cap. IV.1, parte prima).
Nei vari distretti encefalici esaminati sono stati osservati fenomeni regressivineuronali consistenti in rarefazione o scomparsa delle zolle di Nissl e impallidi-mento del nucleo fino alla sua scomparsa, così conferendo ai neuroni colpitil’aspetto di ombre, appena visibili all’esame microscopico. I suddetti fenomeni re-gressivi sono apparsi particolarmente evidenti nei suicidi (Fig. 28,29), nei quali,come già accennato, macroscopicamente è stato addirittura osservato assottiglia-mento della sostanza grigia corticale, come suole accadere normalmente nell’etàavanzata e nel m. di Cushing. Le suddette alterazioni sono state osservate in circail 50% delle vittime di omicidio, nel 90% nei suicidi effettuati con mezzi non ve-nefici e nella totalità dei casi di suicidio effettuato con mezzi venefici.
Frequenti i fenomeni di edema perivascolare e pressochè costante la prolife-razione gliale astrocitaria soprattutto nella sostanza bianca semiovale, talora condisposizione perivascolare (Fig. n. 30,31).
Le alterazioni regressive delle cellule nervose vengono considerate conse-guenza degli effetti tossici esercitati dai glicocorticoidi, come già detto e come siè visto da parte di altri AA. specialmente a carico dell'ippocampo (Sapolsky ecoll., 41-43), ove i relativi recettori sono altamente espressi. I suddetti AA. hannovisto che il trattamento con glicocorticoidi in animali da esperimento determinalisi delle cellule nervose dell’ippocampo. Secondo Gotthard ed Henser (44), la
139
Fisiopatologia dello stress
lisi dei suddetti neuroni appare maggiormente evidente quando il trattamentocon glicorticoidi è associato con altri fattori patogeni, quali l’ipossia o gli ami-noacidi ad attività neurotossica, di cui si è già detto (6-10). Il ruolo neurotossicodi detti aminoacidi, secondo un’indagine condotta da McEwen e coll. (11), sa-rebbe addirittura prevalente in confronto all’azione neurotossica dei glicocorti-coidi, tanto che il blocco sperimentale dei recettori dei medesimi aminoacidisarebbe idoneo a prevenire l’atrofia dendritica daterminata dagli stress. Qui, pe-raltro, non si può fare a meno di considerare la possibilità che nel meccanismosuddetto possa assumere un ruolo non trascurabile la liberazione di quantità ri-levanti di ossido d’azoto (NO), visto che negli stress tale composto, come già ac-cennato nella prima parte, può essere attivato. Al riguardo dev’essere anchericordato che gli astrociti, secondo Lee e coll. (45), possono liberare NO sotto lostimolo dell’interleuchina-1 (IL-1) sintetizzata dalle medesime cellule.
La proliferazione astrocitaria da noi osservata (Fig.n. 30,31) può essere attri-buita anche all’aumentata attività metabolica del tessuto nervoso e alla ritenzionedi acqua e di sodio che usualmente complica gli stress cronici e gli stati depres-sivi: ritenzione che nella specie è confermata dalle note di edema perivascolare danoi osservato. D’altra parte la stimolazione sensoriale (come accennato nel capi-tolo III della parte prima) può incrementare la proliferazione degli astrociti e deglioligodendrociti negli animali da esperimento, e che queste cellule, specialmentegli astrociti, hanno un ruolo essenziale nel metabolismo encefalico, specie nel tra-sporto di aminoacidi e ionico, nell’attivazione di mediatori chimici, nel metabo-lismo dei fosfolipidi, nelle funzioni escretorie tenuto conto che il SNC nonpossiede rete linfatica (46). E’ da ritenere che in questo meccanismo abbiano unruolo importante le cellule staminali presenti nell’encefalo, (come già detto nellaIntroduzione).
A proposito delle funzioni metaboliche e proliferative delle cellule gliali Vin-cent (47) scrive: “Si parla spesso della funzione nutritiva delle cellule gliali comese fosse una cosa ovvia e senza preoccuparsi di quali cose comprenda. E’ possi-bile in effetti che le cellule gliali catturino e forniscano poi ai neuroni precursoridei neurotrasmettitori, siano cioè una sorta di dispensa. Tuttavia è più importanteinsistere su una proprietà che le cellule gliali, al contrario di quelle nervose, hannodi moltiplicarsi. Rakic e Sidman” - continua Vincent - “in una serie di studi de-dicati allo sviluppo della corteccia cerebrale e del cervelletto nelle scimmie e nel-l’uomo, hanno mostrato che le cellule gliali e i loro prolungamenti formavanouna specie di trama o di rete sulla quale i neuroni migravano per raggiungere laloro destinazione finale. La possibilità di riprodursi permette alle cellule gliali disvolgere una funzione nella riparazione delle lesioni nervose, in quanto occupanolo spazio rimasto vuoto e guidano e favoriscono la crescita di elementi nervosi so-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
140
stitutivi secernendo fattori di crescita. Una proteina che favorisce la crescita dellecellule nervose (NGF) può essere estratta dai tumori gliali.”
Bibliografia 1. Stein M.A., Hanna C., Koverola C., Torchia M., McClarty B., Structural brainchanges in PTSD. Does trauma alter neuroanatomy? Ann. New York Acad. Sci. 821,76-82. 1997.
2. Bremner J.D., Randall P., Scott T.M., Bronen R.A., Seibl T.M., Southwick S.M.,Delanoy R.C., McCarty G., Charney U.S., Innis R.B., MRI-based measurement ofhippocampal volume in combat posttraumatic stress disorder. Am. J. Psy. 152-973-981,1995.
3. Gurvits T.G., Shenton M. R., Hokama H., Ohta H., Lasko N.B., GilbertsonM.W., Orr S.P., Kikinis R., Jolesz F.A., McCarley R.W., Pitman R. K., Magneticresonance imaging study of hippocampal volume in chronic, combat-related posttraumaticstress disorder. Biol. Psychiatry 40, 1091-1099, 1996.
4. Bremner J.D., Randall P., Vermetten E., Staib L., Bronen R.A., Mazure C., Ca-pelli S., McCarthy G., Innis R.B., Charney U.S., MRI-based measurement of hip-pocampal volume in posttraumatic stress disorder to childhood physical and sexual abuse: apreliminary report. Biol. Psychiatry 41, 23-32, 1997.
5. Stein M.B., Koverola C., Hanna C., Torchia M., McCarthy B., Hippocampal vo-lume in women victimized by childhood sexual abuse. Psychol. Med. 1997 (cit. da Steinet al., n. 1).
6. Teicher M.H., Ito Y., Glod C.A., Andersen S.L., Dumont N., Ackerman E.,Preliminary evidence of abnormal cortical development in physically and sexually abusedchildren using EEG coherence and MRI. Ann. New York Acad. Sci. 821, 160-175,1997.
7. Sapolsky R.M. et al., Hippocampal damage associated with prolonged glucocorticoid ex-posure in primates. J. Neurosci. 10, 2897-2902, 1990.
8. McGaugh J.L. et al., Involvement of the amygdaloid complex in neuromodulatory in-fluences on memory storage. Neurosci. Biobehav. Rev. 14, 425-431, 1990.
9. Goddard C.V., McIntyre D.C., Leech C.K., A permanent change in brain functioningresulting from daily electrical stimulation. Exper. Neurol. 25, 295-330, 1969.
10. Uno H., Tarara R., Else J.G., Suleman N.A., Sapolsky R.M., Hippocampal da-mage associaded with prolonged and fatal stress in primates. J. Neurosci. 9, 1705-1711,1989.
141
Fisiopatologia dello stress
11. McEwen B.S., Magarinos A.M., Stress effects on morphology and function of the hip-pocampus. Ann. New York Acad. Sci. 821, 271-284, 1997.
12. McEwen B.S., Albeck D., Cameron H., Chao A.M., Gould E., Hastings N.,Kuroda Y., Luine V., Magarinos A.M., McKittrick C.R., Orchinik M., PavlidesC., Vaher P., Watanabe Y., Weiland N., Stress and the brain: a paradoxical role foradrenal steroids. In: Litwack G.D., Vitamines and Hormones. Acad. Press, SanDiego 1995 p.371-402.
13. Aus der Mulhen K., Ockenfels H., Morphologische Veränderungen im Diencepha-lon und Telencephalon: Storungen des Regelkreises Adenohypophysenebennierinden. Z. Zel-lforsch. Mikrosck. Anat. 93, 126-141, 1969.
14. Mizoguchi K., Kunishita T., Chui D.H., Tabira T., Stress induced neuronal deathin the hippocampus of castrated rats. Neurosci. Letts. 139, 157-160, 1992.
15. Cammermeyer J., Is the solitary dark neuron a manifestation of postmortem trauma tothe brain inadeguately fixed by hyperfission? Histochemistry 56, 97-115, 1978.
16. Landfield P., Modulation of brain aging correlates by long-term alterations of adrenalsteroids and neurally-active peptides. Progr. Brain Res. 72, 279-300, 1987.
17. Sapolsky R., Stress, the Aging Brain and Mechanism of Neuron Death. CambridgeMIT Press, Cambridge MA, 1992, p.1-423.
18. Issa A., Rowe W., Gauthier S., Meaney M., Hypothalamic-pituitary-adrenal activity,cognitively unimpaired rats. J. Neurosci. 10, 3247-32-54, 1990.
19. Lambert K.G., Quadros P., Aurentz C., Lowry C., Kinsley C.H., Does chronicactivithy-stress produce hippocampal atrophy and basal forebrain lesions? A preliminaryanalysis. Ann. New York Acad. Sci. 877, 1999, p.742-746.
20. Magarinos A.M., Verduco Garcia J.M., McEwen B.S., Chronic restraint stress cau-ses ultrastructural changes in rat mossy fiber terminals. Soc. Neurosci. 22, 1196, 1996.
21. McKittrick C.R., Magarinos A.M., Blanchard D.C., Blanchard R.J., McEwenB.S., Chronic social stress decreases binding to 5HT transporter sites and reduces dendri-tic arbors in CA3 of hippocampus. Soc. Neurosci. 22, 2060, 1996.
22. Green A.H. et. al., Neurological impairment in maltreated children. Child AbuseNeglect 5, 129-134, 1981.
23. Green A., Dimension of psychological trauma in abused children. J. Am.Ass. ChildPsychiatry. 22, 231-237, 1983.
24. Davies R.K., Incest: some neuropsychiatric findings. Int. J. Psychiatry Med. 9, 117-121, 1979.
25. Thatcher R.W., Krause P.J., Hrybyk M., Cortico-cortical associations and EEG co-herence. A two compartment model. Electroenceph. Clin. Neurophysiology 64, 123-143,1986.
26. Thatcher R.W., Walker R.A., Giudice S., Human cerebral emispheric development atdifferent rates and ages. Science 236, 1110-1113, 1987.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
142
27. Marosi E. et al., Maturation of the coherence of EEG activity in normal and learning-disabled children. Electroenceph. Clin. Neurophysiol. 83, 350-357, 1992.
28. Ford M.R., Goethe J.W., Dekker D.K., EEG coherence and power in the discrimi-nation of psychiatric disorders and medication effects. Biol. Psychiatry 21, 1175-1188.1986.
29. Merrin E.L., Floyd T.C., Fein G., EEG coherence in unmedicated schizophrenic pa-tients. Biol. Psychiatry. 25, 60-66, 1989.
30. Achenbach T.M., The child behavior profile. I. Boys ages 6 through 11. J. Consult Clin.Psychol. 46, 478-488, 1978.
31. Achenbach T.M., Edelbrock C.S., The child behavior profile. II. Boys aged 12 to 16and girls aged 6 to 11 and 12 to 16. J. Consult Clin. Psychol. 47, 223-233, 1978.
32. Witelson S.F., Hand and sex differences in the isthmus and genu of the human corpuscallosum. Brain 112, 735-799, 1989.
33. Ross E.D., The aprosodias: functional-anatomic organization of the affective componentsof language in the right hemisphere. Arch. Neurol. 38, 561-569, 1980.
34. Hirschman R.S., Safer M.A., Hemispheric differences in perceiving positive and nega-tive emotions. Cortex 18, 569-580, 1982.
35. Silberman E.K., Weingartner H., Hemispheric lateralization of funcions related toemotion. Brain Cogn. 5, 322-353, 1986.
36. Tomarken A.J. et al., Individual differences in anterior brain asymmetry and funda-mental dimensions of emotion. J. Pers. Soc. Psychol. 64, 676-687, 1982.
37. Borod J.C., Interhemispheric and intrahemispheric control of emotion: a focus on unila-teral brain damage. J. Consult. Clin. Psychol. 60, 339-348, 1992.
38. Joseph R., The rigth cerebral hemisphere: emotion, music, visual-spatial skills, body-image, dreams, and awareness. J. Clin. Psychol. 44, 630-673, 1988.
39. Muller R.J., Is these a neural basis for bordeline splitting? Compr. Psychiatry 33, 92-104, 1992.
40. Galaburda A.M., Anatomical asymmetries in the human brain. In: Gerschwind N.,Galaburda A.M., Biological Foundation of Cerebral Dominance. Harward Univ. PressCambridge, MA, 1984.
41. Sapolsky R.M., Krey L.C., McEwen B.S., Prolonged glucocortoid exposure reduces hip-pocampal neuron number: implication for aging. J. Neuroscience 5, 1222-7, 1985.
42. Sapolsky R.M., Lewis C.K., McEwen B.S., Neuroendocrinology of stress and aging:the glucocorticoid cascade hypthesis. Endocrin. Rev. 7, 285-301, 1986.
43. Sapolsky R.M., Plotshy P.M., Hypercorticosolism and its possible neural bases.Biol. Psychiatry 27, 932-52, 1990.
44. Gotthard V., Hensen I., Neuroendokrinologische Forschung in der Psychiatrie. In:Lieb K., Riemann D., Berger M., Biologische-psychiatrische Forschung. Fisher, Stutt-gart, 1995, p.43-70.
143
Fisiopatologia dello stress
45. Lee S.C., Dickson D.W., Brosnam C.F., Interleukin-1, nitric oxide and reactive astro-cytes. Brain Behav. Immun. 9, 345-354, 1995.
46. Testut L., Latarjet A., Trattato di Anatomia Umana. Vol. III, UTET, Torino1961, p. 56-59.
47. Vincent J.D., Biologia delle Passioni. Einaudi, Torino, 1988, p.63.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
144
Capitolo V
Stress cronici e danni immunitari
La conoscenza che l’insorgenza e l’evoluzione di processi infiammatori sianofacilitate da condizioni di stress è da tempo acquisita ed al riguardo sono state con-dotte sull’uomo indagini per la verifica degli effetti di diversi tipi di stress fisici epsicologici sui parametri immunitari. Un modello di indagine di questo tipo èquello condotto su studenti di medicina, nei quali si è osservato poco prima delcimento in esami particolarmente difficili che le risposte dei linfociti T alla sti-molazione con sostanze antigeniche erano diminuite in modo significativoquando confrontate con quelle degli altri studenti effettuate molto prima degliesami; nel test suddetto era anche diminuita l’attività dei linfociti NK (1).
Si è ritenuto che il fenomeno fosse connesso al dimostrato effetto linfocitoli-tico attribuito ai glicocorticoidi, effetto che in particolari forme di stress può es-sere assai rapido. Nell’assideramento sperimentale, ad esempio, lo spopolamentolinfocitario dei follicoli linfatici splenici avviene in brevissimo tempo dopo l’espo-sizione al freddo di animali da esperimento (cavie): 1 ora e mezza- 2 ore (2), el’ipotrofia di detti follicoli in soggetti venuti a morte dopo agonie protratte è dicomune osservazione. Altri AA. (3, 4) hanno visto che topi trattati con cortico-sterone mostrano significativa atrofia della milza e del timo già al terzo giorno, esoppressione dal 30 all’85% della risposta proliferativa dei linfociti splenici a variesostanze antigeniche.
Studi di Rabin e coll. (5) indicherebbero l’esistenza di tre vie attraverso le qualigli stress producono effetti depressivi sulla risposta immunitaria: una via oppioideche altera la funzione dei linfociti NK; una via non-oppioide e non surrenale-di-pendente che altera la funzione dei linfociti splenici; una via surrenale-dipendenteche deprime la funzione dei linfociti periferici. Secondo gli stessi AA., i linfocitilinfonodali non sarebbero interessati dagli stress e ciò potrebbe essere spiegatoo con la perdita dei recettori ormonali di questi linfociti ovvero con un difetto del-l’innervazione propria dei linfonodi.
Altra ipotesi è quella formulata da Bernton e coll. (3-5), i quali sulla base delleloro osservazioni sperimentali, sostengono che la prolattina sembra possedereproprietà di antagonizzare gli effetti immunosoppressivi dei glicocorticoidi nelcorso degli stress e di impedire l’atrofia splenica e timica indotta dal trattamentocon corticosterone. Sì che lo stress inciderebbe sulla risposta immunitaria so-prattutto quando coesista difetto di produzione di prolattina a livello ipofisario.
Per quanto attiene al rapporto causale glicocorticoidi-immunosoppressione,sono stati avanzati dei dubbi da Friedman e Irwin (6). Questi AA. prendono lo
145
spunto dai risultati di varie indagini sperimentali dimostranti che gli ormoni dellacorteccia surrenale non sono indispensabili nel rapporto causale con l’immuno-soppressione da stress. Essi ricordano: a) che Keller e coll. (7) hanno constatato che il danno immunitario da stress era
presente anche in ratti surrenectomizzati, pur se questo effetto non fossedrammatico come quello osservabile in animali intatti;
b) che Cunnick e coll. (8) ed altri ricercatori (9-13) hanno notato simile dissocia-zione fra funzione immunitaria ed ormoni ipofisi-corticosurrenali, e perciòche l’immunosoppressione ricorreva in assenza di attivazione dell’asse ipofisi-corticosurrene;
c) che Keller e coll. in altra indagine (14) hanno visto che il danno immunitarioera presente anche in ratti ipofisectomizzati. Per cui, nel complesso, questidati sperimentali starebbero ad indicare che il punto di partenza del dannoimmunitario da stress avesse origine più in alto dell’ipofisi e perciò nell’ence-falo.
Friedman e Irwin (6) riassumono come segue gli argomenti che localizzanonell’encefalo la responsabilità dell’immunosoppressione da stress: a) lesioni di specifiche aree encefaliche, come l’ippocampo ventrale e l’ipotalamo
anteriore, si sono dimostrate capaci di modulare le funzioni immunitarie (15,16): peraltro i due emisferi cerebrali sembrano esercitare influenze diversificatesulle funzioni immunitarie: così lesioni in determinate aree della neocortecciadell’emisfero destro del topo, ma non del sinistro, producono modificazionidelle risposte immuni, cellulari e umorali (17);
b) alla qualità del coinvolgimento psicologico dello stress (piacevole o spiacevole)corrispondono diverse risposte immunitarie: per esempio, lo shock elettricoinevitabile, ma non quello evitabile, determina immunosoppressione (12, 18):similmente lo stress associato all’isolamento sociale nei primati non umaniproduce declino delle funzioni immunitarie, che può essere quasi completa-mente evitato se l’animale è posto in ambiente familiare e sociale (19);
c) lo stress da paura determina depressione immunitaria (20); d) la dimostrazione di legami fra l’encefalo e il sistema immunitario per via di
proiezioni noradrenergiche ai tessuti linfoidi (21) supporta la possibilità chel’encefalo possa influenzare direttamente le funzioni immunitarie.A questo riguardo, si ritiene che il ruolo principale in questo meccanismo sem-
bra essere assunto dal CRH, il che è sostenuto sulla base delle seguenti circo-stanze: a) il CRH è presente, oltre che nel nucleo paraventricolare dell’ipotalamo ante-
riore, anche nella corteccia cerebrale, nel sistema limbico e nei nuclei del tronco
Marcello Aragona, Francesco Aragona
146
encefalico (22), nonchè nella stria terminalis e nel nucleo centrale dell’amigdala(23);
b) in generale il CRH è ritenuto un importante regolatore dei sistemi monoami-nergici centrali, stanti la sua ampia distribuzione nell’encefalo e le regioni oveesso è ubicato;
c) infusioni di basse dosi di CRH nel locus coeruleus aumentano l’attività deineuroni noradrenergici (24);
d) il CRH produce attivazione del sistema nervoso simpatico quando è intro-dotto in sedi multiple dell’encefalo (25).Irwin e coll. (26) hanno visto che anticorpi monoclonali anti-CRH bloccano
completamente gli effetti immunosoppressivi degli stress sull’attività NK, il cheè stato confermato da analoghi esperimenti condotti da altri AA. con anticorpianti-CRH purificati (27), nonché dal fatto che la soppressione della proliferazionedei linfociti e delle loro attività NK, prodotta dallo shock elettrico era attenuatain modo significativo dalla presomministrazione nei ventricoli cerebrali di un an-ticorpo policlonale anti-CRH (28).
Che il CRH sia idoneo ad attivare il sistema nervoso simpatico (29) è confer-mato dalla capacità della somministrazione centrale di CRH esogeno di soppri-mere numerose funzioni immunitarie, ed in particolare dalla riduzione dell’attivitàNK e della proliferazione linfocitaria indotta da antigeni, sia a livello della milzache del sangue periferico (30). Gli effetti del CRH centrale sull'attività NK dei lin-fociti splenici è rapida: entro 30 minuti dall’infusione i valori litici declinano dicirca il 50% rispetto ai controlli (31). Un test cruciale a favore dell’ipotesi che lamobilizzazione centrale del CRH durante gli stress agisca in maniera indipen-dente dai corticosteroidi surrenalici consiste nel fatto che anticorpi anti-CRH at-tenuano la soppressione immunitaria indotta dagli stress sia nei ratti normali chein quelli surrenectomizzati (28), ed anche nel fatto che la soppressione immuni-taria da CRH persiste almeno per 60 minuti in seguito all’infusione centrale, men-tre le concentrazioni plasmatiche di corticosterone rimangono elevate per almeno2 ore (32). Ancora la somministrazione periferica di anticorpi CRH attenua l’ele-vazione di ACTH e di corticosterone indotta dagli stress, ma non attenua la sop-pressione dell’immunità cellulare indotta dallo stress (26).
Come già accennato il CRH attiva il sistema nervoso autonomo, specie il sim-patico, il quale è ritenuto capace di ridurre le risposte immunitarie in seguito astress (33). Fibre noradrenergiche sono state descritte nella milza e nei maggioritessuti linfoidi (timo), che rappresentano la probabile via attraverso la quale ilsimpatico influenza l’apparato immunitario (21, 34). Inoltre le cellule del sistemaimmunitario rispondono direttamente alle catecolamine. Le cellule NK, ad esem-pio, hanno recettori per le catecolamine e probabilmente anche per il neuropep-
147
Fisiopatologia dello stress
tide Y (35, 36), e sperimentazioni in vitro hanno dimostrato che questi neurotra-smettitori simpatici possono inibire la proliferazione linfatica, l’attività NK e le ri-sposte immunitarie umorali dipendenti dai linfociti T (Th, cioè T helper ) (21).Infatti, con l’uso di un ganglioplegico (clorisondamina), incapace di superare labarriera emato-encefalica, ma che riesce a bloccare la neurotrasmissione nei gan-gli simpatici, si abolisce l’aumento della noradrenalina plasmatica prodotta dalCRH e si previene la soppressione della citotossicità indotta dallo stesso neuror-mone: così dimostrando che detta soppressione immunitaria NK è connessa al-l’attivazione del sistema simpatico (37).
Anche altri fattori che hanno la capacità di rilasciare CRH, come l’interleu-china 1, alterano l’attività NK e le risposte proliferative linfocitarie attraverso imeccanismi del sistema nervoso autonomo (38). I medesimi AA. ammettono,peraltro, che anche l’asse ipofisi-corticosurrene svolge simili funzioni sull’appa-rato immunitario attraverso l’interleuchina 1. La simpaticectomia chimica dellamilza (prodotta dal trattamento subacuto con 6-idrossidopamina) riduce la con-centrazione di noradrenalina e di adrenalina nel plasma prodotta dal CRH: cosìviene a mancare l’azione immunosoppressiva di detto neurormone (39).
Friedman e Irwin (6) ricordano ancora che i pazienti depressi presentano ele-vate concentrazioni di CRH nel liquido cefalorachidiano e che nelle vittime disuicidio esiste una riduzione della regolazione dei recettori CRH nel tessuto ce-rebrale, come osservato da Nemeroff e coll. (40). Nei pazienti depressi, pertanto,l’attività simpatica è elevata mentre sono ridotte sia la proliferazione linfocitariache le funzioni citotossiche NK dei linfociti T. Il neuropeptide Y, presente nellefibre nervose simpatiche periferiche, è anch’esso rilasciato negli stress e potenziagli effetti vasoattivi delle catecolamine e di altre sostanze pressorie (41). A que-sto proposito, secondo altri AA. (42), e come già detto in precedenza, è ormai no-zione consolidata che citochine sintetizzate e secrete dalle cellule immunitariedurante i processi infiammatori possano stimolare varie aree encefaliche e so-prattutto l’asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene, i cui ormoni sono consideratidai suddetti AA. i principali fattori dell’immunosoppressione. In particolare ci-tochine stimolano l’ipotalamo a rilasciare CRH e di conseguenza l’ACTH ipofi-sario e gli ormoni corticosurrenali. Varie citochine sono capaci di favorire questoprocesso: l’interleuchina 1 (IL-1), l’interleuchina 6 (IL-6), il fattore di necrosi tu-morale (TNF) e l’interleuchina 2 (IL-2). Nell’uomo la IL-6 sembra essere il piùpotente stimolo dell’asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene. Dette citochine eser-citano la loro azione attraverso vari meccanismi: in primo luogo si deve conside-rare che dette sostanze, specie IL-1, possono superare la barriera emato-encefalicae possono stimolare direttamente l’ipotalamo, ed anche che IL-1, come già dettoin precedenza, è sintetizzata anche nel sistema nervoso centrale dagli astrociti,
Marcello Aragona, Francesco Aragona
148
che sono numerosi nell’ipotalamo. Le medesime cellule sono inoltre capaci disintetizzare altre citochine (IL-6, TNF). Le concentrazioni plasmatiche del neu-ropeptide Y, come già ricordato, sono elevate anche in pazienti depressi e in in-dividui ansiosi (43) ed esso contribuisce ad accentuare il danno immunitarioriscontrato negli stress e nella depressione. Secondo Glaser e coll. (44), le difeseimmunitarie, che si ritengono ottenibili con le vaccinazioni, possono non esserecompletamente efficienti se l’immunizzazione viene effettuata durante periodi distress.
Biondi e Pancheri (45), sulla base di un’ampia revisione della letteratura, ri-cordano che numerosi studi sperimentali, sia in vivo che in vitro, hanno dimo-strato il ruolo delle catecolamine (noradrenalina, adrenalina) nella reattivitàimmunologica. Riportano che, secondo dati della letteratura, l’aumento delle ca-tecolamine ricorrente negli stress può essere associato con un aumento dei lin-fociti NK e non con una loro riduzione. Tuttavia, gli stessi AA. fanno presenteche altri ricercatori hanno osservato reperti opposti. Citano anche uno studio diIrwin e coll. del 1988, condotto su donne in lutto che presentavano una ridottaattività dei linfociti NK associata con un aumento del cortisolo plasmatico.
Nel complesso l’ipotesi che negli stress gli effetti immunosoppressivi sianosvolti essenzialmente dalle catecolamine per loro attivazione operata dal CRH,non esclude che in questo meccanismo intervengano anche i glicocorticoidi comesostenuto in passato ed anche in qualche studio più recente (42). D’altra partepure nei dati sperimentali che hanno rilevato l’esistenza di danno immunitario dastress in ratti surrenectomizzati, gli AA (7) hanno ammesso che il danno sud-detto non fosse di pari drammaticità rispetto a quello ottenibile in ratti con sur-reni intatti.
1. Organi linfoidiDobbiamo infine far presenti nostri studi (46) attinenti alle capacità reattive
degli organi linfoidi (tonsille, timo, milza, linfonodi) in soggetti sotto stress cro-nico venuti a morte per complicanze infettive, di natura batterica o virale.
Timo. E’ noto che quest’organo suole essere presente solo nell’infanzia e checon gli anni va incontro ad atrofia: nell’età adulta, a volte, persiste sotto forma dicumuli linfocitari follicolosimili nel contesto del tessuto adiposo retrosternale:tali cumuli sono costituiti da uno strato esterno di linfociti T, tipici della cortec-cia timica, e da uno strato interno chiaro simulante la morfologia di centri ger-minativi. Nelle nostre osservazioni, l’organo, anche nella prima infanzia, è apparsoipotrofico a livello della corticale in rapporto allo stress da malattia infettiva cheaveva preceduto l’evento mortale. Al riguardo si è visto che condizioni patologi-
149
Fisiopatologia dello stress
che di durata anche assai breve (36 ore) sono in grado di produrre una profondadeplezione timocitaria (47). Nei casi da noi studiati abbiamo visto nel timo digiovani e di adulti che i sepimenti interlobulari erano in varia misura infiltrati datessuto adiposo, che la midollare appariva più o meno ispessita, riconoscibilecome tale per la presenza di corpi di Hassall, e che la componente linfatica era inparte costituita la linfociti B di tipo centrocitico, cioè da linfociti piccoli o grandicon nucleo clivato o non, e meno frequente- mente di tipo centroblastico, cioèda linfociti a citoplasma basofilo e con nucleo contenente uno o due nucleoli disolito adesi alla membrana nucleare (tale identificazione è stata fatta in base aicriteri citologici descritti da Lennert, 48; e da Lukes e Collins, 49). I linfociti T, ti-pici della corticale timica normale, sono stati riscontrati attorno ai campi midol-lari sopra descritti, nel loro insieme simulanti immagini di lobuli timici neoformati.
Tonsille. Nei processi infettivi con localizzazione tonsillare ed extratonsillare,esaminando con cura, oltre al contenuto delle cripte, anche le condizioni dei fol-licoli linfatici, si è visto in questi ultimi la presenza di centri germinativi più omeno ampi, tanto da costituirne spesso la componente principale, essendo l’ori-ginaria area linfatica ridotta ad un sottile alone periferico. I centri germinativisono apparsi ricchi di macrofagi, i quali erano gli elementi cellulari di gran lungaprevalenti commisti alla rete delle cellule dendritiche. Plasmacellule in grande nu-mero infiltravano la tonaca propria della mucosa, anche all’interno delle cripte.
Linfonodi. E’ ovvio che la partecipazione dei linfonodi a stimoli antigene è cir-coscritta alla sede corporea interessata dal processo infiammatorio, essendo in-vece in riposo quelli delle altre regioni. Lo sviluppo dei centri germinativi èpeculiare caratteristica dei primi, ed in questi possono anche comparire, sotto lostimolo antigene follicoli secondari nella midollare. I centri germinativi sono co-stituiti oltre che da macrofagi e da cellule dendritiche, pure da linfociti B con lecaratteristiche morfologiche dei centrociti ma più spesso dei centroblasti. Si è no-tata anche la presenza di plasmacellule, talora prevalenti numericamente rispettoalle altre cellule e diffuse anche nei cordoni della midollare. Pressochè costantela presenza di macrofagi nei seni periferici, a costituire la cosiddetta linfoadenitecatarrale. La componente linfocitaria sottocorticale e paracorticale, solitamentecostituita da linfociti T, è apparsa diradata. Così pure quella dei linfociti B propridei follicoli.
Milza. Nella casistica studiata i follicoli splenici sono abitualmente ridotti di vo-lume, essendo assai sensibili agli stress, similmente alla corticale timica. Parimentirarefatti sono i linfociti dei cordoni. Come già abbiamo avuto occasione di ri-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
150
cordare lo spopolamento linfocitario da stress è estremamente rapido, verifican-dosi nello spazio di alcune ore negli stress molto intensi qual è l’assideramento.Tuttavia, pure nelle condizioni di stress, e perciò in condizioni di spopolamentolinfocitario, la stimolazione antigene è in grado di determinare la comparsa dicentri germinativi quasi esclusivamente costituiti da macrofagi nella rete di celluledendritiche, con presenza di rari linfociti e di qualche plasmacellula. Un sottilealone linfocitario si è notato attorno ai suddetti centri germinativi.
I reperti degli organi linfoidi sopra descritti, attinenti a soggetti venuti a morteper processi infettivi e di stress (traumatizzati cranici con processi broncopol-monitici acuti, tossicodipendenti con analoghi processi infiammatori polmonarie/o con epatiti virali, alcuni casi di miocardite acuta virale, due casi di epiglotti-dite acuta nella prima infanzia) hanno dimostrato che pure in condizioni di stressl’organismo è in grado di rispondere all’aggressione batterica o virale, peraltro li-mitata esclusivamente alla proliferazione macrofagica. Reazione perciò espres-siva d’un semplice processo di captazione dell’antigene senza la successiva,indispensabile, partecipazione linfocitaria, citotossica o umorale.
La soppressione immunitaria sopraddetta giustifica la costante impossibilità diimpedire, anche con trattamenti antibiotici congrui, l’evoluzione letale dei processiinfiammatori acuti batterici, specie a carico dell’apparato respiratorio, insorgentinegli stati di coma protratto.
2. Stress cronici e tumori.Secondo alcuni ricercatori (50,51,52), stimoli stressanti inevitabili, intensi e
protratti sarebbero capaci negli animali da esperimento sia di determinare un au-mento dell’incidenza dei tumori, sia la loro diffusione metastatica: quale conse-guenza della soppressione immunitaria.
Al contrario delle conclusioni di detti studi sperimentali, indagini statistichesull’uomo, su numerosa casistica, non portano a risultati favorevoli al rapportocausale stress-tumori (53,54 ).
Vi sono, peraltro, numerosi studi clinici che riportano una concomitanza fradepressione e tumore, ma non un chiaro rapporto di causalità, sia per la notevoleestensione del tempo (nell’ambito di decenni) di entrambe le patologie, sia per laconsiderazione che la depressione può essere conseguenza del tumore e non lacausa. Inoltre la classificazione della depressione è di tipo categoriale (DSM-IV),comprendendo forme acute, croniche, gravi, moderate, lievi, unipolari, bipolari,ecc., senza nessuna valutazione delle alterazioni biologiche-genetiche che ne sonoalla base (55,56,57), alterazioni che, nei sistemi sperimentali aumentano l’inci-denza di tumori e la loro diffusione metastatica (50,51,52). Va qui ricordato cheWatson e coll. (58) hanno evidenziato come pazienti con tumore della mammella
151
Fisiopatologia dello stress
e depresse mostravano una minore sopravvivenza rispetto a quelle di controlloaffette dallo stesso tipo di tumore ma non depresse.
Inoltre i risultati di un nostro studio su 138 pazienti con carcinoma della mam-mella hanno evidenziato che la sopravvivenza globale si riduce in relazione allapresenza di un particolare sottogruppo di disturbo depressivo dell’umore che èstatisticamente correlato ad alcuni marcatori di malignità tumorale (67).
Altri studi (59-61) hanno evidenziato come vari tipi di intervento psicologico-psicoterapeutico e sul supporto sociale sembrano influire positivamente sia sullaqualità di vita, che sulla progressione tumorale e sulla sopravvivenza globale, pro-babilmente attraverso effetti positivi sul sistema neuroendocrino-immunitario(62-65).
Peraltro in questo contesto ci induce a riflettere la lunga travagliata esistenzadi una delle vittime sopravvissuta all’atroce delitto del Circeo verificatosi nel set-tembre 1975, e cioè di Donatella Colasanti diciassettenne venuta a morte per uncarcinoma mammario plurimetastatizzato dopo trent’anni dal fatto (30 dicembre2005). La storia di questa donna è stata contrassegnata da uno stato angosciosomai sopito per il terrore di subire la stessa sorte della sua amica Rosaria Lopez di-ciannovenne violentata ed uccisa nel 1975 (anche la Colasanti ritenuta mortavenne nascosta con il corpo della Lopez nel bagagliaio dell’autovettura di pro-prietà di uno dei responsabili ed ivi casualmente rinvenuta per i lamenti uditi daun passante essendo l’autovettura posteggiata). Il terrore della Colasanti era mo-tivato: a) dall’essere stata la testimone del fatto delittuoso durante il processo contro i
suoi autori (Giovanni Guido, Angelo Izzo, Andrea Ghira), che furono can-dannati alla pena dell’ergastolo;
b) dall’inspiegabile concessione della semilibertà ad Angelo Izzo, il quale in talmodo si rese responsabile dell’uccisione di altre due persone (moglie e figliadi un pentito conosciuto in carcere);
c) dall’evasione dai penitenziari degli altri due, uno dei quali (Giovanni Guido)nuovamente arrestato e detenuto in carcere e l’altro (Andrea Ghira) non piùrintracciato;
d) dal convincimento che la morte di quest’ultimo per overdose di stupefacentiavvenuta nel 1994 in Marocco, appresa dagli inquirenti nell’ottobre del 2005ed accertata con il riscontro dell’assetto genetico DNA sui resti mortali, nonfosse reale: ella temeva che il suddetto vivesse nascosto in Roma ed avrebbepotuto incontrarlo in quasiasi momento;
e) da ultimo dalla morte della propria madre dalla quale traeva l’unico sostegnopsicologico, morte avvenuta circa un mese prima della sua morte. Inoltre, tenuto conto degli specifici danni prodotti dagli stress cronici sul si-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
152
stema immunitario, si potrebbe ipotizzare che una qualche influenza degli stressnell’etiopatogenesi dei tumori possa sussistere nelle forme nelle quali il ruoloetiologico fondamentale sia connesso ad agenti biologici di cui alla voce Epide-miologia dei tumori nel Trattato di Medicina Interna, Fisiopatologia e Clinica (66) ecioè: a) i parassiti Clonorchis sinensis e Opistorchis viverrini, responsabili di carcinomi
colangiocellulari in alcune aree del sud della Cina e del sud-est asiatico; b) l’infestazione da Schistosoma haematobium responsabile della bilharziosi e del
cancro della vescica, ricorrente in Mozambico e in Egitto; c) l’heliobacter pylori, che colonizza nel tratto gastro-intestinale specialmente nei
Paesi in via di sviluppo, nel carcinoma e nel linfoma dello stomaco; d) nei portatori cronici del virus dell’epatite B (HBV) il rischio dell’insorgenza di
una carcinoma epatocellulare è da 10 a 30 volte maggiore rispetto alla popo-lazione generale;
e) è stato accertato che il virus dell’epatite C (HCV) possiede un ruolo cancero-geno nell’uomo, specie nei soggetti HbsAg-;
f) nelle aree geografiche ad alta incidenza del linfoma di Burkitt (Africa tropicalee subtropicale) il virus di Epstein-Barr (EBV) sembra essere causa nel 97% deicasi di detto linfoma;
g) il papilloma virus (HPV) possa avere importanza causale nel carcinoma dellacervice uterina.
Bibliografia1. Tecoma E.S., Hucy L.Y., Psychic distress and the immune system. Life Sci. 104, 1009,
1985.2. Aragona F., Le Sindromi Decorrenti con Anossia. SEP, Pavia, 1960, p.70-86.3. Bernton E.W., Bryant H., Woldeyesus J., Holaday J., Suppression of lymphocyteand adrenal cortical function by corticosterone: in vivo antagonism by prolactin. The Phar-macologist 30, A123, 1988.
4. Bernton E.W., Prolactin and immune host defenses. Progress in Neuroendocrinim-munology 2, 21, 1989.
5. Rabin B.S., Cunnick J.E., Lysle D.T., Stress-induced alteration of immune function.Progress in Neuroendocrinimmunology 3, 116, 1990.
6. Friedman E.,M., Irwin M.R., A role for CRH and the sympathetic nervous system instress-induced immunosoppression. Ann. New York Acad. Sci. 771, 396-418, 1995.
153
Fisiopatologia dello stress
7. Keller S.E., Weiss J.M., Schliefer S.J., Miller N.E., Stein M., Stress-induced sup-pression of immunity in adrenalectomized rats. Science 221, 1301-1304, 1983.
8. Cunnick J.E., Lysle D.T., Kucinsky B.J., Rabin B.S., Evidence that shock-inducedimmune suppression is mediated by adrenal hormones and peripheral beta-adrenergic re-ceptors. Pharmacol. Biochem. Behav. 36, 645-651, 1990.
9. Flores C.M., Hernandez M.C., Hargreaves K.M., Bayer B.M., Restraint stress-in-duced elevation in plasma corticosterone and beta-endorphin are not accompanied by alte-rations in immune function. J. Neuroimmunol. 28, 219-225, 1990.
10. Friedman E.M., Coe C.L., Ershler W.B., Time-dependent affects of peer separationon lymphocyte proliferation responses in juvenile squirrel monkey. Dev. Psychobiol. 24,159-173, 1991.
11. Jessop J.J., Bayer B.M., Time-dependent effects of isolation on lymphocyte and adreno-cortical activity. J. Neuroimmunol. 23, 143-147, 1989.
12. Mormede P., Dantzer R., Michaud B., Kelley K.W., Le Moal M., Influence ofstressor predictability and behavioral control on lymphocyte reactivity responses and neuro-endocrine activation in rats. Physiol. Behav. 43, 577-583, 1988.
13. Nerozzi D., Santoni A., Bersani G. et al., Reduced natural killer cell activity in majordepression: neuroendocrine implications. Psychoneuroendocrinol. 14, 295-301, 1989.
14. Keller S.E., Schliefer S.J., Liotta A.S., Bond R.N., Farhoody N., Stein M., Stress-induced alterations of immunity in hypophysectomized rats. Proc. Natur. Acad. Sci.USA, 88, 9297-9301, 1988.
15. Cross R.J., Brooks W.H., Roszman T.L., Hypothalamic-immune interactions. I. Theacute affect of anterior hypothalamic lesions on immune response. Brain Res. 196, 79-87,1980.
16. Devi R.S., Namasivayam A., Modulation of specific immunity in albino rats. J. Neu-roimmunol. 33, 1-6, 1991.
17. Barneoud P., Neveu P.J., Vitiello S., Le Moal M., Functional heterogeneity of theright and left cerebral neocortex in the modulation of the immune system. Physiol. Behav.41, 525-530, 1991.
18. Laudenslager M.L., Ryan S.M., Drugan R.C., Hyson R.C., Maiser S.F., Copingand immunosuppression: inesplecable but not escapable shock suppresses lymphocyte proli-feration. Science 221, 568, 1983.
19. Coe C.L., Wiener S.G., Rosenberg L.T., Levine S., Endocrine and immune re-sponses to separation and maternal loss in nonhuman primates. In: Reite M., Fields T.,The Psychobiology of Attachment. Acad. Press, New York, 163-199, 1985.
20. Lysle D.T., Cunnick J.E., Fowler H., Rabin B.S., Pavlovian conditioning of shock-induced suppression of lymphocyte reactivity: acquisition, extinction, and preexposure effects.Life Sci. 42, 2185-2194, 1988.
21. Felten D.L., Felten S.Y., Bellinger D.L. et. al., Noradrenergic sympathetic neural in-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
154
teractions with the immune sistem: structure and function. Immunol. Rev. 100, 225-260, 1987.
22. Spadaro F., Berridge C.W., Baldwin H.A., Dunn A.S., Corticotropin-releasing fac-tor acts via a third ventricle sito to reduce exploratory behavior in rats. Pharmacol. Bio-chem. Behav. 36, 305-309, 1990.
23. Gray T.S., Magnuson D.S., Neuropeptide neuronal efferents from the bed nucleus ofthe stria terminalis and central amygdaloid nucleus to the dorsal vagal complex in the rats.J. Comp. Neurol. 262, 365-374, 1987.
24. Valentino R.J., Foote S.L., Aston-Jones G., Corticotropin-releasing factor activites no-radrenergic neurons of the locus coeruleus. Brain Res. 270, 363-367, 1983.
25. Brown M.R., Fisher L.A., Webb V., Vale W.W., Rivier J.E., Corticotropin-releasingfactor: a physiologic regulator of adrenal epinephrine secretion. Psychiatry Res. 328, 355-357, 1985.
26. Irwin M.R., Vale V., Rivier C., Central corticotropin-releasing factor mediates the sup-pressive effect of stress on natural killer cytotoxicity. Endocrinology 126, 2837-2844,1990.
27. Vaughn J., Rivier J., Corrigan Z. et al., Detection and purification of inhibin usingantisera generated against synthetic peptide fragments. Methods Enzymol. 168, 588,1989.
28. Jain R., Zwickler D., Hollander C.S. et al., Corticotropin-releasing factor modutatesthe immune response to stress in the rat. Endocrinology 128, 1329-1336, 1991.
29. Brown M.R., Fisher L.A., Spiess J. Rivier C., Rivier J., Vale W., Corticotropin-re-leasing factor: actions on the sympathetic nervous system and metabolism. Endocrinology111, 928-931, 1982.
30. Irwin M.R., Vale W., Britton K.T., Central cortocotropin-releasing factor suppresses na-tural killer cytotoxicity. Brain Behav. Immun. 1, 81-87, 1987.
31. Strasbaugh H., Irwin M.R., Central corticotropin-releasing hormone reduces cellularimmunity. Brain Behav. Immunol. 6, 11-17, 1992, II.
32. Irwin M.R., Jones L., Britton K., Hauger R.L., Central corticotropin-releasing fac-tor reduces natural cytotoxicity. Neuropsychopharmacology 2, 281-284, 1989.
33. Murray D.R., Irwin M.R., Rearden C.A., Ziegler M., Motulsky H., Maisel A.S.,Sympathetic and immune interactions during dynamic exercise: mediation via beta2-adre-nergic dependent mechanism. Circulation 83, 203-213, 1992.
34. Williams J.M., Peterson R.G., Shes P.A., Schmedtje J.F., Bauer D.C., FeltenD.L, Sympathetic innervation of murine thymus and splen: evidence for a functional linkbetween the nervous and immune systems. Brain Res. Bull. 6, 83-94, 1981.
35. Maisel A.S., Fowler P., Rearden A., Motulsky H.S., Michel M.C., A new methodfor isolation of human lymphocyte subsets reveals differential regulation of beta-adrenergicreceptors by terbutaline treatment. Clin. Pharmacol. Ther. 46, 429-439, 1989.
155
Fisiopatologia dello stress
36. Nair M.P.N., Effect of neuropeptide Y on natural killer activity of normal human lym-phocytes. Brain Behav. Immun. 7, 70-78, 1993.
37. Irwin M.R., Hauger R.L., Brown M., Britton K.T., CRF activates autonomic ner-vous system and reduces natural killer cytotoxicity. Am. J. Physiol. 255, R744-R747,1988.
38. Sundar S.K., Cierpial M.A., Kilts C., Ritchie J.C., Weiss J.M., Brain IL-1-induced immunosuppression occurs through activation of both pituitary-adrenal axis andsympathetic nervous system by corticotropin-releasing factor. J. Neurosci. 10, 3701-3706,1990.
39. Irwin M.A., Hauger R.C., Jones L., Provencio M., Britton K.T., Sympatheticnervous system mediates central corticotropin-releasing factor induced suppression of natu-ral killer cytotoxicity. J. Pharmacol. Exp. Ther. 255, 101-107, 1990.
40. Nemeroff C.B., Owens M.J., Bisette G., Stanley M., Reduced corticotropin-relea-sing factor binding sites in the frontal cortex of suicide victims. Arch. Gen. Psychiatry45, 577-582, 1988.
41. Romano T.A., Felten S.Y., Felten D.L., Olschowka J.A., Neuropeptide-Y inner-vation of the spleen: another potential immunomodulatory neuropeptide. Brain Behav.Immun. 5, 116-131, 1991.
42. Sternberg E.M., Licinio J., Overwiev of Neuroimmune Stress intersections. Implica-tions of susceptbility to inflammatory disease. Ann. New York Acad. Sci. 771, 364-371, 1995.
43. Irwin M.R., Brown M., Patterson T., Hauger R., Maschovich A., Grant I.,Neuropeptide Y and natural killer cell activity: finding in depression and Alzheimer care-giver stress. Faseb J. 5, 3100-3107, 1991.
44. Glaser R., Kiecolt-Glaser J.K., Bonneau R.H., Markey W., Kennedy S., HughesJ., Stress-induced modulation of the immune response to recombinant hepatitis B vaccine.Psychosom. Med. 54, 22-29, 1992.
45. Biondi M., Pancheri P., Clinical research strategies in psychoimmunology: a review of46 human research studies (1972-1992). In: Leonard B.E., Miller K.: Stress, the Im-mune System and Psychiatry. Wiley & Sons, 85-111, 1995.
46. Aragona M., Cardia G., Aragona F., Nuove acquisizioni sul significato dell’iperpla-sia dei centri germinativi nei follicoli linfatici. Atti Accad. Peloritana dei Pericolanti,60, 171-183, 1992.
47. Muller-Hermelink H.K., The Human Thymus. Histophysiolgy and Pathology. Sprin-ger, Berlin, 1986.
48. Lennert K., Malignant Lymphomas. Springer, Berlin, 1978.49. Lukes R.J., Collins R.D., Approaches on the classification of lymphomata. Br. J. Can-
cer, suppl. II, 1-28, 1975.50. Riley V., Psychoneuroendocrine influences on immunocompetence and neoplasia. Science
Marcello Aragona, Francesco Aragona
156
212, 110-1109, 1981.51. Ben-Eliyahu S., Yimiya R., Liebskind L.C., Taylor A.N., Gale R.P., Stress in-creases metastatic spread of a mammary tumor in rats: evidence for mediation by the im-mune system. Brain Behav. Immun. 5, 193-205, 1991.
52. Page G.G., Ben-Eliyahu S., Liebskind J.C., The role of LGL/NK cells in surgery-induced promotion of metastasis and its attenuation by morphine. Brain Behav. Immun.8, 241-250, 1994.
53. Reynaert C., Libert Y., Janne P., Psychogenesis of cancer: between myths, misures andrealty. Bull. Cancer 87, 655-664, 2000.
54. Aragona M., Il sistema Psico-Neuro-Endocrino-Immunitario in Oncologia. Riv. Ital.Oncol. 15, 103-115, 1988.
55. Aragona M., Muscatello M.R.A., Mesiti M., Depressive mood disorders in patientswith operable breast cancer. J. Exp. Clin. Cancer Res. (Roma) 16, 111-118, 1996.
56. Aragona M., Relazione fra stress e tumori. In: Aragona M., La Torre F., NuoveStratergie Terapeutiche e Qualità di Vita in Oncologia. Atti Congr. Universtà di Mes-sina 9-10 marzo 2001,136-138.
57. Chrousos G.P., Gold P.W., The concept of stress and stress system disorders: overviewof physical and behavioral homeostasis. JAMA 267, 1244-52, 1992.
58. Watson M., Haviland J.S., Greer S., Davidson J., Bliss J.M., Influence of psycho-logical response on survival in breast cancer: a population based cohort study. The Lan-cet 354, 1331-6, 1999.
59. Spiegel D., Psychosocial intervention in cancer. J. Nat. Cancer Inst. 85, 1198-1205,1993.
60. Fawzy F.I., Psychosocial interventions for patients with cancer: what works and what doe-sn’t. Eur. J. Cancer 35, 1559-64, 1999.
61. Kogon M.M., Biswas A., Pearl D., Carlson R.W., Spiegel D., Effects of medicaland psychotherapeutic treatment on the survival of women with metastatic breast carcinoma.Cancer 80, 225-230, 1997.
62. Kiecolt-Glaser J.K., Glaser R., Psychoneuroimmunolgy and cancer : fact or fiction?Eur. J. Cancer 35, 1603-7, 1999.
63. Maruta T., Colligan R.C., Malinchoc M., Offord K.P., Optimists vs pessimists:survival rate among medical patients over a 30-year period. Mayo Clinic Proc. 75, 140-3, 2000.
64. Greer S., Mind-body research in psychooncology. Adv. Mind Body Med. 15, 236-44,1999.
65. Giraldi T., Stress, metastasi e curabilità dei tumori. In: Bellani M.L., Morasso G.,Amadori D., Orrù W., Grassi L., Casali P.G., Bruzzi P., Psiconcologia. Masson,Milano, 97-108, 2002.
66. Rodella S., Cetto G.L., Epidemiologia dei Tumori. In: Scuro L.A., Medicina Interna.
157
Fisiopatologia dello stress
Fisiopatologia e Clinica. UTET, Torino, Vol. III, 85-111, 1997.67. Aragona M., Muscatello M.R.A., Panetta S., Psychobiological variables before dia-gnosis may predict survival of breast cancer patients. Atti VI Congresso Nazionale diOncologia Medica. Bologna 21-24 sett. 2004. Annals of Oncology 15, N53,2004.
Capitolo VI
Lesioni cardiache negli stress
In seguito al forte terremoto che colpì l’area attorno a Los Angeles nel 1994,oltre ai decessi avvenuti nell’immediatezza del sisma, vi fu una seconda serie didecessi (con una media giornaliera di 15.6, rispetto ai 51 nel giorno del sisma)connessa a sequele morbose cardiache in persone rimaste incolumi durante il ter-remoto. Il New England Journal of Medicine sostenne che negli individui predispo-sti lo stress emotivo avesse determinato il quadro della morte cardiaca in soggettiportatori di danni cardiaci misconosciuti. Era stato tuttavia ammesso uno strettorapporto causale fra stress e danno cardiaco non solo in caso di shock improv-visi ed acuti come quelli suscitati da terremoti, ma anche in rapporto a stress cro-nici come ansia, depressione, lunghi periodi di lavori pesanti, minacce dilicenziamento, ecc., anche quando manchino i comuni segni premonitori (iper-tensione, ipercolesterolemia, obesità). In uno studio pubblicato su The Lancet nel-l’anno precedente all’infarto miocardico un campione di 11.000 persone avevasubito livelli di stress eccezionali (La Repubblica, 10 ottobre 2005).
La cardiomiopatia osservabile nel corso degli stress in realtà non sempre ri-produce il quadro classico dell’infarto, ma si caratteriza per focolai di necrosisparsi nel contesto del miocardio e che saranno in seguito descritti, attribuibili al-l’azione diretta sulle fibre miocardiche dalle catecolamine (noradrenalina, adre-nalina) ampiamente e costantemente ipersecrete nel corso degli stress, sia acuti checronici, non solo liberate dalla midollare surrenale e riversate nel circolo sangui-gno ma anche liberate (noradrenalina) a livello delle terminazioni simpatiche pe-riferiche, comprese quelle cardiache, come ricordato nella prima parte di questovolume. Si ritiene che gli ormoni della corteccia surrenale possano concorrerenel favorire i suddetti effetti nocivi delle catecolamine sulle fibre muscolari car-diache. Secondo Raab (1), il mantenimento di una certa concentrazione e d’un re-ciproco rapporto del potassio, del magnesio e del sodio all’interno della fibramuscolare cardiaca costituisce un requisito essenziale per la normale formazionee conduzione dello stimolo elettrico. Disturbi critici del bilancio elettrolitico mio-cardico sono abitualmente presenti in rapporto a difetti irrorativi del miocardio,ma possono essere attuali per l’azione congiunta catecolamine–steroidi surrena-lici, sia glicocorticoidi che mineralcorticoidi, attraverso un difetto di apporto diossigeno al miocardio essendovi una discrepanza fra l’effettivo apporto locale diossigeno e il suo consumo, che per effetto delle catecolamine è esageratamenteaumentato. Le condizioni ipossiche che in tal modo vengono a realizzarsi nelmiocardio determinano, durante la contrazione sistolica, perdita di potassio e di
159
magnesio da parte della fibra miocardica e contemporaneamente assunzione disodio, senza che successivamente si abbia il ripristino fisiologico del gradiente io-nico della fase intra- ed extra-cellulare. Da ciò derivano disturbi del ritmo e dellacontrattilità cardiaca. Se la perdita di potassio e di magnesio è cospicua, si realiz-zano fenomeni di lisi delle fibre miocardiche, le quali possono presentarsi sottoforma di aree di necrosi focale o come ampie zone di necrosi di tipo infartuale.L’incremento di produzione di mineralcorticoidi, che abitualmente complica glistress, aggrava gli effetti suddetti per la ritenzione di sodio e di acqua, spesso re-sponsabile anche dell’edema interstiziale che frequentemente si osserva nei casimortali.
Il suddetto rapporto causale, fra catecolamine e necrosi miocardica, è docu-mentato non solo dai numerosi dati della letteratura attinenti all'azione cardio-tossica propria delle catecolamine, anche sperimentali come sarà detto più avanti,ma soprattutto dai danni miocardici costantemente osservati nei portatori di feo-cromocitoma, notoriamente neoplasia di natura benigna ma produttrice di ab-normi quantità di catecolamine (2-8).
La necrosi miocardica da catecolamine, nota come miocitolisi coagulativa, è ca-ratterizzata nella fase iniziale da ipercontrazione delle fibre muscolari con accor-ciamento dei sarcomeri, associata a frammentazione delle miofibrille eformazione di bande anomale trasverse riferibili a coagulazione dei sarcomeriipercontratti, bande poi destinate alla lisi sotto forma di disgregazione miofibril-lare. Il nucleo permane inalterato per breve tempo, per poi scomparire insiemecol tessuto muscolare necrotico. Mancano lesioni vasali, sia ematiche che linfati-che, del sarcolemma, dell’endomisio e del perimisio interno, nonché infiltrati cel-lulari. Le suddette alterazioni compaiono dopo pochi minuti dall’incidenzadell’effetto cardiotossico delle catecolamine com’è documentato da indagini spe-rimentali (9-13) e, per la loro morfologia, depongono per un arresto della fibramuscolare in fase di contrazione (morte tetanica). Per quanto attiene alla man-canza di alcuna reazione cellulare, come invece costantemente si verifica nel pro-cesso riparativo della classica necrosi infartuale da occlusione coronarica, e perquanto attiene allo smaltimento del tessuto necrotico, si dirà in seguito a com-mento delle nostre osservazioni.
La rapidità d’insorgenza della miocitolisi coagulativa è da correlare al fatto chedi regola le catecolamine sono attive per brevissimo tempo dopo la loro libera-zione: la noradrenalina liberata direttamente nei tessuti dalle terminazioni ner-vose rimane attiva solo per pochi secondi; la noradrenalina e l’adrenalina immessein circolo dalla midollare surrenale rimangono attive per 10-30 secondi, dopo diche la loro attività va decrescendo fino ad estinguersi entro uno-molti minuti,come già ricordato nel capitolo IV/2.1.2 della parte prima (14).
Marcello Aragona, Francesco Aragona
160
Dal punto di vista biochimico, l’effetto cardiotossico di dette sostanze è statoindagato da numerosi ricercatori soprattutto sperimentalmente sugli animali. Si èvisto che le catecolamine interferiscono sull’attività elettrica delle cellule miocar-diche attraverso la stimolazione dei recettori alfa e beta-adrenergici. Svolgono quiil ruolo più importante i recettori beta in quanto regolatori dei numerosi tipi dicorrenti ioniche che attraversano le cellule muscolari cardiache, tra le quali vannoricordate quelle del calcio, del sodio, del potassio e la pompa sodio-potassio (15-29). L’aumento del calcio intracellulare, in quanto indicativo di alterazioni dellapermeabilità della membrana cellulare, è stato considerato fattore di primaria im-portanza nel determinismo della cardiomiopatia da catecolamine (30). Alcune ri-cerche dimostrerebbero che l’aumento del calcio intracellulare indotto dallecatecolamine sarebbe in relazione agli effetti fluidificanti prodotti dalle medesimesul distrato lipidico della membrana cellulare attraverso l’attivazione del sistemafosfatidiletanolamina-N-metiltransferasi del sarcolemma (31). L’aumento del cal-cio all’interno dei cardiociti comporta un incremento dei suoi legami ad una spe-cifica proteina regolatrice (la troponina nel complessotroponina-tropomiosina-actina), che permette la formazione di ponti fra la mio-sina ed i siti di actina dei filamenti sottili. Si ha così formazione di actomiosina,che è associata ad un aumento dell’attività ATPasica miosinica, a traslocazione dimiofilamenti e ad accorciamento delle miofibrille (31).
Inoltre, a proposito della stimolazione dei beta2-recettori e della pompa delsodio-potassio, è stata presa in considerazione anche la possibilità di una cadutadel contenuto di potassio nel plasma, che costituirebbe un fattore ulteriore didanno cardiaco (32). Le conseguenze biochimiche a livello cellulare della stimo-lazione predetta comprendono anche una sequenza di aumento e di riduzionedei livelli di AMP ciclico (33,34), deplezione delle riserve di adenosina trifosfatoe di creatininfosfato (35,36), alterazioni morfologiche e funzionali dei mitocon-dri (37,38). Beamish e coll. (39) richiamano l’attenzione anche sul ruolo pato-geno svolto dai prodotti di degradazione delle catecolamine derivanti da loroautossidazione, ed in particolare dell’adrenocromo in quanto capace di produrrearitmie, di deprimere la funzione cardiaca e di causare la morte degli animali daesperimento in rapporto alla dose; ed inoltre in quanto capace di alterare la mor-fologia delle cellule miocardiche e di deprimere le funzioni mitocondriali e i livellidi ATP e CP. L’adrenocromo può essere ulteriormente ossidato producendo ra-dicali liberi, i quali hanno il potere di aumentare la permeabilità delle membranecellulari e di produrre danni cellulari irreversibili (40-42).
Sulla base di queste conoscenze, nell’ambito della nostra casistica di cui al ca-pitolo IV della Prima parte, abbiamo studiato il cuore di 208 casi di omicidio, di
161
Fisiopatologia dello stress
cui 113 casi raccolti fra il 1958 e il 1975 e 95 casi fra il 1988 e il 1997. Si trattavadi soggetti per la maggior parte venuti a morte istantanea o rapida, ad eccezionedi 5 casi deceduti rispettivamente dopo 1 ora, 12 ore, 24 ore, 60 ore, 7 giorni.Sono stati studiati anche 62 casi di suicidio e i due casi omicidio-suicidio, com-presi quelli da avvelenamento già ricordati a proposito dell’indagine sull’encefalo,nonché i 30 casi deceduti per trauma cranico, ed i 33 casi di tossicodipendenti de-ceduti per overdose, anch’essi già ricordati nell’indagine sull’encefalo. Inoltre sonostati studiati per controllo: a) 18 soggetti giovani venuti a morte per elettrocuzione accidentale, 16 dei quali de-
ceduti istantaneamente o rapidamente, 1 dopo 36 ore dall’insulto elettrico pertrauma cranico riportato nella conseguente precipitazione dall’alto (caso noncompreso nell’elenco dei 30 traumatizzati cranici sopra riportati) e l’altro dopo33 giorni per complicanze emorragiche gastro-intestinali da stress (questa par-ticolare patologia da stress sarà trattata successivamente);
b) 2 casi di morte inattesa da arresto cardiaco conseguente a somministrazioneparenterale di 0.5 mg di atropina in preanestesia (giovane di anni 17 traumatiz-zato cranico in stato di coma vigile da 48 giorni, non compreso nel gruppo deitraumatizzati sopra considerato; donna di 39 anni): questi casi sono stati uti-lizzati per la conoscenza che l’atropina, per il prevalere del tono simpatico,produce di frequente tachicardia e può determinare arresto cardiaco;
c) 3 casi di morte improvvisa da coma ipoglicemico da iperinsulismo endogeno: 1 caso at-tinente ad una adolescente di 14 anni, 2 casi attinenti a neonati affetti da ne-sidioblastosi, uno dei quali deceduto dopo 15 ore dalla nascita e l’altro dopo2mesi dalla nascita. In complesso il cuore è stato studiato, compresi i controlli, in 360 casi. Lo stu-
dio istologico è stato eseguito su sezioni di miocardio prelevate dalla parete delventricolo sinistro e dal setto interventricolare, nonché su sezioni ventricolaricomprendenti i tronchi coronarici principali.
I vetrini di pezzi inclusi in paraffina sono stati colorati con emallume-eosina,Mallory-Vannucci, reazione al PAS. I preparati sono stati esaminati anche a lucepolarizzata per la ben nota conoscenza che le bande delle fibre muscolari striate,scure nella colorazione con emallume-eosina sono birifrangenti o anisotrope (bandeA), mentre le bande poco colorabili sono isotrope (bande I) o molto debolmente ani-sotrope e perciò sostanziamente non birifrangenti.
Risultati1. Miocitolisi coagulativaNella casistica esaminata, compresi i controlli, le fibre miocardiche appaiono
pressochè costantemente ipercontratte, tanto che a luce polarizzata non è possi-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
162
bile distinguere le bande A dalle bande I, per il fatto che le fibre stesse appaionouniformemente birifrangenti, come se le bande anisotrope si siano fuse tra loromascherando del tutto le bande intermedie isotrope. Per questo motivo i sarco-meri risultano accorciati, ma non sempre aumentati di spessore, come avvienenella contrazione normale, perché nel contempo sopravviene la miocitolisi coa-gulativa, la cui immagine iniziale sembra consistere in un fenomeno di fissurasionelongitudinale con principio a livello dello spazio fusiforme sede del nucleo, chenon è interessato dalla lesione. Tali immagini, che possono ritenersi il processoiniziale dei focolai di miocitolisi coagulativa, come accennato, caratterizzano leforme nelle quali la morte è sopravvenuta in brevissimo tempo per arresto car-diaco: elettrocuzione; ipertono simpatico per iniezioni di atropina in preaneste-sia, coma ipoglicemico. In questi casi, ed in modo particolare nell’elettrocuzione,i sarcomeri, oltre ad apparire ipercontratti, e spesso tra di loro distaccati, sono de-formati per loro fissurazione longitudinale che li assottiglia fino a trasformarlitalvolta in formazioni a spirale. La fissurazione longitudinale produce spesso nellefibre ipercontratte marcata divaricazione centrale realizzante immagini lacunari adellissi delimitate da sottili pareti fibrillari fuse e compattate (Fig. n. 32,33).
Per il critico assottigliamento dei sarcomeri si realizzano immagini lacunari,prive di contenuto, anche nell’interstizio. I focolai di miocitolisi coagulativa con-clamata sono caratterizzati da disgregazione granulare di segmenti o di interi sar-comeri che perdono gradualmente la birifrangenza fino alla loro completadissoluzione realizzante campi interstiziali lacunari, che differiscono da quelle inprecedenza descritte per il fatto che in queste si rinvengono grovigli fibrillari piut-tosto lassi, capillari sanguigni e linfatici, tubi sarcolemmatici vuoti sotto forma diesilissimi filamenti appaiati a decorso flessuoso, separati da sottili spazi vuoti cen-trali, appena visibili con le comuni colorazioni (Fig. 34).
Nelle lacune vi possono essere pure frammenti di cardiociti meglio apprezza-bili a luce polarizzata, frammenti di cardiociti deformati a salsicciotto o a spiraleo come masserelle amorfe solo in parte birifrangenti, nuclei nudi di cardiociti,granuli, parimenti birifrangenti, incrostanti i tubi sarcolemmatici vuoti: perciònelle prime fasi i nuclei dei cardiociti, rimanendo integri, sono frammisti alle altrestrutture organiche presenti nelle lacune da miocitolisi. Non sono riscontrabilimacrofagi, né linfociti, né polinucleati neutrofili: il che differenzia sostanzialmentetale forma di necrosi dalla necrosi infartuale e l’avvicina all’apoptosi. Focolai dimiocitolisi coagulativa si riscontrano anche nel contesto del fascio di conduzioneatrio-ventricolare, ove all’assottigliamento del corpo cellulare si associa un as-semblamento delle miofibrille per verosimile riduzione della componente sarco-plasmatica.
Le lesioni miocitolitiche interessano in modo ineguale i cardiociti, talchè la
163
Fisiopatologia dello stress
loro estensione ed il loro grado non sono proporzionali alla durata dello stress,bensì alla sua intensità e alla sua qualità, com’è dimostrato dal fatto che i focolaidi miocitolisi sono meglio evidenti nei casi di morte da stress iperacuto, nellemorti da overdose, nei suicidi, in vittime di omicidio quando l’uccisione era statapreceduta da uno stress molto intenso, anche non in relazione con l’aggressionemortale.
L’ipercontrazione delle miofibre è solo parziale o manca del tutto quando l’ef-fetto catecolaminico preesistente è soverchiato dalla sovrapposizione d’una in-tensa liberazione di acetilcolina che determina una decontrazione conassottigliamento delle miofibre: è il caso di soggetti che vengono a morte per ab-norme stimolazione parasimpatica (morte da inibizione da trauma su zona ri-flessogena) nel corso di una forte emozione (rissa o altra simile situazioneemotiva). Analogo fenomeno si osserva quando nel sangue circolante subentra unpatologico aumento dell’acetilcolina per mancata degradazione enzimatica con-seguente a blocco delle colinesterasi, come accade nell’avvelenamento suicidiarioda esteri fosforici, posto che detto effetto acetilcolinico si sovrappone al preesi-stente stato emotivo connaturato con la maturazione e l’attuazione del propositosuicida e quindi contrassegnato da accentuata liberazione di catecolamine. In talicasi, perciò, possono contemporaneamente osservarsi nel miocardio l’ipercon-trazione da catecolamine e la decontrazione da acetilcolina, oltre, naturalmente,ai reperti tipici di altri organi che caratterizzano la morte da inibizione, su cui siritornerà in seguito.
Nei vari gruppi di soggetti presi in esame, i suddetti focolai di miocitolisi coa-gulativa sono stati osservati con diversa frequenza: costanti nei tossicodipendenti,specie nei cocainomani (notoriamente la cardiopatia dei cocainomani è tipica-mente simile a quella da stress), nei traumatizzati cranici e nello stress acuto; quasicostanti nei suicidi. Per quanto riguarda le vittime di omicidio le suddette lesionimiocardiche furono osservate in circa la metà dei casi nel gruppo studiato fra il1958 e il 1975 e nella totalità dei casi nel gruppo studiato fra il 1988 e il 1997, etra questi anche quando la morte era avvenuta istantaneamente, evidentemente inrelazione allo stato di stress cronico che aveva preceduto l’aggressione mortale.Questa deduzione è confermata dal fatto che nelle cosiddette vittime innocenti,coinvolte casualmente nel fatto delittuoso, il processo era assente.
La differente incidenza del danno cardiaco da stress riscontrata fra i due gruppidi omicidi esaminati (1958-1975; 1988-1997): in quasi la metà dei casi fra il 1958e il 1975 e nella totalità dei casi fra il 1988 e il 1997, è a nostro avviso da attribuireal fatto che nel contesto sociale in studio (Provincia di Reggio Calabria) la lottaper il predominio negli interessi deliquenziali, nel secondo periodo considerato,era divenuta asperrima, tale da creare negli individui che vi partecipavano situa-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
164
zioni di conflitto infrapsichico difficilmente compensabili. E’ verosimile che ilmutamento ambientale peggiorativo possa essere collegato alla graduale scom-parsa dei capi carismatici della delinquenza locale, o per morte naturale o per sop-pressione violenta: capi, i quali oltre a controllare tutte le attività illecite delproprio gruppo, col loro prestigio garantivano agli affiliati una certa tranquillitàesistenziale, tranne per coloro che non erano rispettosi dei limiti territoriali dicompetenza ovvero dei divieti, assai severi, nei confronti di attività illecite ini-zialmente non accettate, fra le quali soprattutto lo spaccio di stupefacenti. In rap-porto a quanto sopra si era instaurata una competizione senza quartiere fra igruppi criminali al di fuori di qualsiasi regola di comportamento (ammesso chedi regole si possa parlare in ambito criminale), ognuno dei quali intendeva rag-giungere ad ogni costo il predominio incontrastato nelle attività delinquenziali,esclusivamente finalizzate al guadagno immediato ed ingente, senza limitazioniterritoriali. Si ebbe di conseguenza un notevolissimo incremento degli omicidi(non più circoscritti ai casi di deroga non consentita dalle disposizioni di ver-tice) e quindi anche l’annullamento della barriera protettiva un tempo garantita dalcapo, donde l’insicurezza assoluta circa la propria incolumità per chiunque fa-cesse parte delle suddette organizzazioni: era divenuto allora imperativo mante-nere uno stato di vigilanza anche nelle ore dedicate al riposo, con indubbioturbamento dei bioritmi. Sì che la situazione ambientale rappresentava nel con-testo subculturale preso in esame il fattore causale di gran lunga prevalente nel-l’etiopatogenesi del danno cardiaco osservato: altrimenti non si sarebbero dovuteriscontrare differenze fra la casistica anteriore al 1975 e quella successiva al 1988.
2. FibrosiNelle aree di miocitolisi, quasi contestualmente alla necrosi dei cardiociti, si
realizza il collasso, con loro assemblamento, delle strutture reticolari interstizialie vascolari rimaste integre, nonché dello strato esterno del sarcolemma, dell’en-domisio e del perimisio interno. Si realizzano così grovigli fibrillari nei quali èpossibile abitualmente riconoscere, come già detto, tubi sarcolemmatici vuotisotto forma di filamenti appaiati, paralleti, ondulati, delimitanti un sottilissimocanale vuoto (Fig. 35,36).
Pertanto non vi è neoformazione di connettivo cicatriziale come avviene nelclassico infarto. Le strie fibrotiche mantengono indefinitamente decorso ondu-lato delle fibrille che le compongono, riferibile all’accorciamento subìto dai sar-colemmi e dall’endomisio durante l’ipercontrazione tetanica delle miocellule almomento dell’insulto necrotizzante. Accanto alle suddette strie fibrotiche chesono disposte parallelamente al decorso delle miocellule, si possono riscontrarestrie fibrose a decorso trasversale rispetto alle miofibre. Esse si sviluppano at-
165
Fisiopatologia dello stress
torno a diramazioni arteriose seguendone il decorso e nella loro composizionepartecipa pure il perimisio interno. Ad uno dei loro versanti estremi possono os-servarsi sfioccamenti di un insieme di fibrille, fittamente intrecciate, disposte afrangia, che compenetrano i fasci miocardici adiacenti, decorrendo parallelamentea questi ultimi: si ha l’impressione che queste strie di fibrosi si realizzino quandola necrosi interessa i punti di ancoraggio delle miocellule al perimisio interno, conloro totale distacco (44).
Le lesioni, sia acute che croniche, sono più marcate nel setto interventrico-lare, laddove interessano pure, come già detto, le miocellule del fascio di condu-zione atrio-ventricolare. Non di rado qui la fibrosi che consegue alla miocitolisiincarcera in modo più o meno diffuso le miocellule di Purkinje (Fig. 37).
Nelle vittime di omicidio, come nei suicidi, nei tossicodipendenti, nei trau-matizzati cranici ed in coloro che vivono in stato di allerta o di tensione continuile sopra descritte lesioni miocardiche si riscontrano pure in giovani al di sotto dei20 anni, del tutto indipendentemente da danni a carico delle coronarie. In dettacasistica, infatti, lievi note di fibrosi intimale nei rami coronarici sottoepicardicie/o ispessimento della media nelle arteriole intramurali sono state osservate incirca un quarto dei casi studiati, mentre la fibrosi miocardica era presente in tuttii tossicodipendenti, in tutti i suicidi, nei soggetti tormentati da problemi psico-logici fonti di frustrazioni afflittive (vittime di omicidio-suicidio), nei traumatiz-zati cranici lungodegenti, in coloro che, per motivi professionali (pilota di aereo)o per diporto (motociclista), la tensione psichica era massima, in tutte le vittimedi omicidio esaminate successivamente al 1988 ed in circa la metà di quelle esa-minate fra il 1958 e il 1975.
I danni miocardici sopra descritti sono, infine, più accentuati nei cocainomani.
3. Le ghiandole surrenaliLe ghiandole surrenali studiate nelle vittime di omicidio, nei controlli e nei
tossicodi- pendenti presentavano immagini di stimolazione cronica sia a livellocorticale che midollare, e spesso immagini di sovrastimolazione acuta, già de-scritte nel capitolo IV.2 della parte prima. Detti reperti di sovrastimolazione acutaosservati nelle vittime di omicidio sono da riferire al fatto emotivo terminale con-nesso all’improvvisa consapevolezza della propria imminente uccisione, mentrenei suicidi sono da attribuire alla fase di maturazione dell’idea di autosoppres-sione (vedi in seguito nel capitolo IX). Nell’ambito delle vittime di omicidio sonoda segnalare otto casi, i primi due senza lesioni cardiache, presenti invece neglialtri: il primo riguardante un uomo di 32 anni, impiegato, che conduceva una vitatranquilla, aggredito ed ucciso inaspettatamente ed immotivatamente da personaaffetta da malattia mentale, il secondo attinente a giovane diciassettenne ucciso
Marcello Aragona, Francesco Aragona
166
perché casuale testimone d’un omicidio. Nel primo caso (vedi fig. 1) non esistevaalcuna modificazione morfologica a livello surrenale, il che dimostra che il sog-getto non sospettava neppure si essere bersaglio di immaginarie rivendicazioni delsuo aggressore; nel secondo invece la corticale e la midollare surrenale mostra-vano segni parcellari di stimolazione iperacuta riferibili allo stato improvviso dipaura, peraltro di brevissima durata. Negli altri sei casi, riguardanti uomini di anni18, 22, 36, 40, 41, 58, uccisi di sorpresa alle spalle, portatori di fibrosi cardiaca edi segni morfologici di iperattività cronica della corticale e della midollare surre-nale, mancavano in questa ghiandola segni di sovrastimolazione acuta, per cuideve ritenersi che i soggetti non abbiano avuto alcuna contezza di quanto stavaper accadere.
Relativamente al reperto surrenalico nel gruppo dei suicidi, ci si sofferemerànel capitolo IX.
Sintesi conclusivaLe indagini condotte confermano che la miocitolisi coagulativa è da conside-
rare conseguenza diretta dell’effetto cardiotossico esplicato dalle catecolaminesulle fibre muscolari cardiache, come già ampiamente documentato in patologiasperimentale e nei portatori di feocromocitoma (2-8). Detto effetto si concretaperciò in tutte le condizioni che comportino immissione in circolo abnorme dicatecolamine dalla midollare surrenale e liberazione locale delle medesime dalleterminazioni simpatiche periferiche. L’effetto necrotizzante predetto si realizzanello spazio di qualche minuto per le ragioni già accennate. A parte il feocromo-citoma, che è un vero e proprio esperimento di natura, le condizioni di cui sopraricorrono più comunemente nel corso di qualsiasi stress a carattere cronico, chegeneri angoscia o stato persistente di allerta e non trovi alcun compenso dalpunto di vista psicologico e che non siano perciò rimossi. Si è detto in prece-denza quali siano i meccanismi patogenetici d’ordine biochimico attraverso i qualile catecolamine esplicano la loro azione lesiva diretta sulle fibre miocardiche. Quiè necessario ribadire, sulla base dei riscontri obiettivi della presente indagine, cheil danno morfologico essenziale ed iniziale consiste in uno stato d’ipercontra-zione delle miocellule associato ad assottigliamento delle stesse (immagini simili,ma molto più marcate, si osservano nella morte da elettrocuzione). A detto fe-nomeno iniziale segue la necrosi focale per disgregazione granulare. La necrosi èlimitata ai soli cardiociti, con risparmio dei loro nuclei e senza interessamento deisarcolemmi e delle strutture interstiziali, fibrillari e cellulari, e dei vasi capillari, siaematici che linfatici. L’assottigliamento delle fibre miocardiche, che interessa purele cellule di Purkinje del fascio di conduzione atrio-ventricolare e che contrastacol loro stato d’ipercontrazione, è verosimilmente da riferire alla perdita di acqua
167
Fisiopatologia dello stress
e di sali in conseguenza delle alterazioni metaboliche intrinseche cui già accennatoe che conduce, prima della necrosi, alla fissurazione longitudinale delle stesse apartire dallo spazio perinucleare.
Altra caratteristica assolutamente peculiare di questa particolare forma di ne-crosi consta nella mancanza di qualsiasi reazione cellulare diretta allo smaltimentodei prodotti della necrosi e alla riparazione mediante tessuto di granulazione,come di solito avviene in qualunque processo necrotico, compreso quello ische-mico classico cardiaco da ostruzione arteriosa. Poiché lo smalti- mento del tes-suto necrotico è qui fenomeno assai fugace, tanto che di detto tessuto si colgonousualmente solo le immediate conseguenze e cioè le immagini lacunari realizzatedalla sua eliminazione, e poiché i capillari sanguigni e linfatici non vengono coin-volti dalla necrosi, è da ritenere che i prodotti della lisi miocellulare siano pron-tamente riassorbiti ed eliminati attraverso il torrente circolatorio ematico e/olinfatico. Se così non fosse, si dovrebbero sempre riscontrare, ai margini dei fo-colai necrotici, polinucleati neutrofili, linfociti, macrofagi e poi anche fibroblasticon capillari neoformati, come naturale reazione ai criptoantigeni liberati dallanecrosi cellulare (necrotassi di Bessis: 45) e non riconosciuti come propri, cosìcome si verifica nella necrosi infartuale, ove la simulatanea compromissione deivasi non consente un rapido riassorbimento del tessuto necrotico che perciò vieneriassorbito secondo gli schemi classici conosciuti in patologia.
Non è, peraltro, escluso che la mancata, consueta, reazione riparativa intersti-ziale sia anche connessa al risparmio, nella miocitolisi coagulativa, dei nuclei deicardiociti, a cui va attribuito, secondo la patologia moderna, il principale ruolo an-tigene. Il riscontro sporadico di mastcellule nei focolai di miocitolisi dimostra cheneppure questi elementi, di comune riscontro nel miocardio normale, subisconogli effetti della necrosi.
In una recentissima indagine condotta da Wittstein e coll. (46) su 19 soggettiviventi, di età compresa fra 27 e 87 anni, ma in prevalenza superiore agli anni 50(18 di sesso femminile), che avevano accusato dolori toracici, relativa al rapportoetiopatogenetico fra danno cardiaco e stress emotivi episodici (gravi controver-sie, incidenti stradali, morte di familiari, paura di parlare in pubblico, ecc.), hannonotato disordini funzionali del ventricolo sinistro senza compromissione coro-narica. Hanno concluso per un verosimile rapporto causale con un ipertono sim-patico. In 5 dei 19 casi studiati hanno eseguito una biopsia endomiocardica, in 4dei quali hanno notato la presenza di infiltrati linfocitari e macrofagici con bandedi contrazione senza necrosi miocitaria; nel quinto caso estesi infiltrati linfocitarie focolai multipli di miocitolisi.
Riguardo agli infiltrati linfocitari e macrofagici dobbiamo osservare che si trattadi manifestazioni morfologiche che non sono per nulla specifiche della miocito-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
168
lisi da stress per il fatto, già ricordato, che i fenomeni necrotici delle fibre mu-scolari cardiache sono limitati alle miofibrille ed al sarcoplasma, mentre riman-gono del tutto indenni l’endomisio, il perimisio interno ed i sarcolemmi, nonchéi nuclei miocellulari e le strutture interstiziali (fibre reticolari, capillari sanguignie linfatici): ciò rende possibile l’eliminazione rapida del materiale necrotico, inbrevissimo tempo, per via della circolazione ematica e linfatica, senza che ab-biano luogo locali fenomeni infiammatori riparativi, al contrario di quanto ac-cade nella classica necrosi infartuale, come già ricordato. A ciò si aggiunge laconoscenza che la risposta immunitaria nel corso degli stress è sostanzialmenteinibita. Per cui deve ritenersi che gli infiltrati linfocitari e macrofagici descritti daisuddetti AA. (46) in frammenti bioptici endomiocardici non siano confermatividelle condizioni di stress, ma abbiano un significato diverso, presumibilmente dinatura infiammatoria. Le strutture non compromesse dalla necrosi (strato esternodel sarcolemma, endomisio, perimisio interno) vanno molto rapidamente incon-tro a collasso ed al loro assemblamento, realizzando le strie fibrotiche che costi-tuiscono l’esito finale dei focolai di necrosi. In tali strie le fibrille reticolarimantengono stabilmente il loro aspetto ondulato (connesso all’origiaria ipercon-trazione delle miocellule, poi andate in necrosi), e nel loro contesto rimangonoincarcerati i capillari sanguigni e linfatici e le fini diramazione arteriose. Sì che, no-nostante i vasi predetti non siano colpiti dalla necrosi, il loro incarceramento neltessuto fibroso ne determina l’obliterazione e la loro esclusione dalla circolazione.
La circostanza che le lesioni da catecolamine siano più marcate nel setto in-terventricolare, interessando anche il fascio di conduzione atrio-ventricolare, èda attribuire al fatto che qui il tessuto miocardico è più sensibile all’azione dellecatecolamine (47).
Così come succede nella cardiomiopatia da feocromocitoma è da presumereche anche nello stress cronico non compensato la ripetizione nel tempo di epi-sodi di miocitolisi coagulativa e la fibrosi da collasso conseguente conducano adassottigliamento delle pareti cardiache concretando il quadro della cardiomiopatiadilatativa (8). Sì che questa forma patologica che oggi incide più frequentementerispetto al passato può in molti casi essere conseguenza dello stress cronico con-nesso ai radicali mutamenti della società moderna, che valorizza soprattutto il be-nessere materiale, economico (l’Avere di Fromm, 48), mentre trascura del tutto gliaspetti interiori, spirituali, culturali della personalità (l’Essere di Fromm). Il rap-porto causale dello stesso quadro patologico con l’effetto cardiotossico delle ca-tecolamine è ancora convalidato dal fatto che tale forma morbosa si riscontraanche nei cocainomani (49, 50), laddove le lesioni miocardiche, sia a carattereacuto che cronico, sono più accentuate in ragione del fatto che la cocaina, svol-gendo sulle cellule miocardiche un effetto tossico simile a quello delle catecola-
169
Fisiopatologia dello stress
mine, ne potenzia l’azione (51, 52).E’ illuminante a questo proposito un richiamo alla patologia cardiovascolare
della popolazione negra americana in quanto la medesima trova adeguata spie-gazione etiopatogenetica nello stress, in tempi non troppo remoti, connaturatocon le condizioni di vita di detta popolazione nel contesto della società nord-americana e che qui si somatizzava principalmente con l’aumento della pressionearteriosa. Già negli anni trenta del secolo scorso era stata segnalata la grande fre-quenza della sclerosi renale maligna in detta popolazione nella città di Chicago,quale sequela della precoce comparsa dell’ipertensione arteriosa in questa razza(53). Le condizioni di disagio psicologico nella popolazione negra sono state se-gnalate da diversi AA., posto che i fattori di rischio psicosociali apparivano più ele-vati fra i negri rispetto ai bianchi (54). I quali fattori consistevano principalmentenel fatto che la parità di diritti sancita dalla costituzione americana non sempreaveva trovato nella pratica piena applicazione, tanto che, non essendo stati total-mente scomparsi i pregiudizi razziali, l’eguaglianza fra i cittadini non era stata suf-ficientemente raggiunta e ciò comportava un insufficiente inserimento dei negrinel tessuto sociale americano, con più elevata incidenza della povertà fra i negririspetto ai bianchi e con più elevata loro esposizione ad ambienti ricchi di stress,com’era comprovato dal loro modo di vivere in ambienti sopraffollati, dal nu-mero di delitti che i medesimi compivano, dagli insufficienti rapporti interperso-nali che erano capaci d’instaurare, nonché dalle differenze socio-culturali chepotevano ulteriormente ridurre le capacità di adattamento (54). Da ciò l’elevataincidenza dell’ipertensione arteriosa (55-67) e delle complicanze cardiovascolari,cerebrali e renali, per cui le malattie cardiovascolari costituivano in quella popo-lazione le più frequenti cause di morte.
La frequenza dell’infarto miocardico acuto nei negri, paragonata a quella deibianchi, appariva tuttavia controversa (68,69). Invero, considerata la maggiorefrequenza dell’ipertensione arteriosa nei negri, ci si sarebbe aspettata nei mede-simi una maggiore frequenza dell’infarto miocardico.
In effetti non era così. Roigg e coll. (70), basandosi su indagini statistiche con-dotte sulla mortalità in ospedale per infarto del miocardio, registrata nel periodo1978-1982, non hanno trovato differenze fra negri e bianchi in tutte le età. Tut-tavia gli studi angiografici dimostravano sorprendenti reperti nell’ambito di pa-zienti negri. Era stata di frequente constatata normalità delle arterie coronarie innegri sofferenti di angina pectoris, in paragone con pazienti bianchi sofferenti dellastessa sindrome. Studi di Simmons e coll. (71) hanno permesso di identificaredue gruppi nell’ambito dei pazienti negri predetti: in un gruppo i sintomi clinicierano sostenuti da grave stenosi coronarica, mentre nell’altro le coronarie appa-rivano indenni.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
170
In un’accurata revisione dei dati della letteratura condotta da Curry e Craw-ford-Green (60) circa l’incidenza di lesioni coronariche in soggetti affetti da sin-drome anginosa era emerso che la coronarografia dimostrava immagini dinormalità coronarica o la presenza di minime lesioni coronariche nel 45% deinegri maschi e nel 60% delle donne sofferenti di angina pectoris. Per cui detti AA.affermavano che il significato di queste discrepanze fra quadro clinico e arterio-grafico nei negri appariva enigmatico ed aperto alla discussione. In effetti è quivalida l’ipotesi di Curry e Crawford-Green (60), i quali sostengono che nei casisuddetti il danno sia a livello della microcircolazione pur essendo normali le ar-terie sottoepicardiche.
Questa ipotesi coincide con i risultati delle nostre indagini. Infatti, benchè i ca-pillari sanguigni endomiocardici non vengano coinvolti nei focolai di necrosi,come già ricordato, è certo che i medesimi successivamente siano esclusi dallacircolazione perchè compressi nelle strie fibrotiche da collasso, venendosi così aridurre l’apporto ematico nel corrispondente territorio miocardico. E’ intuitivoche nei casi nei quali strie fibrose interessano estesi settori del tessuto miocar-dico è da attendersi la comparsa della sintomatologia anginosa, clinicamente nondifferenziabile da quella più comune determinata dalla stenosi dei rami corona-rici principali. Le presenti indagini danno inoltre ragione della frequente inci-denza della cardiomiopatia dilatativa nella popolazione negra degli Stati Unitid’America, cui in precedenza accennato.
Al riguardo Williams (72) ha rilevato che nell’ambito delle tre forme di car-diomiopatia (dilatativa, ipertrofica e restrittiva) la forma dilatativa è quella più im-portante perché costituisce quasi il 90% del totale. Tale forma, secondo i datistatistici di Gillum (73), attinenti alla casistica esaminata fra il 1970 e il 1982, avevauna frequenza di circa tre volte superiore nei negri, sia maschi che femmine, ri-spetto a quella osservata nei bianchi. E’ intuitivo che in rapporto alla gradualescomparsa, ripetuta nel tempo, di gruppi di cellule miocardiche sotto l’azionedelle catecolamine liberate nel corso di ricorrenti episodi di stress, si avrà assot-tigliamento della parete miocardica ventricolare e settale sino al concretarsi dellacardiomiopatia dilatativa. Come già ripetutamente detto, questo fenomeno ri-corre nei portatori di feocromocitoma (2-8), laddove l’immissione in circolo di ca-tecolamine è pressochè continua, ed anche nei cocainomani (49,50), laddoveall’effetto cardiotossico delle catecolamine si aggiunge quello della cocaina, cheè della stessa natura.
Alcuni anni fa un soggetto, R.A. di anni 64 (Gazzetta del Sud 5.3.2003), con-dannato all’ergastolo per associaziazione mafiosa e per omicidio, è deceduto incarcere per una grave cardiopatia ischemica, per la quale era stato operato duevolte con l'applicazione di by-pass. Poiché detti interventi chirurgici non furono
171
Fisiopatologia dello stress
idonei a far regredire i sintomi della cardiopatia, appare ragionevole ritenere cheil soggetto fosse affetto da miocardiopatia dilatativa, connessa sia allo stress cro-nico della vita delinquenziale, sia allo stress da detenzione in carcere duro.
Bibliografia1. Raab W., Cardiotoxic biochemical effects of emotionalenvironmental elicited by experimen-tal coronary occlusion. In: Levi L., Society, Stress and Disease. Oxford UniversiyPress, London, New York, Toronto, vol. I, 1971.
2. Baker G., Zeller N.H., Weitzner S., Leach J.K., Pheochromocytoma without hyper-tension presenting as cardiomyopathy. Am. Heart J. 83, 688, 1972.
3. Donovan K.L., Fisher D.J., Unusual diagnosis of pheochromocytoma. Lancet 335,118, 1990.
4. Kline I.K., Myocardial alterations associated with pheochromocytoma. Am. J. Pathol.38, 539, 1961.
5. Sardesai S.H., Mourant A.L., Sivathandon Y., Farrow R., Gibbons D.O, Pheo-chromocytoma and catecholamines induced cardiomyopathy presenting as heart failure. Br.Heart J. 63, 234, 1990.
6. Sutton M., Sheps S.G., Lie J.I., Prevalence of clinically unsuspected pheochromocytoma:review of a 50 year autopsy series. Mayo Clinic Proc. 56, 354, 1981.
7. Von Vliet P.D., Burchell H.B., Titus J.L., Focal myocarditis associated with pheo- chro-mocytoma. N. Engl. J. Med. 274, 1102, 1966.
8. Aragona M., Aragona F., Feocromocitoma e cardiomiopatia da catecolamine. Patholo-gica, 84, 197, 1992.
9. Csapo Z., Dusek J,. Rona G., Early alterations of cardiac muscle cells in isoproterenol-induced necrosis. Arch. Pathol. 93, 356, 1972.
10. Haft J.I., Kranz P.D., Albert F.J., Fani K., Intravascular platelet aggregation in theheart induced by norepinephrine. Microscopic studies. Circulation 46, 698, 1972.
11. Raab W., Stark E., Macmillan W.H., Gigee W.R., Sympathogenic origin and antia-drenergic prevention of stress induced myocardial lesions. Am. J. Cardiol. 8, 203,1961.
12. Rosenblum J., Wohl A., Stein A.A., Studies in cardiac necrosis. I) Production of car-diac lesions with sympathomimetic amines. Toxicol. Appl. Pharmacol. 7, 1,1965.
13. Schenk E.M., Mos A.J., Cardiovascular effects of sustained norepinephrine infusions.Morphology. Circ. Res. 18, 605, 1966.
14. Ganguly P.K., Sherwood G.R., Cardiac sympathetic:basic aspects. In: Canguly P.K.,Catecholamines and Heart Disease. CRC Press Boca Raton (Florida), 1-13, 1991.
15. Reuter H., Calcium channel modulation by neurotrasmitter, enzymes and drugs. Na-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
172
ture 301, 569, 1983.16. Bean B.P., Two kinds of calcium channels in canine atrial cell: differences in kinetics, se-lectivity, and pharmacology. J. Gen. Physiol. 86, 1,1985.
17. Windisch M., Trihart H., Isoproterenol, norepinephrine and phosphodiesterase inhibi-tors are blockers of the depressed fast Na+ system in ventricular muscle fibres. J. Mol. Cell.Cardiol. 14, 431, 1982.
18. Hisatome I., Kiyosme T., Amanishi S., Arita M., Isoproterenol inhibits residualfast channel via stimulation of beta-adrenoceptors. J. Mol. Cell. Cardiol. 17, 657, 1985.
19. Schubert B., Van Dongen A.M.J., Kirsch G.K., Rrown A.M., Beta-Adrenergicinhibition of cardiac sodium channels by dual G-protein pathways. Science 245, 516,1989.
20. Ono K., Kiyosme T., Arita M., Isoproterenol, DBcAMP, and forskolin inhibit car-diac sodium current. Am. J. Physiol. (Cell Physiol. 25), C1131, 1989.
21. Schubert B. Van Dongen A.M.J., Kirsch G.K., Brown A.M., Inhibition of car-diac Na+ channels by isoproterenol. Am. J. Physiol. (Heart Circ.Physiol.) 258 (27),H977, 1990.
22. Tsien R.W., Giles W., Greegard P., Cyclic AMP mediates the effects of adrenalin oncardiac Purkinje fibres. Nature 240, 181, 1972.
23. Bennet P., McKinney L., Begendisch T., Kaas R.S., Adrenergic modulation of thedelayed rectifier potassium current in calf cardiac Purkinje fibres. Biophys. J. 49, 836,1986.
24. Harvey R.D., Hume J.R., Autonomic regulation of the delayed rectifier K+ current inmammalian heart involves G-proteins. Am. J. Physiol. (Heart Circ. Physiol.) 257(26), H818, 1989.
25. Nakayama T., Fozzart H.A., Adrenergic modulation of transient outward current inisolated canine Purkinje cells. Circ. Res. 62, 162, 1988.
26. Harvey R.D., Hume J.R., Autonomic regulation of a chloride current in heart. ScienceWashington DC 244, 983, 1989.
27. Harvey R.D., Hume J.R., Isoproterenol activates a chloride current, not transient out-ward current, in rabbit ventricular myocytes. Am. J. Physiol. (Cell Physiol.) 257 (26),C1177, 1989.
28. Eagan T.M., Noble D., Noble S.J., Powell T., Twist V.W., An isoprenaline acti-vated sodium-dependent inward current in ventricular myocytes. Nature 328 (6131), 634,1987.
29. Eagan T.M., Noble D., Noble S.J., Powel T., Twist V.W., Yamaoka K., On themechanism of isoprenaline- and forskolin-induced depolarization of single guinea-pig ven-tricular myocytes. J. Physiol. 400, 299, 1988.
30. Endoh M., Blinks J.R., Action of sympathomimetic amines on the Ca2+ transients andcontractions of rabbit myocardium: reciprocal changes in myofibrillar responsiveness to
173
Fisiopatologia dello stress
Ca2+ mediated through alpha- and beta –adrenoceptors. Circ. Res. 62, 247, 1988.31. Dhalla N.S., Pierce G.N., Panagia V., Singal P.K., Beamish R.E., Calcium mo-vements in relation the heart function. Basic Res. Cardiol. 77, 117, 1982.
32. Meij J.T.A., Panagia V., Catecholamine and heart disease: status of phospholipid si-gnaling pathways. In: Ganguly P.K., Catecholamine and Heart Disease. CRC Press,Roca Raton, Ann Arbor, Boston, London, 245, 1991.
33. Smith S.R., Kendall M.J., Metabolic response to beta2-stimulants. J.R. Coll. Physi-cians London 18, 190, 1984.
34. Bhagat B., Sullivan J.M., Fischer V.W., Nadel E.M., Dhalla N.S., Cyclic AMP ac-tivity and isoproterenol-induced myocardial injury in rats. Recent Adv. Stud. CardialStruct. Metab. 12, 465, 1978.
35. Opie L.H., Nathan D., Lubbe W.F., Biochemical aspects of arrythmogenis and ven-tricular fibrillation. Am. J. Cardiol. 43, 131,1979.
36. Fleckenstein A., Janke T., Doering H.J., Pachingoer O., Ca overload as a the de-terminant factor in the production of catecholamine-induced myocardial lesions. RecentAdv. Stud. Cardiol. Struct. Metab. 2, 455, 1973.
37. Takenaka F., Higuchi M., High energy phosphate contents of subendocardium and su-bepicardium in the rat treated with isoproterenol and some drugs. J. Mol. Cell. Cardiol.6, 123, 1974.
38. Dhalla N.S., Singal P.K., Dhillon K.S., Mitochondrial function and drug-inducedheart disease. In: Bristow M.R., Drug-Induced Heart Disease. Vol. V, North-HollandBiochemical Press, New York, 39, 1980.
39. Nirdlinger E.L., Bramante P.O., Subcellular myocardial ionic shifts and mytochondrialalterations in the course of isoproterenol-induced cardiomyopathy of the rat. J. Mol. Cell.Cardiol. 6,49,1974.
40. Beamish R.E., Singal P.K., Ganguly P.K., Stress, catecholamines, and heart disease.In: Ganguly P.K., Catecholamines and Heart Disease. CRC Press, Roca Randon,Ann Arbor, Boston, London, 231, 1991.
41. Yates J.C., Beamish R.E., Dhalla N.S., Ventricular dysfunction and necrosis produ-ced by adrenochrome metabolite of epinephrine: relation to pathogenesis of catecholamine car-diomyopathy. Am. Heart J. 102, 210, 1981.
42. Singal P.K., Dhillon D.S., Beamish R.E., Kapur N., Dhalla N.S., Myocardial celldamage and cardiovascular changes due to i.v. infusion of adrenochrome in rats. Bri. J.Exp. Path. 63, 167, 1982.
43. Ganguly P.K., Beamish R.E., Dhalla N.S., Catecholamine cardiotoxicity in pheo-chromocytoma. Am. Heart J. 117, 1399, 1989.
44. Aragona F., La miocitolisi coagulativa ed i suoi esisti nelle vittime di omicidio. Riflessionisul relativo significato psicologico. Pathologica 83, 259, 1991.
45. Bessis M., Cellules du Sang Normal et Pathologique. Masson, Paris, 1972.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
174
46. Wittstein I.S., Thienemam D.R., Lima J.A.C., Baufghman K.L., Schulman S.P.,Gerstenblith G., Wu K.C., Rade J.J., Bivalacqua T.J., Champion H.C., Neuro-humoral features of myocardial stunning due to sudden emotional stress. New Engl. J.Med. 352, 539-548, 2005.
47. Raum W., Laks M., Garner D., Swerdloff R., Beta adrenergic receptor and cyclicAMP alterations in the canine ventricular septum during long-term norepinephrine infusion:implications for hypertrophic cardiomyopathy. Circulation 68, 693, 1983.
48. Fromm E.: Avere o Essere?Mondadori, Milano, 1977.49. Karch S.B., Billingham M.E., The pathology and etiology of cocaine-induced heart di-sease. Arch. Pathol. Lab. Med. 112, 225, 1988.
50. Weiner R.S., Lockart J.T., Schwartz R.G., Dilated cardiomyopathy and cocaine abuse.Report of two cases. Am. J. Med. 81, 699, 1986.
51. Levy M.N., Blattberg B., The influence of cocaine and desipramine on the cardiac re-sponse to exogenous and endogenous norepinephrine. Eur. J. Pharmacol. 48, 37, 1978.
52. Starke K., Regulation of noradrenaline release by presynaptic receptor systems. Rev. Phy-siol. Biochem. Pharmacol. 77, 1, 1977.
53. Jaffe, Hypertonie und maligne Nephrosklerose bei Negern. Centr. Allg. Path. 55, 6,1932.
54. Lewis C.E., Raczynski J.M., Oberman A., Cutter G.R., Risk factors and naturalhistory of coronary heart disease in blacks. In: Saunders E., Brest A.N., Cardiovascu-lar Diseases in Blacks. Davis Company, Philadelphia, 29, 1991.
55. Gillum R.F., Pathophysiology of hypertension in blacks and whites. Hypertension 1,484, 1979.
56. Gillum R.F., Coronary heart disease in black population. I) Mortality and morbidity.Am. Heart J. 104, 839, 1982.
57. Gillum R.F., Cardiovascular diseases in the United States: An Epidemiologic Oberview.In: Saunders E., Brest A.N., Cardiovascular Diseases in Blacks. Davi Company,Philadelphia 1991, p.3.
58. Lacroix A., Haynes S.G., Savage D.D. et al., Rose questionnaire angina among Uni-ted States black, white and Mexican-American women and men. Am. J. Epidemiol.129, 669, 1989 (cit. da Curry e Crawford-Green: 57).
59. Curry C.L., Crawford-Green C., Coronary artery disease in blacks: past perspectivesand current overview. In: Saunders E., Brest A.N., Cardiovascular Diseases in Blacks.Davies Company, Philadeplphia, 197, 1991.
60. Kasl S.V., Social and psychologic factors in the etiology of coronary heart disease in blackpopulations: an exploration of research needs. Am. Heart J. 108, 660, 1984.
61. Kasl S.V., Harburg E., Mental health and the urban environment: some doubts and se-cond thoughts. J. Health Soc. Behav. 16, 268, 1975.
62. Katz P., Taylor D., Eliminating Racism. Plenum Press, New York, 1988.
175
Fisiopatologia dello stress
63. Farley R.: Blacks and Whites: Narrowing in the Gap? Harward University Press,Cambridge, 1984.
64. Taylor R.J., Jackson J.S., Quick A.D., The frequency of social support among BlackAmericans: Preliminary findings from the National Survey of Black Americans. UrbanRes. Rev. 8, 1, 1982.
65. Strogatz D.S., James S.A., Social support and hypertension among blacks and whitesin a rural Southern community. Am. J. Epidemiol. 126, 949, 1982.
66. Strogatz D.S., Use of medical care for chest pain: differences between blacks and white.Am. J. Public Health 80, 290, 1990.
67. Noorman P.G., Hames C.G., Tyroler H.A., Socioeconomic status and morbidity inhypertensive blacks. In: Saunders E., Brest A.N., Cardiovascular Diseases in Blacks.Davis Company, Philadelphia, 179, 1991.
68. Cooper R.S.,Ghali J.K., Coronary heart disease: black-white differences. In: SaundersE., Brest A.N., Cardiovascular Diseases in Blacks. Davis Company, Philadelphia,205, 1991.
69. Keil J.E., Tyroler H.A., Gazes P.C., Predictors of coronary heart disease in Blacks.In: Saunders E., Brest A.N., Cardiovascular Diseases in Blacks. Davis Company,Philadelphia, 227, 1991.
70. Roig E., Castaner A., Simmons B. et al., In-hospital mortality rates from acute myo-cardial infarction by race in US. Hospitals: Findings from the National Hospital Di-scharge Surwey. Circulation 76, 208, 1987.
71. Simmons B.E., Castaner A., Campo A. et al., Coronary artery disease in blacks forlower socioeconomic status: angiographic findings from to Cook County Hospital Heart Di-sease Registry. Am. Heart J. 116, 90, 1988.
72. Williams R.A., Sudden cardiac death in blacks, including black athletes. In: SaundersE., Brest A.N., Cardiovascular Diseases in Blacks. Davis Company, Philadelphia,297, 1991.
73. Gillum R.F., Idiopathic cardiomyopathy in the United States 1970-1982. Am. HeartJ. 11, 752, 1986.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
176
Capitolo VII
Le lesioni da stress di altri organi
1. Fegato, reniNel fegato, oltre alle modificazioni del glicogeno, di cui s’è detto nella parte
prima, può verificarsi, specie nei soggetti a lungo ospedalizzati e quando esista unarelativa insufficienza corticosurrenalica un’infiltrazione adiposa di vario grado.Le gocciole grassose che infiltrano gli epatociti possono essere piccole e nume-rose, talora voluminose fino ad ocupare tutto il corpo cellulare, che appare ri-gonfio e deformato, con nucleo spostato perifericamente. Detta infiltrazione puòcolpire pochi gruppi di cellule al centro del lobulo, ma può essere anche moltoestesa, tanto da essere apprezzata macroscopicamente sotto forma di aree gialla-stre. E’ da ritenere verosimile l’ipotesi che l’organo in questi casi non riesca asmaltire tutti i lipidi che per effetto dello stress gli vengono convogliati dai depositiadiposi, in quanto mobilizzati dalle catecolamine, dai glicocorticoidi e dallo stessoACTH.
Steatosi molto marcata è di comune riscontro dell’assideramento, come co-stantemente avviene nell’assideramento sperimentale. Il fegato di tali animali ap-pare infatti aumentato di volume ed estesamente infiltrato da gocciole adipose(1-3). Una marcatissima steatosi, che non risparmiava alcuna cellula, è stata danoi osservata nel fegato di un bambino di 8 anni morto lentamente per assidera-mento in un bosco innevato ad un’altitudine di 1.400 metri, nonché in trauma-tizzati immobilizzati a letto per lunghi periodi (1).
Nei reni possono verificarsi negli stress cronici ricorrenti con ipertensione ar-teriosa note di sclerosi parcellare o totale di glomeruli nonché delle arteriole.
2. Esofago, stomaco, intestinoAccanto alle alterazioni gastro-intestinali nel corso della malattia da ustione
(ulcera di Curling), note sin dal 1800, e che oggi vengono annoverate nell’ambitodelle manifestazioni organiche da stress, si è notato in questi ultimi quarant’anniun significativo incremento della malattia ulcerosa, peraltro diradatosi negli annipiù recenti (4). Il processo è stato messo in relazione alle modificazioni metabo-liche causate dagli stati di stress, che le condizioni di vita odierne producono nellagrande maggioranza degli individui. Ciò avvera il detto che lo stomaco rispec-chia fedelmente gli stati emotivi, sì che Boyd (5) affermava: “se poi consideriamocome esso sia continuamente sottoposto ad un bombardamento di stimoli ner-vosi, secretori, ormonali, senza contare i fattori esogeni irritanti di ogni specie eforma, ci si dovrebbe meravigliare che esiste ancora qualcuno con la digestione
177
normale”. Lo stesso Boyd sottolineava la più elevata incidenza dell’ulcera ga-strodudeonale nelle professioni che maggiormente espongono ad elevate ten-sioni emotive. Egli scriveva: ”Le preoccupazioni e la tensione nervosa siaccompagnano ad iperacidità e questo forse spiega perché le ulcere siano fre-quenti fra i chirurghi, mentre mancano fra gli anatomopatologi. Io infatti”- con-tinua Boyd - “ho conosciuto un solo anatomopatologo affetto da ulcera pepticae si trattava di un rettore”. E più avanti ancora: “Ad esempio fra gli chefs degli al-berghi vi è una percentuale insolitamente elevata di sofferenti di ulcera peptica acausa della vita piena di tensione nervosa”. Nell’indagine statistica condotta su4.217 autopsie consecutive Dalgaard (6) osservò 208 ulcerazioni peptiche acute,comprendenti la cosiddetta esofagomalacia, la gastromalacia, le erosioni emorragiche acutee la vera ulcera acuta. In 19 di questi stessi casi esistevano anche ulcerazioni croni-che. In altri 177 casi esistevano solo ulcerazioni croniche e loro sequele. Dei sog-getti con ulcerazioni acute, il 76% aveva subito lesioni encefaliche e l’altro 24%,tranne qualche eccezione, aveva sofferto di sindromi decorrenti con ipossia ouremia, o aveva subito stress gravi e acuti nel periodo immediatamente prece-dente alla morte. L’A. sottolineava il fatto che mentre è possibile intravedere unanetta correlazione fra ulcere acute, lesioni cerebrali e stress gravi, analoga corre-lazione non è apprezzabile per le ulcere peptiche croniche. Konrad e Wedeli (7)hanno riscontrato un’incidenza dell’ulcera da stress nel 2.8% degli operati sulcuore e sui vasi; Kricke (8) in materiale cadaverico ha osservato il reperto nel12% dei soggetti sottoposti ad interventi di chirurgia generale; Fletcher e Harkins(9) hanno visto un’incidenza dell’ulcera acuta nell’1% dei casi su 4.000 interventichirurgici, e all’incirca simile frequenza (0.7%) hanno riscontrato Jenny e coll.(10) in analogo materiale chirurgico. In un’indagine condotta da Brihayae e coll.(11) su 91 casi di complicanze gastro-intestinali da stress chirurgico, le sedi dellelesioni erano le seguenti: 3 volte nell’esofago, 42 volte nello stomaco, 31 volte nelduodeno, 9 volte nello stomaco e nel duodeno, 2 volte nel digiuno, 4 volte nelcolon. Le lesioni erano molteplici 26 volte nello stomaco, 11 volte nel duodeno,2 volte nel digiuno, 4 volte nel colon. Gli stessi Autori in 245 ustionati hanno ri-levato le seguenti localizzazioni ulcerose: 9 volte nell’esofago (3.7%), 98 voltenello stomaco (40%), 135 volte nel duodeno (55,1%), 3 volte nell’intestino tenue(1.2%).
Pertanto, dal punto di vista statistico, le ulcerazioni interessano più frequen-temente lo stomaco e il duodeno, con lieve prevalenza per il duodeno, mentreassai più di rado sono localizzate in altri distretti del canale digerente, con fre-quenza per lo più simile (esofago, digiuno, colon.) Le ulcerazioni possono essereisolate o multiple. Questi dati coincidono pressochè con le analoghe lesioni ri-scontrabili nella malattia da ustione.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
178
Numerosissime sono le indagini sperimentali condotte sull’argomento, con lemetodiche più varie. Un ottimo modello d’ulcera sperimentale da stress è quelloottenibile mediante costrizione forzata dell’animale (Brady e coll., 12; Cucinotta,13; Luher e coll., 14; Klein e coll., 15).
Dal punto di vista anatomo-patologico macroscopico si possono avere ero-sioni superficiali, uniche o multiple, le quali appaiono come depressioni roton-deggianti od ovalari, per lo più con fondo emorragico e perciò di colorito nerastroper le modificazioni indotte dai succhi digestivi sul pigmento ematico, oppure ul-cere vere e proprie. Queste ultime appaiono spesso come escavazioni crateri-formi, più o meno profonde, con margini duri, rilevati ed arrotondati. Hannospiccata tenden- za alle emorragie e alla perforazione, tanto che ad esse conse-guono spesso cospicue ematemesi e non di rado peritoniti acute, o aderenze conorgani viciniori (pancreas, colon trasverso). Si possono anche realizzare fistolegastro-coliche e duodeno-coliche. Le ulcerazioni multiple del colon, che soglionointeressare cieco e colon ascendente, possono presentarsi come noduli rilevati daun grano di miglio ad una lenticchia ulcerati nella sommità.
Le numerose indagini sin qui fatte su queste sindromi dimostrano che le me-desime compaiono in media a distanza di 4-20 giorni dall’evento stressante. Esi-ste perciò un vero e proprio intervallo libero che contribuisce a distinguerenettamente tali lesioni da quelle da traumatismi diretti o indiretti sull’addome, lequali di solito s’instaurano pressochè contestualmente al traumatismo (ad ecce-zione, naturalmente, delle forme che si attuano in due tempi: rotture parenchimali,perforazioni di visceri cavi).
Nella nostra casistica, nell’ambito del gruppo dei traumatizzati cranici figu-rano quattro casi con complicazioni ulcerose gastro-intestinali: 1) uomo di 35 anni deceduto dopo 7 giorni da trauma cranico e vertebro-midol-
lare con paraplegia flaccida e complicazioni broncopolmonitiche: presentavanumerose erosioni della mucosa, con fondo nerastro, nell’antro pilorico (Fig.38);
2) uomo di anni 76, deceduto dopo 22 giorni da trauma cranico e toracico ri-portato in incidente stradale, che presentava nel duodeno, in prossimità del-l’anello pilorico, ulcerazione a margini rilevati con fondo emorragico e dicolorito nerastro;
3) donna di anni 81, deceduta, in stato di coma, dopo 12 giorni da trauma cranicoriportato in incidente stradale, e presentante nel duodeno un’ulcera perforata;
4) donna di anni 40, deceduta dopo 10 giorni da trauma cranico e da frattura delginocchio sinistro, riportati in incidente stradale, in conseguenza di copiosasindrome emorragica da ulcerazioni multiple coliche: del cieco e del colon
179
Fisiopatologia dello stress
ascendente. Per quanto attiene alla patogenesi, si è visto in clinica che ulcerazioni gastro-
duodenali acute, non di rado seguite da emorragie e da perforazioni, possonocolpire soggetti sottoposti a prolungato trattamento con glicocorticoidi o conACTH. Per cui si è ritenuto che nella patogenesi di dette ulcerazioni il ruolo piùimportante fosse esplicato dai glicocorticoidi dismessi dalla corteccia surrenaledurante lo stress, attraverso un’inibizione della secrezione di muco e un’altera-zione della sua composizione chimica: sì che verrebbe a far difetto la funzioneprotettiva del muco stesso nei confronti dell’azione potenzialmente autodigestivadelle secrezioni peptiche e acide. Tuttavia la morfologia delle formazioni ulce-rose consente di ipotizzare che qui entri in gioco pure l’azione vasocostrittivadelle catecolamine, come risulta dall’aspetto istologico di dette lesioni e come so-stenuto nella già citata indagine sperimentale di Klein e coll. (15) sulla base di in-dagini sperimentali. Detti AA. hanno visto che in ratti sottoposti a stress le lesionigastriche si realizzavano attraverso tre processi: un primo caratterizzato da turbefunzionali circolatorie negli strati profondi della parete gastrica, consistenti spe-cialmente in costrizione delle arteriole: un secondo processo caratterizzato da al-terazioni trofiche della mucosa consecutive all’ipossia e alla stasi nei capillari dellamucosa stessa; un terzo processo caratterizzato da moderata quantità di succogastrico, con elevata concentrazione di acido cloridrico. Secondo i suddetti AA.,l’azione del succo gastrico sulla mucosa così alterata sarebbe facilitata dalla con-trazione della parete gastrica che consentirebbe un più intimo contatto del succogastrico ristagnante con la mucosa stessa. Le erosioni ed ulcerazioni della mu-cosa gastrica compaiono dopo circa un’ora dall’acme delle secrezione acida. Tut-tavia, secondo quanto da noi visto nell’indagine istologica dei nostri casi, cheesporremo tra breve, queste ipotesi sono valide per quanto attiene al ruolo esple-tato dalle turbe circolatorie, mentre un ruolo del tutto secondario dev’essere at-tribuito alla secrezione acida gastrica, la quale ultima potrebbe essere chiamata incausa per le lesioni in sede gastrica e non già per quanto riguarda le lesioni dastress ubicate in altri distretti dell’apparato digerente.
Secondo quanto da noi osservato, le ulcerazioni gastrointestinali constano diperdite di sostanza che si affondano nella sottomucosa, che appare rigonfia per lapresenza di trombosi arteriose e venose associate a spiccato rigonfiamento mucoide, necrosi fi-brinoide e a stravasi emorragici. Mancano spesso segni di movimenti cellulari ripara-tivi.
Nelle semplici erosioni si rilevano solo perdite di sostanza circoscritte alla mu-cosa associati a spandimenti emorragici; possono coesistere nella sottomucosanote di rigonfiamento mucoide con trombosi fibrinose. Nel caso con interessa-mento del colon le ulcerazioni multiple interessavano la sommità di micronoduli
Marcello Aragona, Francesco Aragona
180
costituiti da sparsi ematomi intramurali affioranti in superficie, ubicati nel conte-sto della mucosa e talvolta estesi fino alla muscolaris mucosae. Coesistevano oc-clusioni trombotiche dei vasi.
Queste ulcerazioni coliche portano a ritenere, come già premesso, che il ruolodei succhi digestivi nella patogenesi della malattia ulcerosa da stress non sia pri-mario, prevalendo, invece, l’ischemia connessa alle turbe circolatorie locali, so-prattutto fondate sulle formazioni trombotiche favorite dalle catecolamine, per laben nota loro capacità di incrementare e di accelerare la coagulazione sanguigna.
3. Ghiandole genitaliLe ghiandole genitali, ed in particolare i testicoli, sono assai sensibili agli stress.
Testicoli. Varie metodiche sperimentali hanno dimostrato che gli stress protratticonducono ad arresto maturativo della linea seminale ed a comparsa di cellulegiganti plurinucleate nei tubuli seminiferi (16,17). Quadri di grave atrofia testico-lare sono stati inoltre osservati in soggetti sopravvissuti ai campi di concentra-mento durante l’ultimo conflitto mondiale.
L’esposizione cronica al rumore produce analoghi effetti (18,19) e reperti si-mili sono stati riscontrati in suicidi (20,21). Costante il danno testicolare da noiosservato nei suicidi, nelle vittime di omicidio e nei traumatizzati cranici a lungodegenti.
Il quadro morfologico testicolare osservato nella suddetta casistica costitui-sce, secondo Selye (22), “effetto assolutamente caratteristico dell’esposizione allostress sistemico”. Egli aveva osservato che sono particolarmente sensibili le cel-lule sessuali mature, ma quando l’esposizione allo stress è prolungata tutti gli ele-menti dei tubuli seminiferi, ad eccezione delle cellule del Sertoli e degli elementiseminali più immaturi (spermatogoni e spermatociti di prim’ordine), vengonocoinvolti e nel lume tubulare possono comparire spermatociti giganti plurinu-cleati (Fig. 39).
Sul vivente sono stati osservati effetti depressivi sulla funzione sessuale (di-minuzione della libido e della potenza) di lavoratori ed altri soggetti esposti quo-tidianamente a stress di vario genere (23).
Ovaie. Sono note turbe mestruali come conseguenza di stress, le quali, secondole nostre indagini su suicide, sono da riferire nella comparsa nelle ovaie di cisti acellule tecali secernenti estrogeni.
Nel materiale autoptico di Fazekas e Jakobovits (24), composto di 300 sui-cide, di cui 222 tra i 10 e i 50 anni e le altre 78 fra i 50 e i 90 anni, esistevano nelleovaie di 37 casi (15 dei quali in fase mestruale) piccole e grosse cisti.
181
Fisiopatologia dello stress
Tali effetti sulle ghiandole genitali sono da riferire alla circostanza che il CRHinibisce la liberazione delle gonadotropine ipofisarie (25, 26, 27).
Le suddette alterazioni ovariche rappresentano verosimilmente la causa prin-cipale dell’invecchiamento precoce rilevato negli Stati Uniti d’America nelle donnesottoposte a stress cronici.
Bibliografia1. Aragona F., Le Sindrome Decorrenti con Anossia. SEP. Pavia, 1960.2. Foglia V.G., Selye H., Morphological changes produced by alarm reaction in the giunea-pig. Can. Med. Assoc. J. 39, 188, 1938.
3. Levin L., Physical stress and liver content of the fasted mouse. Feder. Proc. 8, 218,1949.
4. Di Paolo M., Toni C., Stamile A., De Simone L., Su sei casi mortali di ulcera dastress. Questioni di responabilità professionale. Riv. Ital. Med. Leg. 25, 1065-1087,2003.
5. Boyd W., Le Basi Anatomopatologiche della Medicina Interna. Vallardi, Milano, 1966.6. Dalgaard J.B., Agonal peptic ulceration in hypoxia, uremia and stress. Congr. Am. Acc.
Legal Med. Chicago-Illinois, 25-28 febbraio 1959. In: Acta Medicina Legaliset Socialis 12, 70, 1959.
7. Konrad R.M., Wedeli J., Das akute postoperative Magen-Duodenalgeschwur mit beson-derer Beruchsichtigung des Ulcus postoperativum nach kardiovaskularen Eingriffen. Dtsch.Med. Wschr. 89, 616, 1964.
8. Kricke E., Die akuten Erosionen und Ulcerationen des Magens als postoperative und po-sttraumatische Komplikation Langenbecks. Arch. Klin. Chir. 304, 685, 1963.
9. Fletcher G.D., Harkins H.N., Acute peptic ulcer as a complication of major surgery,stress or trauma. Surgery 36, 212, 1954.
10. Jenny M., Trabert E., Bircher J.B., Akovbiantz A., Das akute postoperative ga-stroduodenale Stress-ulcus. Schweiz. Med. Wschr. 98, 1507, 1968.
11. Brihaye J., Kiekens K., Van der Voort G., De Roy G., Desneux J.I., SnoeckJ.M., Les ulcération digestives dans les états de stress. Acta Chir. Belg. Suppl. 1, 7,1969.
12. Brady J.V., Porter R,W., Conrad D.G., Mason J.W., Avoidance bahavior and the de-velopment of gastroduodenal ulcers. J. Exp. Anal. Behav 1, 69, 1958.
13. Cucinotta U., Sulle lesioni gastriche sperimentali da costrizione. Atti Accademia Pe-loritana dei Pericolanti. Vol. 59,1964; Vol. 59, 1965; Vol. 60, 1966; Vol. 60,1967.
14. Luther I.G., Heistad G.S., Sparber S.B., Influence of pregnancy on gastric ulcer in-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
182
duced by restraint. Psychosom. Med. 31, 45, 1969.15. Klein H.J., Gheorghiu Th., Hubner G., Eder M., Zur Pathogenese stress-bedingterMagenulcera. Virch. Arch. 352, 195-208, 1971.
16. Dina M.A., Alberti R., Mariuzzi G.M., Alterazioni dell’epitelio seminifero testicolareconseguenti a stress. Endocrinologia e Scienza della Costituzione 23, 338, 1954.
17. Jankälä E.O., Näätänen E.K., Effect of intense mental train on the morphological pic-ture of the testis. Ann. Med. Exp. Fenn. 33, 231, 1955.
18. Selye H., Testbock of Endocrinology. Acta Endocrinologica, Montreal, 1949.19. Sackler A.M., Weltman A.S., Bradahaw M., Jurtshuk P.Jr., Endocrine changes dueto auditory stress. Acta Endocrinol. 31, 405, 1959.
20. Fazzari C., Il testicolo nei suicidi e nei deceduti per trauma accidentale. Minerva Medi-colegale 76, n.4, 1956 (estratto).
21. Aragona F., La Personalità Suicida (Aspetti somatici). Il Pensiero Scientifico, Roma,1971.
22. Selye H., The physiology and pathology of exposure to stress. Acta Inc. Med. Publ.,Montreal, 1950.
23. Pancheri P., Stress Emozioni Malattia. Mondadori, Milano, 1980.24. Fazekas I.G., Iakobovits A., Zustand der weiblichen Geschlechtsorgane und Selbe-stmord. Zentr. Gynaek. 78, 420, 1956.
25. Ono N., Lumpkin M.D., Samson W.K., McDonald J.K., McCann S.M., Intra-hypothalamic action of corticotropin-releasing factor (CRF) to inhibit growth hormone andLH release in rat. Life Sci. 35, 1117, 1984.
26. Rivier C.B., Vale W.W., Influence of corticotropin-releasing factor on reproduction fun-ctions in the rat. Endocrinology 114, 914, 1984.
27. Nikolarakis K.E., Almeida O.F.X., Herz A., Corticotropin-releasing factor (CRF)inhibits gonadotropin-releasing hormone (GnRH) release from superfused rat hypothalamusin vitro. Brain Res. 377, 388, 1986.
183
Fisiopatologia dello stress
Capitolo VIII
La morte come conseguenza di stress acuti e cronici
La morte da stress acuti è di solito a carattere improvviso, cioè inatteso. Si in-tende per morte improvvisa o inattesa il tipo di morte caratterizzato dall’assenza diogni azione violenta esteriore, dalla rapidità del decesso, dal fatto che colpiscepersone in apparente buona salute o uno stato di malattia che non minacci la vitadi un pericolo attuale. Tuttavia, sono comprese in tale tipo di morte pure quelleforme conseguenti ad influenze esteriori di non rilevante entità e che solitamentenon risultano idonee a cagionare la morte e cioè: traumi psichici, sforzi corporei,brusche alterazioni della temperatura, per cui vi sono comprese anche le emo-zioni, ed in genere gli stress.
La morte da stress acuti si compendia sostanzialmente in due forme: quellacardiaca e quella cerebrale. La morte cardiaca, a sua volta, è distinguibile in una formaacuta o improvvisa, ed in una forma cronica a lenta evoluzione contrassegnata daisintomi tipici dell’insufficienza miocardica progressiva.
1. La morte improvvisa cardiaca da stressLa morte improvvisa da stress d’origine cardiaca è da mettere in relazione a
due meccanismi patogenetici: a) quello connesso al danno miocardico determinato dalle catecolamine e dagli or-
moni corticosurrenalici di cui s’è detto nel capitolo VI di questa parte; b) quello connesso a preesistenze patologiche coronariche clinicamente silenti e
rese manifeste dallo stress acuto.Esempi della prima forma sono i casi di morte improvvisa osservati nel
gruppo del Centro Spaziale Kennedy da Eliot e coll. (1). Detti AA. osservaronoche in quell’ambiente, carico di tensione emotiva per le enormi responsabilitàconnesse al lavoro dei progetti spaziali, l’incidenza degli incidenti cardiovascolariimprovvisi e mortali era più elevata di quasi il 50% rispetto a quelli osservati neigruppi di controllo ed era caratterizzata da quadri conclamati di miocitolisi coa-gulativa. Detti accidenti ricorrevano in individui relativamente giovani, nono-stante occupati a terra.
Merita qui un cenno anche la morte improvvisa da superlavoro particolarmente te-stimoniata da indagini condotte in Giappone sin dal 1978, qui definita karoshi.Masaya Yamauchi (2) ha osservato che il karoshi non colpisce soltanto il mondooperaio, ma anche gli uomi d’affari giapponesi per il loro eccesso di lavoro, e ri-corda che il dr. Tesunojo Uehata, del National Institute of Public Health, affer-mava che benchè casi di morte improvvisa fossero stati segnalati anche fra uomi
185
di affari occidentali, le vittime del karoshi in Giappone si distinguono per la granquantità di ore lavorative. Ha osservato ancora che secondo un’indagine su stresse salute condotta su larga scala dal gruppo di studio del dr. Uehata nel 1990, circail 45% degli uomini e delle donne d’affari lavorava più di 50 ore alla settimana epiù d’un quarto effettuava anche più di 30 ore di straordinario ogni mese. Comeesempio riporta il caso di un soggetto addetto agli imballagi in un’indudtria ali-mentare nella prefettura di Gihu, il quale aveva effettuati due turni di lavoro gior-nalieri per 4 anni e mezzo prima di morire per infarto del miocardio nell’aprile del1988: egli cioè lavorava 14-16 ore al giorno con lo straordinario, e spesso portavaa casa lavoro dall’ufficio durante i giorni di festa ed anche durante la settimana.A quel tempo in Giappone non esistevano provvidenze assicurative statali percui la vedova dovette dimostrare non senza difficoltà il rapporto causale fra lavoroe decesso, anche per il contrasto dei datori di lavoro che si erano rifiutati di rico-noscere il diritto al dovuto indennizzo. Successivamente ulteriori indagini con-dotte in Giappone su lavoratori con oltre 15 anni di anzianità, con medialavorativa fino a 14-16 ore giornaliere, hanno calcolato che annualmente almeno3.000 giapponesi erano venuti a morte improvvisa per il superlavoro. SecondoKiyoyasu Arikaw (3), esperto in medicina del lavoro, la morte improvvisa da su-perlavoro, al tempo in cui egli svolse la sua indagine, era divenuta assai più fre-quente rispetto al passato, tanto che ne osservò solo 10 casi nel 1963, mentre icasi osservati nel 1987 furono oltre 150.
Peraltro, si deve tener conto del fatto che esistono qualità di superlavoro lequali non soltanto non sono nocive alla salute, ma sono invece altamente gratifi-canti e perciò utili al benessere psichico: basti pensare al lavoro del ricercatore incampo scientifico, a quello dello scrittore, del filosofo, del poeta, del musicista,dell’artista, ecc., laddove l’interesse perspicuo nell’esecuzione d’un programmadi ricerca, nella creazione d’un’opera d’arte o di una composizione poetica o mu-sicale, e così via, fondandosi su doti personali improntate ad entusiasmo, quasimai finalizzato all’acquisizione di beni materiali, suole suscitare nei suddetti indi-vidui condizioni di intima soddisfazione che consentono loro di lavorare per granparte della giornata senza dispendio fisico e mentale: la storia del pensiero è riccadi esempi del genere. Per essere generatore di malattia qualsiasi attività fisica,anche limitata nel tempo, ed assumere valore patogeno deve coinvolgere il be-nessere psichico: stati di allerta per difesa personale o altrui o condizioni d’isola-mento ambientale che rendono impossibile qualsiasi richiesta di aiuto, ecc. In uncaso da noi osservato, e riportato alla lettera d) del n.3 della casistica elencata nelcapitolo IV.1 della parte prima, la morte conseguì ad un episodio accidentale emo-tivamente altamente frustrante che gli precluse qualsiasi possibilità di soccorso. Sitrattava di un giovane di 26 anni venuto a morte in seguito ad una caduta acci-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
186
dentale durante una battuta di caccia in grave stress psicofisico per l’incapacità dicompiere qualsiasi movimento per i traumi subiti e di chiedere aiuto. Infatti, nellacaduta aveva riportato ferite alla testa, peraltro limitate al cuoio capelluto, ed al to-race con fratture costali e pneumotorace traumatico destro. E’ stato soccorsodopo alcune ore già morente ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Glieffetti dello stress acuto erano di tutta evidenza a livello cardiaco (miocitolisi coa-gulattiva) e delle surrenali, specie della midollare (Fig. 3, 40, 41).
Nei casi nei quali fenomeni di miocitolisi coagulativa interessano estesamentele due branche del fascio di conduzione atrioventricolare, o il fascio principale, lamorte improvvisa è conseguenza di un blocco cardiaco completo. A questo ri-guardo occorre ricordare che sulla base di studi anatomopatologici sistematici (4)il blocco cardiaco completo si realizza più di frequente per gravi lesioni distrut-tive di entrambe le branche del fascio di His.
Nella seconda forma, di gran lunga più comune rispetto a quella sopra pro-spettata, l’evento mortale si realizza per la preesistenza nelle coronarie di pro-cessi patologici di natura aterosclerotica: si calcola, infatti, che il 75% delle mortiimprovvise sia dovuto a coronaropatie (5). Detti processi patologici consistonoin placche ateromasiche complicate da fenomeni di capillarizzazione intimale.
A questo proposito Cavallero (6) fa presente che la capillarizzazione intimalecostituisce reperto di comune riscontro negli ateromi e nel processo di sostitu-zione connettivale delle zone necrotiche. Qui si ha, infatti, comparsa di vasi e dilacune sanguigne molto sottili rivestite da endotelio, i quali possono andare in-contro a rottura spontanea dando luogo ad ematomi intramurali e quindi a nuoviprocessi di sclerosi connettivale cicatriziale con la comparsa di accumuli di side-rociti. Secondo Ascenzi e Mottura (7), i capillari anzidetti provengono o dalla pa-rete esterna (dall’avventizia, o dai vasa vasorum nelle arterie che ne sono fornite)o dalla parete interna mediante gemmazione angioblastica dell’endotelio intimale.Anche Gould (8), con riferimento specifico alle coronarie, ritiene che la neofor-mazione capillare possa instaurarsi nel corso del processo di organizzazione dellanecrosi ateromasica, ma, secondo Peterson (9) può essere anche rinvenuta nelleplacche fibrotiche più precoci. I reperti suddetti sono stati confermati da Willis(10) nei vasi poplitei e femorali e, secondo Boyd (11), si riscontrano comune-mente nelle lesioni ateromatose delle arterie polmonari, cerebrali, carotidee, re-nali e femorali. Per Leary (12) a partire dagli anni 40 in circa il 50% dei casi leplacche ateromasiche vengono invase da capillari sanguigni.
Secondo Davies e Thomas (13), le modificazioni acute all’interno delle plac-che ateromasiche, che comprendono l’edema delle stesse e l’ematoma intramu-rale, incidono con una frequenza varia che in media può essere valutata attornoal 40-50%. In uno studio su 100 casi mortali di occlusione coronarica acuta ate-
187
Fisiopatologia dello stress
rosclerotica, Horn e Finkelstein (14) osservarono che l’ostruzione era dovuta adematoma intramurale nel 62.5% dei casi ed a formazione di trombi su placca ate-romasica nell’altro 37.5% dei casi.
D’altra parte studi statistici su più ampia casistica hanno documentato chenella morte improvvisa da coronaropatia la trombosi coronarica figura in un nu-mero esiguo di casi. Helpern e Rabson (15) in una serie di 2030 casi di morte im-provvisa hanno accertato l’incidenza di una coronaropatia in 617 casi e che solonel 27% di questi casi era presente una trombosi coronarica. Secondo Pruitt (16),la trombosi coronarica occlusiva è osservabile nel 25% dei casi. Myerburg e Davis(17) in uno studio autoptico su 1348 casi di morte improvvisa su coronaropaticial di sotto dei 66 anni hanno osservato che l’evento era stato in relazione ad emor-ragie in placche aterosclerotiche, a trombosi recenti, a grave stenosi su base ate-rosclerotica.
Per quanto attiene al valore patogenetico dell’emorragia intramurale nel mec-canismo della morte improvvisa coronarica Friedberg (18), molto opportuna-mente, osserva, sulla base dei dati di Wartman (19), che quando il processoaterosclerotico produce un ispessimento notevole, tale da lasciare pervio solo unpiccolissimo lume, la rottura di un capillare intimale può portare alla formazionedi un ematoma che può essere sufficiente, con l’aumentato spessore della placca,ad occludere totalmente il già ristretto lume del vaso senza che avvenga una trom-bosi. Analoghe le conclusioni di Saphir (20), il quale afferma che l’emorragia su-bintimale in una zona circondata da una placca aterosclerotica fibroialina può dasola dar luogo all’occlusione coronarica.
L’emorragia nel contesto di placche aterosclerotiche, secondo Lynch e Ed-wards (21), è processo patologico comune degli ateromi già ben costituiti in rap-porto alla nota presenza di capillari neoformati, ma non sempre l’emorragia stessaè sufficiente per determinare occlusione, tanto che spesso essa va incontro adorganizzazione com’è dimostrato dal fatto che nelle placche ateromasiche è pos-sibile documentare la presenza di macrofagi carichi di emosiderina (6, 22).
Per quanto attiene al meccanismo delle emorragie intramurali Gould (8) so-stiene che i capillari neoformati nel processo di organizzazione della necrosi ate-romasica abbiano notevole predisposizione alla rottura, più frequentemente inrapporto al collasso che essi subiscono quando all’intorno s’instaurano fenomenidi necrosi, o anche per la compressione che possono subire da parte del materialeateromatoso. Ma sono da prendere anche in considerazione le brusche elevazionidella pressione intracapillare, quali possono aversi nel corso di crisi ipertensive,per una forte emozione o in seguito a sforzo (9). Si concreta in tal modo l’emor-ragia intimale, che può essere progressiva conducendo alla formazione di un ema-toma intramurale. Il quadro può essere di tali proporzioni da occludere il lume
Marcello Aragona, Francesco Aragona
188
coronarico, soprattutto quando questo era già notevolmente ristretto, come già ri-cordato; oppure causare la lacerazione dell’intima ed aprirsi nel lume medesimoponendo le basi per la formazione del trombo. Se non si verifica la morte im-provvisa, la deposizione trombotica, con la perdita di liquido e la lisi globulare,tende a retrarsi e ad organizzarsi; oppure può distaccarsi, in tutto od in parte,ostruendo i territori vascolari a valle. Nelle aree emorragiche intimali, in conse-guenza delle modificazioni cui va incontro il sangue, si realizzano altre placche ate-rosclerotiche. Dalla lisi delle emazie, infatti, si liberano fosfolipidi (lecitina,cefalina, sfingomielina) e il colesterolo in esse contenuti; ed il reticolo di fibrinasi organizza in connettivo. La ripetizione nel tempo di questi fenomeni conduceall’occlusione coronarica.
Ma non si deve trascurare la possibilità che l’aumento di volume delle placcheateromasiche, occlusivo o meno, oltre che dall’ematoma intramurale, può esseredeterminato da un rigonfiamento edematoso acuto del connettivo della placcaconseguente ad un brusco aumento della permeabilità della parete dei capillarineoformati in relazione a fatti ipossici locali conseguenti anche ad episodi di spa-smo coronarico. Un simile rigonfiamento edematoso di placche fibrotiche coro-nariche è stato descritto in casi di morte improvvisa di giovani soggetti (23) ed èstato anche da noi riscontrato. Tale edema delle placche fibrotiche intimali puòcomplicarsi con emorragie diapedetiche e può condurre, quando la morte non av-venga in modo assai rapido, a discontinuazione dell’intima e alla trombosi.
A sostegno del ruolo sostanzialmente secondario svolto dalla trombosi nel-l’occlusione coronarica acuta si devono considerare le osservazioni statistichecirca l’efficacia della terapia fibrinolitica nell’infarto miocardico acuto, sospetto oaccertato. In uno studio randomizzato di ampie dimensioni, cui hanno contri-buito esperti di 19 nazioni (24), tra i quali anche italiani, condotto su 58.600 pa-zienti, si è visto che la terapia fibrinolitica è risultata meno efficace nel prevenirela morte rispetto ai controlli nelle fasi iniziali della sintomatologia. Infatti, nei pa-zienti presentatisi all’osservazione dopo 0-1 ora dalla comparsa dei sintomi lamortalità entro 1 giorno non era sostanzialmente diversa fra i casi sottoposti atrattamento fibrinolitico (78 casi su 1.678) ed i controlli (83 casi su 1.670), men-tre la differenza negli stessi casi era statisticamente significativa nel successivoperiodo di osservazione da 2 a 35 giorni (81 decessi in trattamento fibrinoliticocontro 134 nei controlli). Le differenze erano ancora più significative nei pazientipresentatisi dopo 2-3 ore dall’insorgenza della sintomatologia, sia rispetto allamortalità entro 1 giorno (302 casi su 8.297 in trattamento fibrinolitico, 339 casisu 8.315 controlli), sia ancor più rispetto alla mortalità nel successivo periodo diosservazione da 2 a 35 giorni (331 casi in trattamento fibrinolitico, 550 casi neicontrolli).
189
Fisiopatologia dello stress
L’indagine clinica qui sopra assai brevemente sintetizzata nelle parti attinentialla tematica di cui ci stiamo occupando dimostra, in sostanza, che la minore uti-lità terapeutica del trattamento fibrinolitico nelle primissime fasi dell’occlusionecoronarica debba essere ricondotta all’assenza di formazioni trombotiche nellefasi suddette, che devono invece ritenersi presenti immediatamente dopo se nonsubentra l’evento mortale, anche se non si possa escludere l’incidenza in qualchecaso d’una rottura cardiaca in sede d’infarto successiva a riperfusione da trom-bolisi, come segnalato da altri AA. (25), peraltro in pazienti con sintomatologiastenocardica di maggiore durata prima del trattamento fibrinolitico.
Di questa seconda forma di morte improvvisa cardiaca riportiamo tre casi dinostra osservazione di cui siamo stati a conoscenza dei fatti che precedettero l’ac-cadimento della morte (nella casistica medico-legale, infatti, non sempre si hannonotizie cliniche attendibili). Appariva qui essenziale la conoscenza dell’intervallodi tempo intercorso fra l’inizio della sindrome e l’exitus, nonché, soprattutto, larealtà della condizione di stress che aveva preceduto la sindrome mortale. Talicasi non sono compresi nella casistista elencata nel capitolo IV.1 della parte prima.
Caso I: Uomo di anni 38 (A.M.), impiegato, coniugato, nel primo pomeriggioaveva accusato malessere generale accompagnato da dolore precordiale con in-tervalli di benessere. Analoghe crisi si erano ripetute verso le ore 11 del giornosuccessivo dopo una notte trascorsa senza disturbi, con rapida spontanea remis-sione, e poi nuovamente nel primo pomeriggio. In quest’ultima occasione, men-tre stava per essere accompagnato in ospedale veniva a morte improvvisa. Leindagini cliniche ed elettrocardiografiche espletate in occasione delle crisi sud-dette, dal medico di famiglia ed in un pronto soccorso ospedaliero, non avevanoevidenziato segni di danno cardiaco. La condizione di stress, esclusivamente psi-cologica, era qui intravista sia nella sintomatologia stenocardica ripetuta che avevapreceduto il decesso, sia nel fatto che non era stato possibile procedere al rico-vero del soggetto durante la seconda crisi per mancanza di posti nell’ospedalepresso il quale era stato accompagnato: l’episodio mortale era avvenuto duranteil trasporto in altro ospedale. La sindrome in complesso ebbe la durata di circa24 ore.
All’autopsia il cuore appariva aumentato di volume, del peso di gr. 490, conpunta formata da entrambi i ventricoli e sparse ecchimosi subepicardiche. Il trattoiniziale della coronaria sinistra era occluso per la lunghezza circa 15 mm da vo-luminosa placca fibro-ateromasica e da formazione trombotica recente aderenteall’intima. Fortemente ristretto da placca fibro-ateromasica appariva anche il trattosottostante alla zona occlusa della stessa arteria.
L’esame istologico della coronaria sinistra e del cuore dimostrò nel segmento
Marcello Aragona, Francesco Aragona
190
prossimale dell’arteria marcato restringimento dell’arteria ad opera di una volu-minosa placca fibrosa a disposizione eccentrica, a tratti infarcita di gocciole lipi-diche, cristalli di colesterolo e granuli di calcio, con presenza anche di capillarineoformati. Il connettivo della placca, che aderiva intimamente alla media disso-ciando l’elastica interna ed in parte anche la parete muscolare, aveva in vasti set-tori aspetto ialino per rigonfiamento edematoso non solo nel primo tratto maanche più a valle. Nel tratto prossimale, inoltre, aderiva intimamente all’intima, insede di discontinuazione dell’endotelio, una rete fibrinosa infarcita da emazie fit-tamente addensate. Nello spessore della placca si riscontravano pure infiltrati cel-lulari costituiti in prevalenza da linfociti e monociti. Cumuli linfocitari eranopresenti nell’avventizia. Nel miocardio si rilevò soltanto lieve ispessimento delconnettivo in sede periarteriosa. Non alterazioni dei vasi arteriosi intramurali.Congestione pluriviscerale. Edema polmonare. Marcata steatosi epatica. Note distimolazione acuta della corticale surrenale. Midollare surrenale non valutabileper fenomeni di autolisi post-mortale.
Caso II. Uomo di anni 68 (S.F.), pensionato, aggredito e malmenato da tre sco-nosciuti in una via pubblica, verosimilmente a scopo di rapina; colto da malore èdeceduto poco dopo sul luogo dell’aggressione.
All’autopsia il cuore appariva aumentato di volume, del peso di gr. 535, conpunta formata dal ventricolo sinistro, ectasia e fibrosi eccentrica della coronariaanteriore e dei suoi rami diagonali. Il tratto iniziale del ramo diagonale prossi-male della stessa coronaria era ostruito da formazione rosso scura similtrombo-tica, ma anche le pareti del vaso avevano analogo colorito. Parete del ventricolosinistro assottigliata con presenza in prossimità della punta di area laminare cica-triziale di cm 2x0.6, nonché di strie grigiastre sparse lungo tutta la parete stessache si estendevano fino all’anello d’inserzione della valvola mitrale. Area d’ispes-simento dell’endocardio settale nel versante sinistro in continuità con strie fibro-tiche intramurali. Milza raggrinzita, con polpa ischemica.
L’esame istologico dimostrò estese aree fibrotiche nella parete del ventricolosinistro ed in parte anche nel setto interventricolare, più accentuate in sede sot-toendocardica; qualche area emorragica perivenosa; sparsi focolai di miocitolisicoagulativa. Nel ramo diagonale prossimale della coronaria anteriore, apparsomacroscopicamente ostruito, il lume era fortemente ristretto, per vasta placca fi-brosa a disposizione pressochè concentrica ricca di capillari neoformati e con-gesti, sia nella parte esterna prossima alla media apparsa assai assottigliata, sianella sua parte interna a ridosso dell’endotelio. La placca fibrosa predetta, cheaderiva all’elastica interna ed a tratti la usurava, era occupata da concamerazioniateromasiche ricche di materiale necrotico, di gocciole grassose e di cristallli di co-
191
Fisiopatologia dello stress
lesterolo, nonché di depositi calcifici e di macrofagi carichi di granuli di emosi-derina. L’occlusione del vaso era determinata da vasto infarcimento emorragicodella placca, con globuli rossi ben conservati, diffuso nel tessuto necrotico e dis-sociante il tessuto fibroso adiacente, che appariva rigonfio per edema, ed in parteanche la media. Aspetto ischemico della milza e dei glomeruli renali; note diedema polmonare; segni di stimolazione iperacuta della midollare e della corticalesurrenale.
Caso III. Uomo di anni 42 (M.F.) addetto ad un distributore di benzina in unazona periferica della città di residenza. Verso le ore 6 del mattino fu aggredito ascopo di rapina da sconosciuti e ferito con un colpo di pistola all’addome. Op-pose strenua resistenza. Nonostante ferito riuscì a raggiungere in pochi minuti,alla guida della sua auto, la più vicina caserma dei Carabinieri per denunziare l’ac-caduto, ma poco dopo fu colto da malore. Trasportato subito al pronto soccorsodell’ospedale del luogo, vi giunse cadavere. Tracce di sparo sugli indumenti incorrispondenza del foro d’entrata alla regione ipocondriaca sinistra.
All’autopsia, tramite emorragico addominale obliquo da sinistra a destra e dal-l’avanti all’indietro, con lacerazione della convessità dell’ala destra del fegato, di-screto emoperitoneo con qualche voluminoso coagulo, perforazione dell’emifrenedestro e della base del polmone omolaterale con modesto versamento ematico en-dopleurico. Cuore lievemente aumentato di volume, punta formata dal ventri-colo sinistro, coronaria anteriore ispessita per placca biancastra, molle, gelatinosa,occludente completamente il suo tratto iniziale (Fig.n. 42); modesto ispessimentodella parete del ventricolo sinistro.
L’esame istologico dimostrò che la coronaria anteriore nel suo tratto inizialeera quasi del tutto ostruita da placca fibrosa a disposizione eccentrica, costituitada connettivo fibroso rigonfio per edema della sostanza fondamentale, specie neisuoi strati interni a ridosso del lume vasale. In prossimità dell’elastica interna nu-merosi capillari sanguigni ravvicinati, per lo più dilatati e repleti (Fig. 43). Nellospessore della stessa placca erano presenti lacune riferibili a gocciole grassose ea cristalli di colesterolo andati disciolti nel procedimento d’inclusione in paraffinadel pezzo. In qualche punto l’elastica interna nella zona di aderenza della placcafibrosa presentava segni di slaminamento e di frammentazione. Nel contesto delmiocardio qualche area di miocitolisi coagulativa e nel ventricolo sinistro rare sot-tili strie di fibrosi. Note di steatosi epatica. Marcati segni di stimolazione ipera-cuta della midollare e della corticale surrenale. Aspetto ischemico della milza e deiglomeruli renali.
In sintesi, nel primo caso, nel quale la sindrome ebbe una durata di circa 24 ore,la placca fibroateromasica, che conteneva capillari neoformati e che interessava
Marcello Aragona, Francesco Aragona
192
in modo eccentrico la coronaria anteriore nel suo tratto prossimale, appariva quasiovunque rigonfia per edema, da riferire all’aumento della permeabilità delle pa-reti capillari in rapporto all’ipossia conseguente a spasmo coronarico da stressconnesso alle vicende di disagio psichico che caratterizzarono tutto il decorso delquadro morboso. Tuttavia qui l’edema della placca, giustificativo delle crisi ste-nocardiche, non era tale da realizzare la completa occlusione del vaso, la quale, in-vece, si concretò quando, in rapporto a fenomeni discontinuativi del rivestimentoendoteliale dell’arteria, avvenne la formazione del trombo occludente. Vi era con-gestione pluriviscerale.
Nel secondo caso, nel quale preesisteva un danno cardiaco da pregresso infartoda occlusione del ramo diagonale prossimale della coronaria anteriore con im-magini di ricanalizzazione e di ricca neoformazione capillare nel tessuto fibrosoocclusivo adiacente, l’acuto nuovo episodio ostruente fu determinato da vastaemorragia intramurale nell’ambito del pregresso tessuto di organizzazione, non-ché di edema nelle zone viciniori non emorragiche. Vi fu, pertanto, uno strettorapporto causale fra il violento stress psico-fisico e l’accadimento dell’ematomae dell’edema del tessuto riparativo e di ricanalizzazione della pregressa trombosi,con repentina nuova occlusione del ramo arterioso responsabile dell’infarto pre-gresso. Quanto sopra in relazione con una crisi ipertensiva e vasocostrizione ge-neralizzata, com’è pure dimostrato dall’ischemia splenica e dei glomeruli renali.
Nel terzo caso, infine, l’occlusione coronarica era esclusivamente dovuta a co-spicuo rigonfiamento edematoso della placca fibro-ateromatosa ricca di capillarineoformati presente nel tratto iniziale della coronaria anteriore. Come nel casoprecedente, qui entrò in gioco un improvviso rialzo pressorio determinato dallaviolenta aggressione subita, responsabile della repentina ischemia locale con au-mento della permeabilità delle sottili pareti dei numerosi capillari sanguigni dellaplacca fibro-ateromatosa. Nello stesso caso giocò un ruolo favorente lo shockemorragico endoperitoneale per la ferita della cupola epatica e pleuro-polmonaredestra, ancorchè la perdita ematica fosse stata di non rilevante entità: certamentenon era tale da raggiungere il volume universalmente ritenuto idoneo a cagionareda solo il decesso con le modalità verificatesi. E’ noto, infatti, che la morte rapidada emorragia avviene quando la perdita ematica ammonta in breve tempo, in in-dividuo normalmente sanguificato, a 2.000-2.500 ml.
Si constatò nei tre casi un diverso comportamento nel circolo venoso-capil-lare: nel primo caso, infatti, si manifestò terminalmente un fenomeno congesti-zio pluriviscerale, che comprendeva soprattutto la milza ed i glomeruli renali;mentre negli altri due casi gli stessi organi erano ischemici. Si desume, pertanto,che nel II e nel III caso vi fosse stato fino all’esito letale una persistente iperatti-vità del sistema nervoso simpatico concorde a massiva immissione in circolo di
193
Fisiopatologia dello stress
catecolamine dalla midollare surrenale, documentata anche dal reperto istologicodelle ghiandole surrenali, specie della midollare, tipico dell’iperattività acuta. Siintegrava così il classico quadro della morte da emozione, caratterizzato appuntoda tale reperto endocrino e circolatorio. Nel I caso, invece, alla condizione distress iniziale si sovrappose da ultimo, come dimostrato dalla congestione pluri-viscerale, un riflesso neurovegetativo vasodilatatore periferico, quale può verifi-carsi in alcuni pazienti in seguito ad occlusione coronarica (26, 27). Per cui ilquadro circolatorio terminale osservato nel I caso corrisponde a quello dellamorte per inibizione.
Condizioni di questo genere si possono anche osservare quando ad una si-tuazione iniziale di tipico stress, quale può sussistere nella concitazione di unarissa, si aggiunge lo scatenamento di un riflesso parasimpatico per stimolazionedi zone riflessogene: traumi nelle regioni orbitarie, sul collo, sull’addome, sui te-sticoli (in condizioni patologiche anche per punture pleuriche, embolismo pol-monare, introduzione di acqua fredda nei condotti uditivi o nelle cavità nasali,incaute manovre ostetriche sull’utero). Si ritiene che possano svolgere un simileruolo riflessogeno anche stimolazioni in zone non riflessogene in cardiopatici, inendocrinopatici, in neurolabili ed in genere in soggetti, per cause tuttora ignote,nei quali esista uno squilibrio umorale che renda più suscettibili i recettori, pre-sumibilmente attraverso un patologico aumento della permeabilità ionica dellamembrana, tale da abbassare la soglia recettoriale (28).
2. La morte improvvisa cerebrale da stressPer effetto di stress acuti la morte improvvisa può avvenire per ischemia ce-
rebrale da occlusione di vasi arteriosi o per ictus emorragico.La forma ischemica è connessa, dal punto di vista patogenetico, ad occlusioni
arteriose intracerebrali da ematomi intramurali su placche fibro-ateromatose ric-che di capillari neoformati conseguenti a crisi ipertensive da stress acuti: si trattaperciò di quadri simili a quelli che possono verificarsi nel cuore. L’occlusione ar-teriosa può essere anche causata da emboli cruorosi distaccatisi da coaguli suplacche ateromasiche nella carotide comune o nella carotide interna in seguitoad analoghe crisi ipertensive improvvise da stress.
La forma emorragica, cerebrale, e anche meningea, può essere sostenuta darottura improvvisa di microaneurismi in rapporto ad un brusco aumento pres-sorio.
In indagini anatomopatologiche sistematiche condotte su cadaveri di soggettiche in vita avevano sofferto di ipertensione arteriosa sono stati di frequente ri-scontrati aneurismi multipli nelle piccole arterie e nelle arterie cerebrali (29-32).Si è anche visto (32), tuttavia, che simili microaneurismi possono essere presenti
Marcello Aragona, Francesco Aragona
194
ed andare incontro a rottura anche in individui normali, pur se con minore fre-quenza rispetto ai pazienti ipertesi. I medesimi AA. (33) hanno anche osservatoall’esame necroscopico di pazienti deceduti per cause diverse che nell’encefalodei soggetti ipertesi vi erano spesso piccole emorragie, le quali comparivano solonei portatori di microaneurismi e nei distretti cerebrali interessati dai microa-neurismi stessi.
Gli aneurismi sono frequentemente di natura congenita ed è bene ricordareche essi incidono nel materiale autoptico con una frequenza tra lo 0.25% e il 9%secondo i vari Autori; sono multipli in circa il 15% dei casi, sono spesso bilate-rali, interessano più comunemente i vasi che costituiscono la metà anteriore delpoligono del Willis, si riscontrano nel sesso femminile con frequenza due voltemaggiore rispetto al sesso maschile, vanno incontro a rottura più frequentementefra i 50 e i 55 anni, si associano talvolta ad altre malformazioni (rene policistico,coartazione aortica). La rottura, come accennato, coincide solitamente con bru-schi rialzi pressori.
Gli aneurismi cerebrali possono essere anche di natura aterosclerotica, in-fiammatoria o traumatica.
Gli aneurismi aterosclerotici sogliono presentarsi sotto forma di dilatazionidiffuse e cilindriche, prevalentemente ubicati a livello dell’arteria basilare o dellevertebrali o dell’ultima parte della carotide interna. La loro rottura è del tutto ec-cezionale, ma se si dilatano acutamente si possono avere effetti compressivi sultessuto nervoso limitrofo, i quali sono di rilevanza notevole se interessano la ba-silare o l’ultimo tratto delle arterie vertebrali perchè in tal caso l’effetto com-pressivo si esercita sul bulbo e/o sul ponte.
I rari aneurismi infiammatori insorgono in seguito a distruzione della paretearteriosa, di solito nel punto ove si arresta un embolo infetto. Analogamente al-l’embolia, questi aneurismi sono più frequenti a livello dell’arteria cerebrale mediae si osservarno soprattutto in individui con endocardite batterica (cosiddetti aneu-rismi micotici). Rarissimi gli aneurismi luetici, ammesso che esistano.
Anche gli aneurismi post-traumatici possono essere sede di rotture in conse-guenza di bruschi aumenti della pressione arteriosa, tuttavia con una frequenzaassai inferiore rispetto agli aneurismi congeniti. Nell’indagine condotta da Ja-kobsson e coll. (34) dal marzo 1966 all’agosto 1980 furono osservati 5 pazienticon rottura di aneurismi traumatici, di contro a 667 pazienti con rottura di aneu-rismi congeniti. Simili le osservazioni di Benoit e Wortzman (35), che ne riscon-trarono 4 casi su una serie complessiva di 850 aneurismi intracranici.
3. La morte da ulcerazioni gastro-intestinaliNei portatori di ulcerazioni gastriche o intestinali può verificarsi la morte im-
195
Fisiopatologia dello stress
provvisa per gastrorragia o enterorragia irrefrenabili.
4. La morte da stress croniciCome già detto a proposito delle alterazioni patologiche da stress a carico del
cuore, la ripetizione nel tempo degli episodi di miocitolisi coagulativa, a causa deifenomeni di collasso dei fasci miocardici sulle lacune interstiziali realizzate dallanecrosi dei cardiociti, cioè del reciproco compattamento e avvicinamento dei fascimuscolari integri a livello delle lacune suddette, conduce ad un progressivo as-sottigliamento delle pareti del cuore con indebolimento delle stesse e dilatazionedelle cavità cardiache, con la conseguenza finale d’un ingrandimento dell’organofino a realizzare il quadro della cosiddetta miocardiopatia dilatativa. In queste con-dizioni la morte è determinata dalla progressiva insufficienza miocardica.
Quanto sopra è confermato anche dal fatto che spesso i latitanti catturati emantenuti in regime di isolamento in carcere vanno incontro a sindromi simulanticardiopatie ischemiche, come da insufficienza coronarica, e ricorrono ad inter-venti chirurgici di by-pass aorto-coronarici, anche multipli, che tuttavia risultanodel tutto inefficaci. In effetti, in tali casi il danno circolatorio non è a livello deirami coronarici principali, bensì a livello della microcircolazione, in quanto com-pressa dal sopraddetto collasso e compattamento dei fasci muscolari cardiaci in-tegri fiancheggianti aree miocitolitiche, i quali fasci, comprimendo i capillari, che,non danneggiati dalla miocitolisi, li mantengono sostanzialmente esangui.
Bibliografia1. Eliot R.S., Buell J.L., Dembroski T.M., Biobehavioral perspectives and coronary heartdisease, hypertension and sudden cardiac death. Acta Med. Scand. 666 (Suppl.) 203,1982.
2. Masaya Yamauchi, Il karoshi colpisce ancora. Br. Med. (Ed. It.), 16, 229, 1992. 3. Kiyoyasu Arikav, cit. da Pieroni B.P., Voglia di lavorare ? Si, da morirne. Med. Trib.
(Ed. It.) 10, 23, 1991.4. Lev M., The normal anatomy of the conduction system in man and its pathology in atrio-ventricular block. Ann. N.Y. Acad. Sci. 111, 817, 1964.
5. Stein B., Roberts R., Sincope, lipotimia, palpitazioni, morte improvvisa. In: Hurst, IlCuore Arterie e Vene. 8 Ed. McGraw-Hill, Milano, Vol. I, 514-515, 1995.
6. Cavallero C., Istologia Patologica. Vol. II, Ambrosiana, 715, 1968.7. Ascenzi A., Mottura G., Trattato di Anatomia Patologica per il Medico Pratico. Vol.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
196
I, UTET, Torino, 206, 1971.8. Gould S.E., La patogenesi dell’occlusione arteriosa coronarica. In: Likoff W., Moyer
J.H., La Cardiopatie Coronariche. Arti e Scienze, Roma, 145, 1964.9. Paterson J.C., Coronary occlusion. Arch. Path. 25, 474, 1938.10. Willis G.C., Ascorbic acid deficiency and atherosclerosis. Canad. Med. Ass. J. 77, 106,
1957.11. Boyd W., Le Basi Anatomopatologiche della Medicina Interna. Vallardi, Milano, 96,
1966.12. Leary T., Vascularization of atherosclerotic lesions. Am. Heart J., 16, 549, 1938.13. Davies M.J., Thomas A., Thrombosis and acute coronary artery lesions in sudden car-diac ischemic death. N. Engl. J. Med. 310, 1137, 1984.
14. Horn H., Finkelstein L.E., Am. Heart J. 19,655, 1940. In: Friedberg C.K., Ma-lattie del Cuore, vol. I, USES, Firenze, 1969.
15. Helpern N., Rabson S.M., Sudden and unexpected natural death. Generals conside-rations and statistics. N. Y. State J. Med. 45, 1197, 1945.
16. Pruitt R.D., On sudden death. Am. Heart J. 68, 111, 1964.17. Myerburg R.J., Davis J.H., The medical ecology of public safety. I. Sudden death dueto coronary hearth disease. Am. Heart J. 68, 586, 1964.
18. Friedberg C.K., Malattie del Cuore, Vol. I, USES, Firenze, 874, 1969.19. Wartman W.B., Am.. Heart J. 15, 459, 1938. In: Friedberg C.K., Malattie del
Cuore, vol. I, USES, Firenze, 1969.20. Saphir O., Trattato di Patologia Sistematica. Il Pensiero Scientifico, Roma 82,
1969.21. Lynch R., Edwards J.E., Anatomia patologica dell’alterosclerosi coronarica e delle suecomplicazioni. In: Hurst J.W., Logue R.B., Il Cuore, Vallardi, Milano 1097, 1973.
22. Paterson J.C., Moffatt T., Mills J., Hemosiderin in early atherosclerotic plaques. Arch.Path. 61, 496, 1956.
23. Müller E., Zur Morphogenese der tödlichen Koronarsklerose Jugendlicher. Zentralbl.Allg. Pathol. Anat. 83, 70, 1945.
24. FTT Collaborative Group, Indicazioni alla terapia fibrinolitica nell’infarto miocardicoacuto sospetto: rassegna dei risultati riguardanti la mortalità precoce e morbilità da causemaggiori ottenuti nella globalità degli studi randomizzati con più di 1000 pazienti. TheLancet (Ed.Ital.) 11, 330, 1994.
25. Carlsson J., Rahlf G., Tebe U., Letter to Editor. The Lancet 343, 912, 1994.26. Hainsworth R., Reflexes from the heart. Physiol. Rev. 71, 617, 1991.27. Hanley H.G., Cortin J.C., Skinner N.S.jr., Differential reflex adjustements in cuta-neous and muscle vascular beds during experimental coronary artery occlusion. Am. J. Car-diol. 27, 513, 1971.
28. Aragona F., La diagnosi differenziale fra morte da emozione e morte riflessa da inibizione.
197
Fisiopatologia dello stress
Zacchia 64, 450, 1991.29. Charcot J.M., Bouchard C., Nouvelles recherches sur la pathogénie de l’hémorrhagie cé-rébrale. Arch. Physiol. Norm. Pathol. 1,110, 643, 727, 1868.
30. Russell R.W., Observations of intracerebral aneurysms. Brain 86, 425, 1963.31. Dinsdale H.B., Spontaneous hemorrhage in the posterior fossa. Arch. Neurol. 10, 200,
1964.32. Cole F. M., Yates P.O., The occurrence and significance of intracerebral microaneu-rysms. J. Path. Bact. 93, 393, 1967.
33. Cole F.M., Yates P.O., Intracerebral microaneurysm and small cerebrovascular lesions.Brain 90, 759, 1967.
34. Jakobson K.E., Carlsson C., Elfverson J., Von Essen C., Traumatic aneurysm ofcerebral arteries. A study of five cases. Acta Neurochir. 71, 91, 1984.
35. Benoit B.G., Wortzman G., Traumatic cerebral aneurysms. Clinical features and na-tural history. J. Neurosurg. Psychiat. 36, 127, 1973.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
198
Capitolo IX
Il suicidio. L’omicidio-suicidio
1. Il suicidio: anche sul ruolo patogenetico del bullismo nei fanciulli edell’uso prolungato di farmaci antidepressivi
Occorre in primo luogo ricordare che, secondo una recente stima dell’Orga-nizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il suicidio fra i giovani fra i 15 e i 29 annifigura al terzo posto fra le cause di mortalità, preceduto dall’AIDS (I posto) edagli incidenti stradali (II posto). Tuttavia, da dati recenti risulta che in Europa an-nualmente si uccidono in media circa 58.000 persone: 8.000 in più di quanti nemuoiono per incidenti stradali. Negli Stati Uniti i suicidi sarebbero circa 1 mi-lione per ogni anno, essendo pressochè quintuplicati dal 1950 ad oggi. Secondoun recente studio su militari combattenti nella guerra in Iraq si sono registraticasi di suicidio con un tasso superiore alla media:17 casi ogni 100.000 soggetti (1).Nel 2000 in Italia si sono verificati circa 4.000 casi, un quarto dei quali per im-piccamento: nell’ultimo decennio numerosi suicidi si sono verificati in soggettiimpoveriti dall’usura. Relativamente frequenti i suicidi collettivi tra giovani inGiappone realizzati di consueto con l’ossido di carbonio in automobili ermeti-camente chiuse ed effettuati anche per accordi presi via internet. In Italia sonostati segnalati recentemente, nella stampa quotidiana, casi di suicidio causati da bul-lismo in fanciulli frequentanti scuole medie inferiori (vedi capitolo 1.1 della parteprima).
Il quotidiano “La Repubblica”, in un articolo dal titolo “Il male oscuro di Cal-tanissetta” (3.4.2007), informa circa l’aumentata frequenza del suicidio in tuttaquella provincia: nel 2005 si erano avuti 20 casi di suicidio, aumentati nel 2006.Si era trattato soprattutto di giovani, di commercianti indebitati, disoccupati edanziani. Nei giovani il motivo principale sarebbe connesso principalmente al-l’isolamento relazionale. Nel servizio si fa anche presente che, secondo le stati-stiche Istat, ogni anno in Italia si verificano oltre 3000 suicidi ed altrettanti tentatividi suicidio con maggiore frequenza nel sesso maschile: ogni 100.000 abitanti si ve-rificherebbero circa 10-12 casi di suicidio all’anno: un numero quasi superioreagli incidenti stradali soprattutto nel Nord Italia e nelle isole. Tuttavia in Sicilia nelcorso del 2004 si sono registrati 205 suicidi (con una diminuzione del 20% ri-spetto all’anno precedente). Ciò farebbe pensare ad un miglioramento delle con-dizioni di vita. Per contro, però, “se nel sud si analizzano i dati nel loro complesso,negli ultimi 20 anni, il suicidio è aumentato di quasi 200 casi l’anno.”
Secondo quanto detto nell’Introduzione, la biologia, intesa nel senso più ampiodel termine, va sempre più dimostrando gli stretti legami esistenti fra attività neu-
199
ropsichiche ed omeostasi neurovegetativa e metabolica, cioè fra vita di relazionee vita vegetativa, per cui non è concepibile uno studio della personalità umana chenon tenga conto della sua componente biologica mediante l’esplorazione degliaspetti organici che si sono dimostrati intimamente connessi all’attività psichica.A questa esigenza non ci si può sottrarre nello studio del substrato organico checaratterizza il comportamento suicida, anche se gli indirizzi metodologici preva-lenti abbiano ritenuto che in questo campo siano più utili le indagini psicologica,ambientale e statistica. Ma va precisato che le indagini statistiche non sempre rie-scono a cogliere l’essenza del fenomeno suicida, in quanto, come osservato daStengel (2), rappresentano una specie di “rifugio nel mondo delle cifre” a detri-mento di un reale approfondimento del problema e, come aveva osservato Fran-chini (3), sono costituite da dati “spesso incompleti e non paragonabili fra loro,risultando così solo parzialmente considerato il reale aspetto del fenomeno e sa-crificata la personalità psichica del suicida.” L’indagine psicologica è invece di pri-maria importanza sia per la classificazione tipologica dei suicidi, sia per indagarenel profondo dell’Io al fine di cogliere i moventi dell’idea suicida e le fasi psico-logiche che conducono all’atto suicida, e l’indagine ambientale è di utile ausilio allostudio psicologico.
Naturalmente la suddetta metodica d’indagine può essere applicata compiu-tamente solo quando si ha da fare col vivente, cioè con soggetti che sono venutiall’osservazione per avere almeno una volta tentato il suicidio, non riuscendovi.
A proposito di suicidio tentato non bisogna dimenticare però che vi sono opi-nioni discordi circa la piena sovrapponibilità degli stati psicologici che lo carat-terizzano con quelli del suicidio vero e proprio. Non vi è, infatti, unadocumentazione statistica valida che dimostri l’effettiva frequenza con la quale siverifica la recidiva, seguita o meno da morte. Secondo Stengel (2), solo una mi-noranza di individui (valutabile attorno al 10%), fra quelli che hanno tentato il sui-cidio, finisce col suicidarsi a distanza di vario tempo dal primo tentativo. Ciò,peraltro, non toglie che il tentativo di suicidio sia meritevole di attenzione e di stu-dio, anche per potere isolare quei casi, attraverso l’indagine psicologica e clinico-umorale, che abbiano una reale tendenza al suicidio, e quei casi, al contrario, chesono ben lungi dalla situazione psicologica del vero suicida: i cosiddetti tentatividi suicidio puramente dimostrativi, per ricatto, ecc.
Ma, in tema di suicidio, l’oggetto di studio è per lo più un cadavere, sì che nonè possibile eseguire sul suicida, specie se nella sua storia non figurino pregressi epi-sodi di suicidio tentato o altre manifestazioni di etero- o di auto-aggressività, ac-certamenti di ordine psicologico e clinico-funzionale, bensì solo sondaggianamnestici ed ambientali. I quali non possono che offrire dati meramente orien-tativi, se non, talora, addirittura contraddittori o non rispondenti alla realtà, come
Marcello Aragona, Francesco Aragona
200
non raramente capita nel caso in cui i familiari, per celare eventuali pregressetare psicologiche del defunto, stabili o episodiche, lo descrivono agli inquirenticome individuo perfettamente normale o, al contrario, nel caso in cui i familiariper ragioni di convenienza morale, sociale e soprattutto religiosa, segnalano tarepsichiche per mascherare, secondo quanto afferma Somogyi (4), “l’atto comecommesso in un momento d’insanità (gesto insano) al fine di attenuare eventuali re-sponsabilità e per ottenere dalle autorità ecclesiastiche di non considerare il fattocome suicidio puro e semplice – caso in cui il defunto non può essere seppellitosecondo il rito religioso - ma come conseguenza di un processo morboso, percui non vi possono essere sanzioni religiose contro il peccatore”.
Tale carenza indagativa emerge ancor più in quei casi nei quali l’atto suicidaviene realizzato come effetto di un impulso autodistruttivo improvviso ed im-prevedibile “anche per il soggetto stesso che sembra esserne sopraffatto” (Bazzi,5): cosiddetto suicidio a tipo di raptus (“raptus suicide”, secondo Ey, 6).
Non bisogna dunque rinunziare a priori, nello studio del suicida, a ciò che puòoffrire l’esame anatomo-patologico, anche se in passato si ritenne che detto esamefosse di limitatissima utilità. Invero, siffatta convinzione è giustificata dalla lacu-nosità delle indagini anatomo-patologiche sinora condotte. Basti pensare che perlo più dette indagini si sono limitate all’identificazione del mezzo e delle moda-lità di attuazione del suicidio e tutt’al più ad un superficiale esame di parte del-l’encefalo, e non mancarono Autori che, seguendo l’opinione espressa da Paltauf(1889) sul cosiddetto stato timico-linfatico, ritennero di avere individuato in esso laspiegazione del suicidio.
Oggi si è fatta giustizia di dette ipotesi, ma si è voluto nel contempo addebi-tare l’insuccesso della ricerca unilaterale condotta dai suddetti Autori alla stessaAnatomia e Istologia patologica. La quale, secondo la grande maggioranza di co-loro che hanno affrontato il problema del suicidio, non è in grado di offrire al-cunchè di utile ai fini della comprensione, nei singoli casi, dei motivi che hannocausato o concausato l’atto suicida, tanto che Deshaies (7) a questo proposito siesprimeva nei termini seguenti: “Codeste ricerche” - cioè quelle anatomo-pato-logiche - “tuttavia non sono così vane come potrebbero apparire, perché unaconclusione negativa possiede un valore reale, contrariamente all’opinione troppofrettolosa e corrente in medicina. Nel caso particolare, esse attestano un erroredi metodo…”.
In questi ultimi anni si è notato, al contrario, che lo studio ad orientamento bio-logico sia in vita che post-mortem può essere di notevole utilità per identificarele disfunzioni organiche che sono alla base del comportamento suicidiario.
I primi resoconti di anormalità biologiche nella personalità di soggetti suicidisono relativi a disfunzioni dell’asse ipofisi-corticosurrene. Riguardano suicidi af-
201
Fisiopatologia dello stress
fetti da sindrome di Cushing, nei quali sono frequenti disturbi emozionali domi-nati da depressione (8). Ulteriori segnalazioni relative alla sindrome di Cushingsuggerirono l’esistenza generica di anormalità endocrine nel suicidio. Ad esem-pio, una donna con un disordine mentale complicante la sindrome di Cushingmostrò una remissione dei suoi propositi suicidi dopo essere stata sottoposta aterapia Rx sull’ipofisi (9). Successivamente in uno studio su 35 soggetti con sin-drome di Cushing si dimostrò che 6 pazienti (17%) avevano ricorrenti pensieri disuicidio e che 2 di questi (7%) avevano tentato il suicidio durante un aggrava-mento del loro ipercorticismo (10). La possibilità che l’iperattività dell’asse ipo-talamo-ipofisi-corticosurrene possa avere uno speciale rapporto colcomportamento suicidiario era stata inizialmente suggerita da indagini del Na-tional Institute of Mental Healt, nelle quali erano state osservate elevate con-centrazioni di 17-idrocorticosteroidi urinari in pazienti che successivamente sisono suicidati (11, 12). Tuttavia, in vari ulteriori studi che hanno esaminato que-sto rapporto i risultati sono stati discordanti (13-15). Inoltre, indagini sul rap-porto fra comportamento suicida e livelli del cortisolo plasmatico, prima e dopola somministrazione di desametazone, hanno offerto risultati non del tutto uni-formi, in quanto i valori di non soppressione del test al desametazone sono ap-parsi elevati in pazienti depressi che avevano tentato o effettuato il suicidio, inparagone con quelli, parimenti depressi, che non avevano tentato il suicidio (16-19). Più recentemente, Nemeroff e coll. (20) hanno osservato riduzione dei sitidi legame CRH nella corteccia frontale di suicidi. Poiché è risaputo che il CRH èalla base della disregolazione del cortisolo nella depressione, questi reperti si ac-cordano con l'ipotesi che il CRH sia ipersecreto nella depressione con un abbas-samento della regolazione recettoriale.
L’interesse dei successivi ricercatori si è concentrato nello studio post-mortemdella noradrenalina e della serotonina in varie aree cerebrali di suicidi con l’im-piego delle metodiche più moderne: autoradiografia quantitativa recettoriale, im-munoblotting, immunoistochimica, morfometria cellulare, ibridizzazione in situ,Northen blotting per lo studio dell’RNA, come sintetizzato da Bachus e coll.(21). Ad esempio, Sastre e coll. (22) e García-Sevilla e coll. (23) hanno esaminatoi recettori proteici dell’imidazolina sia nelle piastrine di soggetti viventi, sia nellacorteccia prefrontale di suicidi. Detti recettori identificati nell’encefalo si dimo-stravano capaci di interagire col sistema noradrenalico in quanto idonei ad im-pedire il rilascio di noradrenalina nel tronco encefalico ed a stimolare nelle cellulecromaffini la produzione di tirosinaidrossilasi (TH: noto enzima necessario perla biosintesi delle catecolamine). Biegon e Fieldust (24), usando anticorpi anti-ti-rosinaidrossilasi (anti-TH) ed anticorpi per la dopamina-ß-idrossilasi (anti-DßH)su sezioni di locus coeruleus di sei suicidi e di sei controlli di pari età, hanno os-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
202
servato significative riduzioni della densità ottica dell’immunorettività della THnei campioni dei suicidi, ma non nei controlli. Tuttavia, il numero dei neuroniTH-reattivi era immodificato, indicando una riduzione di TH per neurone. Nes-suna differenza è stata osservata nell’immunoreattività DßH fra i due gruppi inesame. Questo studio ha per primo evidenziato il coinvolgimento della TH nellocus coeruleus di suicidi. Purtroppo l’esiguità dei casi esaminati limita il valoredi questi risultati, tanto più che Ordway e coll. (25) hanno riscontrato risultati op-posti, e cioè elevate quantità di TH nel locus coeruleus di suicidi.
In una indagine di morfometria cellulare quantitativa computerizzata Arangoe coll. (26) hanno osservato in suicidi, con tecniche neurochimiche, che l’inner-vazione noradrenalinica del tronco encefalico al proencefalo appariva deficitaria.Infatti, hanno rilevato che i corpi cellulari NE pigmentati erano ridotti del 23%nel numero e del 38% nella densità di questi neuroni nei suicidi, senza una ridu-zione complessiva nell’estensione e nel volume del locus coeruleus. Si è visto chela riduzione era anatomicamente circoscritta nella porzione rostrale del locus coe-ruleus, la quale provvede all’innervazione della corteccia piuttosto che a quella delromboencefalo.
Per questi studi va richiamata l’attenzione sulla circostanza che l’intervallotemporale post-mortale del prelievo è un fattore critico che può giustificare ri-sultati contraddittori fra i vari ricercatori.
Secondo Stockmeyer e coll. (27), nella depressione maggiore e nel suicidiosono implicate alterazioni nella neurotrasmissione serotoninica, specie nella cor-teccia prefrontale e nell’ippo-campo.
A proposito della serotonina non si può fare a meno di ricordare qui che infavore di un coinvolgimento di detto mediatore nei suicidi esistono numerosistudi clinici che documentano i danni psico-comportamentali osservabili nei sog-getti trattati con composti antidepressivi di tipo SSRI (“selective serotonin reuptake in-hibitors”), prescritti ad oltre 35 milioni di persone in tutto il mondo, secondol’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) con conseguenze a dir poco di-sastrose sulle funzioni del sistema nervoso centrale conducenti ad un alto tassodi suicidi, sia nell’età giovanile che adulta. I suddetti psicofarmaci, infatti, il prin-cipale dei quali è il composto farmaceutico “Prozac”, inibendo il riassorbimentodella serotonina, producono frequentemente ansia, agitazione, attacchi di panico,insonnia, irritabilità, iperattività, ostilità, impulsività e ciò può condurre ad ag-gressività contro gli altri o contro se stessi. Sembra che Joseph Wesbrecker, chenel 1989 uccise 8 persone e ne ferì altre 12, fosse sotto trattamento cronico conProzac.
Le ricerche biologiche post-mortem sopradette, come si è visto, sono state li-mitate esclusivamente su determinate aree encefaliche e le relative compromis-
203
Fisiopatologia dello stress
sioni della noradrenalina e della serotonina considerate come primitive, e cometali responsabili di comportamento suicida, senza prendere, perciò, in considera-zione la conoscenza che le medesime potessero essere conseguenza delle situa-zioni di stress connaturate con la personalità suicida e segnatamente delcoinvolgimento primario dell’asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene, nonché del si-stema nervoso simpatico e della midollare surrenale. Per quanto riguarda que-st’ultima, è d’altra parte noto che i relativi enzimi biosintetici della noradrenalina,il che vale anche per la noradrenalina encefalica, sono costantemente implicatinel corso degli stress: un’ottima revisione di queste problematiche è contenuta nellavoro di Kvetñanský e coll. (28).
Va detto anche che le indagini biologiche post-mortem, cui accennato in pre-cedenza, in quanto limitate al solo cervello, non consentono di ottenere una vi-sione completa della personalità del suicida, essendo necessario, per questo fine,uno studio anatomo-patologico completo, cioè esteso a tutti gli organi, conside-rati anche gli effetti nocivi che, di riflesso, svolgono sull’encefalo processi pato-logici di altri organi e segnatamente delle ghiandole a secrezione interna (nonlimitati all’asse ipotalamo-ipofisi-corteccia surrenale), del fegato, dei reni, non-ché di quei visceri che arrecano notevoli sofferenze soggettive in coloro che nesono affetti, non solo di natura psichica, ma anche fisica: basti pensare al dolorecardiaco da ischemia miocardica con i suoi riflessi di natura psichica, o a quellopleuro-polmonare nei processi infiammatori o neoplastici ad evoluzione pro-tratta; ecc.
Per cui risulta che la negazione del valore probatorio dell’indagine anatomo-patologica sostenuta dal Deshaies (7) si basa sostanzialmente sulla considerazioneche la medesima sia idonea a svelare situazioni organiche statiche, quali sono al-l’atto della morte, e non già idonea ad evidenziare con l’applicazione dell’istologiafunzionale estesa a tutti gli organi, le alterazioni biodinamiche, che eventualmentedette situazioni organiche esprimono. L’istologia funzionale, infatti, come si èvisto a proposito della descrizione dei reperti istologici e istochimici dell’ipota-lamo, dell’ipofisi, della tiroide, delle surrenali e di altri organi (fegato, milza, reni,organi genitali), in gran parte riportata nel capitolo IV della parte prima, com-prende le modificazini citologiche e istochimiche dei vari organi esprimenti sia lostato di riposo funzionale, sia l’incremento o il decremento della relativa attivitàfunzionale, valutati correlativamente, in rapporto alle stimolazioni esogene odendogene. La valutazione negativa espressa dal Deshaies (7) circa l’indagine ana-tomo-patologica nel suicidio è ulteriormente rafforzata nella frase seguente: “Ilpunto di vista statico in medicina si trova oggi largamente superato a favore di undinamismo fisiologico e persino psicofisiologico, al quale la psicologia è diretta-mente interessata. Lasciamo dunque il cadavere per ritrovare il vivo con le sue agi-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
204
tazioni e le sue avanie”: quasi che si dovrebbe risvegliare il cadavere per poter sudi esso condurre le indagini psicologiche, posto che, nell’ambito del suicidio,come già detto, si ha da fare sempre con cadaveri! Non esistendo nella realtà sog-getti clinicamente identificabili come sicuri futuri suicidi, tanto che le ipotesi teo-riche sulla personalità del suicida sono state sempre frutto di indagini a posteriori. CosìRingel (29) schematizza la psicologia del suicida in tre fasi: 1) in una prima fase, o sindrome presuicidiaria, dominano manifestazioni di ansia
e di irrequietezza; 2) in una seconda fase, o di restringimento psichico, compaiono manifestazioni
autoaggressive (scoppi di rabbia o di disperazione); 3) nella terza fase, o di fuga nell’irrealtà, predomina negazione della realtà o un
quadro di anestesia psichica annullante del tutto il senso di timore o di paura perla morte. L’atto suicida si realizzerebbe nella seconda o nella terza fase. Si desume che la situazione psicologica del suicida non sia diversa da quella di
stati ansiosi o angosciosi di altra natura, specie nella supposta maturazione del-l’idea suicida, per cui in vita non risulta possibile identificare il vero candidato alsuicidio. Vi è poi la circostanza che molti Autori sostengono l’esistenza di casi disuicidi che in vita avevano sempre mantenuto un comportamento assolutamentenormale, o apparentemente tale, che vengono classificati nel cosiddetto gruppodel suicidio del normale. Jaspers (30) a questo riguardo affermava che la “maggiorparte dei suicidi non sono commessi da malati di mente, ma da individui con di-sposizioni abnormi (psicopatici)”. Nel qual senso si è pronunciato anche Chiodi(31) per il suicidio nei giovani. Altri AA., pur con impostazioni concettuali nonsempre sovrapponibili, hanno ammesso l’esistenza di un “suicidio del normale”come conseguenza di una reazione abnorme all’avvenimento (Schneider, 32). Giordae Merli (33) definirono come suicidio del normale “quello che si determina peruna particolare condizione di conflitto tra la personalità ed il mondo esterno”. Nelprocesso di adattamento dell’individuo nel suo ambiente di vita, egli andrebbeincontro quotidianamente a necessarie limitazioni della sua personalità, limita-zioni che in casi eccezionali possiederebbero una tale carica frustrante da cau-sare anche nel normale la reazione suicida.
Significativa a questo riguardo una inconsueta frequenza del suicidio notata re-centemente, nei primi mesi del 2007, nella fabbrica automobilistica della Peugeotin Francia: sei vittime da febbraio a luglio dell’anno in corso (la Repubblica, 18luglio 2007). A parte un soggetto che si era ucciso in fabbrica per accertati mo-tivi sentimentali, per gli altri casi si è ritenuto che la causa principale fosse stataconnessa ai ritmi di lavoro eccessivi durante tutti i giorni, imposti dall’aziendaper aumentare la produttività: si tratta di 10.500 persone addette alla produzionedella nuova Peugeot 108, i quali, peraltro, pur ricevendo una retribuzione congrua,
205
Fisiopatologia dello stress
non riuscivano a sopportare i ritmi frenetici della fabbrica. Si è proposto di con-siderare questo tipo di suicidio come infortunio sul lavoro, con conseguenti be-nefici economici assicurativi per la famiglia. Si tenga anche presente la costanzadel rumore ambientale e la necessità di mantenere ritmi lavorativi fuori del con-sueto. Nello stesso quotidiano (La Repubblica, 20-02-2008) si dà notizia circa uninspiegabile aumento dei suicidi negli ultimi cinque anni (1999-2004) fra gli ame-ricani di età compresa fra i 45 ed i 54 anni. Per quanto riguarda detto aumentodel suicidio nel sesso femminile si ipotizza che il fenomeno possa dipendere dalcrollo, in quelle età, nell’uso di terapie ormonali dopo la menopausa, che farebbedar luogo a depressioni cliniche. Non sono noti i riscontri anatomo-istologicidella suddetta casistica. Si è anche ipotizzato che il fenomeno nel suo insieme, spe-cie nel sesso maschile, possa essere conseguenza dell’abuso di droghe, e vi figu-rano anche reduci di guerra specie quelli del Vietnam. Eventi di cronaca hannodocumentato che anche il mobbing (vedi capitolo I della parte prima) può esserealla base di tendenze suicide. Un esempio recente (31.10.2007) riguarda un ra-gazzo di 14 anni di Ischia, primo della classe (tutti nove nelle varie materie di stu-dio), emarginato, vessato e preso in giro dai compagni che lo definivano“secchione e crumiro”. Il ragazzo si impiccò ad un albero nei pressi della sua abi-tazione.
Un notevole incremento degli episodi di suicidi si è verificato di recente in la-voratori francesi: si ritiene che il fenomeno sia in rapporto alle maggiori esigenzedi perfezionismo, non facilmente raggiungibile dai singoli lavoratori delle variespecialità (vedi La Repubblica 1-10-2009).
A questo riguardo, tuttavia, occorre tenere presente che l’atto suicida, tranneparticolari forme di suicidio (eroico, religioso, rituale, di protesta) è difficilmentecomprensibile nel normale. Ci sembra che in primo luogo occorra intendersi sulsignificato di normale, se cioè esso sia da riferire solamente alle apparenze psi-cologiche antecedenti all’attuazione dell’atto suicida, o, invece, e soprattutto, allesue condizioni biologiche di base. E’ ovvio che, se nel catalogare nell’ambito dellanormalità un suicida ci si attiene soltanto ai dati anamnestici comportamentaliraccolti dai familiari e dagli intimi conoscenti, si è ben lungi dal penetrare nel-l’essenza interiore del soggetto, dato che questa è la risultante non solo degli at-teggiamenti psicologico-comportamentali, ma anche, e forse essenzialmente, delperfetto equilibrio dei meccanismi omeostatici organici.
Intanto esistono in letteratura approcci biologici più o meno recenti, di cui siè già detto, che dimostrano l’esistenza di generiche predisposizioni al suicidio aiquali si rimanda. Per quanto riguarda i corticosterioidi, Sachar (34) aveva con-cluso per la necessità di tenere sotto controllo quei pazienti depressi nei quali sifossero riscontrati alti livelli di corticosteroidi per impedire che, a insopportabili
Marcello Aragona, Francesco Aragona
206
stati di conflitto interno, seguisse il suicidio o altra irrazionale soluzione. A proposito della casistica elencata nel capitolo IV.1 della parte prima, è op-
portuno ripetere ancora che le motivazioni che stanno alla base dello stress dellevittime di omicidio e quelle che coinvolgono i suicidi ed i responsabili di omici-dio e poi di suicidio sono sostanzialmente diverse.
Nel primo caso si tratta di motivazioni prevalentemente di origine esterna con-nesse al timore o addirittura alla paura o al terrore di essere sotto la continua mi-naccia, anche per la vita, di competitori nelle attività delinquenziali esimultaneamente anche nel mirino delle forze dell’ordine specie quando trovansiin stato di latitanza. Nei soggetti uccisi in condizione di detenzione, specie semantenuti stabilmente in isolamento, era soprattutto questa condizione la sor-gente dello stress.
Nei suicidi, invece, a parte le forme connesse a sopravvivenza a campi di con-centramento o a prolungata ed ingiusta detenzione nei detenuti nelle carceri ita-liane si è notata una costante elevata incidenza del suicidio in questi ultimi anni:
nonchè al rimpatrio da lunghe e frustranti guerre (vedi capitolo II.2, secondaparte), le motivazioni sono quasi esclusivamente interne, connesse raramente avere e proprie sindromi psichiatriche, più spesso a processi morbosi latenti, asin-tomatici o al più oligosintomatici e perciò di difficile identificazione diagnostica,i quali, tuttavia, sono idonei a determinare un abbassamento più o meno marcatodella soglia sensoriale al punto da accrescere la risonanza soggettiva di stimolazioni emo-zionali che prendono lo spunto da fatti esteriori spiacevoli che nei soggetti nor-mali non sono idonei ad incidere sulla psiche e sul comportamento. Daconsiderare a parte sono anche i cosiddetti kamikazemotivati da credenze religioseresponsabili di atti terroristici col sacrificio della propria persona, nonché le gio-vani donne vergini di nazionalità turca ritenute responsabili di atti contrari al-l’onore familiare. Appare qui utile trascrivere i dati dell’elaborato di MarcoAnsaldo pubblicato su La Repubblica del 14.07.2006, dal titolo: Turchia, il suici-dio delle vergini “Ci hai disonorato, devi ucciderti”: Record di morti: Nella cittàturca di Batman, nel sud est dell’Anatolia negli ultimi 6 anni si sono verificati 106casi di suicidio, di cui 102 compiuti da donne. Dall’inizio del 2006 le donne che
207
Fisiopatologia dello stress
Anno Casi
65 su 53.322
72 su 53.193
57 su 55.668
65 su 56.081
2000
2001
2002
2003
si sono suicidate sono state ben 36. Le cause del disonore: nelle zone rurali del-l’Anatolia a scatenare la decisione di istigare una ragazza al suicidio non è piùsolo la colpa di avere avuto rapporti sessuali, ma l’aver messo una gonna corta,oppure essere andata al cinema!
Come già accennato nel corso del 2007, dal febbraio al luglio è stato registrato,come riportato dai quotidiani, un sensibile aumento della frequenza dei suicidi inuna città della Francia (Mulhouse), nel constesto della fabbrica di automobili (Peu-geot-Citroen), ove lavorano circa 1500 persone. Nel suddetto periodo si sono ve-rificati sei suicidi per lo più per impiccamento (operai di mezza età: 50-55 anni).Non è facile identificarne la causa: si suppone che ciò sia connesso ai pesantiturni lavorativi lunghi e ripetitivi e perciò conducenti spesso alla noia e/o a stan-chezza mentale. Non ci è noto se su tali soggetti siano state eseguite indagini au-toptiche.
Invero, nei comuni casi di suicidio, a parte le sindromi psichiatriche concla-mate, ad impronta per lo più depressiva, le alterazioni psicologiche e comporta-mentali sono spesso in correlazione, come già accennato, con squilibri ormonalie/o del metabolismo, fra i quali prevalgono quelli da ipertiroidismo, di solito mi-sconosciuto, cui si associano i reperti propri degli stress a carattere cronico. Nellanostra casistica attinente al suicidio, come già detto nel capitolo IV.1 della parteprima, l’esame istologico ha dimostrato nel 95% dei casi segni indubbi di iper-funzione tiroidea, caratterizzati da follicoli ghiandolari per lo più piccoli, vuoti ocontenenti colloide poco densa e vacuolata ai margini, in contrasto con la colloidedensa, spesso festonata, dei follicoli in riposo funzionale, e con cellule di rivesti-mento cubici, vacuolati in contrasto con le cellule assottigliate, endoteliformi, deifollicoli in riposo funzionale. Solo in alcuni casi abbiamo osservato nella tiroideproliferazione interstiziale di cumuli linfoidi quali si sogliono osservare nel morbodi Basedow. Per cui il suddetto reperto tiroideo (comunemente non basedowiano),che si differenzia da quello riscontrato anche nelle vittime di omicidio perché quiassai meno pronunciato e meno frequente, induce ad ipotizzare l’attualità di sin-tomi psicologici dominati da ansietà, in quanto facenti parte del quadro clinicodell’ipertiroidismo, similmente al quadro clinico del m. di Basedow, e perciò pre-disponenti a comportamenti aggressivi contro se stessi, in rapporto a stimoliemozionali spiacevoli, agevolmente rimossi e superati dagli individui normali. Ladifferenza osservata fra le vittime di omicidio ed i suicidi a proposito del repertotiroideo consente di ritenere che in questi ultimi l’ipertiroidismo debba preesi-stere allo stress, anche se aggravato dallo stress medesimo. Questo orientamentoè convalidato dalla nostra osservazione (come si vedrà anche nei casi di omicidio-suicidio) che nei casi di suicidio con veleni bloccanti la trasmissione sinaptica alivello centrale, e segnatamente con i barbiturici, il suddetto reperto tiroideo era
Marcello Aragona, Francesco Aragona
208
presente. D’altra parte in alcuni casi di suicidio con barbiturici il reperto era ad-diritura quello tipico del morbo di Basedow (Fig. n. 44): il che conferma la pree-sistenza della relativa sindrome clinica all’attuazione dell’atto suicida. Inoltre in uncaso di omicidio-suicidio mediante avvelenamento con stricnina, composto chi-mico con attività ben diversa dai precedenti, il reperto istologico era anche quellotipico del morbo di Basedow (Fig. 45). Su quest’ultimo caso si ritornerà nell’ap-posito paragrafo.
Fra le alterazioni metaboliche non sono da trascurare quelle di origine epaticae si devono considerare anche le sindromi dolorose viscerali, specie di genesi car-diaca, nonché i disordini comportamentali connessi ad altri disordini ormonalicome il morbo di Cushing, nel corso del quale è pressochè costante la comparsadi manifestazioni di carattere depressivo, come già ricordato.
Per quanto attiene alle modificazioni istologiche e istochimiche delle ghiandolesurrenali nel suicidio, vi è da osservare che abitualmente mancano i reperti di sovrasti-molazione acuta sia nella midollare che nella corticale, pur esistendo quelli tipici della sti-molazione cronica. Ciò indicherebbe che nella fase di attuazione del suicidio lostress non sia più attuale o non assuma quel carattere di violenta stimolazioneche si osserva nelle vittime di omicidio nel momento in cui, accorgendosi del-l’agguato, le medesime divengono improvvisamente consapevoli e terrorizzatedall’impossibilità di evitare la morte imminente. Ciò indicherebbe che nel suicidanella fase di attuazione del suicidio lo stress che ne è responsabile non sia più at-tuale e che, pertanto, l’assenza di segni di attivazione funzionale iperacuta di detteghiandole sia attribuibile alla seconda e soprattutto alla terza fase della situazionepsicologica del suicida, secondo Ringel (29), cui accennato in precedenza. In so-stanza il reperto suddetto rispecchierebbe la fuga nell’irrealtà, nella quale predo-mina la negazione della realtà o un quadro di anestesia psichica annullante del tuttoil senso di timore o di paura per la morte. Per cui le modificazioni funzionali delleghiandole surrenali registrate nei suicidi, che sono a carattere subacuto o cronicosono da riferire al periodo di maturazione dell’idea al suicidio e non al momentodella sua attuazione.
Per quanto attiene al fegato, nella maggioranza dei casi studiati l’organo è ap-parso normale sia macroscopicamente che istologicamente, mentre il suo conte-nuto in glicogeno era diminuito o assente in circa la metà dei casi. Non lesionimacroscopiche e istologiche dei reni, tranne modeste note di aterosclerosi in sog-getti oltre gli anni 50. In tutti i soggetti di sesso maschile i testicoli mostravanoarresto maturativo della linea seminale (Fig. 39), mentre nei soggetti di sesso fem-minile è stato costante il riscontro di cisti a cellule tecali nelle ovaie.
In conclusione, sulla base delle suddette indicazioni necroscopiche, adeguateindagini di laboratorio sul vivente, dirette a valutare la funzionalità della tiroide,
209
Fisiopatologia dello stress
delle ghiandole surrenali, di quelle sessuali, nonché del fegato e dei reni, possonofornire utili indizi in favore del reale proposito suicida in soggetti depressi o cheabbiano in precedenza tentato il suicidio.
Alcuni esempi sono necessari per meglio illustrare i concetti sopra esposti,non tutti compresi nella casistica elencata nel capitolo IV.1 della parte prima.
a) Uomo di 73 anni scomparso da casa fu rinvenuto cadavere dopo alcunigiorni in località di campagna in prossimità dell’abitato ove scorreva un torrente.Il cadavere aveva gli indumenti in ordine, non presentava segni esterni di vio-lenza, giaceva a terra sul fianco destro con la testa immersa in un fossato pienod’acqua proveniente dal torrente. Il fossato era largo circa 1 metro, profondo 40cm ed era fiancheggiato da alcuni massi. Il soggetto, circa 30 anni, prima avevatentato il suicidio per scannamento e successivamente ricoverato in manicomiocon diagnosi di sindrome schizofrenica. Dimesso dopo stabile remissione dellasindrome psichiatrica, aveva mantenuto un comportamento normale ed aveva ri-preso il suo abituale lavoro di bracciante agricolo. All’esame necroscopico e isto-logico, oltre alle note di annegamento, presentava segni di involuzione seniledell’encefalo, note di iperattività della tiroide, vaste aree a cellule scure della cor-ticale surrenale, e parziale degranulazione delle cellule cromaffini della midollaresurrenale, fegato morfologicamente normale, ricco di glicogeno.
Il caso si distingue per la non comune modalità dell’annegamento, fermamentedeciso e realizzato, stante la difficoltà di mantenere lo stato di apnea fino alla per-dita di coscienza e alla morte in un piccolo specchio d’acqua, e per il riscontro diun apparente stato di riposo funzionale della midollare surrenale, con il quales’accorda anche il normale contenuto in glicogeno del fegato.
Modalità suicidiarie come quella osservata nel caso suddetto, furono osser-vate in passato, specie in psicopatici. Il Borri (35) in proposito scrive: “a priori,non deve contrastare all’ipotesi del suicidio nessuna circostanza che possa im-pressionisticamente sviar la mente da tale ipotesi, a meno che non apparisca di persé incompatibile con un siffatto meccanismo di morte. Così taluno (psicopatico,peraltro) ha saputo morire per asfissia da annegamento cacciando e mantenendola faccia in una catinella d’acqua, altri cercando in ogni modo di prevenire gli istin-tivi movimenti di difesa e di tentativi di salvamento, mediante pietre, o pesi legatial collo, o autolegature complicate…., altri, prima di annegarsi, può essersi in-ferte, ad intento suicida, delle violenze le più svariate ed anche di assoluta gravità.”
b) Donna di 46 anni, nubile, casalinga, ricoverata in un reparto psichiatricoospedaliero in seguito ad un tentativo di suicidio effettuato con l’ingestione di
Marcello Aragona, Francesco Aragona
210
varechina. La donna al sesto giorno di ricovero, elusa la vigilanza del personalesanitario, si lanciò nel vuoto da un balcone del secondo piano del reparto, dal-l’altezza di circa 15 metri, venendo a morte dopo 3 giorni in stato di coma cere-brale, frattura della base cranica e fratture multiple degli arti inferiori. All’esamenecroscopico e istologico, oltre alle lesioni traumatiche multiple con contusionimeningo-encefaliche dirette e indirette, risultò affetta da ipertiroidismo con iper-basofilia ipofisaria, note di atrofia delle circonvoluzioni cerebrali, specie frontali,cariolisi e degranulazione delle cellule nervose, specie nel cervelletto, con imma-gini di proliferazione gliale, miomatosi uterina con atrofia endometriale. La pree-sistente situazione patologica di fondo era complicata da un’epatite acuta,caratterizzata da focolai disseminati di necrosi centrale e mediocentrale con mo-derata reazione infiammatoria interstiziale, nonché lievissima steatosi e scom-parsa del glicogeno epatico. Le manifestazioni necrotiche interessavano anche lacorteccia surrenale. Il disordine psichico che indusse la donna in un primo tempoad un tentativo di suicidio e dopo al suicidio è da ritenere qui soprattutto connessoall’intossicazione d’origine epatica e cioè ad un’encefalopatia epatica, nonché al-l’ipertiroidismo, in quanto è venuta a mancare l’azione demolitiva che il fegatonormalmente esercita sugli ormoni, fenomeno idoneo a realizzare le sindrominote in clinica come disormonosi metaepatiche. L’encefalopatia epatica abitualmentecomporta stato di agitazione, ansia, insonnia, aggressività e può essere erronea-mente confusa con una psiconevrosi. Poiché la morte era avvenuta dopo 3 giornidalla precipitazione dall’alto non è stato possibile valutare quanto spettassero altraumatismo cranico, commotivo-contusivo, e allo stato agonico protratto equanto all’encefalopatia epatica e all’ipertiroidismo le riscontrate alterazioni re-gressive neuronali e proliferative gliali osservate nel sistema nervoso centrale.Tuttavia, il comportamento della donna, decisamente orientato in senso autodi-struttivo sin dall’iniziale tentativo di suicidio e lo stato ipotrofico di tipo senile del-l’encefalo starebbero in favore d’una azione patogena prevalente dell’epatopatiaacuta, dell’ipertiroidismo ed anche della sicura esistenza di uno stato ipoglice-mico. In tale ultimo senso orienta, infatti, la totale scomparsa del glicogeno epa-tico. E’ da tempo noto che l’ipoglicemia provoca nell’encefalo alterazioniregressive simili a quelle prodotte dall’anossia. Infatti, nel corso dell’ipoglicemiale lesioni encefaliche consistono in riduzione di volume dei neuroni che mostranonuclei in cariolisi o picnotici, scomparsa delle granulazioni citoplasmatiche finoalla completa dissoluzione cellulare, ampliamento degli spazi pericellulari (36).
c) Uomo di 44 anni che, dopo qualche giorno dall’inatteso licenziamento dallavoro, si uccise con un colpo di pistola al torace, produttivo di una lesione nontrapassante del cuore: l’organo era stato colpito sul margine ottuso del ventricolo
211
Fisiopatologia dello stress
sinistro senza penetrazione in cavità ma con lacerazione orizzontale, a semicanale,della parete miocardica e lesioni discontinuative di rami coronarici e contusionidel tronco principale della coronaria anteriore e del margine inferiore del ramo si-nistro dell’arteria polmonare; perforazione a tutto spessore del tratto prossimaledel lobo inferiore del polmone sinistro con modesto emotorace omolaterale.Morte rapida.
Nel soggetto, oltre ad una sindrome coronarostenotica cronica con aree di fi-brosi miocardica da pregressi fenomeni ischemici episodici, verosimilmente an-ginosi, esistevano alterazioni di carattere regressivo del sistema nervoso centrale,consistenti in ipotrofia di tipo senile delle circonvoluzioni della corteccia frontalecon ispessimento ialino delle arteriole, rarefazione della popolazione neuronica,specie degli strati corticali profondi e note di degranulazione citoplasmatica ecromatolisi neuronale con comparsa di neuroni dall’aspetto di ombre (Fig. 28).Coesistevano analoghe lesioni nelle cellule di Purkinje del cervelletto e rarefa-zione dei neuroni dello strato granulare della stessa corteccia cerebellare (Fig. 29),nonché di quelle del nucleo dentato cerebellare, e dei nuclei bulbo-pontini e delcorpo striato; iperplasia astrocitaria con affollamento pericapillare, specie nellasostanza bianca, ove comparivano immagini di mielinolisi con rigonfiamento delleguaine soprattutto nel ponte e nel bulbo; aspetti di stimolazione cronica dellacorteccia e della midollare delle ghiandole surrenali, arresto maturativo della lineaseminale nei testicoli, assenza di glicogeno nel fegato. Per cui i danni cerebrali acarattere acuto, che riproducono quelli tipici da ipossia, possono essere stati con-nessi a precedenti episodi di ipoglicemia: condizione metabolica evidentementepresente anche nel momento del suicidio. In questo complesso dismetabolico,con anestesia psichica, deve essere maturato il movente principale del suicidio sca-tenato dal recente licenziamento dal lavoro e presumibilmente da una contestualecrisi anginoide.
2. L’omicidio-suicidioRiguardo al fenomeno omicidio-suicidio è opportuna la distinzione suggerita da
Franchini (37), il quale sostiene la necessità di tenere separata la figura dell’omi-cidio di persona non consenziente seguita dal suicidio dell’autore, che caratteriz-zerebbe il tipico omicidio-suicidio, mentre si dovrebbe parlare di omicidio delconsenziente-suicidio quando l’evento suicidio si attua come conseguenza dell’ipotesidi omicidio del consenziente prevista dall’art. 579 del codice penale, il quale recita:“Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la re-clusione da sei a quindici anni. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio(artt. 575-577) se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni 18;
Marcello Aragona, Francesco Aragona
212
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienzapsichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefa-centi;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con vio-lenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.” Si tratta, perciò, di ipotesi sostanzialmente diversa, dal punto di vista psicolo-
gico, dall’uccisione di persona inconsapevole, come accade nel tipico omicidio-suicidio, essendosi frapposta, secondo Franchini, fra i due episodi (l’omicidio delconsenziente ed il suicidio) “una nuova situazione psicologica (pentimento, ti-more di essere punito, ecc.)”, mentre nella figura classica dell’omicidio-suicidio ilfattore causale dei due fenomeni aggressivi (contro altri e contro se stesso) è con-nesso a motivazioni unilaterali dell’autore dei fatti, derivanti da sue situazioni psi-cologiche abnormi, non raramente frutto di tormentosi e assillanti gelosie.
Il classico omicidio-suicidio è fenomeno relativamente raro. Masotti e coll.(38) ne hanno descritti nove casi osservati nell’arco di tempo di un ventennio(1983-2002) nel settorato medico-legale di Parma, con maggiore concentrazionenel biennio 1998-1999 (3 casi).
La stampa quotidiana di questi ultimi sei anni ha dato notizie di episodi diomicidio-suicidio, accaduti in Italia, con una frequenza di gran lunga superiore ri-spetto al passato.
Riportiamo qui di seguito in sintesi i casi di cui siamo venuti a conoscenza nelrecente passato, oltre alcuni casi di nostra osservazione, due dei quali compresinell’elenco del capitolo IV della Prima Parte.
213
Fisiopatologia dello stress
Località
Foggia
Campanel la(VI)
Verderio Supe-riore (Lecco)
Castel delSasso (Caserta)
Bolzaneto (GE)
TrenoReggioC.-Torino
Aprile 1997
Settembre 1999
Giugno 2000
Agosto 2000
Agosto 2000
Maggio 2001
Donna di 35 anni uccise mediante strangolamento i due figli di5 e 8 anni e poi s’impiccò.
E.D.D. (a.45) strangola le figlie di 16 e 13 anni, uccide la mogliecon un colpo di fucile e si uccide con la stessa arma.
M.M. (a.45) uccide con colpi di pistola due figli (13 e 8 anni) e lamoglie e poi si uccide con la stessa arma.
Una donna A.P. (a.36) uccide le tre figlie (6, 2, 1 anno) e sestessa col gas dell’auto in cui erano rinchiuse, avendone all’in-terno del veicolo predisposto lo scarico.
A.G. (a.60), affetto da un tumore, uccide con un fucile da cacciala moglie, il figlio, una vicina di casa e il figlio di costei handi-cappato, e poi si uccide con lo stesso mezzo.
P.M. (44 anni) spara e uccide la moglie di 22 anni e la suoceradi 44 anni, marocchine, perché la moglie vuole separarsi, e si uc-cide in modo analogo.
Anno Descrizione
Marcello Aragona, Francesco Aragona
214
Tra Anzio e Net-tuno (Roma)
Lanusei (Nuoro)
Roma
GenovaCornigliano
Trapani
Provincia di Catania
Viganò (Lecco)
Monticelli Bru-sato (Brescia)
Caserta
Molino di Malo(VI)
Polistena (RC)
Robecchetto(MI)
Monopoli (BA)
Palermo
Firenze
Siracusa
Agosto 2002
Giugno 2003
Luglio 2003
Agosto 2003
Novembre 2003
Gennaio 2004
Gennaio 2004
Gennaio 2004
Gennaio 2004
Gennaio 2004
Gennaio 2004
Gennaio 2004
Gennaio 2004
Febbraio 2004
Febbraio 2004
K.W. (cittadino tedesco) di anni 63 uccide la moglie di 54 annicolpendola ripetutamente con un tondino di ferro e quindi i figlidisabili di 11 e 15 anni soffocandoli e poi si uccide lanciandosi daun balcone. Sembra che i Servizi sociali volessero togliergli ifigli.
L.N. di anni 47, uccide a coltellate le figlie di 9 e 7 anni e si uc-cide con lo stesso mezzo. Egli era ossessionato dal fatto che laconvivente aveva deciso di abbandonarlo e di condurre con séle due figlie.
Un cittadino egiziano uccide i figli della convivente, di anni 21 e27, e poi si suicida. Prima di suicidarsi uccide anche la nonna deidue giovani.
S.G. di a. 47 uccide con un colpo di pistola la seconda moglie, ifigli di 4 e 8 anni, e si uccide con la stessa arma.
F.C. di anni 40 uccide a colpi di pistola i suoi due figli, di anni 8e 12, e si uccide.
F.R. di anni 42 uccide a fucilate la moglie di a.37, la figlia a. 16e poi tenta il suicidio con la stessa arma.
F.Z. di anni 54. Diabetico, depresso, uccide a colpi di pistola nelsonno i due figli di 19 e 25 anni e la moglie di anni 51, e poi siuccide con la stessa arma.
D.A. di anni 78 ha tentato di uccidere con un corpo contundentela moglie, pure di anni 78, affetta da morbo di Alzheimer e poi siè ucciso con un colpo di pistola
L.L. di anni 56, sposato e separato, vivente con i due figli a casadei genitori, uccide con un fucile da caccia la propria madre dianni 81 e ferisce di striscio il padre; rivolge poi il fucile contro sestesso ferendosi gravemente (ricoverato morente in rianima-zione)
G.P. di anni 59 uccide a colpi di pistola la convivente e il figlio diquest’ultima e poi si uccide con la stessa arma.
R.C. di anni 40 uccide con un colpo di pistola la moglie di anni36 ed il figlio di anni 5 e poi si uccide con la stessa arma.
S.F. di anni 40 uccide sua madre di anni 72 con un colpo di pi-stola e poi si uccide con lo stesso mezzo.
P.F. di anni 53 uccide con un colpo di pistola la convivente di a.68, dormiente, e poi si uccide con la stessa arma.
G.C, di anni 79 uccide con due colpi di pistola la moglie di a.69,dormiente, affetta da una sindrome che la obbligava su unasedia a rotelle, poi si uccide con un colpo alla tempia destraesploso dalla stessa arma.
G.F. di anni 58 uccide la moglie di anni 45 con un colpo di pistolae poi si uccide con la stessa arma.
S.F. di anni 57, sposato e padre di una ragazza, uccide la madredi anni 84, soffocandola e si toglie la vita lanciandosi da un bal-cone del quarto piano
Marzo 2002
215
Fisiopatologia dello stress
Luglio 2004
Novembre 2004
Novembre 2004
Gennaio 2005
Gennaio 2005
Gennaio 2005
Maggio 2005
Giugno 2005
Giugno 2005
Giugno 2005
Luglio 2005
Settembre 2005
Settembre 2005
Vieste (FG)
Chieri (TO)
Genova
Bologna
Somma Lom-bardo (VA)
Signa (Firenze)
Palermo
Torino
Rotondella (MT)
Mogliano Veneto(TV)
Barcellona P.G.(ME)
Fontana di Villorba(TV)
Barriera di Milano
DB. G. di anni 33, casalinga, ha soffocato con nastro adesivosulle aperture aeree i due figli, rispettivamente di anni 4 e 1, e poisi è uccisa con la medesima dinamica. Vi erano insanabili dis-sapori col marito.
Un giovane armato di mitraglietta, due pistole ed una rivoltella haucciso in rapida successione l’ex consorte, la madre di lei, il fra-tello della stessa con la moglie, due vicini di casa ed un’operaia,presenti sul luogo del delitto, e subito dopo si è suicidato.
Un ispettore di polizia ha ucciso con colpi di pistola la moglie se-parata, i due figli di 8 e 4 anni e poi si è suicidato con la stessaarma. Pare che l’odio omicida sia stato motivato dal rifiuto delladonna di fargli frequentare i figli.
Un medico (G.C.) di 54 anni, separato da 7 anni dalla moglie,conducente una vita apparentemente tranquilla, uccide a colpi dipiccone la figlia di 10 anni e dopo aver confessato il delitto aipropri genitori, sostenendone la necessità per il bene della fi-glia, si è gettato nel vuoto da una finestra della sua abitazioneubicata al terzo piano venendo a morte immediata.
Un uomo di 54 anni (E.S.), per motivi di interesse, uccide concolpi di pistola la sorella di 56 anni, e poi si uccide con un colpoinfertosi in bocca con la stessa arma.
Uomo di 56 anni (F.G.), pensionato, dopo aver perso tutti i suoirisparmi al gioco del lotto, uccide con una pistola la moglie ed ilproprio figlio, suicidandosi immediatamente dopo con un colpoalla testa con la stessa arma.
Uomo di 67 anni (P.R.), pensionato, uccide con un colpo di pi-stola alla testa la moglie dormiente, affetta da circa un decennioda morbo di Alzheimer, poi si uccide con un colpo in boccaesploso con la stessa arma.
Uomo di anni 49 (Z.S.), operaio disoccupato, uccide con uncolpo di pistola la moglie dormiente, di anni 44, inveterata alco-lizzata. Poi si uccide con la stessa arma.
Uomo di 36 anni (P.P.), sembra per motivi di gelosia, uccide nelsonno la moglie, di 33 anni, e la figlia di 5 anni, a colpi di man-naia, e poi si uccide impiccandosi.
Donna di anni 75 uccide il figlio di anni 38, tetraplegico immobi-lizzato in carrozzella, spingendolo nel fiume Zero e poi si è sui-cidata gettandosi nello stesso fiume. I corpi sono stati recuperatia valle a distanza di 500 metri.
Uomo di 83 anni uccide con un colpo di pistola al collo la moglieseparata di anni 63 e poi si uccide con la stessa arma con uncolpo alla testa.
Uomo di anni 41 uccide la moglie di anni 40 con due colpi di pi-stola al torace e poi si si uccide con un colpo alla tempia esplosocon la stessa arma.
Uomo di a. 55 uccide con un colpo di pistola alla testa la mogliedi anni 38, dalla quale viveva separato, e poi si uccide con lastessa arma esplodendo un colpo alla tempia.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
216
Uomo di 53 anni uccide la moglie coetanea mentre essa dor-miva nel suo letto, con un colpo di fucile al torace, poi si uccidecon la stessa arma pure con un colpo al torace. Pare vivesseroin precarie condizioni economiche.
Uomo di 52 anni uccide la moglie di anni 46 a colpi di coltelloda cucina, L’omicidio è avvenuto nel retrobottega del negozioda loro gestito. Si è poi ucciso con lo stesso mezzo infisso neltorace. Sembra che il fatto fosse stato preceduto da un forte li-tigio fra i due.
Uomo di 34 anni, licenziato dal lavoro nel 2004 e separato dallamoglie da alcuni mesi, uccide con un colpo di fucile il padre di 77anni, col quale conviveva, e poi si uccide con la stessa arma.
Uomo di 44 anni, artigiano, uccide la moglie di 39 anni, separata,e la figlia di anni 7 a colpi di fucile e poi si uccide con la stessaarma.
Uomo di 49 anni, autotrasportatore, uccide nel sonno la mogliedi 44 anni e la figlia di 10 anni, con una mazza da muratore, fe-risce gravemente i due figli maschi di 16 e 14 anni con lo stessomezzo, e poi si uccide tagliandosi la gola con un coltello: era os-sessionato per il calo del consumo della carne di pollo che gliaveva ridotto notevolmente le commesse di trasporto delle carnisuddette a causa della crisi del settore connessa alla virosi avia-ria.
Uomo di 60 anni uccide il nipote di 32 anni con un colpo di pi-stola, ferisce la cognata di anni 55 anni, e poi si uccide con uncolpo della stessa arma alla tempia. Pare ci fossero motivi d’in-teresse.
Uomo di 33 anni uccide con un colpo di pistola un uomo di anni32 e poi si uccide con la stessa arma. I due erano legati a vin-coli di antica amicizia: pare che - l’autore del fatto soffrisse didepressione.
Uomo di anni 80 uccide a colpi di pistola la sorella di anni 84 epoi si uccide con la stessa arma con un colpo alla tempia destradopo avere ucciso anche il cane.
Uomo di 34 anni, con una pistola cal.9, uccide la moglie ex cam-pionessa di sci incinta di tre mesi, dalla quale si era separato dacirca una settimana, alla quale attribuiva eccessiva trascura-tezza nell’allevamento del figlio di 2 anni; uccide anche il fratellodi lei di anni 32, e poi viene trovato morto a distanza dal luogodel duplice omicidio in luogo solitario con la pistola accanto. Invita aveva ripetutamente lasciato delle lettere in cui affermava:“uccido tutti e mi ammazzo”.
Tunisino di 41 anni uccide a coltellate la moglie gestante al terzoe poi ei toglie la vita lanciandosi dal vuoto dal terzo piano.
Uomo di 47 anni uccide la moglie di 43 anni con un colpo di pi-stola e poi si uccide con la stessa arma.
Uomo di 52 anni, impiegato comunale, uccide a colpi di pistolail sindaco del luogo e poi si uccide con la stessa arma.
Novembre 2005
Novembre 2005
Gennaio 2006
Gennaio 2006
Febbraio 2006
Febbraio 2006
Febbraio 2006
Marzo 2006
Maggio 2006
Agosto 2006
Settembre 2006
Ottobre 2006
Porto Viro (RO)
San Felice Can-cello (CE)
S. Vito di Ca-dore (BL)
Precenico (UD)
Grezzana (VR)
Rhemes SaintGeorges (AO)
Chieti (CH)
Termini Imerese(PA)
Les Crosets(Svizzera)
Bologna
Mantova
Villa Bartolomea(VR)
I moventi dei delitti in questione sono stati soprattutto passionali, in rari casianche motivati da interessi economici o per pietà verso la vittima dell’omicidio.Da una mozione presentata alla Camera dei Deputati della nostra Repubblica nel-l’ottobre 2004 dagli onorevoli Carla Mazzucca e Marco Boato si apprende che lecoppie familiari in crisi uccidono in media 15 bambini l’anno. La sindrome psi-chica responsabile è definita “sindrome del padre allontanato” ovvero “sindrome daalienazione parentale”, così nota da studi di R.A. Gardner e caratterizzata da de-pressione, aggressività, raptus conducente al suicidio o all’omicidio-suicidio. Nel94% dei casi delle separazioni coniugali il coniuge affidatario è la madre, il che puòprodurre nell’uomo dolore psichico ed atti di violenza contro se stesso e controgli altri: in elevatissima percentuale dei casi (98% circa); sono perciò i padri gli au-tori dell’omicidio-suicidio. Nel corso dell’ultimo decennio, per la fine della con-vivenza e per i figli contesi furono uccisi 158 minori (v. La Repubblica, 27.10.2004,pag. 25), cui va aggiunto il bambino ucciso nel 2007.
Non abbiamo nozione se siano state eseguite indagini necroscopiche e isto-logiche dei vari organi nei casi sopra menzionati.
Noi abbiamo osservato alcuni casi di omicidio-suicidio, non tutti compresinell’elenco della casistica riportata nel capitolo IV.1 della parte prima.
1) Un primo caso riguarda un uomo di anni 38 psicopatico che nel 1975, inMessina, uccise nel sonno il padre, di anni 58, commerciante, schiacciandogli latesta con un grosso masso. Fu ricoverato in manicomio (si era in epoca antece-dente alla promulgazione della legge n. 180/1978 che aboliva i manicomi). Unanno dopo, cioè nel 1976, eludendo la vigilanza del personale sanitario riuscì adevadere. Fu rinvenuto cadavere a fianco della strada ferrata in prossimità dellacittà maciullato da un treno in corsa. La sua testa, staccata dal corpo, era schiac-ciata e l’encefalo, in sfacelo, si trovava a distanza di circa 20 metri dal corpo stesso,
217
Fisiopatologia dello stress
Marzo 2007
Settembre 2007
Medico endocrinologo di 54 anni uccide a coltellate il figlio di 11anni e poi si suicida buttandosi sotto un treno in transito neipressi di Pisa. Pare esistessero dei dissapori con la moglie,madre del piccolo, con intenti di separazione e che l’uomostesse attraversando un periodo di depressione anche per la re-cente morte dei genitori, che vivevano in Calabria.
Noto filosofo francese, di anni 84 (Andrè Gorz), amico e allievodi Jean-Paul Sartre, uccide la moglie di anni 82, da tempo sof-ferente per un processo neoplastico e si suicida con lo stessomezzo, peraltro non specificato nella stampa quotidiana che nedà notizia. Aveva scritto lettere di addio ad i suoi amici ed unmessaggio sulla porta del suo appartamento: “Avvertite i gen-darmi”. Le salme dei coniugi giacevano l’una accanto all’altra.Stante l’assenza di lesioni esterne di alcun genere è da presu-mere che la morte sia stata cagionata da veneficio consensuale.
Lucca
Parigi
il quale presentava multiple lesioni sfacelative e fratturative. Si è supposto che ilsoggetto, in un momento di lucidità mentale, abbia avuto contezza e ricordo del-l’uccisione paterna e delle sue modalità ed abbia di proposito disposto la testasulla strata ferrata in modo da autopunirsi con simile modalità.
2) Nel 1989 una donna (D.B.M.)di 73 anni uccise, al risveglio mattutino, il ma-rito (M.D.) di anni 78, inconsapevole, con la somministrazione di stricnina nelcaffè e poi si suicidò con lo stesso mezzo. La donna presentava una singolare,poco comune, complessa disendocrinia dominata da un abito cushingoide (ad-dome voluminoso con strie rubre - essa non aveva avuto mai gravidanze), iper-trofia bilaterale dei surreni, aree basofile alternate a campi eosinofili nell’ipofisi,ove al limite fra i due lobi si evidenziava un circoscritto microscopico craniofa-ringioma, degranulazione delle cellule nervose nei nuclei paraventricolari e so-praottici dell’ipotalamo; ipotrofia della corteccia frontale con cariolisi e tigrolisiin numerosi neuroni sia nella corteccia cerebrale che nella corteccia cerebellare,nel ponte, nel bulbo e nel corpo striato, iperplasia astrocitaria. Coesistevano –eventi di non comune riscontro - un reperto tiroideo di tipo basedowiano (ti-roide d’aspetto iperfunzionante con noduli linfatici interstiziali (Fig. 45), iper-prolattinemia documentata dalla presenza di secrezione lattea negli acinighiandolari mammari, peraltro indovati in aree fibrotiche; assenza di glicogeno nelfegato, iperattività a carattere cronico della midollare surrenale senza segni di so-vrastimolazione acuta (Fig. 46, 47).
Da notizie successivamente apprese risultava che la donna era gelosissima delmarito, più anziano di lei di 5 anni: sembra che lei avesse notate particolari at-tenzioni che il marito dedicava ad una giovane impiegata che lavorava nel loro ne-gozio. La conclusione che il marito fosse del tutto all’oscuro dei propositi omicididella moglie nei suoi confronti emergeva dalla assai modesta stimolazione dellacorteccia e della midollare dei surreni, da correlare esclusivamente alle crisi con-vulsive realizzate dall’avvelenamento da stricnina. Simile reperto surrenalico nel-l’avvelenamento da stricnina era stato osservato in precedenti ricerchesperimentali condotte da uno di noi su ratti e cavie (39). Nell’encefalo del maritovi erano note di atrofia senile, mentre i nuclei ipotalamici apparivano normali.
Non vi può essere alcun dubbio che le complesse preesistenti disendocrinieabbiano ipertrofizzato il sentimento di gelosia al punto da impedire, in sede ce-rebrale già menomata dagli effetti nocivi dei glicorticoidi, degli ormoni tiroidei eda un presumibile abbassamento del tasso glicemico, come indicato dall’assenzadi glicogeno nel fegato, gli impulsi aggressivi certamente maturati in diversi giornie non esplosi repentinamente, come risulta dalla mancanza di segni di sovrasti-molazione acuta nella midollare surrenale (Fig. 47).
Marcello Aragona, Francesco Aragona
218
3) Nel dicembre 1992 un uomo (S.G.) di anni 34, regolarmente sposato, padredi tre figli, uccise con un colpo di pistola la sua amante (G.M.) di anni 31, an-ch’essa regolarmente sposata e madre di due bimbi, e poi si uccise con la stessaarma con un colpo alla tempia destra. Dalla ricostruzione medico-legale del fattoè emerso che l’uomo si avvicinò alla donna, forse abbracciandola, e le sparò abruciapelo un colpo di pistola calibro 7.65 alla regione temporo-zigomatica sini-stra. Il proiettile, diretto verso l’alto, attraversò la scatola cranica, determinandoun vasto tramite emorragico nell’encefalo, con lesioni anche ipotalamiche,uscendo dalla regione temporale sinistra. L’uomo quindi rivolse l’arma contro sestesso esplodendo un colpo a contatto alla regione temporale destra. Da notizieapprese la morte della donna non fu immediata, essa fu soccorsa da familiari cheavevano udito gli spari e trasportata ad un vicino ospedale, ove però giunse ca-davere. Per l’uomo, invece, la morte fu istantanea.
Pare che la donna avesse deciso di interrompere quel rapporto per ritornare avivere con la sua famiglia e di questo avesse reso edotto l’amante. Essa non eraperciò consenziente alla fine tragica che l’aspettava, decisa autonomamente dal-l’uomo, che si presentò armato di pistola all’appuntamento.
I dati degli esami anatomo-istologici hanno confermato quanto sopra circa ilmancato consenso della donna alla sua morte violenta. Infatti, nell’uomo la no-tizia della cessazione del rapporto apparve inattesa ed improvvisa per aver pro-dotto in lui gli effetti di una forte emozione, come di una perdita affettivairreparabile. I quali effetti risultano:
a) in primo luogo dalle lesioni cardiache miocitolitiche, tra le quali alcune acarattere iperacuto in lui riscontrate, espresse dalla presenza di cardiociti in necrosinon ancora riassorbiti (Fig. 48, 49), non presenti con lo stesso carattere di acuzienella donna (in essa esistevano focolai di miocitolisi coagulativa di data non re-centissima, caratterizzati da sparse lacune connesse al riassorbimento dei cardio-citi necrotici, ma non ancora compattate). Al riguardo si deve ricordare che, adifferenza della necrosi cardiaca infartuale evidenziabile non prima di 20-24 oredall’inizio dell’infarto, l’effetto cardiotossico da catecolamine è apprezzabile dopopochi minuti com’è documentato da indagini sperimentali (40-44): la noradrena-lina liberata direttamente nei tessuti dalle terminazioni simpatiche periferiche ri-mane attiva solo per pochi secondi; la noradrenalina e l’adrenalina, immesse incircolo dalla midollare surrenale, rimangono attive per 10-30 secondi, dopo diche la loro attività va decrescendo in uno-vari minuti (45).
b) In secondo luogo, dal reperto della midollare surrenale ove nell’uomo tuttele cellule cromaffini, che in parte avevano nuclei ipertrofici e ipercromici, eranodiminuite di volume, degranulate e totalmente vacuolizzate (Fig. 50) come da at-tivazione cronica con marcata sovrastimolazione acuta, ed anche nella corticale
219
Fisiopatologia dello stress
vi erano immagini di analogo significato funzionale: reperti che si sogliono os-servare nelle forti ed improvvise distruttive emozioni, come, ad esempio, nel ter-rore, nella paura. Inoltre, il soggetto era ipertiroideo (Fig. 51), presentavaalterazioni regressive delle cellule nervose, specie nella corteccia cerebrale e nellacorteccia cerebellare. Per cui, a differenza del comune suicidio e del precedentecaso di omicidio-suicidio, in questo omicida-suicida persisteva una marcatissimaed acuta stimolazione delle ghiandole surrenali, specie della midollare: fenomenoda ritenere connesso, insieme col reperto cardiaco, all’improvviso, doloroso, im-pulso omicida.
c) Dal fatto che nella donna, che pur presentava, in correlazione allo stato psi-cologico connesso alla relazione trasgressiva, tutti i segni dello stress cronico: nelcuore, come già detto, e nelle ghiandole endocrine, furono osservati solo mode-sti segni di attivazione acuta della midollare surrenale che per i loro caratteri mor-fologici erano da attribuire all’attimo dell’inattesa aggressione da parte dell’amantee fors’anche allo stato agonico, ancorchè di assai breve durata. E’ da escludere chelo stato agonico abbia avuto alcun ruolo sulla funzione della corteccia surrenaleper la distruzione traumatica dell’ipotalamo.
Quanto esposto sin qui in merito alla casistica cadaverica studiata con meto-diche istofisiologiche ed istopatologiche nella maggior parte degli organi (speciesistema nervoso centrale, organi endocrini ed a funzione cardio-circolatoria e me-tabolica) consente valutazioni di ordine psicologico, antiche e recenti; della vittimae se questa era quella designata ovvero uccisa per errore o perché presente ca-sualmente nel luogo del delitto. Riteniamo perciò che gli orientamenti indagativiattuali, condotti mediante accertamenti esclusivi su dati raccolti nel corso del so-pralluogo, anche se assai preciso e compiuti da personale altamente specializzatoin laboratori di alto valore scientifico (RIS delle forze dell’ordine) non possonocondurre sempre alla dinamica causale esatta sia nei casi di omicidio, che in quellidi suicidio e di omicidio-suicidio.
Bibliografia1. Hoge C.W., Castro C.A., Messer S.C., Combat duty in Iraq and Afghanistan mentalhealth problems, and barriers to care. New England J. Med. 351, 13-22, 2004.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
220
2. Stengel E., Selbstmord und Selbstmordversuch. In: Gruhle et al., Psychiatrieder Gegenwart, Vol. III. Springer, Berlin, 1961, p. 51.
3. Franchini A., Aspetti medico-legali del suicidio. In: Suicidio e Tentato Suicidio in Italia.Giuffrè, Milano, 1967, p.367.
4. Somogyi S., Il suicidio in Italia, 1864-1962. Analisi statistica. In: Suicidio e TentatoSuicidio in Italia. Giuffrè, Milano, 1967, p. 3.
5. Bazzi T., Abnormi psichici. In: Bini L., Bazzi T., Trattato di Psichiatria, II, Vallardi,Milano, 1967.
6. Ey H., Le suicide pathologique. In: Études Psychiatriques. Tome II, Desclée de Brou-wer, Paris, 1950.
7. Deshaies G., Psicologia del Suicidio. Astrolabio, Roma, 1951.8. Trethowan V.H., Cobb S., Neuopsychiatric aspekts of Cushing’s syndrome. AMA
Arch. Neurol. Psychiatry 67, 283- 309, 19529. Spillane J., Nervous and mental disorders in Chusing’s syndrome. Brain 74, 72-93, 1954.10. Starkmann M.N., Schteingart D.E., Shork M.A., Depressed mood and other psy-chiatric manifestations of Cushing’s syndrome: relationship to hormone levels. Psycho-som. Med. 43, 3-18, 1981.
11. Bunney W.E., Fawcett J.M., Possibility of the biochemical test for suicide potential.Arch. Gen. Psychiatry 13, 232-239, 1965.
12. Bunney W.E., Fawcett J.M., Davis J.M., Gifford S., Further evaluation of urinary17-hydroxy-corticosteroids in suicidal patients. Arch. Gen. Psychiatry 21, 138-150,1969.
13. Krieger G., The plasma level of cortisol as a predictor of suicide. Dis. Nerv. Syst. 35,237-240, 1974.
14. Levy G., Hansen E., Failure of the urinary test for suicide potential. Arch. Gen. Psy-chiatry 20, 415-418, 1969.
15. Trasman L., Tybring G., Åsherg M. et al., Cortisol in the CSF of depressed and sui-cidal patients. Arch. Gen. Psychiatry 37, 761-767, 1980.
16. Coryell W., Schlesser M.A., Suicide and the dexamethasone suppression test in unipo-lar depression. Am. J. Psychiatry 138, 1120-1121, 1981.
18. Targu S.D., Rosen M.A., Capodanno A.E., The dexamethasone suppression test in sui-cidal patients with unipolar depression. Am. J. Psychiatry 140, 877-879, 1981.
19. Van Wettere J.P., Charles G., Wilmotte J., Test de function a la dexamethasone et sui-cide. Acta Psychiatr. Belg., 83, 569-578, 1983.
20. Nemeroff C.B., Owens M.J., Bissette G., Andorn A.C., Stanley M., Reduced cor-ticotropin releasing factor binding sites in the frontal cortex of suicide victims. Arch. Gen.Psychiatry 45, 577-579, 1988.
21. Bachus S.E., Hyde T.M., Akil M., Weickert C.S., Vawter M.P., Kleinman J.E.,Neuropathology of Suicide. Ann. New York Acad. Sci. 836, 201-219, 1997.
221
Fisiopatologia dello stress
22. Sastre M., Escriba P.V., Reis D.J., Garcia-Sevilla J.A., Decreased number and im-munoreactivity of I2-imidazoline receptors in the frontal cortex of suicide victims. Ann.New York Acad. Sci. 763, 520-522, 1995.
23. Garcia-Sevilla J.A. et al., Immunodetection and quantitation of imidazoline receptor pro-teins in platelet of patients with major depression and in brain of suicide victims. Arch.Gen. Psychiatry 53, 803-810, 1996.
24. Biegon A., Fieldust S., Reduced tyrosine hydroxylase immunoreactivity in locus coeru-leus of suicide victims. Synapse 10, 79-82, 1992.
25. Ordway G.A., Smith K.S., Haycock J.W., Elevated tyrosine hydroxylase in the locuscoeruleus of suicide victims. J. Neurochem. 62, 680-685, 1994.
26. Arango V., Underwood M.D., Mann J.J., Fewer pigmented locus coeruleus neurons insuicide victims: preliminary results. Biol. Psychiat. 39, 112-120, 1996.
27. Stockmeyer C.A., Neurobiology of serotonin in depression and suicide. Ann. NewYork Acad. Sci. 836, 220-232, 1997.
28. Kvetñansky R., Pacák K., Fukuara K., Viskupic E., Hiremagular B., NankovaB., Goldstein D.S., Sabban E.L., Kopin I.J., Sympathoadrenal system in stress. Inte-ractions with the hypothalamic-pituitary-adrenocortical system. Ann. New York Acad.Sci. 771, 131-158, 1995.
29. Ringel E., Der Selbstmord. Maudrich, Vienna, 1953.30. Jaspers K., Psicopatologia generale. Il Pensiero Scientifico, Roma, 1964.31. Chiodi V., Casistica medico-legale sul suicidio nei fanciulli e nei giovani. Arch. Antr.
Crim. Psich. Med. Leg. 64-65, 67, 1945.32. Schneider K., Psicopatologia clinica. Sansoni, Firenze, 1954.33. Giorda R, Merli S., Suicidio e stato mentale del suicida. Zacchia 34, f. 1, 1959.34. Sachar E.J., Psychological homeostasis and endocrine function. In: Mandel A.J., Man-
dell M.P., Psychochemical Research in Man. Academic Press, New York, London,1969, p. 219.
35. Borri L., Lesività meccanico-asfittiche. In. Borri L., Cevidalli A., Leoncini F., Trat-tato di Medicina Legale. Vallardi, Milano, 1924, v. II, p. 678.
36. Asmundo A., Aragona M., Gualniera P., Aragona F., La morte improvvisa da ipo-glicemia. Pathologica, 87, 603, 1995.
37. Franchini A., Medicina legale. X Ed., CEDAM, Padova, 1985, p.440-441. 38. Masotti G., Magliona B., Del Sante M., L’omicidio-suicidio nel settorato medico-le-gale parmense (1983-2002). Riv. It. Med. Leg. 25, 1107, 2003.
39. Aragona F., Patogenesi del blocco ghiandolare endocrino in alcuni avvelenamenti. Studiosperimentale. Atti XX Congr. Naz. Soc. It. Med. Leg. Trieste, 8-11 sett. 1966,p.99-260.
40. Csapo Z., Dusez J., Rona G., Early alterations of cardiac muscle cells in isoprotere-nol-induced necrosis. Arch. Pathol. 93, 356, 1972.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
222
41. Haft J.I., Kranz P.D., Albert F.J., Fani K., Intravascular platelet aggregation in theheart induced by norepinephrine. Microscopic studies. Circulation 46, 698, 1972
42. Raab W., Stark K., MacMillan W.H., Gigee W.R., Sympathogenic origin and antia-drenergic prevention of stress induced myocardial lesions. Am. J. Cardiol. 8, 203, 1961.
43. Rosenblum I., Wohl A., Stein A.A., Studies in cardiac necrosis. Production of car-diac lesions with sympathomimetic amines. Toxicol. Appl. Pharmacol. 7, 1, 1965.
44. Schenk E.A., Mos A.J., Cardiovascular effects of sustained norepinephrine infusions.Morphology Circ. Res. 18, 605, 1966.
45. Ganguly P.K., Catecholamines and Heart Disease. CRC Press. Boca Raton, AnnArbor, Boston, London, 1991.
223
Fisiopatologia dello stress
Capitolo X
Utilità dello studio clinico e medico-legale in situazioni di stresscompreso anche quello psichico ed esistenziale risarcibile
Note diagnostiche e terapeutiche
Quanto esposto sin qui ha valore non soltanto nel sollecitare una quanto piùpossibile corretta e completa conduzione delle indagini necroscopiche, ai finidella valutazione dell’attualità di condizioni di stress e l’eventuale rapporto cau-sale fra dette condizioni e l’evento mortale, ma consente anche nel vivente delleriflessioni sull’utilità dello studio clinico e medico-legale degli stessi organi ed ap-parati a fini terapeutici e risarcitori, ivi compreso il danno psichico ed esistenzialerisarcibile (1, 2, 3) quando dipendente da situazioni di stress (disordine post-trau-matico da stress o DPTS, mobbing, nonnismo, superlavoro, ecc.).
Sono in particolare indispensabili indagini specifiche sull’encefalo (vedi capi-toli I, II,III, seconda parte, ove sono menzionati anche i procedimenti indagativiin vivo); sui secreti delle ghiandole a secrezione interna in particolare dell’ipofisi,delle surrenali, sia midollare che corticale, della tiroide, nonché funzionali sul fe-gato, pancreas, milza, reni (vedi capitolo IV della parte prima); su eventuali lesionidel canale digerente e delle ghiandole genitali (vedi capitolo VII della parte se-conda); su manifestazioni di insufficienza del sistema immunitario (vedi capitoloV della parte seconda); su eventuali danni cardiaci (vedi capitoloVI della parteseconda).
Pertanto, occorre impiegare le indagini che sono entrate nel patrimonio esplo-rativo clinico moderno di cui vi è ampia trattazione nella recente letteratura (4, 5,6), la quale, ad esempio, per quanto riguarda il cuore valorizza non solo le co-muni indagini da tempo in uso (ECG, Rx, dosaggi enzimatici, ecc), ma anchequelle specifiche ecografiche: ecotomografia, Doppler continuo, eco-Doppler,color-Doppler, ecografia intravascolare; nonché la tomografia assiale compute-rizzata (TAC); la risonanza magnetica nucleare (RMN) e ancor più la risonanzamagnetica funzionale (fRM): le quali, nel loro insieme, consentono l’acquisizionedi importanti informazioni dinamico-funzionali, le condizioni anatomiche deivasi, l’apprezzamento di reperti patologici endoluminali, parietali ed estrinseci,compresa l’esistenza di infarti parcellari.
Per quanto riguarda i pazienti affetti da tumori, cui già fugacemente accen-nato nel capitolo I della parte prima, i livelli di stress psico-fisico sono assai ele-vati per il notevole impatto della malattia, che è spesso drammatico e destruente,ma anche per i connessi risvolti emotivi, simbolici che sconvolgono la loro vita
225
evocando l’idea della morte. Dati della letteratura riportano che lo stato psicolo-gico (ansia, depressione, ecc.) di pazienti con tumore può avere influenze nega-tive sia sul sistema immunitario, come già ricordato in precedenza per qualsiasitipo di stress, sia sullo stato biologico della malattia in sé e sulla propria soprav-vivenza (7,8). La presenza e la consapevolenza di “avere un cancro” varia le mo-dalità di concepire se stessi nel mondo e di relazionarsi con esso. Cambia lapropria rappresentazione simbolica e la propria produzione immaginativa ed in-conscia, alterando il linguaggio del corpo e la sua relazione con il mondo. Comeconseguenza di ciò si può arrivare alla perdita dei movimenti involontari, comegesti mancanti e significanti, asimmetria dei movimenti pendolari, in relazionealla sede del tumore, ecc. (9). Oggi non si può rimanere legati al concetto mec-canicistico della mente che comanda e del corpo che esegue, che rappresenta soloil supporto fisico che trasporta la mente. E’ necessario integrare questi elementiperché sono solo due aspetti della stessa medaglia.
Pertanto queste alterazioni dello schema corporeo con negazione, maschera-mento, discono- scimento o dissociazione di alcune aree corporee cariche di con-notati simbolici conflittuali sono spesso la sede somatica di vecchi traumi emotivinon risolti, di conflitti fra conscio ed incoscio, in cui la risposta fisiologica di at-tacco o fuga è stata inibita, non agìta, non completata (10). Ciò spesso comportauna struttura caratteriale che cronicamente si irrigidisce (11), che tende a disso-ciarsi dagli esiti dei traumi o a negarli per ridurne la sofferenza (10), con conse-guente carente attenzione ai propri bisogni, alla realizzazione del proprio sé, delleproprie esigenze, del proprio corpo, con tendenza ad orientarsi all’esterno (12).Questi aspetti, congiuntamente a tanti altri, sembrano giocare un ruolo impor-tante nel ridurre il controllo neuro-fisiologico su quella particolare area corporeain cui le cellule trasformate potrebbero essere più libere di proliferare e di essere“tollerate” dal sistema immunitario. Interessante sembra a questo punto il paral-lelismo di funzio-namento tra il sistema nervoso che riduce il controllo neuro-funzionale su di una particolare area corporea ed il sistema immunitario che èconsiderato un “organo di senso” (13), e che “tollera” cellule tumorali in accre-scimento.
1. Note di terapiaPer quanto riguarda questo aspetto, l’attenzione è stata essenzialmente rivolta
al trattamento delle conseguenze psicologiche e psichiatriche, posto che si trattadelle conseguenze patologiche più comuni degli stress. Per questo motivo si è ri-tenuto opportuno fare ricorso a sonniferi e tranquillanti, i quali, tuttavia, non ar-recano sostanziali benefici. In Francia, secondo Stora (14), annualmente sivendono più di 25 milioni di scatole di antidepressivi e 75 milioni di scatole di
Marcello Aragona, Francesco Aragona
226
tranquillanti. Analogamente sembra avvenire in Germania. In Francia più di 11milioni di persone non riescono a far fronte allo stress quotidiano e per questomotivo ricorrono ai farmaci suddetti. Secondo Stora (14), inoltre, sembrano es-sere più efficaci in questo campo: a) gli esercizi di rilassamento del corpo;b) i metodi di rilassamento mentale (meditazione: due sequenze di 10-20 minuti al
giorno); c) il rilassamento nell’acqua in una vasca speciale perfettamente isolata; d) metodi psicoterapici, i quali sono tuttavia efficaci soltanto in individui che hanno
la volontà di metterli in pratica. Se i metodi suddetti risultano inefficaci è ne-cessario rivolgersi a medici psichiatri, psicoanalisti, psicoterapeuti, psicoso-matisti.Nei pazienti oncologici è stato descritto un effetto positivo indotto da tecni-
che di rilassamento e visualizzazione guidate sullo stato psicofisico e sul sistemaimmunitario, anche con un rallentamento della crescita neoplastica ed un pro-lungamento della sopravvivenza (15-17). Ciò attraverso la mediazione del sistemapsico-neuro-endocrino-immunitario (7,18), compresa la liberazione di vari or-moni, tra i quali la serotonina (responsabile del “buon umore”).
A questo riguardo bisogna far presente che le tecniche che sfruttano la medi-tazione sembrano essere idonee ad influenzare gli ormoni dello stress: riduzionedella noradrenalina, regolazione della produzione del cortisolo, con aumentatasecrezione di melatonina (ormone del sonno) (19).
Secondo la nostra esperienza su pazienti oncologici abbiamo deciso di utiliz-zare varie tecniche ad orientamento psico-corporeo per permettere ai pazienti dientrare in contatto con le parti più profonde del proprio Sé, sia a livello psichico,inconscio, simbolico che somatico, vegetativo (si rimanda all’Appendice). Lavo-riamo prevalentemente con pazienti affetti da tumore della mammella per ripri-stinare il loro equilibrio psico-fisiologico, recuperare la completezza dello schemacorporeo e tentare di ripristinare, attraverso la stimolazione dell’emisfero cerebraledestro, la funzionalità del sistema immunitario. L’obiettivo principale è quello dimigliorare la qualità di vita. Al riguardo Davidson (20) scrive che la percezione dellasofferenza attiva la corteccia prefrontale destra, l’amigdala l’ippocampo e conse-guentemente i relativi assi immunoneurendocrini, substrato emozionale ed adat-tativo. Al contrario, immaginare la soluzione della sofferenza attiva la cortecciaprefrontale sinistra che riduce l’attivazione dell’amigdala e quindi quella neuro-endocrina, con estinzione della reazione psico-emotiva negativa e induzione sog-gettiva di benessere: l’esperienza della realtà può essere modificata cambiando ilsubstrato neuronale dell’esperienza stessa (20). L’utilizzazione terapeutica di que-sti meccanismi induce un immediato effetto sul benessere dei pazienti. Per esem-
227
Fisiopatologia dello stress
pio, con la meditazione della compassione, che attiva la corteccia prefrontale si-nistra con alta sincronizzazione interemisferica si induce uno stato di profondobenessere. Anche metodi cognitivo-comportamentali, attraverso la riprogram-mazione delle credenze malsane che sottendono l’esperienza di sofferenza stessa,è possibile indurre un miglioramento della qualità della vita molto rapidamente(17), anche con attenuazione dell’ansia, della depressione, della risposta da stress(20).
Le tecniche di intervento che si possono utilizzare in campo psiconcologicosono estremamente varie ed eterogenee, anche se alcune sembrano più utili e spe-cifiche (21) a questo scopo.
Tra queste alcune sono più adatte a fornire un supporto psicologico ed uncontrollo dello stress per migliorare la qualità della vita, altre sono più orientatea modificare quei meccanismi conosciuti che possono facilitare la progressionetumorale, inclusa la tolleranza immunitaria, stimolando le risorse psico-fisichepersonali. In particolare noi stiamo utilizzando, in pazienti con tumore mamma-rio, in fase di remissione clinica, varie tecniche ad orientamento transpersonalepsico-corporeo di gruppo (bioenergetica, meditazioni e visualizzazioni guidate,metodo Simonton, disegno creativo, ecc.). L’uso di una particolare tecnologia psi-coacustica, che induce una sincronizzazione dell’attività elettrica fra i due emi-sferi cerebrali, a bassa frequenza, è utilizzabile per facilitare uno stato meditativoe di rilassamento profondo, riducendo il controllo cognitivo inibitore ed attivandoil pensiero destro, creativo, simbolico; ridurre situazioni di stress e di squilibripsico-biologici, migliorare la qualità di vita e la funzionalità del sistema immuni-tario (tecnologia del binaural beats Metamusic®, Hemi-Sync®, Monroe Institute.Virginia USA).
Sviluppando le potenzialità creative ed immaginative della mente, caratteristi-che dell’emi-sfero cerebrale destro, si cerca di ridurre gli effetti di gravi traumiemotivi recuperando la consapevolezza del proprio corpo (felt sense) (13), tra-sformando le proprie “credenze malsane” in più utili e sani processi cognitivi(17), attenuare gli stati di stress, stimolare delle risorse di auto-guarigione dell’or-ganismo, ecc., nonché migliorare lo stato generale di salute e di benessere psico-fisico.
I risultati preliminari dell’applicazione di queste tecniche sono molto promet-tenti, specie per quando riguarda il notevole miglioramento della qualità della vita.Infatti tutte le pazienti in studio (10 pazienti con tumore della mammella in re-missione clinica, parziale o completa: con esclusione dei casi con metastasi cere-brali, con precedenti episodi epilettici, con disturbi uditivi perché controindicaticon la binaural beat technology e quelli in trattamento antiblastico per la sua interfe-renza con il sistema immunitario) hanno riferito un notevole miglioramento del
Marcello Aragona, Francesco Aragona
228
benessere soggettivo in vari aspetti della loro qualità della vita, a volte chiedendoesplicitamente la continuazione del trattamento. Riportavano frasi come queste:“la mia qualità di vita è migliorata”, “la mia autostima è cresciuta”, “la mia vita è più di-versificata”, “mi sento felice e gioiosa”, “il gruppo è stato magnifico”, “il gruppo è stato bellis-simo, le persone che si sono messe in discussione mi hanno dato molto”, “mi sono passate quasitutte le paure”, “sono più sicura di me stessa”, “mi rendo conto che le cose che faccio ho piacerea farle e me la godo di più”, “se mi devo prendere le mie libertà ora me le prendo, prima misembrava ingiusto”, “ho cambiato molte cose in questi mesi e mi sento meglio, più tranquilla,ottimista, positiva”, “mi sento più attenta a me stessa, mi sono stancata di essere così ‘tollerante’rispetto a tante cose ed anche tanto meno appesantita da pensieri, doveri, ho cominciato a scrol-larmeli dalle spalle, sono grosse conquiste”, “quando ho visto il test (SEIQoL, sulla qualitàdella vita, alla rivalutazione) sapevo che avrei risposto diversamente, perché io sono diversa”.
Gli indici globali di qualità della vita non mostrano particolari differenze traprima e dopo i trattamenti come evidenziato dal test SEIQoL per la qualità dellavita. Si tratta di un test narrativo in cui è il paziente stesso che inserisce i 5 più im-portanti “desiderata” per la propria qualità della vita.
Analizzando invece la qualità delle risposte relative ai “desiderata” che le pa-zienti hanno inserito si è potuto osservare una drastica trasformazione dei desi-derata che inizialmente erano focalizzati prevalentemente sui bisognifondamentali e sulla salute, poi invece orientati maggiormente ai bisogni più evo-luti relativamente all’autostima e alla realizzazione di sé. Ciò è spiegabile per ilnotevole lavoro di elaborazione psicoterapeutica, sia a livello fisico che emotivoe mentale, effettuata nel gruppo relativamente alle problematiche della malattia edel suo impatto sulla vita personale e di relazione.
Secondo il modello della psicologia transpersonale il concetto di salute ottimalepuò essere schematicamente descritto su cinque livelli integrati di benessere: fi-sico, emotivo, mentale, esistenziale, spirituale (21). Il primo livello è relativo ai bi-sogni fondamentali, dalla sofferenza fisica alla sopravvivenza. Una volta chequeste esigenze del benessere fisico siano soddisfatte è possibile per il soggettoportare attenzione al livello successivo del benessere emotivo e così via, del be-nessere psicologico, di autostima (benessere esistenziale), della realizzazione delsé (benessere spirituale).
Analizzando gli stessi dati del SEIQoL da questo punto di vista si osserva unariduzione drastica del peso relativo dei desiderata relativi alla componente fisica(dei bisogni fondamentali) e di quella emotiva (bisogni di sicurezza) dopo tratta-mento. Parallelamente sono aumentati i desiderata relativi agli aspetti esistenziali(bisogni di autostima) e spirituali (bisogni di realizzazione del sé).
In conclusione, su questi soli dati il notevole miglioramento del benessere ri-portato dalle pazienti dopo 8 mesi di trattamenti psico-corporei ad orientamento
229
Fisiopatologia dello stress
transpersonale e l’esplicita richiesta delle pazienti di continuare queste terapie in-dica la necessità di strutturare in modo più stabile questa risorsa per i pazientioncologici (8).
I benefici effetti connessi ad adeguati trattamenti su base psicologica su sog-getti esposti a stress distruttivi sono confermati dall’esperienza personale di HansSelye, lo scienziato che identificò lo stress e per primo descrisse le sue conse-guenze patologiche. All’età di 65 anni Selye ammalò di un reticolosarcoma, neo-plasia notoriamente ad esito solitamente infausto e di conseguenza altamentestressante. In un’intervista (22) Selye si espresse come riuscì a reagire in modo deltutto eccezionale: ”Io ero sicuro di essere prossimo a morire, così dissi a mestesso: tutto benissimo in questo momento, questo è quasi il più assolutamentepeggiore affare che possa accaderti, ma qui vi sono due vie per sorreggerti; delledue l’una: o si va verso una sensazione simile ad un miserevole candidato in rigaper la morte e gemere quasi un anno, o diversamente tentare di ottenere dallavita adesso quanto più possibile. Io ho scelto questa seconda via perché sono unlottatore ed il tumore mi ha fornito il più grande conflitto della mia vita. Io l’hopreso come un esperimento naturale che mi ha spinto verso il test definitivo seio ho ragione o torto. Quindi è successa una strana cosa: un anno è trascorso,poi due, quindi tre e vedo cos’è successo. E’ risultato che io ero quella fortunataeccezione…”.
In caso di morte, il rapporto causale con lo stress dev’essere dimostrato me-diante un esame accurato, macroscopico ed istologico di tutti i visceri, con spe-ciale attenzione all’encefalo, compresi i nuclei ipotalamici con metodi idonei adevidenziarne la neurosecrezione, alle ghiandole a secrezione interna, soprattuttoall’ipofisi (neuro- e preipofisi), alle surrenali a livello della midollare e dei varistrati della corticale con tecniche idonee, peraltro assai semplici (vedi capitolo IVdella parte prima), alle ghiandole genitali (arresto maturativo della linea seminalenei testicoli, degenerazione cistica nelle ovaie), al fegato (stato del glicogeno), alcuore a livello del miocardio ventricolare e settale e delle coronarie, ai reni, agliorgani linfoidi (tonsille, timo o eventuali resti timici, milza, linfonodi), allo sto-maco e all’intestino.
Bibliografia 1. Buzzi F., Vanini M., Il Danno Biologico di Natura Psichica. CEDAM, Padova, 2001.2. Mariotti P., Toscano G., Danno Psichico e Danno Esistenziale. Giuffrè, Milano,
Marcello Aragona, Francesco Aragona
230
2003.3. Cendon P., Zivig P., Il Risarcimento del Danno Esistenziale. Giuffrè, Milano, 2003.4. Negri M., Progressi. I. Fisiopatologia Clinica Diagnostica. Farmacoterapia. Vol. I e
II. UTET, Torino, 2002.5. Pigoli G., Gli esami di laboratorio. Prescrizione e interpretazione. UTET, Torino, 2003.6. Caimi V., Tombesi M., Medicina Generale. UTET, Torino, 2003. 7. Aragona M., Il sistema Psico-Neuro-Endocrino-Immunitario in Oncologia. Rivista Ita-
liana di Oncologia, XV, 5-6:103-15,1988.8. Aragona M., Aspetti Psicobiologici di pazienti con tumore della mammella: relazioni conla sopravvivenza. Relazione all’VIII Convegno Nazionale della SIPO (SocietàItaliana di Psico-Oncologia) “L’integrazione tra cure mediche, trattamento farmaco-logico e intervento psicologico in oncologia”. Acireale, Catania. 7-11 Ottobre 2003.Atti del convegno a cura di Lucia Toscano. Lorenzo Strano, Catania, pp. 101-103, 2004.
9. Godard H., Matino G., Motion ed E-motion in Oncologia: una lettera integrata del lin-guaggio del corpo e della sua relazione con il mondo. In Bellani M.L., Morasso G.,Amadori D., Orrù W., Grassi L., Casali P.G., Bruzzi P., Psiconcologia, Masson,Milano, p.875-881, 2002.
10. Levine P., Traumi e shock emotivi. Macroedizioni. Diegaro di Cesena (FO), 2002.11. Lowen A., Arrenderci al Corpo. Astrolabio, Roma, 1994.12. Odoul M., Dimmi dove ti fa male e ti dirò perché. Edizioni I punti d’incontro, Vi-
cenza, pp.98-99, 2001.13. Blalock J.E., A molecular basis for bidirectional communication between the immune andneuroendocrine systems. Physiol. Review 69, 1 Jan. 1989.
14. Stora J.P., Lo Stress. Carocci, Roma, 2004.15. Fawzy F.I., Psychosocial interventions for patients with cancer: what works and what doe-sn’t. Eur. J. Cancer, 35 (11), 1559-64, 1999.
16. Spiegel D., Psychosocial intervention in cancer. J. Natl. Cancer Inst. 85, 1198-1205,1993.
17. Simonton C., Simonton S., Creighton J., Star bene nuovamente. Ed. Nord-Ovest.1978.
18. Ader R., Cohen N., Felten D., Psychoneuroimmunology: Interactions between the ner-vous system and the immune system. The Lancet 345, 99-103, 1995.
19. Carosella A., Bottaccioli F., Meditazione, Psiche e Cervello. Rotolito Lombarda(MI) 2003.
20. Davidson R. J., Van Reekum C., Emotion is not one thing. Psychological Inquiry,16, 16-18. 2005.
21. Vaughan F.E., Spiritualità e salute nella psicologia transpersonale. Cittadella Ed.,1989.
231
Fisiopatologia dello stress
APPENDICE
La via transpersonale nella gestione dello stress in oncologia
Marcello Aragona
Come già descritto nei capitoli precedenti, la sofferenza indotta dallo stress di-pende prevalentemente da come l’evento, o gli eventi stressanti, sono elaborati dalsoggetto interessato, nel tentativo di adattarsi all’ambiente, nel miglior modo pos-sibile. Le modalità di elaborazione sono estremamente variabili, avvengono a piùlivelli, sia in modo consapevole che inconscio, nell’ambito del continuum che ini-zia con la percezione dell’evento, variamante modulato da innumerevoli filtri fi-sici-emotivi-mentali, ecc. che tengono conto dell’intera storia genetica e biograficadel soggetto, per l’attuazione di comportamenti finalizzati all’adattamento ai varilivelli dell’essere: dal fisico, all’emozionale, al mentale, al sociale, allo spirituale.
Un modello molto interessante per esplorare questi meccanismi è quello dellapatologia oncologica, anche per la possibilità di verificare gli effetti terapeutici divarie tecnologie che si possono applicare.
Il disagio in oncologiaLa sola parola “cancro” è considerata, nel linguaggio comune, sinonimo di
morte, fine della vita, con inimmaginabile sofferenza. Nonostante gli enormi pro-gressi della medicina e dell’oncologia, la percezione comune è sempre focalizzatasulle ancora troppe persone che muoiono di questa malattia ed ancora con grandisofferenze. È una sofferenza enorme che coinvolge tutti, a partire dalle personeche si ammalano di tumore, ai familiari e conoscenti, al personale sanitario, a chientra in contatto con questa realtà, spesso anche attraverso i mezzi di comunica-zione, che mirano di più alla spettacolarizzazione che alla crescita personale e so-ciale. Coinvolge le singole persone a livelli differenti di consapevolezza, sia allivello cosciente che a quello inconscio, subliminale e quindi più difficilmente ri-conoscibile.
Ho sperimentato direttamente questa sofferenza in tanti anni di lavoro in on-cologia come medico e ricercatore nel campo della psico-neuro-endocrino-immunologia dei tumori, presso il Dipartimento di Oncologia Medicadell’Università di Messina. Cercare di trovare un senso alla sofferenza delle per-sone malate di cancro ed a quella che cominciavo a provare io stesso, stando vi-cino a loro, mi ha guidato in questi anni attraverso un percorso parallelo dicrescita, tra ricerca scientifica medica e psicologica, tra assistenza e mia crescitapersonale. Scoprivo che la depressione e lo stress hanno un ruolo nella lunga sto-
233
ria naturale dei tumori, dalla loro comparsa, alla crescita e progressione delle cel-lule neoplastiche, nella tolleranza immunitaria, ma anche nella qualità della vita(Aragona 1987-2006). Ma continuavo a non comprendere il senso di tutto ciò, delperché c’è tanta variabilità e tanta complessità, del perché le cellule tumorali di-ventano immortali e crescono senza controllo, perdendo il loro programma bio-logico di morte cellulare programmata, del perché il DNA può diventare piùfragile e più difficilmente riparabile in soggetti depressi, del perché il sistema im-munitario diventa tollerante a cellule normali che si trasformano e si rivoltanocontro l’organismo ospite. Cercavo dei punti critici su cui poter agire per ripor-tare il sistema tumore/ospite all’equilibrio. Così ho cercato di studiare sempre dipiù il sistema di controllo, il cervello, che modula la funzionalità di ogni organo,di ogni apparato, di ogni singola cellula e gli aspetti psicologici ed emotivi che vi-vono i pazienti nella loro profonda sofferenza, al di la della semplice classifica-zione psicopatologica in ansia, depressione, di stress, ecc. Ho provato ad entraresempre più a fondo nella loro sofferenza, nel loro disagio, nel loro stress estremo,così come nella mia, mentre stavo accanto a loro. Le difficoltà ed i disagi che in-contravo in questo mio percorso erano notevoli ma si stava preparando il mo-mento di una svolta.
Incontro con Joules GrossmanQuesta ricerca mi ha portato ad incontrare Arturo Sica e l’approccio tran-
spersonale, psico-corporeo e spirituale di Joules Grossman (1992). Sono venutoa conoscenza del lavoro di Joules Grossman attraverso una sua intervista pub-blicata su Riza nel 1983. Ero laureato in medicina da due anni, mi stavo specia-lizzando in Medicina Interna ed ero uno studioso dello stress e dei collegamentimente-corpo attraverso il sistema immuno-neuro-endocrino. Avevo già fatto unpercorso personale interiore anche con lo yoga, il training autogeno, l’ipnosi, labioenergetica, la meditazione. Il lavoro di Joules mi aveva affascinato. Gli hoscritto una lettera chiedendogli se aveva in programma di fare dei seminari più vi-cino a Messina. Non mi ha mai scritto. Avevo continuato la mia ricerca scienti-fica nel campo della psico-neuro-endocrino-immunologia dei tumori e la miaformazione personale. Nel 2000 scopro, nella posta scartata dal mio Direttore, unprogetto dell’Università di Genova per uno “Studio sull’applicazione di tecniche dicounseling nel rapporto operatori sanitari/paziente” e per l’organizzazione di un “Corsodi formazione alla comunicazione in oncologia”. Lo prendo, mi piace, chiedo l’autoriz-zazione a partecipare e il mio Direttore mi dice: “fai fai, fai quello che vuoi”. Atti-viamo quindi un corso di formazione che inizia nel marzo 2001 e viene a condurloil Dr. Sica, che non conoscevo. Di seguito riporto una descrizione più dettagliatadel corso con i risultati ottenuti. L’incontro successivo, aprile 2001, il Dr. Sica mi
Marcello Aragona, Francesco Aragona
234
porta una lettera che aveva trovato nel suo archivio: era la lettera che avevo scritto18 anni prima a Joules. Non ricordavo più di averla scritta. Ed ora era venuto aMessina il suo allievo, a tenere un corso proprio qui, come avevo chiesto nella let-tera. Ma ancora più strano è che ho scoperto con meraviglia che Joules è statomale nell’estate del 1984 a Stromboli ed è morto, per infarto del miocardio, nelPoliclinico di Messina, dove lavoravo io in quel periodo e dove lavoro tutt’oggi.Ho anche scoperto che quell’estate Joules aveva chiuso tutte le sue attività pro-fessionali, come se fosse consapevole della sua fine.
Sebbene non ci siamo mai incontrati fisicamente, con Joules il legame è evi-dentemente molto intenso.
Corso sulla ComunicazioneNel marzo del 2001 è quindi iniziato questo corso esperienziale “Corso di For-
mazione alla Comunicazione per Operatori in Oncologia”. Secondo il progetto, finan-ziato dall’Istituto Superire di Oncologia (ISO), doveva essere uno studiomulticentrico che doveva coinvolgere le oncologie universitarie italiane. Strana-mente il corso si è potuto attivare e concludere solo a Messina. Era articolato in3 moduli di 3 giorni ciascuno per 72 ore complessive, a cui hanno partecipato 5medici, 5 paramedici e 3 biologi, 2 psicologi e 3 conduttori. Ciascun modulo delCorso era didattico-esperienziale, aveva come tema conduttore la gestione dellostress, del potere e delle risorse, e si avvaleva di tecniche di psicologia transper-sonale, psico-corporee, immaginative, di rilassamento, respirazione, meditazione,con l’uso del movimento, della musica.
I corsisti hanno verificato un netto miglioramento soggettivo del tono del-
235
Fisiopatologia dello stress
Fig.: Le barre azzurre descrivono il miglioramento delle abilità comunicative, rispetto ai valoribasali che corrispondono allo 0,0. Il risultato è statisticamente significativo (p<0.001). Le barrerosse descrivono il miglioramento che è mantenuto nei gruppi di condivisione anche se con mi-nore intensità.
l’umore, della disponibilità relazionale e particolarmente dell’ascolto, nel relazio-narsi con pazienti e colleghi, insieme ad un miglioramento dei punteggi nei cin-que parametri di valutazione del questionario: capacità intellettuali, relazionali,gestionali, innovative, emozionali; p<0.001. Una rivalutazione con lo stesso que-stionario dopo 4 mesi di gruppo di condivisione e supporto ha evidenziato unmantenimento del miglioramento nelle capacità intellettuali e relazionali(p<0.001), ma non di quelle gestionali, innovative, emozionali che ritornano ai li-velli di baseline.
Ne abbiamo concluso che una specifica formazione del personale, associataad una parte di riflessione su di sè, offre la possibilità di dare più coerenza alla co-municazione ed all’informazione, così come di migliorare la disponibilità el’ascolto; permette quindi di entrare meglio in contatto con la parte nascosta disè e quindi più facilmente con pazienti e colleghi, e suggerisce l’importanza diquesto approccio che permette di offrire qualcosa di più per aiutare i pazienti amantenere la speranza, a migliorare la qualità di vita e sentire che non sono soli,mentre al personale sanitario di mantenere la voglia di continuare ad operare inquesto campo più a misura d’uomo (Aragona 2002, 2005, 2007).
È proprio in seguito al beneficio che ho provato con questa esperienza che hoiniziato un percorso di formazione transpersonale con Arturo Sica. Ero anche psi-coterapeuta ed ho incrementato la mia attività clinica assistenziale a pazienti on-cologici per aiutarli nel loro percorso di malattia. La mia attività lavorativa comeoncologo e ricercatore vira maggiormente verso l’assistenza psico-oncologica.Riesco anche ad attivare un ambulatorio specifico di psiconcologia.
Questa mia formazione transpersonale mi ha aiutato a “stare” con le personemalate, con la loro sofferenza, entrare insieme nel loro dolore ed aiutarli secondole loro possibilità. La grande sfida era proprio cercare di portare benessere lì dovela realtà fisica non può cambiare, dove il dolore è estremo, la malattia porta amorte. Ma come fare? La risposta è arrivata quando ho cominciato a vedere glieffetti dello spostare l’attenzione ed il livello di coscienza secondo quanto impa-ravo dall’approccio transpersonale.
La via transpersonaleCon il termine transpersonale (James, Jung, Assagioli), si indica l’espansione
della consapevolezza di sè oltre i confini di ciò che definiamo persona, speri-mentando i punti di confine tra il Sè ed il nonSè, tra la persona e l’ombra, tra lamente ed il corpo, tra l’organismo in toto e l’ambiente e varcarli, per mezzo di statimodificati di coscienza (Wilber, Grossman), di esperienze transpersonali (Fer-rucci), di stati meditativi (Dossey, Grof), mistici (Beauregard), o esperienze scia-maniche (Lattuada, Grof), ecc.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
236
L’espansione di coscienza permette di diventare più consapevoli dei processimentali, emozionali, delle radici del malessere, di vecchi modelli e comportamentilimitanti, di atteggiamenti, sentimenti, bisogni, sia carenziali che di crescita-tra-scendenza, delle scissioni, separazioni interiori (Grossman) e quindi spostare ilpunto di osservazione e attenzione, lasciare i pattern maladattivi. Ci si sposta dalgiudizio all’intenzionalità positiva (Grossman, Kasprow), per promuovere nuovimodelli di pensiero, emozioni e comportamenti (Kasprow), verso la ricerca disenso, significato, più orientato alla salute, sui diversi livelli dell’esistenza, dal cor-poreo all’emozionale, mentale, sociale, spirituale.
Espandere la consapevolezza, per esempio col movimento, il suono, il man-tra, può liberare una nuova energia dal sè interiore, raggiungere le radici del ma-lessere che sono collegate a vecchi modelli, a comportamenti limitanti, spessomodi illusori di vedere noi stessi e gli altri; anche usando il beneficio del dubbiosi può spostare l’attenzione dalla parte critica, per portarla sull’intenzionalità po-sitiva (Teddi Grossman 1992).
L’approccio transpersonale quindi opera per la consapevolezza e realizzazionedel Sé, attraverso l’espansione multidimensionale di coscienza, della creatività, lepeak esperiences, le esperienze dell’unità, la spiritualità, oltre i confini razionalidella coscienza, verso le potenzialità più evolute dell’uomo, quale unità bio-psico-spirituale (Tart, Wilber, Grossman, Ferrucci, Lattuada).
Il superamento degli aspetti duali, porta ad una percezione e consapevolezzadell’Unità (Grossman, Wilber, Beauregard) ed una trasformazione molto rapidadi situazioni di sofferenza (Grof), dolore, disagio anche estremo e l’induzione diprofondi stati di benessere, anche in situazioni drammatiche, per esempio di do-lore oncologico (Aragona), di morte (Grof, Grossman, Simonton, Aragona).Questi aspetti hanno specifici pattern di attivazioni neuro-biologiche a livello ce-rebrale (Beauregard, Davidson) e delle cascate neuroendocrine del sistema PNEI,sia sul tumore che sull’ospite e tutti i suoi organi e apparati (McGregor, Aragona).
L’approccio transpersonale, estremamente variegato tra differenti scuole, siavvale dei tradizionali metodi psicoterapeutici in integrazione con l’uso terapeu-tico degli stati modificati di coscienza (Kasprow).
Le via chiave quindi è rappresentata dall’induzione di esperienze transperso-nali, di stati modificati di coscienza. Queste sono esperienze fisiologiche dellequalità superiori dell’essere umano, come l’ispirazione creativa, l’espansione dicoscienza, intuizione, estasi, illuminazione e sono esperienze che hanno caratte-rizzato l’attività eccelsa dei principali personaggi dell’umanità (Ferrucci). Sonoassociati ad un’attività cerebrale con onde a bassa frequenza, tipo alfa, theta odelta, anche se in stato di veglia. Sono stati in cui il mondo inconscio si esprimecon facilità e può essere integrato ed armonizzato nell’esperienza cosciente, spe-
237
Fisiopatologia dello stress
cie all’interno di un setting specifico, inducendo profonde trasformazioni della co-scienza con cambiamenti in ogni area della percezione, intense ed insolite emo-zioni, forti risposte psico-biologiche, profonde modificazioni di pensiero,acutezza introspettiva e comprensione intuitiva inimmaginabili (Ferrucci).
Possono essere esperienze occasionali, di stato (peak experiences) o stabili neltempo, di tratto, come le plateau experiences descritte da Maslow, verso il po-tenziamento delle risorse, e l’induzione di un benessere di tipo eudaimonico-spi-rituale.
Queste esperienze, che sono risorse potenziali di tutti gli esseri umani, in pas-sato sono state confuse con manifestazioni psicotiche e possono esitare in ma-nifestazioni psicotiche in persone non preparate e non integrate (Kasprow) o insquilibri neurovegetativi come nella Sindrome di Stendhal (già citata in prece-denza). Una diagnostica differenziale è necessaria secondo le specifiche lineeguida dei modelli transpersonali (Lukoff, Kasprow) ed una preparazione ade-guata è spesso essenziale per integrarle a livello profondo.
Le applicazioni sono numerose nel campo della psicoterapia, della psichiatria,della medicina (Grof, Assagioli, Kasprow, Dossey), dell’oncologia (Aragona) edin particolare nell’approccio alla vita e alla morte (Grossman, Aragona).
La sofferenza, specie in oncologia, è spesso molto profonda ed espressa fisi-camente con sintomatologie complesse, dolore, disagi anche estremi; ma anchecon intense emozioni, quali paura, rabbia, ansia, depressione. Il paziente entra incontatto con la propria morte, sia realmente che simbolicamente, e con il signi-ficato della propria vita: qualche volta può arrivare alla fase finale dell’accetta-zione (Kübler Ross). Il disagio è talmente intenso da attivare vari meccanismi didifesa e focalizzare l’attenzione prevalentemente a livello fisico, fino a rifiutarespesso il supporto psicologico o spirituale, perché giudicato “futile” rispetto allagravità di una “malattia” che loro vedono solamente fisica. In realtà basta aiutarequeste persone ad aprirsi un po’ e loro subito vanno oltre il disagio della malat-tia ed iniziano a condividere i loro veri disagi, quelli più profondi, quelli che rap-presentano le loro grandi rinunzie. Infatti la maggior parte di loro vive per gliobiettivi di qualcun altro, non più per i propri, relegati nell’inconscio più pro-fondo. Spesso proprio loro sono, già da allora, morti dentro, anche se in generedicono che hanno una gran voglia di vivere. E vivere diventa necessario, solo pernon fare soffrire i familiari. Caratteristico è il caso di Maria:
Maria1, donna di 47 anni, affetta da carcinoma mammario con diffusissimemetastasi ossee che la costringono ad un decubito obbligato a letto da 5 annicirca. Dopo varie linee terapeutiche si decide di tentare un’ultima linea di che-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
238
1I nomi di tutti i pazienti sono stati cambiati per mantenere la privacy.
mioterapia. L’oncologo le comunica la necessità di una nuova chemioterapia (IVlinea). Lei è sconcertata, piange, si rifiuta di accettare una nuova terapia. Dopo lavisita chiede: “cosa ha detto il medico? Non ho sentito nulla oltre la parola “chemioterapia”!È terrorizzata, specie di perdere nuovamente i capelli. Lavoriamo un pò sull’in-formazione e sulla comunicazione, ma anche sulla sua rabbia. Parallelamente aiutoil collega a comprendere la loro difficoltà comunicativa. Si riesce a fare quest’al-tra linea di chemioterapia ma con scarso beneficio. Si decide quindi di proseguirecon sole terapie palliative orientate solo al miglioramento della qualità della vitae diminuire i disagi. Maria ha una grande rabbia e la sua domanda più insistenteè “perché”, “e perché”. Ha un dolore osseo severo, parzialmente resistente ad altedosi di oppiacei. Per l’insopportabilità del dolore mi chiede “Mi aiuti a morire!”.L’ambiente è piuttosto caotico con 6 pazienti quasi terminali in un’unica stanzaed un continuo avvicendarsi di colleghi e infermieri. Affrontiamo in quel settingmolto difficile i vari aspetti di quella sofferenza. Tentavo anche di arginare le in-tromissioni della paziente del letto accanto. Scopro che Maria è disperata, oltre cheper il dolore fisico, anche per il fatto che crede di pesare in tutto e per tutto sullafamiglia: è convinta che lei è la causa del disagio dei familiari, specie dei figli. Leiè sempre attenta ai bisogni degli altri ma i sui sono secondari, poco importanti.Le chiedo cosa è che le da gioia e mi risponde: “niente, solo i figli”.
Dopo aver trasformato in parte questo disagio iniziamo a recuperare le risorseinteriori (Maslow, Grossman) e poi facciamo una breve meditazione sul respiromentre le massaggio l’addome, dove percepiva il disagio emozionale: improvvi-samente spalanca gli occhi con un grandissimo sorriso, come non le avevo maivisto fare prima, e dice “ho una sensazione bellissima nella pancia, come un formicolio,non ho provato mai niente del genere”. È stata un’esperienza intensissima e fuori dal-l’ordinario: io ero convinto che si stesse rivolgendo a qualcuno dietro di me, misono girato, ma non c’era nessuno in quel momento. Non ha più chiesto di es-sere aiutata a morire ed il dolore è diventato più sopportabile, come se avesseraggiunto la fase di accettazione. Pian piano le sue condizioni cliniche si sono ag-gravate e dopo pochi giorni è morta lì in ospedale.
Come descrive Maslow (1962), padre della psicologia umanistica e transper-sonale, oltre la sofferenza su cui si focalizzano la maggioranza degli approcci te-rapeutici, c’è un altro grande mondo che è quello delle risorse, del benessere, dellaparte sana della persona. Si passa infatti dal concetto di malattia a quello di salute,che è definito come uno “stato di completo benessere fisico, emozionale, mentale, sociale espirituale, non semplicemente assenza di malattia o di infermità” (Organizzazione Mon-diale della Sanità). Quindi anche in presenza di malattia può essere raggiunto unostato di benessere ottimale che, secondo Maslow, può essere schematicamentedescritto su livelli integrati di benessere, fisico, emotivo, mentale, esistenziale, spi-
239
Fisiopatologia dello stress
rituale, relativamente alla soddisfazione dei propri bisogni. I bisogni sono, se-condo Galimberti (1999), uno “stato di tensione più o meno intensa dovuto alla man-canza di qualcosa che risponde o a esigenze fisiologiche più o meno impellenti o a esigenzevoluttuarie divenute, per abitudine, necessarie, o a esigenze psicologiche avvertite come indispen-sabili per la relaizzazione di sé, o a esigenze sociali apprese dall’ambiente”.
Nella piramide dei bisogni di Maslow il primo livello è quello relativo ai biso-gni fondamentali, vitali, al sollievo dalla sofferenza fisica, alla sopravvivenza. Unavolta che queste esigenze del benessere fisico siano soddisfatte è possibile, per ilsoggetto, portare l’attenzione al livello successivo dei bisogni di sicurezza, poi diappartenenza e di autostima, relativi al benessere emotivo, psicologico, sociale.Dopo la soddisfazione di questi bisogni detti carenziali si passa a quelli evolutivi,di crescita, della realizzazione del sé, di significato, di trascendenza (benesserespirituale o trascendente).
Il bisogno si esprime attraverso l’emozione che Bonesso (2008) definisce comel’informazione operativa del bisogno, costituita da uno stato psichico-affettivomomentaneo, derivante dalla reazione dell’organismo a percezioni esterne o arappresentazioni interne, che modificano l’equilibrio della persona. Le emozionisi sviluppano in modo binario, corrispondentemente alla possibilità che un biso-gno ha di essere soddisfatto o meno. Le coppie di emozioni opposte (vedi ta-bella) regolano i sistemi fondamentali di soddisfazione dei bisogni, in cuil’emozione positiva segnala lo stato di soddisfazione-appagamento, mentre quellanegativa esprime carenza, insoddisfazione.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
240
Contunuum emozionale
1. Attrazione-Repulsione (interesse, curio-sità, aspettativa – schifo, ribrezzo, ripugnanza)
2. Piacere–Dispiacere (soddisfazione, appa-gamento – insoddisfazione, sofferenza)
3. Fiducia-Paura (calma, sicurezza, affida-mento – timore, insicurezza, angoscia)
4. Attaccamento-Rabbia (amicizia, affilia-zione, attaccamento, accudimento – irritazione,avversione, collera, indignazione)
5. Gioia-Tristezza (allegria, eccitazione, esul-tanza – perdita, malinconia, abbandono, de-pressione)
6. Felicità - Senso di colpa (contentezza,flusso, serenità – disperazione, perdita morale,vergogna)
7. Beatitudine-Malignità (serena attività, en-tusiasmo, perdono, umiltà - distruttività, attivitànascosta, perfidia)
Bisogni corrispondenti
bisogni vitali
bisogni fondamentali
bisogni di sicurezza
Bisogni di appartenenza
Bisogni di autostima
Bisogni di autorealizza-zione
Bisogni di trascendenza
Mi interessa? È desiderabile?
Mi fa stare bene?Mi soddisfa?
È buono, bello? È si-curo? Posso fidarmi?
Mi vuole bene? Mistima? Mi ama?È con me?
Ce la faccio, riesco,vinco?
È bene, giusto, amore?Ha significato?
Che cosa è bene?
Criterio assiologico
La tabella schematizza questa classificazione bidimensionale delle emozionisecondo un continuum tra emozioni opposte in associazione ai bisogni corri-spondenti, i criteri assilogici (adattata da Cervi M., Bonesso C: Emozioni per cre-scere, educare l’emotività. Armando Editore. Pag 46, 2008) ed i modelli dipensiero sottostanti e spesso inconci, che spesso si riferiscono a una radice deltipo: io non sono, io non posso. Si deve comunque tenere presente che dietrol’emozione principale se ne annidano altre su vari livelli (Bonesso).
Questa classificazione può essere molto utile nei programmi di sviluppo del-l’intelligenza emotiva, nella terapia di gestione dello stress, di emozioni e modellidi pensiero limitanti e disfunzionali.
Attraverso la soddisfazione dei bisogni, verso la realizzazione del Sè, viene de-finito un percorso di crescita personale e di intelligenza emotiva per trascenderela malattia. La malattia fisica o mentale però tende a riportare, ancorare la personaai bisogni fondamentali, non soddisfatti o carenziali e modificare, facilitare, il per-corso evolutivo verso la realizzazione di sé. Lavorare solo sulla sofferenza spessonon aiuta in questo percorso, specie se la malattia non può essere guarita. Sti-molare invece anche il benessere e la soddisfazione dei bisogni, specie quelli piùprofondi, aiuta la persona a stare meglio ed avvicinarsi con più energie al processoconsapevole di accettazione della malattia ed anche della morte o anche al pas-saggio verso una vita migliore (Grossman). Infatti l’accesso a esperenze tran-spersonali permette una visione diversa della realtà, da un punto di vista diverso,più distaccato rispetto alle dinamiche limitanti (sofferenza-pensiero-emozione-relazione) per evidenziare il modello disfunzionale e sperimentarne uno nuovo piùsalutare, più a misura del proprio Sè. Parallelamente ed anche paradossalmente lapersona cambia le proprie priorità, apprezza di più la vita e ne trae gioia.
Questo percorso viene descritto da tanti autori tra cui Assagioli, Wilber, Vau-ghan, Tart, Grof, Ferrucci e molti altri. Ma gli insegnamenti di Joules Grossman,di Arturo Sica, come quelli di Carl Simonton che ho conosciuto nel frattempo,mi hanno ispirato maggiormente nel mio lavoro e nella mia ricerca personale.Continuo ad integrare questi livelli facendo da ponte con la scienza medica, neu-roscienze, psicologia, emozioni, spiritualità.
Questa via mi ha portato ad esplorare gli stati di coscienza che stanno al di ladi quelli ordinari (veglia, sonno, sogno). Infatti noi siamo consapevoli general-mente solo di una minima parte, spesso molto meno del 5% di ciò che siamo.Tutto il resto è automatico, inconscio, al di sotto del livello di coscienza. Ma la sof-ferenza che percepiamo, così come il dolore, non sono altro che la punta del-l’Iceberg, sono solo una piccola parte. Esplorare cosa c’è sotto, dietro lasofferenza, ci aiuta a comprenderne il senso e trovare un modo nuovo per af-frontarla e per ritrovare il proprio benessere. Per fare questa esplorazione nel
241
Fisiopatologia dello stress
mondo interiore si deve accedere agli stati non ordinari di coscienza, dove la no-stra mente razionale non può arrivare direttamente. Sono quegli stati che dalpunto di vista elettrofisiologico sono detti alpha, theta o delta in cui le onde ce-rebrali sono sempre più lente come nel rilassamento, sogno e sonno profondo.Al contrario i livelli di coscienza ordinari in stato di veglia sono caratterizzati daonde cerebrali di tipo beta ad alta frequenza o gamma ad altissima frequenza, ti-piche degli stati di estrema focalizzazione dell’attenzione. Raggiungere questi statidi onde lente, durante la veglia, specie quelli a frequenza più bassa, theta e delta,permette di esplorare il mondo interiore, i disagi, ma anche le capacità, le risorse,amplificando i momenti in cui ci sentiamo particolarmente "creativi", insolita-mente "intuitivi", eccezionalmente "lucidi", profondamente "rilassati”, disponi-bili alle peak experiences (esperienze vetta), alle sincronicità, agli stati mistici,meditativi.
Si possono utilizzare numerose tecniche per entrare in queste esperienze. Èpossibile infatti attivare, per esempio con la meditazione, la corteccia cerebraleprefrontale sinistra che induce uno stato di profondo benessere: queste espe-rienze inducono anche una inibizione della corteccia prefrontale destra e di tuttoil sistema emozionale negativo e dello stress (amigdala, ippocampo, ipotalamo, si-stema endocrino, immune, patologia da stress) (Davidson, 2000-2005). In piùcon l’allenamento il cervello si adatta, in modo plastico, si ispessisce e l’induzionedel benessere è più facile e rapido (Lazar 2005, Lutz 2004, Davidson 1999, 2003).Quindi si può schematizzare che due specifici sistemi sottendono allo stato dibenessere e di sofferenza: entrambi attivano o disattivano il sistema psico-neuro-endocrino-immunitario (PNEI). Un sistema è legato alla vita inconsapevole, è at-tivo in condizioni di stress, ansia, dolore, irritabilità, disagio, sofferenza ed èmediato da catecolamine, steroidi surrenalici, oppioidi endogeni ed innumerevolialtri mediatori neuro-endocrini, induce immuno-depressione ed innumerevoli pa-tologie (Aragona F. 1990-91, Aragona M. 1988-2007, Selye 1974, Biondi 1995).L’altro sistema è legato alla vita cosciente-supercosciente ed è attivo in condi-zioni di espansione di coscienza, specie spirituale e del piacere, di eccitazioneestatica sessuale; è costituito fondamentalmente dalle interazioni unitarie fraghiandola pineale, sistema endogeno cannabinergico e sistema Gabaergico-tipoA; media uno stato di immuno-attivazione ed è associato al benessere (Lissoni,2003). Questo tipo di benessere è anche detto “eudaimonico” ed è caratterizzatoda alti livelli di autonomia, padronanza dell’ambiente, crescita personale, relazionipositive con gli altri, obiettivi nella vita, autoaccettazione, che dà il senso che lavita è degna di essere vissuta. Questo stato può non essere accompagnato allasensazione di sentirsi bene. Il benessere eudaimonico va differenziato da quello“edonico” che è riferito ad aspetti più superficiali del piacere (Urry, 2004).
Marcello Aragona, Francesco Aragona
242
La tecnologia può venirci in aiuto per esplorare questi livelli di coscienza. Peresempio la Metamusica con la “Binaural beat technology” (Hemi-Sync, MonroeInstitute, Virginia, USA), ha una piccola sfasatura tra canale sinistro e destro, cheil crevello non può ascoltare contemporaneamente senza essere costretto a farneuna media a livello del nucleo olivare. Questo terzo suono è studiato in labora-torio per essere a bassa frequenza, in genere a livello delle onde alfa, theta e/odelta. Per effetto della risonanza, questo terzo suono si diffonde a tutto il cervellofacilitando una sincronizzazione tra i due emisferi cerebrali a quelle basse fre-quenze. Quindi anche in stato di veglia si può indurre il cervello a raggiungere unostato di profondo rilassamento ed entrare in contatto con livelli profondi di co-scienza, meditativi, creativi, di integrazione sensoriale e benessere. Queste musi-che si possono usare anche come sottofondo per la meditazione come descriveròdi seguito.
È molto particolare l’evidenza scientifica che i cervelli di persone che medi-tano insieme si sincronizzano tra di loro, anche se non è evidente nessun colle-gamento fisico (Montecucco, 2005).
Questo effetto forse può essere ottenuto tramite l’attivazione dei “neuroni aspecchio” che facilitano la sincronizzazione tra l’osservatore e l’osservato. Que-sto è un sistema molto complesso, un network di interconnessioni neuronali dif-fuso prevalentemente a livello corticale frontale, temporale, parietale e posteriorecon connessioni anche profonde con aree filogeneticamente più antiche tipo il si-stema limbico. Questo network di neuroni a specchio, detto Social Brain, serve daspecchio e simula ciò che è percepito a livello sensoriale e fornisce la base per lemultiformi condivisioni delle esperienze interpersonali, per l’empatia, la com-prensione esperienziale delle emozioni degli altri (Burns, 2006) ed il sistema fon-damentale che permette l’instaurarsi della relazione terapeutica: più il social brainriesce a mimare, specchiare l’altro, più è facile comprendere empaticamente l’al-tro e la sua autenticità. Questa capacità può essere educata, stimolata e l’approc-cio transpersonale sembra particolarmente efficace in questo senso.
A questo proposito l’intimità che si condivide quando l’empatia è profondanon ha parole che la possano descrivere e la comunicazione che avviene rifletteprevalentemente gli aspetti più profondi di sé, l’armonia e l’autenticità interiore.
Domenico: giovane paziente di 30 anni sposato con una figlia piccola, è ormaiin fase terminale per un tumore della testa/collo. Ha una grossa massa latero-cervicale sinistra, a cui è solito rivolgersi nei suoi momenti di intimità, chiaman-dola per nome, che ometto per suo rispetto. Sorride al mio arrivo mentre la madree la moglie si lamentano: “ma perché quando viene il dottore sorridi e con noi no?”. E lui
243
Fisiopatologia dello stress
risponde: “ma cosa c’entra! Con il dottore è come se ci conoscessimo da sempre”.Forse questa è la base di una vera “relazione terapeutica”.
Il caso di Lucio esprime come è possibile lavorare sui vari sistemi neuroen-docrini e su vari livelli di coscienza senza coinvolgere il sistema cognitivo razio-nale, che a volte è di ostacolo. Infatti le scelte effettuate non hanno seguitoun’elaborazione logica-razionale, ma solo intuitiva-creativa e sono state efficaci. Lucio: 30 anni con tumore dello stomaco, metastatico, con dispnea grave per
imponente versamento pleurico e peritoneale. È disperato per la grave difficoltàrespiratoria. Era stato ricoverato per eseguire una chemioterapia. Tuttavia perl’imponente progressione di malattia non era più possibile somministrarla e labuona pratica clinica suggeriva di continuare con al sola terapia di supporto. MaLucio non voleva essere dimesso senza che gli fosse somministrata la chemiote-rapia. Era in fase terminale ma non voleva accettarlo, nonostante la comunica-zione diagnostica e prognostica era stata chiara. Chiede un supporto psicologicoche è difficile per le sue notevoli difficoltà a respirare e parlare. Lo psicologo con-tattato, non potendo lavorare a livello verbale, chiede il mio intervento. Facciamoun breve colloquio anche se con molta difficoltà. Riesco a capire che la sua piùgrande sofferenza, paradossalmente, non era dovuta al cancro, ma ad un dissidiofamiliare che lo dilaniava e che “non digeriva”: per lui era insanabile. Per le suecondizioni cliniche gravi non era possibile spostarsi in ambulatorio. Facciamouna meditazione con la metamusica in corsia, in condizioni ambientali critiche:nella stessa stanza c’erano altri 5 pazienti gravi. Medici ed infermieri si avvicen-davano rumorosamente ed imprevedibilmente. Nonostante tutto, dopo la medi-tazione Lucio riferisce un notevole piacere per l’esperienza ed il sollievo nelrespirare. Dice che è stata un’esperienza meravigliosa e che non aveva mai fattonulla di simile e, riferendosi alla visualizzazione, diceva: “ma come faceva a sapere do-v’ero e cosa stavo facendo?”. Non abbiamo parlato nè delle sue difficoltà nel respirare,né della chemioterapia, nè della prognosi. Il giorno dopo mi dice: “sa dottore, que-sta notte ho pensato che forse è meglio che io vada a casa”. Era come se avesse compresoe accettato il suo stato di malattia e l’avvicinarsi della morte: senza che ne aves-simo parlato, almeno a livello cosciente. Viene dimesso, attivando l’assistenza do-miciliare e, dopo 3 giorni, muore tranquillo a casa sua.
A volte, il livello di coscienza ordinario, razionale, può essere d’inciampo, per-ché legato a modelli di pensiero e credenze non salutari (Simonton) che vengonoritenute vere e non messe in discussione.
Recentemente Wilber descrive una vera e propria mappa dei livelli di coscienza,che lui chiama spettro della coscienza, in cui suddivide gli aspetti che si conside-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
244
rano “Sé” da quelli “non Sé” sia a livello della persona/ombra che delmente/corpo, individuo/società, fino alla cosiddetta “coscienza dell’unità”. Ogniseparazione, ogni limite è da lui considerato un terreno di battaglia, di conflittotra due parti di sé, quindi di sofferenza, disarmonia, dispendio energetico. Traquesti livelli se ne inserisce uno molto particolare che è quello delle “bande tran-spersonali”. Per ogni livello possono essere utilizzate differenti tecniche tera-peutiche: quelle transpersonali sono quelle che integrano tutte le altre in tutti ilivelli dello spettro (Wilber, 1981-2002). Nella parte bassa dello spettro c’è quelloche viene considerato da sempre l’obiettivo ultimo, l’accesso alla spiritualità, la co-scienza dell’unità.
Le basi neuroscientifiche dell’esperienza spirituale sono particolarmente com-plesse: persone che sperimentano uno stato mistico manifestano l’attivazione didozzine di aree cerebrali coinvolte nella percezione, emozione, coscienza comela corteccia orbito-frontale mediale destra, corteccia temporale mediale destra,lobi parietali inferiori e superiori di destra, caudato destro, corteccia prefrontalemediale sinistra, corteccia del cingolo anteriore sinistra, lobulo parietale inferioresinistro, insula sinistra, caudato sinistro, tronco cerebrale sinistro (Giordano 2006,Beauregard 2006). In riferimento a questi studi la rivista Science titola: “God onthe Brain” (Dio sul cervello) esprimendo che la condizione mistica ha una sua pro-pria caratteristica neurobiologica ed è associata ad uno stato di estremo benessere,pace e amore. La particolarità di questo stato è che è possibile anche sperimen-tarlo, con relativa facilità ed opportune tecniche. Non parliamo qui di pratiche re-ligiose, ma dello sperimentare, a livello fisico e diretto, l’accesso alle proprie risorsespirituali sia a livello individuale che relazionale. Accedere alle risorse spirituali inoncologia porta notevoli miglioramenti nella qualità della vita, come si evince da
245
Fisiopatologia dello stress
CON
FINE
Sé
Persona Ombra Counseling, terapia di Sostegno
Pratiche Spirituali
Psicoanalisi, Psicodramma, Analisi Transazionale,
Psicologia Umanistica, Terapia diRogers, Gestalt, Analisi esisten-ziale, Bioenergetica, Logoterapia
Psicolgia Analitica di Jung,Maslow,Psicosintesi, Transpersonale
Corpo
Ambiente
Transpersonali
Mente
Organismototale
Bande
Coscienza dell’Unità (Universo Manifesto e non)
Non Sé Terapie utilizzate
quanto riportato di seguito. È incredibile come proprio in oncologia, dove si vivequotidianamente a stretto contatto con la morte, la spiritualità sia ancora un tabù.
Vediamo qui nel caso di Paolo come le credenze possano fare soffrire e comela loro trasformazione possa portare all’accettazione:
Paolo: 55 anni, è ricoverato con tumore al polmone metastatico, in fase termi-nale. È iperattivo, non riesce a stare fermo anche se non può alzarsi dal letto, nérespirare bene. Mi parla dei sui disagi e, dopo una breve meditazione sul respiro,mi comunica del suo senso di inadeguatezza che lo costringe in ogni momento afare di più, ad “essere migliore”. Mi racconta della morte della madre, suicida,quando lui aveva 4 anni. Dice che in un momento di disperazione, dopo un altroevento critico in età adulta, ha chiesto: “Dio puniscimi con una malattia”. Dopo pochimesi gli viene diagnosticato il cancro al polmone. Si sente rassegnato perché hachiesto lui stesso la malattia. Questa è arrivata ed ora non può tirarsi indietro. La-voriamo molto sulla spiritualità e cerchiamo di trasformare questa credenza mal-sana secondo il metodo Simonton ed anche sulla morte con l’approcciotranspersonale di Joules Grossman ed Arturo Sica. Il giorno dopo ha la febbre altae dorme. Parlo con la moglie e insieme facciamo una meditazione sulla saggezzainteriore. Paolo era accanto a noi e dormiva tranquillamente nel suo letto. Ilgiorno dopo parliamo delle sue sofferenze legate ai diversi aspetti della sua per-sonalità. Gli consiglio di focalizzare la attenzione alle cose che gli danno gioia,come guida per stimolare il sistema del benessere. Sembra molto più tranquillo.La notte muore quasi in modo inaspettato, nonostante la sua situazione clinicafosse gravissima, ma era tranquillo. Sono rimasto sorpreso, la mattina dopo, nelsapere della sua morte. Sono andato al suo funerale per salutarlo e per elaborarequesto mio lutto, per comprendere la risonanza che ha avuto in me.
Si integrano molto bene nella via transpersonale, per la caratteristica di esplo-rare ed usare gli stati modifiati di coscienza, i vari modelli sciamanici, usati da mi-gliaia di anni in tutte le culture come via per guarire se stessi e gli altri (Grof,Lattuada).
Vivere e MorireIn questo percorso mi ha aiutato molto il lavoro sul “Vivere e Morire” fatto
con Arturo Sica in questi anni: mi ha portato all’organizzazione di un Corso espe-rienziale dal titolo “Vivere e morire: accettare la morte per migliorare la relazione terapeu-tica” (Messina, 30-31 marzo 2007; Autorizzazione del Ministero della Salute edassegnazione da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continuadi 12 crediti ECM. Richiesta n. 1127-268104). Lo stesso evento formattivo è stato
Marcello Aragona, Francesco Aragona
246
organizzato anche nel 2008 e 2009 ed è stato presentato come Workshop all’11EUROTAS International Conference nell’ottobre 2009. L’idea centrale di questocorso è che la “relazione terapeutica” è inevitabilmente influenzata dalla perce-zione individuale della sofferenza dell’altro, così come della propria. Questo pro-cesso avviene prevalentemente a livello non verbale, inconscio. L’entrare incontatto anche con la sensazione, l’idea, che l’altro possa soffrire e morire, puòinfluenzare, pur se al di fuori del livello di coscienza ordinario, il “Social Brain”(Burns 2006), tramite cui, empaticamente, il vissuto dell’altro viene associato conil proprio e quindi con la propria sofferenza, le proprie paure interiori, le rabbie,i conflitti non risolti, i “no” interiori, la propria paura di soffrire e morire. Di-scriminare questi differenti livelli è spesso difficile e la formazione accademica ècarente.
Esplorare però questi processi, imparando ad entrare in rapporto con ciò cheviene suscitato dalla sofferenza dell’altro, dai suoi impulsi vitali e/o di morte, op-pure dalle nostre emozioni, dai nostri vissuti, dalle nostre credenze, dalla nostrapaura di morire, riesaminare tutto ciò per accettare attivamente, può aiutarci a“vivere” in modo più consapevole ed efficace la relazione terapeutica, ma anchela nostra stessa vita.
Il subire in modo inconsapevole questo complesso processo relazionale, maanche intra-individuale, potrebbe spiegare quell’atteggiamento spesso sterile e di-staccato che si ha nei confronti dei cosiddetti pazienti “difficili”, di coloro che sof-frono o che si avvicinano alla morte. Spesso c’è una grande e non riconosciutapaura interiore, come la percezione di sentirsi impotenti a guarire l’altro o di sen-tirsi responsabili della sua salute, che ostacolano l’ascolto attivo, il parlare aper-tamente e francamente della morte e di tutto il resto con i pazienti. Tutte le nostrepaure inevitabilmente si inseriscono in modo non verbale nella comunicazione.È spesso anche la paura che la vita sia senza significato che fa allontanare questisentimenti sulla morte, con cui non è facile entrare in contatto, mentre accettarli,come percepire la finitezza della propria vita aiuta ad apprezzare la pienezza stessadella vita (Grossman 1992).
Ma la paura dello sconosciuto e della solitudine, la paura di perdere le cose ole persone a cui siamo attaccati, la paura della sofferenza fisica si frappongono allapossibilità di vivere con serenità il dolore legato alla separazione, alla sofferenzae infine alla morte. Spesso molte persone affermano di voler vivere, tuttavia concomportamenti, atteggiamenti, emozioni, stili di vita, dimostrano di aver già ri-nunziato da tempo a vivere.
Di fronte a questa incongruenza, tra conscio ed inconscio, l’altro (il sanitario)può trovarsi confuso e la relazione si può caricare di incomprensioni, false aspet-tative, attaccamenti, illusioni, emozioni distruttive. Spesso anche con i familiari la
247
Fisiopatologia dello stress
comunicazione diventa difficile perché carica di sofferenza non riconosciuta.Se subita inconsapevolmente, questa sofferenza non viene adeguatamente ela-
borata e si interpone, come una barriera comunicativa inevitabile, trasformandoin modo drammatico la relazione terapeutica ed incidendo spesso in modo ne-gativo sul benessere sia dei pazienti che dei sanitari.
Proprio esplorando, in modo verbale e non verbale, il proprio corpo, le emo-zioni, i sentimenti, pensieri e costrutti mentali, credenze, specie sulla morte e sulmorire, imparando a riesaminarli ed accettarli, è possibile entrare umanamentein rapporto con altre persone e/o con il loro processo del morire, ma anche im-parare ad entrare in contatto con la propria parte più profonda, inconscia, adavere più fiducia in se stessi, ad amarsi ed accettarsi più di prima, ad avere una vi-sione di maggiore speranza, una nuova percezione della vita, così com’è, e viverlain modo più soddisfacente e gioioso (Grossman 1992).
La E. Kübler-Ross (1992) scrive di una sua paziente: “Sorrideva come una che sa,pensava e conversava sulla sua morte, chiedeva un po’ di conforto e amicizia” .. .. “sentiva ilnostro rispetto”. Ed anche Treya Wilber alla fine della sua vita dice: “Poiché non possopiù ignorare la morte, presto più attenzione alla vita” (Wilber 2002).
Il corso ha seguito questo nuovo modello formativo esperienziale già speri-mentato da Joules Grossman ed Arturo Sica ed integrato da una parte didattica.Tutti i partecipanti hanno apprezzato ed esplorato con soddisfazione, in un am-biente protetto, il proprio vissuto, le proprie difficoltà relazionali ed emotive ri-guardo a persone morenti, ma anche alle proprie “piccole morti”, separazioniquotidiane. Tutti hanno evidenziato l’importanza di questa formazione ed espli-citamente richiesto di continuare questo lavoro. Eravamo seduti in cerchio in unambiente molto accogliente, si condivideva su “Vivere e Morire come percorsodi consapevolezza”, sulle esperienze individuali, sul contatto con la morte, per-sonale-reale o simbolica. Entravamo in contatto sempre più profondo con leemozioni, le paure, i disagi, le credenze attraverso le pratiche corporee come labioenergetica, la meditazione, la metamusica, il mantra.
Scriveva un corsista “Descrivere un’esperienza con una persona morente non è facile edin ogni caso le parole non riescono ad esprimere i sentimenti che si provano, specie se si tratta diuna persona cara, in quanto il coinvolgimento emotivo è troppo forte e non mi viene di esprimerea parole tutte le emozioni e gli stati d’animo che si succedono.”
Un altro corsista scrive “Un mio paziente ha voluto avermi accanto fino all’ultimoistante ed è spirato non appena sono arrivato, appena dopo che ci siamo salutati. Questo ha la-sciato in me un tormento emotivo che si è sempre riversato nel mio quotidiano.”
Queste esperienze sono troppo forti per le capacità individuali di affrontarle,specie se non si è preparati e la formazione è carente. Il disagio che ne deriva puòsfociare nella sindrome da burnout. È uno squilibrio tra le richieste professionali
Marcello Aragona, Francesco Aragona
248
e la capacità individuale di affrontarle. Può anche essere considerato come unasollecitazione emozionale di frustrazione e demoralizzazione, con difese inade-guate e comportamenti maladattativi (Muscatello 2003, 2006), a cui consegue undeterioramento della relazione medico-paziente, con minore empatia, maggioretensione, ansia, depressione dell’operatore, con diminuzione della quantità e dellaqualità dell’assistenza prestata ed una maggior possibilità di errori medici.
Questo disagio va correttamente condiviso, elaborato ed usato come risorsa,come momento di crescita personale e relazionale, ma non ci si può cullare nel-l’oblio del tempo.
Entrando più profondamente in contatto con la propria parte più intima, il Séspirituale, si esplora in modo più aperto e da una nuova prospettiva l’esperienzae si rimodulano le priorità individuali, il senso della propria vita.
Con il Role Playing i corsisti hanno potuto sperimentare, in modo simulato,ma molto realistico, così come succede nei processi immaginativi profondi, in-consci, i diversi livelli di coscienza del processo del morire, come dell’accompa-gnare un morente. Tutti sono rimasti particolarmente colpiti per la profondità diquesta esperienza, inizialmente vissuta come un gioco e poi come esperienzaquasi vera, per la profondità raggiunta sia dal punto di vista fisico, che emotivo,mentale, relazionale e spirituale. Era comunque una condizione limite della pro-pria vita dove non ci sono più barriere interpersonali, né maschere dietro cui na-scondersi, uno spazio-tempo indefinito in cui cambia completamente laprospettiva quotidiana di relazione con sé e col mondo, in cui le priorità vengonosovvertite, sfumano i bisogni futili ed emergono i bisogni veri. Tutti hanno pro-vato una profonda empatia e compassione con l’altro, consapevoli che era una si-mulazione, ma soprattutto nella concretezza, nella realtà del contatto umano eprofondo con l’altra persona.
Un corsista scrive: “questo esercizio mi ha consentito di sperimentare quanto sia impor-tante la comunicazione non verbale, il contatto fisico, rassicurante per il malato, ma anche perchi accompagna, sperimentare come la cosa più importante sia “esserci”, non fuggire spaventatio presi dalla frenesia di un fare che non ha significato”.
Si è sentita molto intensa l’emozione di tutti i partecipanti. Qualcuno si è sen-tito confuso nel riportare l’esperienza durante la condivisione di gruppo, proba-bilmente perché cambiano le certezze relative ad esperienze, comunquemisteriose, quali la morte e la relazione terapeutica, o il senso della propria vita.Comunque è proprio questa la base fondamentale per una più ampia aperturaempatica ed una maggiore consapevolezza delle proprie risorse. Tutti hannoespresso uno spirito vitale alla fine del corso ed il bisogno di concretizzare que-sta esperienza di trasformazione interiore, chiedendo di continuare con queste ini-ziative, potersi reincontrare per continuare queste esperienze, in modo tale che,
249
Fisiopatologia dello stress
come dice un corsista, “anche noi operatori possiamo affrontare le nostre morti per poi ral-legrarci delle rinascite”.
L’applicazione in clinica di queste esperienze è veramente molto coinvolgentee profonda, fulcro di grandi trasformazioni. Per esempio:
Alfredo 67 anni, tumore al fegato, di oltre 9 centimetri, non operabile, in faseterminale. È sempre stato molto aperto all’esterno, belle macchine, belle donne.Sposato più volte. Lavoriamo sulla morte e, qualche giorno prima di morire, faquesto disegno (Fig.52): si disegna basso e largo mentre lui e magro e molto alto.La sua malattia è disegnata nel cuore che è a destra e nel fegato, che vengono in-globati con linee rosse ed aree chiuse. Dice che li ha “sigillati” per “non fare casino”,li ha inglobati, rinchiusi per evitare che facciano del male agli altri. Scherzava sullasua morte e diceva che voleva una bara molto robusta e ben sigillata per “conte-nere” bene. Il tratto è molto leggero, a volte impercettibile. Mi racconta, in rife-rimento al cuore ed al fegato, che ha cerchiato di rosso, che ha ancora 4 battaglieda fare, a cui aveva sempre rinunziato. Facciamo una meditazione sulla perce-zione del fegato e lo invito a combattere immaginativamente quelle battaglie. Èl’ultima volta che lo vedo. Muore alcuni giorni dopo.
Carmelo 62 anni, in fase terminale per tumore polmonare a piccole cellule, me-tastatico, pluritrattato. Ha massive infiltrazioni mediastiniche nel pericardio, atriosinistro, vene polmonari, esofago. È in avanzata progressione di malattia ed è ingrave rischio di vita per la diffusione metastatica cardiaca e vascolare. Si ricoveraperché dopo l’ultimo ciclo di chemioterapia ha una pancitopenia con grave di-spnea e versamento pleurico. Nonostante la sua enorme sofferenza, quei suoigrandi occhi chiari esprimevano una profonda saggezza e consapevolezza. Midice: “sto andando lontano. Dottore me lo conferma?”. Rispondo istintivamente chestiamo facendo di tutto per farlo stare meglio, cercando di fargli mantenere lasperanza. Improvvisamente si perde l’accesso venoso in corso di trasfusione. Siha molta difficoltà a trovare un altro accesso venoso e lui è rassegnato con lebraccia abbandonate sul letto mentre gli infermieri si accaniscono per prendereun’altra vena che inevitabilmente si rompe. Le lenzuola sono tutte sporche di san-gue. Dico all’infermiere di sospendere tutte le terapie e lasciare solo l’enalgesicoed il cortisone, mentre sto in contatto con lui, con la mia mano destra poggiatasulla sua spalla sinistra. Immediatamente l’infermiere prende la vena. Carmelosta un poco meglio, respira meglio ed è più tranquillo. Facciamo un controlloelettrocardiografico per le sue gravissime condizioni cardiologiche: era sovrap-ponibile al precedente. Dopo pochi minuti, mentre gli sento il polso, il suo cuore
Marcello Aragona, Francesco Aragona
250
rallenta e poi si ferma. Lui continuava ad essere in apparente tranquillità, mentremoriva.
Sebbene il nostro incontro sia durato solo poche ore è stato molto intenso econ pochissime parole. Io mi trovavo nella condizione duplice di medico, chedeve fare di tutto per mantenerlo in vita, e da psicologo che deve fare di tutto perfargli accettare il passaggio della morte. Ho percepito qualche momento di grandeconflitto interiore, specie nel momento in cui dovevo scegliere le terapie da som-ministrare. Poi ho accettato anch’io il mistero di questo grande passaggio tra lavita e la morte e ci siamo congedati tenendoci per mano.
La vicinanza con la morte o con i morenti è fonte di grandi insegnamenti.Come scrive la E. Kubler- Ross (1992): Al malato terminale … “abbiamo doman-dato di essere nostro maestro in modo che noi potessimo imparare qualche cosa in più sulletappe finali della vita con tutte le sue ansie, timori e speranze….. I pochi che sapranno avvici-nare questi malati “senza speranze” scopriranno anche che può essere un’esperienza reciproca-mente gratificante; essi impareranno molto sul funzionamento della mente umana, sugli aspettiumani eccezionali della nostra esistenza e usciranno da questa esperienza arricchiti e forse conminori ansie riguardo la propria fine”.
Ma avvicinarsi alla morte può essere anche un potente stimolo alla vita comesi può evincere dai casi seguenti:
Claudia: insegnante di 45 anni, non è sposata e vive con i genitori. Ha un tu-more del colon operato, in corso di chemioterapia adiuvante che le causa impor-tanti effetti collaterali tra cui una grave flebite che rischia di ostacolare l’infusionedegli ultimi cicli terapeutici. Mi parla del disagio della malattia ma anche del suosenso di inadeguatezza. Le faccio fare un disegno (Fig.53) di sé secondo le diret-tive di Simonton che includono nello stesso disegno la rappresentazione dellamalattia, delle terapie e delle risorse. Si disegna orientata al passato e mancantedella parte bassa del corpo. Il tumore viene disegnato fuori dal corpo come unaspirale e la chemioterapia come una flebo che fluisce nel braccio. Il tutto in biancoe nero. Al contrario le risorse sono disegnate a colori. Dal disegno era evidentecome lei si considerasse guarita: in effetti il tumore dovrebbe essere stato aspor-tato completamente. Pertanto lei giudicava che la chemioterapia era inutile, anzidannosa. In questi casi la chemioterapia è indicata per bonificare le micrometa-stasi, quasi sempre presenti e non diagnosticabili. Lavoriamo sul significato dellachemioterapia utilizzando la metodologia e le visualizzazioni di Simonton, maanche sul suo bisogno di controllo che si apre su un senso di inadeguatezza, dinon essere all’altezza, di dipendere dall’approvazione degli altri. Usiamo la bioe-nergetica, le musiche subliminali e delle meditazioni profonde anche con il man-
251
Fisiopatologia dello stress
tra, per esplorare le cause limitanti e stimolare le risorse verso l’accettazione di sée delle terapie. Lavoriamo con incontri settimanali per circa 4 mesi. Gli effetticollaterali della chemioterapia sono notevolmente ridotti e comunque ben tolle-rati. Si sente anche molto cambiata. Dice: “la malattia mi ha cambiata in meglio”; “po-trei addirittura dire che ringrazio Dio per avermi dato questa malattia perché finalmente hol’opportunità di ritrovare me stessa”; “questi sono gli anni più belli della mia vita, perché possofinalmente essere me stessa”. Si sente meno tollerante, meno accomodante, più con-sapevole dei suoi bisogni profondi, percepisce un senso di ribellione focalizzatonella pancia: mi racconta che l’ultimo quadro che ha dipinto (è una pittrice) eracompletamente diverso dagli altri. Prima usava colori pastello, delicati, perfetti ousava il bianco e nero. Quest’ultimo è un mare in tempesta con colori molto ac-cesi. Adesso ha completato le terapie, è in remissione completa di malattia, stabene e si sente bene.
Aurora. 50 anni, sposata con una figlia. Ha un tumore del pancreas operato edin corso di chemioterapia. Ha molto dolore. Sua madre ha un tumore della mam-mella in remissione completa ed è molto depressa, mentre la sorella muore pertumore del pancreas. Tutta la sua vita è centrata sul lavoro. Si sente bene finchèriesce a nascondere tutto come uno struzzo ma il dolore la riporta alla realtà.Dopo le problematiche relative al tumore comincia a raccontare delle sue scon-fitte, delle rinunzie, per conquistarsi la libertà, dei suoi lutti. Ogni volta che entranella sua sofferenza, solitudine, ha un’emozione e disagio nell’area epigastrica,addome superiore e le viene da piangere. Le chiedo cosa vorrebbe fare se que-sto fosse il suo ultimo anno di vita, risponde: “niente. Perché dovrei fare qualcosa se poitutto finisce?”. Lavoriamo molto sulle sue sofferenze, ma anche sulle sue risorse, percirca 4 mesi. Sta molto meglio, non ha più dolori, ha finito la chemioterapia, cli-nicamente è in remissione completa. La rivedo dopo alcuni mesi e sta benissimo,ha trasformato la sua vita, va in palestra ed è felice anche perché ora aspetta unnipotino.
Anche Carl Simonton considera il lavoro sulla morte come uno dei punti car-dine del suo metodo psiconcologico. È un programma formativo per pazienti, ac-compagnatori e sanitari che può essere schematizzato secondo le seguentitematiche, così sviluppate nei suoi corsi intensivi di 3 o 5 giorni:
Marcello Aragona, Francesco Aragona
252
Importanza della gioia, del gioco e della dolcezza nella propria vita
Uso della visualizzazione, il contatto con la saggezza interiore: come utilizzarli per inte-grare il potere dello spirito e della spiritualità nel processo di guarigione
Simonton osserva, come fanno anche altri studiosi, che le persone che guari-scono o che vivono a lungo, fanno dei grandi cambiamenti negli stili di vita (Si-monton 2005, LeShan 1994, Hirshberg 2005). Berry Siegel li chiama pazientieccezionali (2002). Questi con grande frequenza hanno cambiato le loro cre-denze, dato nuovi significati alla loro vita, stretto forti legami con amici, parenti,sanitari; hanno imparato ad esprimere le emozioni, a prendere il controllo dellapropria vita, risvegliare il desiderio di scoprire e comprendere chi siamo real-mente, essere meno tolleranti, meno pazienti, essere più spontanei.
Con questa spinta positiva sull’attivazione delle risorse interiori ho provato adattivare un “progetto di ricerca sull’approccio transpersonale in pazienti con tumore mamma-rio in remissione clinica”.
Sono stati inclusi nello studio 55 pazienti con tumore della mammella in re-missione clinica (parziale o completa) non in trattamento antiblastico. Ci incon-travamo in gruppo per circa tre ore ogni settimana e per circa un anno. Ognigruppo era per massimo 15 persone. Lavoravamo condividendo le sofferenzeper trasformarle e stimolando le risorse secondo l’approccio psicoterapeuticotranspersonale, psico-corporeo-spirituale. Lavoravamo con la Bioenergetica(Lowen 1983, Grossman 1992, Ponticelli 2005), entravamo nel profondo con tec-niche di Psicodinamica, secondo il metodo di M. Maltz dell’Istituto Sperimentaledi Psicodinamica Applicata (ISPA di Milano) (Riva 2001); usavamo specifiche vi-sualizzazioni guidate, dedicate anche alla stimolazione del sistema immunitario;elementi del metodo Psico-Oncologico Simonton (1978, 2004, 2005); la meta-musica con la “Binaural beat tecnology” (Hemi-Sync, Monroe Institute, Virgi-
253
Fisiopatologia dello stress
Trasformazione di pensieri e credenze per gestire il dolore emozionale e stress relativi alcancro, ai trattamenti, sistema di guarigione del proprio corpo, sistema immunitario, la vitae la morte
Sviluppare la fiducia e speranza, come aumentarle e mantenerle
Comprendere il significato della malattia, messaggio, i vantaggi nascosti
Identificare i propri bisogni essenziali
Come i nostri comportamenti e il nostro stile di vita influenzano la salute
Creare un programma di salute di 2 anni, fissandosi degli obbiettivi secondo un ritmo sano,lasciando spazio alla gioia e alla pienezza
Trovare delle ragioni per vivere
La persona di sostegno e il suo ruolo, la comunicazione
Affrontare la recidiva e la morte come stimoli ad aumentare l’energia per vivere e guarire
Il ritorno a casa, come mantenere il processo di ritorno alla salute
nia, USA) che stimola a basse frequenze acustiche (onde delta) una sincronizza-zione tra i due emisferi cerebrali. L’esperienza terapeutica veniva integrata conl’uso di arteterapia, di condivisione e psicoterapia di gruppo ad orientamentotranspersonale.
Abbiamo cercato di aumentare la consapevolezza sia a livello corporeo inter-venendo su percezione, sensibilità e schema corporeo; sia a livello emotivo sullapercezione delle emozioni, dei blocchi emotivi pregressi ed attuali, anche con-nessi alla malattia tumorale, ma spesso riferiti ad altre problematiche più pro-fonde; sia a livello mentale sui modelli di trasformazione dei costrutti mentali,delle credenze, delle convinzioni malsane; sia a livello sociale sulle relazioni im-portanti, sui doveri, sensi di colpa; sia a livello spirituale sulla consapevolezza disé, sull’autostima, sulla realizzazione di sé e sul senso della propria esistenza.
Tutti i pazienti hanno riferito un notevole miglioramento del benessere sog-gettivo in vari aspetti della loro qualità della vita e chiedevano esplicitamente dicontinuare questi incontri terapeutici di gruppo. Numerosi pazienti riferivanospesso che vedevano gli altri componenti del gruppo come trasformati in me-glio, mentre non pensavano la stessa cosa di se stessi. Questo effetto tendeva adattenuarsi nel tempo, man mano che aumentava la consapevolezza di sé. Moltepersone riferivano alcuni cambiamenti importanti riguardo i loro stili di vita, sisentono sempre più responsabili della loro vita che vivono con più gioia, piacere,con meno paure, con più decisione, sicurezza di sé. Molti dicono: “adesso mi sentouna ‘persona’ e sono padrona della mia vita”; “sono stata sconosciuta a me stessa per anni”,“ora mi sento più responsabile e più decisa”, “riesco a giocare”, “mi sento felice”, “ho ritrovatol’armonia con i miei familiari”, “questi sono gli anni più belli della mia vita”, “gli amici mivedono rinata”, “è stato illuminante scoprire che posso volermi bene”.
Pian piano i bisogni fondamentali, fisici, legati alla malattia ed i bisogni di si-curezza, emozionali diventavano sempre meno importanti, perdevano quellagrande priorità determinata dalla malattia. Le persone infatti cominciavano a ren-dersi conto di quali erano i loro veri bisogni, quelli più profondi, quelli a cui ave-vano rinunziato, per adattarsi all’ambiente sociale in cui avevano scelto di vivere.Cominciavano ad avere sempre più importanza il bisogno di autostima, piuttostoche di essere approvate dagli altri, ed il bisogno di realizzazione di sé (graf. 1).
Marcello Aragona, Francesco Aragona
254
Grafico 1: il test SEIQoL sulla qua-lità della vita descrive la riduzione diimportanza dei bisogni fondamen-tali, fisici ed emotivi, di sicurezza ri-spetto al test basale (p=0.05).Aumentano gli aspetti esistenziali(bisogni di autostima) e spirituali (bi-sogni di realizzazione di sé) (R2=0.9303; r= 0,898; p<0,001).
Grafico 1: il test SEIQoL sulla qualità della vita descrive la riduzione di im-portanza dei bisogni fondamentali, fisici ed emotivi, di sicurezza rispetto al testbasale (p=0.05). Aumentano gli aspetti esistenziali (bisogni di autostima) e spiri-tuali (bisogni di realizzazione di sé) (R2= 0.9303; r= 0,898; p<0,001).
Cominciavano a definire i loro tempi, delimitare i loro spazi, inizialmente conqualche senso di colpa, ma poi con grande piacere e benessere. Cominciavano atrovare alcune risposte chiave ad domande tipo: Chi sono? Che cosa faccio qui?Ho un’idea chiara di ciò che voglio dalla mia vita? Sono felice di come sono, op-pure credo solo di esserlo? Sono realmente quello che credo, oppure sono ciòche gli altri vogliono che io sia? Conosco tutte le potenzialità del mio essere?Quali sono i miei ideali? Si sentivano sempre più centrate su se stesse e menosulle aspettative degli altri.
Miglioravano anche il tono dell’umore e l’auto-valorizzazione, secondo il testdi personalità MMPI2. A livello biologico e particolarmente a livello del sistemaimmunitario si è osservato un miglioramento con riduzione dell’Interleuchina-18 (IL18) pro-infiammatoria ed aumento della dell’Interleuchina-12 (IL12) sti-molatoria (graf. 2). Tuttavia, dato il ridotto numero di casi, l’analisi statistica nonè significativa.
Grafico 2.
Quasi tutte queste pazienti sono in buona salute ed in atto in remissione com-pleta di malattia.
Ho presentato questi dati al Congresso Mondiale di Psiconcologia (IPOS) aVenezia nel 2006 (Aragona 2006, Respini 2006) ed altri risultati al successivo Con-gresso IPOS nel 2007. Questi miglioramenti sono stati parziali solo in 3 soggetti:
G.S. 50 anni, con tumore mammario con metastasi ossee. Ha forti dolori alla
255
Fisiopatologia dello stress
spalla sinistra ed è in trattamento con oppioidi (fentanyl transdermico) + antin-fiammatori. Tuttavia il dolore continua ad essere forte. Durante un gruppo set-timanale, dopo una mediatazione, ha notato la scomparsa del dolore. L’effetto èdurato 2 giorni circa. L’analgesia dopo la meditazione si è ripresentata anche neigruppi successivi. Dopo un poco non ha partecipato più ai gruppi, la malattia èprogredita fino a portarlo a morte circa un anno dopo.
Questi tre soggetti hanno contattato la possibilità di trasformare la loro vita eridiventarne artefici, ma hanno scelto di non farlo, di non alterare l’equilibrio rag-giunto, hanno preferito rimanere nella loro sofferenza pur di non rischiare di al-terare gli equilibri costituiti, individuali, familiari e sociali, spirituali.
La maggior parte degli altri soggetti hanno chiesto entusiasticamente di con-tinuare in questo percorso da cui a loro dire hanno tratto enorme giovamento.Pertanto ho attivato in modo stabile e continuativo questo modello terapeuticodi gruppo, nel mio reparto ospedaliero-universitario.
In conclusione, nonostante l’enorme difficoltà a stare accanto a queste personeche soffrono intensamente, è altamente gratificante stare insieme a loro, riuscirea guardarsi negli occhi, toccarsi e gioire di questi brevi ma intensi momenti dicrescita reciproci, dove è relativamente importante saper “fare”, ma soprattuttosaper “essere”, consapevoli dei nostri limiti, delle nostre maschere ed essere di-sponibili ad accettare di essere lo strumento attraverso cui la persona che soffrepuò scegliere di fare ciò che è pronto a fare, per ritrovare se stesso.
Come scrive Patch Adams (1999): “La visita porta al capezzale del malato una po-tente medicina… per alleviarne la sofferenza. Rendetevi conto che il modo con cui trattate unamico malato è un potente strumento a vostra disposizione”.
Cercando di mantenere l’umiltà nel riconoscere i limiti della nostra cono-scenza, possiamo apprezzare quello che scrive Berry Siegel (2002): “Se davvero vuoicomprendermi, ti prego, ascolta quello che non dico, quello che non sarò mai in grado di dire”.Questa comprensione, anche se molto più difficile di quella cosciente, è molto piùdiretta, va oltre le parole: è una qualità che può e deve essere coltivata. Se vo-gliamo cercare il senso della nostra vita, per ritrovare il piacere di vivere, pos-siamo forse comunicarlo ai nostri pazienti, con il nostro modo di essere.
Accedere a livelli diversi di coscienza permette di avere una visione più ampiadella propria realtà e di intravedere la possibilità che una soluzione ci sia, per tro-vare un senso alla sofferenza, un sollievo, ma anche per accettare la realtà cosìcom’è, quale passaggio fondamentale per affrontare la morte, ma ancora di piùla vita, lunga o breve che sia.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
256
Come ci insegnano le neuroscienze questo processo riflette fasi funzionali delnostro cervello che possono essere modificate semplicemente spostando i livellidi attenzione, focalizzandola concentrandosi sulla sofferenza o sul benessere, op-pure espandendola al di la dei confini sensoriali verso la spiritualità (diffusa atti-vazione cerebrale) tramite cui è più facile avere una visione d’insieme, quella cheWilber e le grandi tradizioni spirituali definiscono “coscienza dell’Unità”. La solacoscienza razionale della corteccia cerebrale sinistra non ha questa possibilità,che si può acquisire solo quando si riesce ad integrare tutte le funzioni cerebrali,specie quella razionale con quella intuitiva, creativa, della corteccia cerebrale de-stra. Con questo accesso anche la vita e la morte possono essere viste come mo-mento di passaggio. Come dice Simonton “la maggior parte delle persone che hannopaura della morte, non si sono concesse alla gioia, nel corso della vita”. L’attaccamento allavita non è più necessario quando si è pronti al “grande salto” e, paradossalmente,qui comincia la gioia di vivere.
BibliografiaAragona F., L'azione cardiotossica delle catecolamine: la miocitolisi coagulativa. Zacchia
1990, 63, 253-92.Aragona F., L' immagine istologica delle surrenali quale test psicologico post-mortale. Riv. it.
med. leg. 1990, 12, 125-38.Aragona F., La miocitolisi coagulativa ed i suoi esiti nelle vittime di omicidio. Riflessioni sulrelativo significato psicologico. Pathologica 1991, 83, 259-80.
Aragona M., Il sistema Psico-Neuro-Endocrino-Immunitario in Oncologia. Riv. it. oncol,XV, 5-6, 103-15, 1988.
Aragona M., Mondio M., Panetta S., Detection of lymphocytic (PBL) ß-endorphin (ß-END) by flow cytometry (FCM). Pharmacol. Res., London, 26, S2, 182-3, 1992.
Aragona M., Cavaliere R., Panetta S., Ferlazzo G., Costa G., Adamo V., FCM de-tection of lymphocytic ß-endorphin in cancer patients during hospedalization and after invitro culture with IL2. Pharmacol. Res., London, 26, S2, 180-1, 1992.
Aragona M., Aragona F., Feocromocitoma e cardiomiopatia da catecolamine. Pathologica,Genova, 84, 1090, 197-203, 1992.
Aragona M., Aragona F., Chronic stress and histologic effects on the human central nervoussystem and other organs. Funct. Neurol., Roma, 9, 3, 121-131, 1994.
Aragona M., Muscatello MRA., Mesiti M., Prevalence of depressive mood disorders inbreast cancer patients of Southern Italy. Ann. N.Y. Acad. Sci., New York, NY., 784,
257
Fisiopatologia dello stress
482-485, 1996.Aragona M., Muscatello M.R.A., Pastura G., Castagnetta L., Mesiti M., Estrogen re-ceptor expression and depressive mood disorders in untreated breast cancer patients. Oncol.Rep., Atene, 3, 661-665, 1996.
Aragona M., Muscatello M.R.A., Losi E., Panetta S., La Torre F., Pastura G., Ber-tolani S., Mesiti M., Lymphocyte number and stress parameter modifications in untrea-ted breast cancer patients with depressive mood and previous life stress. J. Exp. Ther.Oncol., London, 1, 354-360, 1996.
Aragona M., Muscatello M.R.A., Mesiti M., Depressive mood disorders in patients withoperable breast cancer. J. Exp. Clin. Cancer Res., Roma. 16, 1, 111-118, 1997.
(Dati selezionati, per qualità metodologica, insieme ad quelli di altri 28 studi edutilizzati per una meta-analisi pubblicata da Petticrew su British Journal ofHealth Psychology (1999).
Aragona M., Panetta S., Silipigni Am., Romeo D., Pastura G., Mesiti M., CascinuS., La Torre F., Nerve Growth Factor Receptor Immunoreactivity in, Breast Cancer Pa-tients. Cancer Inv. 19 (7), 692-697, 2001.
Aragona M., Broccio L., De Cataldo P., Morelli M., Panetta S., Pantò S., PasturaG., Talamo Rossi R., Sica A., Verna A., La Torre F., Experience of Staff SupportGroup Meetings in Messina Medical Oncology. 4. Congresso Nazionale di Oncolo-gia Medica (AIOM). Torino, 28 sett.-1 ott. 2002. Ann. Oncol. 13, S3, 50, 2002(1. premio Sergio Sugliano, come miglior Poster sulle Cure Palliative e Psi-concologia, istituito dalla Fondazione Ricerca Tumori Molinette).
Aragona M., Le emozioni nella relazione di cura in oncologia, in M. Gensabella Furnari(a cura di), Il paziente, il medico e l’arte della cura. Rubbettino Ed. pp. 189-211,2005. Atti del Seminario di Studi di bioetica clinica. Messina 25 gennaio 2003.
Aragona M., Aspetti Psicobiologici di pazienti con tumore della mammella: relazioni con lasopravvivenza. Relazione all’8. Convegno Nazionale della SIPO (Società Italianadi Psico-Oncologia). “L’integrazione tra cure mediche, trattamento farmacologico e in-tervento psicologico in oncologia”. Acireale (Catania) 7-11 ottobre 2003. Atti delconvegno a cura di Lucia Toscano. Lorenzo Strano Catania, 101-103, 2004.
Aragona M, Muscatello M.R.A., Panetta S., Psycho-biological variables before diagnosismay predict survival of breast cancer patients. Atti del VI Congresso Nazionale diOncologia Medica - Bologna 21-24 settembre 2004. Ann. Oncol. N 53, 2004.
Aragona M., Tecniche psico-corporee e qualità di vita in oncologia: risultati preliminari di unasperimentazione clinica. Atti del 9° Congresso Nazionale Società Italiana di Psi-concologia. Arcavacata di Rende (CS) 16-18 giugno 2005; Giorn. It. Psico-Oncol.. 7, 64-65, 2005.
Aragona M., Arena R., Amico G., Bonforte C., La Torre F., Nuovi approcci di sup-porto per la riduzione del burnout: lo Shiatsu ad oncologi medici. Atti del 9° Congresso
Marcello Aragona, Francesco Aragona
258
Nazionale Società Italiana di Psiconcologia. Arcavacata di Rende (CS) 16-18giugno 2005; Giorn. It. Psico-Oncol. 7, 31-32, 2005.
Aragona M., Gruppi di Condivisione e supporto per operatori sanitari in onco-logia. Relazione tenuta all’Adunanza della Classe di Scienze Medico-Biologi-che tenuta a Messina il 30-11-2004. Atti Accademia Peloritana dei Pericolanti.Edizioni Scientifiche Italiane. Messina-Napoli. Vol. XC-XCII: 287-290; 2005.
Aragona M., Sperimentazione clinica di Terapie Psico-corporee per migliorare la Qualità diVita e la funzionalità del Sistema Immunitario di pazienti con tumore della mammella inremissione clinica: risultati preliminari sulla qualità di vita. Atti dell’Accademia Pelo-ritana dei Pericolanti. Aprile 2005. Vol XCIII-CCLXXVIII, 57-62; EdizioniScientifiche Italiane, Napoli. 2006.
Aragona M., Transpersonal mind-body-spirit approach to explore different levels of sufferingand well-being in persons living with cancer: an experimental study. Atti del 8th WorldCongress of Psycho-Oncology. Venezia 18-21 ott 2006. Psycho-Oncology15(2):125-126; 2006
Aragona M., Metastasi Cerebrali aspetti bioetici e psicologici. Atti del Winter Meetingdella Società Italiana di Neurochirurgia (SINch). Roma 2-4-feb-2006. Instampa.
Aragona M., Communication with patient from the psychoncologic point of view. Atti del 55°Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurochirurgia (SINCh). Sor-rento 18-22 novembre 2006: pp.12-15.
Aragona M., Panetta S., Altavilla G., Transpersonal integrated interventions to improvequality of life in cancer patients in all stages of disease. Atti del 9th World Congressof Psycho-Oncology. Londra 16-20 2007. Psycho-Oncology 16: S97–S98(2007).
Aragona M., Neuroscientific and transpersonal aspects of spirituality. Atti del 10th WorldCongress of Psycho-Oncology. Madrid 9-13 giugno 2008. Psycho-Oncology.
Aragona M., Approccio Transpersonale in Oncologia. Atti Del Xi Convegno Nazio-nale SIPO (Società Italiana di Psico-Oncologia) Senigallia (An) 1-3 Ottobre2009. pp. 149-151. 2009.
Aragona M., Living And Dying: Therapeutic Relationship Improvement through Death Ac-ceptation in the Transpersonal Approach. [Workshop]. Atti del 11° Eurotas Italy2009: Beyond The Mind: Towards a Consciousness of Unity. From a Cultureof Competition to a Culture of Sharing. Milano 15-18 Ottobre 2009. AnimaEdizioni 2009:46-48
Beauregard M., Paquette V., Neural correlates of a mystical experience in Carmelite nuns.Neuroscience Letters: 405 (3): 186–190, Sep 25, 2006.
Beauregard M., God on the Brain. Science Vol 313: 1369; 8 sep 2006.Biondi M., Pancheri P., Clinical research strategies in psychoimmunology: a review of 46
259
Fisiopatologia dello stress
human research studies (1972-1992). In, Leonard BE, Miller C, eds. Stress, the im-mune system and psychiatry. Chichester: Wiley 85-111, 1995.
Burns J., The social brain hypothesis of schizophrenia. World Psychiatry 5:2 -June 2006:77-81.
Davidson R.J. et al., Individual Differences in Prefrontal Activation Asymmetry Predict Na-tural Killer Cell Activity at Rest and in Response to Challenge. Brain, Behavior, andImmunity 13, 93–108 (1999)
Davidson R. J., Cognitive Neuroscience Needs Affective Neuroscience (and Vice Versa).Brain and Cognition 42, 89–92 (2000).
Davidson R.J., Kabat-Zinn J., Schumacher J., Rosenkranz M., Muller D., Santo-relli S.F., Urbanowski F., Harrington A., Bonus K., Sheridan J.F., Alterations inBrain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation. Psychosomatic Me-dicine 65:564–570 (2003).
Davidson R.J., Kabat-Zinn J., Schumacher J., Rosenkranz M., Muller D., Santo-relli S.F., Urbanowski F., Harrington A., Bonus K., Sheridan J.F., Alterations inBrain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation. Psychosomatic Me-dicine 66(1):148–52 (2004).
Davidson R.J., Well-being and affective style: neural substrates and biobehavioural correla-tes. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B (2004) 359, 1395–411)
Davidson, R. J., van Reekum C., (2005) Emotion is not one thing. Psychological In-quiry, 16, 16-18.
Dossey L: Medicina Transpersonale. Red Ed. 2001Ferrucci P., Esperienze delle Vette: Creatività estasi illuminazione, le nuove frontieredella psicologia traspersonale. Astrolabio, Roma, 1989.
Giordano J., Engebretson J., Neural and cognitive basis of spiritual experience: biopsy-chosocial and ethical implications for clinical medicine. Explore. 2(3):216-25; 2006.
Grof S.: Oltre il cervello. L’esplorazione transpersonale delle possibilità della coscienza umana.Cittadella Ed. Assisi. 1997.
Grof S.: L’ultimo viaggio: terapia psicheddelica, sciamanesimo, morte e rinascita. Urra Ed.Milano. 2007.
Grossaman J., Vivere ed Amare. Ed. Crisalide. 1992.Hirshberg C., Living with cancer: from victim to victor, the integration of mind, body, andspirit. 2005.
Jung CG., Symbols of transformation. 1912Kasprow: A Review of Transpersonal Theory and Its Application to the Practice of Psy-chotherapy. J Psychother Pract Res, 8(1): 12–23, Winter 1999
Kübler-Ross E., La morte e il morire, tr.it. C. Di Zoppola, Cittadella editrice, Assisi1992.
Lattuada PL. Oltre la mente. Teoria e pratica della psicologia transpersonale. Franco An-
Marcello Aragona, Francesco Aragona
260
geli Ed. 2004Lazar S.W., Kerr C.E., Wasserman R.H., Gray J.R., Greve D.N., Treadway M.T.,
McGarvey M., Quinn B.T., Dusek J.A., Benson H., Rauch S.L., Moore C.I.,Fischl B., Meditation experience is associated with increased cortical thickness. Neuro-report. 2005 Nov 28;16(17):1893-7.
Leone A., Galletti G., Lupo G., Aragona M., Integrated Transpersonal and MedicalTreatment of Cancer Pain: Phase II Study. Atti del 10th World Congress of Psy-cho-Oncology. Madrid 9-13 giugno 2008. Psycho-Oncology, 2008.
Le Shan L., Cancer as turning point. Plume Ed. New York, 1994.Lissoni P., Malugani F., Manganini V., Ardizzoia A., Gardani G., Bartolacelli E.,
Messina G., Tancini G., Psychooncology and cancer progression-related alterations ofpleasure-associated neurochemical system: Abnormal neuroendocrine response to apomor-phine in advanced cancer patients. Neuro Endocrinol Lett. 2003 Feb-Apr; 24(1-2):50-3.
Lowen A., Bioenergetica. Feltrinelli MI, 1983.Lukoff D., The diagnosis of mystical experiences with pychotic fetures. J. Transpersonal
Psycol 1985; 17:155-81Lutz A., Davidson R. et al., Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma syn-chrony during mental practice. PNAS November 16, 2004, vol. 101, no. 46, 16369–16373.
Maslow A., Toward a psychology of being. Van Nostrand Company, Inc, New York.1962.
Montecucco N.F., Psicosomatica olistica: la salute psicofisica come via di crescita personale,dai blocchi psicosomatici all’unità dell’essere. Mediterranee Ed. Roma. 2005.
Muscatello M.R.A., Aragona M., Carroccio C., Cedro C., Bruno A., La Torre D.,Di Rosa A.E., La Torre F., Zoccali R., Correlation Between Anger and Burnout inthe Oncology Staff. 5° Congresso Nazionale di Oncologia Medica (AIOM) Roma21-24 Ott. 2003. Annals of Oncology 14; S4: iv97, 2003, (comunicazioneorale).
Muscatello M.R.A., Bruno A., Carroccio C., Cedro C., La Torre D., Di Rosa A.E.,Zoccali R., Aragona M., La Torre F., Mattei A., Angelone A.M., Di Orio F., As-sociation between burnout and anger in oncology versus ophthalmology health care profes-sionals. Psychol Rep. 2006 Oct;99(2):641-50.
Patch A., Visite a domicilio. 1999.Ponticelli R., L’emozione della memoria: per non dimenticare chi siamo. Xenia Ed. 2005.Respini D., Lissandrello G., Aragona M., Tralongo P., The Spirituality Human Di-mension as a Join Forces Against Cancer. Atti del 8th World Congress of Psycho-Oncology. Venezia 18-21 ott 2006. Psycho-Oncology 15(2):380-381; 2006
Riva D., Meditazione per la nuova era: tecniche evolutive per il terzo millennio. Edizioni
261
Fisiopatologia dello stress
Mediterranee. 2001. Selye H., The Stress of Life. Lippincott, Philadelphia, 1974. Siegel B., Love, medicine & miracles: lessons learned about self-healing from a surgeon’s ex-perience with exceptional patients. Quill. New York 2002.
Simonton C., Simonton S., Creighton J., Star bene nuovamente. Ed Nord-Ovest.1978.
Simonton C., Seminario introduttivo al metodo Psico-Oncologico Simonton. Fi-renze 2004.
Simonton C., Formative Course for Counseling of the Simonton Method. Schonried, Sviz-zera17-22 apr.2005.
Urry H.L. et al., Neural Correlates of Well-Being Making a Life Worth Living. Psy-chol.Sci.15(6):367-72;2004.
Vaughan F.E., Spiritualità e salute nella psicologia transpersonale. Cittadella Ed. 1989.Wilber K., No Boudary: Eastern and western approaches to personal growth. Shambal,
Boulder, USA. 1981Wilber K.,Grazia e Grinta. Cittadella Ed. 2002.
Marcello Aragona, Francesco Aragona
262