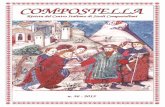I maccheroni di Anton Francesco Doni
Transcript of I maccheroni di Anton Francesco Doni
Vol. CXC ANNO CXXX Fasc. 630 2o trimestre 2013
DIRETTO DA
L. BATTAGLIA RICCI - F. BRUNI - S. CARRAI - M. CHIESA A. DI BENEDETTO - M. MARTI - M. POZZI
2013
LOESCHER EDITORETORINO
I MACCHERONI DI ANTON FRANCESCO DONI (1)
Non c’è troppo da stupirsi se nel sedicesimo secolo – e, almeno per buona parte, anche in quello successivo – il silenzio critico intor-no all’opera di Teofilo Folengo venne infranto quasi esclusivamente da personalità altrettanto eccentriche. Scrive Momigliano: «nel suo secolo il Baldus non trovò nemmeno un critico titolato che lo degnas-se di un serio esame. È però notevole che nessuno lo ricordò per cen-surarlo: evidentemente quel poema era fuori del campo della critica» (2). La peculiarità delle rarissime eccezioni testimonia che gli sguardi dei letterati furono, se non fugaci o distratti, perlomeno intenzionati a ignorare il successo di pubblico delle scandalose Macaronee.
La situazione non fece che peggiorare con l’inasprimento della censura controriformistica, fino alla definitiva comparsa del capo-lavoro folenghiano all’interno dell’Indice clementino nel 1596 (3). Le continue ristampe della redazione Toscolanense rendevano però poco praticabile il tentativo di far passare sotto silenzio l’intera opera del mantovano; e inevitabilmente qualcosa filtrò. Per citare solo due casi tra i più noti, Cesare Caporali fece di Merlin Cocai l’irascibile protagonista di una scazzottata con Francesco Berni nelle Esequie di Mecenate (4), mentre Giordano Bruno si appellò a Mafelina Lodola – musa macaronica dell’astronomia – per la sua catabasi londinese nella Cena de le Ceneri, dopo aver peraltro riciclato nel Candelaio un verso (riadattato) della Moscheide (5). Testimonianze che si vanno a
(1) Desidero ringraziare in questa sede i Proff. Alberto Beniscelli, Simona Moran-do e Franco Vazzoler per il loro prezioso aiuto nella stesura di questo saggio e i Proff. Mario Chiesa e Luca Curti per i fondamentali consigli e suggerimenti.
(2) A. MoMigliano, La critica e la fama del Folengo sino al De Sanctis, in questo «Giornale», LVII (1921), p. 177.
(3) Ancora nel 1557, il futuro Pio V, Michele Ghislieri, poteva scrivere all’inqui-sitore di Genova, a proposito dell’Orlandino, testo folenghiano di moderato successo: «non si leggono come cose a qual si habbi da credere ma come fabule» (L. Von Pa-stor, Storia dei Papi dalla fine del Medioevo, VI, Roma, Desclée, 1922).
(4) Cfr. F. Ciri, “Merlin Coccajo” in Parnaso. Folengo nell’opera burlesca di Cesare Caporali, in «Quaderni Folenghiani», 5, 2006, pp. 97-103.
(5) Ne hanno parlato diffusamente G. BarBeri squarotti, Bruno e Folengo, in questo «Giornale», LXXV (1958), pp. 51-60, M. Faini, Il cosmo di un irregolare. L’u
VARIETÀ
186 VARIETÀ
sommare ai numerosi episodi minori dove la temperie sperimentatri-ce suggerisce un’affinità di fonti e di soluzioni poetiche, inestricabil-mente attorcigliate intorno a un’instabilità dei generi che fu occasio-ne per un’eterodossia non solo formale.
La cronologia e il dato testuale non possono comunque esse-re contraddetti: il primo letterato a citare con una certa regolarità Folengo fu Anton Francesco Doni. Il valore da assegnare a questi rimandi è stato fonte di discussione tra alcuni dei folenghisti più il-lustri, e non contribuisce alla chiarezza l’inevitabile tentazione di ri-unire sotto una seducente etichetta di “eterodossi” dei letterati assai diversi tra loro per biografia, formazione ed esiti artistici. Così Goffis, impegnato – come si vedrà – a smontare l’identificazione di Vigaso Cocaio in Doni, si spinge a dire che «Il Doni ignora l’opera di Merlin Cocai» (6) (corsivo dell’autore), mentre per Momigliano «Il Doni ha amato certamente il Folengo, e ne ha derivato qualche modo bizzarro e qualche invenzione» (7).
Certo è che il poligrafo fiorentino omaggiò Merlin Cocai in una novella dalle molteplici letture “a chiave” nei Marmi, dipinse con tinte simili a quelle dell’ultimo libro del Baldus l’episodio del «gab-bione» dove vengono rinchiusi i poeti nella Zucca e infine citò, in ap-parenza solo di striscio, Folengo in persona nella Libraria. A riprova di questa percepita contiguità tra i due autori va considerata la lunga tradizione che – almeno fin dal Quadrio – identifica Doni o Ludovico Domenichi come la probabile identità nascosta dietro allo pseudo-nimo di Vigaso Cocaio, cioè il misterioso prefatore dell’omonima e ultima redazione macaronica (8), nei secoli variamente considerato un alias dello stesso Folengo o un letterato a lui molto vicino. Del tut-to particolare è infine l’accenno – nella Libraria, nella Zucca e in una lettera – a una fantomatica traduzione delle Macaronee per la penna di un finora non meglio identificato Basilio Berta Rossa, del quale si proverà ad abbozzare un profilo biografico nelle pagine successive.
niverso malinconico del Baldus, in Gli irregolari nella letteratura. Atti del convegno, Ca-tania, 31 ottobre-2 novembre 2005, Roma, Salerno Editrice, 2007, pp. 521-534, e più recentemente S. gulizia, (S)omnia ostendere: Folengo e Bruno a Venezia, in «Quaderni Folenghiani», 6-7, 2010, pp. 113-134.
(6) C.F. goFFis, Finzioni editoriali di Merlin Cocai, in «Convivium», XVI, 1947, p. 777.
(7) A. MoMigliano, La critica e la fama del Folengo sino al De Sanctis cit., p. 185. La vicinanza tra questi autori e l’Aretino è d’altronde alla base dei due fondamentali volumi di Cordié editi da Ricciardi (Folengo, Aretino, Doni. Opere, a cura di C. Cordié, Milano-Napoli, Ricciardi, 1977).
(8) «E questa nuova Riforma scrisse già Vagaso Coccajo (cioè il Domenichi, o il Doni, come si suppone», F.S. quadrio, Della storia, e della Ragione d’ogni Poesia, VI, Milano, Francesco Agnelli, 1739, p. 555. Oltre allo studio di Luca Curti di cui si parla abbondantemente più avanti, si vedano anche le osservazioni contenute in Fo-lengo, Aretino, Doni. Opere, I cit., p. XV: «Carente in generale di ogni nuovo e valido apprezzamento critico l’esegesi settecentesca non mise a punto col Quadrio altro più
187VARIETÀ
1. L’enigma Berta RossaIl primo passo dell’intricata vicenda legata a Basilio Berta Rossa
è la lettera di Doni «a M. Francesco Revesla» (9) del 10 marzo 1547, vergata quando il poligrafo si trovava a Firenze dopo l’esperienza piacentina. In quei giorni aveva avviato, con la protezione del duca Cosimo, una nuova attività di stampatore (10) destinata però a bre-vissima vita. Pochi mesi dopo (circostanza di non poco conto) ci sa-rebbe stata la rottura con Ludovico Domenichi; da quel momento in poi l’ex amico venne osteggiato fino ad arrivare alla delazione presso i suoi avversari (11).
A Reveslate Doni invia un elenco di «opere nello scrittoio» e «opere nella cassa», manoscritte e in attesa di essere da lui stampate. Si tratta di una lista eterogenea («saggio d’una biblioteca curiosa e fantastica», la definisce Bongi) (12), dove già l’improbabilità di alcuni titoli fa scorgere un embrione di quell’operazione di accostamento tra libri reali, parodie e pseudobiblia che caratterizzerà la seconda Li-braria, vero catalogo delle polemiche e delle idiosincrasie doniane (13). Accanto a opere illustri – che comunque per la maggior parte
dell’ipotesi che a Vigaso Cocaio avesse prestato la penna il Domenichi o il Doni. Una congetturina, come si vede, non priva del suo sale accademico, ma anche diminuente e troppo per il Folengo, cui veniva detratta una capacità burlevole ed ammiccante in ordine troppo superiore e non tanto al Quadrio, al Doni stesso o al Domenichi, ma al secolo medesimo».
(9) Anche Reveslate, Reveslà, Reveslato o Reveslati. Più precisamente, con l’indi-cazione di «Francesco Reveslati, Academico Fenicio» sono raccolti quattro suoi sonet-ti ne Il sesto libro delle rime di diuersi eccellenti autori, nuouamente raccolte, et mandate in luce. Con un discorso di Girolamo Ruscelli, Venezia, Al segno del Pozzo, 1553 (Mira con gli occhi, e si dibatte assisa; Mentre, pur vuol per darmi pace, Amore; Hor ben de l’infernali acque l’oblio; Se Amor, tu c’hai ogni mia sorte in mano). Oltre che di Doni, il conte novarese, giureconsulto e occasionale poeta Francesco Reveslate poteva dirsi amico anche dello stesso Domenichi – per il quale aveva fatto da tramite il 16 aprile 1544 con Bona Sforza d’Aragona, regina di Polonia, affinché le donasse il primo libro delle sue Rime – e di Pietro Aretino, che ne elogiò l’abilità di ritrattista dilettante in una lettera del 1545. Sui suoi rapporti col Doni cfr. anche G. Masi, Echi ficiniani dal dialogo ‘Torricella’ di Ottone Lupano al ‘Mondo savio/pazzo’ del Doni, in «Filologia e critica», XVII, gennaio-aprile 1992, 1, pp. 57-58, e G. Masi, Appunti su Anton Fran-cesco Doni e sull’edizione dei ‘Mondi’ e degli ‘Inferni’, in «Filologia e critica», a. XXII, maggio-agosto 1992; l’episodio di Bona Sforza è ricordato anche in G. CioFFari e M. Werner, Bona Sforza: donna del Rinascimento tra Italia e Polonia, Bari, Levante, 2000.
(10) Rimangono preziose ancora oggi le indicazioni biografiche di S. Bongi, Vita di Antonfrancesco Doni fiorentino, in A.F. doni, I marmi, Firenze, Barbera, 1863.
(11) Ivi, pp. XLIV-XLVIII.(12) S. Bongi, Annali di Gabriel Giolito de’ Ferrari da Trino di Monferrato, Lucca,
Giusti, 1890, I, p. 261.(13) Il secondo trattato avrà infatti come titolo Trattato secondo de gli autori, ve-
duti a penna, i quali non sono ancora stampati, il nome, il cognome, i titoli e le materie. A proposito della Libraria e per tutto il discorso che segue, resta valido il giudizio di Amedeo Quondam sul testo doniano, che «presenta una riflessione sullo stato dell’operazione letteraria certamente acuta (e singolare), in grado di mostrare l’altra
188 VARIETÀ
non vedranno la luce grazie a Doni ma ad altri tipografi, come per le Vite vasariane – ne vengono menzionate altre di origine assai dubbia (una Poliantea composta da Giovanni Giustiniano di Candia) (14) o possibili ma perdute (la Gigantomachia di Betto Arrighi (15), che ser-vì da «ispirazione» per la Gigantea di Girolamo Amelonghi, il Gobbo da Pisa, qui sarcasticamente citato in qualità di suo commentatore).
Un po’ a sorpresa, nell’elenco compaiono anche le Macaronee.
Opere nello scrittoio prima Orazioni diverse numero trenta, Lezioni de gli Acade-mici Fiorentini sopra Dante libro primo, Prose diverse antiche di Dante, Petrarca, e Boccaccio, nuovamente raccolte e divise in tre libri, Le vite de gli artefici, architetti, scultori, e pittori, cominciando da Cimabue fino a tempi nostri, scritte per Giorgio Va-sari pittore Aretino, con una introduzione nell’arti del medesimo non meno necessaria che nuova, La Poliantea tradotta in versi sdruccioli per M. Giovanni Giustiniano di Candia, La Maccheronea di Merlino in ottava rima di M. Basilio Berta Rossa […] (16)
Sembrerebbe solo un accenno fugace, oltretutto viziato dal cli-ma informale della stessa lettera. Non sarà il solo. Nella già citata seconda Libraria, edita nel 1551, fa infatti la sua comparsa anche una rubrica dedicata a Basilio. A quattro anni di distanza questo nome difficilmente può essere considerato solo uno pseudonimo inventato sul momento:
BASILIO BERTA ROSSAE’ si suol dire che ogni pittor dipinge sé e che ogni simile appetisce il suo simile,
ma se non ci fosse che ogni regola patisce eccezione, si potrebbe dire che questo uomo galante avesse trovato il suo, avendo tradotta La Maccheronea, in ottava rima (17).
Qui il parere di Doni sulla Maccheronea – lo stesso che divise an-che Goffis e Momigliano – è cruciale per intendere il senso della ru-
faccia – non enunciata dai “teorici” e dai “grammatici” – della sua formalizzata pro-ducibilità, quella che trascrive l’imitazione in parodia, la fedeltà ai canoni in stravol-gimento, l’obbedienza alla grammatica linguistica in beffarda invenzione» (A. quon-daM, La letteratura in tipografia, in Letteratura italiana, diretta da Alberto Asor Rosa, II, Produzione e consumo, Torino, Einaudi, 1983, p. 631).
(14) Cfr. A. roMando, L’officina degli irregolari: scavi aretiniani e verifiche stili-stiche, Viterbo, Sette Città, 1997, p. 112; secondo una nota di Apostolo Zeno al Fon-tanini, «Il Doni nel libro II. delle sue Lettere pag. 61 fa menzione di una Poliantéa, tradotta in versi sdruccioli dal Giustiniano; ma credo, che cotal opera non fosse, se non in quel fantastico cervello del Doni» (Biblioteca dell’eloquenza italiana di Monsignore Giusto Fontanini con le annotazioni del Signor Apostolo Zeno, Venezia, Pasquali, 1758).
(15) Cfr. G. Masi, Il commento doniano alle rime del Buchiello, in La fantasia fuor de’ confini: Burchiello e dintorni a 550 anni dalla morte, Atti del Convegno (Firenze, 26 novembre 1999), a cura di M. Zaccarello, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2002, p. 178. Secondo lo stesso Masi, l’elenco doniano è «un elenco di propaganda editoriale da mettere sicuramente in relazione con l’aggregazione all’Accademia Fiorentina» (ivi, p. 176).
(16) C. riCottini Marsili-liBelli, Anton Francesco Doni scrittore e stampatore. Bibliografia delle opere e della critica e annali tipografici, Firenze, Sansoni, 1960, pp. 339-340.
(17) A.F. doni, La libraria, a cura di V. Bramanti, Milano, Longanesi, 1972, p. 278.
189VARIETÀ
brica, nonché il valore, sarcastico o meno, di quel «galante» uomo; e viceversa. Berta Rossa ha tradotto un’opera in qualche modo simile a lui, tuttavia esiste la proverbiale eccezione per ogni regola. La corre-lazione si sbiadisce. Vedremo ancora questo tipo di ambiguità, forse non involontaria, quando Doni dovrà nuovamente parlare del testo di Merlin Cocai.
A proposito di Basilio, nel suo già citato saggio sulla fortuna di Folengo Momigliano confessa di non essere «riuscito a scovar nulla intorno a questo traduttore dal nome molto singolare, citato – per di più – in quella delle Librarie che ha l’apparenza più sospetta. Se quella traduzione fosse stata fatta e si potesse rintracciare, sarebbe molto curioso leggerla, anche perché sarebbe il primo tentativo d’una versione del Baldus. Ma, ripeto, questa faccenda ha un’aria piuttosto fantastica» (18).
Effettivamente non è facile trovare ulteriori menzioni del mi-sterioso personaggio, almeno per quanto riguarda la sua dimensio-ne letteraria. Gli indizi della presa in giro sembrano celarsi dietro ogni pretesa di plausibilità, sempre abbastanza in vista perché amici e compari possano cogliere al volo l’intento satirico. Né migliora le cose ricordare che il termine «berta», inteso non come forma alterna-tiva di “berretta” ma come calco del francese bertoder, significa “bef-fa” e che lo stesso Doni giocherà sull’equivoco berta-beffa-berretta rossa (e cardinalizia) nella Vita dello infame Aretino (19).
Sembrerebbero esserci ragioni a sufficienza per seguire il buon-senso e collocare tranquillamente Basilio tra le altre creazioni della fantasia doniana. Eppure controlli più approfonditi e ricerche d’ar-chivio mostrano documentate occorrenze del Bertarossa nella Pia-cenza del primo ’500 (la città e l’epoca dell’Accademia Ortolana, a cui sia Doni che Domenichi furono affiliati) all’interno della classe notarile. Proprio da Piacenza Doni era appena tornato prima di scri-vere la lettera a Revesla.
In particolare, nel 1528 un Basilio Bertarossa fu il notaio che suggellò la rinuncia dell’11 dicembre all’esercizio della giurisdizione feudale nei loro territori da parte dei marchesi discendenti dai Mala-spina di Varzi e a favore degli Sforza (20). Ancora, l’abate Don Bene-
(18) A. MoMigliano, La critica e la fama del Folengo sino al De Sanctis cit., p. 184.(19) «Et lo credeste tanto chiaro, che ve ne andaste a casa l’Imbasciador d’Urbino,
a dirgli che vi prestasse il palazzo ducale per che aspettavi d’hor in hora la berretta rossa. La berta rossa, nel nome di Dio, et non la berretta, dovevate aspettare» (A.F. doni, Contra Aretinum, a cura di P. Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli, 1998, p. 67). Il curatore Paolo Procaccioli in nota a «berta» pone semplicemente «beffa».
(20) Nel suo volume sui Malaspina, lo studioso piacentino Giorgio Fiori annota: «I Malaspina che rinunciarono l’11 dicembre 1528 rogito Basilio Bertarossa di Pia-cenza all’esercizio della giurisdizione a favore degli Sforza di Varzi, furono Spinetta fu Antonio, Antonio fu Giovanni, Giovanni fu Francesco, anche a nome dei suoi nipoti, Antonio fu Cesare, Nicola fu Luigi anche a nome dei loro consorti marchesi di Varzi e
190 VARIETÀ
detto Rossetti nel 1795 cita «Basilio Berta-Rossa», «Notare Imperiale ed Apostolico», a proposito di questioni legate alla campana dell’ab-bazia di San Colombano a Bobbio (21). Il nome non certo comune, l’estrazione sociale colta e il periodo – pochi anni dopo la pubblica-zione della redazione Toscolanense – coincidono significativamente. Inoltre, altri Bertarossa (Francesco, Nicolò, Giacomo Antonio) com-paiono nelle cronache dell’epoca (22) e il «podere Berta Rossa» è ancora oggi una proprietà del piacentino, nel comune di Besenzone; ed è ragionevole credere che questo nome sia sopravvissuto nei secoli in virtù degli antichi proprietari.
Un altro dato contrasta con l’ipotesi di Bramanti (23), altrove quasi sempre corretta, riguardo agli autori sconosciuti della seconda Libraria: e cioè che questi siano integralmente parto della fantasia doniana, portati in vita per incarnare una sorta di reazione polemica alla seriosità della prima parte – quella sì, rassegna abbastanza fedele e pioneristica del cosmo gravitante intorno alle tipografie a metà del Cinquecento. Una via di mezzo, in altre parole, tra parodia dei lette-rati in toga e umorismo tongue–in–cheek grondante risentimento per i nemici storici; quasi che nel comporla Doni non avesse più dovuto tenere a freno gli articolati pensieri che gli derivavano dalla sua com-petenza sul campo di dottore in libris. Non a torto, Bramanti ritiene inutile perdersi in indagini perché ciò significherebbe non capire il senso che anima il gioco del fiorentino (24).
di Santa Margherita, nonché Battaglino e Antonio Maria fu Bonifacio, anche a nome del fratello Gianfrancesco, tutti marchesi di Varzi e di Fabbrica». (G. Fiori, I Malaspi-na: castelli e feudi nell’Oltrepò piacentino, pavese, tortonese, Piacenza, TipLeCo, 1995, p. 35).
(21) «Quindi si rileva, che il Comune di Bobbio non ebbe altra torre, né altre campane fuorché quelle del Monastero fino al 1532, in cui le fu ceduta la campana suddetta con quella delle ore per instrumento di convenzione fatta dal Monastero colla detta Comunità, rogato dal Notaro Imperiale, ed Apostolico Basilio Berta-Rossa a’ 5 luglio di detto anno» (Bobbio illustrato dal padre Don Benedetto Rossetti, Torino, Stamperia Sociale, 1795, p. 182).
(22) Cfr. tra gli altri A. Vasina, Repertorio degli statuti comunali emiliani e roma-gnoli: secc. XII-XVI, Roma, Istituto storico Italiano per il Medio Evo, 1998, 2, pag. 399; e l’accenno a un Bertarossa come «causidico» a Roma in G. P. de’ CresCenzi roMani, Corona della nobiltà d’Italia overo compendio dell’istorie delle famiglie illustri, Bologna, Tebaldini, 1639, Parte Prima, p. 219.
(23) «Andranno probabilmente prese sul serio le parole dello stesso Doni che, quasi in chiusura di libro, viene a scrivere che ‘…c’è tal cosa in questa Libraria la quale è sognata che val più che non varranno l’opere che faranno certi biasimatori novelli’, e quindi affidare tutta la compagine di questo secondo Trattato al mondo della fantasia e dell’inventiva del suo autore senza perdersi in indagine destinate per lo più a rimanere prive di risposta» (V. BraManti, Introduzione a A.F. doni, La Libraria cit., p. 39).
(24) Un panorama sistematico ed esauriente degli autori e delle opere nelle varie Librarie è quello di P. Pellizzari, «Per dar cognizione di tutti i libri stampati vulgari»: ‘La libraria’ del Doni, in Nascita della storiografia e organizzazione dei saperi, a cura di E. Mattioda, Firenze, Olschki, 2010, pp. 43-86, anche in relazione alla lettera a Reve-
191VARIETÀ
Eppure il caso di Berta Rossa è un po’ diverso. Per dissipare ul-teriormente le nebbie che avvolgono la sua identità, è opportuno a questo punto dividere le attribuzioni legate all’analisi incrociata tra la lettera a Reveslate e le altre pagine doniane in tre: da una parte libri e relativi autori reali o blandamente celati sotto altro nome, da un’altra opere sconosciute o inventate di personaggi comunque ben noti; sen-za sottovalutare infine chi, proprio come Basilio Berta Rossa e la sua traduzione, appare di ardua identificazione sia personale che relativa ai propri scritti, e che quindi si candida tra i più evanescenti in assoluto.
Oltre a Basilio, compaiono in entrambi i testi – lettera e seconda Libraria – il Burchiello, Brunetto Latini, Dante, Petrarca, Boccaccio, Bartolomeo Bagarotto, Giovanni Brevio, Gelli, il Gobbo da Pisa, l’E-trusco (Alfonso de’ Pazzi), Matteo Palmieri. Tutti autori di limpida biografia o almeno identificabili senza fatica, anche se talvolta citati per opere fittizie e non, come sarebbe lecito aspettarsi, per i capola-vori già riconosciuti in quanto tali all’epoca. Se fosse solo un’inven-zione di Doni, Basilio sarebbe dunque l’unico autore inesistente tra i citati a comparire nei due testi malgrado l’intervallo di tempo, laddo-ve è probabile che parecchie nuove rubriche satiriche a cavallo delle due Librarie siano state composte in tempi non di molto antecedenti alla pubblicazione, secondo l’estro dell’autore e le contingenze della sua movimentata esistenza.
C’è di più. Di una traduzione dell’opera folenghiana si parla una terza volta nella Zucca. Il Frutto XXX è dedicato infatti a un pro-blema che affligge Doni e lo riguarda molto da vicino (si rammenti l’episodio della “traduzione” delle epistole senechiane, in realtà un plagio dall’edizione del 1494 di Sebastiano Manilio) (25): quello rela-tivo ai volgarizzamenti e alle traduzioni dei classici, sovente giudicati con asprezza immotivata da chi non avrebbe i titoli per farlo («Dante quante volte dagli sciocchi è stato levato a cavallo!») (26). Nel brano,
slate. «La sua Libraria ne ha ritrovati molti che giacevano negletti, sull’orlo di un oblio definitivo, e molti altri ne ha “trovati de’ buoni, che soffocati dalla moltitudine de’ libracci, si muffavano”, consegnandoli, quindi, “alla chiarezza di questa età”. Detto in altri termini, ha riscoperto volumi dimenticati, alcuni nonostante il loro valore: la vita di un libro, pertanto, può essere garantita soltanto da un altro libro, che lo riporti alla luce e lo faccia rivivere» (ivi, pp. 51-52).
(25) Cfr. G. Masi, «Quelle discordanze sì perfette». Anton Francesco Doni 1551-1553, in «Atti e Memorie dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colomba-ria», LIII, 1988, p. 23. A testimonianza però di un significato sovente più complesso nelle spregiudicate pratiche tipografiche doniane, cfr. per questo episodio la presenza di Erasmo (e la possibilità di una lettura moralistica per i Marmi) secondo G. geno-Vese, «Parlo per ver dire». Generi d’invenzione morale nei Marmi, in I marmi di Anton Francesco Doni. La storia, i generi e le arti, a cura di G. Rizzarelli, Firenze, Olschki, 2012: sarebbe infatti «verosimile la presenza dell’edizione erasmiana, accanto alla ver-sione di Manilio, sullo scrittoio doniano» (p. 156).
(26) A.F. doni, La Zucca, in Le novelle, a cura di E. Pierazzo, Roma, Salerno editrice, 2003, II, p. 571.
192 VARIETÀ
il Veloce, accademico Peregrino, narra l’episodio di una «dottoressa» (di immediata ambiguità, tant’è vero che a lei ci si rivolge alternati-vamente al maschile e al femminile) che si permette di snobbare Ber-nardo Tasso e Machiavelli. O, addirittura, giudicare con sufficienza Bembo:
Io fui per dirgli: «Deh castronaccio, buffolo, e’ voi mi parete una gran pecora!» ma volli udir prima dirgli dell’altre babuasserie: «Quali sono le traduzzioni che vi piaccio-no – diss’io – da che le composizioni non vi hanno dato alcun gusto?».
«Le cose del signor Aretino mi sanno buone, perché ha fatto stil da sé, e son tutte sue, né va togliendo da questo o da quello, ma da una vena divina naturale». «Questa ve la fo buona, perché è cosa che ci si sa, lo dice ogniuno per una bocca, sì che di questo voi sarete solo a dirne male. Ma delle traduzzioni che dite?». «Polibio mi gusta assai, il Nardi non mi diletta né il Valerio Massimo, il Sacroregno è la mia anima e ho in odio quelle del Dolce». «Ora mi parete voi quel dottore veramente che in prima vista mi imaginai! La traduzzione della Maccaronea v’avvi ella per la fantasia?». «Oh, io non l’ho veduta» disse la dottoressa. «Umbè, messer dottore, voi ve ne rifaresti assai se la gustaste: O mal che Dio vi dia, ell’è la bella cosa!». E qui non potendo più ignorare la sua ignoranza gli feci un risciacquamento, di: «Ignorantone, bestia» e simil epiteti da suo pari. Sì che, signori, la diritta sarebbe a stare a vedere fare gl’altri e attendere a godere quel poco che l’uomo ha (27).
Il passo è ancora una volta di non immediata interpretazione (28) (ma tutto il Frutto è arduo in alcuni passaggi): accenno ironico a una traduzione in realtà inesistente o di comprovata incompiutezza – al-meno nella cerchia degli amici accademici di Doni –, a una di difficile comprensione e degna soprattutto di palati fini, o viceversa a una di bassissima qualità adatta solo per ignoranti come il nostro dottore? Quale che sia la soluzione dell’enigma, la concordanza di queste fonti diverse suggerisce di nuovo uno status per la traduzione di Basilio Berta Rossa superiore agli altri pseudobiblia doniani.
A complicare ulteriormente il tutto contribuisce la vicenda legata all’identità di Vigaso Cocaio, controverso prefatore dell’ultima reda-zione delle Macaronee e ormai identificato da Luca Curti in Ludovi-co Domenichi con decisivi argomenti (29). Colpiscono infatti alcune somiglianze tra il passo qui sopra e la rubrica dedicata nella seconda Libraria allo stesso Domenichi–Echimenedo Covidolo (30). Anche
(27) Ivi, p. 572.(28) Elena Pierazzo, nella sua edizione della Zucca, indica (ibidem) l’opera citata
nella Macharonea di Tifi Odasi, ma la soluzione più semplice – considerata la diffe-renza di statura e la diffusione prevalentemente padovana e orale di Tifi – è che si tratti proprio Folengo. Così d’altronde riteneva anche Momigliano («Questa faccenda ha un’aria piuttosto fantastica, benché lo stesso Doni poi nella Zucca, parlando di traduzioni, nomini e lodi, in mezzo ad altre non inventate, la traduzione della Maccha-ronea»; A. MoMigliano, La critica e la fama del Folengo sino al De Sanctis cit., p. 184).
(29) L. Curti, Vigaso Cocaio, in «Rivista di Letteratura italiana», IX, 1991, pp. 119-176.
(30) Sulla querelle Doni-Domenichi nella Libraria, sulle allusioni contenute nella rubrica di Echimenedo e più in generale sulla vicenda tipografica del catalogo doniano
193VARIETÀ
in queste pagine un dottore di sesso incerto («in utriusque sexus», consueto gioco di parole come anche altrove nei Marmi) (31), eletto a tipologia di pedante e saccente, viene attaccato da Doni con gli stessi termini della Libraria – «bestia» e «buffolo» – in un’invettiva che tocca anche il problema delle traduzioni e dei rifacimenti: «Echime-nedo», che è il vero bersaglio, viene sarcasticamente contrapposto a tali scribacchini.
E gli ch’è tale che si crede essere un gran dottore, ch’io gli avrei fatto conoscere essere un saccente e onorato buffolo! E però con questo credere da bestia, e’ metton mano a voler impacciarsi di stati e tassar le persone da bene. […] Alcuni altri hanno mandato le traduzioni belle e stampate alla stampa a stampare, fatte da altri, e attribuitosi il libro e la fatica, ponendola in uso della loro arrogante ignoranza, dedicando l’opera in suo nome per attaccar l’ancino alla scarsella di alcun signore, colonnello o capitano, sperando di rubarne qualche ducato. Quanti ci sono stati ancora che, essendo gaglioffi, dappochi, insolenti e mariuoli, che non si son vergognati a metter mano nell’opere de’ dotti, con il volerle rassettare, correggere, accrescere e minuirle, ponendo i nomi moderni in cambio degli antichi, così delle città come degli uomini senza vergognarsi? (32)
Nella triangolazione Folengo–Doni–Domenichi, l’identità del prefatore della quarta redazione macaronica costituisce una tappa fondamentale e ancora non del tutto risolta. Prima al Quadrio e poi al Momigliano parve di intravedere i contorni del fiorentino dietro al nome «Vigaso Cocaio», ma Billanovich (33) si oppose a questa pos-sibilità: troppo arduo attribuire a Doni una perizia mimetico–lingui-stica sufficiente a pennellare la prefazione con una patina dal chiaro sentore lombardo. Non c’era insomma ragione di trovare ulteriori «teste di turco»: come Merlin Cocai, Limerno Pitocco, Fùlica o Ac-quario Lodola, anche Vigaso doveva mettersi in fila, ultimo nell’in-terminabile serie dei nom de plume folenghiani. Ancora più drastico, come si è visto, Goffis, convinto dell’inesistenza di un Vigaso diverso da Folengo: «l’argomento che deve indurre a non perdere troppo tempo in simili ipotesi è l’assenza di ogni influsso del Folengo sull’o-pera del Doni» (34). Si tornerà più avanti su questo giudizio lapida-rio, analizzando le singole occorrenze. Per ora è sufficiente ricordare come già il Quadrio avesse citato anche il Domenichi tra i candidati; più di recente, Curti ha dimostrato che le obiezioni sufficienti a ta-
cfr. A. sorella, Riedizioni, varianti e attacchi personali, in «Una soma di libri». L’edi-zione delle opere di Anton Francesco Doni, a cura di G. Masi, Firenze, Olschki, 2008, pp. 37-58.
(31) A titolo di esempio, anche nella rubrica dedicata a «Gismondo Pavese», con tutta probabilità ennesimo alter ego dell’ex amico, lo si accusa di praticare «la lussuria soddomitica, senza freno alcuno di rimordimento o di vergogna».
(32) A.F. doni, La libraria cit., pp. 307-308.(33) Cfr. G. BillanoViCh, Tra don Teofilo Folengo e Merlin Cocaio, Napoli, Piron-
ti e figli, 1948, pp. 189-190, e il già citato intervento di Cordiè.(34) C.F. goFFis, Finzioni editoriali di Merlin Cocai cit., p. 777.
194 VARIETÀ
gliar fuori Doni non sono altrettanto probanti per il suo tradizionale avversario. Nella prefazione appare provata la frequentazione delle Macaronee da parte di Vigaso, ma non a tal punto da consentire l’i-dentificazione con il loro autore. Con buona pace della «precisione» lodata da Goffis (35), la conoscenza delle opere folenghiane è infatti piuttosto imprecisa (datazioni, edizioni, alcuni titoli errati, i tre libri della Moscheide indicati come quattro e il loro metro come «penta-metro», la cronologia delle opere macaroniche, le inspiegabili e cla-morose inesattezze sul Varium Poema) pur dimostrando inaspettata correttezza in dettagli sorprendenti (i dati relativi alla Palermitana, rimasta inedita per secoli). L’ipotesi di Curti è che Domenichi si fosse trovato tra le mani i fogli del monaco appena defunto; il piacentino volgarizzò quindi alcuni esametri autobiografici di Merlino nella Ci-padense – in un paio di occasioni anche letteralmente (36) – e fu forse l’autore di una serie di tagli e rimaneggiamenti tra la Cipadense e la Vigaso Cocaio. Anche Billanovich (37) riconosce la perizia linguisti-ca del prefatore, proprio per negarne l’identificazione con Doni. La stessa possibilità di curare l’edizione, anche se poi non si tramutò in una stampa immediata (la Vigaso Cocaio vede la luce in tipografia solo nel 1552) è un segno non trascurabile di contiguità: tanto che Domenichi non esitò a inserire un lungo accenno a un inesistente quanto concettualmente improbabile rifacimento dell’Orlando Inna-morato da parte di Folengo appena prima che venisse pubblicato il proprio, in una sorta di autopromozione cifrata.
Non è dato sapere se il Basilio Berta Rossa citato da Doni fosse effettivamente il notaio che curò gli interessi locali dei Malaspina, forse affiliato Ortolano che tentò la non facile impresa di tradurre il testo di Merlino, una sorta di schermo per un volgarizzamento da parte dello stesso Domenichi o, ancora, un’opera del notaio usurpata dal piacentino («attribuitosi il libro e la fatica», si dice nella Libraria a proposito delle abitudini di Echimenedo). È comunque probabile che le ragioni per non consegnare Basilio, e con lui la sua traduzione,
(35) «Quanto diversa la prefazione di Vigaso! […] Chi non noterebbe la diffe-renza?», ibidem.
(36) Scrive Curti: «Anche se il contenuto di quella digressione non è, probabil-mente, così leggendario come giudicarono Billanovich e gli altri, e se dunque Vigaso poteva averlo assimilato da altra fonte (collocata, per esempio, all’interno o nelle adia-cenze della famiglia Folengo), il testo della prefazione riflette, in due punti almeno, la lettera di quegli esametri. Uno di questi punti è costituito dall’espressione «per un gran disordine e pericolo della vita» che richiama il «nascente disordine magno» del v. 150; l’altro, dal nome del fantastico istitutore che, prima ancora di accompagnarlo a Bologna, aveva iniziato il puer Merlinus alle macaronee: «Cocaio praeceptore» (vv. 127-8)» (L. Curti, Vigaso Cocaio cit., p. 175).
(37) «[…] la lingua evidentemente dettata da un lombardo e le professioni riso-lute di una retorica che è pure, altrettanto evidentemente, lombarda ci riportano con intera certezza non al Doni, ma al latinista e lombardo Folengo». (G. BillanoViCh, Tra Don Teofilo e Merlin Cocaio cit., p. 190).
195VARIETÀ
alla vacua legione delle opere e degli autori immaginari siano meno fragili di quanto il fantasioso contesto della seconda Libraria lasce-rebbe supporre.
2. Le fontane di LiburnioLa seconda Libraria del 1551 ospita anche una delle prime men-
zioni di Teofilo Folengo in un testo di rilievo. Merlin Cocai non è titolare di una sua rubrica, ma occupa una buona parte del profilo dedicato a Niccolò Liburnio:
NICCOLÒ LIBURNIOGli umori che noi abbiamo nella zucca son tanti e sì fatti, che ci fanno fare di biz-
zarre cose. Oltre che ci fanno comporre l’opere or goffe, or belle, ora ridicolose, ora da piangere e talvolta che le non son buone né a l’uno né a l’altro effetto, ci fanno ancora, poi che le son fatte, mettere sopra il titolo qualche nome finto, per veder talvolta quel che se ne dice per bocca della generalità.
Per questa cagione non mi par ben fatto, avendo udito cento volte biasimare i migliori autori che si legghino e lodare i più goffi che si trovino: e’ mi piace bene a certe cose, come è alla Ficata il comento di Ser Agresto; alla Maccheronea Merlino Cocaio, e simil cose. Le lettere per parte mi danno il mio resto, o certi nomi composti parte dal greco, parte dal latino per parer dotti, come i pedanti per lettera; e di che sorte nomi udite questo, Cataphylomeno Tynamite, per non dire d’altri. Benedetto sia il Liburnio, che non ha voluto finger il suo nome, perché si debbe credere che l’opere che fanno gli uomini, sieno di tre cotte: o belle o mediocri o brutte, e in ciascuno grado che le sieno, le trovono esito, spaccio e vendita. Buone, le si vendano; mediocri l’hanno esito con baratti, con soprasselli, come dire la carne e la giunta; brutte, spaccio a furia: butiri, salsiccie, formaggio, furbicularius e altre fiere della mercatantia dignissime. Ècci poi una cosa che mi piace molto: i titoli secondo l’opere. A quel dire di Merlino, non si poteva imbroccare nel più bel titolo che Maccharonea, il medesimo autore ha fatto il Caos, il Tre per uno, l’Orlandino e altre cose, e a tutte ha acchiappato il nome che si convien loro (38)
Il testo presenta scelte lessicali e semantiche caratteristiche di tutta l’opera doniana, ma che ricorrono con particolare frequenza nei passi in cui viene citato più o meno velatamente Folengo. Non si può tacere l’impressione di forzatura dell’impianto della rubrica, evidente perfino nel contesto del periodare sovente scomposto del poligrafo fiorentino; più che Liburnio, al centro del discorso sembra esserci proprio Merlino, menzionato a proposito di entrambi i nuclei argomentativi della rubrica: l’opportunità di usare degli pseudonimi per le proprie opere e la scelta di titoli efficaci (39).
(38) A.F. doni, La Libraria cit., pp. 155-156.(39) «Un caso particolare (e fuori computo) è costituito dalle menzioni oblique:
Teofilo Folengo non gode di alcuna ‘voce’ specifica nel regesto autori/opere, ma vi è co-munque citato [...] con lo pseudonimo di Merlino Cocaio, all’interno di quella dedicata a Niccolò Liburnio per la Maccheronea, il Caos del tri per uno e l’Orlandino. Quest’ultimo è segnalato anche nella sezione per materie (sotto i Romanzi) e nella Tavola generale (Orlandino Pitocco), nella quale viene immesso pure il Caos» (P. Pellizzari, «Per dar cognizione di tutti i libri stampati vulgari»: ‘La libraria’ del Doni cit., p. 59).
196 VARIETÀ
Né pare casuale che l’esordio sia affidato alle bizzarrie della zucca, ortaggio–metafora verso il quale Doni, al di là dell’opera omonima e dei suoi rapporti con gli accademici Ortolani, sembra avere una vera ossessione (40) e che compare più volte anche nella novella “mer-liniana” dei Marmi. Alla dichiarazione esplicita di pluristilismo (gli «umori» che fanno fare «bizzarre cose», le «opere or goffe, or belle, ora ridicolose, ora da piangere») si accompagna la ripresa del tema gastronomico con la scelta di alimenti bassi, popolari e tipicamente folenghiani: le salsicce, il burro, il formaggio e la riduzione dell’opera brutta a «furbicularius», hapax già di per sé di formazione macaro-nica. Ma la vera rivincita di Merlino, arriva con una breve carrellata delle altre sue opere all’epoca già edite: il Caos del Triperuno (qui sdoppiato in Caos e Tre per uno) e l’Orlandino, più «altre cose»: di certo La Humanità del Figliuolo di Dio o il Varium Poema, entrambi stampati (41) nel biennio 1533–34 da Aurelio Pincio, editore delle epistole senechiane tradotte da Doni nonché, secondo le ricostruzio-ni di Massimo Zaggia (42) e Angela Nuovo (43), della terza redazione macaronica, la Cipadense.
Se Momigliano trova significativa la menzione di Folengo nella Li-braria («In tanto silenzio, anche il pochissimo è qualche cosa») (44), Goffis appare tutt’altro che impressionato. Anzi, proprio dalla cita-zione prende le mosse per negare il legame tra i due autori:
Il Doni ignora l’opera di Merlin Cocai. Per constatarlo cominciamo col prendere in mano la I Libraria, che per essere del 1550 e di intenti bibliografici, dovrebbe conte-nere notizie interessanti. Troviamo, invece, prove di scarsa conoscenza del Folengo. Significative le “assenze”. Assenti le voci Maccheronea e Baldus dall’elenco generale dei libri citati; assenti le stesse voci dall’elenco dei romanzi cavallereschi; nulla nell’elenco delle opere “Sopra la Sacra Scrittura et spirituali”, nonostante la produzione religiosa di Teofilo stia a cuore a Vigaso Cocaio. Solo incidentalmente si loda il finto nome di Merlino Cochaio (!) posto alla Maccheronea, e poco oltre, a proposito di titoli appro-priati, si aggiunge: “non si poteva in broccare nel più bel titolo che maccharonea. Il medesimo autore ha fatto il Caos, il Tre per uno; l’Orlandino; et altre cose, et a tutti a acchiappato il nome che si convien loro”. Vigaso Cocaio è ben informato delle opere del Folengo e certo non dimenticherebbe la Zanitonella, le opere latine e quelle religio-se, non farebbe del Caos e del Tre per uno due opere distinte. È vero che più avanti la I Libraria cita l’Orlandino pitocco ed il Tri per uno Caos; ma queste citazioni confermano, a mio parere, non solo l’ignoranza di tali libri, ma anche il nessun interesse del Doni ad appurare il vero titolo del Caos. Quanto diversa la precisione di Vigaso! (45)
(40) Cfr. a questo proposito M.C. Figorilli, Meglio ignorante che dotto. L’elogio paradossale in prosa nel Cinquecento, Napoli, Liguori, 2008, p. 35.
(41) L’Humanità fu stampata a sé, mentre il Varium Poema e il poemetto Janus vennero inclusi nei Pomiliones di Giovanni Battista Folengo.
(42) Cfr. Breve percorso attraverso le quattro redazioni delle Macaronee folenghia-ne, in Teofilo Folengo nel quinto centenario della nascita. Atti del Convegno, Mantova-Brescia-Padova, 26-29 settembre 1991, a cura di G.B. Perini e C. Marangoni, Firenze, Olschki, 1993 («Accademia Nazionale Virgiliana. Miscellanea», 1), pp. 85-101.
(43) A. nuoVo, Alessandro Paganino (1509-1538), Padova, Antenore, 1990.(44) A. MoMigliano, La critica e la fama del Folengo sino al De Sanctis cit., p. 185.(45) C. F. goFFis, Finzioni editoriali di Merlin Cocai cit., p. 777.
197VARIETÀ
Il Goffis è tanto impegnato nel negare (correttamente) l’identifi-cazione di Vigaso con Doni da opporre argomentazioni non sempre inattaccabili alle frequentazioni folenghiane del nostro. Si è visto so-pra come la meticolosità di Vigaso sia in realtà tutt’altro che adaman-tina, e la corretta citazione in elenco del Tri per uno Caos (46), più che «il nessun interesse del Doni» verso il testo, sembra piuttosto da imputare alla scarsa passione filologica del fiorentino. Di certo Doni, che altrove confessa candidamente di non aver letto alcune opere di rilievo, ha una conoscenza più che superficiale dei testi in questione; altrimenti non si vede come potrebbe (o perché dovrebbe) prendere proprio Merlino a esempio di una lodevole corrispondenza tra titoli e contenuti. È vero, gli manca una certa coerenza nell’usus scribendi: ma se in nota Goffis sostiene ad esempio che Doni, «contrariamente all’uso folenghiano», usi sempre «Maccheronea e maccherone» inve-ce di «Macaronea e macarone», si è visto come nella Zucca compaia «Maccaronea», e «Maccharonea» segua «Maccheronea» nella stes-sa Libraria (e nelle edizioni successive al 1550 viene corretto anche «Cochaio»). Ma alla tesi di Goffis risponde soprattutto una conside-razione rilevante: quella che nega l’incidentalità della menzione fo-lenghiana all’interno della rubrica dedicata a Liburnio e che tenterò di dimostrare, basandomi su una fondamentale intuizione di Folena.
È comprensibile rimanere perplessi di fronte al bifrontismo nelle pagine citate della Libraria, ma va ricordato che il legame tra Folengo e il Liburnio non è affatto peregrino. È lo stesso Caos a darcene con-ferma. Le tre fontane vennero pubblicate a Venezia nello stesso anno (il 1526) e tramite lo stesso tipografo dell’Orlandino di Limerno Pi-tocco, Gregorio de Gregori (47). Seppur portate avanti con una certa rozzezza, le teorie antibembesche di Liburnio – che alla prima delle tre «fontane» della lingua, quella dantesca, ascrive un gettito dop-pio di quelle di Petrarca e Boccaccio, una scelta che probabilmente avrebbe fatto anche Folengo – non si discostano dall’insofferenza del mantovano verso la normalizzazione di quegli anni, o perlomeno dal suo complesso d’inferiorità nei confronti dei toscani. Secondo Mario Pozzi (48) è proprio nell’Orlandino che un simile atteggiamento si traduce addirittura in un’aperta ribellione a Bembo, a Trissino e ai tentativi di regolamentare le diverse stravaganze locali. Ne è una pos-sibile prova «lo exastico» e il primo sonetto nel Dialogo de le tre etadi del contemporaneo Caos:
(46) Nelle edizioni da Sabbio, Tri per uno in frontespizio è composto da tre parole separate.
(47) L’editore dell’Orlandino fu invece Nicolò Garanta; l’opera folenghiana fu forse l’ultima del sodalizio con De Gregori. Cfr. N. harris, Nicolò Garanta editore a Venezia 1525-1530, in «La Bibliofilia», 97, 1995, 2, pp. 99-148.
(48) M. Pozzi, Teofilo Folengo e le resistenze alla toscanizzazione letteraria, in que-sto «Giornale», CLV (1978), p. 178-203.
198 VARIETÀ
MERLINUSTres sumus unius tum animae tum corporis. Istenascitur, ille cadit, tertius errigitur.Is legi paret Naturae, schismatis ille rebus, evangelico posterus imperio.Nomine sub ficto Triperuni cogimur iidem:infans et iuvenis virque, sed unus inest.
LIMERNOGiove, Nettuno, Pluto d’un Saturnoebber a sorte il ciel, il mar, l’inferno;fulmini, denti, teste in lor governo:tre trine insegne per tre cause furno.Tre fonti, oltra la tre del mio Liburno (49),nacquer d’un capo santo al sbalzo terno:così Merlino, Fulica, Limernosi calzian d’un Teofil il coturno.Mantua se ’n ride e parla con Virgiglio:– Tu sei pastor, agricola, soldato(perché del nomen terno Dio s’allegra).Ridi tu meco ancora, dolce figlio,quando che sotto un nome triplicatosortisca una confusa mole e pegra (50).
Non è un riconoscimento da poco. La tripartizione di Teofilo nei suoi due più celebri alter ego più un terzo, Fùlica (‘folaga’: l’animale a cui è legato il casato dell’autore), personaggio del Caos che è anche l’emblema delle dispute teologiche allora preponderanti nell’ordine benedettino, viene legata alle «tre fontane del mio Liburno» in versi di manifesto valore allegorico, dove fortissima è l’insistenza su Virgi-lio triplice autore e sull’elemento trinitario cristiano. Arduo suppor-re a questo punto che si tratti di un intervento casuale: soprattutto registrando il pluristilismo di Folengo, che nel Caos si diverte a va-riare tono e forma abbeverandosi a sua volta alle «tre fontane», una per ciascuno dei suoi personaggi. In particolare, Merlino si concede
(49) Cordié riteneva che «Liburno» fosse da scriversi minuscolo: «latinismo, da liburna, vascello veloce, legno corsaro, che qui sta come «navicella del mio ingegno», ma non è chiaro cosa sarebbero le tre sue fonti». Impossibilitato a interpretare cor-rettamente, deve quindi azzardare che le tre fonti siano «forse quelle delle tre virtù teologali, che il poeta immagina scaturite dal capo di san Paolo quando fu rapito al terzo cielo» (Folengo, Aretino, Doni cit., I, pp. 805-806). Folena chiarisce definitiva-mente la questione: «Non mi par dubbio che qui le «tre fonti […] del mio Liburno» siano Le tre fontane dell’amico Niccolò Liburnio, appena sortite di tipografia accanto all’Orlandino. Credo che questa importante indicazione sia passata finora inosservata, ed è stata obliterata dall’ultimo benemerito editore, che poi è il secondo moderno e il primo commentatore del Caos, il Cordié, che stampa Liburnio con la minuscola» (G. Folena, Il linguaggio del caos. Studi sul plurilinguismo rinascimentale, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, pp. 156-157).
(50) T. Folengo, Caos del Triperuno, in Opere italiane, a cura di U. Renda, Bari-Roma, Laterza, 1911, I, p. 183.
199VARIETÀ
licenze macaroniche e grottesche che – come d’altra parte accade già nel Baldus – mostrano immediato il debito dantesco, laddove Limerno si misura in sonetti dichiaratamente petrarcheschi di buo-na fattura e Fùlica, che pur è lontanissimo dalla coscienza laica e borghese di eredità boccacciana, è comunque il più pronto dei tre a operazioni narrative e metadiegetiche di lungo respiro (come dimo-stra l’Asinaria).
Come sappiamo, a Venezia Folengo giunge subito dopo essere uscito dall’ordine benedettino. Qui medita per breve tempo di de-dicarsi all’attività di stampatore ma finisce precettore in casa Orsini, compito decisamente più idoneo alle sue capacità e al suo bagaglio di latinista (51). Non perde però il contatto con l’ambiente della stampa e attende alla pubblicazione di Caos e Orlandino, impegnandosi in prima persona nel seguire il processo in tipografia. A testimonianza dello stretto rapporto tra l’autore e il De Gregori, sempre nel Caos Paola sostiene che «Limerno compose cosi precipitosamente che li stampatori non poteano supplire a l’abbondanzia e copia de’ suoi versi» (52). Sorti analoghe per Liburnio, che nella città lagunare la-vora prima per breve tempo nell’officina di Aldo Manuzio e si rende parimenti conto di non essere tagliato per un simile mestiere; è poi pievano di Santa Fosca e canonico della basilica di San Marco.
Contando insomma sulla vivacità dell’ambiente culturale venezia-no, fra i due religiosi ci furono sufficienti incroci per legarli d’amicizia e giustificare il familiare possessivo usato da Limerno nel Dialogo. È difficile dire se venticinque anni dopo Doni – con il Caos ristampato solo tre anni prima – si sia ricordato di questo legame e abbia nasco-sto l’omaggio a Merlino nella biografia di un linguista a lui caro; di caratura modesta sì, ma affine a entrambi nell’insofferenza alla rigi-dità normativa che i seguaci del Bembo, allora, stavano cominciando a introdurre col manto dei vincitori nella questione della lingua. Mi limito a far notare che una simile cifratura, per quanto complessa, non sarebbe inconsueta nelle allusioni doniane a Folengo. Più avanti lo dimostrerà una novella dei Marmi.
(51) «Ma Teofilo aveva bisogno di procurarsi presto una dignitosa e sicura si-stemazione professionale […] La prima e più facile professione che si offriva a un letterato fervido e ingegnoso nel grande centro editoriale di Venezia era di vivere con gli stipendi di stampatori. Ma per Merlino, grammatico di esperienza saldissima, più quieto e più onesto era l’ufficio di precettore in una grande famiglia. Teofilo tentò immediatamente la prima via; ma, per fortuna sua e delle Maccheronee, subito dopo ripiegò nella seconda» (G. BillanoViCh, Tra Don Teofilo Folengo e Merlin Cocaio cit., p. 112).
(52) T. Folengo, Caos del Triperuno, cit., p. 175. Per Mario Chiesa, però, questa dichiarazione a proposito dell’Orlandino è formulaica: come viene dimostrato abbon-dantemente nell’introduzione all’edizione critica, la composizione dell’opera fu ben più ragionata di quanto non voglia far credere Folengo. Cfr. T. Folengo, Orlandino, a cura di M. Chiesa, Padova, Antenore, 1991.
200 VARIETÀ
3. L’ineluttabilità della phantasiaIl triangolo Folengo–Domenichi–Doni si riaffaccia in un passo
della lettera fittizia Al S. Cotone Sami della Zucca, già inclusa nella raccolta del 1547, originariamente indirizzata a Domenichi e datata 15 febbraio 1546, poco prima cioè della rottura. Grazie a questa mis-siva l’intricata relazione si arricchisce di un ulteriore protagonista: il Burchiello.
Come si ricordava più sopra, la lettera a Reveslate include, ol-tre alle opere «nello scrittoio», altre «in cassa». Fra queste anche il «Burchiello col comento del Doni» che venne effettivamente stampa-to a Venezia dal Marcolini nel 1553. Nella Libraria Doni non si era scostato dalla prammatica nel presentare il più celebre barbiere del Quattrocento come un autore strampalato e assai insidioso per i suoi interpreti, a metà strada tra il ciarlatano e il custode di una saggezza fatalmente intraducibile per tutti, compreso sé stesso:
Questo antico poeta fiorentino fu uno stravagante cervello, dove alcuni vogliono che le sue rime sien fanfalucole, ciancie e baie, alcuni altri l’hanno per un cervello bizzarro, talmente che si può lasciar nel giudicio del mondo, perché in verità io credo che non ci sia chi l’intenda, e forse egli stesso non seppe ciò che si volesse dire (salvo sempre la ragione de’ comentatori che s’azzufferanno con esso) (53).
Un «cervello bizzarro», indicato per «bizzarre cose» come quelle accennate nella scheda su Liburnio e Folengo. La lettera della Zucca a Domenichi/Sami riporta immediatamente a queste atmosfere «stra-ne», quando non «balzane» o «pazze», notevoli anche da un punto di vista lessicale, rimarcando la difficoltà di un commento:
Ho comentato il Burchiello con le più strane novelle, con le più bizzarre fantasie, con i più pazzi vocaboli e con la maggior cosa d’invenzioni che voi vedeste mai. Ma io vi dico bene che e’ non è pasto da dotti, ma da cervelli balzani (54).
Come si è visto, nella Libraria si intrecciano due motivi: il tentati-vo di sistematizzazione di un universo editoriale in continua crescita e la provocazione verso il mondo delle tipografie e dei commentatori senza scrupoli. Mentre la sua varietà espositiva segue un percorso razionale, non altrettanto si può dire della Zucca: le pagine dell’o-pera più tentacolare di Doni sono frazionate nella struttura secondo una mise en abyme di ispirazione vegetale, e come tali diventano il regno dichiarato di «chiacchiere, baie e cicalamenti» secondo il ben noto modello della conoscenza nascosta sotto un’apparenza innocua. Recita infatti il frontespizio: «La Zucca del Doni fiorentino, divisa in cinque libri di gran valore, sotto titolo di poca consideratione». Il bal-
(53) A.F. doni, La Libraria cit., p. 91.(54) A.F. doni, La zucca cit., p. 470.
201VARIETÀ
zano può così sfidare il dotto e rivelare inaspettate sfaccettature del suo pensiero (55).
Proseguendo la metafora culinaria, Burchiello commentato da Doni non è «pasto da dotti, ma da cervelli balzani», tutto somma-to più stimolante che indigesto. La miscellanea doniana, policentri-ca e polisemica, sfrondata da un obiettivo didascalico-pedagogico e dall’ampio respiro che caratterizza le sue migliori collezioni di novel-le, è in qualche modo terreno fertile per l’introspezione, tanto che è proprio il brano della Zucca a ospitare una riflessione sul lavoro che caratterizza l’uomo di lettere. E per parlare degnamente di Burchiello Doni deve abbandonare il distacco del professionista di tipografia, dare sfogo cioè alla vena più fantasiosa e umorale della propria vo-cazione poetica: in una parola, malinconica. Il tentativo è ricco d’in-sidie, tanto che più di una volta minaccia di assorbire il raziocinio del commentatore; eppure, dovendo dar retta alla Pistola dedicatoria, resta l’unico in grado di spiegare la scelta – o l’auto-imposizione poe-tica – di un autore tanto ostico.
Essendo una volta inalberato, il senno m’inviluppò il ghiribizzo nella fantasia, e mi pareva essere a un medesimo tempo, savio, pazzo, dotto, ignorante, eccetera (56).
L’ispirazione, la molteplicità di uno sguardo durato un baleno dentro la vertigine, il furor che arriva dall’esterno sono dunque ciò che ha influito sugli intenti del Doni per guidarlo verso prode ver-gini ma poco sicure, sfaccettando la sua personalità in una chimera affamata di opposti. Questo rapimento fantastico, passivo e subito, è familiare per il lettore folenghiano fin dal proemio del Baldus:
Phantasia mihi plus quam phantastica venithistoriam Baldi grassis cantare Camoenis (57).
Venit: la scelta della tematica bizzarra arriva spontaneamente in-vece di discendere in linea diretta dalle muse macaroniche, più com-pagne di viaggio del poeta che sue ispiratrici. Nel cruciale libro XXV la combriccola degli eroi, impegnata nelle proprie peregrinazioni in-fernali, si imbatte nella celeberrima «domus phantasiae». Subito una serie di invenzioni e sciocchezze fatta materia attacca fisicamente gli inermi protagonisti:
(55) Lo coglierà perfettamente Giovan Battista Marino, che nella Galeria così fa parlare Merlin Cocai: «La gran Maccheronea da me composta/è fatta a punto come i maccheroni,/che sopra di formaggio hanno la crosta,/e dentro son fodrati di capponi:/perché tanta dottrina v’è nascosta/che non è da inghiottirla in due bocconi./E se ben la coverta è saporita,/chi tocca il fondo si lecca le dita». (G.B. Marino, La galeria, a cura di M. Pieri, Lavis, La Finestra editrice, 2005, p. 285).
(56) A. F. doni, La zucca cit., p. 472.(57) T. Folengo, Baldus, a cura di M. Chiesa, Torino, UTET, 1997, p. 66, I, vv.
1-2.
202 VARIETÀ
Sic phantasiae tenues sensusque bizarridant simul assaltum sociis picigantque cerebros,intrantesque caput sotosora silentia mandant (58).
Sull’ambiguo significato in Folengo del termine phantasia – pa-rola, come si è visto, con cui si apre il poema – si è comprensibil-mente detto molto. Il recente contributo di Marco Faini ne identifica l’origine malinconica e diabolica, ben distante dall’ispirazione esta-tica e divina che invece emana con benefico calore dalle Muse (59) classiche. Il poeta che ne è preda – o il traduttore/commentatore, nel caso del Doni e del Burchiello – perde il controllo dei propri mezzi e viene trasportato in un pelago apparentemente senza fondo, dal quale solo un nuoto affannoso può trarlo in salvo. Non a caso i compagni di Baldo si fanno sedurre dalle bizzarrie della domus e co-minciano a inseguirle, come mosche che non riusciranno a trattenere nel pugno, cercando via via di acchiappare le massime di Epicuro o l’abilità dialettica del pluricitato Scoto. Solo l’eroe intactus remanet, legato com’è a un vitalismo virile che lo rende immune alle fascinazio-ni poetiche: a differenza degli iperletterari Cingar e Boccalo, maestri di parola e per questo inevitabilmente sottoposti alla corruzione che contagia ogni erudito, Baldo antepone sempre l’azione alla contem-plazione. Perfino quando il rumore del dibattito argomentativo mi-naccia di sopraffarlo come un canto di sirena si tappa le orecchie, con ferrea volontà. Merlino e Folengo (e Doni) non godono delle stesse virtù: sono autori che si calano nel labirinto poetico un po’ coscien-temente e un po’ spinti da una fantasia a cui non sanno resistere. Alla fine è proprio la trasumanazione letteraria per eccellenza, la catabasi dantesca, a unirli giungendo fino alla citazione quasi letterale (Doni lo farà anche all’esordio dei Mondi, opera votata alla fantasia e all’im-maginazione dove è chiara l’influenza di Luciano, il «Prometeo nel dire»). Ma quel che più conta è che anche per il fiorentino la dimora dei poeti sia di natura dichiaramente infernale:
Ultimo le girelle stracorsono insino in Parnaso, credendovi trovare quel cavallo bar-dato, quella fonte e quell’altre chiacchiere, o che la fosse vera o no, io mi trovai in una selva scura che la diritta via era smarrita, dove era un gabbione grande grande, o simil cosa (60).
(58) Ivi, p. 1032, vv. 502-505.(59) Nella sua Introduzione a La cosmologia macaronica. L’universo malinconico
del Baldus di Teofilo Folengo (Roma, Vecchiarelli, 2010) Faini identifica due accezioni di phantasia, fantasia e malinconia, che discendono significativamente dalla tradizio-ne medievale: «La fantasia è [...] un’illusione provocata dal demonio [e] nasce come visione delirante nel momento in cui il monaco si trova in una disposizione d’animo dominata da quel peccato capitale che viene chiamato accidia o tristitia. Incapace di concentrarsi, egli si abbandona ad una forma di stupore, di inattività che conduce alla malinconia. Ma può accadere anche il contrario: il monaco, ammalato di malinconia, non riesce a concentrarsi nella preghiera e lascia vagabondare la mente» (ivi, p. 12).
(60) A. F. doni, La zucca cit., p. 472.
203VARIETÀ
La somiglianza tra questo «gabbione» che nell’atmosfera onirica delle visioni malinconiche mantiene i suoi contorni sfumati e e la ga-bia stultorum dell’ultimo libro del Baldus era già stata notata da Mo-migliano. «Dall’episodio finale del Baldus dev’esser in parte derivata l’immaginazione della Zucca, in cui il Doni racconta d’essersi trovato in una selva scura, dov’era un gabbione grande grande, con dentro molti pazzi, fra cui dei poeti» (61).
Hic phantasiae domus est, completa silentimurmure, vel tacito strepitu, motuque manenti, ordine confuso, norma sine regula et arte. Undique phantasmae volitant, animique balordisomnia, penseri nulla ratione movesti, solicitudo nocens capiti, fantastica cura,diversae formae, speciesque et mentis imago. Gabia stultorum dicta est, sibi quisque per illam beccat cervellum, pescatque per aëra muscas (62).
La fantasia ha condotto fino alla sua stessa casa, con un’innegabile volontà propria. Goffis minimizza il legame: «Il rinchiudere i pazzi in una gabbia, ed il dire che i poeti hanno tutti un po’ del pazzo, non mi paiono idee da doverne cercar fonti letterarie. Né il Doni aveva bisogno di suggestioni folenghiane per considerarsi un po’ pazzo, pazzo non poeta. Certo il Folengo ha voluto dire ben altro: lo stare per l’eternità nella zucca corrisponde ad ottenere la laurea di poeta» (63). Tralasciando l’interpretazione del brano conclusivo del Baldus, questa poligenesi – con il topos del poeta pazzo – può ben essere. Eppure le assonanze non si riducono alla semplice superficie: dopo i sofisti, nella cococchia – cioè la zucca allungata del libro XXV – sono presenti tremila barbieri il cui compito è cavare simbolicamente i denti ai poeti che gridano per il dolore. È soprattutto a quest’ultima suddivisione della domus di Merlino che si rifà Doni, tanto che il barbiere Burchiello è il bersaglio dei più combattivi poeti nella Zucca. Tra questi ci sono addirittura Dante e Petrarca che non esitano ad attaccare i sonetti burchielleschi, rimproverando la loro natura mo-struosa e ibridata.
alcuni tirando il cordovano dicevano: – I tuoi sonetti sono ermofroditi, o pazzo umore! – Il Bernia diceva: – O ve’, fusto da far versi! – Dante bravava passeggiando per quella selva, e diceva: – Burchiello, Burchiello, tu te ne vai rigonfio come un quarterone poeta posticcio, tu non lo credi –. Il Petrarca, ch’era in compagnia di Dante lo cominciò a piluccare col dire: – Ogomagogo, non son così paffuti i tuoi sonetti come tu credi, fa-vella con essomeco e non ti mettere in dozzina con i prosanti che non se n’intendono. Io ti farò ben rannicchiare taccola, spippola, grimo e forchebene, sta pure in cotesta gabbia – (64).
(61) A. MoMigliano, La critica e la fama del Folengo sino al De Sanctis cit., p. 185.(62) T. Folengo, Baldus cit., p. 1030-1032, vv. 476-484.(63) C.F. goFFis, Finzioni editoriali di Merlin Cocai cit., p. 779.(64) A.F. doni, La zucca cit., p. 473.
204 VARIETÀ
La condanna della poesia non conosce appello né attenuanti. Ogni poeta è menzognero. Nell’assimilazione citazionistica di Merlin Cocai e Virgilio con cui si chiude il Baldus
He heu, quid volui, misero mihi? Perditus Austrumfloribus et liquidis immisi fontibus apros (65).
si inserisce un sottinteso religioso che spiega e non dà scandalo, mal-grado l’accostamento sulle prime quasi blasfemo, e che toglie pre-gnanza al rilievo di Goffis sulla zucca e la laurea poetica: al di fuori del Libro tutto è ciancia (66), dall’Eneide alle Macaronee. La dimen-sione religiosa è, va da sé, praticamente assente nell’orizzonte donia-no, che preferisce invece concentrarsi sull’intima natura di artigiana-to mendace nascosto dentro ogni opera. È questo anche il senso della lunga tirata con cui «un certo quanqua» arringa i poeti del gabbione con un’esplosiva enumeratio folengo-rabelaisiana (67):
Voi vi tenete bene per savi: quante volte avete voi mentito con le vostre poesie, che non sono altro che lusinghe donate agli orecchi fitti ne’ capi balordi e sciocchi? È ella altro cotesta vostra arte (daché n’andate tanto altieri) che fabrica de bugie, sfacciatezza e ardimento d’ubriachi? Avete voi mai detto se non ladrerie? […] Voi siate i rigogliosi, i pastricciani, i materozzoli, i lecconi, gli svenevoli, che inconocchiate su ogni cosa. Io non vi cederei un iota, stucchevoli, sgangherati, babbioni, scipiti, cianfrusaglia, che avete infino sfardellato la stiatta de’ vapori farnetichevoli, smilzi, intricati e stippole […] Vino d’errore, cibo da diavolo, dicono i dottor santi, che l’è questa vostra cicaleria da voi poesia chiamata (68).
Cibo (ancora) da diavolo, come insegnava Girolamo. Cingar nel Baldus è «salsa diabli». Né un letterato può garantire redenzione: nel ferino universo folenghiano Merlino diventa solo un altro della lunga schiera dei poeti. L’autobiografismo tracima nella metanarrazione.
(65) T. Folengo, Baldus cit., XXV, vv. 657-658.(66) A questo proposito cfr. quanto dice M. Chiesa, Il Parnaso e la zucca: la lette-
ratura secondo il Folengo, in Teofilo Folengo nel quinto centenario della nascita cit., p. 51: «Da questo rifiuto di riconoscere un valore in sé alla letteratura, di porre una di-stinzione di valore fra un suo livello alto e un suo livello basso, discende ancora la gran-de libertà di giudizio critico del Folengo: può chiamare nuovo Petrarca quell’Ariosto sull’opera del quale il Bembo non dice verbo; anteporre Omero a Virgilio e Dante a Petrarca; può mettere insieme Pulci, Boiardo, il Cieco e l’Ariosto proprio mentre gli stessi fiorentini rinnegano il Morgante e altri riscrivono l’Innamorato; può negare ogni modello linguistico o formale e il principio stesso dell’imitazione; l’irregolare Ariosto può autorizzare l’uso dell’ottava nel poema sacro negli stessi anni in cui si pubblicano De partu Virginis e Christias».
(67) È certamente vero che analoghe «girandole di sinonimi», probanti per Mo-migliano, sono «simili alle filatesse di sinonimi della Toscolana, ma non solo di essa», come invece fa notare Goffis; l’elenco cui faccio riferimento, però, è differente da quello analizzato dai due critici (contenuto nella Tavola per Sommario della Zucca) e mi sembra più significativo sia per la sua posizione all’interno del testo che per le affinità foniche e lessicali.
(68) A.F. doni, La zucca cit., p. 474.
205VARIETÀ
Anche Doni lo sa: il destino di chiunque si guadagni il pane scriven-do è segnato, ed è in questo senso, e non limitandosi a una lettura epidermica, che l’accenno nella Zucca
Così, aggiratomi intorno assai, non gli fu ordine a passare per allora, né tempo d’en-trare in quella gabbia (benché io viddi il mio luogo a ordine che m’aspettava) (69).
diventa l’eco perfetta del folenghiano
Zucca mihi patria est: opus est hic perdere dentestot, quot in immenso posui mendacia libro (70).
Nella Zucca l’atmosfera sospesa tra la fandonia e la narrazione ibrida che essa sottende è estesa a tutti gli artisti della parola – nessu-no escluso – dal già citato quanqua. Il suo attacco chiama a correi del Burchiello anche i più blasonati poeti del passato recente e remoto:
Avete voi mai detto se non ladrerie? Come dire: il figliare di Venere, il castrar di Celo, la zana di Giove, la gabbia di Saturno, i sudori di Latona, il dar fuoco di Semele e in-sino ragghiato i due sessi di Bacco! Poi sono infinite le girandole che voi avete cicalato delle fatiche d’Ercole, della zuffa di Nettuno e del Sole, d’un uomo con cento occhi e una donna trasfigurata in vacca, e tante frappe di satiri, sirene, centauri, e il mal che Dio vi dia(71).
Satiri, sirene, centauri hanno in comune l’ambivalenza fisica; ne deriva il valore rappresentativo della semiumanità metaforica propria dei sonetti burchielleschi. In Folengo l’allegoria letteraria raggiunge il culmine quando l’ibrido per eccellenza – la Chimera – fa la sua com-parsa nella conclusione del Baldus, insieme a una misteriosa forma di vita che sembra discendere dai protouomini platonico-aristofanei, riadattati però alle dispute della Scolastica:
Has inter follas scoperta est bestia tandem, cui caput est asini, cui collum more camelli, mille manus, ac mille pedes, ac mille volantes fert alas, ventremque bovis, gambasque capronis, quae si non caudam simiae de retro teneret, cum qua dattornum nequeat scazzare tavanos, toccaret summo coeli testone solarum, atque vorare uno vellet boccone Minervam. Sed quia quidquid agit, cauda mancante, lasagna est, ducitur in nihilum, meritoque Chimera vocatur, quae parit oh magnos montes nascitque fasolus! Hic quoque monstrum aliud duplici cum ventre videtur qui sustentatur binis tantummodo gambis; sic tenet impressos tacuini charta gemellos Castora, Pollucem, monstrans signalia lunae.
(69) Ivi, p. 473.(70) T. Folengo, Baldus cit., XXV, vv. 649-650.(71) A.F. doni, La zucca cit., p. 475.
206 VARIETÀ
Non aliter formatur ibi vir corpore duplo, sive viri duplices coëuntes inguine tantum. Dicitur hic Utrum; Utrum forma ista vocatur; qui sibimet diris semper dat verbera pugnis, scilicet alterutrum pars haec, pars illa flagellat (72).
Richiama il legame metaforico tra chimera e fantasia «balzana» an-che la missiva Ai lettori dello Svegliato nell’introduzione dei Marmi:
Mille volte, uscito che io son del sonno, il piú delle notti, mi sto con la fantasia a chi-merizzar nel letto, non solo sopra i fatti miei, ma sopra quei degli altri ancora; non già in quella maniera che fanno i plebei né in quella forma che pensan i letterati, ma da capriccioso cervello (73).
Anche qui nulla più che una suggestione, eppure è non privo di interesse rilevare come il campo semantico culinario – tra le salda-ture più robuste, lo si è visto, che uniscono l’afflato grottesco dei due autori – si completi in tutta la sua contiguità al mondo letterario ed editoriale proprio nel Comento all’episodio della Zucca: Doni ha «rimestato assai buffonerie, berte, burle e baie» (74) (corsivo mio), cavato solo «capogirli, castelli in aria, arzigogoli e baruffe» e non può che prendere gli scartabegli di Burchiello per cominciare a «cicalarvi sopra». Ancora una volta è la fantasia che viene e comanda.
Poi mi è venuto fantasia trarli nelle man de’ popoli e ficcargli nella bocca delle plebe, acciocché avendo trapellato in non nulla, me ne sia dato una pesta, e toccando quando una zimbellata da questo zugo caldo e quando una frugata da quel infreddato, si truovi alla fine qualche rampollo da succiare, benché io credo che gl’avesse più dello sciope-rone che del poeta, e quando noi aremo fatto e rimestato questi vapori, la sarà borra e scialaquata di parole. Ora, per spremere e dargli la tara, ho trovato molti testi diversi rimescolati e scompigliati, sì ne’ principi come ne’ mezzi e nella fine (75).
4. Criptocitazioni folenghiane nei Marmi Tra le varie raccolte doniane, il carattere di levigatezza che è pro-
prio dei Marmi agisce come limite e sfida. Ciò che poteva essere pa-lesato senza particolari preoccupazioni all’interno della Zucca o nella seconda parte della Libraria, opere improntate a un certo grado di sperimentalismo e ribellione formale, attraversa una codificazione più o meno articolata; e in trasparenza si continua a scorgere il sor-riso compiaciuto dell’autore, fiero di essere riuscito a celare accenni scandalosi all’interno di brani solo all’apparenza innocui.
(72) T. Folengo, Baldus cit., p. 1036, libro XXV, vv. 545-564. Come ricorda Chie-sa, anche nell’Orlandino Limerno sostiene che «La stella di Saturno o sia pianeta/è quella che mi fa d’uomo chimera,/lo qual non ebbi mai né avrò mai queta/la mente, in fantasie matin e sera».
(73) A.F. doni, I marmi, a cura di E. Chiorboli, Bari, Laterza, 1928, I, p. 5.(74) A.F. doni, La zucca cit., p. 476-477.(75) Ibidem. Come rileva Elena Pierazzo in nota, «lo zugo, che qui vale ‘semplice,
sciocco’, è una sorta di frittella avvolta in un fuscello e cotta nell’olio caldo».
207VARIETÀ
È questo il caso delle testimonianze di sfumatura folenghiana con-centrate nella seconda parte dell’opera, introdotta dal Ragionamento della Stampa fatto ai Marmi di Fiorenza (76). Il primo brano (in realtà un plagio del Dialogo della stampa proprio del Domenichi) (77) vede confrontarsi tra loro Alberto Lollio, Francesco Coccio e Paolo Crivello su un argomento comprensibilmente caro a Doni: l’invenzione della stampa e l’impatto sociale e industriale di questa nell’universo edito-riale (78). Secondo gli interlocutori, le potenzialità sono bilanciate da un’esplosione di dilettantismo e dall’effettiva abolizione di ogni cano-ne, fino a sfiorare atmosfere analoghe a quella dell’ignota «dottoressa» che nella Zucca si permetteva di criticare le traduzioni più rinomate:
Ogni pedante fa stampare una leggenda scacazzata, rappezzata, rubacchiata e strappa-ta da mille leggendaccie goffe, e se ne va altiero per due fogliuzzi, che pare che egli abbi beuto sangue di drago o pasciutosi di camaleonti. Come egli vede qualche sua cantafa-vola in fiera, egli alza la coda e dice: – Fate largo; io non credo al Bembo; l’Ariosto l’ho per sogno; il Sanazzaro e il Molza non son degni di portarmi dietro il Petrarca. – Cosí, credendosi rubar la fama altrui, acchiappa su la vergogna per sé (79).
Il dialogo successivo vede protagonisti accademici Fiorentini e Peregrini ed è il pretesto per un ritratto affettuoso dell’accademia veneziana, degna di essere accostata alle toscane pur nella sua unicità linguistica. Il brano di gran lunga più interessante è però l’ultimo del trittico, La Zinzera, Verdellotto e plebei. Per Goffis i Marmi «appena ricordano la Maccheronea, senza citarne l’autore, né trarne spunti» (80); anche in questo caso il giudizio mi pare ingeneroso (e, almeno per quanto riguarda la citazione dell’autore, errato): ritengo che die-tro alla lettera del racconto balenino infatti occasioni interpretative di un certo interesse.
Fin dalla definizione dei protagonisti, Doni opera un accosta-mento ardito tra alcune figure del volgo dai contorni incerti (quasi un’antropomorfizzazione del ruolo sociale di rottura) e due figu-re appartenenti al bel mondo fiorentino dell’epoca. Si tratta della Zinzera, ossia «la Nannina Zinzera cortigiana» di cui parla diffu-samente il Lasca (81) e che si esibiva cantando negli Orti Oricel-
(76) Il brano è stato analizzato approfonditamente da P. Pellizzari in ‘Forme brevi’ nei Marmi, in I marmi di Anton Francesco Doni. La storia, i generi e le arti cit., da p. 145 a p. 149. «Nell’economia complessiva del Ragionamento questo fuoco di fila di novelle risponde a un criterio di varietà stilistica e tematica, ma soprattutto costituisce un alleggerimento in senso ‘comico’ della sua conclusione» (ivi, p. 145).
(77) Sul punto si veda soprattutto G. Masi, Postilla sull’«affaire» Doni-Nesi. La questione del ‘Dialogo della stampa’, in «Studi italiani», II, 1990, 2, pp. 41-54.
(78) Si veda a questo proposito anche l’analisi del brano contenuta in A. rondini, Sociologia della letteratura. Un profilo storico, Milano, Mondadori, 2002, pp. 22-24.
(79) A.F. doni, I marmi cit., I, p. 186.(80) C.F. goFFis, Finzioni editoriali di Merlin Cocai cit., p. 779.(81) Cfr. A. grazzini, Le rime burlesche edite ed inedite, a cura di C. Verzone,
Firenze, Sansoni, 1882, pp. 244-245.
208 VARIETÀ
lari (82), e il Verdellotto: nient’altri che Philippe Verdelot, padre musicale del madrigale italiano. Sono pagine dove il rovesciamento carnascialesco è molto marcato; l’esordio non nasconde lo smarri-mento scherzoso dei due illustri protagonisti e insiste ancora sulle categorie ormai familiari della bizzarria e del cibo intellettuale.
ZINZERA. Da sta sera in fuori, ogni sera ci suol esser qualche ragionamento bizzarro: io per me non ci veggo altri che plebei: s’io l’avesse creduto, non ci venivo altrimenti; e s’io non ci veniva, il pan muffava.VERDELLOTTO. Almanco ci fossero Bruett, Cornelio e Ciarles, ché noi diremmo una dozzina di franzesette e pasteggieremmo qua questo mucchio di plebei.PLEBEI. Da che voi non potete sodisfare a noi con la musica, noi disturberen voi con certe nostre novellaccie che contiamo l’uno all’altro (83).
I plebei come da tradizione rivestono il ruolo di disturbatori pro-fessionisti. Il loro compito è quello tipico della satira del villano e del-le pasquinate: scuotere l’ordine costituito fino a farlo vacillare, sicuri della protezione garantita da un anonimato di fatto che deriva dal nome collettivo tanto quanto dal ricorso a soprannomi popolareschi. Lo pseudonimo usato per indicare il «beffatore» nella prima novella narrata dai Plebei attinge direttamente a uno dei punti di contatto più significativi tra Folengo e Doni: «Il Zucca», di professione palla-io, che si trova in casa alcuni forestieri venuti a Firenze «per palloni» e li inganna con una falsa pesca miracolosa. Dopo alcuni brevi inter-venti di Zinzera (84) e Verdellotto, la parola torna ai Plebei:
PLEBEI. Io, che son grosso come l’acqua de’ maccheroni, ne dirò una da maccherone; e non l’ho cavata però della Maccheronea, ma l’accoccai a una mia zia cugina, nipote d’un mio genero, che fu figliola d’un fratel di mio cognato (85).
Già Cordiè (86) rilevava come quell’accoccai fosse un chiaro riferimento proprio a Merlin Cocai (87), che della Maccheronea
(82) «Dans le Ragionamento della stampa Doni fait se tenir dans l’Orto de’ Rucellai une discussion “fra [...] dotti” sur la Laure de Pétrarque qui est inspirée par la discussion qui eut lieu dans l’Académie Florentine en 1546» (M. PlaisanCe, Le retour à Florence de Doni: d’Alexandre à Côme, in id., L’Accademia e il suo principe. Cultura e politica a Fi-renze al tempo di Cosimo I e di Francesco de’ Medici, Manziana, Vecchiarelli, 2004, p. 410.
(83) A.F. doni, I marmi cit., I, p. 202. Per un approfondimento sulla Zinzera e su alcuni aspetti di questa novella, cfr. anche M. C. Figorilli, Machiavelli moralista: ricerche su fonti, lessico e fortuna, Napoli, Liguori, 2006, p. 115 e seguenti.
(84) Va segnalato che nll’edizione Barbera dei Marmi (1863) Pietro Fanfani se-gnala in nota, a proposito della prima novella della Zinzera, quella sulla «bottega»: «Di questo sozzo raccontone fece un epigramma maccaronico anche il Folengo». Sia Momigliano che Goffis ignorano a che cosa ci si riferisca.
(85) A.F. doni, I marmi cit., I, p. 208.(86) «“la rifilai”, con evidente allusione allo pseudonimo del Folengo». Cfr. C.
Cordiè, Folengo, Aretino, Doni cit., p. 820.(87) «L’esordio – lo aveva già evidenziato Carlo Cordiè – è folenghiano, non sol-
tanto per l’evocazione delle Macaronee, ma anche per la burlesca genealogia della pro-tagonista femminile» (P. Pellizzari, ‘Forme brevi’ nei Marmi cit., p.148).
209VARIETÀ
(indicata ancora al singolare e per antonomasia, come nella Zucca, conferma indiretta che anche in quel brano ci si riferiva a Folen-go e non a Tifi Odasi) fu l’autore; inoltre, la strana parentela – la «zia cugina» – sembra provenire direttamente dal «barba cusino» del Baldus, nell’episodio della beffa con l’orcio di sterco giocata da Cingar a Zambello:
An nescis quod Bertus erat Pannada fradellusMignotti Zanchi, de quo me medda Catina protulit, atque tuam simul ac insemma sorellam,unde mihi nezza est et ego tibi barba cusino? (88)
Questo particolare io narrante si distingue dagli altri Plebei in virtù di significativi incisi – «sapete che sempre ho avuto il cervel balzano», così come la zia lo dice «pazzo» e quando si decide alla partenza fa «capo grosso da buon senno» – e nei fatti si propone come un rappresentante tout court della schiera irregolare: soldato di ventura, picaro, che parte in cerca di gloria ma non osa chiedere il permesso alla parente per paura di essere diseredato. Lo stragemma escogitato è degno di Cingar in quanto a cinismo e surreale finezza. Il protagonista finge di essere caduto in preda a una malattia, per la quale l’unico rimedio sembra essere una pantagruelica indigestio-ne di maccheroni: e tratta dal Baldus sembra la scena che ne deriva, con la povera zia che per accontentare il nipote riempie letteralmente la sua stanza dei più vari contenitori traboccanti di quegli gnocchi, «unti bene e incaciati» come da prassi.
O povera zia! Pensate che l’empié di piattegli, scudelle, catini e pentole tutta la mia camera, piena di maccheroni; poi mi si fece al letto, e cominciò a dirmi: – Caro nipote, tôi due bocconi; ecco che io t’ho contentato; mangia de’ maccheroni. – Pensate quan-do la mi rizzò a seder sul letto, che io viddi tanti maccheroni, che io fui per trarre uno scoppio di risa; ma mi ritenni per finire il mio disegno (89).
Il diabolico nipote improvvisamente si rifiuta di ingozzarsi dei maccheroni che ha ordinato in così gran quantità, sostenendo che se non verrà insultato e spaventato non riuscirà più a continuare il pasto. Per amore la zia prende a minacciarlo e accetta addirittura di vestire l’armatura dell’astuto picaro, finché questi scappa in strada e la accusa di essere impazzita. È un rovesciamento da manuale: pazzo e savio si scambiano i ruoli, e il tono compiaciuto con cui il Plebeo rimarca la situazione ne è l’ulteriore conferma. La novella termina con un riferimento alla scarsa “fiorentinità” del macche-rone, ineludibile (e balzano) cibo plebeo, ma ricco di fascino per Doni:
(88) T. Folengo, Baldus cit., p. 346, VII, vv. 512-515.(89) A.F. doni, I marmi cit., I, p. 209.
210 VARIETÀ
Alla fine, quanto piú diceva piú l’avevano per matta spacciata; e la legarono; poi ne seguí mille bei dialoghi fra lei e me. Io la spacciai per pazza e messi mano su la roba e cominciai a trionfare e andai al soldo, e feci e dissi, e dissi e feci quel che io volli. Onde allora si messe in uso un certo modo di dire: quando uno vorrebbe qualche cosa che non è dovere, come volli io dalla mia zia, e’ se gli dice súbito: «Ehi, maccherone, torrestila tu?». Ci son poi certi dotti in lingua toscana che non direbbon mai «Ehi, maccherone», per non dir come i fiorentini plebei, ma dicono in quello scambio: «Ehi, bietolone, minestrone, pappalefave, ghignaceci, pincione», e simil pappolate, proprio proprio da maccherone (90).
giordano rodda
(90) Ivi, I, p. 210.
































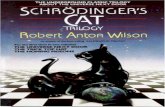


![Opere di Francesco Redi [electronic resource]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63365079d2b728420308455e/opere-di-francesco-redi-electronic-resource.jpg)