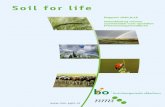Federico Ubaldini. I Documenti d'Amore di Francesco da Barberino, 1640
Transcript of Federico Ubaldini. I Documenti d'Amore di Francesco da Barberino, 1640
ARCHIVIO BAROCCO
Diretto da Marzio Pieri
1. GIOVAN PAOLO LOMAZZO, Della forma delle Muse [EDIZIONE] a c. di A. Ruffino, pres. di L. Tongiorgi Tomasi e con uno scritto di M. Pieri br. pp. 176, 2002, [ISBN 88-88097-08-2]
2. ALESSANDRO GUIDI, Prima dell’Arcadia. Le poesie liriche e l’Amalasonta in
Italia (1671-1681) [EDIZIONE] a c. di L. Salvarani, pref. A. M. Razzoli-Roio, br. pp. 272, 2005 [ISBN 88-88097-03-1]
3. FRANCESCO PONA, La maschera iatro-politica [EDIZIONE] a c. di F. Bondi, pres. di A. Ruffino br. pp.192, 2005 [ISBN 88-88097-44-9]
4. PACE PASINI, La Metafora. Il Trattato e le Rime [EDIZIONE] a c. di M. T. Pedretti, pres. di L. Salvarani br. pp. 544, 2005 [ISBN 88-88097-01-5]
5. MICHELANGELO BUONARROTI “IL GIOVANE”, Le rime di Michelangelo [1623] a c. di M. Pieri e L. Salvarani br., pp. 136, 2006 [ISBN 88-88097-71-6]
6. FRANCESCO BRACCIOLINI, L’Elettione di Papa Urbano VIII – FRANCESCO BARBERINI, Poesie toscane – HIERONYMUS KAPSBERGER, Poematia et carmina a c. di L. Salvarani, br., pp. 574, 2006 [ISBN 88-88097-60-0]
7. IL BURATTO E IL PUNTO. G.B. MANZINI, Delle Meteore Rettoriche – A. G. BRI-GNOLE SALE, Tacito Abburattato a c. di M. Pieri e D. Varini, br., pp. 592, 2006 [ISBN 88-88097-62-6]
8. FEDERICO ZUCCARI, Il passaggio per Itali [EDIZIONE] a c. di A. Ruffino br. pp. 224, 2007 [ISBN 978-88-88097-74-0]
9. GIOVAN BATTISTA ANDREINI, L’Adamo [EDIZIONE] a c. di A. Ruffino br. pp. 272, 2007 [ISBN 978-88-88097-76-3]
10. GIAMBATTISTA BÀFFARI, La caccia comica a c. di M. Pieri br. pp. 192, 2008 [ISBN 978-88-88097-81-7]
11. CLAUDIO ACHILLINI, Il sangue dell’ucciso: Prose e Poesie a c. di M. Pieri e L. Salvarani br. pp. 224, 2008 [ISBN 978-88-88097-96-1]
12. RIDOLFO CAMPEGGI, Le lagrime di Maria Vergine a c. di M. T. Pedretti, intr. di L. Salvarani br., pp. 304, 2009 [ISBN 978-88-88097-09-7]
FEDERICO UBALDINI
I DOCUMENTI D’AMORE DI FRANCESCO DA BARBERINO
1640
PETRARCA RE ROBERTO IL TESORETTO
A CURA DI LUANA SALVARANI
LA FINESTRA Editrice LAVÌS MMIX
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA Archivio Barocco
Diretto da Marzio Pieri
Volume pubblicato col contributo del MIUR nell’ambito del progetto PRIN 2006 (“Margini e livelli dell’orazione del Cinquecento Barocco”) coordinato dal Prof. Andrea Padovani
dell’Università di bologna, Unità di Ricerca dell’UNIVERSITÀ DI PARMA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELLA FORMAZIONE E DEL TERRITORIO, diretta dal Prof. Marzio Pieri
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
2009 LA FINESTRA Editrice 12, piazza Grazioli I – 38015 Lavis (TN) www.la-finestra.com infola-finestra.com fax +39 461 241800 PRODOTTO IN ITALIA - UE
INDICE
Urban Primitives. Federico Ubaldini e gli antichi testi italiani Introduzione di Luana SALVARANI 3
I DOCUMENTI D’AMORE 25
LE RIME DI M. FRANCESCO PETRARCA ESTRATTE DA UN SUO ORIGINALE IL TRATTATO DELLE VIRTÙ MORALI DI ROBERTO RE DI GERUSALEMME IL TESORETTO DI SER BRUNETTO LATINI CON QUATTRO CANZONI DI BINDO BONICHI DA SIENA 585
APPARATI INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI DEI DOCUMENTI D’AMORE 685
NOTA AGLI ABBOZZI PETRARCHESCHI 689
INDICE DEGLI ABBOZZI PETRARCHESCHI 698
URBAN PRIMITIVES Federico Ubaldini e gli antichi testi italiani
luana salvarani
l modernismo e l’internazionalismo sono tratti vistosi, riconosciuti,
della vita culturale e artistica nella Roma di Urbano VIII Barberini.
L’interesse per l’arte contemporanea, e in particolare per quegli artisti
e architetti in grado di modificare lo spazio cittadino, il passaggio dalla de-
corazione all’urbanistica, le spese ingenti per rendere pubblica e spettacola-
re ogni operazione, per travalicare i limiti e la stessa idea (rinascimentale,
superata) di “corte”; la corsa per rimanere alla moda, sia in arte che in lette-
ratura; l’inclinazione, la preferenza esibita per i modi e gli atteggiamenti
della monarchia di Parigi (non solo nei termini dell’effimero ma anche in
quelli della struttura amministrativa e della diplomazia). La fisionomia ge-
nerale è ben definita e in questo senso si sono mossi i numerosi studi finora
condotti, soprattutto nel campo dell’architettura e del collezionismo erudi-
to1.
Tra i progetti barberiniani, le grandi operazioni editoriali di Federico Ubal-
dini — i Documenti d’Amore di Francesco da Barberino e il “codice degli 1 In questa introduzione si è fatto tesoro soprattutto degli studi barberiniani di MARY ARON-
BERG LAVIN, DAVID FREEDBERG, FREDERICK HAMMOND, FRANCIS HASKELL, DAVID JAFFÉ, IRVING
LAVIN, HANS PETER RIETBERGEN, SEBASTIAN SCHÜTZE, JOHN BELDON SCOTT, FRANCESCO SOLINAS, J. DOUGLAS STEWART, e dei lavori su Andrea Camassei di ANN SUTHERLAND HARRIS.
I
LUANA SALVARANI
abbozzi” petrarchesco col Tesoretto di Brunetto Latini — sono rimaste fino-
ra piuttosto in ombra, e non sono state considerate parte di questo disegno.
Gli storici dell’arte ci hanno fatto conoscere i Documenti riediti
dall’Ubaldini in virtù del loro maestoso apparato iconografico, mentre il suo
Petrarca, privo di illustrazioni, ha attirato l’attenzione dei filologi e degli
specialisti,2 nel quadro della ricognizione del Vaticano Latino 31963. Ma si
tratta sempre di testi antichi, in gran parte fiorentini, e per questo sono stati
associati dagli studiosi barberiniani a un filone antiquario-encomiastico
minore. Da una parte le glorie del pontificato moderno (Bernini, Pietro da
Cortona, le opere in musica di Luigi Rossi, le feste e gli apparati...),
dall’altra le ‘curiosità’ legate all’illustre passato fiorentino, mirate a nobilita-
re un casato non poi così antico e di origini mercantili come quello dei Bar-
berini. Ma è proprio così? Se la linea di connessione tra l’arte medievale e le
ricerche figurative di Borromini è da darsi oggi per accertata, non si vede
perché la ricerca ubaldiniana sui testi antichi italiani e provenzali, assieme
al suo rinnovato interesse per Dante e per la letteratura civile dell’età co-
munale4, non debba avere agito da nutrimento sostanzioso nel rinnovamen-
to letterario e culturale promosso da Urbano, poeta in prima persona sotto
il segno della poesia utile alla res publica. Rinnovamento di cui papa Urba-
no, fin da quando era ancora Maffeo Barberini, aveva dato il primo segno
2 L’operazione dell’Ubaldini ha ricevuto consacrazione definitiva da parte di Cesare SEGRE nell’articolo “Petrarca e gl'incunaboli della critica genetica”, Critica del Testo, VI/1-2-3, 2003 (ne riportiamo qui il sommario): «L'edizione del “codice degli abbozzi” di Francesco Petrarca (1652) ad opera di Federico Ubaldini è senza dubbio il primo esempio di edizione genetica di un testo. Gli editori successivi, in particolare il Muratori, l'hanno utilizzata come una raccol-ta di varianti. Non hanno invece avvertito le implicazioni dell'edizione per l'analisi dell'ela-borazione poetica del Petrarca». Noi qui desideriamo, “da parte barocca”, studiare le impli-cazioni dell’edizione Ubaldini per l’elaborazione culturale del modello barberiniano. 3 Cfr. Laura PAOLINO, Il codice degli abbozzi. Edizione e storia del manoscritto Vaticano la-tino 3196, Milano-Napoli, Ricciardi 2000. Qui ci basta riportare la storia del manoscritto, come la tracciò Carlo Albertini nella sua edizione petrarchesca del 1832: “II Beccadelli però senza far parola d'altro manoscritto autografo mai posseduto dal Bembo, dice che nel 1530 vide appresso di lui solamente alquanti fogli staccati, contenenti la più parte Sonetti e Can-zoni, con frequenti correzioni e postille. [...]. Mancato di vita il Bembo, que' Frammenti scrit-ti in carta comune [...] passarono in mano di Torquato suo figlio, il quale al Mureto e ad altri li comunicò; poi con altri preziosi codici li vendè a Fulvio Orsino, e questi alla Biblioteca Va-ticana nobilissimo lascito ne fece. I frammenti furono da Federico Ubaldini dati fuori in Ro-ma l'anno 1642 nello stato medesimo in cui erano stati lasciati dall'Autore, con le correzioni e postille tutte, e con la stessa sua ortografia”. 4 Un classico: Umberto COSMO, Con Dante attraverso il Seicento, Bari 1946.
URBAN PRIMITIVES
abbandonando i circoli bolognesi e in particolare l’Accademia dei Gelati, di
cui era stato promotore e sostenitore. La direzione era esplicita: abbando-
nare la lirica, con il pretesto della sua peccaminosa sensuosità; e più in ge-
nerale abbandonare la letteratura art pour l’art. Tornare al poema e alla
prosa, alla scrittura grave, all’allegoria continuata, ai piani molteplici delle
scritture medievali con i commenti e le glosse. Un primo passo in questa di-
rezione era stato già fatto da Ridolfo Campeggi a Bologna con il poema Le
Lagrime di Maria Vergine, di cui Maffeo fu il primo dedicatario5. Ma non
bastava; e se Francesco Bracciolini (non l’ormai defilato e troppo vecchio
Chiabrera) fu il poeta scelto da Urbano per condurre in prima linea la rivin-
cita contro la testa di turco del marinismo, Federico Ubaldini fu
l’esploratore e il ricercatore delle retrovie, nei terreni allora in gran parte
ignoti o mal noti del Medioevo romanzo.
Tutto ciò che sappiamo su Federico Ubaldini6 ci viene da testimonianze di
passaggio e occasionali da parte dei suoi contemporanei: menzioni in lette-
re, citazioni, encomi, e le sue poche opere pervenuteci: oltre ai due volumi
qui pubblicati, una Vita di Mons. Angelo Colocci7 e il dialogo Il Giordano
5 Ridolfo CAMPEGGI, Le Lagrime di Maria Vergine, a cura di Maria Teresa Pedretti, introdu-zione di L.S., “Archivio Barocco”, Trento, La Finestra, 2009. Per i rapporti tra il giovane Bar-berini e il Campeggi, cfr. Sebastian SCHÜTZE, Kardinal Maffeo Barberini und die Entstehung des Römischen Hochbarock, Munich, Hirmer Verlag, 2007, pp. 175-180, in part. p. 178: “Am 5. Juli 1617 teilte er Maffeo mit, er hoffe nun, letzte Hand an sein großes Versepos, Le La-grime di Maria Vergine, legen zu können, und wolle dieses Maria de’ Medici widmen”. Maf-feo rispose alla richiesta di scambio di opinioni letterarie sul poema, ma non diede troppo seguito alla richiesta di raccomandazione presso Maria de’ Medici, alla quale il poema fu ef-fettivamente dedicato nell’edizione di lusso del 1617, con doppio frontespizio di Gian Luigi Valesio. 6 Stiamo lavorando a una monografia sull’Ubaldini; in questa sede ci limitiamo quindi a for-nire i dati essenziali per l’inquadramento delle opere presentate. 7 L’opera non fu pubblicata a stampa nel Seicento, ma ne esiste un’ottima edizione moderna: Vita di Mons. Angelo Colocci, edizione del testo originale italiano (Barb. Lat. 4882), a cura di Vittorio FANELLI, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1969.
LUANA SALVARANI
ovvero Nuova difesa di Dante8. Una prima ricostruzione biografica venne
effettuata nel secolo scorso da Guido Vitaletti9, che lo presenta così:
Segretario del Sacro Collegio, diplomatico esperto, ma soprattutto indagatore co-
scienzioso e sagace dei fatti storici [...] coltivò con passione gli studi letterari e mo-
strò per essi gusto sicuro, disposandolo ad una dirittura di giudizio e ad una incon-
tentabilità critica che potevano sembrare veramente eccezionali ai suoi tempi.
Dal saggio del Vitaletti e dalle allusioni sparse che raccogliamo in studi de-
dicati a Peiresc, a Cassiano del Pozzo, a Francesco Barberini, si ha immedia-
tamente l’impressione di una vita di studio e di curiosità attiva, densa, feb-
brile, e forse di una rincorsa al prestigio dei maîtres-à-penser della corte
barberiniana. Quando Urbano fu eletto al soglio pontificio, l’Ubaldini aveva
tredici anni (era nato nel 1610) e tutta la sua formazione si svolse nell’era
delle Api. A differenza dei pesi massimi della corte (Lucas Holstenius, Ga-
briel Naudé, Cassiano del Pozzo, Leone Allacci) l’Ubaldini non era, dunque,
un intellettuale già affermato quando cominciò a lavorare per il papa. È il
rapporto tra il Francesco Barberini ‘francese’ e il grande provenzalista Pei-
resc a coinvolgere l’Ubaldini nei progetti su Francesco da Barberino e
l’antico volgare italiano.
Francesco Barberini left Paris in 24 September 1625, after Louis XIII presented
him with seven tapestries after Rubens’ Constantine series. On 19 October the party
stopped at Aix to visit Peiresc [...] The Encounter was to lead a long and rich corre-
spondence between Peiresc, Cassiano dal Pozzo, and Francesco Barberini [...]. As
his letters of April 1629 and September 1631 demonstrate, Peiresc helped with Bar-
berini campaign to integrate the fourteenth-century poet, Francesco di Barberino,
into the family’s cultural history.10
8 Il dialogo, rimasto manoscritto, è stato parzialmente trascritto da Giuliana ANGIOLILLO (U-na inedita difesa di Dante nel secolo XVII: il “Giordano o vero Nuova difesa di Dante” di Federico Ubaldini, Salerno, Edisud, 1984. 9 Guido VITALETTI, Intorno a Federico Ubaldini e ai suoi manoscritti, con tre chiose dante-sche inedite, in Miscellanea Francesco Ehrle, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1924, vol. V, pp. 489-508. 10 David JAFFÉ, The Barberini circle, p. 122-123
URBAN PRIMITIVES
Per svolgere il compito affidatogli, e mantenersi all’altezza della sua fama,
l’uomo di mondo Peiresc ha bisogno di un vero esperto di letteratura volga-
re italiana delle origini. E forse cercando qualcuno che faccia il lavoro spor-
co per lui, si rivolge all’Ubaldini, che nel 1636 aveva già aiutato Gassendi a
svolgere le sue ricerche provenzali. È l’occasione d’oro per il giovanissimo
studioso, che alla morte di Peiresc prenderà le redini delle ricerche su Fran-
cesco da Barberino e le condurrà a termine.
In 1637, a few months before his death, Peiresc was boasting of having acquired
‘des habitudes à Florence’, and of receiving from the Laurentiana copies of two
grammars of old Provençal — an event placed in 1636 by Gassendi, who adds that
Peiresc ‘multa quoque disseruit’ concerning them. They were without any doubt
copies of the Donat provensal of Uc Faidit and the Razos de trobar of Raimon
Vidal, still preserved at Florence in chansonnier P.
In this same period Peiresc continued in communication with the Vatican, and he
had made contact there with the Provençalist Federico Ubaldini, from whom in
1636, according to Gassendi, he had received various indexes and ‘books’, concern-
ing Provençal. It has long been known that Peiresc had obtained copies from the
Vatican of the notes of the sixteenth-century antiquary and Provençal scholar An-
gelo Colocci, and this aroused a certain interest, especially since a notice found by
Debenedetti among the Vatican manuscripts shows that the notes copied con-
cerned, in part at least, vocabularies and rimes.11
Forse le ricerche lessicografiche di Angelo Colocci12 pervenute a Peiresc e-
rano state copiate dall’Ubaldini stesso. In ogni caso, molti dei suoi materiali
vengono dall’opera dell’erudito cinquecentesco, vero modello per l’Ubaldini
(anche nel metodo di lavoro a “postille e appunti staccati, risposte a saltua-
rie domande di metrica e di lingua, confronti dell’italiano antico col proven-
zale, copie e tavole parziali”13) che ne scrisse la Vita14 con evidente passione 11 Francis W. GRAVIT, Peiresc’s provençal manuscripts, p. 229. 12 L’opera di riferimento è oggi il volume a cura di Corrado BOLOGNA e Marco BERNARDI, An-gelo Colocci e gli studi romanzi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008. Sempre valido lo studio di Vittorio FANELLI, Ricerche su Angelo Colocci e sulla Roma cinque-centesca, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1979. 13 Santorre DEBENEDETTI, Tre secoli di studi provenzali, in Provenza e Italia, a cura di V. CRESCINI, Firenze 1930, p. 167. 14 Vita di Mons. Angelo Colocci, ed. FANELLI cit. (nota 7).
LUANA SALVARANI
e partecipazione. La somiglianza tra le due figure fu notata ripetutamente
anche da Vittorio Fanelli, editore di quella biografia15:
L’Ubaldini cita a preferenza Francesco da Barberino e Re Roberto dei quali pubbli-
cò le opere, del primo i Documenti d’Amore (Roma 1640) dedicati a Maffeo e Noc-
colò Barberini, del secondo il Trattato delle canzoni morali, che veramente è opera
di Graziolo Bambaglioli, assieme alle Rime del Petrarca, al Tesoretto di Brunetto
Latini e a Quattro canzoni di Bindo Bonichi (Roma 1642) dedicati a Taddeo Barbe-
rini. La curiosità per il Colocci sorge nell’Ubaldini proprio quando trova in lui gli
stessi suoi interessi che lo portano a ripercorrere lo stesso cammino attraverso le
indagini sui nostri poeti delle origini e sui loro legami con la lingua provenzale.
Il Colocci fu tra i protagonisti del dibattito sulla lingua per la parte cortigia-
na e trissiniana, e questa scelta di campo interessa e affascina l’Ubaldini,
che nella Vita non si stanca di ribadirla16. A metà Seicento la questione della
lingua era morta e sepolta, e l’Ubaldini, così attento a vivere nell’oggi, si
guarda bene dal riesumarla. Ma la sua presa di posizione a favore di Dante,
i suoi studi provenzali e trecenteschi dichiarano in modo evidente che la so-
luzione toscana non gli pareva un punto d’arrivo soddisfacente. Mancavano,
nel toscano letterario limato e tornito dalla lirica manierista, la varietà fone-
tica (e il fascino dell’aspro e del petroso) del volgare antico, ma anche tutta
una gamma di significati dal morale al politico all’allegorico, usciti da trop-
po tempo dal canone della letteratura volgare. La questione della lingua di-
venta una questione di codice e di civiltà, e Ubaldini ricorre ai provenzali
del Colocci sperando di ricavarne una propria, più ricca lingua moderna.
15 Ibidem, p. 94, n. 168. 16 “Ammassò egli [il Colocci] da’ Toscani antichi osservazioni di parole e di frasi, e tra gli altri dagli scritti di Ms. Francesco da Barberino e del Re Ruberto di Gerusalemme, i quali forse hebbe da Napoli, dove Roberto regnò e dove sappiamo che il Re sudetto fe’ venire l’opere del Barberino comperate per cinque once d’oro. Non è da ammirarse se Angelo, così esperto in questa favella, sia introdotto da Pierio Valeriano, nel Dialogo di essa, a raccontare il discorso seguìto in una cena del Card. Giulio de’ Medici sopra il nome della nostra lingua; inclinava il Colocci, secondo si mostra nella sudetta narratione , all’opinione di Gio: Giorgio Trissino, anzi come si raccoglie dall’Ercolano del Varchi, il Colocci aiutò con alcune ragioni l’opinione di esso Trissino per chiamarla lingua Italiana: il che con ingenuità lombarda confessa l’istesso Trissino nel suo Castellano” (Vita di Mons. Angelo Colocci, pp. 94-96).
URBAN PRIMITIVES
Raggiunta una solida credibilità ben prima dei trent’anni, l’Ubaldini ebbe
una prima battuta d’arresto a soli trentatré, quando la morte del papa con-
dannò in gran parte i suoi progetti prima alla quarantena e poi a un binario
morto; e morendo l’Ubaldini a sua volta a quarantasette anni, non riuscì né
a completare i filoni di ricerca avviati, né a compilare o far compilare affre-
schi biografici conclusivi della sua vita di studioso. Tuttavia, il breve pas-
saggio di questi progetti nella cultura barocca ha lasciato alcune indicazioni
forti. La filologia more ubaldiniano non riuscì a farsi scuola, anche se costi-
tuisce un punto di svolta per la cultura umanistica: quel passaggio
dall’archeologia al senso della storia, dal bello scrivere al pensare la scrittu-
ra, dall’erudizione al sapere applicato, che le grandi monarchie europee e la
potenza sovranazionale dei Gesuiti avevano già compreso e indicato da oltre
mezzo secolo. Quel metodo però non seppe o non fece appunto in tempo a
dare risultati tangibili, e ne rimangono solo le vestigia, le indicazioni chiare
ma celate, in operazioni come questi recuperi di autori ‘primitivi’. È solo nel
Novecento, e nelle migliori e più vive intenzioni della filologia musicale, nel
recupero pratico della musica cosiddetta antica come “cosa nostra”17, che si
è affacciato qualcosa di simile alla filologia ubaldiniana.
Federico Ubaldini dedica molto tempo alle repliche a Messer Fagiano,
l’accademico Niccolò Villani di Pistoia, che aveva pubblicato nel 1631 un
pamphlet antimariniano18 nel quale spicca un severo attacco a Dante. Molte
delle repliche, confluite poi nel dialogo Il Giordano, ci sono pervenute in un
manoscritto pubblicato dal Vitaletti19. Così scrive l’Ubaldini:
i nostri che sono tanto dotti e tanto investigatori delle cose antiche [...] pare la veri-
tà che non vogliano rimanere nel tempo nel qual siamo ma a quello prima, non sen-
za qualche disprezzo della Natura e di Dio, che adesso vogliono che siam vivi, a’
tempi nostri dico.
17 Bruce HAYNES, The End of Early Music. A Period Performers’ History of Music for the XXI century, Oxford University Press, 2007. 18 Considerationi sopra la seconda parte dell’Occhiale del Cav. Stigliano, contro allo Adone del Cav. Marino e sopra la seconda difesa di Girolamo Aleandro, Venezia, Pinelli, 1631. 19 Art. cit, p. 503.
LUANA SALVARANI
Per comprendere il suo stile di ricerca dobbiamo abbandonare i criteri con-
sueti, storico-tematici. Non gli interessa un periodo né una figura in parti-
colare, i suoi studi si estendono a momenti ed aree diverse del Medioevo
romanzo. Studia Dante, Francesco da Barberino, i trovatori, Brunetto Lati-
ni, Petrarca perché ciò che gli interessa è la vitalità, la potenziale polisemia
di una lingua in formazione. Interessano molto all’Ubaldini anche le apertu-
re di significato provocate da contrapposizioni ironiche o allusive tra lin-
guaggi diversi: si direbbe che li ritenga alla base del codice allegorico trami-
te il quale le opere narrative e di fantasia divengono portatrici di significato,
in una trasmissione storica analoga per struttura a quella della patristica.
Così avviene che, per difendere Dante da una delle accuse di blasfemia mos-
segli da Messer Fagiano (per aver fatto pronunciare il Vexilla regis pro-
deunt inferni al pagano Virgilio), Ubaldini tracci una storia che va dalla mi-
stione di poesia pagana e scrittura religiosa, all’uso ironico della parola sa-
cra: da San Paolo, attraverso una lunga genealogia (qui la abbreviamo ci-
tando) arriva a Gregorio di Nazianzo, a Sannazzaro e infine al Pulci, antepo-
sto con scelta significativa, e sia pure sotto il paravento linguistico della
Crusca, a quel Tasso che era divenuto il vessillo più dichiarato che seguìto
del nuovo Barocco “morale”. Così l’Ubaldini:
Sicché senza che Virgilio avesse l’occhio a quell’inno, si potria dire che profferisse
quel verso siffatto e che per esserci una certa solenne minchionatura del Diavolo,
Dante non lo traducesse come gli altri fa, sì come si vede che nel Paradiso comincia
latino e poi seguita toscano, per non tôrre quella energia a quelle parole. Ma posto
ch’abbi avuto questo risguardo e posto che sia cosa sacra, non sarìa, secondo me,
grande errore né degno dell’Inquisizione del Santo Uffizio. San Paolo non si serve
egli dei versi di Arato, di Menandro, di Epimenide? [...] San Gregorio Nazianzeno
nella tragedia che fe’ della morte di Cristo, vi pose molte cose favolose e finte, le
quali furon così poste per mostrare ch’era una poesia. E Giacopo Sannazzaro nelli
libri De Partu Virginis ha trattato molte cose da gentile, né perciò profanatore
dell’istoria sacra è egli nomato, né ha avuto rimprovero da alcuno; che dal Sig. Era-
smo, anzi che da da quelli che sono arbitri di tutta la sacra università dei cristiani
ha meritato lode non mediocre, come appare ne’ Brevi di Leone e di Clemente,
sommi pontefici, e la ‘Prefazione’ di Egidio cardinale. E se ne’ fatti è stato lecito al-
URBAN PRIMITIVES
cuna simigliante cosa, perché non sarà ella sopportabile nelle parole altresì? Buon
Dio, quante ‘imprese’ accademiche si leggono con i motti della Scrittura? e non si
proibiscono. Il Pulci nel Morgante, il quale dagli dottissimi Signori della Crusca è
preferito alla Gerusalemme del Tasso, recita:
Deus in adiutorium meum intende:
Domine ad adiuvandum me festina.20
La curiosità dell’Ubaldini si aggancia perfettamente al fastidio di Maffeo
Barberini poeta per i topoi, per le formule fisse della tradizione lirica, che
dietro al bisogno di novità e di variatio nascondono poi la licenza e il pecca-
to. Il volgare del Duecento e del Trecento è interessante perché è ancora in
cerca del proprio codice e delle proprie istituzioni; crea, nel farsi, la propria
cultura. È chiaro che in quel processo l’Ubaldini legge un modello per
l’utopia di papa Barberini, con le sue origini mercantili orgogliosamente
contrapposte all’antica nobiltà romana: una civiltà che riscrive da capo le
proprie regole, le forme, le scritture. A questo, e non a una curiosità lessico-
grafica tipica di età più tarde (nel Seicento l’italiano letterario era ancora
una lingua viva), mira, per esempio, l’imponente apparato dei Documenti,
un glossario che ricostruisce genealogia e occorrenze letterarie di tutte le
parole significative o storicamente connotate, come i provenzalismi più
crudi. Parole ‘significative’, per l’Ubaldini, sono quelle che definiscono il
codice etico e le convenzioni civili della società ideale tracciata nei Docu-
menta; parole ‘storiche’, quelle che lo aiutano non a distanziare il testo, a
farne spiccare l’eccezionalità antiquaria, bensì ad accertarne la normalità21,
l’appartenenza ad un codice condiviso in formazione. Il testo diventa un fat-
to sociale: anzi il possibile atto di fondazione di una società. E la fedeltà
all’ortografia, alla metrica, alla lingua antica con le sue irregolarità e oscilla-
zioni è rispetto di un sistema di riferimenti che vanno oltre la lingua.
20 Art. cit., p. 502. 21 “Quelli poi [gli autori ‘del buon secolo, come di dice, o Provenzali’] si recano in mezzo, a dimostrare che nella maniera ch’egli ha scritto, anche gli altri di quella età solevano scrive-re”.
LUANA SALVARANI
La scelta di Francesco da Barberino come primo soggetto delle edizioni u-
baldiniane deriva dal legame dinastico, vero o presunto, dell’antico scrittore
con i Barberini; ma lo sviluppo dell’ardua commissione è costruito sul tema
di uno scrittore che fu innanzitutto giurista e cittadino22. Non andrà so-
pravvalutata la funzione anche encomiastica del tema (Maffeo Barberini a-
veva compiuto gli studi di legge). La rilevanza del modello giuridico come
base, logica e funzionale, di tutta la sfera degli studia humanitatis e
dell’intero cielo delle arti, trova nella Roma barberiniana la possibilità di
farsi sistema: ma risaliva a prima, in particolare alla Bologna di Achillini,
Campeggi e Malvezzi, che con l’Accademia dei Gelati (quando anche il gio-
vane Maffeo, come si è visto, partecipava ai lavori di essa) era stata al centro
del Barocco primosecentesco23.
A questo tema, nell’operazione di Ubaldini, si aggiunge quello
dell’eteronomia dell’arte, per dirla con le parole del nostro secolo. La tesi
era questa: le leggi della scrittura sono le leggi del pensiero, e su di esse e
sui valori di riferimento della società civile — per quanto oggi ciò possa ap-
parire sconcertante — si deve modellare la pratica delle arti della parola. È
in tal senso che Francesco da Barberino può essere il punto di riferimento
di questa cultura. L’Ubaldini inserisce nelle Testimonianze fatte da huomi-
ni illustri raccolte all’inizio dei Documenti, tra molte citazioni appunto illu-
stri, una misteriosa nota “d’Incerto”, tradotta da Filippo Villani. Non esclu-
deremmo che tale testimonianza possa essere un falso di mano
dell’Ubaldini, che in questo modo riuscirebbe a inserire nell’opera, con
straordinaria sottigliezza, il ‘proprio’ ritratto di Francesco. In ogni caso, es-
sa sembra un prontuario ufficiale dell’uomo di lettere barberiniano, il cui
esempio perfetto è papa Urbano:
22 Quello stesso Francesco da Barberino che pronunciò la condanna al rogo di Cecco d’Ascoli, e quindi a contatto, nelle vesti dell’uomo d’ordine, con la cultura alchemica e misteriosòfica dello Stabili, non rientra nella prospettiva dell’Ubaldini. 23 Luoghi del Giure. Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e religione, Atti del-la giornata di studi a Palazzo Malvezzi, Bologna, 30 maggio 2008, a cura di Bernardo PIERI E
Ugo BRUSCHI, Bologna, Gedit, 2009.
URBAN PRIMITIVES
Francesco da Barberino fe’ professione nella civile, e canonica legista disciplina,
nelle quali fu dottissimo; studiò anche altre discipline, massime nella poetica: non
però che facesse versi, ma che intendeva bene le fittioni de’ Poeti. Huomo investiga-
tore delle genti & di costumi, e quelli, che per lascivia erano labili o morbidi, con
quello stile che potè migliore correggeva, e riprendeva: e quelli, che il volgo appella
Gentili per nobiltà di sangue, già quasi spenti & a rusticane usanze accostatisi, si
sforzò a memoria revocare, accioché, se esser poteva, i Cittadini nuovi, che deposta
la zappa erano trascorsi nella Città, riducesse a civile, & costumata disciplina. [...]
Questo huomo grave & temperato, havendo opinione che dalle punture d’Amore,
come da natural principio tutti i beni e mali procedessero, imitando Boetio di con-
solatione, ma in materno sermone, compose un libro in versi e prosa distinto, nel
quale le nature d’Amore, che a virtù & a vizio s’accostan pienamente, trattò.24
Il parallelismo tra il ruolo di Francesco da Barberino nella Firenze del Tre-
cento e quello di Maffeo Barberini papa e poeta nella Roma del Seicento è
evidente e sufficientemente sottolineato: riportare la letteratura alla sua
funzione morale e civile, in un’epoca di edonismo e di facile versificare sui
sempiterni temi amorosi. Qui vale la pena notare che tale ripristino non
comporta alcun tipo di restaurazione o ‘riduzione’ stilistica. Molto si è scrit-
to e sentenziato sul cosiddetto Barocco moderato o Classicismo barocco25,
senza che tali definizioni rendano conto integralmente della cultura barbe-
riniana: niente di “moderato”, nessuna cosciente riduzione delle possibilità
espressive o retoriche nei poemi di Francesco Bracciolini o nelle fiorite liri-
che latine del papa, meno che mai nelle pagine dantesche e trecentesche che
attiravano l’attenzione dell’Ubaldini. Al contrario, è il campo della lirica
amorosa post-manierista, del sonetto e del madrigale “preziosi”, che sembra
ristretto e autoreferenziale, a Federico come al papa-poeta appassionato di
scienze naturali. Il piano stilistico di superficie è del resto quello su cui U-
baldini non interviene praticamente mai nelle sue operazioni editoriali,
guardandosi bene dal sovrapporre al mondo vario e interessante delle scrit-
ture antiche un piano di valori e gerarchie stilistiche contemporanei che
24 Documenti d’Amore, p. non num. (ma quarta delle Testimonianze). 25 Cfr. Franco CROCE, Tre momenti del Barocco letterario italiano, Firenze, Sansoni, 1966, ricco di affondi storiografici e riscontri materiali allora evitati a favore di una più generale e comoda polemica antisecentesca.
LUANA SALVARANI
sente limitati e insoddisfacenti. Il testo antico non va reso come documento
normativo, ma come finestra su una rinfrescante alterità, pronta a proiet-
tarsi immediatamente sui testi di riferimento del mondo contemporaneo26:
Del modo poi usato nello scrivere (favello del materiale) egli è notissimo, che a quei
tempi un punto metteva termine al verso, e nella medesima riga, si congiungeva il
seguente, la qual cosa tra gli altri luoghi è dimostrata a bastanza nella voce Sonetto
della Tavola del Barberino. All’ortografia non ci siamo curati di accrescere nulla di
novo, ma solo si è copiato diligentemente l’Originale. Per dinotare le cassature s’è
servito lo stampatore della varietà de’ suoi caratteri; perché per lo carattere tondo si
mostra quello, che l’autore lasciò per allora senza cassare: il corsivo significa o
quelle cotali compositioni, che non sono sue, come avviene ne’ due primi Sonetti, e
se elle sono, quelle che sono da lui medesimo cassate: del corsivo picciolo si è valso
a dinotare quando in un verso è più d’una mutazione, secondo che la prima non ag-
gradiva all’orecchie del Poeta: ove si assegnano l’ore, i giorni, gli anni, e gli altri
particolari, si sono adoprati quei caratteri, che più è paruto fare a proposito, per la
varietà, che per altro. Era veramente necessario per dichiarazione delle postille, e
d’altro qui contenuto, scrivere alcuna cosa d’avantaggio; ma essendo l’opere Latine,
e Toscane del Petrarca comuni a tutti, si è giudicato di far torto alla diligenza degli
studiosi, se vi ci affatichiamo suso. Puossi a quelle ricorrere, che l’una opera serve
bene spesso all’altra di verissimo Comento27.
Il rispetto del lettore ― non assediato con precisazioni tediose ma sempli-
cemente servito da un testo di elevata qualità, in grado di suggerire da solo
a occhi avvertiti le proprie direttrici ― è sintomo del fatto che il testo antico
per l’Ubaldini non va stabilito o accertato, ma reso accessibile, restituito alla
circolazione e al dibattito. La ricerca di varietà attraverso i diversi caratteri,
in una pagina perfettamente organizzata ma graficamente complessa come
quella dell’edizione petrarchesca, potrebbe apparire quantomeno superflua.
Essa risponde invece a un’esigenza fondamentale di vitalità della pagina:
non conta fornire il testo definitivo del codice (tanto più che, ai tempi
26 [...] “& al certo confrontandosi questi Documenti col Galateo di Monsignor Giovanni della Casa, apparirà non oscura tale imitazione”: Documenti d’Amore, in chiusura della presenta-zione A’ lettori. 27 Le rime di M. Petrarca..., pp. [3] e [4] della presentazione al lettore.
URBAN PRIMITIVES
dell’Ubaldini, il testo petrarchesco ‘definitivo’ era quello fissato dal Bembo e
a nessuno veniva in mente di discuterlo), conta rendere la pagina di diario
che si rivela tra gli abbozzi del Petrarca, con le note di mano del poeta (del
tipo “sono le dieci di mercoledì”, oppure “ora vado che la cena è pronta”,
“questo non mi è venuto abbastanza triste” 28); pagina inevitabilmente mos-
sa e irregolare e piena di incongruenze grafiche e strutturali.
Ubaldini tenta l’ideale utopico di ogni filologia illuminata dall’intelligenza,
rendere l’unicum (non trasmissibile, e di fatto illeggibile) del testo-origine,
con tutti gli umori e le transeunti fluttuazioni dell’autore, in un testo rispet-
toso di questa unicità e però minimamente interfacciato con altri lettori e
altri umori ed epoche irriducibilmente diverse. Ricordiamo che la raccolta
ubaldiniana comprende nell’ordine le rime del Petrarca, il Tesoretto del La-
tini e il Trattato delle virtù morali attribuito a Re Roberto d’Angiò. Nel caso
di opere non inedite come il Tesoretto, che era già un classico cent’anni
prima, il compito per l’Ubaldini consisteva innanzitutto nel fornire un testo
‘perfetto’: dove perfezione non è da intendere in senso filologico o codicolo-
gico ma nel senso dell’equilibrio interno e della perspicuità storica del risul-
tato finale. Il Tesoretto dell’Ubaldini tiene conto del lettore del Seicento,
delle sue abitudini visive e grafiche, dei suoi ritmi mentali e delle sue esi-
genze in termini di interpunzione e sintassi. Al contrario, il suo Petrarca è
scabro, irregolare, volutamente arcaico, quanto il Brunetto era modernizza-
to con intelligenza e scorrevolezza. E dato che il lettore barocco assomiglia
molto più a quello di oggi che il lettore duecentesco, ne risulta che questo
Tesoretto è rimasto il migliore che mai si sia letto in epoca moderna, grazie
a una familiarità costante con il dettato medievale e senza alcun bisogno di
stemma codicum.
Il peso specifico del Canzoniere e del Tesoretto non era, per l’Ubaldini, in
discussione, anche se l’editore sente il bisogno di ribadirne le funzioni eti-
che e filosofiche ponendoli in trittico, come si è detto, col Trattato delle Vir- 28 “Sed vocor ad cenam”; “Non videtur satis triste principium” (riferito all’abbozzo di “Amo-re, in pianto ogni mio riso è vòlto”).
LUANA SALVARANI
tù Morali29. Il Trattato viene dall’Ubaldini, sulle orme del Colocci, attribui-
to a Re Roberto d’Angiò, ma è in realtà dell’illustre giurista bolognese Gra-
ziolo de’ Bambagliuoli, il commentatore di Dante (1324); e, ancora una vol-
ta, non ci sentiremmo di escludere che l’editore conoscesse la corretta attri-
buzione, di cui si sarebbe poi gloriato a suo tempo il Crescimbeni, e giocasse
di sponda.
Nel caso dei Documenti d’Amore si tratta, invece, di una vera e propria ri-
scoperta, nella quale l’Ubaldini travasa la sua passione di difensore d’ufficio
di Dante. Come già si è visto, la vitalità della scrittura dantesca, per
l’Ubaldini, si basa sulla polisemia e sulle possibilità interpretative del codice
allegorico, pronto a ramificarsi in epoche anche storicamente lontane, a di-
venire anche molti secoli dopo modello per altre civiltà e nuovi cittadini. La
chiave allegorica è la migliore per restituire Francesco al lettore barocco, ed
è qui che entra in campo lo stupefacente apparato iconografico30
dell’edizione 1640.
Il codice manoscritto in possesso di Francesco Barberini31 (ora alla Bibliote-
ca Vaticana), certamente autografo e alla base della recente edizione di rife-
rimento dei Documenti d’Amore32, illumina il testo e le glosse a margine
con un ricco apparato di miniature eseguite da Francesco stesso o basate su
29 “Questo Bonagrazia o Graziolo di Bambagliolo Bambaglioli, uomo valente nelle cose giudi-ziarie e ne’ poetici numeri, veniva dichiarato notaio dell’anno 1311, ed in sull’entrare del 1324 era del novero degli Anziani in Bologna sua patria; dal che potrebbe inferirsi che avesse già tocchi i quarantanni, se anziani e priori ne’ reggimenti a Comune rispondevano ai senatori d’oggidì nei governi costituzionali. [...] Scrisse Graziolo un Trattato delle Virtù Morali, divi-so in Cento Rubriche, il quale contiene sentenze gravi, attinte alle fonti della Filosofia e della Teologia, ed è esposto in istrofe di vario metro: in che venne forse imitato da Francesco Bar-berini o da Barberino ne’ suoi Documenti d’Amore. Orna Graziolo il Trattato delle Virtù con acconci Commentari in lingua latina, riboccanti d’erudizione sacra e profana, e lo dedicò a Bertrando del Balzo cognato di Roberto re di Napoli e capitano di guerra dei Fiorentini. Pare che l’opera del Bambagliuoli o Bambagiuoli, passasse dalle mani di Bertrando a quelle di Roberto, il quale essendo amatore delle buone lettere, ne fece trar copia, o la trasse egli stes-so dall’originale: onde poi l’abbaglio di Federico Ubaldini, che pubblicava quel Trattato come scrittura di re Roberto” (Salvatore MUZZI, I primi bolognesi che scrissero versi italiani, Me-morie storico-letterarie e saggi poetici, Torino tip. di Giulio Speirani e figli, 1863). 30 Cfr. il Catalogo delle illustrazioni, con le relative attribuzioni (qui a p. **). 31 Il Barb. lat. 4076-4077 (cfr. qui l’Indice dei manoscritti a p. **). 32 I Documenti d’Amore – Documenta Amoris Glossae, a cura di Marco ALBERTAZZI, Lavis (TN), La Finestra Editrice, 2008 (2 tomi DI 424+587 pp.).
URBAN PRIMITIVES
disegni di lui. È certo che l’edizione ubaldiniana dei Documenti, commis-
sionata direttamente dalla corte pontificia in formato in-folio di gran lusso,
fosse prevista fin dall’inizio come riccamente illustrata, per pareggiare e la
bellezza del’originale miniato. Il desiderio di aggregare attorno a questa o-
perazione editoriale gli artisti più quotati della corte romana33 è un’altra
motivazione estrinseca delle 14 grandi tavole allegoriche del volume, alle
quali lavorarono artisti che siamo abituati a considerare portatori di modelli
differenti se non incompatibili, come il Cortona, Andrea Camassei, e il
Poussin.
La varietà e la complessità della struttura iconografica, nel dialogo tra dise-
gnatori e incisori, emerge da questa accurata descrizione del volume, forni-
ta dal catalogo di una libreria antiquaria americana, apparso su Internet:
This edition is illustrated with fourteen superlative allegorical engravings "very similar to
emblems" (Praz) which introduce each of the twelve parts of the Documenti as well as the
prologue and final section of additional poems. Engraved by Bloemart, G. F. Greuter and
Fabio della Cornia, they reproduce drawings by A. and L. Magalotti, C. Massimi, F. Zuccaro
and other well-known artists of the period. The portrait of the author (signed: Nic. Pucci,
inv.) and the last engraving (p. 357), showing the god of love astride a horse in the sky,
shooting his arrows into humans below, are after drawings by Nicholas Poussin. Although
the latter engraving is signed by Greuter after Camillo Massimi, its true source was revealed
when the original drawing by Poussin was discovered in the Windsor Castle collections in
the 1960s. It has been suggested that the two other engravings signed by Massimi (pp. 91
and 307) might also in fact be Poussin's work. Another engraving, the one on p. 211, is based
on a drawing by Federico Zuccaro. The Documenti are divided into 12 parts, each under the
rubric of a different virtue (Docilità, Industria, Costanza, Pazienza, Prudenza, etc.). The edi-
tor Federico Ubaldini added an impressive scholarly apparatus including a life of the author,
a brief summary of each Canzone, and a detailed glossary of Francesco's vocabulary and spe-
cial usages of words and phrases, including citations of similar usages in contemporary Ital-
33 Lo stesso sarebbe avvenuto per i trattati botanici del gesuita Giovan Battista Ferrari, e in particolare per le Hesperides sive de malorum aureorum coltura, illustrato sontuosamente da Guido Reni e Pietro da Cortona.
LUANA SALVARANI
ian and Provencal literary works and from contemporary and later dictionaries; the 8-page
list of these sources specifies the manuscripts or printed editions consulted. A few other po-
ems, including a short ballet, are printed at the end.
Il senso dell’operazione è difficile da individuare esaminando il volume iso-
latamente, e quasi tutti coloro che se ne sono occupati, soffermandosi
sull’interesse e la qualità delle singole illustrazioni, hanno di fatto rinuncia-
to a trovare all’apparato visivo nel suo complesso un significato diverso da
quello encomiastico-celebrativo. Le figure hanno invece uno scopo preciso,
che emerge mettendo l’apparato visivo in relazione con la mentalità
dell’Ubaldini e con la funzione dei Documenti nella politica culturale barbe-
riniana.
Il 1640, anno in cui esce il volume, non è un anno facile per Urbano VIII. Il
pontificato, nei diciassette anni precedenti, ha superato senza palesi diffi-
coltà i fallimenti nelle trattative diplomatiche con la Spagna. Ha impostato
una politica urbanistica coraggiosa, di forte impatto, perfetta per creare
un’identità del pontificato percepibile dai romani e dai viaggiatori. Ha gesti-
to con cura la clientela dinastica fornendo all’inevitabile nepotismo modi
per esprimersi di indubbia pubblica utilità, tra cui l’apertura del Teatro
Barberini e della Biblioteca Barberina, prima biblioteca scientifica in Euro-
pa a libero accesso per gli studiosi. Gli errori militari nella campagna contro
i Farnese non si erano ancora verificati.
Eppure, una crisi culturale a quell’altezza si va affacciando: il papa che ave-
va avuto il coraggio di fare piazza pulita delle costruzioni antiche e di im-
porsi con la forza dell’homo novus sulle consuetudini della nobiltà romana
(costruendosi, dopo Sisto V, il “popolano”, e dopo il chierico bolognese Lu-
dovisi, “l’integrato”, una fisionomia di papa riservato ed intellettuale), dopo
diciassette anni ha bisogno di istituzioni. Ha bisogno di fondarsi, di creare
una propria agiografia e mitologia. È costretto a ricorrere al fascino del pas-
sato, all’eterna seduzione della Storia: proprio lui che aveva fatto un em-
blema della libertà nel prescinderne.
URBAN PRIMITIVES
Un’occasione in parte perduta è quella del centenario della fondazione della
Compagnia di Gesù, che ricorreva proprio il 27 settembre 1640. Urbano fi-
nanzia per tutto l’anno precedente feste e “rinfrescamenti”, offre indulgenze
plenarie come se piovesse, conia medaglie commemorative in oro e argento,
in vista della cerimonia ufficiale al Collegio Romano organizzata diretta-
mente dalla Compagnia34. Ma la grande operazione editoriale a lui dedicata
nell’occasione del centenario, la serie di emblemi con epigrammi Imago
primi saeculi, riesce, grazie al talento dei Gesuiti in questo senso, a risultare
come una grande celebrazione dell’Ordine finanziata da Urbano, dove il pa-
pa risulta di fatto marginale.
Un’altra impresa, questa non realizzata, avrebbe inteso ispirarsi anch’essa
al modello della monarchia francese, ormai paradigmatica nel mostrarsi
passato e presente, storia e racconto, mito e rito di se stessa. Imitando i ce-
lebri arazzi di Rubens per Maria de’ Medici, e quelli, sempre di Rubens, su
Costantino ricevuti in omaggio da Luigi XIII, Urbano pensa ad un ciclo di
affreschi o di arazzi sulla propria vita. In parallelo con l’uscita dei Docu-
menti, l’Ubaldini si dedica, tra il 1640 e il 1643, a redigerne il programma.
La morte del papa impedirà la realizzazione degli affreschi, ma il program-
ma verrà ripreso vent’anni dopo, nel 1663, dal cardinale Francesco Barberi-
ni, per una magnifica serie di arazzi, oggi ai Musei Vaticani35. Confrontando
gli arazzi con gli affreschi di Palazzo Barberini e con le illustrazioni dei Do-
34 “Am 2 August 1640, kurz nach dem Festtag des heiligen Ignatius, war ein im Hof des römischen Kollegs errichteter Festapparat vollendet. Seine Finanzierung hatten die Jesuiten selbst übernommen und entsprechend sollte die ephemere Dekoration nicht zuletzt die Ho-chachtung und Dankbarkeit des Ordens der Societatis Iesu gegenüber Papst Urban VIII ein-drücklich vor Augen führen. Das Programm hatte der Jesuitenpater Pietro Sforza Pallavicino gemeinsam mit Schülern des Kollegs erarbeitet, von welchem eine detaillierte Beschreibung des Cortile überliefert ist” (Ralph-Miklas DOBLER, Urban VIII und die Jesuiten. Die Dekora-tion des Cortile del Collegio Romano in Jahr 1640 und ein Impresenbuch für den Papst, ne I Barberini (Atti del Convegno Internazionale, Roma, Palazzo Barberini alle Quattro Fonta-ne, 7-11 Dicembre 2004), a cura di Lorenza MOCHI ONORI, Sebastian SCHÜTZE e Francesco SOLINAS, De Luca Editori d’Arte, 2007, pp. 195-202). Manca per ora, come osserva lo stesso Dobler, uno studio sui rapporti tra Urbano e i Gesuiti, basato su un controllo di prima mano dei documenti della Compagnia. 35 James Gordon HARPER, War & Peace in the Barberini Tapestries, ne I Barberini cit., 431-446.
LUANA SALVARANI
cumenti, emerge una vera e propria iconografia barberiniana, organizzata
in un sistema di corrispondenze tra elementi classici e pagani, simbologia
religiosa, elementi della tradizione figurativa barocca ed emblemi
dell’impresistica rinascimentale36. L’apparato allegorico che ne deriva è
quindi il risultato di una “scuola” che si era raccolta attorno a Pietro da Cor-
tona37, Andrea Sacchi e Andrea Camassei. Caratterizzata da un segno e da
consuetudini rappresentative riconoscibili al di là delle differenze indivi-
duali.
Di questa “scuola” le figure dei Documenti d’Amore rimangono l’unico pro-
getto concluso nel corso del pontificato barberiniano.
36 Per lo studio dell’iconografia barberiniana in ambito pittorico rimandiamo agli studi di John Beldon SCOTT, Images of Nepotism: The Painted Ceilings of Palazzo Barberini, Prince-ton University Press, 1991. Ma tale sistema andrebbe interconnesso con opere barberiniane fondamentali come il Theatro di imprese di Giovanni Ferro e con la miriade di illustrazioni del Museum Chartaceum di Cassiano dal Pozzo. Abbiamo tentato una prima ricognizione di questa iconografia discutendo il sistema allegorico del poema di Francesco Bracciolini, L’Elettione di Urbano papa VIII, Trento, La Finestra, 2006. 37 Il Cortona seguirà i disegni degli arazzi fino sua morte nel 1669.