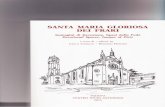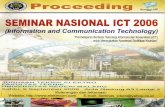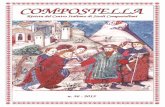Ahiqar tra leggenda e rielaborazione letteraria. Una tradizione e i suoi riflessi
I santi all’assedio: nascita e fortuna di una leggenda comunale tra XV e XVIII secolo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of I santi all’assedio: nascita e fortuna di una leggenda comunale tra XV e XVIII secolo
Alessia Cotti
I santi all’assedioNascita e fortuna di una leggenda comunale tra XV e XVIII secolo
Pubblicato in
«El patron di tanta alta ventura»Pietro Avogadro tra Pandolfo Malatesta
e la dedizione di Brescia a Venezia
Travagliato-BresciaEdizioni Torre d’Ercole
2013
AlessiA Cotti
i sAnti All’Assedio: nAsCitA e fortunA
di unA leggendA ComunAle trA xv e xviii seColo
La nascita di una leggenda
Alla figura di Pietro Avogadro è legato un episodio assai noto del-la storia civile di Brescia: l’assedio posto alla città nel 1438 dalle truppe milanesi guidate da Niccolò Piccinino.1 Le vicende che ne seguirono, in particolare il fallito tentativo da parte dei viscon-tei di impadronirsi della città, determinarono la fioritura di un altrettanto noto episodio, questa volta legato alla tradizione reli-giosa: il racconto dell’apparizione di Faustino e Giovita, secondo il quale il 13 dicembre del 1438 i santi avrebbero respinto, dagli
1. Per una prima conoscenza degli eventi si veda La cronaca di Cristoforo Soldo, a cura di g. BrizzolArA, in Rerum Italicarum Scriptores [d’ora in avanti RIS], ii ed., xxi/3, Bologna 1938. Il Soldo, testimone oculare degli eventi narrati, ci ha lasciato un’articolata relazione relativa al periodo dell’assedio. Altrettanto interessanti le osservazioni di un altro illustre testimone oculare, il capitano di Brescia Francesco Barbaro, autore di due famose lettere nelle quali celebra il valore dimostrato dai cittadini bresciani durante l’assedio: A.M. Que-rini, Francisci Barbari et aliorum ad ipsum epistolae ab anno Christi mccccxxv ad annum mccccliii nunc primum editae ex duplici ms. cod. brixiano et vaticano uno, Brescia, Rizzardi, 1743, pp. 76-79; A. Brognoli, Memorie anedote spettanti all’assedio di Brescia dell’an-no 1438 ed alle cose relative, Brescia, Berlendis, 1780; C. PAsero, Il dominio veneto fino all’incendio della Loggia (1426-1575), in Storia di Brescia, ii, La dominazione veneta (1426-1575), diretta e promossa da g. treCCAni degli Alfieri, Brescia 1963, pp. 3-78. Ai titoli proposti sono da aggiungere le testimonianze relative all’assedio che ancora si conservano manoscritte e quelle che, sebbene edite, attendono uno studio approfondito e critico; è questo il caso di una storica d’eccezione, la badessa di Santa Giulia Angelica Baitelli (1588-1650) che descrive con grande pathos le condizioni del monastero durante quegli anni: «Si era come ho detto di sopra la nostra città donata alla Serenissima Repubblica di Venetia, essendosi scossa da se stessa dalla tirannide de ducchi di Milano, che favorendo gebelini imponevano gravissime taglie a guelfi, che erano ridotti a mal partito il che seguì l’anno 1422. Gl’anni susseguenti patì la nostra città l’assedio delli anni 1438, 1439 e 1440, nel quale con la città stessa si ridussero anche le nostre monache in estrema miseria, come ben racconta una nostra cronichetta di quel tempo, nel quale stettero sempre le nostre madri in orationi e digiuni, e voluntari e necessari, perché non havevano altro che vivere che pane e aqua e ad ogni momento volavano le muraglie del monastero, per aria gettate dalle artegliarie di Niccolò Piccinino che l’assediava» (A. BAitelli, Annali historici dell’e-dificatione, erettione e dotatione del serenissimo monasterio di San Salvatore e Santa Giulia di Brescia, Brescia, Antonio Rizzardi, 1657, p. 79).
122 ALESSIA COTTI
spalti del castello, l’assalto finale delle truppe nemiche.2 Finalità del mio intervento sarà quella di tentare di comprendere se e in che modo il racconto di tale episodio sia da leggere in relazione con il consolidamento del sentimento civico, cercando proprio attraverso questa linea d’indagine di conoscere meglio anche la società e le istituzioni che lo produssero.3 A tal fine è necessario fare riferimento a documenti in larga misura noti, ai quali è forse giunto il momento di rivolgere quesiti nuovi.
Il primo accenno alle figure di Faustino e Giovita compare nelle provvisioni del Comune di Brescia:
1438 die xv mensis decembris
Convocatis et congregatis infrascriptis dominis, abbate et antianis nego-tiis Comunis Brixiae presidentibus ac additis de mandato et in praesen-tia magnifici domini potestatis et spectabilis domini vicarii scilicet
omissis
Praefati domini consiliarii multiphariam experti misericordiam et pie-tatem clementissimi Domini Dei nostri et efficatiam intercessionum beatissimae Virginis Mariae et beatorum martirum Faustini et Jovitae et omnium sanctorum qui dignati sunt pro nobis intercedere, nam die sanctae Luciae xiii presentis mensis et die sequenti, videlicet die sancti Viatoris episcopi Brixiae xiiii dicti decembris, hanc civitatem in locis Mombelli, Turris Longae et Ravarotti et in partibus circonstantibus quod per totum conati sunt hostes viribus armorum et per proelium ordinatum civitatem intrare et cum milibus fulminibus bombardarum,
2. P. guerrini, L’assedio di Brescia del 1438 e le memorie religiose che lo riguardano, «Me-morie storiche della Diocesi di Brescia», 9 (1938), pp. 176-86; A. fAPPAni, I Santi Faustino e Giovita, Brescia 1985; P. guerrini, Una leggenda popolare intorno ai Santi Faustino e Giovita, in id., Santi e beati, i, Brescia 1986.
3. Scrive Paolo Golinelli: «le fonti agiografiche» consentono «di conoscere aspetti trascu-rati o dimenticati della storia» (P. golinelli, Città e culto dei santi nel Medioevo italiano, Bologna 1996, p. 9). Si vedano inoltre: g. KlAniCzAy, I miracoli e i loro testimoni. La prova del soprannaturale, in Il pubblico dei santi. Forme e livelli di ricezione dei messaggi agiogra-fici, Atti del iii convegno di studio dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia (Verona, 22-24 ottobre 1998), a cura di P. golinelli, Roma 2000, pp. 367-86 (si veda in particolare l’ampio apparato bibliografico) e Miracoli dai segni alla storia, a cura di S. BoesCh gAjAno, m. modiCA, Roma 2000.
123I SANTI ALL’ASSEDIO
tandem Deo iuvante vicimus dura et aspera bella cum grandi et innume-rabili strage morte atque conflictu hostium.4
Il riferimento ai santi in un atto pubblico ci porta immediata-mente a riflettere su quelle figure di martiri, vescovi, monaci e sul loro rapporto con le istituzioni civili che come scrive R. Grégoire quando scelgono i loro protettori innescano un meccanismo che «è qualcosa di più dell’uso di scegliersi un patrono [...], il patro-cinio del santo corrisponde ad una tappa dello spirito cittadino e quindi appartiene ad una presa integrale di coscienza di una identità, non soltanto religiosa ed ecclesiale, ma anche politica e strutturale, sociale e amministrativa [...], il santo è l’espressione di una consapevolezza collettiva»;5 in altri termini il santo è un soggetto essenziale nella formazione di una precisa e ben defini-ta identità locale e diviene un elemento portante nei meccanismi di promozione della coesione sociale.6 Francamente non stupisce
4. Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, ms. M f ii 8, f. 86r. Da qui in avanti tutti i ma-noscritti citati si intendono conservati presso la Biblioteca Queriniana, salvo diversa in-dicazione.
5. r. grégoire, Manuale di agiologia. Introduzione alla letteratura agiografica, Fabriano 1987, pp. 380-81; A.m. orselli, L’immaginario religioso della città medioevale, Ravenna 1985; J. delumeAu, Rassicurare e proteggere. Devozione, intercessione, misericordia nel rito e nel culto dell’Europa medioevale e moderna, Milano 1992; P. golinelli, L’agiografia cit-tadina: dall’autocoscienza all’autorappresentazione (sec. IX-XII; l’Italia Settentrionale), in Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350), Atti del quattordicesimo convegno di studi del Centro Italiano di studi di Storia e Arte (Pistoia, 14-17 maggio 1993), Pistoia 1995, pp. 253-74; P. golinelli, Città e culto dei santi nel Medioevo italiano, Bologna 1996, p. 151; G. KlAniCzAy, Ordini religiosi e culti dei santi nella costruzione delle identità territoriali nell’Europa centrale, in Vita religiosa e identità politiche. Universalità e particolarismi nell’Europa del tardo Medioevo, a cura di s. gensini, Pisa 1998, pp. 83-105; d. von der nAhmer, Le vite dei santi, Genova 1998, p. 18 e segg.
6. Il peso dei due martiri nella formazione di una forte coscienza civica trova conferma anche nella monetazione bresciana più antica risalente al XII-XIII secolo; troviamo infatti che sul grosso d’argento, precisamente sul lato dove precedentemente era inserita la figura dell’imperatore, compaiono i due santi: «i due santi patroni vengono posti sulle monete, eliminando ogni richiamo all’Impero che pure aveva dato autonomia alla città. Nessun altro simbolo cittadino venne adottato all’infuori dei due santi considerati in quel secolo come l’elemento di gran lunga prevalente a rappresentare lo spirito cittadino». Lo stesso accade nel XV secolo: «passata Brescia sotto la signoria di Pandolfo Malatesta, ancora nella moneta d’argento di maggior modulo vengono impressi i due santi patroni. Pare logico pensare che il Malatesta, nel far rinnovare tale iconografia, avesse inteso, se non accattivarsi la simpatia cittadina, almeno non creare ulteriori ragioni di distacco dall’a-nimo popolare in un periodo in cui il culto dei patroni era ancora estremamente vivo e
124 ALESSIA COTTI
che sia proprio nella calamitosa contingenza dell’assedio che tale racconto trovi la sua ragione di essere, in un momento cioè in cui per le istituzioni politiche più difficile era diventato l’esercizio stabile della propria autorità. Appare allora importante sottoline-are come siano proprio le istituzioni cittadine a riferirsi per prime e con precisione ai due santi, invocati a difesa della città nel luogo esatto dove ben sapevano il nemico avrebbe colpito, come risulta chiaramente dalla provvisione del 10 dicembre 1438: [...] tria evidentissima pericula memorabat contra que necessarium erat omnimode et subito providere quoniam certus erat quod intra tres vel quattuor dies hostes dare intendebant proelia ordinata contra civitatem in locis specialiter antedictis et primo: primo locum Ravarotti et a Ra-varotto superius, secundo Revilinum portae, seu Rocche Turris Longe cum anexa porta veteri, tertio Mombellum.7
Il progetto appare chiaro e si configura come il tentativo di inne-scare, attraverso l’epico racconto dell’apparizione dei patroni in armi, quei meccanismi in grado di contrastare le forze disgreganti l’assetto sociale, che l’assedio doveva aver, inevitabilmente, mes-so in atto.8 Ed è difficile pensare ad un elemento più forte della devozione per Faustino e Giovita: due figure che nel comune sen-timento religioso erano indissolubilmente legate alle più antiche e gloriose pagine della storia cittadina.9
pregnante di significato politico» (E. mAinetti gAmBerA, Il culto dei santi Faustino e Gio-vita: i primi centri di diffusione in Italia e l’apporto della monetazione bresciana, in Studi in onore di Luigi Fossati, [s.c.], Brescia 1974, pp. 118-19). Sul tema del patrocinio del santo martire cittadino, rimangono fondamentali gli studi di orselli, L’immaginario religioso ed eAd., Simboli della città cristiana fra tardoantico e medioevo, in La città e il sacro, a cura di F. CArdini, Milano 1994, pp. 419-50. Si veda inoltre la preziosa rassegna di studi offerta da A. Benvenuti nella sua introduzione a h.C. Peyer, Città e santi patroni nell’Italia me-dievale, Firenze 1998, pp. 29-37.
7. Brescia, Archivio di Stato, Archivio Storico Civico [d’ora in avanti ASC] 1099, Provvi-sioni, anni 1438-1439, sub die 10 dicembre 1438.
8. Ancora una volta vengono in nostro aiuto le Provvisioni cittadine, in modo particolare quelle dei mesi immediatamente precedenti agli eventi del dicembre 1438; in esse appa-iono forti il malcontento e la preoccupazione degli assediati (si veda PAsero, Il dominio veneto fino all’incendio della Loggia, pp. 40-41).
9. Sull’origine aristocratica e bresciana dei due martiri scrive il Malvezzi: «In illis tem-poribus fuerunt Faustinus et Jovita Brixiae cives illustres troianorum nobilium sanguine
125I SANTI ALL’ASSEDIO
Contestualmente ai documenti della cancelleria, va citata una testimonianza scritta di carattere privato: una lettera. Si tratta del testo inviato il 10 gennaio 1439 da Niccolò Colzè all’amico Nic-colò Chiericati,10 nel quale si attribuisce ai due santi, in modo palese, la salvezza dalle truppe milanesi:
Plurimi autem, etiam gravissimi, ab hostibus auditum referunt medio in conflictu duos aureis armis insignitos in pugnam se exhibuisse, qui nedum vi et armis sed minitanti ac pene divino quodam aspectu et ho-stes terrere et ipsos aggeribus sternere visi sunt, quo nonnulli existimant clarissimos martyres urbisque huius patronos, Faustinum scilicet et Jo-vitam, cedentibus humanis viribus, se locum et gentem tutari voluisse.11
La testimonianza del Colzè presenta alcuni caratteri veramen-te singolari tipici dei racconti agiografici. L’apparato linguistico e l’impianto descrittivo infatti sono quelli comuni alle narrazioni di miracoli: presentazione di un evento calamitoso, manifestazio-ne di un intervento divino, elaborazione di una testimonianza o, se vogliamo chiamarla in altro modo, di una leggenda.12 Nel te-sto è interessante focalizzare l’attenzione sul termine «gravissimi», personaggi cioè degni di credito: non da popolani o da dicerie di
procreati. Horum progenitores longissimis temporibus inter ceteros brixianae urbis cives divitiis, potentia et honoribus praevalebant. Pater eorum caput senatus fuit; ipsi in civitate primates erant, militari gloria redimiti, viri eruditissimi et sapientiae studiosi, Reipublicae maximi curatores»: Chronicon brixianum ab origine urbis ad annum usque mcccxxxii, in RIS, xxiv, a cura di l.A. murAtori, Milano, Società Palatina, 1729, col. 795; si vedano inoltre d. PodAvini, De nobilitate Brixiae, Brescia, Vincenzo Sabbio, 1587, c. A2v; j. Bol-lAndus, g. hensChenius, Acta sanctorum. Februarius, Tomus ii, Antverpiae, apud Jaco-bum Meursium, 1658, pp. 805-21; A. BArChi, Storia dei santi martiri bresciani investigata nei primi nove secoli del cristianesimo, Brescia 1842, p. 59; G. BrunAti, Vita o gesta di santi bresciani, i, Brescia 1854, pp. 169-223.
10. Sul Colzè: r. riCCiArdi, s.v. Colzè, Niccolò, in Dizionario Biografico degli Italiani, 27, Roma 1982, pp. 506-7.
11. F. odoriCi, L’assedio di Brescia del 1438. Narrazione contemporanea del vicentino Ni-colò Colzè riveduta sul codice marciano da cui fu tratta e preceduta da un cenno istorico dell’assedio stesso, Parma 1869, p. 23.
12. In presenza di un miracolo, la descrizione che ne segue è codificata: «[...] è molto importante che l’episodio miracolistico avvenga in presenza del gruppo e sia, in seguito, registrato da testimoni degni di fede. Il prodigio si svolge secondo un itinerario regolare, spesso attestato. In se stesso, è una esperienza» (grégoire, Manuale di agiologia, pp. 305-20: 315). Si veda inoltre H. delehAye, Le leggende agiografiche, Firenze 1906.
126 ALESSIA COTTI
donne, dunque, traeva origine il racconto, ma da individui che go-devano di una forte autorevolezza a livello sociale. Tutto questo rende difficile assecondare certe linee interpretative dell’evento che vedrebbero nascere il racconto tra gli ambienti popolari e ap-prodare poi, sotto forma di leggenda, tra gli strati più elevati della popolazione.13 Il meccanismo sembra esattamente opposto: sono le autorità cittadine che promuovono e sollecitano nell’immaginario collettivo le figure dei due patroni, attorno ai quali intendono con-centrare l’assenso: si direbbe proprio che ci troviamo di fronte ad un bell’esempio di “leggenda comunale” tutta tesa a consolidare il sentimento civico e, oserei direi, patriottico dei bresciani.14
Le disposizioni emanate dal Comune pochi mesi dopo sono altrettanto indicative e significative: si decide infatti di far esegui-
13. guerrini, i santi martiri Faustino e Giovita, p. 110 e e. ferrAglio, La città ed i patro-ni: Brescia ed un miracolo controverso, in Florentissima proles ecclesiae. Miscellanea ha-giographica, historica et liturgica Reginaldo Grégoire O.S.B. xii lustra complenti oblata, a cura di d. goBBi, Trento 1996, p. 245. Altrettanto poco convincente è l’idea secondo cui sia stato «lo stesso Piccinino o qualcuno dei suoi condottieri minori a lanciare, in buona o mala fede, la notizia della visione dei due guerrieri, apparsi sulle contese mura del Roverotto in armature splendenti e con cipiglio severo, a difendere Brescia e a respin-gere gli assalti degli assediatori. La supposizione che la leggenda abbia avuto origine dalla mentalità superstiziosa del Piccinino non è difatti improbabile per chi conosce la figura e la psicologia di questo audace, crudele ma sfortunato condottiero visconteo»: guerrini, L’assedio di Brescia del 1438, p. 184.
14. Non è possibile in questa sede dare conto della copiosa tradizione di racconti di ap-parizioni che vedono protagonisti i patroni in qualità di difensori delle città a loro consa-crate. Ci sembra nondimeno interessante il riferimento ad un episodio che doveva essere assai noto a Brescia, quello cioè dell’apparizione di sant’Ambrogio durante la battaglia di Parabiago del 1339, reso famoso dal racconto di Galvano Fiamma: «Postquam Lodrisius Vicecomes Abduam transivit, et Legnanum pervenit, Theutonici ipsi subesse aut obedire contempserunt. Determinaverunt inter se, si civitatem optinere potuissent, interfectis ci-vibus de Mediolano rusticos pro agricoltura conservare et theutonicos innumerabiles de Allamania convocare et Lombardiam sub jugo Theutonicorum supponere et civitatem Mediolanensem in colonia redigere. Sed Deus tantorum malorum refrenator existens, mi-sit beatum Ambroxium, qui in albis cum scutica in manu visibiliter hostes victoria potitos percussit: ex quo perdiderunt vires et superati sunt; ex hoc facta est in civitate processio cleri et religiosorum et progressi sunt ad sanctum Ambroxium» (G. fiAmmA, Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino et Johanne Vicecomitibus ab anno mcccxxviii usque ad annum mcccxlii, a cura di C. CAstiglioni, in RIS2, xii/4, Bologna 1938, p. 31. Si vedano a solo titolo d’esempio: A. rigon, S. Antonio da «pater Padue» a «patronus civitatis», in La religion civique à l’époque médiévale et moderne (Chrétienté et Islam), Actes du colloque organisè par le Centre de recherche «Histoire sociale et culturelle de l’Occident. xiie-x-viie siècle» de l’Université de Paris x-Nanterre et l’Institut universitaire de France (Nan-terre, 21-23 juin 1993), Rome 1995, pp. 69-70; KlAniCzAy, Ordini religiosi e culti dei santi, pp. 98-99; A.i. Pini, Città, Chiesa e culti civici in Bologna medievale, Bologna 1999, p. 211.
127I SANTI ALL’ASSEDIO
re un imponente stendardo da mandare a Venezia, sul quale com-paiano san Marco, lo stemma del Comune e i due santi Faustino e Giovita:15
Providerunt et ordinaverunt quod ad honorem et perpetuam famam istius civitatis fiat unum grande et honorabile stendardum sive confano-num supra quo sit arma Comunis, immago veneranda sancti Marci et be-atissimorum martirum Faustini et Iovittae expensis Comunis et dicatur in consilio generali quod stendardum donetur per communitatem serenissi-mo domino, domino nostro in signum fidelitatis et caritatis.16
Due giorni dopo il consiglio comunale è nuovamente riunito e de-cide per un ulteriore, e non casuale, aggiunta da farsi al gonfalone da inviare a Venezia:17
Providerunt et ordinaverunt [...] fiat unum confanonum sive stendar-dum supra quo sit arma Communis quod donetur serenissimo domino nostro parte communitatis in signum fidelitatis et amoris et quod consulat spectabilem dominum Paulum filium domini potestatis, qui est vir exper-tus et magne prudentiae, supra facto factionis et expense, avisando de ar-mis et imaginibus quas supra ipso volumus et quod in ipso sit unum breve litterarum grandium de auro infrascripti tenoris, et postea rescribat:
BrixiA mAgniPotens fidei suAe Coeteris urBiBus testimonium tulit.18
È difficile non pensare alle parole che, poco più di una decina di anni prima, erano state solennemente pronunciate a San Pie-
15. g. degli Agostini, Notizie storico critiche intorno la vita e le opere degli scrittori vinizia-ni, ii, Venezia, Simone Occhi, 1754, pp. 85-86; A. vAlentini, Ricerche intorno al gonfalone antico della città di Brescia, Brescia 1898. Ci sembrano quanto mai significative a questo punto le considerazioni della Benvenuti quando afferma «l’inutilità, se non l’erroneità, per lo storico, di una separazione fittizia tra la sfera del “civile” o “laico” e quella del “religio-so” o “ecclesiastico” nella interpretazione dei simboli di identità municipale nel Medioevo comunale italiano» (A. Benvenuti, I culti patronali tra memoria ecclesiastica e costruzione dell’identità civica: l’esempio di Firenze, in La religion civique, p. 101).
16. Brescia, Archivio di Stato, ASC 1099, Provvisioni, anni 1438-1439, sub die 24 marzo 1439.
17. In merito all’uso dei gonfaloni si veda e. duPré theseider, Sugli stemmi delle città comu-nali italiane, in La storia del Diritto nel quadro delle scienze storiche, Atti del primo congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Firenze 1966, pp. 311-48.
18. Brescia, Archivio di Stato, ASC 1099, Provvisioni, anni 1438-1439, sub die 26 marzo 1439.
128 ALESSIA COTTI
tro de Dom nelle mani del Carmagnola, quando al termine della sontuosa celebrazione che vedeva Brescia legarsi a Venezia, era stata innalzata una preghiera in esametri che non lasciava dubbi su ciò che i Bresciani si aspettavano dalla fedeltà alla Serenissima. Allora le autorità cittadine si erano poste sotto la tutela del solo san Marco scrivendo:
BrixiA mAgniPotens floresCAt, PrAeside mArCo
AsPerA nunC Positis mitesCAnt syderA Bellis.19
Oggi la situazione era cambiata e accanto all’evangelista trova-vano posto, alla pari, i due numi tutelari Faustino e Giovita. I concetti sui quali si insiste ora sono quelli della lealtà ma anche dell’autoaffermazione: Brescia è fedele, lo è stata nel frangente doloroso dell’assedio, lo è tra le tante città che ruotano nella sfera d’influenza della Serenissima, ma Brescia ribadisce la sua capa-cità di muoversi in piena autonomia affiancando all’evangelica protezione marciana quella tutta propria dei martiri Faustino e Giovita, celebrati nello stendardo ma soprattutto nell’epico epi-sodio della loro provvidenziale apparizione contro le truppe del Piccinino.20
Il racconto nella storiografia cittadina
È a questo punto che ci chiediamo se, come e quando il racconto entri nelle cronache cittadine.21 Il primo testo a stampa nel quale
19. Iuramentum fidelitatis Brixianorum anno 1426, ms. Brescia, Biblioteca Civica Queri-niana, C i 13°, f. 69r.
20. Sembra proprio di poter dire che Brescia non si sottragga alla comune sorte delle città venete di Terraferma che «nella comune tensione ad esprimere se stesse anche attraverso la religione, cercano e trovano forme diverse: dal controllo delle istituzioni ecclesiastiche e religiose (penso ai benefici ecclesiastici o ai monasteri femminili), all’esaltazione di santi patroni più o meno tradizionali» (g. de sAndre gAsPArini, L’amministrazione pubblica dell’evento religioso: qualche esempio della terraferma veneta del secolo XV, in La religion civique, pp. 204-5).
21. Non è qui possibile passare in rassegna in modo realmente esaustivo tutte le fonti che riportano riferimenti all’apparizione, il compito che ci siamo proposti è stato quello piuttosto di operare un primo tentativo di analisi attraverso i secoli e i generi letterari, così
129I SANTI ALL’ASSEDIO
compare un esplicito riferimento all’apparizione è del 1505. Si tratta della cronaca di Elia Capriolo, in essa leggiamo:
Ferunt hic quidam in Picinini castris famam exiisse duo numina super muro ad Apollonianum in pugnantium speciem ab ipsis hostibus visa, quae divos Faustinum et Jovitam fuisse postea est existimatum.22
Il Capriolo non scrive di credere all’apparizione, ma in quel suo «ferunt» ci dà la cifra chiara della diffusione di un racconto, che non poteva essere taciuto da chi si fosse proposto il compito di narrare uno degli episodi di maggiore impatto politico relativi alla storia di Brescia.23
Racconto che orgogliosamente si piaceva narrare ai nobili e potenti alleati veneziani. È questo ciò che accadde con un os-servatore d’eccezione come Marin Sanudo che nel suo Itinerario, dopo aver annotato come Brescia si distinguesse per le sue «mura grosse, alte, belle et inexpugnabille» aggiungeva come proprio «tra le Pille et Torre, e dove Nicolao Picenino bombardava […] li apparse san Faustin, san Jovita, e sant’Apollonio, tutrici e prote-tori di Brexa, et per questo si levò dil campo».24
da mostrare quanto profondamente l’episodio al Roverotto sia divenuto parte integrante dell’identità culturale cittadina.
22. e. CAPriolo, Chronica de rebus Brixianorum, Brescia, Arundo de Arundis, [c. 1505], c. K5v. Per la figura e l’opera del Capriolo si veda s. signAroli, Brescia, Venezia, Leida: i Chronica di Elia Capriolo nella Respublica literaria dell’Europa moderna, «Italia medioe-vale e umanistica», 49 (2008), pp. 287-329.
23. La vittoria di Venezia su Milano, infatti, condizionerà pesantemente le vicende dell’Ita-lia settentrionale nella prima età moderna e Brescia ne era stata la protagonista essenziale, a detta dei cittadini, proprio grazie al provvidenziale intervento dei bellicosi protettori.
24. m. sAnudo, Itinerario per la Terraferma veneziana nell’anno 1483, Padova 1847, p. 70. I nomi dei due martiri accompagnano, da sempre, quelli dei vescovi Apollonio e Filastrio nel ruolo di patroni e protettori della città, come ben testimonia la ricca letteratura litur-gica intorno al loro culto. Si vedano: B. fAino, Martyrologium Sanctae Brixianae ecclesiae, Brescia, eredi di Antonio Rizzardi, 1665; G.M. Biemmi, Istoria di Brescia, i, Brescia, Co-lombo, 1748, p. 259; I.H. grAdoniCi Pontificum Brixianorum series commentario historico illustrata, Brixiae, ex typographia Ioannis Baptistae Bossini, 1755, pp. xvii-xxii; guerrini, i santi martiri Faustino e Giovita, pp. 85-104; P. tomeA, «Agni sicut nive candidi». Per un riesame della Passio Faustini et Iovite BHL 2836, in San Faustino Maggiore di Brescia, il monastero della città, Atti della giornata nazionale di studio (Brescia, 11 febbraio 2005), a cura di g. ArChetti, A. BAronio, Brescia 2006 (in «Brixia Sacra», s. iii, 9), pp. 17-48; s. gAvinelli, Cultura religiosa e produzione libraria, in A servizio del Vangelo. Il cammino
130 ALESSIA COTTI
Appare evidente che non possiamo pensare ad una casualità, se l’episodio trova le sue prime forme di diffusione scritta non in testimonianze a carattere religioso, ma appunto in quelle crona-che che si prefiggevano di ricostruire i momenti memorabili della storia cittadina. Un’ulteriore conferma la troviamo tra le righe di un testo veramente singolare: il Fioretto delle antiche e moderne croniche della magnifica città di Brescia tradotto in ottava rima per Stefano mantovano e il Fortunato, aggiuntovi alcune belle memorie di cose successe in diversi tempi, cosa dilettevole da intendere, né più stampata, Brescia, Sabbio, [1553].25 Nella lettera prefatoria è illustrata in modo esplicito la finalità di chi scrive, raggiungere la schiera di illetterati che la mancata conoscenza del latino tiene lontani dalle dotte cronache municipali:
La cognitione della istoria, benignissimi lettori, è detta da gli dotti luce de’ tempi, vita de la memoria, noncia de l’antichità et maestra del ben vivere […]. Et perché più è il numero de gli indotti che quello de’ dotti, mi è parso di ridur in un fascetto piccolo in verso vulgare semplicissimo di ottava rima il bosco e la gran selva delle istorie bresciane, acciò che quelli che non hanno il modo o la commodità di leggere i gran volumi non rimanghino al tutto privi de così picciole e dilettevoli lettioni.
Il Fioretto, un testo in ottava rima di facile comprensione e dal ritmo linguistico accattivante, fu chiaramente elaborato perché gli ascoltatori potessero fissare bene nella memoria i fatti narrati; in modo particolare proprio l’epico episodio faustiniano:
Vedendo il Piccinin tanta costanzagli fe soto piantar l’artiglieria per voler far a tutta sua possanzapiù che poteva larga batteria,ma il gran motor, che tutto rege e avanzafece che il giorno di santa Luciasu la muraglia incontro al Piccininoapparve san Iovita e san Faustino.
storico dell’evangelizzazione a Brescia, i, L’età antica e medievale, a cura di g. AndennA, Brescia 2010, pp. 567-94.
25. guerrini, i santi martiri Faustino e Giovita, pp. 114-15.
131I SANTI ALL’ASSEDIO
Nel 1566 è la volta di Bernadino Vallabio e ancora di una cronaca, la Breve cronichetta dilettevole. Trattando del xv secolo, non può mancare il racconto dello scontro al Roverotto, con la relativa apparizione:
Del 1438. Nicolò Picinino capitano di Filippo Maria Visconte duca di Milano, venne a campo alla città di Brescia e vi stete 26 mesi, dil che li poveri Bresciani erano afflitti da la fame, che mangiavano sino li sorzi e la soma del grano valeva 60 lire di Brescia e il giorno di santa Lucia apparse san Faustino e Giovita su la muraglia de sotto del Torrione della Posterla. Vedendo Nicolò Picinino questo miracolo, si levò con tutto il campo e la città fece far le imagini de detti santi, le quali al presente si pon vedere.26
Il resoconto, al tempo stesso minuzioso (precisa notazione sul costo del grano) e patetico (riferimento al nutrirsi di topi),27 pre-senta il miracolo come l’unico elemento essenziale e risolutivo dell’intera vicenda, senza nemmeno un accenno al valore dimo-strato dai cittadini bresciani, donne comprese,28 o dai soldati in quei terribili frangenti: l’apparizione ha ormai focalizzato attorno a sé tutto l’episodio.
La tradizione a stampa di carattere religioso e la questione dei santi Faustino e Giovita “primi” e “secondi”
Solo nel 1588 il racconto entra anche nella produzione a stampa di carattere religioso grazie a La vera historia della passione de’
26. B. vAllABio, Breve cronichetta dilettevole nella quale si narra il principio di questa città di Brescia con la maggior parte delle ruine, guerre e sacchi che essa ha havuto fin al presente giorno mdlxiii cavate dalle antiche e moderne croniche insieme con molte altre cose successe in diversi altri luochi, Brescia, Damiano Turlino, 1566, c. B4v. Il testo del Vallabio conobbe una discreta fortuna editoriale fino al XVII secolo.
27. Il Vallabio riprende palesemente il testo del Soldo: «E anchora fu de quelli che manzò de li cani e deli sorzi e de altre cose triste» (La cronaca di Cristoforo da Soldo, p. 45).
28. Qui non possiamo non ricordare la singolare ma sfuggente figura di Braida Avogadro, che si guadagnò sul campo di battaglia, lei donna, un vitalizio quale riconoscimento del valore dimostrato nei terribili mesi dell’assedio. Per tutta la questione si veda il contributo di Enrico Valseriati nel presente volume.
132 ALESSIA COTTI
gloriosi martiri et cavalieri di Christo santi Faustino et Giovita:29
Ma pur tornando a ragionar de’ miracoli degli stessi santi, non mi par di passar sotto silenzio quello che, quantunque già gran tempo fa si sia avvenuto, resta nondimeno ancora come fresco nella memoria di tutta questa magnifica città. Questo è che nel 1438 Nicolò Picinino, capitanio di Filippo Maria Vesconte duca di Milano, venne a campo alla città di Brescia e vi stette vintisei mesi, onde i poveri bresciani erano astretti dal-la fame e mangiavano fino i sorzi e la soma del grano valeva lire 60 bre-sciane. Et il giorno di san Luca [sic] apparsero i santi Faustino e Giovita su la muraglia sotto il torrione della Posterla. Vedendo Nicolò Picinino questo miracolo si levò con tutto il campo e la città fece far l’imagine di detti santi, le quali ancora al presente si possono vedere.30
Il testo in esame aveva già conosciuto una prima edizione, stam-pata a Brescia per i tipi di Damiano e Giacomo Filippo Turlino nel 1534, con il titolo di Legenda overo passione de li sancti mar-tyri Faustino e Giovita cavalieri de Christo e non presentava alcun riferimento all’apparizione. È l’editore Giovanni Battista Borella che, quando decide di dar vita ad una nuova stampa, ritiene ne-cessario farvi entrare anche l’epico episodio del Roverotto, come egli stesso spiega nella lettera prefatoria.31
L’edizione del Borella obbliga a questo punto ad entrare nel merito di una spinosa querelle storiografica, intrecciata indissolu-bilmente con il racconto dell’apparizione: l’assai nota questione dei santi Faustino e Giovita primi e secondi.32 Il testo presenta in-
29. Non va dimenticato che nel 1490 era stata pubblicata la Legenda de Sancto Faustino e Jovita, ad opera del Farfengo, e che in essa non aveva trovato posto il riferimento all’ap-parizione del 1438. Per l’edizione del 1490 rimandiamo a g. PetrellA, Battista Farfengo e l’illustrazione libraria a Brescia nel Quattrocento, in id., Uomini, torchi e libri nel Rinasci-mento, Udine 2007, pp. 80-99.
30. La vera historia della passione de’ gloriosi martiri et cavalieri di Christo santi Faustino et Giovita nobili bresciani et della conversione di sant’Afra e di molti altri santi con i loro nomi e cognomi, aggiuntavi la traslatione e processione solenne con i miracoli seguiti, Brescia, Policreto Turlino per Giovanni Battista Borella, 1588, pp. 182-83.
31. Egli scrive di aver voluto offrire «la vera historia della vita e passione de’ gloriosi marti-ri santi Faustino e Giovita da me fatta con ogni diligenza ricercare, corregere, authenticare e stampare con alcune aggiunte di non picciola importanza». Le aggiunte si riferiscono appunto al racconto del miracolo al Roverotto.
32. La questione nasce nel XII secolo quando, in seguito a lavori di restauro nella chiesa
133I SANTI ALL’ASSEDIO
fatti la trascrizione di due elenchi di martiri, in realtà già presenti nell’edizione del 1534, le cui reliquie si conservavano a San Fau-stino ad sanguinem.33 L’attenta lettura delle due serie martirolo-giche riserva ad un certo punto una curiosa dicitura: compaiono infatti altri due santi Faustino e Giovita della famiglia dei Pre-gnacchi. Gli elenchi insomma attestano palesemente la diffusione di un doppio culto attribuito ad una seconda coppia di martiri, omonimi.34 Il miracolo al Roverotto sarà attribuito talvolta all’ap-parizione dei primi, talaltra a quella dei secondi!35
di San Faustino ad sanguinem, sono rinvenuti due corpi e una lastra marmorea con un’i-scrizione votiva. Subito viene sapientemente diffusa la notizia che si tratti dei veri corpi dei due martiri, in contrapposizione alla credenza generale che li dice custoditi a San Faustino Maggiore almeno dal IX secolo. Da quel momento si sviluppa tra le due fondazioni, San Faustino ad sanguinem e San Faustino Maggiore, una contesa destinata a protrarsi nel tempo con il preciso intento di ribadire, ognuna, la presenza dei resti dei patroni cittadini. Si vedano in proposito A. geroldi, Espositione del marmo di Vittore Mauro e d’alcuni altri marmi antichi, Brescia, Rizzardi, 1688; A. BAronio, Il monastero di San Faustino nel Medioevo, in San Faustino Maggiore di Brescia, pp. 76-80; d. veCChio, Fonti bresciane per la storia di San Faustino. L’Historiola del 1187, in San Faustino Maggiore di Brescia, pp. 431-43; n. d’ACunto, La pastorale nei secoli centrali del Medioevo. Vescovi e canonici, in A servizio del Vangelo, i, pp. 84-88.
33. La chiesa di San Faustino ad sanguinem, sorta sul cimitero di San Latino, sarà varia-mente denominata nel corso dei secoli: è nota infatti anche come chiesa di Sant’Afra e infine, a partire dal 1945, di Sant’Angela Merici, copatrona (da pochi anni) con Faustino e Giovita della città di Brescia.
34. Il primo elenco si trova alle pp. 166-69 e ricorda i martiri che subirono il supplizio con Faustino e Giovita, il secondo, che si trova alle pp. 170-75, si afferma copiato da un’antica cronaca. I nomi dei martiri sono quelli delle famiglie aristocratiche bresciane: Maggi, Avo-gadro, Martinengo e così di seguito. Saremmo dunque palesemente in presenza di quei cataloghi, assai diffusi nelle cronache municipali, fatti elaborare dalle famiglie patrizie, nel preciso intento di legare il proprio nome a quello della storia cittadina più antica. La scelta del cognome antico e prestigioso di “Pregnacchi” non era ovviamente casuale. Interessanti in proposito le osservazioni di Biemmi, Istoria di Brescia, i, pp. 290-94.
35. Sulla questione dei santi Faustino e Giovita primi e secondi la bibliografia è copio-sissima. Non esistono testi, antichi e moderni, relativi ai due martiri che non ne abbiano ampiamente trattato. Ad essi dunque rimandiamo. A solo titolo d’esempio e per avere un’idea di come ancora nel XVIII secolo la questione fosse tutt’altro che sopita, riassu-miamo in questa sede quanto accade quando il già citato Biemmi pubblica la sua Istoria e dedica l’intero libro quinto a Faustino e Giovita. Carlo Doneda scrive allora le Osservazio-ni storico-ecclesiastiche sopra il tomo primo dell’Istoria di Brescia del Signor don Giammaria Biemmi, Brescia, [s.n.], 1749, non lesinando critiche all’autore. Lo stesso fa Vincenzo Poncarali, abate dei Canonici Lateranensi di Sant’Afra, che legge entrambi i testi e stende a sua volta la Lettera di un cittadino bresciano al Signor don Giammaria Biemmi autore dell’Istoria di Brescia sopra ciò che egli scrive intorno alla traslazione de’ santi martiri Fau-stino e Giovita, Lugano, Agnelli, 1749, nella quale è molto critico sull’uso delle fonti e
134 ALESSIA COTTI
I testi successivi dedicati ai due martiri, infatti, difficilmente eviteranno di entrare nella contesa primi e secondi, a partire da quella licenziata da Ascanio Martinengo nel 1602 per i tipi del Marchetti.36 Per il Martinengo la faccenda era tutt’altro che di secondaria importanza, essendo egli abate di Sant’Afra e quindi quantomai interessato a mantenere vivo il culto delle reliquie pa-tronali presso il suo monastero. Non è casuale che sia proprio il
sulle affermazioni del Biemmi. La critica del Poncarali provoca un nuovo intervento del Doneda, cioè la Risposta alle difficoltà in vari tempi prodotte contro l’esistenza dei corpi de’ santi martiri Faustino e Giovita nella chiesa di San Faustino Maggiore di Brescia, Padova, Conzatti, 1751, con la quale l’autore ribadisce la presenza dei martiri solo a San Faustino Maggiore. Poncarali scrive allora la Lettera seconda di un cittadino bresciano al Signor don Giammaria Biemmi in cui si disamina la risposta alle difficoltà in vari tempi prodotte contro l’esistenza de’ corpi de’ santi martiri Faustino e Giovita nella chiesa di San Faustino Maggiore di Brescia, Lugano, Agnelli, 1752 e smonta una dopo l’altra le affermazioni di Doneda. È a questo punto che entra nella questione l’abate benedettino Giovanni Ludovi-co Luchi. Egli pubblica il 24 giugno 1752 la Prima lettera di N.N. al signor don Giammaria Biemmi intorno l’esistenza dei corpi de’ santi martiri Faustino e Giovita nella chiesa di San Faustino Maggiore in confutazione della lettera seconda del cittadino bresciano al medesimo indirizzata, Brescia, Turlino, 1752; il 1° agosto 1752 la Lettera seconda di N.N. al signor don Giammaria Biemmi, Brescia, Turlino, 1752; il 15 settembre 1752 la Lettera terza di N.N. al signor don Giammaria Biemmi, Brescia, Turlino, 1752; il 30 gennaio 1753 la Let-tera quarta di N.N. al signor don Giammaria Biemmi, Brescia, Turlino, 1752, nelle quali conferma l’esistenza dei corpi dei santi in San Faustino Maggiore. Il caso bresciano che vede contrapporsi due monasteri potenti e prestigiosi, nel preciso intento di rivendicare ognuno il possesso delle reliquie patronali, è in realtà assai comune. Si vedano in proposito le attente osservazioni di P. Golinelli, Antichi e nuovi culti cittadini al sorgere dei Comuni nel nord-Italia, «Hagiographica», 1 (1994), p. 166 e segg.
36. «Chi non sa quel gran miracolo che occorse nell’anno 1438 quando stringendo Nicolò Picinino, capitano di Filippo Maria Visconte duca di Milano, questa città con sì atroce e lungo assedio di più di due anni che astretti i cittadini dalla fame si pascevano di cose lorde come sorzi e altre simili e stavano per cadere a hora per hora nelle mani del nemico sitibondo del sangue loro, apparvero i gloriosi martiri Faustino e Giovita il giorno di san Luca (sic), alla parte di levante non molto lontano da quel baloardo che si chiama della Pusterla, su le mura e rintuzzando miracolosamente l’ardire e forze dell’inimico, lo con-strinsero a levarsi dall’assedio; il che fecero sì per salute della sua amata città come per diffesa di quelle chiese dove giaceano le loro sacratissime ossa»: A. mArtinengo, Vite de’ gloriosi santi martiri Faustino et Giovita et di sant’Afra et d’altri santi bresciani gli cui sacri corpi et reliquie si conservano in diverse chiese di Brescia, Brescia, Pietro Maria Marchetti, 1602, pp. 58-59. Per la figura di Ascanio Martinengo (1539-1600) si possono vedere C.B. zAmBoni, La libreria di sua eccellenza il nobil uomo signor Leopardo Martinengo patri-zio veneziano conte di Barco, condomino di Villanuova, feudatario di Pavone e signore di Clanesso, cogli uomini illustri della chiarissima famiglia Martinengo umiliata al medesimo cavaliere dalla spettabile comunità di Calvisano, Brescia, Vescovi, 1778, pp. 63-66; V. Pero-ni, Biblioteca bresciana, ii, Brescia 1818-1823 (=Bologna 1968), pp. 226-27 e P. guerrini, Una celebre famiglia lombarda. I conti di Martinengo. Studi e ricerche genealogiche, Brescia 1930, pp. 240-41.
135I SANTI ALL’ASSEDIO
dotto abate a riportare con precisione la risposta di papa Grego-rio XIII al quale il Borromeo in persona si era rivolto, nel corso della famosa visita del 1580, per dirimere la questione:
Dobbiamo dire che là in parte e qui in parte si ritrovino [sc. i corpi] e che in ambedue le chiese si debbano honorare. Per il che prudentissi-ma fu la risposta di papa Gregorio decimoterzo di santa memoria, che ricercandogli il cardinal Borromeo, quando fu a Brescia visitatore apo-stolico, d’aprir l’arca e vedere il certo di questa contesa, rispose che non giudicava bene di farlo, ma si lasciasse ch’ i popoli piamente nell’una e nell’altra chiesa honorassero i santi mosso dallo Spirito Santo che regge quella sede, accioché, sì come quelle sante reliquie erano veramente in ambidue i luochi, così in ambidue fussero venerate.37
Negli anni ’20 del XVII secolo è lo storico Ottavio Rossi a dedi-care due testi a Faustino e Giovita. Nel primo l’autore analizza gli eventi legati alla ricognizione dei corpi nel 1623, nel secondo stende una vera e propria storia delle due coppie di martiri.38 Con il Rossi il racconto dell’apparizione e la questione dell’esistenza di quattro corpi di santi si compenetrano ulteriormente. Anche il Rossi ci presenta i santi Faustino e Giovita primi custoditi a San Faustino Maggiore e i santi Faustino e Giovita secondi della famiglia dei Pregnacchi sepolti a Sant’Afra. Questi ultimi, scrive in prima battuta, sarebbero apparsi al Roverotto e avrebbero fer-mato il Piccinino:
Fu detto (come fu poscia parimenti con publica memoria confirmato dalla città) che san Faustino e san Giovita comparendo avanti sopra le muraglie nel luogo del Roverotto, facessero miracolosamente levarci
37. Nel suo testo il Martinengo passava in rassegna la vasta documentazione relativa alle diverse ricognizioni sui resti dei martiri e arrivava alla conclusione che il problema non consisteva, in sostanza, nell’autenticità dei corpi ma sul fatto che non era possibile sapere se erano stati interamente o solo in parte spostati da Sant’Afra a San Faustino Maggiore:
mArtinengo, Vite de’ gloriosi santi martiri Faustino et Giovita, p. 58. Per la visita del Borromeo si vedano San Carlo Borromeo a Brescia, Atti del convegno (Rovato, 27 ottobre 1984), [a cura di e. Bononi], Rovato 1987; Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla Diocesi di Brescia, a cura di A. turChini, g. ArChetti, «Brixia Sacra», s. iii, 8/1-2 (2003).
38. o. rossi, Relatione dell’aprimento dell’arca de’ santissimi protomartiri et protettori del-la città di Brescia Faustino et Giovita scritta all’illustrissimo et eccellentissimo signore il signor Lionardo Mocenigo procurator di san Marco, Brescia, Vincenzo Sabbio e figli, 1623.
136 ALESSIA COTTI
l’assedio di Nicolò Picinino. Si pubblicarono allhora certe scritture e cronichette, nelle quali facendosi chiarissima menzione che i santi mar-tiri Faustino e Giovita primi di questo nome non erano mai stati scolpiti o dipinti in habito di soldati, ma che i secondi fossero bene stati soldati e cavalieri, questi per consequenza, e non i primi, fussero stati quelli che havessero liberata la città da quello assedio longhissimo e acerbissimo.39
Ma poi, qualche pagina dopo, al termine del resoconto sulla ri-cognizione dei corpi custoditi a San Faustino Maggiore nel 1455, precisa:
Si conchiuse perciò più liberamente la verità del sepolcro de’ primi san-tissimi Faustino e Giovita, cognominati i maggiori. Et attribuendosi a loro la comparizione al Raverotto, si diede principio a dipingere e scol-pire anch’essi in habito di cavalieri e così tuttavia si continua di formarli, contra all’uso degli antichi come habbiamo suddetto in habito sacerdo-tale e religioso. Di che se ne vedono esempi nelle medaglie d’argento stampate in Brescia l’anno del 1134 per honorar la venuta in questa città di papa Innocenzo secondo col rovescio del nome di esso papa inquartato con la croce e con le parole nell’orlo BrisiA. Così in quell’altra medaglia del millecento nonant’uno col rovescio di santo Apollonio, co-niata per conservar la memoria dell’acquisto del carroccio cremonese. Così ne’ danari di Pandolfo Malatesta.40
39. o. rossi, Historia de’ gloriosissimi santi martiri Faustino et Giovita scritta da Ottavio Rossi, nella quale si discorre brevemente ancora de gli altri gloriosissimi santi Faustino e Giovita secondi martiri di questo nome e d’altri santi di molte famiglie bresciane, Brescia, Bartolomeo Fontana, 1624, pp. 51-52.
40. rossi, Historia, pp. 56-58. Sembrerebbero della stessa opinione del Rossi anche alcuni storici dell’arte contemporanei, che proprio nell’episodio del Roverotto leggono la piena affermazione del modello iconografico legato alla rappresentazione dei due santi in abiti militari: G. fusAri, Memorie del martirio: le Ricognozioni, in I santi Faustino e Giovita patroni della terra bresciana. Vicende, devozione e arte nel culto delle reliquie, Brescia 2003, p. 15. Il testo del Rossi sollevò non poche polemiche: si veda ad esempio i. ChizzolA, Ri-soluzioni delle opposizioni fatte alli gloriosissimi santi martiri Faustino e Giovita nell’altar maggiore di Sant’Afra in Brescia adorati, Brescia, Paolo Bizardo, 1630, nel quale l’autore ridicolizza la teoria che possa esistere una seconda coppia di martiri. Trova invece assolu-tamente legittimo pensare ai due patroni come a due soldati, prima dediti alla difesa dello Stato poi della fede: «Faustino e Giovitta prima che fossero ecclesiastici erano soldati di Cesare, adonque con giusta ragione vengono nell’archa ove riposano con l’insegne militari honorati. Quelle gloriose insegne militari con mutola favella fanno fede a christiani che quegli i quali erano già soldati del mondo hanno sparso il sangue e data alli marteri la vita combattendo per Christo [...]. Que’ stendardi sono infallibili testimoni delle grandezze de’ santi martiri, che per maggior confirmatione di questa verità come Faustino e Giovitta
137I SANTI ALL’ASSEDIO
Qualche anno più tardi gli farà eco, senza nulla aggiungere di nuovo, Bernardino Faino con la sua Vita delli santi fratelli martiri Faustino et Giovita:
Comparvero gloriosi il giorno di santa Lucia su le mura della città verso San Fiorano in faccia dell’inimico gli nostri santi protettori Faustino e Giovita in habito militare, come pure fu scritto e anco espresso in pittura, divinamente difendendo la loro patria con la total rovina di quell’essercito, che vedendo lampeggiare luce divina d’intorno a gli due potentissimi defensori, intendendo ch’ il Cielo guerreggiava per noi Bresciani, il giorno seguente dileguatosi via in altre parti quell’essercito, rimase da i santi medemi liberata la città. Del qual fatto miracoloso se ne vede alzato su le mura stesse un monimento eterno con l’iscrittioni.41 In questa contingenza pure, non penetrando ’l popolo che anco i santi del paradiso, di qualunque ordine e fino gli angeli stessi quando sono mandati da Dio alla nostra diffesa pigliano il sembiante e l’habito pro-portionato all’impresa ch’ hanno d’essercitare, si sparsero pareri diversi. Poiché chi diceva che non i santi fratelli dell’ordine sacro, venerati per nostri protettori in San Faustino Maggiore, fossero discesi alla protet-tione e liberatione della città, per essere d’habito e professione diversa, ma che fossero stati quelli della professione de’ cavaglieri, venerati in San Faustino ad sanguinem hora Sant’Afra. Altri con raggioni valevoli sostentavano il contrario.42
collocati in Sant’Afra sono i difensori della città, i suoi avvocati, li protettori, in habito pure di guerrieri vollero apparire contro l’essercito di Nicolò Picinino in tempo che la città teneva assediata» (pp. 46-47).
41. Si tratta della nota epigrafe marmorea spesso citata a sostegno della veridicità dell’ap-parizione. Il testo recita: «Hanc penes Roveroti stationem / martires Christi incliti Fau-stinus et / Jovita visi sunt ab hostibus / suis pro civibus suisque pro / moenibus decertare / omnes Brixiae tanti prodigii / publicaeque pietatis causa / fieri iussit / Hoc anno mCCC-Cxxxviii / mense decembris apparuit».
42. B. fAino, Vita delli santi fratelli martiri Faustino et Giovita primi sacrati a Dio. Quella delli secondi cavaglieri secolari. Inventioni e traslationi de i loro venerandi corpi. Dimo-strationi della loro vera esistenza et di essi quali sian i veri patroni e protettori della città di Brescia, i, Brescia, Giacomo Turlino, 1670, pp. 100-1. Il Faino, com’è noto, fu autore anche del Martyrologium Sanctae Brixianae ecclesiae pubblicato a Brescia dal Ricciardi nel 1665. In questo testo non solo sono menzionati i Faustino e Giovita secondi ricordati il 15 marzo, ma anche l’apparizione al Roverotto: «Idibus decembris. Brixiae, apparitio sanctorum martyrum Faustini et Jovitae contra aciem ducis Mediolani, urbem undique vallantem. Profusa namque omni humana ope, qua etiam vita civium contueretur ecce de-lapsi e coelo sancti isti super moenia pugnantes, splendoribus armisque supernis nitentes, perniciem et exitum hostibus minitantes, ni patriam suam incolumen relinquerent. Quo divino prodigio perterriti mox abierunt» (p. 159). Tali numerose ingenuità e soprattutto la
138 ALESSIA COTTI
Tra storia e letteratura
Non è difficile immaginare come gli episodi tragici e spettacolari della passione dei due martiri,43 così come i racconti di miracoli loro attribuiti, potessero incontrare facilmente il gusto di poeti e letterati, in modo particolare di quelli del XVII secolo, arrivando alla trasposizione della leggenda in versi.44 Troviamo un esempio in una canzone dell’accademico errante Antonio Festa, della qua-le a noi interessa in modo particolare una delle stanze finali dove è chiaro l’accenno all’apparizione:
Ma se ’n fin di là su Santi del Ciel beati, scendeste pur quaggiù a difenderci armati,
citazione dei martiri con l’attribuzione dei cognomi delle famiglie aristocratiche bresciane, suscitarono le attente critiche dei Bollandisti che dopo aver analizzato l’opera pubblicaro-no il De martyrologio brixiensi aucto ex catalogis ecclesiae Sanctae Afrae, in Acta Sanctorum, Aprilis, Tomus ii, Antverpiae, apud Michaelem Cnobarum, 1675, pp. xl-lvi. Alle critiche ribatté allora Onorio Stella con la Risposta alla censura de’ padri Godefrido Enschenio e Daniele Papebrocchio sopra il Martirologio bresciano, accresciuto con li nomi de santi martiri venerati nella chiesa di Sant’Afra di Brescia, Brescia, Giovanni Maria Rizzardi, 1687. Egli elaborò una spiegazione decisamente poco convincente, rispetto alle giustificate perples-sità dei Bollandisti, scrisse infatti a p. 115: «Qui non si tratta di riaccendere le fiaccole già estinte dell’antica questione tanto amplificata dalla Censura se li corpi de’ santi Faustino e Giovita siano entro l’arca magnifica della chiesa di San Faustino Maggiore overo riposino in quella di Sant’Afra, se quelli siano li primi e questi li secondi. Sono secreti del gabinetto celeste, sono imperscrutabili arcani di Dio, che permette il corpo d’uno stesso santo sia venerato veracemente in una città e pur veramente s’arritrova in un’altra» (p. 115). L’opu-scoletto dello Stella divenne a sua volta oggetto di critiche, si veda in proposito il già citato geroldi, Espositione del marmo di Vittore Mauro.
43. Per un riesame della passione dei due santi si veda f. sAvio, La légende des ss. Faustin et Jovite, Bruxelles 1896 e, più recentemente, tomeA, «Agni sicut nive candidi», pp. 17-48.
44. In realtà va precisato che già nella seconda metà del xvi secolo il miracolo aveva solleticato le corde dei letterati per i più svariati componimenti, come ben testimoniano le pagine del Podavini, che nel suo panegirico De nobiltate Brixiae (c. B5r) ricordava l’episo-dio in termini a dir poco epici: «Sed ecce subito de coelo - de coelo autem? - de moeniis ipsis effulsere serenissimi illi equites, huiusce civitatis cives et propugnatores acerrimi divi sanctissimi Faustinus et Jovita armis coelestibus induti et hostibus minitantes perniciem exitium, ni discedant civitatemque suam incolumem relinquant. Divino illo prodigio ter-riti hostes in fugam se se contulerunt»; e ancora si pensi ai versi di Bartolomeo Teani da Quinzano nel De clade ac depopulatione brixiana carmen pubblicato a Brescia da Ludo-vico Sabbio nel 1561: «Auxilio tandem supernum divisque paternis / solvuntur: quorum aspectu conterritus ipse / dux acies trepidas alio divertit ab urbe» (c. A4v).
139I SANTI ALL’ASSEDIO
conservate l’amore di questa patria al core. Sia vostro alto pensiero, che Brescia ami mai sempre, opri da vero.45
E sul finire del secolo tocca alla penna illustre di Bartolomeo Dotti:
Brescia difesa dai santi Faustino e Giovita suoi cittadiniapparsi visibilmente contro Niccolò Piccinino.
Brescia pendea tra combattuta e presa,che, de gli assalti e l’iterate scosse,scendean le mura ed ascendean le fossee ’l difensor morìa su la difesa. Quando, a finir la militar contesa,duo suoi guerrieri accelerar le mosse:nel percussor ritorser le percossee rilanciar ne l’offensor l’offesa.
45. A. festA, La canzone ostinata. Martirio e morte de’ santi Faustino e Giovita protettori di Brescia, Brescia, Antonio Rizzardi, 1650, p. 11. Per la figura e l’opera del Festa si veda Peroni, Biblioteca bresciana, ii, p. 58. Come abbiamo già sottolineato la vicenda terrena dei due martiri ben si sposava con il sentire tragico degli autori barocchi, lo dimostra la co-piosa fioritura di componimenti poetici e d’occasione. Si vedano ad esempio: N. Biffi, Le vive perle consacrate alla gloria dei santi Faustino e Giovita protettori dell’illustrissima città di Brescia. Oratione panegirica recitata nella chiesa insigne dei santi medemi il giorno dell’a-perition dell’arca 7 febraro 1668, Brescia, Giacomo Vignadotti, [1668], dove ovviamente non può mancare il racconto del miracolo: «Godi lieta mai sempre e non temere più oltre, con l’esperienza di tue fortune, di barbaro furore gl’assalti, poich’ a reprimerne l’inonda-tione dal fier Picinino, ad atterrirti sospinta, brillano le tue sacre Perle dalle mura su l’erto ed in sembiante guerriero sforzan l’assalitore ad abbandonare ben tosto la temeraria sua impresa»; oppure testi come La costanza coronata nelle persone de santi Faustino e Giovita li secondi e la crudeltà punita in quelle de loro persecutori, Brescia, Giacomo Turlini, 1673, rappresentata presso i Padri della Pace; e ancora A. mAnenti, L’impetrita perfidia dell’em-pio monarca Adriano sprezzata e vinta dall’invitta toleranza ne’ tanti tragici e prodigiosi trionfi de’ gloriosissimi campioni fratelli germani patroni di Brescia santi Faustino e Giovita, santi Calocero et Afra, Brescia, Giovanni Battista Gromi, 1673, 3 pagine non numerate nella lettera prefatoria; h.f. lAntAnA, Le colonne della chiesa bresciana overo oratione panegirica per l’apertura dell’arca dei santi martiri, cittadini e protettori di Brescia Faustino e Giovita dell’anno 1685, Brescia, Giacomo Turlini, 1685, pp. 20-21. L’elenco potrebbe continuare a lungo con l’aggiunta di testi singolari come il componimento Oculi mei erunt aperti (2 Paralip. 7) che si trova nel ms. D iv 6 ai ff. 111r-12r. Lo scritto, che presenta i caratteri di una dotta omelia e si trova all’interno di un codice miscellaneo con documenti datati tra la fine del xvii e l’inizio del xviii secolo, si direbbe un’originale trasposizione della passione dei due martiri alla luce del versetto biblico «Oculi quoque mei erunt aperti et aures meae erectae ad orationem eius qui in loco isto oraverit» (2Cr 7, 15).
140 ALESSIA COTTI
L’oste nemica al’or gridò: «Si cedapure a costor, che questi eroi sovrani,di predator che siam, ci faran preda. Gli sforzi del valor renderan vaniche invincibil son. Perché altri il credabasti dir che sono santi e son bresciani».46
Una leggenda che non finisce mai
Con la fine dell’età barocca, l’attenzione per il miracolo al Rove-rotto sembra ad un tratto venire meno. È la figura eminente del cardinal Querini a rinfocolare la questione, con la celebre pubbli-cazione delle due lettere scritte da Lodovico Foscarini al patriar-ca di Venezia Lorenzo Giustiniani nel 1452, nelle quali si narra di un tumulto cittadino dovuto al timore che si vogliano trafugare a Venezia delle reliquie custodite in San Pietro in Oliveto ed er-roneamente credute di Faustino e Giovita.47 Tutta la questione si snoda ancora una volta attorno al tema dell’apparizione, che il dotto vescovo bresciano sembra ritenere realmente accaduta, in virtù delle affermazioni del Foscarini:
Memores sunt, cum circumvallati, inclusi fame laborarent, ultima expe-rirentur pericula, visos ab hostibus tutores sanctissimos aureis armis Brixiam tueri, quo miraculo attonitus Nicolaus Picininus, dux fortissi-mus, potiundae urbis spem perdidit, supplicii petendi aurumque habendi aviditatem remisit. Quas ob res difficilius his corporibus carerent.48
Il Querini dà nuovo vigore all’accesa e forse mai realmente sopi-ta disputa storiografica, riaprendo un dibattito che coinvolgerà numerosi nomi eccellenti dell’ambiente culturale bresciano, pri-mo tra tutti quello di Baldassarre Zamboni, che nell’affrontare la
46. B. dotti, Rime, Venezia, [s.n.], 1689, p. 93. Sul Dotti si veda C. vovelle, Il fascino discreto della nobiltà: Bartolomeo Dotti tra esilio e compromesso (1674-1706), «Trimestre», 28 (1995), pp. 157-219.
47. Si veda in proposito ferrAglio, La città ed i patroni: Brescia ed un miracolo controverso, pp. 250-57.
48. A.M. Querini, Epistolae, collegit et digessit n. Coleti, Venezia, Sebastiano Coleti, 1756, pp. 42-43.
141I SANTI ALL’ASSEDIO
questione ci ha lasciato un’erudita relazione manoscritta intito-lata Delle lettere di Lodovico Foscarini in proposito della creduta supposta apparizione dei santi martiri Faustino e Giovita;49 in essa lo studioso affronta minuziosamente la questione della fondazio-ne di San Pietro in Oliveto, delle reliquie lì custodite, del culto ai due martiri patroni e arriva alla conclusione che il Querini ha er-roneamente interpretato le parole del pretore Foscarini e che non vi è nessun elemento per ritenere che si stia parlando dei patroni, ma piuttosto dei primi santi vescovi bresciani Paolo, Cipriano, Deusdedit e di sant’Evasio. Se dunque realmente apparvero dei santi, conclude l’erudito, dovette trattarsi di questi ultimi e non certo di Faustino e Giovita, le cui spoglie mortali erano notoria-mente custodite in San Faustino Maggiore.
Al nome dello Zamboni va accostato quello di Antonio Bro-gnoli50 che con la sua nota Appendice alle Memorie anedote spet-tanti all’assedio di Brescia determinerà un’ulteriore stagione di scritti dal forte sapore polemico.51 Anch’egli prendeva le mosse
49. Il testo si conserva manoscritto in due esemplari presso la Biblioteca Queriniana: il primo, autografo ma privo delle note, porta la segnatura F iv 9m2; il secondo, corredato da un minuzioso apparato esplicativo, è rintracciabile ai ff. 213r-252r del manoscritto H vii 13 e si presenta con il titolo: Esame delle due lettere di Lodovico Foscarini patrizio vene-ziano pubblicate dall’eminentissimo cardinale e vescovo di Brescia Angiolo Maria Quirini, nel quale si cerca se in esse lettere si parli dei santi martiri Faustino e Giovita e se possano es-sere addotte in prova della miracolosa apparizione di essi santi martiri nell’assedio di Brescia fatto nel 1438 da Niccolò Piccinino generale del duca di Milano, esteso da Eranio accademico agiato, in difesa dell’Appendice in cui si tratta della visibile apparizione dei santi Faustino e Giovita sopra le mura di Brescia, impressa a carta 191 e seguenti delle Memorie anedote spettanti all’assedio di Brescia dell’anno 1438 ed alle cose relative al medesimo raccolte da Antonio Brognoli patrizio bresciano e stampate in Brescia per Daniel Berlendis 1780 in 8° Cap. ii. Si tratta per la precisione della seconda parte di una dotta dissertazione nella quale lo Zamboni si interroga sulla natura delle fonti storiografiche e soprattutto di quale debba essere il loro uso. Il racconto del presunto miracolo al Roverotto possiamo dire che serva al dotto studioso come case study.
50. Brognoli, Memorie anedote spettanti all’assedio di Brescia, pp. 191-212.
51. La questione è quanto mai controversa, cercheremo di riassumerla nel modo più chia-ro possibile. Lo scetticismo del Brognoli incontra la critica di Giovanni Battista da Ponte detto il Grammatica che scrive gli Argomenti critici contro l’Appendice delle Memorie ane-dote dell’assedio di Brescia del nobil signor Antonio Brognoli, ove si agita la verità dell’ap-parizione dei santi martiri Faustino e Giovita sulle mura di Brescia l’anno dell’assedio 1438. (ms. H vii 13, ff. 18r-53v). Le deboli argomentazioni del Grammatica finiscono presto nel mirino sia dello stesso Brognoli, che gli ribatte con la Risposta di Antonio Brognoli ai Criti-ci argomenti del padre Giambattista da Ponte minore osservante detto il padre Grammatica, scritti contro la sua Appendice pubblicata nelle Memorie anedote intorno all’assedio di Bre-scia del 1438 (ms. H vii 13, ff. 95r-130r), sia di Giambattista Rodella, che contesta numero-
142 ALESSIA COTTI
dall’analisi delle fonti, mettendo in evidenza come il racconto non fosse rintracciabile in nessuno storico contemporaneo alla vicen-da, che ben poca fede si dovesse alla nota epigrafe al Roverotto, della cui arcaicità appariva non affatto convinto, che nulla porta-va a credere che il Foscarini stesse parlando dei patroni nelle due lettere a Lorenzo Giustiniani e che sì nelle provvisioni erano citati i patroni, accanto alla Vergine e ai vescovi, ma nessun accenno era riscontrabile circa una loro visibile apparizione sugli spalti del castello. Più convincente era l’idea che il Piccinino avesse abban-donato l’impresa a causa delle pessime condizioni in cui versava l’esercito, stremato dopo anni di inutile assedio, privo di riforni-menti e sotto la minaccia di un possibile intervento delle truppe del Gattamelata.
Si concludeva in questo modo, tra scetticismo e rigore sto-riografico, l’età delle leggende antiche ed epiche dei santi in armi splendenti. Ma si sarebbe aperto di lì a poco un periodo altrettan-to ben disposto ad accogliere i bellicosi numi tutelari bresciani.
Nel 1797 a Brescia, come in numerose città dell’Italia setten-trionale, viene proclamato un governo provvisorio in seguito alla fine della dominazione veneta. Sono quanto mai interessanti le serie di disposizioni emanate nell’aprile di quell’anno. Fra tutte spicca sicuramente questa, che ben testimonia l’esistenza di un culto civico profondamente radicato nei Bresciani, ben conosciu-to dai “nuovi” inquilini che avevano preso posto in Loggia:
Libertà Virtù Eguaglianza in nome del sovrAno PoPolo BresCiAno
il governo Provvisorio
se delle sue affermazioni con le Note alli critici argomenti del padre Giambattista da Ponte minore osservante detto il padre Grammatica contra l’Appendice pubblicata nelle Memorie anedote intorno all’assedio di Brescia del 1438 da Antonio Brognoli. Colle note perpetue di N.A.A. Cioè l’abate Giovanni Battista Rodella. Copiate dal manoscritto autografo esistente ora presso il signor Francesco Mazzuchelli acquistatore di tutta la paterna biblioteca; il titolo così prosegue: «Avvertasi che queste note furono scritte sopra il primo manoscritto del padre Grammatica intitolato Critici argomenti. Inteso poi dal detto padre che il Brognoli avea con altro manoscritto risposto, riformò il suo lavoro intitolandolo Dissertazione apo-logetica critica etc. come si può confrontare dall’annesse dissertazioni. Copiate da Paolo Brognoli li 24 novembre 1809» (ms. H vii 13, ff. 55r-94r). Come si evince dalla postilla al titolo, prima ancora di Rodella, era stato dunque lo stesso Brognoli a rispondere al Gram-matica che stese, a strenua difesa della veridicità dell’apparizione, un secondo testo cioè la Dissertazione apologetica critica (ms. h vii 13, ff. 132r-191r).
143I SANTI ALL’ASSEDIO
Mentre si riserva un luogo addattato per collocare la statua della Liber-tà, ordina che sopra la colonna in cui era posto il leone veneto vi siano collocate le due statue delli santi Faustino e Giovita. Con tale provvi-denza conosca il popolo quanto stia a cuore ai suoi rappresentanti il culto alli suoi protettori.
Brescia 2 aprile 1797Gaetano Palazzi vice presidenteMarc’ Antonio Fè del governo
Gio(vanni) Battista Bordogni del governoIppolito Bargnani segretario.52
Brescia poteva forse facilmente accettare di non essere più tra le potenti città di Terraferma, ma in un’epoca di profonde incertezze e di continui rivolgimenti politici e sociali, gli apparati di governo sapevano che la cittadinanza aveva bisogno di riconoscersi salda e unita; ed ecco allora rispolverare il culto agli antichi patroni, o meglio, a quei protettori che un tempo avevano respinto gli assalti nemici dal castello ed ora dall’alto di una colonna promettevano libertà ed uguaglianza per tutti.53
52. Raccolta dei Decreti del Governo Provvisorio Bresciano e di altre carte pubblicate a quell’epoca colle stampe, Brescia 1804, p. 109.
53. Ci piace chiudere questo breve contributo ricordando che ancor oggi il 15 febbraio di ogni anno si può vedere una folta processione costituita da semplici cittadini, autorità religiose, civili e militari salire sino al Roverotto e deporre una corona d’alloro. È questo il «Gesto semplice […] nel luogo in cui i santi difesero la città assediata», come recita un opuscolo che ogni anno viene stampato dalla Confraternita dei santi Faustino e Giovita in occasione delle celebrazioni faustiniane che si protraggono da gennaio ad aprile.