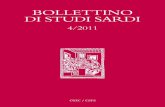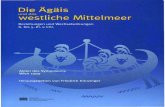F. FRASSON, Il guerriero ligure nei frammenti di Posidonio di Apamea, in F. GAZZANO-G. OTTONE-L....
Transcript of F. FRASSON, Il guerriero ligure nei frammenti di Posidonio di Apamea, in F. GAZZANO-G. OTTONE-L....
EX FRAGMENTIS
PER FRAGMENTA
HISTORIAM TRADERE
A T T I
DELLA SECONDA GIORNATA DI STUDIO
SULLA STORIOGRAFIA GRECA FRAMMENTARIA
Genova, 8 ottobre 2009
a cura di
FRANCESCA GAZZANO - GABRIELLA OTTONE - LUIGI SANTI AMANTINI
Edizioni TORED – 2011
Comitato scientifico:
LIA RAFFAELLA CRESCI, FRANCESCA GAZZANO, GABRIELLA OTTONE, ELEONORA SALOMONE, LUIGI SANTI AMANTINI (Università di Genova) EUGENIO LANZILLOTTA (Università di Roma Tor Vergata) ANTONIO LUIS CHÁVEZ REINO (Universidad de Sevilla) GUIDO SCHEPENS, STEFAN SCHORN (Katholieke Universiteit – Leuven) Responsabile editoriale:
EUGENIO LANZILLOTTA Responsabile grafica e stampa:
AMERICO PASCUCCI Comitato di redazione:
FRANCESCA GAZZANO, GABRIELLA OTTONE, LUIGI SANTI AMANTINI Il volume è stato pubblicato con fondi del MIUR (PRIN 2008) e dell’Università degli Studi di Genova
ISBN 978-88-88617-51-0
© Copyright 2011 Edizioni TORED s.r.l. Vicolo Prassede, 29 00019 Tivoli (Roma) www.edizionitored.com e-mail: [email protected] – [email protected]
FEDERICO FRASSON
IL GUERRIERO LIGURE
NEI FRAMMENTI DI POSIDONIO DI APAMEA
Per quanto siano numerose le testimonianze relative al valore
dei Liguri in battaglia1, le fonti antiche sono piuttosto avare di parti-
colari sulle loro consuetudini belliche e sul loro armamento, se si ec-
cettua un passo di Diodoro Siculo (V 39), dove è contenuto un bre-
ve excursus etnografico sui Liguri. Anche se Posidonio non è citato
espressamente, in genere gli studiosi sono propensi a ritenere che
Diodoro, per la stesura di questo brano, abbia fatto ampio uso
dell’opera dello scrittore di Apamea2, come è suggerito, del resto, an-
1 Cfr. p. es. STRAB. IV 1, 7 (= AESCH., F 326a Mette); POLYB. XXXIII 10, 5-6;
10, 9; DIOD. SIC. IV 20, 1; VERG., Aen. X 185; DION. HAL. I 41, 3; STRAB. IV 6, 2-
3; V 2, 5; LIV. XXVII 48, 10; XXXIX 1, 2; 1, 5-6; PLUT., Aem. 6, 1; FLOR. I 19, 3-4;
DONAT., int. Verg. X 185; JORD., Rom. 177. 2 Già Jan Bake (Posidonii Rhodii reliquiae doctrinae, Lugduni-Batavorum
1810, pp. 134-135) aveva individuato echi posidoniani in due parti del passo, poi
pubblicato per intero dallo Jacoby (FGrHist 87 F 118; cfr. FGrHist, II C, 87, pp.
157, 219, ad F 118) come frammento di Posidonio, sia pure in appendice. Il brano
diodoreo non figura, invece, nell’edizione di Posidonio preparata dall’Edelstein e
portata a compimento dal Kidd (L. EDELSTEIN - I.G. KIDD, Posidonius, I. The frag-ments, Cambridge 1972, di cui in seguito si cita la seconda edizione, pubblicata nel
1989), poiché si scelse di includere in essa solo i frammenti, in cui compariva e-
FEDERICO FRASSON 148
che dall’impiego del verbo latomei'n, adoperato all’inizio del capitolo
per mettere in rilievo la difficoltà di lavorare la terra in Liguria e già
usato a tale proposito da Posidonio, secondo l’esplicita attestazione
di Strabone3.
In Diodoro i Liguri sono presentati, dal punto di vista fisico, se-
condo uno stereotipo ben noto, come individui forti e vigorosi,
temprati dalle fatiche tipiche della loro misera esistenza di montana-
ri4; anche le donne liguri, che sono abituate a lavorare ejp≠ i[sh~ toi'~ ajndravsin, hanno la forza e la tenacia proprie degli uomini, mentre
questi ultimi quelle degli animali selvaggi5. Notizie simili sulla tem-
pra di uomini e donne liguri sono contenute in un altro passo dio-
doreo, ritenuto anch’esso di derivazione posidoniana6, dove si dice,
splicitamente il nome dello scrittore; il Kidd, tuttavia, in POSIDONIUS, II. The commentary: (ii) Fragments 150-293, Cambridge 1988, p. 917, ad F 268, ammise
l’esistenza di elementi posidoniani in DIOD. SIC. V 39. Inoltre, il passo di Diodoro
fu edito come frammento di Posidonio dal Theiler (F 163b; cfr. W. THEILER in
POSEIDONIOS, Die Fragmente, II. Erläuterungen, Berlin-New York 1982, pp. 104-
105) e dal Vimercati (F B19; cfr. E. VIMERCATI in POSIDONIO, Testimonianze e frammenti, Milano 2004, p. 710, ad F B19), e fu considerato tale dal Malitz (Die Historien des Poseidonios, München 1983, pp. 174-175) e da diversi autori che lo
hanno utilizzato nella loro opera, come p. es. F. BORCA, I Liguri nell’etnografia anti-ca, in «Intemelion. Cultura e territorio», V (1999), pp. 11-14, 18. Cfr. anche, in
generale, G. CORDIANO in DIODORO SICULO, Biblioteca storica. Libri I-VIII. Mitolo-gia e protostoria dei popoli orientali, dei Greci e dei Romani, Milano 1998, p. 69; K.
MEISTER, La storiografia greca. Dalle origini alla fine dell’Ellenismo, trad. it., Roma-Bari
20004, p. 214. 3 STRAB. V 2, 1 (= POSIDON., FGrHist 87 F 57a = F 268 Edelstein - Kidd2 = F
36 Theiler = F A299 Vimercati). 4 DIOD. SIC. V 39, 2-3. 5 Cfr. DIOD. SIC. V 39, 2 (per le parole citate); 39, 6. 6 DIOD. SIC. IV 20, 2-3 (= POSIDON., FGrHist 87 F 58b = F 163a Theiler = F
B16a Vimercati); in particolare, per l’episodio della donna ligure, che tornò al
lavoro subito dopo il parto, raccontato in DIOD. SIC. IV 20, 3, la fonte sarebbe
sicuramente Posidonio, che avrebbe appreso la notizia da un suo ospite massa-
liota, testimone oculare del fatto: STRAB. III 4, 17 (= POSIDON., FGrHist 87 F
58a = F 269 Edelstein - Kidd2 = F 25 Theiler = F A300 Vimercati). Vd. anche
IL GUERRIERO LIGURE NEI FRAMMENTI DI POSIDONIO DI APAMEA 149
tra l’altro, che i Liguri th'~ ga;r kata; th;n trufh;n rJaóstwvnh~ polu; ke-cwrismevnoi ejlafroi; me;n tai'~ eujkinhsivai~ eijsivn, ejn de; toi'~ polemi-koi'~ ajgw'si tai'~ ajlkai'~ diavforoi7. La forza fisica, dunque, unita
all’agilità, rende i Liguri formidabili guerrieri, come è messo in evi-
denza dalle molteplici fonti, che ne sottolineano il valore, la bellico-
sità e l’ardimento8: valgano per tutte le parole di Livio, da cui furono
definiti durum in armis genus e hostis levis et velox et repentinus9, termini
ripresi da Floro, il quale coniò la calzante espressione durum atque
velox genus10. I Liguri, comunque, qrasei'~ d≠ eijsi; kai; gennai'oi ouj movnon eij~ povlemon, ajlla; kai; pro;~ ta;~ ejn tw'ó bivwó peristavsei~ ta;~ ejcouvsa~ deinovthta~, come scrive Diodoro (V 39, 8), riferendosi pe-
rò, in quest’ultimo caso, soprattutto all’audacia con cui solcano i
mari, su imbarcazioni semplici e senza l’equipaggiamento adeguato.
Spunti interessanti si possono ricavare anche da DIOD. SIC. V
39, 6, dove si legge:
pollavki~ gou'n fasin ejn tai'~ strateivai~ to;n mevgiston tw'n Galatw'n uJpo; Livguo~ ijscnou' pantelw'~ ejk pro-klhvsew~ monomachvsanta ajnhórh'sqai.
La pratica del duello, comune in varie forme presso i popoli an-
tichi, non è altrimenti attestata per i Liguri, mentre è diffusa nel
mondo celtico11, dove il credo nell’immortalità dell’anima e nella
[ARIST.], Mir. ausc. 91 (837b); AEL., NA VII 12; un episodio analogo è ambienta-
to in Illiria da VARRO, Rust. II 10, 9 e vicino all’Iberia da CLEM. AL., Strom. IV 8,
62, 2 (= POSIDON., F B16b Vimercati). Sulla resistenza alla fatica, la tenacia e il
vigore dei Liguri, vd. anche CIC., Leg. agr. II 35, 95; VERG., G. II 168; SIL., Pun.
VIII 605. 7 DIOD. SIC. IV 20, 1. 8 Cfr. supra, nt. 1. 9 Cfr. rispettivamente LIV. XXVII 48, 10 e XXXIX 1, 6. 10 FLOR. I 19, 4 (cfr. JORD., Rom. 177); sull’agilità dei Liguri, vd. anche SALL.,
Iug. 93, 2-94, 3; FRONTIN., Str. III 9, 3; FLOR. I 36, 14. 11 Per i duelli presso i Celti, vd. già H. D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, Cours de lit-
térature celtique, VI, Paris 1899, pp. 1-34; A. BAYET, La morale des Gaulois, Paris
FEDERICO FRASSON 150
metempsicosi, al quale accennano le fonti, avrebbe portato a un cer-
to disprezzo per la morte12, e, forse, a considerare un grande onore il
cadere combattendo13. Lo stesso Annibale, come attesta Polibio, segui-
to da Livio14, dimostrò di conoscere a fondo tale mentalità quando,
prima della battaglia del Ticino, per distrarre i suoi soldati e incitarli a
non arrendersi, organizzò duelli all’ultimo sangue tra i prigionieri
1930, pp. 85-87; J.J. TIERNEY, The Celtic ethnography of Posidonius, in «Proceedings
of the Royal Irish Academy», Section C, LX, 5 (1960), LX, C, 5, Dublin 1960, p.
202; cfr. più recentemente J.N.G. RITCHIE - W.F. RITCHIE, The army, weapons and fighting, in M.J. GREEN (ed.), The Celtic world, London-New York 1995, pp. 54-55; L. RAWLINGS, Celts, Spaniards, and Samnites: warriors in a soldiers’ war, in T. COR-
NELL - B. RANKOV - PH. SABIN (eds.), The Second Punic War. A reappraisal, London
1996, pp. 86-88; P. CONNOLLY, Greece and Rome at war, London 19982, p. 114;
M. MARTIN, Omero come archetipo culturale nell’etnografia celtica di Posidonio d’Apamea (con un confronto con l’etnografia britannica di Timeo di Tauromenio), in F.
MONTANARI (a cura di), Omero tremila anni dopo. Atti del Congresso di Genova, 6-8 luglio 2000, Roma 2002, pp. 585-588; per il mondo celtiberico, cfr. G. SOPEÑA
GENZOR, El mundo funerario celtibérico como expresión de un ethos agonístico, in «Hi-
storiae», I (2004), pp. 61-62; ID., Celtiberian Ideologies and Religion, in M. ALBER-
RO - B. ARNOLD (eds.), The Celts in the Iberian peninsula (e-Keltoi, 6), 2005, pp.
374-375 (online). 12 DIOD. SIC. V 28, 6; 29, 2 (= POSIDON., FGrHist 87 F 116 = F 169 Theiler =
F B17 Vimercati); cfr. CAES., B Gall. VI 14, 5; STRAB. IV 4, 4; MELA III 2, 19;
VAL. MAX. II 6, 10; vd. p. es. MALITZ, Die Historien, cit., pp. 190-192; G. ZECCHINI,
I druidi e l’opposizione dei Celti a Roma, Milano 1984, pp. 12-15, 28; ST. PIGGOTT,
The Druids, London 19852, pp. 113-115; A. DEMANDT, Die Kelten, München 1998,
pp. 38-39; ID., I Celti, trad. it., Bologna 2003, pp. 40-41; contra TIERNEY, The Celtic ethnography, cit., p. 223.
13 Sull’importanza della morte in battaglia presso i Celti, vd. p. es. J.-L. BRU-
NAUX - B. LAMBOT, Guerre et armement chez les Gaulois. 450-52 av. J.-C., Paris 1987,
pp. 45-46, 48; J.-L. BRUNAUX, La mort du guerrier celte. Essai d’histoire des mentalités, in S. VERGER (éd.), Rites et espaces en pays celte et méditerranéen. Étude comparée à par-tir du sanctuaire d’Acy-Romance (Ardennes, France). Actes de la table ronde, Rome, 18-19 avril 1997, Rome 2000, pp. 241-242, 245-246; SOPEÑA GENZOR, El mundo funera-rio, cit., pp. 56-57, 88; ID., Celtiberian Ideologies, cit., p. 365.
14 POLYB. III 62, 1-63, 4; LIV. XXI 42, 1-4.
IL GUERRIERO LIGURE NEI FRAMMENTI DI POSIDONIO DI APAMEA 151
montani, mettendo in palio cavalli, preziosi saghi e panoplie comple-
te, come quelle indossate dai re dei Galli nelle monomachie15.
Un’armatura nobiliare è in qualche modo protagonista di un ce-
leberrimo duello, cioè quello tra il capo celta Virdomaro e il console
romano Marco Claudio Marcello, che, nel 222 a.C., a Clastidium ot-
tenne le spoglie opime uccidendo l’avversario16, come, per esempio,
racconta Plutarco nella Vita di Marcello (7, 1-2):
«nel frattempo il re dei Galli, scrutandolo [scil. Marcello] e
giudicando dalle sue insegne che si trattava del comandante,
cavalcò molto davanti a tutti gli altri e gli andò incontro, con
grida di sfida e agitando la lancia. Egli superava in statura tut-
ti gli altri Galli e si distingueva per la panoplia, decorata con
argento e oro e colori brillanti e ogni sorta di ornamento, e
splendente come un lampo. Pertanto, non appena Marcello
osservò i ranghi del nemico, questa gli sembrò l’armatura più
bella e concluse che era quella che aveva promesso in voto alla
divinità. Si scagliò contro l’avversario e, perforando con la
lancia il pettorale del nemico e avventandosi su di lui con lo
slancio del suo cavallo, lo gettò, ancora in vita, a terra e, af-
fondando un secondo e un terzo colpo, subito lo uccise».
Del resto, nel mondo celtico e celtiberico la pratica del duello
era radicata a livello sociale, essendo seguita non solo in guerra17, ma
15 RAWLINGS, Celts, cit., p. 89; ID., Hannibal the cannibal? Polybius on Barcid
atrocities, in «Cardiff Historical Papers», (2007), p. 23, nt. 58 (online). 16 Per tale episodio, di cui Polibio non fa menzione, pur raccontando la cam-
pagna del 222 a.C. (POLYB. II 34, 1-15), cfr. soprattutto LIV., Per. XX; PLUT., Rom.
16, 7; Marc. 7, 1-4; 8, 1-6; 31, 4; Inscr. It. XIII 1, pp. 78-79, 550; cfr. anche CIC.,
Tusc. IV 22, 49; VERG., Aen. VI 855-859; PROP. IV 10, 39-44; MANIL., Astr. I 787-
788; VAL. MAX. III 2, 5; SIL., Pun. I 131-133; III 587; XII 278-280; FRONTIN., Str. IV 5, 4; FLOR. I 20, 5; FESTUS, Gloss. Lat., s.v. Opima spolia, p. 204 Lindsay; AMP.
21; [AUR. VICT.], De vir. ill. 45, 1-2; EUTR. III 6, 1-2; SERV., ad Aen. VI 855-859;
OROS. IV 13, 15. 17 Gli antichi ricordano alcune sfide lanciate da guerrieri galli e accettate e
vinte dai Romani, come i duelli di T. Manlio Torquato (367 o 361 a.C.) e M. Va-
FEDERICO FRASSON 152
anche nella vita quotidiana, come è dimostrato da un frammento del
XXIII libro delle Storie di Posidonio, tramandato da Ateneo e ripreso
da Eustazio18, dove si parla dei duelli – anche all’ultimo sangue –
che, presso i Galli, avevano luogo durante i pasti19.
Dopo questa breve digressione, non stupisce la notizia sui duelli
tra Galli e Liguri in DIOD. SIC. V 39, 6; da espressioni del testo greco
quali pollavki~, ejn tai'~ strateivai~ e ejk proklhvsew~ monomachvsan-ta, si comprende inoltre come le citate tenzoni non fossero affatto
risse occasionali, ma duelli singolari veri e propri e in qualche misu-
ra ricorrenti, il cui teatro erano i campi di battaglia. A questo propo-
sito un confronto molto significativo si trova all’interno di un lungo
brano etnografico sui Celti, considerato generalmente di derivazione
posidoniana e scritto da Diodoro pochi capitoli prima:
«quando sono schierati in ordine di battaglia, sono soliti a-
vanzare rispetto alla linea e sfidare a duello singolare i più va-
lorosi tra i nemici schierati di fronte, scuotendo davanti a loro
le armi e intimorendo gli avversari. Quando qualcuno accetta
il combattimento, inneggiano alle valorose gesta degli antena-
ti e proclamano le proprie imprese gloriose, e scherniscono e
lerio Corvo (349 a.C.); cfr. anche i duelli di P. Cornelio Scipione Emiliano e di
Occio, legatus di Metello, i quali sconfissero rispettivamente un guerriero dei Vac-caei (151 a.C.) e due guerrieri celtiberici (143 a.C.). Per le fonti relative a tali epi-
sodi, cfr. T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, I, New York
1951, pp. 119-120, 129, 455-456, 473, 476. 18 ATH. IV 154a-c (= POSIDON., FGrHist 87 F 16 = F 68 Edelstein-Kidd2 = F
171a Theiler = F A296 Vimercati); EUST., Od. VIII 475 (= POSIDON., F 275 Edel-
stein-Kidd2 = F 171b Theiler = F A297 Vimercati); sul frammento, cfr. già BAKE,
Posidonii, cit., pp. 138-139; vd. TIERNEY, The Celtic ethnography, cit., p. 202;
MALITZ, Die Historien, cit., p. 190; KIDD in POSIDONIUS, II. The commentary, cit.,
pp. 315-316, ad F 68; M. RUGGERI, Posidonio e i Celti, Firenze 2000, p. 76; MARTIN,
Omero, cit., pp. 585-586. 19 Cfr. anche DIOD. SIC. V 28, 5, dove, però, i combattimenti sembrano risse
più che duelli; per sanguinose zuffe durante i pasti presso i Germani, cfr. TAC.,
Germ. 22, 1.
IL GUERRIERO LIGURE NEI FRAMMENTI DI POSIDONIO DI APAMEA 153
umiliano il nemico, e insomma cercano prima della lotta, con
le loro parole, di togliergli il coraggio»20.
I Galli, che escono dallo schieramento per sfidare i migliori tra i
nemici ed inveiscono contro quelli, sono evidentemente i più corag-
giosi e forti del loro esercito; si tratta, quindi, di un duello tra cam-
pioni21: un campione, per quanto sui generis, può essere considerato
Virdomaro che cavalca oltre le linee per sfidare Marcello e che fisi-
camente è il più imponente dei suoi22, proprio come oJ mevgisto~ tw'n Galatw'n, che, secondo Diodoro, sovente cade sotto i colpi di un Li-
gure, al confronto gracile.
Non si può escludere, a questo punto, che i duelli tra Galli e Li-
guri seguissero la prassi descritta nell’excursus sui Celti; in tal caso,
per i due popoli si potrebbe postulare, sul campo di battaglia,
l’esistenza di un’usanza condivisa, indizio, forse, di un progressivo
assorbimento da parte dei popoli liguri di consuetudini guerresche
proprie del mondo celtico.
Se si considera attendibile la notizia diodorea, introdotta da un
generico fasivn, termine che potrebbe alludere a una sua origine ora-
le, viene naturale chiedersi quali siano state le guerre in cui poterono
avere luogo questi combattimenti singolari; purtroppo non si può
giungere ad alcuna risposta sicura, dal momento che gli antichi tac-
20 DIOD. SIC. V 29, 2-3. Per l’excursus nel suo complesso, cfr. DIOD. SIC. V 25,
1-32, 7 (= POSIDON., FGrHist 87 F 116 = F 169 Theiler = F B17 Vimercati); vd.
anche FGrHist, II C, 87, pp. 212-219, ad F 116; MALITZ, Die Historien, cit., pp. 180-
198; THEILER in POSEIDONIOS, Die fragmente, II, cit., pp. 107-108, ad F 169; RUG-
GERI, Posidonio, cit., pp. 81-85; VIMERCATI in POSIDONIO, Testimonianze e frammen-ti, cit., pp. 706-709, ad F B17.
21 Cfr. CONNOLLY, Greece and Rome, cit., p. 114. 22 Per la monomachia di Virdomaro, definito vastus dux anche da PROP. IV
10, 40, cfr. supra, nt. 16. Il guerriero gallo dal fisico imponente, che avanza uscen-
do dalle sue schiere e sfida il migliore dei nemici, schernendolo prima del duello,
trova confronto nell’episodio di T. Manlio Torquato, e, parzialmente, in quelli di
M. Valerio Corvo e di Scipione Emiliano (cfr. supra, nt. 17).
FEDERICO FRASSON 154
ciono quasi completamente su eventuali e, a dire il vero, probabili
episodi bellici che abbiano visto contrapposti Liguri e Galli23.
In DIOD. SIC. V 39 non mancano neppure le notizie relative
all’armamento, su cui alcune informazioni si ricavano anche dai re-
perti archeologici24; secondo il passo di Diodoro, che tradisce la cu-
riosità per le armi dei vari popoli nutrita da Posidonio, autore anche
di un trattato di tattica militare25, oJplismo;n d≠ e[cousin oiJ Livgue~ ejlafrovteron tw'n JRwmaivwn thó' kataskeuh'ó26. Da quest’ultima affer-
mazione si potrebbe dedurre una scarsa diffusione delle armature
presso tale popolazione27, cosa non strana se si pensa che anche pres-
23 Per l’assenza di testimonianze relative a conflitti tra Liguri e Galli nel nord
Italia, cfr. già A. BERTHELOT, Les Ligures, in «RA», 6e ser., II, juillet-octobre (1933),
p. 89. Le fonti attestano uno stato di guerra tra Taurini ed Insubri, nel 218 a.C.
(POLYB. III 60, 8; LIV. XXI 39, 1), però gli antichi non sono concordi sull’etnia dei
primi (Liguri per STRAB. IV 6, 6; PLIN., HN III 17, 123; Semigalli per LIV. XXI 38,
5 = COEL. ANTIP., F 14* Peter2; cfr. APP., Hann. 5, 16, in cui la loro città, Taura-siva, è chiamata povli~ Keltikhv); come indizio di guerre tra Liguri e Galli sembra
poco significativo il cenno di AVIEN., ora mar. 129-145. 24 Cfr. p. es. A. FROVA, Una tomba gallo-ligure nel territorio della Spezia, «RStud
Lig», XXXIV, 1-3 (1968), pp. 293-300; A. DURANTE, Corredi tombali con elementi tipo La Tène dal sepolcreto di Ameglia, in D. VITALI (a cura di), Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione. Atti del Colloquio Internazio-nale, Bologna, 12-14 aprile 1985, Bologna 1987, pp. 415, 418-423, 425-434; E. PA-
RIBENI, Il corredo, in E. PARIBENI (a cura di), Guerrieri dell’età del Ferro in Lunigiana,
La Spezia 2001, pp. 43-49; R.C. DE MARINIS - G. SPADEA (a cura di), I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e Mediterraneo, Genova 2004, pp. 278-281, 338-341,
364, 366-367, 376-379, 381, 384-385, 389, 399, 402-404, 408, 411, 413, 415-421,
423, 426-429; P. MELLI, Genova preromana. Una città portuale del Mediterraneo tra il VII e il III secolo a.C., Genova 2007, pp. 65-66.
25 Cfr. ARR., Tact., I, 1-2 (= POSIDON., F 81 Edelstein - Kidd2 = F 468b Thei-
ler = F A330b Vimercati); AEL., Tact., I 2 (= POSIDON., F 80 Edelstein - Kidd2 = F
468a Theiler = F A330a Vimercati); cfr. MALITZ, Die Historien, cit., pp. 10, 31; VI-
MERCATI in POSIDONIO, Testimonianze e frammenti, cit., pp. 697-698, ad F A330a-b. 26 DIOD. SIC. V 39, 7. 27 Cfr. F. FRASSON, Durum in armis genus: i Liguri nell’esercito punico, in M.
MILANESE - P. RUGGERI - C. VISMARA (a cura di), L’Africa Romana. I luoghi e le forme
IL GUERRIERO LIGURE NEI FRAMMENTI DI POSIDONIO DI APAMEA 155
so i Galli sembra che solo gli aristocratici potessero permettersi di
indossare le cotte di maglia28.
Come protezione, è attribuito ai Liguri solo un paramhvkh~ qu-reo;~ eij~ to;n Galatiko;n rJuqmo;n dedhmiourghmevno~29, cioè uno scudo
oblungo fabbricato alla maniera dei Galli; la parola qureov~, infatti,
indica generalmente uno scudo allungato, più esteso in altezza che in
larghezza (lett. “a forma di porta”)30, caratteristica qui ribadita e sot-
tolineata anche dall’aggettivo paramhvkh~, che appare quasi pleona-
stico31. La forma dello scudo ligure è confermata anche da un passo
di Polibio (XXIX 14, 4) relativo alla guerra contro Perseo di Mace-
donia, ripreso da Livio (XLIV 35, 19), dove tale arma di difesa è
chiamata Ligustiko;~ qureov~ in greco e scutum Ligusticum in latino, e
da un passo di Giulio Ossequente (27), in cui si ricorda che nel 134
a.C. uno scutum Ligusticum, custodito a Roma nel tempio di Giuno-
ne Regina, fu colpito da un fulmine32.
dei mestieri e della produzione nelle province africane. Atti del XVIII convegno di studio, Olbia, 11-14 dicembre 2008, I, Roma 2010, p. 250, nt. 32.
28 Cfr. T. WISE, Armies of the Carthaginian Wars. 265-146 BC, Oxford 1982,
p. 16; G. BRIZZI, Annibale. Strategia e immagine, Spoleto 1984, sez. ill., n. 16; BRU-
NAUX - LAMBOT, Guerre et armement, cit., p. 107; CONNOLLY, Greece and Rome, cit.,
pp. 123-125; G. DALY, La battaglia di Canne, trad. it., Gorizia 2008, p. 163. 29 DIOD. SIC. V 39, 7. 30 Cfr. M. ALBERT, s.v. clipeus ou clipeum, in CH. DAREMBERG - EDM. SAGLIO,
Dictionnaire des antiquités Grecques et Romaines d’après les textes et les monuments, I, 2,
Paris 1887, pp. 1254-1256; H. FRISK, s.v. quvra, in Griechisches etymologisches Wörter-buch, I, Heidelberg 1960, p. 695; H.G. LIDDELL - R. SCOTT - H. STUART JONES, s.v. qureov~, in A Greek-English Lexicon, Oxford 19409, p. 811; E. POLITO, Fulgentibus
armis. Introduzione allo studio dei fregi d’armi antichi, Roma 1998, pp. 41-44, tipo B. 31 Nelle fonti greche sono generalmente chiamati qureoi v, tra gli altri, gli scudi
dei Galli (cfr. p. es. POLYB. II 30, 3; 30, 8; DIOD. SIC. V 30, 2) e quelli dei legiona-
ri Romani (vd. p. es. POLYB. XVIII 18, 4; 30, 7). 32 Il termine scutum è il corrispettivo latino del greco qureov~: vd. nt. 30; cfr.
anche CH.T. LEWIS - CH. SHORT, s.v. scutum, in A Latin dictionary, Oxford 1879, p.
1651; H.O. FIEBIGER, s.v. scutum, in RE, II A/1 (1921), coll. 914-915; G.A. MAN-
SUELLI, s.v. scudo, in Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale, VII, Roma 1966,
pp. 142-143. All’impiego di scudi rotondi sembra alludere, invece, l’isolata testi-
FEDERICO FRASSON 156
Secondo Diodoro i guerrieri liguri indossavano una tunica stret-
ta da una cintura e si coprivano con pelli di bestie selvatiche; come
arma da offesa avevano uno xivfo~ suvmmetron, cioè una spada di
media lunghezza. Sebbene il significato vero e proprio di xivfo~ sia
quello di «Schlachtschwert mit gerader zweischneidiger Klinge»33, in
questo caso il termine potrebbe essere usato anche nell’accezione ge-
nerale di “spada”; pertanto è forse un po’ forzato, per quanto sugge-
stivo, trovare riscontri a questo cenno della fonte letteraria, come ta-
lora è stato fatto34, in esemplari di spade lateniane risalenti al III se-
colo a.C. e rinvenute in contesto ligure. Proprio facendo leva sulla
presenza di armi celtiche nei corredi funerari delle necropoli liguri
del III secolo a.C., alcuni, per tale epoca, hanno parlato anche di
una «koiné nel contesto della tradizione guerriera celto-ligure»35, nella
quale ben si inserirebbero le osservazioni fatte in precedenza sulla
pratica del duello, così come l’utilizzo di scudi di tipo gallico, attesta-
to dalle parole di Diodoro.
Gli elementi di affinità tra Liguri e Galli possono trovare, co-
munque, giustificazione nel lungo tempo passato a stretto contatto,
in cui i primi avrebbero potuto subire una certa influenza da parte
dei secondi; non è forse un caso il fatto che Strabone (II 5, 28) abbia
scritto che Liguri e Galli sono di diversa etnia, ma vivono in modo
pressoché uguale.
Nel passo diodoreo vi è anche un accenno al processo di tra-
sformazione dell’armamento avvenuto per influsso romano, dato che
alcuni Liguri avrebbero imitato i loro nuovi dominatori36; non è im-
probabile che tale cambiamento sia avvenuto come conseguenza del
monianza di Strabone (IV 6, 2), che definisce i Liguri, non si sa con quanta preci-
sione, calkavspida~. 33 H. FRISK, s.v. xivfo~, in Griechisches, cit., II, Heidelberg 1970, p. 336; cfr. già
E. BEURLIER, s.v. gladius, in DAREMBERG - SAGLIO, Dictionnaire, cit., II, 2, Paris
1896, p. 1600; vd. anche G.A. MANSUELLI, s.v. spada, in Enciclopedia, cit., p. 423. 34 DE MARINIS - SPADEA, I Liguri, cit., p. 385, nt. 35. 35 A.C. FARISELLI, I mercenari di Cartagine, La Spezia 2002, p. 267. 36 DIOD. SIC. V 39, 7.
IL GUERRIERO LIGURE NEI FRAMMENTI DI POSIDONIO DI APAMEA 157
servizio negli eserciti romani nel corso del II secolo a.C., quando la
presenza di ausiliari liguri è attestata, oltre che nella citata campagna
contro Perseo, anche nella guerra giugurtina e nella battaglia di A-
quae Sextiae37.
Infine, è opportuno sottolineare che non si può dire se il profilo
del guerriero ligure, quale emerge dalle parole di Diodoro, sia valido
per tutte le tribù, dal momento che queste, vivendo in territori distan-
ti fra loro e morfologicamente eterogenei, potevano avere abitudini
differenti, così come l’immagine del Ligure costretto a fatiche disu-
mane per coltivare un terreno ingrato e per spostarsi attraverso luoghi
aspri e montagne innevate può adattarsi alle genti appenniniche e al-
pine, ma meno bene alle popolazioni, che vivevano in alcune aree co-
stiere o nella Pianura Padana. Ugualmente difficile è stabilire
l’orizzonte cronologico al quale riferire le notizie riportate, che sem-
brano fornire un ritratto dei Liguri abbastanza arcaico e, eccezion fatta
forse per quelle tribù che abitavano nei luoghi più isolati, piuttosto
anacronistico, se rapportato alla situazione di fine II-inizio I secolo
a.C., conosciuta direttamente da Posidonio, in occasione del suo viag-
gio in Occidente38; ciononostante le informazioni tramandate sono
preziose, perché uniche nel panorama delle fonti letterarie e attribui-
bili a un autore con una certa competenza in materia militare.
37 Sull’argomento, cfr. F. FRASSON, Addita auxilia, Ligurum duo milia... Gli
ausiliari liguri negli eserciti romani del II secolo a.C., in «Atti e memorie della Società
Savonese di Storia Patria», n.s. XLVII (2011), pp. 5-26; ID., Numidi in Liguria, Liguri in Numidia. A proposito di alcuni episodi bellici del II secolo a.C., in L’Africa Romana. Trasformazione dei paesaggi del potere nell’Africa settentrionale fino alla fine del mondo antico. Atti del XIX convegno di studio, Sassari-Alghero, 16-19 dicembre 2010, cds.
38 Su tale viaggio, cfr. p. es. MALITZ, Die Historien, cit., pp. 12-15; MEISTER, La storiografia greca, cit., p. 199; RUGGERI, Posidonio, cit., pp. 21-22, 95; VIMERCATI in
POSIDONIO, Testimonianze e frammenti, cit., pp. 3, 9. Posidonio fu certamente a
Marsiglia: cfr. D. NASH, Reconstructing Poseidonios’ Celtic Ethnography: some Conside-rations, in «Britannia», VII (1976), p. 119; MALITZ, Die Historien, cit., pp. 13, 170;
vd. anche supra, nt. 6.