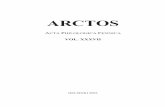El comerç d'art japonès a Barcelona, 1887-1915 (Locus Amoenus, 10, 2009-2010, pp. 259-277)
277 - CIL VI, 8, I: INSCRIPTIONES SACRAE FRAGMENTA (I),
Transcript of 277 - CIL VI, 8, I: INSCRIPTIONES SACRAE FRAGMENTA (I),
I. – I frammenti sono fonte di gioia e tormento (più di tormento, in realtà, chedi gioia) per ogni redattore di Corpora. Sperimentò questa verità anche Luigi Mo-retti che, nel redigere le sue mirabili Inscriptiones Graecae Urbis Romae, si trovò a do-ver trattare molte decine di frammenti, e la sto sperimentando io, nel preparare unnuovo supplemento alle sacrae di CIL VI. Le gioie si provano quando, partendo daframmenti disperati, si riesce a restituire iscrizioni sicure, o probabili, o almenoplausibili; i tormenti quando, nonostante ogni sforzo, si rimane in grave incertezzasulla restituzione e non si capisce bene se valga la pena di insistere con le ipotesi, onon sia meglio dichiararsi vinti e rinunciare. Si aggiunge che spesso i frammenticon cui si ha a che fare non risultano manchevoli solo materialmente, ma anchenelle informazioni che servirebbero su luogo, circostanze di ritrovamento ed altro.E tuttavia, a differenza di altri, che possono scegliersi il materiale su cui lavorare,l’editore di un Corpus non può voltarsi da un’altra parte e fingere di non averli vi-sti. Problemi creano anche le restituzioni grafiche, di cui si avverte sempre più l’op-portunità, in aggiunta alla documentazione fotografica, ogniqualvolta sia possibile.Dedico alla cara memoria dell’amico, la percezione della cui mancanza ci accom-pagna quotidianamente, la trattazione di cinque casi esemplari di questo faticoso la-vorio.
Qualche immagine mi aiuterà a velocizzare un discorso, che non si propone diessere completo, ma si limiterà ad evidenziare gli snodi di ragionamento che por-tano dal punto di partenza (il frammento bruto) alla conclusione (il frammento in-terpretato e integrato); nei casi che tratterò, il problema è anzitutto quello dell’i-dentificazione o meno del nome delle divinità che è andato perduto, del tutto o inparte, dalla quale dipende peraltro la collocazione dell’epigrafe nel Corpus.
1. - Muovo da un’ara di travertino che è molto danneggiata superiormente sicchéla sua intitolazione non è subito evidente (Fig. 1). La trascrizione del Colini, che diquest’ara è stato il primo editore,1 preferendo l’integrazione [Con]c.ord.[iae] a quella,
* Il testo, tranne piccole modifiche, corrisponde a quello letto. Mi sono limitato ad aggiungere noteessenziali.
1 A.M. Colini, Ara dedicata alla Concordia Augusta nel Foro Boario, RPA 43, 1970-1971, 55-70, figg. 1-6 (AE
1971, 27).
CIL VI, 8, 1: INSCRIPTIONES SACRAE
FRAGMENTA (I)*
Silvio Panciera
«mediterraneo antico», xvi, i1, 2013, 609-626
che pure non esclude del tutto, [Vic]tori>[ae], è in qualche modo perfezionata dal-l’accurata ricostruzione grafica (fronte, lati) prodotta per lui, nel suo stesso articolo,dal prof. M. Melis (Fig. 2), e dal controllo autoptico, che rendono evidente come ilresto di lettera che si vede dopo OR appartenga certamente a una D e non ad unaR e la lettera che si intravede prima sia certamente identificabile come una C e noncon una T: dunque sicuramente [Con]cord[iae]. La ricostruzione grafica mostra al-tresì che l’integrazione si adatta perfettamente allo spazio disponibile. Risolto que-sto problema, un altro tuttavia se ne affaccia, riguardante la presenza o meno, su-periormente, di uno o più nomi di dedicanti, che altrimenti mancherebbero. Ècerto che questi non potevano trovarsi sulla faccia dell’ara immediatamente sopra
SILVIO PANCIERA610
Fig. 1. Ara dal Foro Boario (arch. fot. CIL VI, neg. 10.500).
CIL VI, 8, 1: INSCRIPTIONES SACRAE. FRAGMENTA (I)
al nome della divinità perché, come si vede nel rilievo del fianco destro (Fig. 2), un
frammento della cornice di coronamento ivi conservato mostra che non c’era lo
spazio necessario. Il Colini pensa allora che tale indicazione potesse trovarsi sul co-
ronamento stesso. Non mi sembra probabile. Il Colini ha molto ben mostrato che
l’ara, trovata loco suo di fronte ad un base piuttosto grande (priva di coronamento),
atta a sostenere una o più statue, ed a lato di un basolato (Fig. 3),2 dovette apparte-
nere ad un compitum sorgente nel luogo di ritrovamento (Fig. 4).3 Ora, pur non
mancando casi in cui il nome del dedicante precede quello del dio dedicatario in-
vece di seguirlo, non conosco nessuna dedica urbana, collocata in compita o di altra
provenienza, in cui il nome del dedicante o, peggio, dei dedicanti, si trovi ristretto
in analoga posizione, nella quale si può trovare, se mai, il nome del dio. Lo stesso
confronto addotto dal Colini, costituito da un’ara del compitum Acilium (Fig. 5), mo-
stra che nel coronamento c’era solo l’indicazione generica dei magistri vici in carica,
611
2 La base retrostante all’ara, che presenta una fenditura centrale nel senso dell’altezza, misura
124,5×158-97,5×162-110,5. Si potrebbe pensare che la stessa sostenesse una statua di Concordia seduta
com’era nel tempio del Foro e come è frequentemente rappresentata sulle monete: T. Hölscher, Ho-
monoia/Concordia, in LIMC V,1, 481-483 e V,2, 333-335.3 La sistemazione attuale, che risale al 1962 (all’angolo di piazza Bocca della Verità, ove sbocca in
essa via Petroselli [già del Teatro di Marcello], sul terrapieno dove si eleva la ricostruzione della casa
dei Pierleoni) non corrisponde al luogo del ritrovamento, effettuato nel 1939 in piazza Bocca della Ve-
rità (nell’abbassamento dei tubi del gas…in mezzo ad un groviglio di murature e cunicoli). Per mag-
giori dettagli: Colini, Ara, cit., 69 («avanti al terrapieno che sostiene gli uffici comunali presso S. Ma-
ria in Cosmedin, non lontano dal punto in cui oggi lascia piazza Bocca della Verità chi vuole, attra-
verso la breve salita, avviarsi verso via dei Cerchi») e G. Cressedi, Il Foro Boario e il Velabro, BCAR 89,
2, 1984, 272, nr. 26, con pianta a 257 fig. 3, qui riprodotta.
Fig. 2. Ara dal Foro Boario, rilievo Melis: fronte e lati (da Colini, Ara, cit., 63, fig. 7).
SILVIO PANCIERA612
Fig. 3. Ara dal Foro Boario fotografata loco suo
(da Colini, Ara, cit., 61, fig. 5).
Fig. 4. Luogo di ritrovamento dell’ara dal Foro Boario: nr. 26 (dettaglio da Cressedi, Foro Boario, cit., 257, fig. 3).
CIL VI, 8, 1: INSCRIPTIONES SACRAE. FRAGMENTA (I)
mentre i loro nomi seguivano sulla fronte dell’ara prima della dedica ai Lari cheprobabilmente si trovava entro la corona.4 D’altra parte, sono abbastanza numerosi,invece, i casi in cui il dedicante manca e la dedica consiste nel solo nome della di-vinità, con o senza epiteto, per lo più seguita dalla formula di consacrazione come
in questo caso.5 Ritengo dunque di non dover presupporre, sopra, alcuna lacuna.
Concordo con il Colini nell’attribuire quest’ara ancora all’età augustea;6 dubbia mi
613
4 Sul monumento: G. Pisani Sartorio, Compitum Acilium, in LTUR I, 1993, 314-315, con ampia biblio-
grafia, tra cui si vedano in particolare, oltre alla prima edizione di Tamassia, i contributi di Dondin-
Payre e Palombi. Contrariamente a quanto si scrive, l’ara non è perduta, ma ancora nel 1997 si con-
servava nell’Antiquario Comunale del Celio (NCE 3940), dove l’abbiamo vista e fotografata: M. Man-
ganaro, in La collezione epigrafica dell’Antiquario Comunale del Celio, Roma 2001, 411, nr. 503; vd. anche E.
Schraudolph, Römische Götterweihungen mit Reliefschmuck aus Italien. Altäre. Basen, und Reliefs, Heidel-
berg 1993, 229, L 94.5 Una ventina di dediche con nome di divinità più epiteto, mentre i dedicanti mancano, già solo in
CIL VI, 1-804.6 Depongono in tal senso la paleografia, l’uso del travertino, la forte affinità, per l’associazione
ara/base, con la situazione riscontrata a S. Martino ai Monti e datata al 10 a.C. (vd. sotto in n. 10), la
corona di quercia, la dea destinataria e l’epiteto di Augusta che le è attribuito. Sul tempio della Con-
cordia Augusta dedicato da Tiberio il 16 gennaio del 10 d.C., avendo però ricevuto l’incarico della sua
costruzione già nel 7 a.C.: A.M. Ferroni, Concordia, aedes, in LTUR I, 1993, 317. Sulla fortuna del tema
della corona civica dopo che questa fu attribuita ad Ottaviano, insieme con l’appellativo di Augusto, il
13 gennaio del 27: P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, Torino 1989, 97-105, 292-297. Sull’uso a
Roma di Augustus/Augusta come epiteto divino (prime testimonianze epigrafiche certamente datate:
7/6 a.C., Diana, Lares, Mercurius): S. Panciera, Umano, sovrumano e divino. Le divinità auguste e l’impera-
tore a Roma, in The Representation and Perception of Roman Imperial Power (Proceed. of the III Int.
Fig. 5. Ara del compitum Acilium (arch. fot. CIL VI, neg. 8223).
pare invece la sua ipotesi di attribuzione precisamente all’anno 11 a.C., quando, se-
condo Cassio Dione, Augusto volle che certo denaro raccolto dal senato e dal po-
polo per statue in suo onore, fosse destinato invece ad erigere statue di divinità, tra
cui una di Concordia,7 distribuite probabilmente vicatim, come fece anche per le sta-
tue acquistate in quegli stessi anni con le somme raccolte per il suo compleanno.8
Il tenore delle iscrizioni che accompagnavano queste ultime (ne conosciamo sei)9 èinfatti ben diverso ed è l’imperatore stesso a figurarvi come dedicante. A meno cheun’iscrizione del genere non figurasse su una lastra di rivestimento della base re-trostante.10 Una considerazione aggiuntiva: una trentina d’anni fa, pubblicando unframmento epigrafico di quest’ultimo tipo (datato al 10 d.C.), proveniente da viadella Greca, così detta perché corrente a lato della schola Graeca o S. Maria in Co-
smedin,11 e un’ara a Venus Augusta trovata in reimpiego nel Mitreo sotto S. Stefano
Rotondo, ma originariamente collocata anch’essa, come credo, insieme con altre
iscrizioni compitali note da tempo, nei pressi di dove sorse in seguito la chiesa data
ai Greci,12 pervenivo all’ipotesi che tutti questi documenti potessero venire da uno
stesso compitum situato in quei pressi, preferibilmente nell’area antistante alla
chiesa. Mi chiedo oggi (anche se l’esistenza di altri compita nelle vicinanze non può
essere esclusa) se tale compitum non fosse proprio quello che ha restituito l’ara della
Concordia e il basamento, non proprio davanti alla chiesa, ma in posizione un po’
defilata sulla destra rispetto ad essa.13
SILVIO PANCIERA614
Network ‘Impact of Empire’, Rome 2002), Amsterdam 2003, 215-239 = S. Panciera, Epigrafi, epigrafia,
epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici, I («Vetera, Ricerche di Sto-
ria Epigrafia e Antichità» 16), Roma 2006, 521-540; per un’estensione dell’analisi all’Italia (prime atte-
stazioni epigrafiche certamente datate: 1. d.C., Lares, Puteoli; 3 d.C., Fortuna, Pompeii): G.L. Gregori, Il
culto delle divinità auguste in Italia: un’indagine preliminare, in Dediche sacre nel mondo greco-romano (Acta
Inst. Rom. Finl. 35), Roma 2009, 307-330. Un’altra dedica urbana alla Concordia Augusta possibilmente
di età augustea: AE 1913, 1, cfr. Panciera, Umano, cit., 220 n. 18 = Id., Epigrafi, cit., 524 n. 18.7 Dio LIV 35, 2.8 Suet. Aug. 57, 1.9 CIL VI, 456-458 cfr. 30770-30772; 30974; AE 1980, 56; St. De Angeli, L’annua stips e i pretiosissima deo-
rum simulacra di Augusto. Un esempio di rinnovo dei luoghi e delle immagini di culto a Roma in età augustea,
«Daidalos» 3, 2001, 185-208 (vd. anche Panciera, Epigrafi, cit. 279-281 e 286) datate tra il 10 a.C. e il 10
d.C.; si noti che in nessun caso le divinità che vi sono menzionate come destinatarie (Mercurius, Vol-
canus, Neptunus) sono dette Auguste.10 Ma, in accoppiata del tutto analoga di ara/base riscontrabile in via di S. Martino ai Monti (Co-
lini, Ara, cit., 69-70 con fig. 8), la dedica a Mercurio, fatta porre ex stipe da Augusto nel 10 a.C. (CIL VI,
30974) è incisa sull’ara e non sulla base.11 S. Panciera, Nuovi luoghi di culto a Roma dalle testimonianze epigrafiche, ArchLaz 3, 1980, 205-206 (AE
1980, 56) = Id., Epigrafi, cit., 279-281, cfr. 286.12 Panciera, Nuovi luoghi, cit., 203-205 (AE 1980, 54) = Id., Epigrafi, cit., 276-278, cfr. 286. Le altre iscri-
zioni sono: CIL VI, 283 (dedica a Mercurio da parte di magistri vici anni primi vista dal Fabretti ad D.
Mariae in Cosmedin) e CIL VI, 282 (dedica a Ercole da parte dei magistri dello stesso vicus, ma anni XI,
vista dallo stesso Fabretti sub Aventino, in vinea nobb. de Cicciaporcis, prope … templum rotundum ad ripam
Tiberis).13 De Angeli, L’annua stips, cit., non crede che le dediche ex stipe (su cui vd. anche J.P. Lott, The Nei-
ghborhoods of Augustan Rome, Cambridge 2004, 181 ss. e passim) siano da connettere con compita, tutta-
CIL VI, 8, 1: INSCRIPTIONES SACRAE. FRAGMENTA (I)
2. – Talora il nome della divinità
dedicataria è ancora meno conser-
vato, ridotto a qualche residuo di
lettera d’interpretazione in sé im-possibile o malsicura, e un tenta-tivo di identificazione può essereoperato soltanto attraverso unesame d’insieme di monumen -to/epigrafe e qualche opportunoconfronto. È il caso di una piccolabase di donario, di provenienzaignota e mancante della parte su-periore, conservata nelle Colle-zioni già dell’Antiquarium Comu-
nale del Celio (Fig. 6).14 Dalla let-
tura della dedica risulta che un li-
berto imperiale di nome Proculus
offrì alla divinità una palma(m) ar-
gentia(m) del peso di una libbra
(323 gr. circa). Questo tipo di de-
dica fa pensare in primo luogo a
Victoria, ma, curiosamente, non si
conosce alcuna dedica epigrafica
di una palma15 a questa divinità, mentre ne abbiamo per Aesculapius et Pantheus,16
per Caelestis17 e soprattutto per Saturnus, non peraltro l’antica divinità romana, ma
la sua versione africana per la quale la palma, simbolo di vita e benessere, oltre che
di vittoria, riveste un particolare significato.18 Un bel confronto è fornito da una de-
dica di Ippona da cui risulta che un calzolaio scioglie un voto offrendo a una divi-
615
via una connessione di questo genere sembra resa verosimile dalla notizia suetoniana di una distribu-
zione vicatim (e i compita costituivano punto di riferimento religioso dei vici) delle relative statue. Non
sappiamo a quale dio fosse dedicata la statua cui si riferiva il frammento di dedica di via dei Greci (vd.
sopra, n. 12) e può essere puramente casuale che la sua datazione cada nello stesso anno della dedica
del tempio della Concordia Augusta (vd. sopra, n. 6). Comunque le dimensioni originarie della lastra di
via dei Greci, in quanto ricostruibili, non sembrano adattarsi alla base retrostante all’ara della Con-
cordia.14 Panciera, in La collezione epigrafica, cit., 92-94 (AE 2001, 227) = Id., Epigrafi, cit., 497-499.15 Come ramus palmae e attributo della Vittoria: TLL X 1, 1982, 143-144. Per l’iconografia della dea R.
Vollkommer; LIMC VIII, 1, 1997, 237-269, VIII, 2, 1997, 167-194.16 ILTun. 868 b: Aesculapio et Panteo … viso renovavit et … palmam argenteam de suo posuit.17 CIL X, 1598, cfr. L. Cordischi, La Dea Caelestis ed il suo culto attraverso le iscrizioni, ArchClass 42,
1990, 190 nr. 19: elencazione di doni alla dea tra cui una palma aurea.18 M. Le Glay, Saturne africain. Monuments II, Paris 1966, 359 (palmes, palmier); Id., Saturne africain.
Histoire, Paris 1966, 163 ss., 395 ss.; Id., Nouveaux documents, nouveaux points de vue sur Saturne africain, in
Studia Phoenicia VI. Carthago (Orien. Lov. Anal. 26), Leuven 1988, 187-237.
Fig. 6. Ara di provenienza ignota
(arch. fot. CIL VI, neg. 8148).
nità, giustamente identificata per l’ap-
punto con Saturno, una palma d’argento
del peso di quattro libbre.19 Se si ritorna
con questi dati alle tre lettere di cui re-
stano tracce, ci si accorge che per l’ap-
punto esse si adattano solo al nome
Sat[urno], per cui penso che inserirò il do-cumento nel Corpus senz’altro tra le dedi-che a questa divinità.
3. – Altre volte, gli indizi di cui dispo-
niamo sono ancora più tenui. Una situa-
zione del genere presenta una lastra qualificata come di travertino rotta a destra
(Fig. 7), trovata dal Paribeni negli scavi del Foro di Nerva e dallo stesso imperfetta-
mente pubblicata.20 Il Paribeni, che omette di trascrivere il resto di lettera (C, G, O,
o Q) che si vede dopo IVSSV e legge il nome della seconda riga come C(aius) Co[- -
-], invece che come C(aius Cosc[—-], cioè sicuramente Cosc[onius],21 non fornisce al-
cun commento. Si può notare tuttavia che un’iscrizione cominciante con iussu nonsembra ammettere più di due interpretazioni, rispettivamente secondo che, dopo
l’ablativo, s’immagini un nome di persona (o di un organismo collettivo, come il se-
natus o il populus), oppure il nome di una divinità. Nel primo caso l’iscrizione ri-
corderebbe l’esecuzione di qualche lavoro compiuto per volontà umana [celebre
l’obelisco di Cornelio Gallo posto a ricordo del fatto che egli iussu Imp(eratoris) Cae-
saris Divi f(ilii)… forum Iulium fecit],22 nel secondo si avrebbe una dedica, posta in es-
sere, non per spontanea iniziativa del fedele, ma per ordine di un dio (iussu ap-
punto, o anche imperio, oppure, per richieste trasmesse mediante visioni o sogni,
anche visu, somnio monitus o simili).23 La seconda pratica, è da dire, è molto più fre-
quente della prima, nella quale oltretutto l’espressione iussu non compare in genere
all’inizio, ma nel corpo del testo. Inoltre la volontà umana è espressa abitualmente
su supporti di prestigio e in testi di qualche complessità, mentre qui il supporto è
assai modesto e l’iscrizione consta di due sole righe, la seconda delle quali con let-
tere di appena poco più di 2 cm. L’ipotesi da preferire mi sembrerebbe dunque
quella dell’ordine divino. Tre iniziali possibili del nome (G, O, Q), che portano a di-
SILVIO PANCIERA616
19 P. Corbier, Nouvelles inscriptions d’Hippone, ZPE 43, 1981, 92 (AE 1982, 945); Le Glay, Nouveaux do-
cuments, cit., 211 ss.20 R. Paribeni, NSA 1933, 480 nr. 134 (manca in AE). Per il momento non ho potuto verificare il ma-
teriale, che dubito sia travertino.21 CIL VI, Indices 70.22 CIL VI, 882, cfr. 31191 e pp. 3777, 4302. 23 Su questo tema, importante la dissertazione (Duke University 2003), ora in via di pubblicazione,
di G.H. Renberg, Commanded by the Gods. An Epigraphical Study of Dreams and Visions in Greek and Ro-
man Religious Life; vd. anche M. Kajava, Osservazioni sulle dediche sacre nei contesti oracolari, in Dediche
sacre nel mondo greco-romano, cit., 2009, 209-225.
Fig. 7. Frammento di dedica sacra dal Foro
di Nerva (arch. fot. CIL VI, neg. A 109).
CIL VI, 8, 1: INSCRIPTIONES SACRAE. FRAGMENTA (I)
vinità come i vari Genii, oppure a Osiris o a Quirinus, non si prestano molto. Resta l’i-
niziale C, lettera con cui comincia il nome di parecchie divinità venerate a Roma.24
Ma, a parte il fatto che alcune di queste sono di attestazione assai sporadica e spe-
ciale, quel che importa rilevare è soprattutto che non tutte queste divinità si adat-
tano alla nostra tipologia. Anzi, tra di esse la sola che risulti intervenire a Roma con
propri iussa è Caelestis, le cui iscrizioni offrono vari confronti al nostro testo,25 (altri
se ne trovano in Italia a Puteoli e a Mediolanum).26 La constatazione è coerente con il
carattere oracolare di questa dea protettrice di Cartagine, introdotta a Roma dopo la
III Punica, che vide aumentare considerevolmente il suo culto soprattutto dopo il
trasferimento della sua statua da Cartagine a Roma per volontà di Elagabalo.27 Se si
integra qui il nome della dea, è molto probabile d’altronde che si debba presupporre
di seguito anche l’integrazione di qualcuno dei suoi epiteti o il nome di un’altra di-
vinità destinataria di dono per ordine della dea,28 tenendo conto del fatto che, nella
seconda riga, che era centrata, dopo Cosconius, dovevano leggersi almeno il suo co-
gnomen e una formula di dedica del tipo dono dedit, fecit o simili. Includeremo dun-
que l’iscrizione senz’altro tra quelle di Caelestis? Un problema è costituito dalla sua
datazione, resa molto difficile dalla rozzezza dell’esecuzione, che comportò tra l’al-tro l’errore, subito però corretto dell’omissione di una S in IVSSV. Se interpretassimoquesta rozzezza, la forma delle lettere e l’eventuale (dubbio) uso del travertino comesegno di datazione alta, magari ancora della fine dell’età repubblicana, l’attribuzionea Caelestis andrebbe incontro a difficoltà perché non conosciamo a Roma iscrizionidella dea così risalenti: le prime sono del I sec. d.C. e la loro maggior concentrazioneè nel III sec. Ma si può dubitare di questa collocazione cronologica alta: si noti chela stessa dedica iussu presuppone una datazione almeno del I sec. d.C.29 e che Cosco-
617
24 In ordine alfabetico: Caelestis, Caelus, le divinità Campestres, la divinità celtica Camulus (Mars), i Ca-
stores, Cautes, Ceres, Civitas, Clementia, Concordia, Corniscae, Cornix, Coronis, Cupido e Cybele.25 CIL VI, 77, cfr. p. 3755 = Cordischi, Caelestis, cit., 171 ss. nr. 1, con foto: Dominae Caelesti donum de-
dit iussus a numinae (!) eius; CIL VI, 79, cfr. p. 3003 = Cordischi, Caelestis, cit., 173 ss. nr. 3, con foto: Iussu
Caele[stis - - ]; AE 1950, 53 = Cordischi, Caelestis, cit., 183 ss. nr. 12 con foto: Ex imperio daeae (!) Caelestis
Domino Plutoni; se si integrasse [iussu] deae, ma è solo una possibilità) potrebbe essere di Caelestis an-che AE 1992, 129 = I. Di Stefano Manzella, Lapidario profano ex Lateranense. Nuove iscrizioni sacre, impe-
riali, sepolcrali, BMMP 11, 1991, 53 ss. nr. 3 con foto: [Iussu?] Deae [Caelestis?].26 CIL X, 1596 = Cordischi, Caelestis, cit., 189 ss. nr. 18, con foto: ecitium, taurobolium Veneris Caelestae
(!) et panteliu[m] inperio (!) Deae; CIL V, 5765 = Cordischi, Caelestis, cit., 193 ss. nr. 25, con foto: D(eo)I(nvicto) Pantheo iussu imperiove Cael(estis) Dianae Aug(ustae).
27 L. Cordischi, Caelestis, in LTUR I, 1993, 207, con ampia bibliografia; adde (non vidi): M.G. Lan-cellotti, Dea Caelestis. Studi e materiali per la storia di una divinità dell’Africa romana, Pisa-Roma 2006.
28 Epiteti che risultano posposti, Urania: CIL VI, 80 cfr. p. 3003 = Cordischi, Caelestis, cit., 175 ss. nr.4, con foto; Augusta: CIL VI, 780, cfr. p. 838, 3006 = Cordischi, Caelestis, cit. 176 ss. nr. 6, con foto;Triumphalis: AE 1950, 51-52 = Cordischi, Caelestis, cit., 181-183, nrr. 10-11. È invece anteposto Invicta: CIL
VI, 78, cfr. p. 3003, 3755 = Cordischi, Caelestis, cit., 172 ss. nr. 2, con foto; CIL VI, 80, cfr. p. 3003 = Cor-dischi, Caelestis, cit., 175 ss. nr. 4, con foto. Da considerare falsa, con Cordischi, 171, CIL VI, 756 = 30825.Per altre divinità destinatarie di dono per volontà della dea vd. sopra alle nn. 25 e 26.
29 Secondo Renberg, Commanded by the Gods, cit., 157 ss. La maggior parte delle dediche viso/iussu,che compaiono già nel I sec. d.C., sono del II/III sec. e nessuna è posteriore al IV.
nius, un nome abbastanza diffuso aRoma, risulta associato al pre-nome C(aius) solo nel tardo casodel clarissimus puer C. Cosconius
Commodianus.30 Collocando l’iscri-zione in età imperiale, cade inveceogni difficoltà ad attribuirla alladea. Si noti inoltre che la nostraiscrizione, visto il ritrovamento,probabilmente per reimpiego, nelnon lontano Foro di Nerva, po-trebbe per l’appunto venire, comealtre trovate nei dintorni, propriodal Campidoglio.31 Penso di da-tarla nel II/III sec. e di metterla trale iscrizioni di Caelestis, magari conun punto interrogativo.
4. – Altre volte ancora il nomedel dio manca del tutto, ma ciò no-nostante siamo sicuri di aver a chefare con parte di un’iscrizione sa-cra grazie ad altri indizi. È il caso
di un frammento inedito di lastra di travertino conservato in un magazzino delForo di Cesare (Fig. 8), nei cui scavi verosimilmente sarà stato trovato, ma non sonoriuscito a trovare dati precisi sulle circostanze del ritrovamento. Il pezzo non ègrande, poco più di 25 cm per lato, e risulta lacunoso da tutti i lati;32 è certo che l’i-scrizione non constava di più di tre righe33 e apparteneva ad una dedica ex voto,come si ricava dalla metà, in basso, della comunissima formula [v(otum) s(olvit)]l(ibens) m(erito). Il dedicante, con cognome greco iniziante per Philo. [- - -],34 era un li-berto o una liberta di cui ignoriamo il gentilizio. Ma qual era la divinità cui fusciolto il voto? La struttura del testo è chiara: la prima riga doveva essere riservata
SILVIO PANCIERA618
30 VI 1393 = 4229 cfr. p. 3141 e 4691; Imagines, Roma 1, nr. 143.31 Dove certamente il culto fu stabilito fin dall’inizio, anche per l’assimilazione di Caelestis con Iuno
Moneta. Nel III sec. d.C., la dea viene detta praesentissimum numen loci Montis Tarpei: CIL VI, 37170 =Cordischi, Caelestis, cit., 178-181 nr.9, con foto.
32 Le misure sono: 28x27x5 (l’altezza e la larghezza originarie dovevano essere un po’ maggiore laprima e circa il doppio la seconda); lett. 5,5-3,2.
33 Ho potuto sottoporre il pezzo a nuova autopsia grazie alla cortesia della dott. Marina Milella cheme lo ha reso accessibile nonostante il magazzino in cui si conserva sia attualmente chiuso perché pe-ricolante.
34 I nomi greci con questo inizio sono moltissimi (H. Solin, Griechische Personennamen2, Berlin-NewYork 2003, 1695 ss.). Per ragioni d’impaginazione, un nome breve come Philo [n] sembrerebbe in que-sto caso preferibile.
Fig. 8. Frammento di dedica votiva dal Foro di Cesare (arch. fot. CIL VI, neg. 4489).
CIL VI, 8, 1: INSCRIPTIONES SACRAE. FRAGMENTA (I)
al dedicante, la seconda alla divinità, la terza alla formula conclusiva messa in posi-zione centrata. Bisogna dunque concentrarsi sulla seconda riga in cui restano sulbordo di frattura sinistro piccoli residui dei tre tratti orizzontali di una E seguiti,dopo un interpunto triangolare con il vertice in alto (come sono anche gli altri),dalle lettere INTERO o INTERC (del tutto improbabili le letture INTERG o IN-TERQ), lettere che dovevano verosimilmente far parte di un’unica parola perché né
dopo IN né dopo INTER c’è interpunto o spazio extra.35 Ne risulta che dovremmoavere qui il nome di una divinità femminile, al cui nome, al dativo (donde la termi-nazione in -ae, che esclude Venus Genetrix, la prima divinità che viene in mente vi-sto il luogo di ritrovamento, che peraltro non è detto che fosse quello della collo-cazione originaria),36 faceva seguito qualcos’altro che dovrebbe essere, in primis, unepiteto di questa, oppure, ma solo subordinatamente altro: l’indicazione di undono, del motivo per cui la divinità veniva ringraziata, di una data. Confesso il mioimbarazzo. Mentre per la lettura INTERC, scartate forme di verbi come intercedo,
intercido, intercipio o intercludo, la sola parola che potrebbe far senso sarebbe interca-
laris, naturalmente con rinvio ad una data anteriore alla riforma cesariana del ca-lendario, (la quale è esclusa però da quel che viene prima, che non può essere rife-rimento, come ci aspetteremmo, alle calende, alle none o alle idi), per la lettura IN-TERO, la sola associazione che mi viene in mente è con il toponimo Interocrium, omeglio con un etnico da questo derivante, con il risultato che la dedica sarebbe fattaa una divinità con epiteto derivato dall’originario luogo di culto.37 L’ipotesi non è insé impossibile: l’uso di attribuire a divinità epiteti derivati da toponimi è già atte-stato nell’area,38 e si potrebbe pensare che l’epiteto sia stato attribuito ad una divi-nità indigena come Vacuna, tra l’altro identificata anche con Venere.39 Un esempiod’integrazione, ma solo exempli causa, alla Fig. 9. La datazione, considerati mate-riale e paleografia, dovrebbe essere della metà circa del I sec. a.C. Credo che lascerò
619
35 Escludendo dunque, non solo una lettura IN TERO/TERG/TERC/TERQ-, che non dà senso,ma anche un’indicazione topografica INTER O/C/G/Q[- - -] del tipo inter vitores, figulos, falcarios, li-
gnarios (su cui vd. LTUR), in sé non impossibile, ma non facile da inserire in questo contesto.36 Sul tempio di Venus Genetrix nel Foro di Cesare: C. Morselli, Forum Iulium, in LTUR II, 1995, 299-
306.37 Interocrium (Antrodoco), da ocre = montagna (quindi = tra le montagne), si trovava sulla via Sa-
laria, in territorio sabino, nei pressi di Reate. Ignoto l’etnico, che poté essere qualcosa come Interocri-
nus, Interocranus, Interocrensis.38 Cfr. l’iscrizione sulmonese, di recente ritrovamento, dei cultores Iovis Ocriticani, da un verosimile
toponimo locale *Ocriticum): M. Buonocore, Suppl. It. 22 (Sulmo) 101, vd. anche Id., in Dediche sacre, cit.,214 n. 106, con altra bibliografia; degni di nota anche lo Iuppiter Trebulanus di CIL IX, 2823, il Pater Rea-
tinus di CIL IX, 4676, il Pater Albensis di CIL IX, 4177 e il Pater Pyrgensis di CIL XI, 3710 su cui, fra l’altro,Buonocore, in Dediche sacre, cit., rispettivamente a 298 n. 423 e 285 n. 285, e C. Letta, Il culto del Fucino
lontano dal lago, in Le epigrafi della Valle di Comino (Atti del II Convegno epigrafico cominese 2005), Cas-sino 2006, 89 ss.
39 Ps. Acro Hor. epist. I 10, 49: Vacunam alii Cererem, alii deam vacationis dicunt… nonnulli Venerem. SuVacuna come divinità tipicamente reatina: M.C. Spadoni, in Suppl. It. 18, 50 ss.
il frammento tra gli adespoti confinando le mie elucubrazioni interpretative nelcommento.
5. – Concludo con un frammento, conservato nel Museo dell’Istituto di Archeo-logia dell’Università di Pavia, che apparentemente non ha nessun motivo per essereinserito tra le iscrizioni sacre, urbane o no. Nel primo inventario del Museo, datatotra il 1820 e il 1825, si afferma che questo pezzo e altri cinque, sono «provenienti da-gli scavi di Velleia» e «procurati al Gabinetto per merito e cura del Sig. Prof. Mar-chesi»,40 ma tale provenienza, considerata attendibile da Arturo Stenico,41 nonesclusa da Lellia Ruggini42 e certa dallo Chastagnol,43 è giustamente ritenuta invecemolto dubbia da Delfino Ambaglio,44 che preferisce pensare ad una provenienza daRoma, per ragioni che credo si possano confermare e ampliare.
Si tratta di una grande lastra di marmo bianco (lunense?), ottenuta da un paral-lelepipedo assai maggiore tagliandone una fetta a destra rispetto alla faccia iscritta
SILVIO PANCIERA620
40 A. Stenico, Sculture di asserita provenienza veleiate dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Pavia,in Studi Veleiati (Atti e Memorie del 1° Convegno di Studi Storici e Archeologici, Piacenza-Veleia 29-30
maggio 1954), Piacenza 1955, 131 ss.; provenienza confermata anche in un successivo catalogo del 1839.
Il Marchesi deve intendersi come Giuseppe Marchesi (1792-1867), professore di architettura nell’Ateneo
pavese.41 Stenico, Sculture, cit., 132, 135 ss.42 L. Ruggini, Economia e società nell’Italia Annonaria, Milano 1961, 50 n. 108.43 A. Chastagnol, Fastes de la Préfecture de Rome au Bas Empire, Paris 1962, 143 n. 149.44 [C. Tomaselli -] D. Ambaglio [- L.Boffo - E. Gabba], in Museo dell’Istituto di archeologia. Materiali 3
(Fonti e studi per la storia dell’Università di Pavia), Milano 1987, 197-199.
Fig. 9. Integrazione exempli causa del frammento di dedica dal Foro di Cesare (S. Panciera).
CIL VI, 8, 1: INSCRIPTIONES SACRAE. FRAGMENTA (I)
(Fig. 10) e riutilizzandone, comepare, solo in parte l’altezza perscolpire a rilievo su quello che eral’originario lato destro del paralle-lepipedo (sfruttando probabil-mente sia lo spessore dell’even-tuale cornice laterale, sia ancheuna parte estrema dello specchioepigrafico) un amorino dormientedi cui sono andate interamenteperdute le gambe (Fig. 11) e, con laloro estremità, essendo la figuraorientata in senso inverso rispettoalla scrittura, anche la prima rigadell’epigrafe.45
Dell’originaria faccia anterioreiscritta, a causa del taglio e di am-pie scheggiature superficiali, restasolo una porzione triangolare ap-partenente all’estremità destra conresti di tre righe (Fig. 12), in cui sileggono parte di un nome (sicura-mente [V]itrasius), la qualifica div(ir) c(larissimus) e parte del titolodi [praef(ectus)] urbi, o ancheurbi[s], come in quest’epoca era del tutto possibile.46 Nessuna menzione di divinitào formula che rinvii all’ambito sacro. Perché allora si propone d’inserire questoframmento tra le iscrizioni sacre invece che tra le onorarie come suggerì la Ruggini,
che pensava alla base di una statua posta da Vitrasius ad un imperatore o a qualche
altro personaggio?
Occorre considerare un’altra iscrizione (sicuramente urbana in questo caso)
già nota da molto tempo ed edita anche in CIL VI per l’appunto tra le sacre (Fig.
13).47 Evidente l’identità della struttura tra i due testi che potrebbe far pensare che
quello pavese altro non sia che parte di quello romano. Tuttavia non può essere
così, non solo perché, come già notato da Ambaglio, l’iscrizione urbana fu vista
integra da Henzen, inserita nel muro di una casa situata all’angolo delle ora non
621
45 In sostanza le attuali misure della lastra sono di cm 103/106 in altezza, 34,5 in larghezza e 58/57
in profondità. Sono grato alla dott.ssa Paola Tomasi che mi ha procurato fotocopie, fotografie e mi-
sure ed ha controllato sul pesante pezzo, appositamente fatto muovere, le mie ipotesi.46 Abbondanti esempi di datazione tarda di quest’uso in CIL VI, 7, 4 (indices vocabulorum), pp. 4750-
4752.47 CIL VI, 45 cfr. pp. 3003 = ILS 3222.
Fig. 10. Lastra del Museo Archeologico
dell’Università di Pavia con resti di iscrizione
sullo spessore (foto Paola Tomasi).
SILVIO PANCIERA622
Fig. 11. Lastra del Museo Archeologico dell’Università di Pavia: faccia con amorino dormiente (foto Paola Tomasi).
CIL VI, 8, 1: INSCRIPTIONES SACRAE. FRAGMENTA (I)
più esistenti vie dei Vaccinari e
della Fiumara, quando il fram-
mento pavese si trovava già da
tempo nel museo dell’Università,
ma anche perché l’iscrizione ro-
mana non è perduta, come nor-
malmente si ritiene, ma, come ho
potuto vedere, ancora si con-
serva, sia pure in pessime condi-
zioni, non identificata e senza nu-
mero d’inventario, nelle colle-
zioni del Museo Nazionale Ro-
mano, di cui evidentemente entrò
a far parte quando la casa dove
era murata fu abbattuta. Ab-
biamo dunque un testo unico,
pertinente ad un unico personag-
gio, il prefetto urbano Memmius
Vitrasius Orfitus, prefetto urbano
per la seconda volta nel 357/9,48
ma i monumenti sono due e
quello pavese, di origine urbana e
non veleiate, può essere integrato
sul modello di quello urbano: il
disegno ricostruttivo che presento
è stato eseguito dalla dott.ssa Va-
lentina Vegni servendosi del
software Adobe Illustrator (prin-
cipalmente dei comandi di disegno a mano libera) e di modelli paleografici, per
le lettere mancanti, tratti dagli Exempla di Hübner (Fig. 14).
Teoricamente la divinità dedicataria del nostro frammento potrebbe essere anche
un’altra, ma è improbabile che sia così, perché mi pare che entrambi i monumenti
abbiano avuto la medesima origine e una stessa collocazione. Henzen qualifica il suo
documento, oggi perduto, come ara, senza darne le misure. Un’immagine piuttosto
fedele quanto al testo (notare la lettura urbis tacitamente mutata in urbi dal CIL),
meno quanto alle proporzioni e alla paleografia, si trova nel codice ligoriano napo-
letano B XIII.7, e si può vedere ora nell’edizione di Silvia Orlandi49 (Fig. 15); ancor più
essa può ricavarsi oggi dall’esemplare delle Terme, sul quale conto di tornare. Du-
bito che si possa mantenere per entrambi i monumenti la definizione di ara invece
che di base, peraltro non di eguali misure perché quelle che mi pare si possano rica-
623
48 Chastagnol, Fastes, cit., 139-147; PLRE I, 1971, Orfitus 3, 651-653.49 P. Ligorio, Libri delle iscrizioni latine e greche. Napoli-Volume 7, a cura di S. Orlandi, Roma 2008, 33.
Fig. 12. Lastra del Museo Archeologico
dell’Università di Pavia: dettaglio con resti
di iscrizione (foto Museo).
vare dal frammento pavese sono dialmeno cm 130×85×58 mentre le at-tuali dimensioni del monumentodelle Terme sono di cm 103×53×42;diverse sono anche le misure dellerighe e degli spazi interlineari.Come ho detto, riterrei comunqueche entrambe siano state collocatenell’ambito dello stesso tempio dicui Vitrasio, nell’esercizio delle suefunzioni, si era preso cura (così in-
tendo aedem providit).50
Trovate verosimilmente en-trambe nel Ghetto, non lontanoda dove fu vista, in varia colloca-zione, CIL VI, 45, è credibile che iltempio sia stato quello vicino diApollo in Circo, che mostra perl’appunto modesti rifacimenti da-tabili alla metà circa del IV sec.51
L’esemplificazione di una casistica che è molto varia e complessa potrebbe con-tinuare a lungo, ma penso che questa possa bastare. Non esistono delle regole fisseper affrontare questo tipo di problemi, per la cui eventuale soluzione essenziali ri-sultano comunque, da un lato una sufficiente conoscenza delle varie classi epigra-
SILVIO PANCIERA624
50 Che l’aveva cioè in qualche modo restaurato e non costruito, come intendono invece la PLRE,Ambaglio e vari altri. Sulla possibilità di costruire provideo, non solo col dativo, ma anche con l’accu-
sativo: Prisc. gramm. III 358, 2: consulo, provideo prospicio tam dativo quam accusativo coniunguntur.51 A. Viscogliosi, Apollo, aedes in Circo, in LTUR I, 1993, 51.
Fig. 13. CIL VI, 45.
Fig. 14. Restituzione dell’iscrizione frammentaria
alla fig. 12 (V. Vegni).
CIL VI, 8, 1: INSCRIPTIONES SACRAE. FRAGMENTA (I)
fiche, del loro linguaggiosecondo tempo e commit-tenti, delle tipologie monu-mentali, delle specificità lo-cali, anche di tipo officinale,dall’altro un’adeguata atten-zione ai contesti ambientalie cronologici. Utili anchepazienza, tenacia e, poichéil terreno è infido, pru-denza, che non significa tut-tavia, a mio avviso, aste-nersi dal correre qualsiasi ri-schio. Al contrario, corrererischi fa parte della genero-sità che si richiede ad ognieditore. Piuttosto, la pru-denza dell’editore non eso-nera l’utente del suo lavoroda averne altrettanta e chedunque, recependo le pro-poste offertegli, farà bene a non dimenticare che sempre di proposte, per quantomotivate, si tratta, aperte, come tali, tanto a conferma quanto a smentita.
Accademia Nazionale dei [email protected]
Abstract
Esemplificazione dei molti problemi che si devono affrontare nell’edizione dei frammentiepigrafici: 1) dedica a [Con]cord[ia] e non a [Vict]ori[a] Augusta; 2) offerta di una palma ar-gentea a Sat[urnus]; 3) dedica iussu C[aelestis]; 4) scioglimento di voto a divinità ignota dettaIntero>[crina]; 5) Altra base posta ad Apollo da parte del prefetto urbano Memmio VitrasioOrfito.
Parole-chiave: Roma, epigrafia, tituli sacri, frammenti
Some examples of the many problems one has to face in editing epigraphic fragments: 1)dedication to [Con]cord[ia], not to [Vict]ori[a] Augusta; 2) offering of a palma argentea toSat[urnus]; 3) dedication iussu C[aelestis]; 4) keeping a wow to a unknown goddess namedIntero>[crina]; 5) another base to Apollo from the urban prefect Memmius Vitrasius Orfitus.
Key-words: Rome, epigraphy, tituli sacri, fragments
625
Fig. 15. Dedica ad Apollo (da Ligorio).