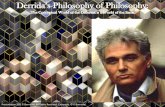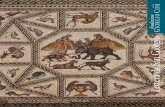A fala em Ferdinand de Saussure: um conceito relacional, opositivo e negativo
LETTERA APERTA con riflessioni sul Corso di linguistica generale di F. de Saussure
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of LETTERA APERTA con riflessioni sul Corso di linguistica generale di F. de Saussure
1
LETTERA APERTA
Roma, 25 Febbraio 2010
Gentile Professor L.,
la lettera che segue trae la sua prima ragion d’essere dalla necessità di dare un senso e un
seguito a una esperienza vissuta questa mattina nel piccolo spazio del corridoio di facoltà, nel
tempo di un appello d’esame universitario. Gli attori- protagonisti: un docente e uno studente.
Lo studente non ha regolarmente effettuato l’iscrizione e perciò non risulta sull’elenco delle
prenotazioni elettroniche. Il docente, per tale ragione, gli nega la possibilità di sostenere
l’esame. Questo, in breve, l’evento. Ma noi non ci soffermeremo sui pochi istanti di dialogo
tra i due interlocutori, né cercheremo di stabilire se ciò che è accaduto sia giusto o ingiusto,
corretto o scorretto, legittimo o ingiustificato. Ci interessa piuttosto osservare lo studente nei
minuti successivi alla conversazione, quando, pensoso, sembra meditare sull’evento e non
potersene fare una ragione. Che ci sia una regola, e che questa venga applicata, non lo deve
certo sorprendere. Che cosa allora non può accettare o spiegarsi? Effettivamente l’evento in sé
non ha niente a che fare con il suo reale turbamento, che ora, guardando più da vicino, sembra
piuttosto delusione e amarezza. Ancora ci sembra di non capire. Continuiamo ad osservarlo e
seguiamone lo sguardo che a un tratto, distogliendosi dall’orizzonte dei pensieri, si rivolge ai
libri: i testi d’esame.
Assieme ai libri, molte pagine spillate a formare delle unità o piccole cartelle: le sintesi
concettuali dei testi studiati. Una piccola unità di fogli è di natura diversa: le riflessioni – nate
durante lo studio del Corso di Linguistica Generale di F. de Saussure - che intendono
guardare al valore e al senso di quel testo in relazione alla storia del pensiero moderno. Un
rapporto vitale con il passato necessita di una relazione viva, e una relazione è viva se
riconosce una vita all’oggetto con cui entra in contatto. Le opere umane in generale e le opere
del pensiero in particolare mostrano una vita autonoma oltre la vita del singolo che le ha
concepite1, una vita che attraversa il tempo e lo spazio con voci e forme che si tramandano e
in tale processo non permangono uguali a se stesse. La forma come atto di conoscenza si
riscrive continuamente, diceva Grotowski.
1 Leggiamo in Bühler lo stesso concetto quando considera il parlare come un’attività (Handlug): «L’opera
linguistica di per sé esige di essere considerata in linea di principio e in linea di fatto sciolta dalla matrice
costituita dalla vita individuale e dall’esperienza vissuta del suo produttore. Il prodotto, in quanto opera
dell’uomo, tende sempre a rendersi indipendente dalla sua genesi e a divenire autonomo» K. Bühler,
Teoria del linguaggio, Armando, 1983 pp. 105- 106.
2
Poiché le premesse ci sembrano buone e lo studente non ha avuto la possibilità di sostenere
l’esame, vorremmo dargli l’opportunità di esporre e di argomentare i concetti e i pensieri che
ha tessuto nel corso della sua esperienza di conoscenza. Al nostro studente non è stato
riconosciuto un contesto spazio- temporale di confronto che può essere ricreato qui e ora. I
discorsi che faremo nel nostro campo non vivranno però dell’esperienza di
contatto/confronto/scambio interumano. Non potremo perciò restituire a questa coscienza
l’aspetto che considera più importante del “momento esame”, e per questo ce ne dispiace, ma
sono, dopo tutto, i limiti che il mezzo ci impone. Iniziamo dal Corso di Linguistica Generale
di F. de Saussure. Per riprendere le parole di Jakobson, ricordate da De Mauro in una nota al
Cours, Saussure è il grande rivelatore delle antinomie linguistiche, relazioni antinomiche
costitutive dell’oggetto lingua: la lingua come fatto individuale e sociale, di cui non si può
concepire l’uno senza l’altro; il suono come unità acustico- vocale (legame tra percezione e
produzione sonora) e fisiologico- mentale. L’antinomia più importante e preziosa dal mio
punto di vista è il rapporto, nella lingua, tra stabilità e mutamento, il riconoscimento di una
contraddizione immanente, non apposta o attribuita estrinsecamente dal linguista ma
emergente come relazione costitutiva dei fenomeni linguistici. La lingua è un sistema stabile e
al contempo si trasforma. Il riconoscimento di tale rapporto nella lingua è un passo
fondamentale verso il riconoscimento dell’organicità dei fenomeni linguistici, del loro “essere
in vita”. «Il fatto che il segno sfugga sempre in qualche misura alla volontà individuale e
sociale, questo è il suo carattere essenziale»2. È un’affermazione che contiene un’intuizione
potente: il riconoscimento che la lingua possiede una vita autonoma indipendente dai singoli
individui a cui tuttavia è legata in senso immanente. La lingua come forma “in vita” è
automovimento, autotrasformazione e autosviluppo.
De Mauro è bravo a fare chiarezza, a distinguere il pensiero di Saussure dalle aggiunte e
interpolazioni degli editori, ad affrontare la questione delle interpretazioni, gli equivoci e le
incomprensioni, le radici delle polemiche e delle accuse tradizionalmente rivoltegli. Vi è un
punto in cui tuttavia Saussure mi sembra avere una maggiore “responsabilità” epistemologica
e metodologica. Egli riconosce come carattere universale dei sistemi linguistici insieme la
mutabilità e immutabilità del segno, ed è emblematica in tal senso la nota che gli editori
sentono di dover apporre a questa affermazione per rassicurare il lettore che l’autore non è
impazzito dichiarando che la lingua è stabile e cambia continuamente. Saussure afferma
infatti che il principio di alterazione si fonda sul principio di continuità: riconosce cioè un tipo
di rapporto dialettico, immanente, intrinseco, tra stabilità e mutamento. Questo è un lascito e
2 F. de Saussure, Corso di linguistica generale, Laterza, 1967, p. 27.
3
una consapevolezza enorme. Tuttavia, subito dopo, troviamo la distinzione netta e ben
definita tra linguistica sincronica e linguistica diacronica. De Mauro precisa che nella
prospettiva di Saussure le due linguistiche si nutrono reciprocamente, che la linguistica statica
trarrà grande giovamento dagli studi storici (in diacronia).
A me sembra che il problema non sia nella distinzione, che può certo avere un carattere
dialettico (anche se così non è stato in seguito), tra linguistica statica e linguistica evolutiva,
quanto piuttosto nella definizione che Saussure delinea di asse della sincronia e di asse della
diacronia: tale definizione, più volte formulata, mostra la difficoltà a tenere insieme i due
piani precedentemente riconosciuti, e la scelta di separarli assegnandoli a due linguistiche
distinte. L’asse della simultaneità si riferisce ai rapporti tra cose coesistenti senza alcun
intervento del tempo (ovvero senza alterazione, si parla di stato assoluto nelle pagine
sull’identità sincronica); l’asse delle successioni studia le stesse cose nei loro cambiamenti. È
sincronico tutto ciò che si riferisce all’aspetto statico, è diacronico tutto ciò che si riferisce
alle evoluzioni. Saussure, una volta riconosciuta la dialettica stabilità- mutamento come
costitutiva della lingua, attribuisce l’uno dei due lati alla linguistica sincronica, l’altro alla
linguistica diacronica: non mantiene cioè la contraddizione all’interno di ciascun punto di
vista che pure può essere distinto. Il problema allora non è nella distinzione tra linguistica
diacronica e linguistica sincronica, ma nel fatto che il punto di vista sincronico e quello
diacronico non tengono la relazione antinomica precedentemente riconosciuta all’oggetto
lingua, per la quale è stata affermata la relazione interna e coesistente tra stabilità e
mutamento, ma tale relazione è successivamente scomposta nei suoi termini, e i due lati, di
cui si è affermata la presupposizione reciproca, sono di fatto separati.
L’asse sincronico, il punto di vista che guarda ai rapporti tra cose facenti parte dello stesso
contesto, coesistenti, vuole descrivere uno stato di lingua, non le sue trasformazioni. Uno
stato di lingua è sempre una lingua come forma, cioè come sistema di valori; ma se abbiamo
riconosciuto che uno stato di lingua è sempre frutto di trasformazioni e di stati precedenti,
cioè che ha in sé, in quanto stato, la realtà del mutamento e, reciprocamente, che l’alterazione
si fonda sulla continuità, allora non è possibile non tener conto di questa natura antinomica
dell’oggetto lingua a livello metodologico. Entrambe le prospettive di fatto poi fanno i conti
con i due lati dell’oggetto: lo studio sincronico incontra le variazioni e i mutamenti anche
all’interno di contesti ben definiti nello spazio e nel tempo, e allo stesso modo lo studio
diacronico si imbatte in elementi di continuità e permanenza mentre indaga le differenze tra
4
gli stati di lingua e le trasformazioni. Dunque, alla base di quello che abbiamo chiamato
“limite” da trasformare c’è una definizione insufficiente e unilaterale del punto di vista
sincronico e diacronico, una rappresentazione che non riesce a tenere, differenziandosi, la
contraddizione precedentemente riconosciuta all’oggetto lingua. Si potrebbe riformulare così:
l’asse della sincronia definisce un contesto spazio- temporale e indaga le relazioni tra elementi,
livelli e dimensioni costitutive di uno stato di lingua. È la stessa indagine sincronica che fa
emergere le relazioni diacroniche, di analogie e differenze, che lo stato di lingua e il contesto
osservato intrattiene con altri stati e contesti della storia umana. In verità lo sguardo
diacronico, che osserva l’oggetto di una indagine scientifica attraverso il tempo, come il
termine ci suggerisce, è tanto più profondo ed esteso quanto più ha consapevolezza della
identità di uno stato di lingua e di un contesto particolare (e di più stati di lingua e contesti) e
dunque del livello sincronico. La ricerca diacronica riesce a seguire e a comprendere
l’evoluzione degli stati di lingua (e i rapporti tra stati diversi) nella misura in cui ha una
conoscenza sincronica, ovvero ha coscienza della stabilità, della particolare identità formale
del sistema e dei sistemi di valori che sta indagando.
«L’entità linguistica non esiste che per l’associazione del significante e del significato;
appena si considera uno solo di questi elementi, essa svanisce; invece di un oggetto concreto
ci si trova dinnanzi a una pura astrazione. […] Una sequenza di suoni è linguistica solo se è il
supporto di un’idea. […] Si è spesso confrontata questa unità a due facce con l’unità della
persona umana composta da corpo e anima. Il raccostamento è poco soddisfacente»3.
Ha ragione Saussure a dire che l’accostamento tra il segno linguistico e l’essere umano è
un paragone poco soddisfacente. È la lingua come forma, non le singole entità linguistiche,
che può essere accostata all’essere umano, un organismo vivente ma ben più complesso
dell’organismo vegetale (la complessità a che fare col maggior grado di libertà). Il
riconoscimento dell’arbitrarietà del segno, cioè della storicità e della socialità delle lingue (per
cui tra le facce dei segni linguistici non vi è un legame predeterminato), è un passo
fondamentale che supera irreversibilmente una concezione della lingua come nomenclatura, la
quale presuppone le cose della realtà già date nella loro determinatezza e differenza, un
mondo già ripartito - e dunque conosciuto - a cui assegnare delle etichette. Saussure critica
una linguistica che guarda alla lingua come un naturalista guarderebbe allo sviluppo di un
vegetale. Il livello delle leggi di tipo deterministico- causale, pur presente nella lingua, non la
3 F. de Saussure, Corso di linguistica generale, cit., p. 125-126.
5
esaurisce perché non tiene conto dell’esser soggetto dell’oggetto considerato, ossia del suo
essere in vita; una vita dialettica è una vita complessa, che si muove tra il dato e il non dato, il
limite e la libertà, la finitezza e l’infinità, la stabilità e il mutamento; non una somma o
giustapposizione di parti, piuttosto una tessitura organica che si autogenera e si autotrasforma.
Pensando a un appello d’esame si potrebbero fare le seguenti associazioni: la relazione con
gli studenti, la tensione etica, la trasmissione dell’esperienza di conoscenza, il confronto
interumano, l’osservazione e la ricerca dal vivo. Invece: i cavilli amministrativo- burocratici,
la tensione nervosa, la fretta e l’approssimazione, i docenti alle prese con l’ennesima riforma
burocratica, gli studenti che discutono dei problemi con la documentazione, delle tasse, delle
scadenze, dei verbali, delle segreterie. Un ingenuo potrebbe pensare che tra i corridoi si
commenti e si faccia un’analisi critica della lezione seguita, del testo studiato, o ci si scambi
informazioni bibliografiche, materiale didattico; o che si parli di ciò che accade nel mondo.
Nella realtà dei corridoi, degli spazi e dei tempi universitari, l’oggetto del discorrere sono
troppo spesso i problemi burocratici, le file agli sportelli, il numero dei crediti mancanti.
Energie materiali e psicofisiche spese a discutere, sperimentare e crucciarsi di un vano vuoto e
atrofizzante nulla. La macchina universitaria fagocita le sue unità concrete. I processi che
generano i danni più gravi oggi sono discreti, trasversali, subdoli, perché la loro forza è di
agire silenziosamente nella lunga durata. L’impotenza di quanti assistono senza riuscire a
immaginare una via d’uscita si comprende pensando che le strutture di organizzazione del
reale, nelle quali e per le quali hanno vissuto, si sono inesorabilmente “consumate” e ciò è
accaduto in un tempo brevissimo se confrontato con altre epoche della storia umana, quando
mutamenti e trasformazioni radicali avvenivano in tempi lunghi o lunghissimi. Le strutture e i
sistemi istituzionali hanno consumato la propria esistenza storico- reale: non sorgono
dall’esperienza vivente di un popolo storico, sono diventate entità positive, istituzionalizzate,
prive del legame immanente con la matrice - l’agire di tutti e di ciascuno - che le genera in un
processualità circolare; una struttura morta può continuare ad essere ed esistere, come un
cadavere tenuto in vita. Il negativo, la lacerazione, la scissione, la morte di ciò che deve
morire, la distruzione e il cessare è indispensabile alla vita stessa. La decadenza, la nostra
decadenza, è indifferenza, stasi, ristagno, immobilità, rigidità, ripetitività, sterilità,
cronicizzazione degli atteggiamenti esistenziali, ipostatizzazione dei paradigmi epistemologici
e metodologici, persistenza di anacronismi, intellettualismi e ideologismi, così estranea a ciò
che per l’umano in se per sé ha senso, eppure così determinante e orientante nella nostra
quotidianità esperienziale.
6
Ma adesso stiamo andando lontano e il nostro studente vuole tornare ai testi. Il libro del
Prof. lo aveva sorpreso assai e non poté che accogliere con un certo stupore il grido di rivolta
nei confronti delle arretratezze teoriche e operative di una scienza - la linguistica - dominata
dai paradigmi strutturalista, generativo e cognitivo. I supporti informatici hanno modificato la
capacità di osservare i fenomeni linguistici e hanno messo a disposizione nuovi dati che,
assieme alle riflessioni scientifiche svoltesi in vari ambiti disciplinari, mostrano “i piedi di
argilla” di teorie, metodologie e paradigmi su cui si basa la ricerca e la trasmissione del
sapere. Ma tali paradigmi permangono, tra cui quello segmentale in linguistica. Quando
l’autore fa riferimento alla consapevolezza del ruolo del contesto nel funzionamento della
lingua, lo studente torna con la mente al saggio sul metodo che ha scritto un anno fa e che
inizia così:
«La consapevolezza dell'importanza di contestualizzare l'oggetto di una indagine scientifica,
facendo riferimento alla realtà in cui è immerso, è uno dei pilastri concettuali del pensiero
critico moderno. In altre parole, il riconoscimento della storicità e della spazialità dei
fenomeni umani diventa un principio epistemologico fondamentale. La contestualizzazione
sostanzialmente individua e pone relazioni: è una tessitura di elementi, livelli e dimensioni
costitutive».
Due cose qui: il riconoscimento dell’importanza del contesto e la concezione del contesto
come una tessitura. Il senso della “tessitura” - riferito non solo al significante fonico - ritorna
nel libro del prof. con l’immagine del “volto fonico”. Al tempo in cui scrisse il saggio, il
nostro studente non aveva ancora letto i testi d’esame ma aveva già usato i termini sincronico
e diacronico in un modo, come poi si era accorto, sensibilmente diverso dal senso che
emergeva dalle pagine del Corso di Linguistica Generale; proprio questa differenza - tra il
suo impiego del termine e quello del maestro francese - lo aveva aiutato a capire come il nodo
cruciale della questione saussuriana non fosse nella distinzione o nell’opposizione tra
linguistica sincronica e linguistica diacronica, ma nel modo di intendere, nella
concezione/idea/rappresentazione/ dello stato sincronico e di quello diacronico: tale
rappresentazione non teneva entro se stessa la contraddizione precedentemente riconosciuta.
Non si può dire che la dialettica sia tra i concetti meglio compresi dagli studiosi moderni.
Ne è prova emblematica la trasmissione e l’apprendimento della dialettica hegeliana come
tesi, antitesi e sintesi. Potremmo chiederci da dove provenga la rappresentazione
(Darstellung) della dialettica presentata nello schemino tesi, antitesi e sintesi, diffuso nella
vulgata accademica e scolastica a tutti i livelli, ma questo non è il luogo per farlo.
7
Generalmente si pensa alla contraddizione dialettica come all’opposizione tra due termini,
mentre il punto cruciale è riuscire a pensare alla dialettica come a una opposizione immanente
a ciascun termine, e riuscire a tenerla, a “sopportarla”. Se la pensiamo in tal modo, allora
capiamo perché il riconoscimento è tra termini che sono in se stessi una differenza interna.
L’intelletto, incapace di tenere la contraddizione, separa i due lati e li concepisce come
opposizioni esterne, estrinseche, poste. Per lo stesso concetto diciamo che, se ci fosse, il
numero della relazione dialettica non sarebbe il tre (la triade sintetica) ma il quattro, perché i
due termini in relazione sono ciascuno ineguale a se stesso. Ciò non avviene nell’etere puro
del pensiero ma si dà in un contesto di realtà. Il riconoscimento è un atto e, come
apprendiamo anche da Bühler: «[…] l’attività, qualunque ne sia la definizione scientifica, è un
concetto storico e non può essere altro neppure in psicologia. Ogni attività è tale in un dato
campo: già anni fa lo definii campo d’azione. […] Ogni attività umana possiede ciò che in un
senso specifico della parola si può definire la sua storia dell’atto (Aktgeschichte)»4. Il campo
di azione è ineliminabile per comprendere e tenere la relazione dialettica. Tornando al saggio
sul metodo scritto dal nostro studente leggiamo:
«Lo sguardo della modernità, che ambisce alla profondità e all'estensione, ritiene altrettanto
necessario confrontarsi con il livello diacronico dei fenomeni umani che ne rivela il carattere
processuale: osservare e comparare l'oggetto di indagine in rapporto ad altre realtà che
attraversano la storia umana. Il contesto spazio-temporale di riferimento, l'operare della
memoria e dell'oblio sono alla base di una identità, di una particolare verità storico-
esistenziale e del suo manifestarsi a livello fenomenologico».
Nel suo libro il prof. si chiede se l’opinione su cui poggia il paradigma segmentale sia
frutto di una proprietà della lingua in sé o di una rappresentazione esterna che a un certo punto
è stata data alla lingua: sta sollevando una questione cruciale per tutte le discipline del sapere,
a cui fa riferimento anche Bühler quando afferma la necessità di una disamina critica dei
concetti con cui opera il linguista e di una comparazione tra questi concetti e quelli degli altri
ambiti disciplinari. L’invito di Bühler viene accolto: il paradigma segmentale è sottoposto ad
una ferrea disamina critica e se ne discutono i fondamenti – per prima cosa la nozione di
fonema - alla luce dell’osservazione fenomenologica della realtà linguistica. Parlando dello
strutturalismo si ricorda che la scissione e la separazione tra langue e parole proviene da una
interpretazione riduttiva del pensiero di F. de Saussure che conduce a una «ipostatizzazione
dell’idea di struttura» e fa passare lo strutturalismo da «metodologico a ontologico». Il nostro
4 K. Bühler, Teoria del linguaggio,cit., 1/I principi della ricerca linguistica, p.108.
8
studente all’inizio ha già messo in luce indirettamente come l’inadeguatezza nel modo di
intendere il rapporto tra langue e parole sia legata a una debolezza anche teorica. Non basta
infatti dire che la gerarchia va intesa in senso metodologico, che è una gerarchia di punti di
vista e non di cose, perché in verità il rapporto tra le cose (gli oggetti) e i punti di vista (i
soggetti) è un rapporto dialettico e la posizione epistemologica è immanente alla posizione
metodologica. Saussure, nell’esplicitare le antinomie linguistiche e nell’affermare che il
principio di alterazione (mutamento) si fonda sul principio di continuità (stabilità), riconosce
una relazione dialettica tra stabilità e mutamento immanente alla lingua ma non riesce a
“tenere” la contraddizione, perché a uno stato di lingua (a un sistema) attribuisce solo
l’aspetto statico (l’identità), all’altro (alla parole, l’atto fonico e significazionale) solo
l’evoluzione (differenza). Dopo aver riconosciuto continuità e discontinuità alla lingua egli
separa questi lati assegnandoli a due linguistiche distinte, mentre in una relazione dialettica i
due poli dovrebbero assumere, ciascuno in se stesso, entrambi i lati della relazione.
Ritorniamo al nostro studente che lasciando il corridoio di facoltà ripensa all’esame che
non ha sostenuto questa mattina. Se avesse effettuato la prenotazione per tempo avrebbe avuto
la possibilità, come gli altri, di confrontarsi con il docente sui concetti che aveva elaborato.
Quando torna a casa inizia a scrivere. La scrittura è in realtà una riscrittura esperienziale, un
atto di rielaborazione di ciò che ha vissuto; è per ricreare uno spazio e un luogo di
contatto/scambio esperienziale, negato alla realtà del contesto interumano, ricreato dalla realtà
del testo scritto. E in ciò trasforma il limite, il negativo, lo riscrive in un altro contesto, può
distanziarsene e osservarlo da fuori, oggettivizzare, rappresentare, scomporre, individuare, e
tornare all’intero. «Il vero è l’intero. Ma l’intero è soltanto l’essenza che si completa mediante
il suo sviluppo. […] proprio in ciò consiste la sua natura, nell’essere effettualità, soggetto o
divenir- se- stesso»5.
In verità Professore, mi piacerebbe discorrere con Lei ancora su altri temi e questioni
aperte, ma per questa volta credo sia abbastanza. Prima di congedarmi devo aggiungere
qualcosa. Dopo il Suo rifiuto di farmi sostenere l’esame mi recai nuovamente al s.o.r.t dove la
mia interlocutrice, assicurando che non sussistevano problemi o impedimenti “tecnici”, mi
esortò a protestare per la decisione che Lei aveva preso. Il Suo volto quella mattina, quando
arrivò in Facoltà, era teso, quasi adirato o nervoso, cupo, accigliato, stanco forse, crucciato.
Se avessi protestato nella maniera tradizionale probabilmente non sarebbe servito a nulla.
Nella nostra realtà esperienziale opera continuamente, anche se per lo più inconsapevolmente,
5 G. W. F. Hegel, Fenomenologia, cit., Prefazione, p.15.
9
il fenomeno della proiezione all’esterno di contenuti immaginativi interni (rappresentazioni);
si può ipotizzare che la decisione di non farmi sostenere l’esame sia, almeno in parte, frutto
dell’aver proiettato a priori l’indolenza, la superficialità e la noncuranza del sistema-
università e dei suoi soggetti su una delle sue unità particolari, il cui atteggiamento (non aver
effettuato la prenotazione) diventa oggetto di disapprovazione anche se il vero bersaglio
polemico è più in generale l’attuale modo di essere del sistema- università e dei suoi soggetti-
attori. Ciascuna delle parti che costituisce un intero è tuttavia essa stessa un’interezza, e in tal
modo deve essere considerata. I limiti dello strutturalismo (in parte già impliciti in alcuni
assunti saussuriani) hanno radici più profonde che si intrecciano al problema delle
interpretazioni fossilizzate della dialettica hegeliana che ne tramandano una rappresentazione
distorta, semplificata, riduttiva, parziale e perversa (capovolta). Un punto su cui mi
piacerebbe un confronto è il tema dei dialoghi interdisciplinari. Credo che le ragioni per cui
una relazione interdisciplinare autentica ed efficace non riesca ad essere agita vadano
ricercate nell’assenza di una campo fisico e concettuale (un campo di attività: Feld, ogni
attività è tale in un dato campo di azione o contesto) in grado di accoglierla, sostenerla,
orientarla. Il campo concettuale/ contesto, capace di tenere una relazione interna al sapere
tanto complessa e articolata, tale da creare una tessitura esperienziale che restituisca alla
scienza la sua interezza - e ciò condurrebbe anche alla riscrittura del legame tra il sapere e la
realtà - è la contraddizione dialettica. Ma non possiamo dare per scontato di intenderci sulla
dialettica perché, nonostante il concetto sia stato già dato e possa essere considerato presente
alla coscienza, persiste, accanto a un modo di essere del pensiero che possiamo chiamare
intellettualistico (di cui il paradigma segmentale è espressione), una rappresentazione triadica,
semplificata, banalizzata, distorta e stravolta della dialettica stessa, che attende una seria
chiarificazione dei concetti e un ritorno ai testi nella loro interezza e complessità. La
Fenomenologia dello spirito è il testo per eccellenza sul quale non si potrebbero applicare i
“metodi di lettura veloce”, perché anche i dettagli, le scansioni, le pause, le particelle come i
“ma” sono di vitale importanza. E, soprattutto, una lettura veloce non è sostenibile dal
pensiero, almeno all’inizio. Comprendere i passaggi e lo svolgersi del discorso significa
tenere insieme diversi piani e livelli che non possono essere lasciati quando si passa ai
successivi, e ciò richiede un certo esercizio perché è una forma mentis a cui non siamo
abituati: la scansione e lo sviluppo lineare, causale e consequenziale informa il nostro modo
di organizzare il pensiero e le nostre rappresentazioni, perciò all’inizio non bisognerebbe
avere fretta e gustare pian piano ciò che si schiude alla coscienza. Mi sono resa conto che il
ritmo, le scansioni e le pause interne, fondamentali per comprendere concettualmente il testo,
10
sono favorite da una lettura “a voce”, una lettura non interiore o soltanto “mentale”, ma che
dia voce prosodico- corporea alle parole e ai concetti. Un racconto che “mette in scena”
l’esperienza della coscienza. Nell’attesa di un inizio di dialogo - di un gesto -
cordiali saluti
M. A.
Roma, 17 Giugno 2010
Gentile Professor L.,
alla fine il momento dell’esame è giunto per il nostro studente; il Professore lo ha valutato
positivamente, con il massimo dei voti, e si è persino rammaricato di non aver ricevuto (o
letto) lo scritto inviatogli dopo l’esame mancato (v. sopra). L’iter burocratico della
prenotazione questa volta non ha subito intoppi, e tuttavia un imprevisto, indipendente dalla
sua volontà, lo ha fatto arrivare in ritardo all’appello. Dopo la prima esitazione il Professore,
sentendo i titoli dei testi d’esame, accetta. - Le devo confessare, dirà alla fine - che ero partito
con un pregiudizio: mi sembrava, dal suo modo di porsi *, che non ci sarebbe stato nulla di
buono in questo esame. E invece è stato il migliore di questa sessione -.
Dopo il confronto dal vivo dell’esame è giunto il momento per lo studente di valutare il
docente nel suo stile di contatto che modula la relazione col mondo. Anche questa volta,
tornando a casa, si trova a riscrivere l’esperienza e le rappresentazioni che sorgono dentro di
sé. Volendo essere schiettamente sincera, professore, io non sono rimasta affatto soddisfatta
del Suo esame: sono rimasta molto delusa. In un certo senso la “colpa” è del mio limite di
sopravvalutare l’oggetto, di idealizzarlo proiettandovi contenuti immaginativi interni. Per
fortuna però la rappresentazione idealizzata non si cronicizza, non si incapsula in uno schema
percettivo: è capace di riscriversi perché lascia sussistere l’oggetto, lascia che esso manifesti
la propria realtà/verità. È quello che farò adesso: riscrivere le rappresentazioni esperienziali.
La prima è l’idea che avevo di Lei come docente; dopo la delusione devo fare i conti con
elementi che non mi aspettavo di trovare e che contrastano incredibilmente con certe posizioni
assunte “teoricamente”. Ma prima chiedo a me stessa se è possibile essere completamente
11
sinceri senza ferire l’altro, senza offendere il suo amor proprio, continuando sempre e
comunque a rispettarlo come essere umano. Rispondo che sì certo è possibile, ma non è detto
che io sia già in grado di farlo adeguatamente. E per questo me ne dispiace.
Possiamo iniziare con un certo schematismo6 da contatto, un modulo/pattern assunto
nell’esperienza di confronto interumano a cui è legata una certa rigidità del pensiero e la
difficoltà di seguire un discorso esteso e complesso - che è stato ogni volta sistematicamente
interrotto -. Una sua affermazione iniziale è significativa al riguardo: - Dando per assodato
che siamo d’accordo sull’idea del parlato come “volto fonico”, altrimenti non sarebbe qui a
fare l’esame, mi piacerebbe sapere … -. Mi chiedo: davvero è stato così sfortunato nella sua
carriera universitaria da incontrare solo studenti in accordo con le sue posizioni teoriche? Ma
Lei non dovrebbe già sapere che ciascuno di noi può imparare e conoscere tanto (della propria
scienza e del mondo) confrontandosi con una critica ragionata, argomentata, esposta, che
parte da una conoscenza non superficiale della materia su cui riflette? E non sa forse anche
già che il vero, grave e decadente problema, tanto nel sapere quanto nella realtà, non è
l’opporsi, il criticare, il mettere in discussione, il negare, quanto la piatta adesione, la
ripetitività delle formule e delle rappresentazioni trasmesse, la chiusura dei sistemi, la
cronicizzazione e l’ipostatizzazione dei paradigmi conoscitivi? Ma come Professore, non
aveva affermato anche questo nel suo libro? E quanto sia importante invece mettere in moto il
pensiero, rendere fluide le categorie, smuovere dal torpore, dall’abitudine che è come una
seconda natura? Questo aspetto mi riporta purtroppo e per fortuna (la fortuna sta nel fatto che
si aggiungono altri esempi concreti tratti dell’esperienza a cui far riferimento) a una delle
scissioni più care alla coscienza moderna, presentatasi più volte alla mia riflessione: quella tra
consapevolezza ed effettualità, tra il sapere una cosa “in teoria” e il metterla in pratica,
renderla effettuale come modulo esperienziale concreto che agisce nella relazione col mondo;
la scissione tra immaginazione/pensiero e azione. Il suo grido di rivolta nei confronti delle
arretratezza teoriche e metodologiche della linguistica mi aveva fatto immaginare un
atteggiamento altrettanto aperto nel confronto interumano dell’esame. E invece non solo era
pieno di schematismi e pregiudizi, ma non è stato capace di ascoltare ciò che volevo
comunicare e, nonostante abbia valutato con il massimo dei voti la mia esposizione, essa
veniva significativamente interrotta prima che potesse arrivare al cuore del discorso. Ciò è
evidentemente segno di una certa difficoltà a stare in contatto con l’alterità e a lasciarla
6
Per schematismo intendo un modulo esperienziale meccanico, rigido, ipercodificato che orienta
l’esperienza subordinandola al proprio modo di essere, non la riconosce nella sua autonomia e
indipendenza. Lo schematismo è un pregiudizio che diventa un modo di porsi compatto, una posizione
esistenziale che si autodifende saldamente e ignora la mobilità del punto di vista.
12
sussistere. Anche questo è profondamente incoerente con la posizione teorica, in linguistica,
che afferma la necessità di lasciar sussistere l’oggetto evitando le due derive metafisiche: che
la realtà si dia senza alcun intervento del soggetto e che sia il soggetto a creare a proprio
piacimento il mondo.
Penso che Lei sia stato anche ingannato da un pregiudizio, per così dire, estetico ... ma
questo non è grave e davvero comprensibile per tempi, i nostri, che non brillano certo per
l’ideale della kalokagathia.
In conclusione Professore, ho inteso focalizzare l’attenzione su un modo di porsi del
soggetto, un esserci (da- sein) o posizione storico- esistenziale nei confronti dell’alterità
esterna e interna. La trasmissione della conoscenza necessità di una virtù altrettanto
importante della preparazione professionale e della competenza nella materia, la cui assenza è
forse più grave di qualsiasi deficit epistemico: la capacità di spostare il punto di vista e
mettersi al posto dell’altro rimanendo se stessi. Una contraddizione che dobbiamo imparare a
sopportare.
Cordiali saluti
Marianna Adilardi