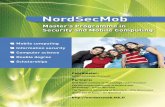Il nuovo mondo e l’altro. Augusta 1504. La prima edizione della lettera sul Mundus novus di...
Transcript of Il nuovo mondo e l’altro. Augusta 1504. La prima edizione della lettera sul Mundus novus di...
Nel 1504, una notizia incredibile si diffuse da Au-gusta per tutta l’Europa. Il tipografo Jean Otmar ave-va appena pubblicato una lettera intitolata Mundus No-vus, stampata su otto pagine di un quaderno in quar-to. Indirizzate a «Laurentio Petri de Medicis» da uncerto «Albericus Vespucius», quelle pagine annuncia-vano che, grazie a una esplorazione navale promossa dalre del Portogallo, erano appena stati scoperti territori«che a buon diritto possono definirsi Nuovo Mondo»:un continente fino ad allora sconosciuto, situato al dilà dell’equatore e densamente popolato. Quell’annun-cio smentiva gran parte delle tesi cosmografiche ere-ditate dall’Antichità, trasmesse dal Medioevo cristia-no e ancora vigenti in quei tempi nuovi: l’ecumene nonpoteva più considerarsi limitata ai tre continenti co-nosciuti e gli antipodi apparivano tutt’altro che disa-bitati.
Il testo sottolinea l’assoluta novità di una scopertatale da rimettere in discussione intere biblioteche del sa-pere occidentale. Contrariamente a quanto riportavanole notizie che si andavano diffondendo da una decina dianni attraverso le lettere di Colombo (soprattutto la tra-duzione in latino della sua Carta a Santángel), nel Mun-dus Novus l’autore sosteneva di aver raggiunto per la pri-ma volta terre che non erano né nuove isole né – al con-trario di quanto credeva fermamente il navigatore ge-novese – l’estremità continentale del Sudest asiatico.Assicurando che «piacque all’Altissimo di mostrarci unnuovo continente e le nuove contrade di un mondo sco-nosciuto», l’autore suggeriva che quella terraferma e le«Indie» non erano affatto contigue. Inoltre, in quel nuo-vo mondo si ravvisava qualcosa di ben altra portata cheun semplice continente: un intero universo del tutto op-posto a ciò che gli uomini avevano conosciuto fino adallora. La novità non era solo geografica e fisica, ma an-che antropologica, zoologica e botanica. L’opuscolo stam-pato ad Augusta, dunque, non può essere consideratocome un mero resoconto di viaggio; piuttosto, si trattadi una sorta di relazione con lo scopo di trasmettere unnuovo sapere circa terre, cieli, esseri umani e ambientinaturali fino ad allora sconosciuti.
Una lunga sezione del Mundus Novus, infatti, è dedi-cata alle «innumerevoli genti e popoli e a ogni specie dianimali selvatici che non esistono nelle nostre terre».Animati da un’attitudine fraterna nei confronti dei nuo-vi arrivati, gli abitanti di quei luoghi vivono nudi e sot-topongono il loro corpo a pratiche bizzarre, come la per-forazione di parti del viso, adornate con pietre prezio-se, o la dilatazione dei propri organi genitali. Poiché que-sta gente non dispone né di possedimenti propri, né digoverno, né di leggi e neppure di un coniuge stabile, nel-la lettera l’organizzazione sociale, politica, economica ereligiosa della collettività è rappresentata al negativo:tradotta in termini moderni, viene descritta come unasocietà a un tempo comunistica e anarchica, nella qualele relazioni di parentela sembrano riassumersi in poli-gamia e incesto, cioè il negativo perfetto delle comuni-tà europee del xvi secolo. Tuttavia, l’autore si azzardaa render conto di quegli uomini avvalendosi di catego-rie classiche: «Che dire ancora? Vivono secondo natu-ra e possono essere definiti epicurei piuttosto che stoi-ci» (epycuri potius dici possunt quam stoici). L’uso di ter-mini dotti in un contesto descrittivo sorprende, e lasciatrapelare l’intenzione di rendere assimilabili quelle stra-ne culture al patrimonio culturale dei lettori del vecchiomondo.
Tra le usanze di quei popoli, una in particolare sa-rebbe potuta risultare intollerabile: il cannibalismo, cheper di più si prestava a colorite esagerazioni, come nelcaso della testimonianza di un uomo che avrebbe man-giato più di trecento persone. Non è tanto la crudeltà diuna simile pratica a essere sottolineata, quanto il fattoche sia una consuetudine associata alla guerra; e a stu-pirsi maggiormente sono gli ospiti indigeni, sorpresi dalfatto che i propri visitatori non usino mangiare i nemi-ci. È significativo come dalla descrizione non trapeli al-cun giudizio dell’autore: l’antropofagia è presentata intermini neutri e l’orrore traspare solo attraverso l’im-magine della carne umana appesa, salata e seccata, «co-m’è usanza da noi appendere il lardo e la carne di maia-le». Quindi, non è tanto l’antropofagia che spinge a de-scrivere questi uomini come «simili alle bestie» o dalle
Augusta, 1504
Il nuovo mondo e l’altro
il tipografo jean otmar pubblica la prima edizione della lettera sulmundus novus di amerigo vespucci. riconoscere la realtà, o una co-smografia pratica. vespucci mercante, geografo e antropologo. luo-ghi esotici attraverso la lente di luoghi comuni. descrivere l’inde-scrivibile
92_Descendre.qxp 29-07-2010 14:23 Pagina 679
«abitudini perverse», ma il fatto che combattano nudi.In compenso, il gusto per il pittoresco porta l’autore adaccostare il tema del cannibalismo a quello della nuditàe della sessualità femminile, non senza qualche dettagliopiccante: la straordinaria compattezza del seno delledonne, la perfezione di ogni parte del loro corpo (e par-ticolarmente di quelle «che per cortesia evito di nomi-nare»), l’impudicizia e la sensualità di cui hanno datoprova quando si sono accoppiate con alcuni cristiani.
Dell’ambiente naturale è vantata l’eccezionale pu-rezza dell’aria, la fertilità della terra e l’abbondanza deisuoi frutti, il rigoglio della vegetazione, la presenza dioro e perle, l’infinito numero di uccelli di cui Plinio stes-so «non ha descritto nemmeno la millesima parte». Se-gue una sezione cosmografica in cui si illustrano diver-si schemi relativi alla configurazione delle stelle più vi-cine al polo antartico e alle rispettive posizioni dell’Eu-ropa e del nuovo mondo, i cui punti zenitali formano unangolo di novanta gradi. L’autore, infine, conclude conalcune notazioni autobiografiche: il viaggio di cui si ètrattato, si legge, costituisce la sua terza spedizione ver-so occidente, preceduta da altre due effettuate entram-be per conto della Spagna. Altri testi vengono menzio-nati: un diario di bordo in possesso del re del Portogal-lo e la redazione di un «libro di geografia o di cosmo-grafia» sulla base delle scoperte fatte, ancora allo stadiodi progetto. Un’ultima ma notevole precisazione mettein risalto il proposito scientifico di colui o coloro chehanno deciso di pubblicare la lettera. L’intero testo, siprecisa, è stato tradotto dall’originale italiano per curadi un misterioso iocundus interpres,
in modo che tutti coloro che conoscono il latino sappianoquante cose ammirevoli vengono scoperte in questo mo-mento, e che sia posto un freno all’audacia di quelli chevogliono esplorare il cielo e la maestà divina e così saperepiù di quanto non sia lecito, poiché, da quando esiste ilmondo, ignoriamo quanto sia vasta la terra e quanto essacontenga.
In queste parole è possibile leggere un appello ai dot-ti affinché scendano dall’insondabile cielo della metafi-sica alle terre della geografia, immense eppure scono-sciute, e abbandonino la sfera speculativa per le esattemisurazioni rese possibili dall’esperienza. Il riferimen-to all’ignoranza circa le vaste dimensioni della Terra co-stituisce di per sé una presa di posizione nel campo del-la cosmografia, in un’epoca in cui si immaginava il glo-bo molto più piccolo di quanto non sia in realtà.
La lettera ebbe un successo strepitoso. Nel giro didue anni, il Mundus Novus di Vespucci conobbe una dif-fusione considerevole per l’epoca, una dozzina di edi-zioni e quasi sempre senza colofone né luogo, né data,come a voler nascondere di aver copiato un testo già pub-blicato. Dopo l’edizione di Augusta nel 1504, usciranno
rapidamente quelle di Parigi e di Venezia; poi, nel 1505,è la volta di quelle di Rostock, Norimberga, Colonia,Roma, Strasburgo e Anversa. Infine, il testo venne nuo-vamente pubblicato da altri tre editori parigini nel 1506.
Nonostante la sua ampiezza, la prima diffusione del-la lettera fu dunque diretta a un pubblico specifico, ecomportò alcuni aspetti notevoli. Innanzitutto, mentrela scoperta potrebbe dare lustro alle nazioni che l’hannopromossa, tanto il Portogallo che la Spagna sembrano re-stare totalmente ai margini della divulgazione dell’ope-ra, nonostante i rispettivi sovrani si fossero impegnatisulle rotte transoceaniche. D’altronde, è comprensibileche entrambi i paesi, in competizione nella corsa all’ac-caparramento economico e politico sulle nuove rotte perle Indie, abbiano preferito il segreto alla pubblicità,adottando la prudenza consigliata da quella che i porto-ghesi chiamavano politica do sigilo. Nell’incertezza, si èritenuto per molto tempo che il luogo naturale per l’ap-parizione della princeps fosse stato Firenze, patria del-l’autore: ma oggi sappiamo che non fu così. Non solo: aFirenze, nessun torchio stampò la famosa lettera in la-tino; l’unico esemplare latino che alcuni attribuivano aFirenze è in realtà una ristampa dell’edizione di Augu-sta. Infine, la geografia editoriale del Mundus colpisceper la sua omogeneità: a eccezione di alcune capitali del-la stampa del tempo – Parigi, Venezia e Roma – l’es-senziale della diffusione del testo si concentra nell’areagermanica. Questo elemento, probabilmente, rivela unacircolazione in ambienti dotti, testimoniata peraltro dal-l’assenza di traduzioni in volgare per tutta la prima fa-se di diffusione; più in particolare, la lettera venne let-ta soprattutto nei circoli di geografi umanisti, allora giànumerosi nell’area germanofona. Sembrerebbe dunqueche la prima diffusione del testo abbia centrato il suoobiettivo dichiarato: incidere in modo decisivo sulla sto-ria del sapere cosmografico.
In seguito, l’interesse dei tedeschi per il Mundus No-vus venne confermato dal numero delle traduzioni nel-la loro lingua volgare: dodici edizioni tra il 1505 e il1508. Nel 1506-507 apparve una versione in fiammin-go, ma la divulgazione massiccia del testo si deve so-prattutto alla traduzione italiana del 1507, inserita inuna delle prime raccolte di relazioni di viaggi oceanici,Paesi novamente retrovati et Novo Mondo da Alberico Ve-sputio Florentino intitulato, pubblicata a Vicenza da Fra-canzio da Montalboddo. La diffusione della raccoltavenne arricchita da una sua traduzione in latino che siaggiunse alla prima versione di Augusta e fu a sua voltaritradotta in altre lingue volgari, soprattutto in france-se e in tedesco: a quel punto, lo scritto che il pubblicoeuropeo leggeva era passato da una lingua all’altra nonmeno di quattro volte! Per di più, il testo di Vespuccisi diffuse anche attraverso altri scritti. In opere geogra-fiche come il Novus Orbis regionum ac insularum veteri-
680 Augusta, 1504
92_Descendre.qxp 29-07-2010 14:23 Pagina 680
bus incognitarum di Simon Grynaeus e Johann Huttich(1532) o le Navigationi et viaggi di Giovanni Battista Ra-musio (1550-59), infatti, ci si imbatte in lunghe citazionidella lettera del navigatore e, talvolta, il testo viene ri-portato addirittura per intero. Questa diffusione capil-lare dunque spiega come mai molte caratteristiche tipi-che di Vespucci, come la sua retorica in negativo per de-scrivere una società primitiva o la pratica cannibalescaconnessa a quella della vendetta, si ritroveranno perfi-no nel celebre saggio di Montaigne Sui cannibali.
Grazie a una sessantina di edizioni comprese tra il1504 e il 1530 (contro le ventidue di Colombo), la let-tera quindi si impose come uno dei maggiori best-sellerdel Rinascimento. L’opera fu tanto influente da battez-zare con il proprio titolo il quarto continente (il toponi-mo Nuovo Mondo si impose nella lingua geografica del-l’epoca) e da fissare una buona parte degli stereotipi,spesso paradossali, che vennero attribuiti a quelle ter-re e ai loro abitanti: usanze bestiali e pratiche raffinate,calorosa accoglienza e atrocità del cannibalismo, nuditàe sessualità senza ritegni, indigenza della popolazione ericchezza aurifera del suolo, rigoglio della natura. In se-guito, una seconda lettera stampata a firma del mede-simo autore (ma questa volta col nome corretto) impo-se un altro nome al «nuovo» continente, proprio e de-finitivo: senza la Lettera di Amerigo Vespucci sulle isoletrovate in quattro suoi viaggi (detta anche Lettera al So-derini), l’«America» non avrebbe ereditato il nome diVespucci.
Nato nel 1454, Amerigo Vespucci apparteneva a unafamiglia che ricopriva cariche importanti a Firenze; ere-de della tradizione fiorentina che intrecciava culturamercantile e cultura scritta, Amerigo era stato istruitoda uno dei suoi zii, Giorgio Antonio Vespucci, noto uma-nista, vicino a Marsilio Ficino, traduttore di Platone eparticolarmente dedito agli studi geografici. Dal 1483,il giovane divenne «maestro di casa» e uomo di fiduciadel ricco banchiere e cugino del Magnifico, Lorenzo diPierfrancesco dei Medici. Costui si era lanciato nel com-mercio con la penisola iberica e aveva impiantato una fi-liale a Siviglia, affidandone la gestione a un altro fio-rentino, il mercante Giannotto Berardi. Quest’ultimo,dedito a diverse attività, tra cui spiccava la tratta deglischiavi, a partire dal 1491 si occupò soprattutto di con-sigliare e finanziare Cristoforo Colombo, assecondan-dolo nel suo progetto di raggiungere le Indie attraver-so la rotta occidentale. Indaffarato su più fronti, Berar-di aveva bisogno di un collaboratore per amministraregli affari di Lorenzo, e fu proprio con questo incaricoche Amerigo venne inviato a Siviglia durante l’inverno1491-92.
Assieme al concittadino di Firenze, allora Vespuccicollaborò ad allestire le prime flotte per Colombo. Neldicembre del 1495, morto Berardi, Amerigo rimase so-
lo a gestire l’azienda, e proprio in un momento critico:nel febbraio del 1496 quattro caravelle, finanziate e ar-mate dai due fiorentini per raggiungere l’Hispaniola, fe-cero naufragio poco dopo aver lasciato Sanlùcar de Bar-rameda. L’incidente trascinò l’azienda nel fallimento, eAmerigo dovette porre fine alla sua attività di mercan-te e armatore. Tuttavia, Vespucci scelse di non rientra-re in patria, dal momento che a Firenze la situazione eraradicalmente cambiata a causa delle guerre d’Italia e del-la caduta dei Medici: il suo protettore Lorenzo di Pier-francesco dapprima si era unito al nuovo regime repub-blicano (meritandosi il soprannome di «Popolano»), maben presto, quando Savonarola e i suoi partigiani pre-sero definitivamente il potere, si allontanò dalla città or-mai ostile. Quanto a Vespucci, archivi e documenti nonci hanno lasciato alcuna testimonianza sicura sulle sueattività tra il 1496 e il maggio del 1499, ma una cosa ècerta: sollevato a forza dalle sue abituali occupazioni,anche lui decise di prendere il largo.
Dei viaggi compiuti da Vespucci, solo quelli effet-tuati tra il 1499-1500 e il 1501-502 sono attestati concertezza dalle sue lettere famigliari. Il primo, intrapre-so per conto di Fernando d’Aragona e di Isabella di Ca-stiglia e posto sotto il comando di Alonso de Ojeda, por-tò Amerigo sulle coste settentrionali dell’America delSud, e in particolare nella stessa regione di Paria giàesplorata un anno prima da Colombo. Come il suo pre-decessore, il fiorentino trasse la conclusione che si trat-tava di un vero e proprio continente; tuttavia, contra-riamente al genovese che, fiducioso negli insegnamentidella Chiesa circa l’inesistenza degli antipodi, si ritene-va agente di un disegno provvidenziale, Vespucci nonidentificò quella terra col paradiso terrestre: più sem-plicemente, concluse che il tracciato dei limiti dell’Asiadoveva essere modificato in modo tale da potervi inte-grare le sue osservazioni, in forza del principio per cui«è certo che più vale la pratica che la teorica» (letteradel 18 luglio 1500). E per quanto anche lui facesse unaccenno al paradiso terrestre, si trattava soltanto di unasimilitudine topica, non certo di un’identificazione deiluoghi.
Il secondo viaggio attestato dalle lettere famigliariscritte nel 1501 e nel 1502 è quello immortalato nel Mun-dus Novus. Questa volta Vespucci si pose al servizio delPortogallo, su ingaggio del re Manuele I che aveva avu-to modo di apprezzarne l’ingegnosità in materia di co-smografia applicata alla navigazione. Infatti, se alloraera possibile calcolare con esattezza la latitudine, la de-terminazione della longitudine restava invece molto piùdifficile: un cruccio per i navigatori che si sforzavano di«fare il punto», cioè di valutare in modo empirico le di-stanze percorse. Ma proprio la valutazione della longi-tudine era diventata a quei tempi una esigenza geopo-litica decisiva, in conseguenza della spartizione tra le
Il nuovo mondo e l’altro 681
92_Descendre.qxp 29-07-2010 14:23 Pagina 681
due potenze iberiche delle terre recentemente scoperte(trattato di Tordesillas del 1494) che fissava come con-fine dei due nuovi imperi una raya situata a 370 leghe aovest delle isole di Capo Verde.
Nel 1500, i portoghesi erano venuti a sapere che Pe-dro Álvares Cabral, all’inizio della sua navigazione ver-so l’Oceano Indiano, aveva esplorato una nuova costaal di là dell’Oceano Atlantico posta tanto a sud da po-ter essere utilizzata come testa di ponte per le Indie; al-lora, si rese necessario esplorarla più a fondo per deter-minare se quelle terre si trovassero al di là o al di quadella raya, e cioè sotto la giurisdizione spagnola o sottoquella portoghese. Probabilmente, Manuele I coinvolseVespucci in considerazione del suo ultimo viaggio, du-rante il quale il navigatore aveva escogitato un calcoloastronomico delle longitudini basato sulla differenza diorario di una congiunzione astrale rispetto all’ora in cuigli almanacchi fissavano il verificarsi della medesimacongiunzione in Europa. Se Vespucci non ebbe mai unruolo di capitano simile a quello di Colombo – né vollemai rivendicarlo – tuttavia nella nuova spedizione del1501, composta di tre navi e destinata a esplorare le co-ste della «Terra da Vera Cruz» (il Brasile), assunse lafunzione non meno decisiva di «pilota».
La lettera che Vespucci inviò a Lorenzo il 4 luglio1501 venne scritta quando la flotta faceva l’ultimo sca-lo africano prima dell’ignoto, a Capo Verde, presso l’i-sola di Gorée; lì, il «pilota» e i suoi avevano sostato as-sieme all’equipaggio di altre due navi portoghesi redu-ci, dopo sedici mesi di navigazione, dalla lunga spedi-zione di Cabral nell’Oceano Indiano. L’essenziale dellalettera era dedicato a un minuzioso elenco, degno dei li-bri di ricordanze dei mercanti fiorentini, delle enormiricchezze che era possibile ricavare dai lunghi viaggi nel-le Indie. Con tali argomenti, Amerigo sembrava voles-se convincere i suoi concittadini a non interrompere gliinvestimenti nelle esplorazioni, per quanto il suo inte-resse personale fosse soprattutto di natura scientifica.Al fiorentino infatti la navigazione stava a cuore non perragioni mercantili, ma per la speranza di diventare fa-moso grazie alle promettenti scoperte cosmografiche:
per causa della detta longitudine, io ho perduti molti son-ni e ho abreviato la vita mia dieci anni; e tutto lo tengoper bene speso, perché spero venire in fama lungo secolo,se io torno con salute di questo.
Vespucci rientrò a Lisbona sano e salvo nel luglio del1502, dopo aver esplorato le coste del Brasile, soggior-nato presso gli indiani Tupì-Guaranì e aver navigato nel-le acque più meridionali fino ad allora mai solcate, es-sendosi spinto probabilmente fino al 50º parallelo. Fu al-lora che il navigatore redasse la terza delle lettere fami-gliari che ci sono giunte. Il racconto epistolare è similea quello del Mundus Novus anche se nella lettera, ancor
più che nella pubblicazione, prevale uno sguardo antro-pologico. Un atteggiamento poco comune per l’epoca,che si riflette nell’insistenza sul lungo «travaglio» indi-spensabile per capire l’Altro nel suo ambiente. «Moltotravagliai ad intendere loro vita e costumi, perché 27 dìmangiai e dormi’ infra loro»: Vespucci sembrava averdispiegato un vero e proprio sforzo di intendimento. Co-me in seguito nel Mundus Novus, anche nella lettera in-fatti la caratterizzazione in negativo del mondo socialemediante una retorica dell’assenza (assenza di religione,di proprietà, di frontiere ecc.) non ne implica lo svili-mento: la mancanza di re è giustificata dall’inutilità diqualsiasi forma di sottomissione politica in una societàin cui «ognuno è signore di sé»; allo stesso modo, l’as-senza di amministrazione giudiziaria non ha nulla di bar-barico poiché, al contrario, è resa possibile dall’inesi-stenza tra quelle genti di ogni forma di cupidigia.
Così, più che delineare il mito del buon selvaggio,Vespucci ragionava sulla base del patrimonio etico co-mune del tempo secondo il quale la cupidigia – l’avari-zia di dantesca memoria – era una delle prime cause dirottura del legame naturale che costituiva la comunità.E, tra le righe, l’assenza di cupidigia rendeva quella so-cietà più positiva di tante altre in cui una giustizia isti-tuzionalizzata si rendeva indispensabile per la convi-venza civile. Per quanto Vespucci sottolineasse la cru-deltà delle guerre, alle quali per di più era associato ilcannibalismo, le sue discussioni con gli abitanti lo por-tavano a cogliere la valenza strutturale di quelle violen-ze: necessari per cancellare le offese che i nemici aveva-no inflitto agli antenati, quei conflitti cruenti assolve-vano le funzioni della vendetta, istituto ben noto ancheai fiorentini.
Le tre lettere di viaggio, manoscritte, non lascianodubbi circa la loro autenticità (così come il FrammentoRidolfi, una lettera polemica e tecnica di grande inte-resse, pervenutaci incompleta); mentre più complesso ri-mane il caso dei testi a stampa, sebbene ormai non sipossa più sostenere che siano opera di spudorati falsari.Il Mundus Novus forse venne composto a Lisbona, nel-l’ambiente cosmopolita dei mercanti; e, nonostante l’as-senza di prove documentarie, lo iocundus interpres chelo tradusse può essere identificato con Giuliano del Gio-condo, un membro della comunità fiorentina locale. Giu-liano era legato alla famiglia dei Fugger, ricchi mercan-ti stabilitisi nella capitale portoghese per investire nellanuova rotta delle Indie, in accordo con gli italiani. For-se è proprio mediante l’intermediazione dei mercanti te-deschi presenti in Portogallo che il testo giunse ad Au-gusta e, ben presto, circolò ampiamente nei territori del-l’Impero.
Il secondo testo a stampa, la Lettera di Amerigo Ve-spucci sulle isole trovate in quattro suoi viaggi, è indiriz-zato al gonfaloniere di Firenze Piero Soderini (da cui il
682 Augusta, 1504
92_Descendre.qxp 29-07-2010 14:23 Pagina 682
titolo breve di Lettera al Soderini), un destinatario nonsorprendente dopo la morte, nel 1503, di Lorenzo diPierfrancesco dei Medici. Il gonfaloniere a vita della re-pubblica fiorentina, oltre a essere legato al Medici, dabambino era stato amico di Amerigo con il quale avevaseguito le lezioni di Giorgio Antonio Vespucci, e anchein seguito era rimasto appassionato di geografia. La let-tera in questione è più lunga delle altre giacché tratta diben quattro viaggi, ma le incoerenze del testo tradisco-no numerosi interventi apocrifi: si tratta dunque di unmontaggio effettuato a partire da fonti diverse, proba-bilmente lettere scomparse e diari di bordo. A un con-fronto con le lettere famigliari, tuttavia, la lingua appa-re autentica, e gli iberismi presenti nel testo ne confer-mano la composizione in Portogallo.
Eppure, il riferimento a un primo viaggio che avreb-be portato l’autore a sbarcare in Honduras nel giugnodel 1497, cioè un anno prima dell’arrivo di Colombo inVenezuela (luglio 1498), non può essere frutto della pen-na di Vespucci. È possibile invece che il successo delMundus Novus abbia spinto qualche mercante fiorentinodi Lisbona a rinnovare l’operazione editoriale, appor-tando modifiche e interventi laddove le fonti non era-no sufficienti a conferire un aspetto organico all’insie-me. Mediante la pubblicazione dell’opera a Firenze, in
toscano invece che in latino, la moltiplicazione di aned-doti divertenti, il taglio delle parti più strettamente scien-tifiche e la valorizzazione di dettagli strabilianti, il pro-motore o i promotori dell’operazione vollero raggiunge-re un pubblico più vasto e meno erudito di quello delMundus Novus: per diffondere in Italia le gesta dell’uo-mo che rappresentava l’orgoglio dei mercanti fiorenti-ni della penisola iberica era necessario rispondere alleprobabili aspettative di un pubblico più vasto e di cul-tura media.
Ultimata la redazione nel settembre del 1504, la let-tera fu trasmessa e stampata a Firenze rapidamente, for-se anche prima della fine dell’anno. Dal momento che iltesto è conservato in quattro copie indipendenti, unamanoscritta e tre a stampa, la sua circolazione dovetteessere piuttosto ampia. Quando poi, nel 1507, venne ri-pubblicata in latino, la Lettera al Soderini raggiunse unadiffusione confrontabile a quella del Mundus Novus. Iltesto latino, intitolato Quattuor Americi Vesputii navi-gationes, costituiva parte di una Cosmographiae introduc-tio, un manuale che aggiornava il sapere geografico to-lemaico, pubblicato a Saint-Dié in Lorena dai dotti delGymnase Vosgien. Vespucci assurse così al rango di mo-derno Tolomeo in quanto grande cosmografo e scopri-tore di quella quarta parte del mondo che, proprio «poi-
Il nuovo mondo e l’altro 683
Figura 1. Martin Waldseemüller, Mappa della terra, stampa, 1507. Berlino, Staatsbibliothek.
92_Descendre.qxp 29-07-2010 14:23 Pagina 683
ché è stata scoperta da Amerigo, è lecito chiamare Ame-rige, ovvero terra di Amerigo, o America» (Americi ter-ram sive America nuncupare licet). Il cartografo MartinWaldseemüller illustrò il testo con un planisfero che rap-presentava gran parte delle coste esplorate dal fiorenti-no affacciate su un continente ancora da scoprire, e re-cava all’altezza corrispondente al Brasile l’indicazione«America». Era nata l’America.
Grazie alla Cosmographiae introductio, la Lettera alSoderini ebbe un ruolo storico di primo piano. Ripresasovente nelle cosmografie assieme al Mundus Novus, di-venne un testo di riferimento per i geografi del Rina-scimento e si impose nel panorama letterario europeo.Nel 1532, i già citati Grynaeus e Huttich pubblicarononuovamente la Lettera a Basilea, all’interno della loroimportante cosmografia, il Novus Orbis. Nel 1544, la co-smografia di Peter Apian e Gemma Frisius presentavaun’America la cui geografia umana e culturale dipende-va ancora da quella di Vespucci; e anche André Thevetcontinuò a descrivere gli «americani» negli stessi termi-ni di Amerigo. Se Thomas More aveva potuto presen-tare il Raffaele Itlodeo della sua Utopia come un com-pagno di viaggio di Vespucci, nella Methodus ad facilemhistoriarum cognitionem di Jean Bodin l’opera del fio-rentino costituiva ancora una delle fonti principali perlo studio della storia americana. L’impronta di Vespuc-ci così andò ben oltre la mera toponomastica: l’immagi-ne stessa dell’America continuò a lungo a dipendere dal-le lettere pubblicate a suo nome, come testimonia ancheuna ricca iconografia ispirata alle scene da lui descritte.
Ma la lettera ebbe anche una fortuna dagli esiti ne-gativi. A causa del racconto di un primo viaggio in cuiil fiorentino avrebbe scoperto il continente prima di Co-lombo, si sarebbe creata la leggenda di un Vespucci im-postore, divulgata in particolare da Bartolomé de LasCasas nella sua Historia de las Indias: il frate domenicanoinfatti non poteva sapere che, in realtà, il fiorentino nonaveva mai rivendicato quella priorità, e che le relazionitra i due navigatori erano state improntate a solido e re-ciproco rispetto. Ma i malintesi hanno vita lunga, se èvero che ancora nel xx secolo gli storici continuerannoa presentare Vespucci come un «geniale falsificatore» oun «patetico bugiardo».
Considerando il verbo nella sua ambiguità di signi-ficato, si potrebbe comunque affermare che Vespucci hascoperto l’America. Nella lingua franca dei navigatori,descubrir o discoprir non significava trovare qualcosa chefosse nascosto ma, in senso lato, esplorare: è in questosenso che molte testimonianze del xvi secolo parlanodella «scoperta» del fiorentino. Era noto che Vespucciintendesse esplorare per il gusto di esplorare, per con-fermare o smentire il sapere geografico di allora fon-dendo scienza ed esperienza, e non per arricchirsi conle spezie, trovare l’oro oppure, come Colombo, farsi
strumento di un destino messianico. Nonostante fosseun mercante, la particolarità del fiorentino era quella dinavigare come uomo di scienza. Le sue ambizioni eranodi ordine cosmografico e la sua fama fu innanzituttoquella di un cosmografo. Altrimenti non si comprende-rebbe perché nel 1508 il re Ferdinando d’Aragona creòper lui l’incarico di piloto mayor: all’interno della Casade la Contratación, a Siviglia, a Vespucci venne affida-ta la formazione di tutti i piloti delle flotte spagnole,nonché la stesura e l’aggiornamento del padrón real, lamappa di riferimento per le esplorazioni e i possedimentioltre oceano a partire dalla quale venivano elaborate tut-te le carte nautiche. Quell’incarico rappresentò così laconsacrazione ufficiale di Vespucci non solo come esplo-ratore, ma pure come cosmografo.
Inoltre, si può parlare di «scoperta» dando alla pa-rola un altro significato ancora: Vespucci fu il primo arendersi conto dell’esistenza di un nuovo continente ea renderlo noto agli europei, mentre Colombo rifiutò fi-no alla morte di accettare quella realtà. Per questa ra-gione i geografi fecero del fiorentino un portabandierae le sue parole vennero a lungo utilizzate per dipingereil ritratto del nuovo mondo. Tuttavia, bisogna aggiun-gere che quel ritratto si formò attraverso stereotipi deiquali Vespucci non fu il solo inventore. L’immagine del-l’America che egli trasmise era in parte già presente inColombo (nudità, cannibalismo, piante sempreverdi ecc.)e prendeva in prestito elementi da Marco Polo e dai rac-conti di viaggio medievali. Si trattava già (o ancora) diletteratura. Attraverso i suoi testi editi, Vespucci si ri-trovò a essere di fatto l’autore degli scritti più influen-ti di un nuovo genere letterario, quello del viaggio nel-le Americhe, a cui diede massimo lustro. Ma l’impiegodi topoi codificati deve forse portarci a concludere sul-la non autenticità di quegli scritti? Se si pensa alla pre-senza di simili espressioni anche nelle lettere famigliari,indubbiamente autentiche, la risposta è negativa. Comespiegare allora l’impiego di quegli stereotipi? Il concet-to di “intertestualità” può essere utile, ma non suffi-ciente: la nudità o il cannibalismo non potevano non col-pire l’europeo che ne veniva a conoscenza, dunque nonè così sorprendente il fatto che i primi autori che si so-no confrontati con quelle realtà abbiano fatto ricorso al-le medesime formule nelle loro descrizioni.
Quei luoghi comuni descrittivi rivelano un fenome-no profondo di storia culturale: le formule stereotiperappresentano la traduzione linguistica immediata del-la novità, dell’inaudito, di realtà senza precedenti perdescrivere le quali le parole non potevano sgorgare spon-tanee ma solo attraverso il filtro delle tradizioni lette-rarie, antiche e recenti. La ripetizione di stereotipi con-sentì dunque di integrare ciò che era estraneo, renden-do possibile la trasmissione di una esperienza altrimentiindescrivibile. Ma quell’uso comportò anche la reifica-
684 Augusta, 1504
92_Descendre.qxp 29-07-2010 14:23 Pagina 684
zione dell’Altro, il suo inquadramento forzato in cate-gorie prestabilite: quell’attitudine linguistica divennecosì parte integrante dell’avventura coloniale. Certo,prima di solcare i mari Vespucci aveva lavorato in so-cietà con un concittadino la cui fortuna era essenzial-mente basata sul traffico di schiavi; inoltre, uno dei suoiviaggi ebbe uno scopo geopolitico e coloniale (esplorareper conto dei portoghesi la possibilità di prendere pos-
sesso di un territorio sconfinato); infine, il fiorentinocombatté in prima linea la guerra di velocità tra porto-ghesi e spagnoli per raggiungere Malacca via mare. MaVespucci provò curiosità per quegli uomini fino ad allo-ra sconosciuti, si impegnò a «intendere la loro vita e co-stumi» e a renderne conto. Il mercante fiorentino vollericonoscere la novità e l’alterità di un nuovo mondo: aquei tempi, non era cosa da poco.
Il nuovo mondo e l’altro 685
romain descendre
Su Vespucci, i lavori di Ilaria Luzzana Caraci e di LucianoFormisano vanno considerati di riferimento, sia per la curadei testi quanto per la loro interpretazione e gli aspetti bio-grafici e storici. A questi due studiosi è particolarmente de-bitore il presente saggio.Per i testi cfr. soprattutto i. luzzana caraci, Amerigo Ve-spucci, 2 voll., Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma1996-99, e l’edizione critica a. vespucci, Lettere di viaggio, acura di L. Formisano, Mondadori, Milano 1985. Per una ver-sione in lingua moderna delle lettere pubblicate cfr. l. for-misano e c. masetti (a cura di), America sive Mundus Novus.Le lettere a stampa attribuite ad Amerigo Vespucci, Società Geo-grafica Italiana, Roma 2007. Cfr. anche i. luzzana caraci em. pozzi (a cura di), Scopritori e viaggiatori del Cinquecento e delSeicento, vol. I, Ricciardi, Milano-Napoli 1991, e p. collo ep. l. crovetto (a cura di), Nuovo Mondo. Gli Italiani (1492-1565), Einaudi, Torino 1991.Le celebrazioni per i cinquecento anni delle «scoperte» hannosuscitato una vasta messe di pubblicazioni in merito; si veda-no l. formisano, Amerigo Vespucci: la vita e i viaggi, in l. for-misano e altri, Amerigo Vespucci: la vita e i viaggi, Banca To-scana, Firenze 1991, pp. 65-201; m. pozzi, Il mondo nuovo diAmerigo Vespucci. Scritti vespucciani e paravespucciani, Edizionidell’Orso, Alessandria 1993 (1ª ed. 1984); l. rombai (a curadi), Il mondo di Vespucci e Verrazzano: geografia e viaggi, Ol-schki, Firenze 1993; r. nanni e m. taddei, Amerigo Vespuccie la scoperta dell’America negli studi di Gustavo Uzielli, Silva-na Editoriale, Milano 2003; l. perini e s. trifogli, AmerigoVespucci: un uomo, un Continente. Guida alla mostra, (Firen-ze, Palagio di Parte Guelfa, 1-16 ottobre 2004), Firenze 2004;a. d’ascenzo (a cura di), Mundus Novus. Amerigo Vespucci e imetodi della ricerca storico-geografica, Atti del convegno inter-nazionale di studi, Brigati, Genova 2004; i. luzzana caraci,«Per lasciare di me qualche fama». Vita e viaggi di Amerigo Ve-spucci, Viella, Roma 2007; i. luzzana caraci e a. d’ascenzo(a cura di), Mundus Novus. Amerigo Vespucci e la sua eredità, At-ti del convegno conclusivo delle celebrazioni vespucciane (Ro-ma, 29-31 maggio 2006), Brigati, Genova 2007. La “questio-ne vespucciana” ha diviso a lungo gli storici della geografia edelle esplorazioni, ma è oggi considerata chiusa: contraria-mente a quanto sostenuto da Magnaghi (a. magnaghi, Ame-rigo Vespucci. Studio critico con speciale riguardo a una nuova
valutazione delle fonti, 2 voll., Treves, Roma 1924), ormai si ri-tiene probabile la partecipazione di Vespucci a quattro viag-gi e non più solo a quelli attestati dalle lettere famigliari.La storia editoriale del Mundus Novus è stata oggetto di nu-merose discussioni; la ricostruzione di i. luzzana caraci, Alleorigini della geografia d’America. Le prime edizioni del MundusNovus, in «Rivista Geografica Italiana», CII (1995), pp. 559-583, secondo cui la princeps non può che essere quella di Au-gusta, è la più convincente. Tuttavia meritano di essere pre-si in esame gli argomenti di coloro che sostengono che il testosia apparso prima a Parigi: l. perini, Due fiorentini nell’Ocea-no Atlantico: Amerigo Vespucci e Giovanni da Verrazzano, inl. rombai (a cura di), Il mondo di Vespucci cit., pp. 125-74;m. candelora siliberto, Il Mundus Novus di Amerigo Vespuccifra discipline geografiche, storiche e filologiche, in «Rivista Geo-grafica Italiana», CV (1998), pp. 277-309. Cfr. anche g. gal-liano, Alcune considerazioni sulle edizioni del ‘Mundus Novus’,in s. ballo alagna (a cura di), Esplorazioni geografiche e im-magine del mondo nei secoli xv e xvi, Alagna, Messina 1994,pp. 153-70. Per i legami tra Firenze e la «scoperta» cfr. s. gen-tile (a cura di), Firenze e la scoperta dell’America. Umanesimoe geografia nel ’400 fiorentino, Olschki, Firenze 1992; Firenze eil ‘Mondo Nuovo’. Geografia e scoperte fra xv e xvi secolo, At-ti del convegno (Firenze, 6-8 ottobre 1992), in «Rivista Geo-grafica Italiana», C (1993), n. 1, pp. 3-485.Su Vespucci nella storia delle scienze geografiche cfr. w. g. l.randles, Dalla Terra piatta al globo terracqueo. Una mutazioneepistemologica rapida, 1480-1520, Sansoni, Firenze 1986; peril posto che occupa nella storia politica delle esplorazioni geo-grafiche cfr. m. pozzi, Politica e grandi scoperte geografiche. Al-cuni aspetti e problemi, in p. carta e r. descendre (a cura di),Géographie et politique au début de l’âge moderne, in «Labora-toire italien. Politique et société», VIII (2008), pp. 15-62. Sul-l’eredità letteraria: l. formisano, Le lettere di Amerigo Vespuc-ci nella storia della letteratura, in a. d’ascenzo (a cura di), Mun-dus Novus. Amerigo Vespucci e i metodi cit., pp. 31-47. Allafine del saggio si fa riferimento diretto a: s. e. morison, Sto-ria della scoperta dell’America, II. I viaggi del Sud, 1492-1616(1974), Rizzoli, Milano 1977; j. gil, Miti e utopie della sco-perta. Cristoforo Colombo e il suo tempo (1989), Garzanti, Mi-lano 1991. Per una bibliografia completa: c. masetti, Biblio-grafia vespucciana, in «Geostorie», X (2002), n. 3, pp. 111-201.
92_Descendre.qxp 29-07-2010 14:23 Pagina 685