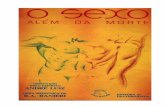Come non temere la morte, l'insegnamento di Epicuro nella lettera a Meneceo
Transcript of Come non temere la morte, l'insegnamento di Epicuro nella lettera a Meneceo
SFA 12/13
COME NON TEMERE LA MORTE L’INSEGNAMENTO DI EPICURO NELLA LETTERA A MENECEO
E1
Jacopo Moruzzi
2 F
INDICE
Introduzione p.2
1. Morte come perdita di sensazione p.2
2. La morte è un male per la persona che muore? p.5
Conclusione p.8
Bibliografia di lavoro p.10
Appendici
A. Diagrammi di partizione p.12
B. Confronto di traduzioni p.14
C. Saggio bibliografico p.15
!1
Introduzione
L’Epistola morale a Meneceo contiene i precetti fondamentali che Epicuro ha elaborato
nell’intento di eradicare dall’animo umano tutte quelle false credenze che ostacolano il
conseguimento di una vita felice. Il filosofo del Giardino imposta una disquisizione che, aprendosi
con l’assunzione fondamentale secondo cui il filosofare è necessario ad ogni età, va ad affrontare le
paure più diffuse tra gli uomini fino a riconoscerne l’inconsistenza, con la conseguente possibilità di
dedicarsi, liberi, alla ricerca dei giusti piaceri.
Oggetto della presente trattazione sarà un’analisi dell’argomento che Epicuro impiega per
curare l’animo dell’uomo dal timore della morte, partendo dall’affermazione che essa non sia «nulla
per noi». Nel primo paragrafo si approfondirà questo principio fondamentale, sia nel contesto 1
della Lettera, sia in rapporto ad altri passi dell’opera del filosofo. Vi saranno anche riferimenti alle
nozioni esposte dal poeta Lucrezio, poiché essenziali per ricostruire le linee più importanti
dell’epicureismo. Nel secondo paragrafo ci si servirà in parte del punto di vista offerto da James
Warren sul problema posto nell’Epistola, che prevede una classificazione delle principali paure che
investono l’uomo di fronte alla morte: uno schema che fungerà da struttura portante per procedere
nella lettura dell’opera e palesarne i nodi centrali e insieme più problematici.
1. Morte come perdita di sensazione
Per riuscire ad inquadrare in maniera sufficientemente corretta l’argomentazione epicurea, è
necessario soffermarsi ad esaminare la frase con la quale il filosofo dà inizio al proprio discorso
sulla morte:
Abituati a pensare che la morte per noi è nulla: perché ogni bene e ogni male risiede nella possibilità di sentirlo: ma la morte è perdita di sensazione.
Epicur. Ep. Men. 124
Epicuro, infatti, non esordisce definendo la morte come un male (lo farà esplicitamente nel
paragrafo successivo ), ma provvede piuttosto ad evidenziarne l’aspetto che causa il suo essere 2
nulla per noi, cioè la «perdita di sensazione» che la accompagna necessariamente. Importante
Epicur. Ep. Men. 125.1
Ibidem.2
!2
sottolineare come questa asserzione provenga da quell’ambito della filosofica epicurea riguardante
la psicologia, in cui la disquisizione intorno all’anima viene impostata sulla base di una fisica di
tipo atomista. Senza entrare nei dettagli di tale teoria, è opportuno qui citare, a titolo d’esempio, un
passo tratto da un’altra opera epicurea, ovvero la Lettera a Erodoto:
[…] bisogna considerare che l’anima è un corpo sottile, diffuso per tutto l’organismo, molto simile
al respiro […] Bisogna inoltre ritenere che l’anima racchiude in sé la causa principale della sensazione: non potrebbe certo avere questa se non fosse contenuta nel resto dell’organismo […] perciò, una volta privato dell’anima, l’organismo non ha la facoltà di sentire.
Epicur. Ep. Hdt. 63-64
Si può innanzitutto notare come per Epicuro l’anima sia un «corpo» (σῶµά): ciò implica che essa
sia formata da atomi e che la sua natura sia dunque materiale. Essa rappresenta inoltre la struttura
fondamentale che sta alla base della possibilità della percezione, seppur non costituendone la
ragione sufficiente, data la necessità che essa si accompagni sempre e comunque ad un organismo. 3
La sensazione può sussistere anche se l’organismo viene privato di qualche sua componente, a
condizione che gli atomi che costituiscono l’anima rimangano integri e che l’organismo stesso non
perisca nella sua totalità. Quando il filosofo parla di morte come «perdita di sensazione», intende 4
dunque dire che ad essa corrisponde una dissoluzione di quel rapporto anima-organismo che sta alla
base della capacità stessa del sentire. Ne consegue che la morte rappresenta un limite invalicabile
sia per lo spirito che per la carne. A tal proposito, sono senza dubbio illuminanti i versi che uno dei
più importanti sostenitori dell’epicureismo, ovvero il poeta latino Lucrezio, impiega per definire il
destino comune del corpo e dell’anima, considerando un aspetto particolare di quest’ultima, cioè la
mente:
Inoltre, avvertiamo che insieme al corpo si forma la mente,
e insieme s’accresce, e ugualmente declina. […] A ciò segue che noi ci avvediamo che, come il corpo soffre orribili malattie, e duro dolore, così l’animo ansie violente, e lutto, e paura: e per questo s’addice che abbia parte all’essenza di morte.
Lucr. DRN III 445-462
Cfr. LONG 1997, pp. 67-76.3
Epicur. Ep. Hdt. 65.4
!3
Due elementi che il poeta dimostra essere simili fin dalla loro origine e che condividono
un’esistenza non esente dal peso della malattia, preludio della finale partecipazione «all’essenza di
morte». Appare chiaro a questo punto come sia opportuno riuscire ad osservare la prospettiva etica
dell’epicureismo nel più ampio orizzonte di una teoria psicologica e fisica.
Ad arricchire tuttavia questo scenario intervengono le parole che Epicuro impiega
procedendo nel proprio discorso. Continuando infatti a leggere la Lettera a Meneceo, si trova
scritto:
Per cui, la retta conoscenza che la morte per noi è nulla rende piacevole che la vita sia
mortale, non perché la prolunga per un tempo infinito, ma perché la libera dal desiderio dell’immortalità.
Epicur. Ep. Men. 124
Emerge qui un nuovo aspetto: la morte non sembra far nascere nell’uomo soltanto paura. Epicuro
parla infatti anche di un «desiderio di immortalità» dal quale si viene liberati nel momento in cui si
impara a considerare correttamente la morte. Si instaura qui un collegamento con l’argomento
precedentemente esposto nella Lettera, ovvero quello in cui Epicuro tenta di convincere gli uomini
dell’assoluta indifferenza nutrita nei loro confronti da parte degli dèi, i quali «dediti soltanto alle
virtù loro proprie, accolgono i loro simili, reputando estraneo tutto ciò che non è tale». Liberare gli 5
uomini dal desiderio di un’esistenza ultraterrena corrisponde per Epicuro anche a distruggere le
ultime tensioni relative alle divinità e al loro giudizio. Non è un caso che, in merito a ciò, Long
scriva: «Negando poi ogni forma di sopravvivenza della personalità individuale dopo la morte,
Epicuro credeva di poter rimuovere la sorgente di una fondamentale ansia umana: il timore del
giudizio divino e del castigo eterno». Poiché un uomo che teme la morte lo fa anche per terrore 6
delle punizioni che lo aspettano una volta inchinatosi al cospetto di quelle divinità che per loro
natura la morte non temono. Acquisendo una retta concezione della morte, dunque, l’uomo rende la
propria esistenza piacevole, in quanto si rende conto di come le sue azioni non debbano essere volte
ad ottenere il favore degli dèi. Questo non implica ovviamente che l’umanità debba condurre
un’esistenza terrena priva di scopo e dominata dalla dissolutezza: altro obiettivo della filosofia di
Epicuro sarà infatti quello di guidare l’uomo nella ricerca dei piaceri necessari alla felicità. 7
Epicur. Ep. Men. 123-124.5
LONG 1997, p.59.6
Epicur. Ep. Men. 127.7
!4
Ritornando all’argomento centrale del discorso, ci si rende conto di come non sia così
immediato interpretare il modello di uomo che Epicuro pone di fronte alla morte e, soprattutto,
quali siano le specifiche tensioni che questo soggetto si trova a soffrire. Occorre dunque proseguire
nella lettura dell’Epistola Morale cercando di elaborare una classificazione degli aspetti e delle
sfaccettature che compongono il concetto di morte e che sono oggetto di paura per l’uomo.
2. La morte è un male per la persona che muore?
Rispetto al problema di comprendere il significato delle parole di Epicuro, assolutamente degna di
nota è la posizione di James Warren, il quale sostiene che nel dire ‘la paura della morte’, abbiamo la
colpa di semplificare la questione. È per questo che nell’elaborare la sua interpretazione
dell’argomento epicureo, egli propone uno schema in cui, a partire dalla domanda fondamentale ‘la
morte è un male per la persona che muore?’ vengono individuate le quattro principali paure che un
individuo potrebbe provare sotto la minaccia di tale male. Esse comprendono:
1*. The fear of being dead.
2*. The fear that one will die, that one’s life is going to end. 3*. The fear of premature death 4*. The fear of the process of dying.
WARREN 2004, p.3
Per quanto riguarda il primo caso, l’ «essere morto» fa fondamentalmente riferimento alla
condizione entro cui si verrebbe a trovare l’anima dell’essere umano una volta avvenuto il decesso.
È già stato mostrato a sufficienza come Epicuro, con la prima parte del proprio argomento, sia stato
in grado di negare anche solo la possibilità che una condizione del genere sia percepibile, sulla base
del principio della mortalità dell’anima stessa. Potrebbe altresì essere proprio la prospettiva di
questo annullamento della propria persona a costituire motivo di terrore per l’essere umano. Una
possibile soluzione a questo problema non è presente nell’Epistola. Ad essere d’aiuto è però ancora
una volta il poema lucreziano, nel quale viene introdotto ciò che Warren definisce Symmetry
Argument: per abbattere l’idea che l’annullamento eterno dell’esistenza possa essere fonte di dolore,
si considera come, allo stesso modo, prima della nascita vi sia stato un abisso altrettanto profondo,
il quale, però, non è visto come fonte di preoccupazioni . Si legge infatti nel De Rerum Natura: 8
Cfr. WARREN 2004, p. 57-108.8
!5
«Considera ancora come un niente sia stata per noi la remota antichità, il tempo eterno trascorso
prima che noi nascessimo». 9
Il secondo caso indicato da Warren, in cui la paura è rivolta all’idea che la propria vita sia
destinata a finire, può essere ricondotto invece ad un disagio fondamentale che caratterizza l’essere
umano nel momento in cui prende coscienza della propria natura mortale. Se si riprende la lettura
della Lettera a Meneceo, si può constatare come anche questo aspetto venga preso in
considerazione da Epicuro:
Cosicché è folle chi asserisce di temere la morte non perché quando sarà presente gli arrecherà
dolore, ma perché è l’attesa che gliene provoca. Ciò che non ci inquieta se presente, ci affligge infatti vanamente quando lo si attende. Il male, dunque, che più ci atterrisce, la morte, è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è la morte, e quando c’è la morte, noi non siamo più.
Epicur. Ep. Men. 125
Ancora prima del timore del giudizio divino, è dunque quello causato dalla prospettiva della morte
ad immobilizzare la vita umana. Si tratta anche in questo caso di una falsa credenza: quel male che,
nel momento in cui ci raggiunge, annulla ogni possibilità di percepirlo come tale, appare ancor
meno minaccioso se osservato da lontano. È per ciò «folle» chi si tormenta nell’attesa della morte, e
chi, come la maggior parte degli uomini «ora fugge la morte come il più grande dei mali, ora la
cerca, come la fine dei mali della vita». A questi, Epicuro contrappone la figura del «saggio» che 10
«non si oppone alla vita e non ritiene un male il non vivere più […] così gode non del tempo più
lungo ma di quello più dolce». 11
Si considera ora la terza possibilità messa in luce da Warren, cioè quella in cui ad essere
temuta sia la morte prematura, che egli stesso definisce mediante il suo counterfactual account:
«What we may call the ‘counterfactual account’ of the harm of death says that death is a harm in so
far as it robs the deceased of goods he would have experienced had he died later». La morte è 12
perciò temuta in quanto rappresenta un limite rispetto alla possibilità di godere dei beni della vita.
Dunque, anche l’uomo che Epicuro definisce ‘saggio’, in quanto perderà la possibilità di godere del
tempo più dolce, è soggetto a questa paura? Per affrontare il problema è opportuno citare
nuovamente il De Rerum Natura di Lucrezio (come del resto fa anche Warren a questo proposito),
Lucr. DRN III 972-973.9
Epicur. Ep. Men. 125.10
Ivi, 126.11
WARREN 2004, p. 31.12
!6
in particolare un passo in cui il poeta riporta ciò che gli uomini dicono erroneamente in merito a chi
è morto:
«Ormai […]. Non potrai più avere felice condizione, ed esser sostegno per i tuoi. A te infelice infelicemente» dicono «ha strappato tutte le gioie della vita una sola infausta giornata». Ma tra queste cose non aggiungono: «E il rimpianto per queste cose non continua a esistere, insieme con te».
Lucr. DRN III 894-901
Che ci sia dunque un desiderio o un rimpianto rivolto alla gioie della vita poco importa, dato che
esso è comunque destinato a scomparire nell’annullamento di anima e corpo. Lo stesso Warren
commenta il passo scrivendo: «Lucretius simply asserts that the deceased will not be deprived of
these goods since after death he will have no desire for them». 13
Se già per definire la terza possibilità è stato necessario esulare dal contesto della Lettera, lo
stesso si può dire per il quarto caso messo in luce da Warren, rispetto a cui Epicuro non fornisce
argomentazioni direttamente in questo testo. Per non deviare eccessivamente dai propositi del
presente paper, ci si limiterà a sottolineare come la paura che ha come oggetto il processo del
morire sia riconducibile alla repulsione nei confronti del dolore che potrebbe accompagnare tale
processo. Da ciò consegue tuttavia che è il dolore di questo processo a qualificarlo come
appropriato oggetto della paura, non il fatto che il processo avrà come risultato la morte. Una 14
paura di questo tipo non esula soltanto dall’argomentazione contenuta dell’opera in esame, ma dal
più ampio contesto del tema della morte, andando infine a sfociare nella dottrina epicurea della
sopportazione del dolore. 15
Nella parte conclusiva del discorso sulla morte, Epicuro inserisce il concetto forse più
emblematico della Lettera, scagliandosi contro chi «invita il giovane a vivere bene e il vecchio a
morire bene». Un invito del genere andrebbe ad annullare completamente quanto esposto nelle 16
righe precedenti, in quanto considerare la morte come posta su di un piano differente rispetto alla
vita comporterebbe una degradazione di quest’ultima: separare i due piani è qualcosa di assurdo
«non soltanto per ciò che di piacevole vi è nella vita, ma anche perché l'esercizio del vivere bene e
WARREN 2004, p.35.13
Cfr. ivi, p.12.14
Per approfondimenti sull'argomento, cfr. ivi, pp.8-15.15
Epicur. Ep. Men. 126.16
!7
del morire bene è il medesimo». Con quest’ultima affermazione, Epicuro ritorna alla premessa 17
fondamentale della Lettera stessa: il filosofare, strumento necessario alla salute dell’anima, finisce
per contenere nell’identico spazio il discorso intorno alla vita come quello relativo alla morte
(nonché gli altri precetti epicurei per il vivere bene), in quanto il suo scopo ultimo rimane il
raggiungimento della felicità. Per concludere poi la propria disquisizione, il filosofo si confronta
con chi afferma che avrebbe preferito non nascere o che, una volta nato, sia meglio morire il prima
possibile: egli ha tutto il potere di togliersi la vita e realizzare così la propria convinzione, ma se
non ne sta parlando seriamente, allora è stolto, poiché la questione richiede che non si scherzi. 18
Conclusione
Si è potuto constatare come Epicuro, nell’argomentare contro la paura della morte, imposti un
discorso che si fonda su principi provenienti da vari ambiti della sua filosofia: centrale per riuscire a
spiegare in che misura la morte non sia nulla, è la concezione atomista dell’anima e la teoria della
sensazione ad essa collegata. Questo principio è di estrema rilevanza, in quanto va a costituire il
punto di partenza per l’intero argomento fin qui analizzato, ed offre nel contempo un terreno stabile
per altre teorie epicuree. È stato poi messo in luce come le parole dell’Epistola a Meneceo
nascondano una molteplicità di interpretazioni rispetto allo stesso concetto di ‘paura’, il quale muta
nel momento in cui si vanno a considerare i diversi aspetti che concernono la morte.
Sono sorti poi, nel corso della trattazione, una serie di punti problematici che
necessiterebbero di ulteriori approfondimenti. Si fa in particolare riferimento all’argomentazione
che viene elaborata dal filosofo per abbattere un’altro timore umano, cioè quello nei confronti della
divinità, che è stato affrontato in questo paper esclusivamente nei suoi punti di contatto con
l’argomento sulla morte. A ciò si aggiunge una possibile elaborazione del tema relativo ai piaceri e
alla loro classificazione, che, insieme al discorso epicureo sulla sopportazione del dolore, andrebbe
ad arricchire ed ampliare la trattazione fin qui svolta. Una disquisizione che miri ad esporre un
pensiero come quello di Epicuro, dovrebbe sempre considerare le singole teorie del filosofo, senza
mai dimenticare il raffinato sistema entro cui esse vanno ad inserirsi.
A tutto ciò si aggiunge una considerazione di carattere filologico. L’assenza materiale delle
opere principali di certi autori porta necessariamente ad impiegare altre fonti per riuscire a
Ibidem.17
Ivi, 127.18
!8
completare l’orizzonte di alcuni tipi di pensiero: un esempio che si può individuare anche nel
presente elaborato è dato dall’opera di Lucrezio, ormai inseparabile dai principi genuini
dell’epicureismo. Proprio per lo stesso motivo, avviene che grandi quantità di attenzione e curiosità
vengano concentrate su quelle poche pagine che l’avido tempo ha consentito di leggere. È forse
anche per questo che le parole di Epicuro, contenute nella Lettera a Meneceo risuonano con così
grande impeto.
!9
BIBLIOGRAFIA DI LAVORO
1. FONTI
1.1 La Lettera a Meneceo di Epicuro
1.1.1 Traduzione di riferimento
Epicuro, Lettere sulla fisica, sul cielo e sulla felicità, prefazione di F. Adorno, a cura di N. Russello,
Milano: BUR, 1994 (rist. 2004).
1.1.2 Traduzioni di confronto
Epicuro, Lettera a Meneceo, in Epicurea: testi di Epicuro e testimonianze epicuree nella raccolta di
Hermann Usener, a cura di I. Ramelli, Milano: Bompiani, 2002.
Epicuro, Scritti morali, a cura di C. Diano e G. Serra, Milano: BUR, 1987 (rist. 2004).
1.2 Altre fonti consultate
Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei più celebri filosofi, a cura di Giovanni Reale con la
collaborazione di G. Girgenti e I. Ramelli, Milano: Bompiani, 2005.
Diogenes Laertius, Lives of eminent philosophers, a cura di T. Dorandi, Cambridge: Cambridge
University Press, 2013.
Lucrezio, La natura delle cose, introduzione di E. Narduccia, a cura di G. Milanese, Milano:
Mondadori, 1992.
2. STUDI
2.1 Vita e dottrina di Epicuro
!10
LONG 1997 A. A. Long, La filosofia ellenistica: Stoici, epicurei,
scettici [1974], traduzione di Alessandro Calzolari, Bologna: il
Mulino, 1989 (rist. 1997).
2.2 I l t e m a
de l la morte in
Epicuro
WARREN 2004
J. Warren,
F a c i n g d e a t h :
Epicurus and his
critics,
O x f o r d :
Clarendo Press ,
2004.
3.
!11
ABBAGNANO/FORNERO 1999 N. Abbagnano/G. Fornero, Protagonisti e testi
della filosofia, 5 voll., Milano: Paravia, 1999, Vol. A, Tomo I.
3.2 Dispense
CAPUCCINO 2012/2013 C. Capuccino, Seminario di Scrittura Filosofica,
2012/13.
!13
B. CONFRONTO DI TRADUZIONI
1. DIFFERENZE DI STILE
2. DIFFERENZE DI CONTENUTO
Nicoletta Russello Carlo Diano Ilaria Ramelli
1. Epicur. Ep. Men.
122
C o s i c c h é d e v o n o filosofare sia il giovane, sia il vecchio…
Per modo che filosofare d e v e i l g i o v a n e e i l vecchio..
C o s i c c h é , d e v e occuparsi di filosofia sia un g iovane s i a un vecchio..
2. Epicur. Ep. Men.
123
Empio non è chi non riconosce gli dèi del volgo…
Ed empio non è chi nega gli dèi dei più…
Ed è empio non chi nega gli dèi venerati dai più…
3. Epicur. Ep. Men.
125
Cosicché è folle… E però parla a vuoto… Cosicché è stolto…
4. Epicur. Ep. Men.
130
P e r c h é i n c e r t e circostanze il bene può essere per noi un male, e viceversa il male può essere un bene.
Vi sono momenti infatti in cui il bene è per noi un male , altri, in cui il male è per noi un bene.
Infatti, capita talora che trattiamo il bene come male, e, per converso, il male come bene.
Nicoletta Russello Carlo Diano Ilaria Ramelli
1. Epicur. Ep. Men.
122
Non aspetti il giovane a filosofare, né il vecchio di filosofare si stanchi: nessuno è troppo giovane o troppo vecchio per la salute dell’anima.
Né giovane indugi alcuno a filosofare, né vecchio di f i l o so fa r e s i s t anch i : g i a c c h é n e s s u n o è immaturo, nessuno troppo maturo per pensare alla salute dell’anima.
N é q u a n d o u n o è g i o v a n e , e s i t i a filosofare, né quando è vecchio, si stanchi di filosofare. Infatti, per nessuno, non è ancora il momento o non è più il momento di acquistare la salute dell’anima.
2. Epicur. Ep. Men.
123
I precet t i che t i ho c o n t i n u a m e n t e raccomandato mettili in pratica ed esercitali , ritenendoli il principio fondamentale di una vita felice.
Le massime che tante volte t’ho date, praticale ed abbile sempre alla mente, considerandole gli elementi primi della vita perfetta.
E quelle cose che ho c o n t i n u a t o a raccomandarti, compile e abbine cura, ritenendo c h e q u e s t e s o n o i fondamenti del vivere bene.
3. Epicur. Ep. Men.
132
Di tutte queste cose il principio e massimo bene è la prudenza…
Principio e bene massimo in tutte queste cose è la prudenza…
D i t u t t i q u e s t i , i l principio e il più grande bene è la saggezza…
!16
C. SAGGIO BIBLIOGRAFICO
1. LETTERATURA PRIMARIA
Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, a cura di M. Gigante, Milano: TEA, 1991.
Épicure, Lettre à Ménécée, a cura di P. Pénisson, Paris: Hatier, 2007.
Épicure, Lettres et Maximes, a cura di M. Conche, Paris: Presses Universitaires de France, 2009.
Epicuro, Opere, a cura di M. Isnardi Parente, Milano: TEA, 1993.
Epicuro, Obras, a cura di M. Jufresa, Barcelona: Altaya, 1994.
Epicuro, Obras completas, a cura di J. Vara, Madrid: Cátedra, 1996.
2. LETTERATURA SECONDARIA
2.1 Studi sul tema della morte in Epicuro
AUSTIN E., Epicurus and the Politics of Fearing Death, «Apeiron: A Journal for Ancient
Philosophy and Science», 45 (2012) 2, pp. 109-129.
BURLEY M., Epicurus, Death, and the Wrongness of Killing, «Inquiry: An Interdisciplinary
Journal of Philosophy», 53 (2010) 1, pp. 68-86.
GREEN O., Fear of death, «Philosophy and Phenomenological Research», 43 (1982), pp. 99-105.
GREY W., Epicurus and the Harm of Death, «Australasian Journal of Philosophy», 77 (1999) 3, pp.
358-364.
KAUFMAN F., Pre-Vital and Post-Mortem Non-Existence, «American Philosophical Quarterly»,
36 (1999) 1, pp. 1-19. !17
LUPER S., Annihilation, «Philosophical Quarterly», 37 (1987), pp. 233-252.
MILLER F., Epicurus on the art of dying, «Southern Journal of Philosophy», 14 (1976), pp.
169-177.
MITSIS P., Epicurus on death and the duration of life, «Proceedings of the Boston Area
Colloquium in Ancient Philosophy», 4 (1988), pp. 303-322.
PASKOW A., The meaning of my own death, «International Philosophical Quarterly», 14 (1974),
pp. 51-69.
ROSENBAUM S., Epicurus and Annihilation, «Philosophical Quarterly», 39 (1989), pp. 81-90.
2.2 Studi sull’etica epicurea
BROVKIN V., The Concept of Virtue in Epicurus, «Schole: Ancient Philosophy and the Classical
Tradition», 6 (2012), pp. 340-349.
FARRINGTON B., The Fait of Epicurus, London: Weidenfeld & Nicolson, 1967.
NIKOLSKY B., Epicurus on Pleasure, «Phronesis: A Journal of Ancient Philosophy», 46 (2001),
PP. 440-465.
WARREN J., Epicurus and Democritean Ethics: An Archaeology of ‘Ataraxia’, Cambridge:
Cambridge University Press, 2002.
WOOLF R., What Kind of Hedonist Was Epicurus?, «Phronesis: A Journal of Ancient Philosophy»,
49 (2004), pp. 303-322.
!18