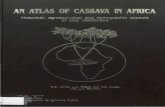M. Venturino Gambari, L. Ferrero, M. Micheletti Cremasco, F. Rubat Borel, Alba, corso Piave. Nuova...
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of M. Venturino Gambari, L. Ferrero, M. Micheletti Cremasco, F. Rubat Borel, Alba, corso Piave. Nuova...
Ministero per i Beni e le Attività CulturaliDirezione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie
Direzione e Redazione
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie
Piazza S. Giovanni 2 - 10122 TorinoTel. 011-5212507, 5213323, 5214069Fax 011-5213145E-mail [email protected]
Direttore della Collana
Egle Micheletto - Soprintendente per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie
Comitato Scientifico
Marica Venturino Gambari Giuseppina Spagnolo GarzoliLuisella Pejrani BariccoMatilde Borla
Coordinamento
Marica Venturino Gambari
Comitato di Redazione
Luisa FerreroElisa PaneroSofia Uggé
Segreteria di Redazione
Maurizia Lucchino
Editing ed elaborazione immagini
Susanna Salines
Progetto grafico e impaginazione
LineLab.multimedia - Alessandria
Stampa
Litografia Viscardi - Alessandria
La redazione di questo volume è stata curata da Luisa Ferrero, Elisa Panero e Sofia Uggé con la collaborazione di Francesca Garanzini e Maurizia Lucchino
Quando non diversamente indicato, i disegni dei reperti sono in scala 1:3 (ceramica, vetri), in scala 1:2 (industria litica levigata, metalli), in scala 1:1 (industria litica scheggiata).
Il volume è stato pubblicato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e con la collaborazione degli Amici del Museo di Antichità di Torino.
© 2011 Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del PiemonteSoprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità EgiziePiazza S. Giovanni 2 - 10122 Torino
NOTIZIARIO 205
e all’eventuale utilizzazione di particolari sostan-ze per spegnere il fuoco, rappresenterebbero in-fatti variabili simboliche e culturali difficilmente individuabili dall’analisi dei dati osteoarcheologi-ci. Potranno contribuire a chiarire questi aspetti le analisi di dettaglio che saranno affrontate nelle prossime fasi dello studio: l’individuazione di una ipotetica relazione tra quantità in peso/colorazione
dei resti scheletrici da un lato e presenza/ricchezza degli elementi di corredo dall’altro, l’esame della di-stribuzione delle temperature a livello delle diverse parti dello scheletro, della sovra- o sottorappresen-tazione dei vari elementi scheletrici. Potrà risultare infine significativo il riconoscimento di eventuali variazioni di uno o più di questi parametri nel cor-so del periodo di uso del sepolcreto. (E.B. - E.P.)
Bedini E. 2006. L’analisi dei resti scheletrici umani, in Navigando lungo l’Eridano. La necropoli protogolasecchiana di Morano sul Po,a cura di M. Venturino Gambari, Casale Monferrato, pp. 41-48.
Bedini E. et al. 2011. Bedini E. - Bertoldi F. - Petiti E., Il gruppo umano di Castelletto Ticino, località via del Maneggio: paleobiologia e aspetti del rituale funerario, in L’alba della città. Le prime necropoli del centro protourbano di Castelletto Ticino, a cura di F.M. Gambari - R. Cerri, Novara, pp. 225-240.
Gambari F.M. 2004a. Le necropoli a cremazione nel quadro dell’e-tà del Bronzo recente in Piemonte, in L’età del Bronzo recente in Italia. Atti del congresso nazionale di Lido di Camaiore, 26-29 ottobre 2000, a cura di D. Cocchi Genick, Viareggio, pp. 53-60.
Gambari F.M. 2004b. Alba (Cuneo), corso Piave 199, in I Ligu-ri. Un antico popolo europeo tra Alpi e Mediterraneo, Catalogo della mostra, a cura di R.C. De Marinis - G. Spadea, Ginevra-Milano, p. 421.
Holck P. 1986. Cremated bones. A medical-anthropological study of an archeaological material on cremation burials, in Anthro-pologiske Skrifter, 1, Oslo.
Mann R.W. - Murphy S.P. 1990. Regional atlas of bone disease. A guide to pathologic and normal variation in human skeleton,Springfield Illinois.
Mays S. 1998. he archaeology of human bones, London.
Navigatori e contadini 1995. Navigatori e contadini. Alba e la val-le del Tanaro nella preistoria, a cura di M. Venturino Gambari, Alba (Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemon-te. Monografie, 4).
Petiti E. 2009. Analisi dei resti cremati, in Non omnis moriar. Manuale di antropologia, a cura di F. Mallegni - B. Lippi, Roma, pp. 169-200.
Shipman P. et al. 1984. Shipman P. - Foster G. - SchoeningerM., Burnt bones and teeth: an experimental study of colour, mor-phology, crystal structure and shrinkage, in Journal of archaeo-logical science, 11, pp. 307-325.
Venturino Gambari M. 2006. La preistoria e la protostoria, in Civico Museo “Federico Eusebio” di Alba. Guida alla visita. 1. Sezione di archeologia, a cura di E. Micheletto - M.C. Preacco - M. Venturino Gambari, Alba (Guide ai musei in Piemonte, 8.1), pp. 17-22; 26-37.
Venturino Gambari M. 2007. La necropoli preistorica lungo il fiume, in Nuove acquisizioni archeologiche ad Alba [2001-2007],a cura di E. Micheletto, Alba, pp. 9-13.
Venturino Gambari - Terenzi P. 2008. Alba, corso Piave. Ne-cropoli a cremazione dell’età del Bronzo medio-recente, in Qua-derni della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 23, pp. 182-185.
Bibliograia
Alba, corso Piave. Nuova piscina comunale Sepoltura dell’antica età del Bronzo e strutture d’abitato della prima età del Ferro
Marica Venturino Gambari - Luisa Ferrero - Margherita Micheletti Cremasco - Francesco Rubat Borel
Dopo alcuni sondaggi preliminari effettuati nel-la primavera 2001, l’assistenza archeologica alle opere di scavo per la realizzazione della nuova piscina comunale di Alba in località S. Cassiano (fig. 47), in prossimità del margine collinare pro-spiciente la valle del Tanaro, aveva portato (no-vembre 2001-gennaio 2002) all’individuazione di una complessa sequenza stratigrafica databile tra l’età romana e l’antica età del Bronzo. Dopo una prima segnalazione del rinvenimento (Ven-turino Gambari et al. 2004) e la presentazione di contesti e reperti particolarmente significativi emersi nel corso dell’indagine (sepoltura dell’an-tica età del Bronzo: Gambari 2004b, p. 81; fibula
a cavallino: Gambari 2004a, fig. 7, p. 23), il com-pletamento delle operazioni di lavaggio, siglatu-ra, restauro (Docilia s.n.c.) e studio dei reperti ne rende ora possibile un inquadramento più com-pleto.
L’indagine archeologica è stata supportata da analisi geoarcheologiche (C. Ottomano) che hanno reso possibile ricostruire in dettaglio l’e-voluzione paleoambientale del sito e le attività antropiche che interessarono quest’area peri-fluviale a partire dall’antica età del Bronzo (XX-XVIII secolo a.C.). La frequentazione antropica, in questa fase, sembra essere stata di carattere episodico, prevalentemente collegata ad attività
206 NOTIZIARIO
pastorali indiziate, oltre che dalle analisi, anche da una grande fossa (us 32, riempimento us 31, da cui provengono solo frustoli di ceramica non diagnostica e di concotto) che ben si collega alle attività di disboscamento connesse con l’apertura a pascolo di un’area in precedenza forestata; un utilizzo anche funerario è testimoniato da un’u-nica sepoltura ad inumazione (t. 2), interessata da fenomeni rituali o da una attività di violazione in antico.
L’utilizzo dell’area a prato-pascolo continuò almeno fino alla prima età del Ferro, con strut-ture (buche di palo, pozzetti) riferibili ad attività di carattere agricolo (uuss 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35). La disposizione planimetrica della rilevante quantità di materia-le ceramico rinvenuta, proveniente in gran parte dalla porzione superiore dello strato (primi 25 cm ca.) e concentrata soprattutto nel settore centrale dell’area, registra una prevalenza di re-perti in posizione orizzontale, attribuibili, alme-no in parte, ad una giacitura primaria, alternati a fasce deposizionali ad inclinazione accentuata, originate presumibilmente dai medesimi eventi colluviali di versante che determinano la gra-duale formazione del deposito. Al medesimo ambito cronologico vanno ascritti i resti di una tomba ad inumazione (t. 1), localizzata sul limi-te sudoccidentale della sponda sinistra del pale-oalveo, che, profondamente alterata dalle attivi-tà fluviali, conservava al suo interno pochi resti scheletrici, relativi agli arti inferiori.
Probabilmente nel corso della seconda età del Ferro, l’attivazione di un grande alveo fluviale in direzione sud-ovest/nord-est (us 44), riferibile ad un episodio di piena particolarmente intensa del Tanaro, causò l’erosione di parte dei deposti
pre-protostorici; successivamente, tra l’età del Ferro e l’età romana, la presenza di un livello al-luvionale sterile (us 5) indica la ripresa di feno-meni di esondazione del fiume, che provocarono l’abbandono momentaneo della frequentazione dell’area.
Il paleoalveo si disattivò progressivamente, presumibilmente in età romana, in seguito alla formazione di depositi (us 3) collegati ad eventi colluviali relativi al degrado dei vicini versanti col-linari: infatti, come confermato dalle analisi geo-archeologiche, i processi di disboscamento delle colline, connessi con l’apertura a pascolo e iniziati già a partire dall’antica età del Bronzo, prosegui-rono fino all’età romana, quando l’area venne in-tensamente coltivata e occupata da insediamenti a carattere rurale. (M.V.G.)
La sepoltura dell’antica età del Bronzo
Nella zona centroccidentale del cantiere, rispar-miata dall’attivazione dell’antico paleoalveo del Tanaro (us 44), al di sotto dell’us 6 si è individua-to, alla quota di ca. 175 m s.l.m., uno strato poco potente di sabbie ben selezionate di origine fluvia-le, con presenza diffusa al tetto di piccoli carboni (us 7), alterato da un suolo evoluto sotto prato-pascolo degradato, che riempiva un avvallamento di sabbie fini limose quarzoso-calcitiche di colore bruno-verdastro chiaro, del tutto sterile e con pre-senza di gasteropodi (us 8). L’us 7 era stata tagliata fino a intaccare la sottostante us 8 dalla fossa ret-tangolare (us 45) di una sepoltura a inumazione (t. 2) di un adulto giovane (Venturino Gambari et al. 2004, pp. 174-175; Gambari 2004b, p. 81), probabilmente all’interno di un tronco ligneo. Il defunto era deposto supino; mancava al momen-to dello scavo il cranio, mentre la mandibola e le ossa appartenenti alla porzione superiore del cor-po si trovavano scomposte e ridislocate sulle ossa del bacino, che assieme alle gambe giaceva in con-nessione anatomica. La datazione radiocarbonica della vertebra ABPS.01 (OZG039: 3534±39 BP) e la tipologia di un pugnale rinvenuto sul lato sini-stro del defunto in corrispondenza delle ossa del bacino datano la sepoltura ad un momento pieno o avanzato dell’antica età del Bronzo.
La fossa ha profilo subrettangolare (L. 2,4 m, l. 0,50 m, prof. 1,10 m) con margini molto re-golari e verticali ed è riempita da uno strato sabbioso-limoso di colore bruno-grigiastro scu-ro con abbondanti carboni (us 39) (figg. 48-49). Ad una estremità della fossa, in corrispondenza del capo del defunto, era stata scavata una buca
Fig. 47. Alba, corso Piave. Nuova Piscina Comunale. Posizionamen-
to del sito (indicato dall’asterisco, al centro dell’area evidenziata)
dell’antica età del Bronzo e dell’età del Ferro (scala 1:20.000) (C.T.R.
Piemonte).
NOTIZIARIO 207
oblunga (us 38), riempita da uno strato limoso-sabbioso bruno grigiastro (us 37). Lo scavo deve essere avvenuto in un momento successivo alla decomposizione del corpo, come documentato dalla dislocazione di alcuni elementi scheletrici. Al momento della manomissione della sepoltura, quindi, il sarcofago doveva essere ancora in buone condizioni e senza consistenti infiltrazioni di ter-ra, permettendo così lo spostamento e l’accumulo di parte delle ossa in un ambiente vuoto.
L’assenza del cranio e la ridislocazione delle ossa pongono alcuni interrogativi all’interpreta-zione del complesso: è possibile ipotizzare una violazione finalizzata alla ricerca di materiali pre-ziosi, come elementi metallici sul capo e sul petto, tuttavia occorre considerare anche la possibilità di trovarsi in presenza di rituali che comportano la riapertura della tomba per il prelievo di parti anatomiche, quali appunto il cranio, a proposito del quale si possono forse citare le sepolture ad inumazione sotto tumulo dell’antica età del Bron-zo di via S. Eurosia a Parma, con tracce di aspor-tazione intenzionale di ossa (Bronzoni et al. in
stampa). Il riempimento della buca us 38 è stato effettuato con accuratezza, riutilizzando la terra scavata, quindi o si è voluto celare completamen-te la profanazione oppure chi ha richiuso la buca aveva intenzione di ripristinare la situazione pre-cedente, modificata da un rituale di prelevamento del cranio, oppure porre rimedio alla violazione. In tal senso, il rinvenimento in prossimità della testa del femore sinistro di un pugnale in bronzo potrebbe far propendere per un’azione non dovu-ta a profanatori di tombe alla ricerca di metalli.
La posizione del pugnale, sul bacino al di sotto delle ossa del torace ridislocate, può essere inter-pretata in due maniere. In un caso, sarebbe stato portato alla cinta o deposto sul ventre, nell’altro l’attuale posizione dipende dalla manipolazione delle ossa della parte superiore del corpo. In tal caso sarebbe possibile che in origine fosse deposto sul petto del defunto, come il pugnale appare por-tato sulle statue-stele antropomorfe dell’età del Rame del Rouergue e della Linguadoca orientale (Maill 2010): l’immanicatura in alto a destra, la lama che scende verso il ventre, in una posizione
Fig. 48. Alba, corso Piave. Nuova Piscina Comunale. Planimetria della t. 2; il retino grigio indica i resti ossei in giacitura secondaria (ril. CO.R.A.
Società Cooperativa).
208 NOTIZIARIO
funzionale per essere sguainato e utilizzato rapi-damente in un combattimento con colpi di punta rivolti verso il basso.
Il pugnale ha la superficie corrosa, con nume-rose incrostazioni, ed è fortemente mutilo: man-ca del tutto la base e si conserva solamente un piccolo rivetto, privo della capocchia, su uno dei lati; anche se la punta è lacunosa, si può ipotiz-zare una lunghezza complessiva di 9 cm. La lama ha invece i margini piuttosto ben conservati, ret-tilinei, e sezione lenticolare (fig. 50). Lungo uno dei margini si conservano due linee parallele di piccole tacche, che tuttavia non paiono essere un motivo decorativo. L’assenza della base non consente una precisa identificazione tipologica; la forma è compatibile con i pugnali tipo Lussan, a base piatta o leggermente arrotondata con due rivetti, lama triangolare lunga tra i 6,5 e i 9 cm, presente nei contesti funerari del Bronzo Antico della Francia meridionale (Gallay 1981, pp. 53-59, nn. 146-156), e con il tipo Mercurago, variante A, a base larga con due rivetti distanti e sezione lenticolare, tranne che per l’esemplare dal sito eponimo, diffuso in tutta la penisola italiana in un momento avanzato del Bronzo Antico (Bianco Peroni 1994, pp. 40-44, nn. 313-326). In ambito funerario, un esemplare era presente nella tomba a inumazione sotto tumulo di Selvis di Reman-zacco (UD), sulla parte sinistra del torace (Vitri1983, figg. 12-13). Qualora la base fosse stata ori-ginalmente ad arco e a tre rivetti, si ricolleghereb-be al tipo Caunes, prossimo al tipo Lussan, e con esemplari della Francia orientale e meridionale datati a un momento centrale dell’antica età del Bronzo, per il quale si conoscono esemplari con decorazione a due linee parallele lungo il tagliente (Gallay 1981, pp. 62-63, nn. 171-176), o al tipo San Maurizio, dalla definizione piuttosto ampia, per lo più con tre rivetti, margini rettilinei e se-zione lenticolare, diffuso nell’Italia centrosetten-trionale in momenti avanzati del Bronzo Antico (Bianco Peroni 1994, pp. 32-35, nn. 236-263); in Piemonte il tipo Caunes è attestato con un esem-plare nella grotticella sepolcrale della Boira Fusca di Cuorgnè (TO) (Cima 2001, fig. 57).
Le cronologie proposte per il pugnale sulla base dell’analisi cronotipologica sono compatibili con la datazione radiocarbonica dei resti ossei dell’i-numato (OZG039: 3534±39 BP), che calibrata a 2σ corrisponde all’intervallo 1.980-1.740 BC, con probabilità al 95,4%. La tomba risulta isolata in un’area perifluviale che, sulla base delle analisi, nell’antica età del Bronzo era caratterizzata da un ambiente disboscato occupato da una vasta
Fig. 49. Alba, corso Piave. Nuova Piscina Comunale. Tomba 2 (a), con
particolare del pugnale in bronzo (b) (foto CO.R.A. Società Cooperativa).
b
a
NOTIZIARIO 209
prateria, probabilmente sfruttata per l’allevamen-to del bestiame, con una situazione analoga a quanto documentato, sempre in un’area pedecol-linare del bacino del Tanaro, nel coevo sito indi-viduato in prossimità dello svincolo autostradale Asti Est dell’autostrada A21 Torino-Piacenza (Ba-rello et al. 2007). (F.R.B.)
Analisi antropologica
A seguito dello studio antropologico dei resti umani si può confermare come si tratti di una inu-mazione individuale in giacitura primaria, anche se parzialmente scomposta a seguito di un distur-bo avvenuto in antico, come sopra documentato.
Sono presenti pressoché tutti gli elementi dello scheletro ad eccezione del cranio, mentre è con-servata la mandibola. I resti scheletrici umani si trovavano al momento del reperimento solo par-zialmente nella loro collocazione anatomica, in quanto le porzioni relative alla parte superiore del corpo, in particolare mandibola, elementi del cinto scapolare di entrambi i lati, strutture toraci-che ed elementi degli arti superiori, si trovavano scomposti, dislocati, ruotati e parzialmente so-vrapposti senza più alcun rispetto dei loro origi-nari rapporti articolari. Il bacino e gli arti inferio-ri sono stati rinvenuti invece rispetto ai rapporti anatomici nella loro collocazione primaria, o co-munque non hanno subito dislocazioni riferibili a disturbi postdeposizionali.
Per quanto riguarda le condizioni di conserva-zione e leggibilità delle superfici ossee va sottoli-neato come ci si trovi di fronte a una situazione particolarmente favorevole. Gli elementi schele-trici sono infatti quasi tutti interi, o ricomposti a partire da due porzioni o poco più, salvo poche eccezioni come nel caso delle coste o di isolati casi. Sono conservate anche parti dello scheletro che solitamente hanno più difficoltà a pervenire
allo studio in quanto particolarmente fragili, quali le scapole e le ossa del bacino, nonché lo sterno, coste e vertebre in particolare. Ottime quindi le condizioni in termini di interezza degli elementi scheletrici e di leggibilità delle superfici.
Lo studio antropologico ha permesso di desume-re, da aspetti morfometrici della mandibola e ossa del bacino, che si tratti di un soggetto maschile. In quanto all’età biologica la morte sarebbe avvenuta ad un’età adulto giovane, come documentano pa-rametri rilevati sul bacino, coerenti con le genera-li condizione dentarie, paradentarie e il livello di usura occlusale, che confermano il raggiungimen-to dell’età adulta, ma comunque giovane.
L’inumato è al momento oggetto di analisi allo scopo di rilevare eventuali indicatori osteologici di attività, di stress di tipo alimentare o biomec-canico funzionale e di completare l’interpretazio-ne dell’individuo nel suo specifico contesto e nel confronto con altre inumazioni rinvenute in altri siti albesi. Di particolare interesse sono alcune evidenze scheletriche di alterazione dei processi di fusione tra nuclei di ossificazione di parti ossee, per difetto o per eccesso a seconda dell’elemento scheletrico. (M.M.C.)
Le strutture di abitato della prima età del Ferro
Nel settore settentrionale del cantiere il paleo-suolo dell’età del Bronzo (us 7) è coperto da un deposito colluviale pedogenizzato di colore bruno (us 6, quota media 175,51-175,61 m s.l.m.), della potenza di ca. 50-60 cm e contenente al suo in-terno elementi di fauna e frr. ceramici dell’età del Ferro. L’orizzonte superiore di us 6 è tagliato da una serie di strutture (uuss 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35) (fig. 51), dai riempimenti delle quali (uuss 15, 17, 19, 29, 35) sono stati re-cuperati abbondante materiale ceramico, fauna e scarsi frr. metallici, tra cui resti di una fibula a ca-vallino in bronzo. La localizzazione delle struttu-re non ha mostrato la presenza di allineamenti si-gnificativi e l’erosione del piano d’uso di us 6 non ha premesso di verificare con certezza la presenza di unità insediative stabili; si segnalano tuttavia le fosse us 22, che conteneva la parte inferiore di un grande vaso ovoide a fondo piatto diritto, in impasto grossolano di colore bruno, interrato presumibilmente per la conservazione di derrate alimentari, e us 24, probabile area di cottura, con-servata solo parzialmente in quanto ubicata sulla sponda del paleoalveo del Tanaro, che presentava al suo interno tracce di terreno rubefatto.
L’esame della totalità dei frr. ceramici evidenzia
Fig. 50. Alba, corso Piave. Nuova Piscina Comunale. Tomba 2. Pugnale
in bronzo (foto Docilia s.n.c.; dis. F. Rubat Borel - S. Salines).
210 NOTIZIARIO
la maggiore presenza dell’impasto grossolano, anche se sono ben attestati gli impasti semifine e fine, con le superfici rifinite con cura.
Le forme chiuse (fig. 52, 1-11) sono rappresen-tate per lo più da olle e ollette ovoidi o globulari, in impasto grossolano o semifine, a fondo piatto diritto o a tacco (uuss 39 e 19) e orlo generalmen-te estroflesso, con decorazioni impresse, sia di-gitali che strumentali, collocate sull’orlo (us 37), all’attacco della parete (us 19) e sulla spalla (uuss 15, 19, 29), che mostrano strette analogie con le olle da dispensa e da cucina rivenute nelle fasi databili dal IX all’VII secolo a.C. in numerosi siti piemontesi (Ferrero - Venturino Gambari2008, p. 23, fig. 8, 1-3 e 6). Più rara risulta la pre-senza di vasi situliformi, caratterizzati dalla de-corazione ad impressioni strumentali sulla spalla (us 6) (Ferrero - Venturino Gambari 2008, p. 23, fig. 8, 7). Fra le decorazioni riferibili a forme chiuse, si segnala ancora la presenza di cordoni a tacche digitali (uuss 6, 37), appartenenti a vasi realizzati in impasto grossolano (Ferrero - Ven-turino Gambari 2008, p. 23, fig. 8, 4-5).
Piuttosto vario è invece il repertorio delle for-me aperte (figg. 52, 18-24 e 53, 1-11). Sono pre-senti tipi dall’ampia diffusione e scarsamente ca-ratterizzanti dal punto di vista crono-tipologico, come scodelle e scodelloni troncoconici inornati, in impasto sia grossolano che semifine (uuss 17, 19), diffusi per tutta l’età del Ferro (per la prima età del Ferro si veda, ad esempio, Ferrero - Ven-turino Gambari 2008, p. 23, fig. 9, 5; per la se-conda età del Ferro, cfr. Ferrero et al. 2004 con
bibliografia precedente). Tra le scodelle di questo tipo si segnala, in particolare, un frammento in impasto grossolano con una profonda tacca di for-ma semicircolare sull’orlo, interpretabile come un beccuccio-versatoio (us 17), che trova analogie con un analogo frammento da Pocapaglia di Bra, sito databile tra l’VIII e la prima metà del VI secolo a.C. (Venturino Gambari 1988, tav. XLVIII, 14).
Le scodelle troncoconiche con orlo leggermen-te estroflesso ed appiattito a formare una piccola tesa (uuss 15, 19) sono una forma di tradizione transalpina, inquadrabile cronologicamente al IX-VIII secolo a.C. (Vital 1990, fig. 7, 3-4) e già atte-stata in Piemonte, ad esempio a Cavour (Menza-no 1996-1997, tav. 17) e Verrua Savoia (Ferrero1999-2000, tav. 20, 100) nel Torinese, e a Fonti di Villaromagnano nell’Alessandrino (Cappelli - Serafino 1998, fig. 4, 3 e 7). Alla stessa cronologia rimandano gli esemplari, piuttosto rari, di scodelle tronconiche con orlo appiattito appena estroflesso e parete decorata da serie di impressioni oblique a stecca (us 19), che trovano confronti nel Cunee-se (Ferrero - Venturino Gambari 2008, p. 23, fig. 9, 6) e sembrano derivare da modelli noti nelle prime fasi degli abitati in area golasecchiana occi-dentale (Gambari 1988, tav. LXII, 4).
Anche le scodelle carenate, a parete più o meno svasata, realizzate in impasto semifine, di colore bruno-grigio scuro e di fattura più accurata (uuss 15, 17, 19), rimandano all’inoltrato IX-VII secolo a.C., con attestazioni nel Cuneese, a Roccavione, loc. Bec Berciassa (Ferrero - Venturino Gam-bari 2008, p. 23, fig. 9, 7-9) e a Pocapaglia di Bra (Venturino Gambari 1988), e nel Canavese (Rubat borel 2006, fig. 2, B 17 e p. 11 per i con-fronti in Savoia).
Ad una occupazione dell’area fino alla fase finale della prima età del Ferro, entro il VI secolo a.C., sono riconducibili le scodelle a vasca emisferica e orlo appiattito e leggermente ingrossato (uuss 19, 29), finora scarsamente attestate nei contesti della prima età del Ferro del Cuneese (Ferrero - Ven-turino Gambari 2008, p. 23, fig. 9, 10), mentre appaiono più comuni negli abitati di Castelletto Ticino e per le quali è stata ipotizzata un’influenza dell’area etrusco-padana (Martignetti - Ruffa 1998, fig. 4, 1, forma C6 e p. 305).
Anche le forme potorie (fig. 53, 12-17), in impasto semifine e fine, rimandano a tipologie vascolari note nei siti piemontesi della prima età del Ferro. I bicchieri ovoidi o globulari (uuss 6, 29), derivati da quelli del G IA, IB e IC, sono ampiamente presenti nei siti di abitato della prima età del Ferro del Piemonte occidentale (Ferrero - Venturino
Fig. 51. Alba, corso Piave. Nuova Piscina Comunale. Planimetria delle
strutture della prima età del Ferro (ril. CO.R.A. Società Cooperativa).
NOTIZIARIO 211
Fig. 52. Alba, corso Piave. Nuova Piscina Comunale. Ceramica della prima età del Ferro: forme chiuse (1-11), pareti (12-15 e 25), fondi (16-17),
forme aperte (19-24) (dis. S. Salines).
212 NOTIZIARIO
Fig. 53. Alba, corso Piave. Nuova Piscina Comunale. Ceramica della prima età del Ferro: forme aperte (1-11) e potorie (12-17), anse (18-20), fondi
(21-23) e fusaiola (24) (dis. S. Salines).
NOTIZIARIO 213
Gambari 2008, p. 26, fig. 8, 8) e risultano ancora attestati, pur sporadicamente, nella media età del Ferro, come a Villa del Foro (Cattaneo Cassano - Giaretti 1998, fig. 4, 9). Sono presenti anche i bicchieri carenati (us 17), meno diffusi nei contesti del Piemonte occidentale, con richiami agli esemplari golasecchiani del G II B (De Marinis 1981, tav. III; Schindler - De Marinis 2000, pp. 166-167, fig. 8), che sembrano costituire gli antecedenti degli esemplari carenati del V secolo a.C. (Cavour: Menzano 1996-1997;Montecastello: Cattaneo Cassano - Giaretti 1998, fig. 4, 10). A forme potorie, come boccali o piccole ollette ansate (cfr. Castelletto Ticino: Martignetti - Ruffa 1998, fig. 4, 3, forma E) sono probabilmente riferibili i pur scarsi frr. di anse a nastro, realizzate in impasto semifine (uuss 6, 37) (Ferrero - Venturino Gambari2008, p. 26, fig. 9, 11-12).
Per quanto riguarda i reperti ceramici non va-scolari si segnala la presenza di una fusaiola (us 35) (fig. 53, 24) in impasto bruno, di forma bi-troncoconica simmetrica, con pareti a profilo quasi rettilineo, carena arrotondata e basi supe-riore e inferiore concave. Le fusaiole, per le loro caratteristiche funzionali, sono scarsamente ca-ratterizzate dal punto di vista morfologico, risul-tando poco utili per una definizione cronologi-ca; è comunque possibile richiamare, nel nostro caso, la stretta analogia con alcune fusaiole rin-venute in corredi della fase II della necropoli di Chiavari, tra il secondo e il terzo quarto del VII secolo a.C. (tipo Fus(fit) T 06: Paltineri 2010, p. 106, fig. 129, tt. 74A e 104B).
Di grande interesse è la presenza della fibula in bronzo (us 6) (Gambari 2004a) (fig. 54); il re-perto, di piccole dimensioni (L. max cons. 3,8 cm; h. max 2,7 cm), privo di parte della staffa e dell’ardiglione, è riconducibile al tipo “con arco zoomorfo” della tipologia della von Eles, caratte-rizzato dall’arco configurato a forma di animale di vario tipo (ariete, cavallo, etc…) ed attestato, pur con un numero piuttosto ridotto di esempla-ri, su un ampio territorio, dall’Etruria, tirrenica e padana, all’Italia settentrionale (per Este, Ca-stelletto Ticino, Chiavari: von Eles Masi 1986, p. 244 tavv. 188-189, con bibliografia precedente; per la Valle d’Aosta: Mollo Mezzena 1997, tav. 27, 7). La concentrazione di un buon numero di queste fibule e con diverse varianti nelle necro-poli del Bolognese ha fatto ipotizzare una produ-zione locale, con l’elaborazione in forme originali di motivi del repertorio orientalizzante (Princi-pi etruschi 2000, pp. 354-355, nn. 485-490). In
particolare, la nostra fibula per la staffa lunga, la molla a doppio avvolgimento, l’arco configurato a cavallino, caratterizzato dall’assenza della cri-niera, dalla forma assottigliata del corpo dell’a-nimale e del muso, allungato e cilindrico, rivolto in avanti, e delle orecchie ritte, trova strette ana-logie con l’esemplare della t. 4 di Casalecchio di Reno, via Isonzo, proprietà Buriani, della prima metà del VII secolo a.C. (Kruta Poppi 2010, p. 216 Cat. 465, tav. XLIII), e con due, pur di minori dimensioni, da Este, datati alla seconda metà del VII secolo a.C. (von Eles Masi 1986, p. 244 nn. 2538-2539, tav. 189, con bibliografia precedente).
I materiali provenienti dalle strutture dell’età del Ferro sembrano indicare una occupazione di quest’area tra l’VIII e il VI secolo a.C. e mostrano caratteristiche analoghe a quelli di altri siti coevi del Cuneese a riprova di una vasta omogeneità culturale; il rinvenimento è di particolare inte-resse in quanto conferma, insieme alle sepoltu-re di via Terzolo (Venturino Gambari et al. 2009), la presenza ad Alba di orizzonti riferibili alla prima età del Ferro, fino ad ora solo scarsa-mente documentati.
Il ritrovamento, ad Alba, della fibula a cavalli-no, costituisce inoltre un’ulteriore conferma de-gli stretti contatti tra la popolazioni del Piemonte sudoccidentale e i centri villanoviani ed etruschi dell’Emilia, che tra VIII e VI secolo a.C. attiva-rono un sistema commerciale gestito in loco da mercanti etruschi e italici d’intesa con i capilocali, che sembra organizzarsi soprattutto lun-go le vie fluviali ed indirizzarsi prevalentemen-te verso le ricche concentrazioni di minerali di rame del comprensorio del Queyras, facilmente raggiungibile dalla pianura padana risalendo il Tanaro, almeno fino a Pollenzo, e poi proseguen-do attraverso i passi delle valli del Varaita (col-le dell’Agnello) e del Po (colle delle Traversette) (Gambari 1995; 2004a, con bibliografia prece-dente). (L.F.)
Fig. 54. Alba, corso Piave. Nuova Piscina Comunale. Fibula a cavalli-
no in bronzo (foto M. Magnasco; dis. S. Salines).
214 NOTIZIARIO
Barello F. et al. 2007. Barello F. - Venturino Gambari M. - Rubat Borel F. - Arobba D. - Ottomano C., Asti, au-tostrada A21 Torino-Piacenza, svincolo autostradale Asti Est. Materiali dell’antica età del Bronzo e strada glareata di età romana, in Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 22, pp. 227-231.
Bianco Peroni V. 1994. I pugnali nell’Italia continentale,Stuttgart (Prähistorische Bronzefunde, VI,10).
Bronzoni L. et al. in stampa. Bronzoni L. - Bernabò Brea M. - Cremaschi M. - Gastaldello M. - Cenci L. - Sal-vadei L., I tumuli del Bronzo Antico rinvenuti a Sant’Eurosia (PR), in Preistoria e protostoria dell’Emilia Romagna. Atti del-la XLV riunione scientifica dell’Istituto italiano di preistoria e protostoria, Modena 26-31 ottobre 2010, Firenze.
Cappelli C. - Serafino C 1998. Il sito protostorico di Fonti di Villaromagnano (AL), in Preistoria e protostoria del Piemon-te. Atti della XXXII riunione scientifica dell’Istituto italiano di preistoria e protostoria, Alba 29 settembre - 1 ottobre 1995,Firenze, pp. 265-278.
Cattaneo Cassano A.C. - Giaretti M. 1998. La media età del Ferro nella Valle del Tanaro, in Preistoria e protostoria del Piemonte. Atti della XXXII riunione scientifica dell’Istituto ita-liano di preistoria e protostoria, Alba 29 settembre - 1 ottobre 1995, Firenze, pp. 313-325.
Cima M. 2001. L’uomo antico in Canavese, Torino.
De Marinis R.C. 1981. La ceramica della prima tomba di guer-riero di Sesto Calende e nuove osservazioni sulla cronologia del Golasecca I, in Rivista archeologica dell’antica diocesi e provin-cia di Como, 163, pp. 5-35.
von Eles Masi P. 1986. Le fibule dell’Italia settentrionale,München (Prähistorische Bronzefunde, XIV, 5).
Ferrero L. 1999-2000. Il sito protostorico di Verrua Savoia,Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Let-tere e Filosofia, relatore prof.ssa C. Chiaramonte Trerè.
Ferrero L. et al. 2004. Ferrero L. - Giaretti M. - Padovan S., Gli abitati della Liguria interna: la ceramica domestica, in La Liguria interna nella seconda età del Ferro. Atti del congresso in-ternazionale, Mondovì 26-28 aprile 2002, Bordighera, pp. 51-80.
Ferrero L. - Venturino Gambari M. 2008. Preistoria e protostoria nella valle del Gesso, in Ai piedi delle montagne. La necropoli protostorica di Valdieri, a cura di M. Venturino Gambari, Alessandria, pp. 15-40.
Gallay G. 1981. Die kupfer- und altbronzezeitlichen Dolche und Stabdolche in Frankreich, München (Prähistorische Bron-zefunde, VI, 5).
Gambari F.M. 1988. Castelletto Ticino. Abitati e necropoli gola-secchiani, in Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 8, p. 195.
Gambari F.M. 1995. L’età del Bronzo e l’età del Ferro: naviga-zione, commercio e controllo del territorio, in Navigatori e con-tadini. Alba e la valle del Tanaro nella preistoria, a cura di M. Venturino Gambari, Torino (Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte. Monografie, 4), pp. 27-49.
Gambari F.M. 2004a. L’etnogenesi dei Liguri cisalpini tra l’età del Bronzo Finale e la prima età del Ferro, in Ligures Celeberrimi. La Liguria interna nella seconda età del Ferro. Atti del congresso in-ternazionale, Mondovì 26-28 aprile 2002, Bordighera, pp. 11-28.
Gambari F.M. 2004b. Le vie tra il grande fiume e il mare. Le prime fasi dell’età del Bronzo nelle valli Curone e Grue, in Alla conquista dell’Appennino. Le prime comunità nelle valli Curo-ne, Grue e Ossona, a cura di M. Venturino Gambari, Torino, pp. 79-88.
Kruta Poppi L. 2010. Le tombe di Casalecchio di Reno (BO), via Isonzo. Una famiglia di maggiorenti di epoca orientalizzante,in Cavalieri etruschi dalle valli al Po. Tra Reno e Panaro, la valle del Samoggia nell’VIII e VII secolo a.C., a cura di R. Bugio - S. Campagnani - L. Malnati, Bologna, pp. 195-217.
Maill M. 2010. Hommes et femmes de pierre. Statues-menhirs du Rouergue et du Haut-Languedoc, Toulouse.
Martignetti P. - Ruffa M. 1998. Insediamenti protostorici a Castelletto Ticino (NO), in Preistoria e protostoria del Piemon-te. Atti della XXXII riunione scientifica dell’Istituto italiano di preistoria e protostoria, Alba 29 settembre - 1 ottobre 1995,Firenze, pp. 297-311.
Menzano A. 1996-1997. L’insediamento protostorico della Rocca di Cavour (TO), Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore prof.ssa C. Chia-ramonte Trerè.
Mollo Mezzena R. 1997. L’età del Bronzo e l’età del Ferro in Valle d’Aosta, in La Valle d’Aosta nel quadro della preistoria e protostoria dell’arco alpino centro-occidentale. Atti della XXXIriunione scientifica dell’Istituto italiano di preistoria e proto-storia, Courmayeur 2-5 giugno 1994, Firenze, pp. 139-223.
Paltineri S. 2010. La necropoli di Chiavari. Scavi Lamboglia (1959-1969), Bordighera-Chiavari (Saltuarie dal laboratorio del Piovego, 8)
Principi etruschi 2000. Principi etruschi tra Mediterraneo ed Eu-ropa, Catalogo della mostra, Venezia.
Rubat Borel F. 2006. Contributo per la definizione dell’areale Taurino-Salasso: i reperti dell’età del Ferro di Belmonte e della Paraj Àuta (900-4000 a.C.), in Bulletin d’études préhistoriques et archéologiques alpines, XVII, pp. 9-36.
Schindler M.P. - De Marinis R.C. 2000. L’età del Ferro nel Canton Ticino e nella Mesolcina, in I Leponti tra mito e realtà. Raccolta di saggi in occasione della mostra, a cura di R.C. De Marinis - S. Biaggio Simona, Locarno, pp. 159-183.
Venturino Gambari M. 1988. Pocapaglia, loc. Strada Valle. Insediamento della prima età del Ferro, in Quaderni della So-printendenza archeologica del Piemonte, 8, pp. 179-180.
Venturino Gambari M. et al. 2004. Venturino Gambari M. - Cerrato N. - Ottomano C., Alba, loc. San Cassiano (nuova piscina comunale). Sepoltura dell’antica età del Bronzo e strutture d’abitato della prima età del Ferro, in Quaderni del-la Soprintendenza archeologica del Piemonte, 20, pp. 174-176.
Venturino Gambari M. et al. 2009. Venturino Gambari M. - Ferrero L. - Giaretti M., Alba, via Terzolo. Tombe a cre-mazione sotto tumulo entro recinto funerario, in Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 24, pp. 200-205.
Vital J. 1990. Protohistoire du Defilé de Donzère. L’âge du Bronze dans la Baume des Anges (Drôme), Paris.
Vitri S. 1983. I tumuli del Friuli, in Preistoria del Caput Adriae,Catalogo della mostra, Udine, pp. 84-86.
Bibliograia