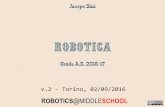Linee guida sulla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
Radicondoli: i percorsi del paesaggio. La Guida
Transcript of Radicondoli: i percorsi del paesaggio. La Guida
La Guida
Bag
gian
i - Gen
nai | R
AD
ICO
ND
OLI: I P
ER
CO
RSI D
EL PA
ESA
GG
IO
La Gu
ida
Il paesaggio di Toscana è un’esperienza estetica diffusa e condivisa. E’ un archetipo famoso nel mondo per l’idea di armonia cui rimanda, connotata dal Rinascimento, se-gno di bellezza, di cultura e di arte. Il paesaggio che si apre intorno Radicondoli è un classico e meraviglioso paesaggio toscano, che ci piace e ci commuove.
Questa Guida propone sei percorsi posti all’interno del territorio comunale, pensati per rendere l’esperienza di lettura semiotica del paesaggio accessibile a tutti.
Percorrendo ogni itinerario e usando gli strumenti grafici e testuali contenuti in questa Guida il turista può pene-trare i segreti del territorio che osserva trasformando l’armonia e la bellezza in conoscenza e appagamento.
Considerare il territorio nella sua dimensione contem-plativa di paesaggio un luogo di sapere non è cosa scontata. La bellezza e la cultura hanno molto in comu-ne, ma cosa? Rispondere vuol dire andar oltre ciò che l’immagine visiva istantaneamente suggerisce; significa prendere spunto dalla bellezza e predisporsi a leggere il testo-paesaggio con pazienza e un po’ di applicazione.
Il risultato sarà straordinario.
La Guida
I PERCORSI DEL PAESAGGIO
RADICONDOLI
Daniele Baggiani - Paolo Gennai
Comune di Radicondoli
copertina_Radicondoli.indd 1 14/09/14 21:44
RADICONDOLII PERCORSI
DEL PAESAGGIO
La Guida
Daniele Baggiani - Paolo Gennai
Comune di Radicondoli
la_guida_radicondoli.indd 1 01/09/14 12:18
Sommario
5
7
14
20
23
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
63
157
161
167
171
Progetto e redazione: Daniele Baggiani, Paolo Gennai
Progetto tecnico e installazioni: Arch. Silvia Ribechini
Progetto GraficoX-BrainFrancesco BorgianniIrene Torresi
ISBN:
Vietata la riproduzione anche parziale di qualsiasi parte del testo senza autorizzazione.
© Comune di RadicondoliTutti i diritti riservati agli autori
Stampa:
PRESENTAZIONE
INTRODUZIONE
GUIDA ALLA LETTURA
QUADRO GENERALE DEI PERCORSI
I PERCORSI
Percorso 1 - Casettino
Punto panoramico 1: PIAZZETTA BECUCCI
Punto panoramico 2: TRABOCCO
Punto panoramico 3: CANTERIE
Percorso 2 - Lucignano
Punto panoramico 4: PAUGNANO
Punto panoramico 5: PORTA OLLA
Percorso 3 - Colombaione
Punto panoramico 6: MONTEMAGGIORI
Punto panoramico 7: BASILICO
Percorso 4 - Tesoro
Punto panoramico 8: PIAZZETTA BECUCCI
Punto panoramico 9: PODERE TESORO
Percorso 5 – Belforte
Punto panoramico 10: L’OLMO
Punto panoramico 11: CIMITERO
Percorso 6 – Anqua
Punto panoramico 12: VILLA DI ANQUA
Punto panoramico 13: CROCI
LE SCHEDE
BIBLIOGRAFIA
INDICE DELLE SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
INDICE DEI LUOGHI
GLOSSARIO
3
la_guida_radicondoli.indd 2-3 01/09/14 12:18
Presentazione
Sono arrivata per caso nei dintorni di Radicondoli nel mese di maggio del 1983, e non me ne sono più andata.Da cittadina urbana quale ero, ne sono stata subito rapita, prima ancora di rendermi conto di quanto immergermi nella vista del paesaggio o camminare i suoi sentieri in questa na-tura generosa e a tratti ancora selvaggia rappresentasse per me un’appagante esperienza fisica di benessere e profondo radicamento alla terra, o di quanto gironzolare nei borghi di Radicondoli e Belforte correggesse il mio tempo giovanile in tranquillità, e con i loro scorci mozzafiato quanto mi suggeris-se intimamente il coraggio dello spazio e del guardare oltre dall’alto, oltre a una collina e poi ancora oltre a un’altra e un’al-tra ancora, fino a perdermi in una assorta meditazione. Il paesaggio come cura quindi, come senso di espansione e respiro dell’anima. Ma anche un percorso nella memoria del territorio così come le donne e gli uomini lo hanno trasformato nei secoli con il loro lavoro nei campi, con la rete di sentieri e strade sterrate che collegano i poderi e gli antichi borghi costruiti e modificati in una antropomorfizzazione senza fine del paesaggio, nella cui antica cultura riconoscersi e rifugiarsi.Essere umani in luoghi come questi indica la giusta armonia dell’esistere “insieme”, dona il conforto dell’appartenenza e l’esperienza dell’entrare in risonanza con ciò che ci circonda, e la consapevolezza di quanto tutto questo sia prezioso ispi-ra il desiderio di condividerlo con quanti, cittadini e benvenuti ospiti, vorranno abitare, anche se per poco, questi luoghi. Un ringraziamento dal cuore quindi agli autori de I Percorsi del Paesaggio, per il loro lavoro di guida complesso ed efficace, che restituisce in un corpo unico occhi e voce, profumi colori e ricordi a questa terra meravigliosa, sonnolenta e forte, che con pazienza e benevolenza sopporta nel tempo i suoi innu-merevoli figli, nativi e acquisiti, a volte grati a volte un po’ di-stratti ma che se ne innamoreranno comunque per sempre.
ELENA ZWEYER
ASSESSORE TURISMO E CULTURA
COMUNE DI RADICONDOLI, SIENA
55
la_guida_radicondoli.indd 4-5 01/09/14 12:18
Introduzione
Il paesaggio è un’esperienza estetica diffusa e condivisa (Ja-kob, 2009); e il paesaggio toscano è, sotto molti punti di vista, un archetipo di paesaggio. La Toscana, infatti, è nota nel mon-do intero proprio per l’idea di paesaggio cui rimanda, conno-tata dal Rinascimento, segno di bellezza, di armonia e di arte1. Per questo nel mondo la Toscana è un mito, un mito contem-poraneo (Bonelli Conenna-Brilli-Cantelli, 2004) .Se la qualità del paesaggio toscano è indiscutibile, appena ci si chiede quali ne siano gli elementi costitutivi, a cosa sia dovuta tale sensazione di bellezza e di pace, in cosa consista, in con-creto, il sentimento di equilibrio che si prova guardando dall’al-to una porzione di territorio segnata dalla linea delle colline toscane, le risposte diventano subito difficili. L’estetica lascia il passo all’ecologia del paesaggio e a infinite questioni culturali.A tali questioni fa riferimento il progetto Radicondoli. I Percorsi del Paesaggio, il cui intento è quello di rendere disponibili al tu-rista, interessato ad approfondire il dato estetico che apprez-za recandosi a Radicondoli, alcuni strumenti utili a penetrare le dinamiche storico-culturali sottostanti il genius loci radicon-dolese. Sì, perché Radicondoli è un vero e proprio regno del paesag-gio, collocato a metà strada tra la dolcezza delle Crete Senesi e l’asprezza delle Colline Metallifere. Un ambiente, quello se-gnato dal limite comunale e dai crinali dintorno, piccolo, rac-colto allo sguardo, ma tanto caratterizzato da poter essere considerato un vero e proprio laboratorio. Un ambiente per-fetto per un prodotto di turismo attivo dedicato al paesaggio. Fare turismo in Toscana significa sicuramente fare cultura. Ma che il paesaggio sia esso stesso cultura, in quanto sintesi di stratificazioni ambientali, storiche e culturali, non è ancora entrato nel senso comune. I curatori di questa guida vanno addirittura oltre questo ragionamento: pensano che il paesag-gio di Radicondoli debba essere giudicato un museo in sé; un museo all’aperto, che esiste naturalmente in quanto luogo di testimonianze storiche e culturali degne del massimo interes-se: tracce, impronte e reperti di grande e piccola entità che ognuno può identificare, contemplare e comprendere nella loro sostanza e nelle loro interdipendenze anche grazie all’a-iuto offerto da questa Guida.Che il paesaggio non sia un bene semplicemente estetico o da conservare in modo improduttivo, ma che occorra risco-prirne il valore e pensare a come valorizzarlo lo notava già,
1 Non a caso la Convenzione Europea del Paesaggio si è tenuta, nel 2000, a Firenze. Conservazione e valorizzazione culturale del pae-saggio sono oggetto di raccomandazioni e di normative europee (cfr. Teofili-Clarino, 2008).
7
la_guida_radicondoli.indd 6-7 01/09/14 12:18
formazioni di merito sulle differenti testimonianze, e iniziare a capire e “vedere“ il territorio nel quale si trova immerso. Questa Guida propone un metodo e un gruppo di strumenti con i quali sciogliere i nodi della sintesi paesaggistica, con il risultato di permettere a chi guarda di passare dallo sgomen-to della bellezza all’appagamento della comprensione. L’idea è ambiziosa ma i dispositivi di lettura offerti in queste pagine sono studiati per essere chiari e fruibili a tutti.È certo che per capire il paesaggio nei suoi segni e nei suoi rapporti occorre la giusta disposizione d’animo. La fretta è nemica della cognizione. Tempo, calma e ordine sono ciò che serve. Si osserva meglio il paesaggio se lo spirito è se-reno; l’uomo deve prima ritrovare se stesso nel contatto con la natura; camminando lentamente si favoriscono attenzione e pensieri. Per questo i percorsi necessitano di un modesto sforzo fisico per raggiungere i tredici punti panoramici dai quali contemplare il territorio prospiciente i paesi di Radicondoli, di Belforte e di Anqua.Attraverso i pannelli informativi predisposti sul terreno e le in-formazioni contenute in questa Guida, il turista attento può identificare e leggere ogni impronta colta a colpo d’occhio, senza temere di tralasciare nulla, senza farsi sopraffare dalla complessità di ciò che vede. Gli strumenti a disposizione di chi osserva sono fondamental-mente cinque.(1) I PERCORSI. Ognuno dei 6 percorsi proposti costituisce un’esperienza differente.(2) I PUNTI PANORAMICI (PP). Ognuno dei 12 Punti Panorami-ci collocati lungo i percorsi dà modo di entrare in contatto con una differente porzione di territorio.(3) I PROFILI DEL PAESAGGIO esemplificano, la porzione di paesaggio colta da uno specifico PP riducendone la comples-sità e permettendone così la lettura, in modo analogo a quan-to fa una cartina geografica rispetto al luogo cui si riferisce. Su ogni PP sono localizzati i reperti contenuti nella porzione di territorio abbracciata dallo sguardo, per ognuno dei quali è stata preparata una Scheda di approfondimento, contenuta in questa Guida.(4) LE MATRICI DEL PAESAGGIO enumerano i reperti e le im-pronte presenti nel panorama osservato classificandoli per tipologia e per l’età storica.(5) LE SCHEDE DI APPROFONDIMENTO forniscono informa-zioni su ogni reperto e testimonianza annotata sui profili e sulle matrici, dando modo allo spettatore di riconnetterli gli uni alle altre. Utilizzati in maniera combinata, gli itinerari, i punti panoramici, i profili, le matrici del paesaggio, le schede di approfondimento ci aiutano a leggere la scena, indicando le stratificazioni stori-che e le connessioni naturali e antropiche tra gli elementi pre-senti sul territorio. Mediante questi cinque strumenti il turista può concretizzare l’esperienza di osservazione traducendo un fatto percettivo nella personale lettura, cognitiva e semioti-ca, di ciò che sta guardando.
molti anni fa, Piero Camporesi (1983). Da allora gli studi sul valore e sul significato del paesaggio si sono moltiplicati, inve-stendo varie discipline scientifiche e umanistiche2.Considerare il territorio nella sua dimensione contemplativa un luogo di sapere non è cosa scontata. Certo la bellezza e la cultura hanno molto in comune. Ma che cosa? Afferrarlo vuol dire andare oltre ciò che l’immagine visuale istantaneamente ci suggerisce; significa prendere spunto dalla meraviglia e pre-disporsi a leggere il testo-paesaggio con pazienza e con po’ di applicazione. Il risultato sarà straordinario. I Percorsi del Paesaggio di Radicondoli sono pensati per ren-dere questa esperienza possibile a tutti. Vogliono essere un modo – snello e fruibile – per cogliere il senso di ciò che os-serviamo e che ci commuove e per moltiplicare il piacere di capire e di conoscere. La formazione del paesaggio, infatti, è un processo assolutamente complesso che tende a sfuggire ai non specialisti. Offrire anche a chi resta nel territorio di Ra-dicondoli solo per il breve tempo di una gita o di una vacanza, per una giornata o per un fine settimana, la possibilità di scio-gliere la complessità del territorio che si offre alla vista e trarne gratificazione, è un grande vantaggio culturale. Il risultato di quest’ambizione è un progetto educativo e tu-ristico al tempo stesso che ha vari obiettivi, i cui presupposti meritano di essere indicati. Anzitutto lo scopo è quello di insegnare il paesaggio (Casti-glioni 2003; Camedieri, 2006) e di dare modo a tutti di affer-rare la complessità di ciò che vediamo e che ci emoziona a partire da una lettura di tipo semantico. L’idea è solo apparen-temente ardua.Ogni paesaggio naturale, umanizzato o urbano che sia, è di fatto un testo che ha un suo codice e con un suo «sistema di significazione». È un complesso dotato di proprie regole di correlazione e di connessione attraverso le quali interpretare i segni dell’identità per ricomporli in sequenze dotate di uno specifico senso (Eco, 1975: 19; Marrone, 2001: 297-320). In secondo luogo, il paesaggio è un fatto relativo, non è fisso e immutabile, sempre uguale a se stesso, ma un’opera i cui contenuti variano in rapporto alla soggettività dello sguardo e dell’interpretazione. Costrutto collettivo e soggettivo al con-tempo, il paesaggio, quindi, è un’opera in perenne divenire, definita da chi la osserva secondo le proprie prospettive cultu-rali e mentali (Vitta, 2005: 9). I paesaggi ‘estetici’ possibili sono infiniti e personali. Guidare in questa interpretazione – nell’analisi sintattica e semantica del paesaggio – è quanto si propone il presente volume. Usandone gli strumenti, chi osserva il territorio può più facilmente da solo individuarne le impronte, ricavare le in-
2 Tra i testi più fruibili in tema di paesaggio ricordiamoTurri (2001), da una prospettiva antropologica; Vitta (2005), che ripercorre l’attenzione al paesaggio nelle discipline dell’arte e della scienza. Si vedano anche Rosario (2006), Turri (2008), Pandakovic-Dal Sasso (2009), Romani (2008).
8 9
la_guida_radicondoli.indd 8-9 01/09/14 12:18
economico, la crescita, la cultura e il futuro (migliore) dialoga-no e si incontrano. Valorizzare il paesaggio rurale con intenti turistici, infatti, rappresenta tanto un’opportunità di produrre reddito quanto una occasione per realizzare scambi culturali coerenti con il tema della sostenibilità dello sviluppo (cfr. Lan-za, 2006; Salvarani, 2005). Il turismo sostenibile, nelle sue numerose varianti, del resto, è un tema cui oggi si presta molta attenzione ma non sempre in modo concreto. Ecoturismo, turismo attivo, turismo integrato, turismo lento, sono tutti modi di descrivere il rispetto dovuto ai luoghi e alle popolazioni nell’ambito di un’attività di frequenta-zione del territorio compiuta sempre, e comunque, per svago e per diletto; ma proprio per questo capace, quando pre-or-ganizzata in modo intelligente, di restituire ai luoghi stessi un valore culturale ed economico non trascurabile (Androla-Ma-nente, 2000; Bimonte-Punzo, 2003; Romei, 2009). Il turismo lento e attivo, escursionistico o didattico sono per noi italiani nuove forme di turismo, alternative a quelle tradizionali, di grandissimo potenziale. La fruizione allargata di un territorio, infatti, espressione di naturalità e di cultura locale, ha il doppio vantaggio di arricchire sia il visitatore di nuove esperienze – le quali, ad esempio, possono completare i percorsi turistici nelle città d’arte della Toscana – sia i cittadini che vivono su quel territorio. Il turismo sostenibile ha il potere di favorire, sempre, la cultura dell’ospitalità nel quadro di uno scambio tra visitatori e residenti improntato alla parità e alla condivisione.Chi abita a Radicondoli e chi ne ha percorso le valli e i crinali sa quale sia la ricchezza geoantropologica e quante risorse si nascondono tra Mensano e Travale, tra la Strada Maremmana e l’Alta Valle del fiume Cecina. Chi padroneggia il territorio per-ché vi è nato sa che Poggio Scapernata è molto più di un mo-desto rilievo, luogo di antichissimi insediamenti lì localizzati; “pi-lastro tettonico” attorno al quale il Cecina girava secondo un tragitto opposto a quello odierno, che rende spiegazione del fatto che la valle dell’attuale Fosso Quarantola è incongruen-te rispetto all’entità del corso d’acqua che oggi la percorre. Ugualmente la zona alluvionale di Coiolo e Materno, abitata in età etrusco-romana. Così come egli sa implicitamente grazie alla propria esperienza concreta, secolare e selettiva, che esi-stono rapporti che legano la presenza del contatto fra i due suoli diversi (i conglomerati e le evaporiti da una parte e le ar-gille plioceniche dall’altra) e l’affiorare dell’acqua e di sorgenti, e quindi la possibilità di costruire lavatoi, pozzi, derivazioni per le colture. In una parola: la possibilità di vita. Non occorre es-sere geologi per afferrare questo particolare; occorre però guardare con attenzione, senza fretta, i due versanti (N e S) del poggio su cui sorge Radicondoli, magari mentre si per-corrono gli itinerari descritti in questa Guida. Ci si accorgerà subito come le forme si differenziano notevolmente; il versan-te N è caratterizzato da tratti a pendenza ripida (ricoperti di bosco) che si alternano a ripiani debolmente inclinati dove vi sono i campi coltivati e le abitazioni rurali storiche. Fra i due è un continuo affiorare di acqua; e infatti proprio in questi punti
Geologia, geomorfologia, storia e lavoro dell’uomo tornano a parlare dal palcoscenico del paesaggio: dal Paleolitico all’Età Etrusca, dai Romani al Rinascimento, dall’Ottocento agricolo all’Età Contemporanea dello sfruttamento geotermico, il pae-saggio di Radicondoli torna a far sentire la sua voce. Di fatto, sono gli aspetti geomorfologici a costituire la piattafor-ma del paesaggio. Sono molte, non a caso, le schede di ap-profondimento dedicate a questo argomento. Le formazioni geologiche, le forme del rilievo e la conformazione delle su-perfici sono fondamentali per intendere le ragioni del succes-sivo popolamento umano nelle differenti fasi storiche; nonché per ricollegare, in un secondo tempo, questi aspetti ai «ca-ratteri delle culture, (a)i modi dell’insediamento, (al)le tradizioni negli usi del suolo (che) modificano lo spazio naturale e lo se-gnano con una grande varietà di impronte. La storia modifica la natura», come ci rammenta Francesco Pardi (2001).Guardando Mensano, Monteguidi, i Piani di Coiolo e Mater-no, dove scorre il fiume Cecina, l’imponenza delle Cornate, le emissioni geotermiche delle Galleraie, i poderi, le pievi e il si-stema di sfruttamento boschivo e agricolo di Radicondoli e dei suoi dintorni, la maglia viaria storica, chi frequenta i percorsi del paesaggio può diventare partecipe dell’esperienza millenaria dei loci di questa splendida porzione di Toscana, posta a due passi da Siena. I Percorsi del Paesaggio sono un prodotto turistico che coniu-ga il camminare nella natura, alla didattica della geografia, al turismo sostenibile e cognitivo.L’escursionismo e il camminare sono modalità di conoscenza. «Il ritmo del passo genera una specie di ritmo del pensiero, e il tragitto attraverso un paesaggio echeggia o stimola il tragitto attraverso un corso di pensieri. Il che crea tra percorso interno e percorso esterno una strana consonanza che suggerisce come la mente sia essa stessa un paesaggio di generi e che il camminare sia un mezzo per attraversarlo. Un pensiero nuo-vo somiglia spesso a un aspetto del paesaggio sempre esisti-to, come se pensare fosse viaggiare invece che fare» (Solnit, 2000: 1). Camminare è un’occasione per meditare: «Quando i cammini cessano di costituire soltanto le esperienze che at-traversiamo, questi divengono ben presto i labirinti sotterranei della nostra interiorità» (Demetrio, 2005: 15).La didattica della geografia, invece, ci spiega come utilizzare le rappresentazioni del territorio mirate a razionalizzare la nostra partecipazione al mondo che fisicamente ci sta intorno, vici-no e lontano. «La lettura geografica di un paesaggio implica […] la messa in opera di una cultura e di ragionamenti spaziali che si realizzano progressivamente. Vera educazione in ma-teria, l’osservazione in situ richiede preliminarmente dei me-todi e un vocabolario per discernere i piani, i diversi elementi e il loro posizionamento reciproco. La prima fase è dunque la “decomposizione del paesaggio”, che permette di porre delle questioni» (Sierra, 2011: 311).Il turismo sostenibile, infine, è la frontiera dello sviluppo e della valorizzazione territoriale verso cui tendere, dove il vantaggio
10 11
la_guida_radicondoli.indd 10-11 01/09/14 12:18
contributo, senza il quale il nostro lavoro non sarebbe stato possibile: Costanza Cucini, Paolo Francalacci e Felicia Rotun-do.Costanza Cucini è autrice di una monumentale opera di storia e di archeologia fondata su di una ricognizione palmo a palmo del territorio, corredata da centinaia di disegni e di mappe, che non cesseremo mai di ammirare conoscendone le immense difficoltà di realizzazione.Felicia Rotundo e Paolo Francalacci sono i redattori del volu-me Radicondoli e il suo territorio: paesaggio e itinerari culturali, che contiene in nuce lo spirito della presente Guida; un volu-me ricco di informazioni sulle testimonianze storiche e artisti-che presenti nell’area comunale, del quale consigliamo la let-tura a chi vorrà conoscere il territorio con maggiore dettaglio.
Ringraziamo infine tutti coloro che utilizzeranno questa Gui-da per capire cosa si nasconde nel paesaggio di Radicondoli, scusandoci con loro per ogni errore od omissione, consci di non essere stati esaurienti e perfetti nelle nostre indicazioni. Vitiis nemo sine nascitur.
A tutti auguriamo che I percorsi del paesaggio possano esse-re un’esperienza gratificante a fronte di un una breve passeg-giata e di uno sforzo di comprensione che certamente sarà ripagato dalla soddisfazione, com’è accaduto a noi. Lo sa bene l’antropologo e scrittore Matteo Meschiari, tra i pri-mi a diffondere il messaggio che «il paesaggio va frequentato con la mente e con il corpo. Camminare e meditare sono le due vie privilegiate per inoltrarsi nei luoghi e arrivare a un’in-tima comprensione delle loro dinamiche» (Meschiari, 2008). Noi siamo con lui: il paesaggio è cultura.
DANIELE BAGGIANIPAOLO GENNAI
si trovano ancora oggi sorgenti, lavatoi, resti di canalizzazioni. I Percorsi 1 e 4 ne rendono ampia testimonianza. Tutt’altra cosa il versante meridionale, regno dell’argilla pura, dalle forme tan-to dolci quanto mobili, in perenne assestamento e per questo privo, o quasi, di abitazioni storiche. Chi abita questi posti infine sa che esistono rapporti che legano gli antichi centri medievali che si susseguono all’orizzonte guardando dal colle di Radi-condoli in direzione N: partendo da Volterra, a sinistra, pas-sando per Monteguidi, Casole d’Elsa, San Gimignano, fino a Mensano, l’ultimo paese a destra, il più vicino, un tempo diret-tamente collegato a Radicondoli.
L’idea di valorizzare la ricchezza paesaggistica di Radicondoli con un progetto dedicato al largo pubblico dei turisti e delle famiglie è scaturita dal desiderio di far partecipare anche chi vi resta un solo giorno della straordinaria ricchezza di queste terre. La sensibilità congiunta degli esperti del territorio e dei rappresentanti del Comune ha permesso di concretizzare il progetto che da molti anni avevamo in mente. Come valoriz-zare questo ambiente? Come convincere i turisti a fermarsi e a prendere parte al paesaggio? Come realizzare un prodotto di turismo attivo attraente, sostenibile, e con un investimento limitato?L’indicazione preliminare dell’Amministrazione Comunale è stata di utilizzare il circuito delle strade vicinali, oggetto di un Regolamento a loro salvaguardia. Pensare alla fruizione turisti-ca attiva di una serie di percorsi intitolati al paesaggio è stato il secondo passo. Portare gli altri a condividere la nostra espe-rienza mediante una serie di strumenti di facile fruizione è stata la sfida. Perché il turismo lento e sostenibile, desideroso di bellezza, di cultura e di relax, di emozioni e di qualità della vita costituisce il paradigma cui tendere per garantire un futuro migliore a noi e al territorio che abitiamo.
Gli autori desiderano ringraziare tutti coloro che hanno cre-duto in questo progetto e tutti i cittadini di Radicondoli che li hanno aiutati nelle nostre ricognizioni, anche con un semplice gesto di simpatia. Un particolare ringraziamento a Guido Cozzi e alla sua agenzia fotografica “Atlantide phototravel”, che ci ha messo a disposizione la sua tecnologia e le sue straordina-rie immagini dei paesaggi toscani siamo grati anche agli amici Luca Leti e Luca Ranfagni per il loro contributo.
Questa Guida se è originale nella sua organizzazione non lo è certo nei suoi contenuti. La storia e i notevoli patrimoni cultu-rali e naturalistici radicondolesi sono ben noti. Noi vi abbiamo aggiunto ben poco. Gli studi scientifici e la bibliografia locale, di ottimo livello anche se non numerosi, sono stati la miniera dalla quale abbiamo estratto le informazioni organizzate in questa Guida.
Tra gli altri, tre autori in particolare vogliamo citare per il loro
12 13
la_guida_radicondoli.indd 12-13 01/09/14 12:18
Guida alla lettura
Il progetto I Percorsi del Paesaggio e l’organizzazione di que-sta Guida meritano di essere chiariti nella loro struttura, così come occorre spiegare in che modo si usano gli strumenti che la compongono. Consigliamo di leggere queste note per sciogliere ogni dubbio circa le modalità di approccio alla let-tura del paesaggio e l’uso integrato di due principali gruppi di strumenti: 1. le istallazioni, presenti sul territorio; 2. gli ausili di lettura e di approfondimento inseriti in questa Guida.
Le installazioni
Il sistema degli itinerari consta di sei percorsi, quattro dei quali dislocati intorno al centro di Radicondoli, numerati in senso orario a partire dalla «Piazzetta Becucci», a O del paese. In piazza Antonio Gramsci si trova il totem che illustra la strut-tura del progetto e le soluzioni di cui si compone.Ogni percorso ha una localizzazione di partenza (P) e uno svi-luppo su sentiero o su strada vicinale sterrata, completato da due o più PP (Punti Panoramici), per un totale di dodici luoghi di osservazione.Due percorsi, il quinto e il sesto, sono posti fuori Radicondoli: uno in località Belforte, l’altro presso il borgo di Anqua. Luoghi che possono essere raggiunti facilmente in automobile o con altro mezzo. L’inizio di ogni percorso è segnalato da un cartello che ne il-lustra lunghezza, difficoltà, sviluppo e collocazione dei Punti Panoramici.
Presso «Piazzetta Becucci» a Radicondoli, e a Belforte, nello spazio pubblico localizzato tra Piazza Dina Ferri e il PP «L’Ol-mo», sono installati due cannocchiali fissi con cui osservare il panorama e i reperti individuabili e spiegati nelle loro caratte-ristiche e connessioni in questa Guida. Presso il Punto Informazioni Turistiche a Radicondoli – all’im-bocco del paese (via Tiberio Gazzei) – negli orari di apertu-ra è possibile ritirare in uso una bussola e un binocolo utili a orientare le mappe e a riconoscere le testimonianze del pa-esaggio durante le passeggiate, presso il Punto Informazioni Turistiche è possibile ritirare una cartina generale dei percorsi (gratuita).Su ogni percorso sono collocati due PP (solo il Percorso 1 «Casettino» ne ha tre). Presso ogni PP è installato un pannello inclinato a 45°, sor-retto da un sostegno a piantana, che reca in figura la stiliz-zazione grafica del paesaggio (profilo) che da lì si osserva. La rappresentazione grafica del paesaggio indica quali sono i punti di interesse, ossia i reperti del paesaggio che si possono vedere da quel punto e che andranno riscontrati utilizzando il binocolo portatile e la bussola. Ogni reperto enumerato ha il suo corrispettivo in una Scheda di Approfondimento conte-nuta in questa Guida.Occorre notare che il profilo del paesaggio non riproduce fedelmente ciò che si vede, bensì costituisce una stilizzazio-ne del paesaggio e delle linee di crinale osservabili da quel punto, secondo un preciso orientamento. Si tratta dunque di una semplificazione del territorio reale che si apre alla vista (analoga a quella realizzata da una cartina geografica) che ha lo scopo di indirizzare l’attenzione verso particolari reperti del territorio osservato facilitandone l’identificazione. Ogni profilo
Percorso Km Difficoltà Punto Panoramico
1 Casettino2,2 KmAndata
Medio
Piazzetta Becucci
Trabocco
Canterie
2 Lucignano 1,6 km FacilePaugnano
Porta Olla
3 Colombaione2,4 kmAndata
MedioMontemaggiori
Basilico
4 Tesoro3,9 kmAndata
ImpegantivoPiazzetta Becucci
Podere Tesoro
5 Belforte 1,3 km FacileL’Olmo
Cimitero
6 Anqua0,7 kmAndata
FacileVilla di Anqua
Croci
VEGETAZIONE E LIMITI DEL CAMPO VISIVO
LISTA DEI REPERTI
NUMERAZIONE DEI REPERTI
CONO VISIVO 45%
ORIENTAMENTO GEOGRAFICO
NUMERAZIONE PP E PERCORSO
ORARI DEL MUSEO
INFORMAZIONI GENERALI
CASE, PAESI
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
14 15
la_guida_radicondoli.indd 14-15 01/09/14 12:18
del paesaggio riportato sui pannelli indicatori e in questa Gui-da si compone di vari elementi. Una linea di crinale maggiore (tratto più spesso), i crinali minori importanti (tratto più fine), i corsi di acqua, le strade e le abitazioni/paesi. È facile ricono-scere i vari reperti sul profilo disegnato guardando dal vivo il paesaggio in quanto i rapporti spaziali e le proporzioni tra i vari elementi sono rispettati. Ma occorre un po’ di attenzione. Il profilo del paesaggio mostra una porzione di territorio di cir-ca 180° misurati dal punto di osservazione, con una prospet-tiva ampliata rispetto al cono visivo umano, che è di circa 45°. Dunque, per osservare l’intero paesaggio descritto sul profilo occorre ruotare lo sguardo da sinistra a destra e coprire tutti i 180° dello skyline riportato sul profilo del paesaggio.
Ausili di lettura e approfondimento: la Guida
La Guida serve a comprendere/interpretare il tessuto del pa-esaggio. A tal fine è corredata di alcuni strumenti. DESCRIZIONE DEI PERCORSI. Ogni percorso è descritto accuratamente nelle sue caratteristiche principali e nel suo andamento, in modo da facilitarne la percorrenza con la de-scrizione speditiva del tragitto. Una tabella ne espone preli-minarmente i dati tecnici: lunghezza, difficoltà, tipo, dislivello totale, descrizione sintetica del percorso, toponimi toccati nel tragitto, caratteristiche principali e cautele da osservare.
PROFILO DEL PAESAGGIO. La Guida presenta anch’essa i profili del paesaggio riferiti ai diversi PP. Rispetto ai pannelli inclinati, i profili della Guida sono ugualmente dettagliati ma più snelli.
Per utilizzarli in maniera corretta è necessario posizionarsi correttamente sul posto e orientare il libro con una busso-la. Tale procedura di orientamento è fondamentale per ri-scontrare sul terreno i reperti indicati sul profilo, che altrimenti possono rimanere nascosti, dato che cambia la porzione di paesaggio visibile.Il profilo del paesaggio riporta tutto ciò che si può osservare in una giornata tersa di massima visibilità. Le condizioni mete-orologiche sono dunque fondamentali per poter individuare reperti che in qualche caso sono distanti diverse decine di chilometri in linea d’aria dal punto di osservazione, come, ad esempio, Volterra o San Gimignano, il Monte Amiata o San Galgano.Il nome di ogni reperto numerato sul profilo è da ritrovare nella sottostante matrice del paesaggio, che a sua volta rimanda alla sezione “Le Schede” della Guida (p. 63 e sgg.). MATRICE DEL PAESAGGIO. Sotto il profilo ogni reperto os-servabile è collocato in una matrice che lo ordina – in verticale (ascisse) – rispetto a un ambito (idrografia, insediamenti, ru-deri, economia...) – e in orizzontale (ordinate) rispetto alla sua età (preistorica, medievale, rinascimentale, attuale...). L’incro-cio delle due caratteristiche assegna al reperto un codice al-fanumerico, secondo la seguente classificazione.
LunghezzaTotale della distanza da coprire a piedi dal punto di partenza
Difficoltà Facile, Medio, Impegnativo, Difficile
Tipo Andata e Ritorno, Ad anello
Dislivello totale
Totale del dislivello da coprire nel tratto in salita
Percorso (toponimi)
Nome delle località, poderi, torrenti ecc. toccati durante dal percorso
Caratteristica prevalente
Motivo principale di interesse, ossi carattere del percorso (ad es. Specificità della geomorfolo-gia, appoderamento collinare e insediamenti fortificati medievali).
CauteleEventuali accortezze da osservare durante il cammino dovute a particolari situazioni, mete-orologiche o stagionali.
Descrizione delle caratteristiche del percorso
A Geomorfologia G Architettura
B Geologia H Resti / Ruderi
C Idrografia IEconomia del bosco Pastorizia
D Natura L Agricoltura
E Viabilità M Metallurgia
F Insediamenti / Paesi N Industria
CASE, PAESI
NUMERAZIONE DEI REPERTI
CONO VISIVO 45%
ORIENTAMENTO GEOGRAFICO
VEGETAZIONE E LIMITI DEL CAMPO VISIVO
16 17
la_guida_radicondoli.indd 16-17 01/09/14 12:18
Il codice alfanumerico è rintracciabile nella tabella che apre ogni scheda.Le Classi e le Età classificano i reperti del paesaggio codifi-candone le caratteristiche. Scorrendo la Matrice si colgono, infatti, degli addensamenti di testimonianze i quali tendono a conferirre al paesaggio una sua particolare personalità geo-morfologica e storica, differente secondo il punto di osser-vazione.
Così il panorama da “Piazzetta Becucci” è connotato dalla geomorfologia e dall’assetto agricolo dei suoli nonché da un popolamento nucleare di sommità di chiara derivazione me-dievale. Il paesaggio osservabile da “Montemaggiore” invece fa pernio su di uno sfruttamento agricolo organizzato intorno a qualche fattoria e ai suoli fertili intorno al fiume Cecina e ai suoi affluenti, nel quadro di un insediamento sparso e rarefat-to d’impianto antico, dove accanto ai siti etruschi si collocano strategicamente una serie di ville-fattorie di età rinascimen-tale.Nella matrice del paesaggio è collocato anche un riquadro con l’indicazione dei “Reperti nascosti”, ovvero di quelle testi-monianze che pur non essendo visibili da quel PP, sono co-munque presenti nel paesaggio e in grado di condizionarlo e arricchirlo nelle sue forme e nelle sue correlazioni storiche fra uomo e natura. I curatori della Guida ritengono questi Reperti nascosti in grado di concorrere alla più generale comprensio-ne del genius loci e per questo meritevoli di essere segnalati.
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO. Contengono informazioni dettagliate circa ogni reperto citato. Ciascuna Scheda consta di quattro o cinque sezioni (possono non essere presenti le notizie “Per approfondire…”).
Di testa si trovano il codice-matrice, l’argomento e l’età (ad es. F4 per un reperto relativo all’ ambito “Insediamenti/pae-si” di età “Rinascimentale”); l’indicazione di posizionamento assoluto GPS: latitudine/longitudine; la distanza (misurata in linea d’aria) dai maggiori centri (Radicondoli, Belforte, Anqua). A questo seguono le indicazioni di visibilità, con i suggerimenti atti a facilitare l’individuazione nel paesaggio di un particolare reperto. Grande spazio è dato alla descrizione del reperto, per la quale si è preferito un linguaggio tecnico e storico–scientifico, ad evitare ogni imprecisione e banalizzazione. La Scheda si chiude con gli approfondimenti e notizie utili a ne-cessità più squisitamente turistiche; che possono riguardare, ad esempio per i paesi più noti circostanti Radicondoli: indi-cazioni di percorrenza per gite ed escursioni sul luogo, feste paesane e manifestazioni locali, curiosità di vario tipo, altri luo-ghi d’interesse, questioni di attualità… Indicazioni le quali sono ovviamente soggette ad aggiornamento nelle date, apertura dei musei, manifestazioni ecc. via via che questa pubblicazio-ne invecchia.
1 Era / Preistoria 4 Rinascimentale
2 Etrusco / Romana 5 XVI-XVIII secolo
3 Medievale 6 Contemporanea
GLI AMBITILE ETÀ
LISTA DEI REPERTI NASCOSTI
1. NUMERAZIONE E TITOLO
3. VISIBILITÀ
5. NOTIZIE DI APPROFONDIMENTO
A USO TURISTICO
2. CODICE E DATI GEOGRAFICI
4. DESCRIZIONE STORICO-SCIENTIFICA
18 19
la_guida_radicondoli.indd 18-19 01/09/14 12:18
Quadro generale dei percorsi
Radicondoli: percorsi 1, 2, 3, 4
Anqua: percorso 6
Belforte: percorso 5
Partenza Percorso
Percorso
Punto Panoramico
Strada di collegamento
Strada Statale (SS) Provinciale (SP)
Numero SS/SP
Paese
Fiume Cecina
la_guida_radicondoli.indd 20-21 01/09/14 12:18
sinistra, individuata da una staccionata; qui si prosegue dritti, prendendo lo stretto sentiero (contrassegnato come l’itine-rario «C» dell’Associazione Ethoikos). Lo stesso sentiero reca il segno bianco-rosso del CAI, Club Alpino Italiano, che indivi-dua i sentieri mantenuti. Il percorso continua a mezza costa. Si seguono le segnalazioni e una volta usciti dal bosco e finita la discesa, si apre un punto panoramico e si entra, sempre in forte discesa, in un campo di olivi. Il sentiero costeggia il limi-tare del bosco. Giunti sotto un pilone elettrico, in prossimità di una grande quercia, si gira a destra e si prosegue sul sentiero che entra in dei campi in parte abbandonati e in parte coltivati. Superata una captazione dell’acqua e un laghetto (posto a sinistra) si giunge a un bivio, dove si tiene la direzione sinistra. Segue un breve tratto in pari che sbuca sulla strada sterrata vicinale, in corrispondenza di un quadrivio. Si svolta, quindi, a sinistra, continuando sulla strada sterrata; si incontrano, sul-la destra, prima il Podere Casettone, poi il Podere Casettino. Giunti a un bivio si tiene la destra e si sale leggermente fino a che il paesaggio si allarga. Percorsi circa 200m si incontra uno slargo sulla destra dove è posizionato il PP 3 «Canterie». La visuale si apre su Monteguidi (con dietro il profilo bosco-so del Berignone) e sul fondovalle del Vetrialla e del Sala a destra, in basso. A sinistra invece, in alto, si ha il profilo della parte orientale del paese di Radicondoli. Si torna indietro dallo stesso percorso, affrontando l’impegnativa risalita.
Percorso 1CASETTINO
Descrizione
Dalla «Piazzetta Becucci», dov’è posizionato il PP 1, si prose-gue su via Tiberio Gazzei in direzione E, attraversando la via principale del paese di Radicondoli, che si percorre intera-mente fino a Piazza Antonio Gramsci, oltre il Punto Informa-zioni Turistiche, presso il Museo delle Energie del Territorio.Si esce dal paese in direzione E, percorrendo via Guglielmo Marconi, in discesa. Dopo circa 100m, all’altezza della Fontina del Trabocco, s’incontra sulla sinistra Viale Luigi Baldi, dove è posizionato il PP2. Presso il PP si origina un trivio. Il percorso continua sullo sterrato centrale, evitando la strada asfaltata più a destra che conduce alla Pieve Vecchia della Madonna, che può essere visitata con una breve deviazione. Si scen-de sullo sterrato per circa 300m, fino a una secca curva a
Lunghezza 2,2 km Andata
Grado di difficoltà
Facile Medio Impegnativo Difficile
Tipo Andata e ritorno
Dislivello totale 200 metri
Percorso agevole ed equilibrato quanto a rapporto sforzo/bel-lezza, contrassegnato da un paesaggio raccolto attorno alla valle del Fosso Vetrialla. La risalita a Radicondoli è però fatico-sa. L’impostazione geologica, la paesaggistica medievale di sommità, in direzione N, da E a O, sulla direttrice da Mensano a Monteguidi, ne contrassegnano la fisionomia nel quadro di un assetto agricolo mezzadrile evidente una volta giunti sulla strada vicinale, in corrispondenza del PP 3 «Canterie», dal nome del podere posto poco più oltre.
Luogo partenza Piazzetta Becucci
Lungo il percorso
Piazzetta Becucci, Via Tiberio Gazzei, Piaz-za Antonio Gramsci, Via Luigi Baldi, Podere San Regolino, Podere Casettone, Podere Casettino, Podere Canterie (pressi) e ri-torno.
Elementi di interesse
Geomorfologia, paesi sommitali di impo-stazione medievale, assetto agricolo di sfruttamento del suolo nel quadro dell’ap-poderamento collinare.
Cautele
Prudenza nello scendere a valle. Il sentiero è stretto e a tratti scivoloso. Molto ripida la strada al ritorno. Valutare la fattibilità nel caso ci siano bambini piccoli.
24 25
la_guida_radicondoli.indd 24-25 01/09/14 12:18
Età
A
spe
tti
12
34
56
PR
EIS
TO
RIC
AE
TR
US
CO
-RO
MA
NA
ME
DIE
VA
LE
RIN
AS
CIM
EN
TO
XV
I-X
IX S
EC
OLO
CO
NTE
MP
OR
AN
EA
AG
EO
MO
RFO
LOG
IA2
0. L
ine
e d
i fa
glia
BG
EO
LO
GIA
15. G
rad
ino
te
tto
nic
o
Co
iolo
-Ma
tern
o
CID
RO
GR
AFIA
01.
Alta
Va
lle d
el F
oss
o
Ve
tria
lla17
. Fo
ssi V
etr
ialla
e S
ala
28
. Va
lle d
el C
ec
ina
DN
ATU
RA
07
. Fo
rest
a d
el B
e-
rign
on
e e
Mo
nte
S
old
an
o
EV
IAB
ILIT
À
FIN
SE
DIA
ME
NTI/
PA
ES
I2
3. M
on
tec
alv
aia
no
23
. Mo
nte
ca
lva
ian
o4
4. M
en
san
o5
0. M
on
teg
uid
i3
6. C
aso
le d
’Els
a5
6. S
an
Gim
ign
an
o4
8. M
on
tec
ast
elli
Pis
an
o
62
. Vo
lterr
a m
ed
ieva
le
GA
RC
HIT
ETTU
RA
HR
ES
TI/R
UD
ER
I
IE
CO
NO
MIA
B
OS
CO
/ P
AS
TO
RIZ
IA
69
. Tra
nsu
ma
nza
n
ell’
Ott
oc
en
to
LA
GR
ICO
LTU
RA
71.
La
me
zza
dria
MM
ETA
LLU
RG
IA
NIN
DU
STR
IA
RE
PE
RT
I NA
SC
OS
TI
11. G
eo
mo
rfo
log
ia C
ase
ttin
o3
0. I
nse
dia
me
nto
ro
ma
no
32
. To
mb
e e
tru
sch
e d
el C
olo
mb
aio
ne
34
. Vo
lterr
a E
tru
sca
3
7. C
aso
le d
’Els
a: l
’arc
hite
ttu
ra4
5. A
rch
itett
ura
a M
en
san
o: b
org
o e
pie
ve4
6. M
inie
re d
’Arg
en
to4
9. M
on
tec
ast
elli:
l’a
rch
itett
ura
54
. Ra
dic
on
do
li m
ed
ieva
le5
5. R
ad
ico
nd
oli:
via
Ga
zze
i ne
l Me
dio
evo
66
. Ra
dic
on
do
li rin
asc
ime
nta
le6
7. R
ad
ico
nd
oli:
via
Ga
zze
i rin
asc
ime
nta
le7
3. R
ad
ico
nd
oli:
via
Ga
zze
i ne
ll’O
tto
ce
nto
77
. La
na
scita
de
lla g
eo
term
ia7
8. P
ast
oriz
ia e
tra
nsu
ma
nza
la_guida_radicondoli.indd 26-27 01/09/14 12:18
Età
A
spe
tti
12
34
56
PR
EIS
TO
RIC
AE
TR
US
CO
-RO
MA
NA
ME
DIE
VA
LE
RIN
AS
CIM
EN
TO
XV
I-X
IX S
EC
OLO
CO
NTE
MP
OR
AN
EA
AG
EO
MO
RFO
LOG
IA
BG
EO
LO
GIA
CID
RO
GR
AFIA
01.
Alta
Va
lle d
el F
oss
o
Ve
tria
lla
DN
ATU
RA
07
. Fo
rest
a d
el B
erig
no
-n
e e
Mo
nte
So
lda
no
27
. Po
gg
io C
asa
lon
e
EV
IAB
ILIT
À7
4. V
iab
ilità
ott
oc
en
-te
sca
FIN
SE
DIA
ME
NTI/
PA
ES
I
23
. Mo
nte
ca
lva
ian
o3
6. C
aso
le d
’Els
a4
4. M
en
san
o5
0. M
on
teg
uid
i5
4. R
ad
ico
nd
oli
me
-d
ieva
le5
6. S
an
Gim
ign
an
o6
2. V
olte
rra
me
die
vale
GA
RC
HIT
ETTU
RA
HR
ES
TI/R
UD
ER
I
IE
CO
NO
MIA
B
OS
CO
/ P
AS
TO
RIZ
IA
69
. Tra
nsu
ma
nza
n
ell’
Ott
oc
en
to
LA
GR
ICO
LTU
RA
MM
ETA
LLU
RG
IA
NIN
DU
STR
IA
RE
PE
RT
I NA
SC
OS
TI
11. G
eo
mo
rfo
log
ia C
ase
ttin
o2
0. L
ine
a d
i fa
glia
34
. Vo
lterr
a e
tru
sca
37
. Ca
sole
d’E
lsa
: l’a
rch
itett
ura
45
. Arc
hite
ttu
ra a
Me
nsa
no
: bo
rgo
e p
ieve
d
i Sa
n G
iova
nn
i5
3. L
a P
ieve
Ve
cc
hia
di R
ad
ico
nd
oli
55
. Ra
dic
on
do
li: v
ia G
azz
ei n
el M
ed
ioe
vo6
6. R
ad
ico
nd
oli
rina
scim
en
tale
67
. Ra
dic
on
do
li: v
ia G
azz
ei r
ina
scim
en
tale
73
. Ra
dic
on
do
li: v
ia G
azz
ei n
ell’
Ott
oc
en
to7
8. P
ast
oriz
ia e
tra
nsu
ma
nza
la_guida_radicondoli.indd 28-29 01/09/14 12:18
Età
A
spe
tti
12
34
56
PR
EIS
TO
RIC
AE
TR
US
CO
-RO
MA
NA
ME
DIE
VA
LE
RIN
AS
CIM
EN
TO
XV
I-X
IX S
EC
OLO
CO
NTE
MP
OR
AN
EA
AG
EO
MO
RFO
LOG
IA
BG
EO
LO
GIA
CID
RO
GR
AFIA
0
DN
ATU
RA
07
. Fo
rest
a d
el B
erig
no
-n
e e
Mo
nte
So
lda
no
EV
IAB
ILIT
À7
4. V
iab
ilità
ott
oc
en
-te
sca
FIN
SE
DIA
ME
NTI/
PA
ES
I
50
. Mo
nte
gu
idi
54
. Ra
dic
on
do
li m
e-
die
vale
GA
RC
HIT
ETTU
RA
53
. La
Pie
ve V
ec
ch
ia d
i R
ad
ico
nd
oli
66
. Ra
dic
on
do
li rin
asc
i-m
en
tale
HR
ES
TI/R
UD
ER
I
IE
CO
NO
MIA
B
OS
CO
/ P
AS
TO
RIZ
IA
LA
GR
ICO
LTU
RA
71.
La
me
zza
dria
MM
ETA
LLU
RG
IA
NIN
DU
STR
IA
RE
PE
RT
I NA
SC
OS
TI
11. G
eo
mo
rfo
log
ia C
ase
ttin
o5
5. R
ad
ico
nd
oli:
via
Ga
zze
i ne
l Me
dio
evo
67
. Ra
dic
on
do
li: v
ia G
azz
ei r
ina
scim
en
tale
73
. Ra
dic
on
do
li: v
ia G
azz
ei n
ell’
Ott
oc
en
to7
8. P
ast
oriz
ia e
tra
nsu
ma
nza
la_guida_radicondoli.indd 30-31 01/09/14 12:18
strada vicinale in debole discesa per circa 100 metri, fino al serbatoio del gas metano del paese, in corrispondenza del quale è posto il PP 4 leggermente oltre la strada in direzione S-SO. Nella vallata di fronte alla strada scorre a circa 500m il fosso Lucignano, con in alto il corto crinale che separa dalla vista di Belforte. Il panorama spazia a E sul Casone, sul pode-re La Torre e, in alto, sul Poggio Casalone, con la riserva e il bosco che ne prendono il nome. Più a destra si vede sullo sfon-do il Castello-Fattoria di Fàlsini. Terminata l’osservazione dal PP 4 si ritorna sulla strada sterrata in leggera discesa, che piega a destra. Si continua fino a passare tra due resedi del Podere Gioglia-no. La strada, poi, risale verso il Convento dei Cappuccini, detto anche dell’Osservanza. Lungo il percorso, a destra, si notano i pennacchi bianchi delle emissioni geotermiche, mentre in alto a de-stra si intravede Radicondoli nel suo assetto di sommità. Il Con-vento dell’Osservanza merita una deviazione per vederlo da vicino, anche se non è possibile visitarne l’interno. A destra dell’incrocio che vi conduce si pone l’area di sosta dei cam-per, dove si possono vedere chiaramente gli affioramenti di conglomerato, lo stesso basamento sul quale poggia il pa-ese di Radicondoli, che tornano visibili sotto Porta Olla. Il PP 5 è posto sulla penultima curva a gomito, a destra, prima di rientrare in paese.
È possibile passare anche da un sentiero posto dietro il cimitero (ango-lo posteriore sinistro) della Pieve Vec-chia, che corre in parallelo alla strada asfaltata, ma non sempre di agevole identificazione. Nel primo tratto un giovane oliveto fiancheggia una pro-prietà privata con piscina (a sinistra) e una zona di fitte scope (a destra), e che corre esattamente sotto la linea elettrica. Si costeggia, quindi, per un breve tratto la recinzione di una villetta, a destra, per arrivare su di una stra-da sterrata di accesso a una nuova zona residenziale. Si segue la strada fino all’asfalto. Poco dopo, a destra, si pone l’inizio del Percorso 2.
Percorso 2 LUCIGNANO
Descrizione
Da via Tiberio Gazzei si esce dal paese in direzione E, oltre-passando piazza Antonio Gramsci e camminando per circa 1.200m sulla strada asfaltata, in direzione Casone. Percorria-mo sull’asfalto via Guglielmo Marconi e poi viale Luciano Be-rio (che termina all’altezza di una serie di villette a sinistra), si continua il percorso sulla stessa strada che diventa la SP Radicondoli 35A, dove, una curva a destra, anticipa l’inizio del percorso posto sul bivio a destra. Qui ha inizio una strada sterrata, denominata «Strada di Giogliano». Si scende sulla
Lunghezza 1,6 km
Grado di difficoltà
Facile Medio Impegnativo Difficile
Tipo Ad anello
Dislivello totale 150 metri
Il percorso è facile e non lungo, adatto anche alle persone an-ziane e ai bambini. Si caratterizza per una progressiva apertura verso E nel primo tratto e verso S nel secondo tratto. L’aspetto geologico del Fosso Lucignano e la geotermia che si apprezza dal PP 5 «Porta Olla» ne costituiscono la principale attrattiva, nel contesto di un impianto dell’insediamento sparso definito nel corso del Medioevo. L’orizzonte si amplia progressivamente a partire dai crinali sulla linea collinare Fàlsini-Belforte-Montingeg-noli fino a mostrare, risalendo in paese, in lontananza, l’alta valle del fiume Cecina e i monti da dove esso ha origine, con le linee dei differenti crinali costellate dai bianchi pennacchi (vapore ac-queo) delle emissioni geotermiche sfruttate per la produzione di energia elettrica.
Luogo partenzaA 200 dal paese lungo la SP Radicondoli 35A, da percorrere tutti in discesa.
Lungo il percorsoPodere Giogliano, Convento dell’Osser-vanza, Area sosta camper, Porta Olla.
Elementi di interesse
Geomorfologia del Fosso Lucignano verso E-SE, tra Radicondoli e Belforte-Montinge-gnoli. Emissioni geotermiche e abitati me-dievali nel panorama in direzione S.
Cautele
Prudenza nel tratto che conduce all’inizio del percorso. Mantenere la destra sulla strada asfaltata. La partenza è raggiungi-bile da un sentiero alternativo posto dietro il camposanto, presso la Pieve Vecchia della Madonna, che segue il limite di una proprietà privata. Per trovare il sentiero oc-corre una carta topografica 1:25.000.
32 33
la_guida_radicondoli.indd 32-33 01/09/14 12:18
Età
A
spe
tti
12
34
56
PR
EIS
TO
RIC
AE
TR
US
CO
-RO
MA
NA
ME
DIE
VA
LE
RIN
AS
CIM
EN
TO
XV
I-X
IX S
EC
OLO
CO
NTE
MP
OR
AN
EA
AG
EO
MO
RFO
LOG
IA2
6. P
og
gio
di M
on
tieri
BG
EO
LO
GIA
CID
RO
GR
AFIA
0 8
. Fo
sso
Lu
cig
na
no
DN
ATU
RA
27
. Po
gg
io C
asa
lon
e
EV
IAB
ILIT
À7
4. V
iab
ilità
ott
oc
en
-te
sca
FIN
SE
DIA
ME
NTI/
PA
ES
I
GA
RC
HIT
ETTU
RA
38
. Ca
ste
llo d
i Fa
lsin
i
HR
ES
TI/R
UD
ER
I
IE
CO
NO
MIA
B
OS
CO
/ P
AS
TO
RIZ
IA
LA
GR
ICO
LTU
RA
MM
ETA
LLU
RG
IA
NIN
DU
STR
IA
RE
PE
RT
I NA
SC
OS
TI
04
. Co
rna
te d
i Ge
rfa
lco
e P
og
gio
Ritr
ovo
li13
. Ge
om
orf
olo
gia
Lu
cig
na
no
35
. Be
lfort
e m
ed
ieva
le4
1. ll
Co
nve
nto
de
ll’O
sse
rva
nza
ne
l M
ed
ioe
vo6
5. B
elfo
rte
rin
asc
ime
nta
le7
0. C
on
ven
to d
ell’
Oss
erv
an
za n
el ‘
60
0
la_guida_radicondoli.indd 34-35 01/09/14 12:19
Età
A
spe
tti
12
34
56
PR
EIS
TO
RIC
AE
TR
US
CO
-RO
MA
NA
ME
DIE
VA
LE
RIN
AS
CIM
EN
TO
XV
I-X
IX S
EC
OLO
CO
NTE
MP
OR
AN
EA
AG
EO
MO
RFO
LOG
IA
04
. Co
rna
te d
i Ge
rfa
lco
e
Po
gg
io R
itro
voli
13. G
eo
mo
rfo
log
ia
Lu
cig
na
no
25
. Pa
leo
co
rso
de
l C
ec
ina
26
. Po
gg
io d
i Mo
ntie
ri
BG
EO
LO
GIA
03
. Co
ng
lom
era
ti
CID
RO
GR
AFIA
08
. Fo
sso
Lu
cig
na
no
DN
ATU
RA
27
. Po
gg
io C
asa
lon
e
EV
IAB
ILIT
À7
4. V
iab
ilità
ott
oc
en
-te
sca
FIN
SE
DIA
ME
NTI/
PA
ES
I3
5. B
elfo
rte
me
die
vale
52
. Mo
ntin
ge
gn
oli
GA
RC
HIT
ETTU
RA
38
. Ca
ste
llo d
i Fa
lsin
i6
5. B
elfo
rte
rin
asc
i-m
en
tale
68
. Villa
di O
lli rin
asc
i-m
en
tale
HR
ES
TI/R
UD
ER
I3
9. C
ast
ello
di E
lci
IE
CO
NO
MIA
B
OS
CO
/ P
AS
TO
RIZ
IA
76
. Fa
tto
ria d
i An
qu
a
og
gi
LA
GR
ICO
LTU
RA
MM
ETA
LLU
RG
IA
NIN
DU
STR
IA7
7. L
a n
asc
ita d
ella
g
eo
term
ia7
5. C
en
tra
li g
eo
term
ich
e
RE
PE
RT
I NA
SC
OS
TI
41.
ll C
on
ven
to d
ell’
Oss
erv
an
za n
el M
ed
ioe
vo5
4. R
ad
ico
nd
oli
me
die
vale
70
. Co
nve
nto
de
ll’O
sse
rva
nza
ne
l ‘6
00
la_guida_radicondoli.indd 36-37 01/09/14 12:19
vegetazione, fiancheggiando la recinzione della Tenuta di Olli. Scendendo ancora si vede sulla sinistra un invaso artificiale. Percorsi circa 900 metri dalla strada asfaltata si raggiunge il Podere Montemaggiori. Lo si aggira a destra con evidente deviazione dal percorso originario e superate le costruzioni si incontra il PP 6, che prende il nome dal vicino podere. Finita l’osservazione, si continua sullo sterrato fino a raggiungere e oltrepassare il rudere del Podere Colombaione, posto sulla destra oltre il ciglio della strada. Quindi, si prosegue in falso-piano seguendo la recinzione, a sinistra; si supera un dosso e si fiancheggiano, sul terrapieno a destra, i ruderi del Podere Gatteresi. Poco oltre, sulla destra, si pone il PP 7 «Basilico», dal nome del podere che si para davanti. Il panorama si apre qui su Montecastelli Pisano, di fronte, e sui Piani di Coiolo e Materno a destra, all’incrocio di tre val-late che convergono verso il fiume Cecina, che all’orizzonte, verso N, entra sotto Volterra prima di sterzare a sinistra ver-so il mare. Alle spalle il paese di Radicondoli da una diversa prospettiva, con i suoi due campanili. Il ritorno si effettua dalla stessa strada.
Percorso 3 COLOMBAIONE
Descrizione
Il percorso ha inizio 1.700 metri a S di Radicondoli, sulla strada asfaltata in direzione Castelnuovo Val di Cecina, all’altezza del Podere Casa Nuova. Il visibile sterrato a destra reca anche la segnalazione del sentiero bianco-rosso CAI, dove si pone la strada di crinale che accoglie il Percorso 3 denominato Stra-da delle Gatteresi. Il primo tratto è in leggera discesa fino a raggiungere il Podere Casa Nuova (di recente restaurato). Si continua a scendere percorrendo un buon tratto dentro la
Lunghezza 2,4 km Andata
Grado di difficoltà
Facile Medio Impegnativo Difficile
Tipo Andata e ritorno
Dislivello totale 150 metri
Il percorso è di medio impegno, anche se posto un po’ fuori dal paese. È molto ricco di reperti ed i panorami che si aprono sono molto interessanti e sollecitano differenti letture. Il suo interesse riguarda tanto la conformazione del paesaggio nel suo comples-so intorno ai torrenti e al fiume Cecina, quanto i molti reperti di età etrusco-romana che testimoniano l’uso dei rilievi per lo sfrut-tamento strategico di questi luoghi già in epoca precristiana, e poi in continuità nel Medioevo e nel Rinascimento.
Luogo partenza
Lungo la SP Radicondoli 35B in direzione Castelnuovo V.C., circa 1.700 metri oltre il paese, direzione E, poi S. Se effettuati a piedi andata e ritorno il percorso risul-ta compessivamente lungo 8,5 km. Chi vuole evitare l’asfalto per raggiungere la partenza può utilizzare le strade sterrate vicinali che conducono a SO del paese, trasformando la passeggiata in un’escur-sione di medio impegno. In questo caso è obbligatorio dotarsi di una cartina detta-gliata in scala 1:25.000.
Lungo il percorsoPodere Casa Nuova, Podere Montemag-giore, Case Colombaione, Podere Gatte-resi, Casa Basilico. E ritorno.
Elementi di interesse
Assetto collinare e idrografico dell’alto cor-so del fiume Cecina e suo paleocorso.
Cautele
Prudenza nel raggiungere l’inizio dell’itine-rario sulla strada asfaltata. Percorso age-vole che può essere molto fangoso in caso di cattivo tempo o di gran caldo.
38 39
la_guida_radicondoli.indd 38-39 01/09/14 12:19
Età
A
spe
tti
12
34
56
PR
EIS
TO
RIC
AE
TR
US
CO
-RO
MA
NA
ME
DIE
VA
LE
RIN
AS
CIM
EN
TO
XV
I-X
IX S
EC
OLO
CO
NTE
MP
OR
AN
EA
AG
EO
MO
RFO
LOG
IA
04
. Co
rna
te d
i Ge
rfa
lco
e
Po
gg
io R
itro
voli
12. G
eo
mo
rfo
log
ia
Co
lom
ba
ion
e2
5. P
ale
oc
ors
o d
el
Ce
cin
a2
6. P
og
gio
di M
on
tieri
BG
EO
LO
GIA
0
CID
RO
GR
AFIA
16. F
oss
o Q
ua
ran
tola
DN
ATU
RA
EV
IAB
ILIT
À
FIN
SE
DIA
ME
NTI/
PA
ES
I
43
. In
sed
iam
en
ti su
i P
og
gi S
ca
pe
rna
ta
e R
an
tìa6
4 A
nq
ua
: il b
org
o
GA
RC
HIT
ETTU
RA
52
. Mo
ntin
ge
gn
oli
68
. Villa
di O
lli rin
asc
i-m
en
tale
HR
ES
TI/R
UD
ER
I
IEC
ON
OM
IA
BO
SC
O/
PASTO
RIZ
IA
LA
GR
ICO
LTU
RA
MM
ETA
LLU
RG
IA
NIN
DU
STR
IA
RE
PE
RT
I NA
SC
OS
TI
29
. Ab
itato
etr
usc
o d
i Ga
tte
resi
32
. To
mb
e e
tru
sch
e d
el C
olo
mb
aio
ne
54
. Ra
dic
on
do
li m
ed
ieva
le6
3. A
nq
ua
: l’a
rch
itett
ura
66
. Ra
dic
on
do
li rin
asc
ime
nta
le
78
. Pa
sto
rizia
e t
ran
sum
an
za
la_guida_radicondoli.indd 40-41 01/09/14 12:19
Età
A
spe
tti
12
34
56
PR
EIS
TO
RIC
AE
TR
US
CO
-RO
MA
NA
ME
DIE
VA
LE
RIN
AS
CIM
EN
TO
XV
I-X
IX S
EC
OLO
CO
NTE
MP
OR
AN
EA
AG
EO
MO
RFO
LOG
IA
12. G
eo
mo
rfo
log
ia
Co
lom
ba
ion
e2
5. P
ale
oc
ors
o d
el
Ce
cin
a2
6. P
og
gio
di M
on
tieri
BG
EO
LO
GIA
15. G
rad
ino
te
tto
nic
o d
i C
oio
lo M
ate
rno
CID
RO
GR
AFIA
16. F
oss
o Q
ua
ran
tola
28
. Va
lle d
el C
ec
ina
DN
ATU
RA
7. F
ore
sta
de
l Be
rign
o-
ne
e M
on
te S
old
an
o
EV
IAB
ILIT
À6
1. V
iab
ilità
min
era
ria
ne
l Me
dio
evo
FIN
SE
DIA
ME
NTI/
PA
ES
I
43
. In
sed
iam
en
ti su
i P
og
gi S
ca
pe
rna
ta e
R
an
tìa
43
. In
sed
iam
en
ti su
i P
og
gi S
ca
pe
rna
ta e
R
an
tìa4
8. M
on
tec
ast
elli
Pis
an
o5
0. M
on
teg
uid
i6
2. V
olte
rra
me
die
vale
GA
RC
HIT
ETTU
RA
68
. Villa
di O
lli rin
asc
i-m
en
tale
HR
ES
TI/R
UD
ER
I
IE
CO
NO
MIA
B
OS
CO
/ P
AS
TO
RIZ
IA
69
. Tra
nsu
ma
nza
n
ell’
Ott
oc
en
to
LA
GR
ICO
LTU
RA
MM
ETA
LLU
RG
IA
NIN
DU
STR
IA
RE
PE
RT
I NA
SC
OS
TI
12. A
rch
eo
log
ia p
ale
olit
ica
a M
ate
rno
16. F
ium
e C
ec
ina
19. I
nse
dia
me
nti
a C
oio
lo e
Ma
tern
o2
9. A
bita
to e
tru
sco
di G
att
ere
si3
2. T
om
be
etr
usc
he
de
l Co
lom
ba
ion
e3
4. V
olte
rra
etr
usc
a4
6. M
inie
re d
’Arg
en
to5
4. R
ad
ico
nd
oli
me
die
vale
66
. Ra
dic
on
do
li rin
asc
ime
nta
le7
8. P
ast
oriz
ia e
tra
nsu
ma
nza
la_guida_radicondoli.indd 42-43 01/09/14 12:19
di «Strada della Fonte vecchia». Il percorso ricalca in questa parte l’itinerario Ethoikos segnato «C». Si supera il podere La Fonte, a sinistra, fino a un trivio. Qui si tiene la sinistra, in legge-ra salita, verso il Podere Colombaia abbandonando l’Itinerario segnato «C». Vediamo in basso a destra un vecchio lavatoio. In cima alla leggera salita si tiene la sinistra (a dritto si va verso Podere Colombaia) e si supera, a sinistra, l’ingresso (segnato da colonne) al Podere la Fonte. Si prosegue dritti, in discesa, passando sotto un pilone elettrico, fino a un podere con log-gia. La strada lo aggira da destra; si prosegue mantenendosi sempre sulla strada sterrata segnata da un filare di cipressi. Si giunge quindi a un quadrivio di strade bianche, nei pressi del Podere La Sala. Il percorso continua dritto verso il Podere La Saletta, che si raggiunge percorsi circa altri 800 metri in discesa. Dallo spazio di fronte all’abitazione si apprezzano la conformazione del fondovalle e il sistema di appoderamento, con i paesi di Mensano e Monteguidi sulle alture. Poco dopo la strada entra, in discesa, in un tratto di bosco caratterizza-to da affioramenti rocciosi di conglomerato, dove è facile in-contrare greggi di pecore al pascolo. Percorso circa un km in discesa la strada attraversa il fosso di Cerniano prima in-contrare sulla destra il caratteristico Podere San Domenico. Si procede ancora avanti per 500 metri, prima in pianura poi in salita, fino a incontrare a sinistra la strada per il Podere Il Teso-ro. Superato il bivio che vi conduce, 300 metri ci separano dal PP 9, intitolato allo stesso casolare. Poco più oltre si pone il confine del territorio comunale tra Radicondoli e Casole d’El-sa. Il ritorno avviene per la stessa strada.
Percorso 4 TESORO
Descrizione
Il percorso inizia dalla «Piazzetta Becucci», posta in alto rispet-to al parcheggio, dove si trova il PP 8. Il panorama verso NO si contraddistingue per la linea di paesi sommitali comprenden-te, su vari crinali, da sinistra a destra: Montecastelli, Monte-guidi, Casole d’Elsa, San Gimignano (che nelle giornate terse si intravede sullo sfondo in lontananza), Mensano. Si scende verso il parcheggio percorrendo un tratto di sterrato a destra, che conduce sotto le mura e porta al tratto, ora asfaltato,
Lunghezza 3,9 km Andata
Grado di difficoltà
Facile Medio Impegnativo Difficile
Tipo Andata e ritorno
Dislivello totale 250 metri
Note dominanti dell’itinerario sono le morfologia del territorio, il suo assetto mezzadrile e gli agglomerati medievali attorno ai quali si distendono gli affluenti di destra del fiume Cecina. Il pa-esaggio è cinto, in ordine, da E a O, sul versante posto a N, da Mensano, San Gimignano, Casole, Monteguidi, e Montecastelli Pisano. Nel quadro di una prospettiva di lettura complessiva del paesaggio questa si riduce progressivamente scendendo dal PP 8 al fondovalle, per poi risalire fino al PP 9. Dalla partenza all’arrivo si passa dalla visione complessiva del paesaggo al con-creto inserimento nella realtà dei luoghi. L’escursione è lunga e appagante anche per quanto riguarda lo sforzo fisico richiesto.
Luogo partenzaPiazzetta Becucci (PP 1, 8), che sovrasta il parcheggio «ex Macelli» (a O del paese).
Lungo il percorso
Podere La Fonte, Podere la Colombaia, Podere La Casina, Podere La Sala, Podere Saletta, Fosso Botrone, Podere an Dome-nico, Podere Tesoro.
Elementi di interesse
Valle tra Radicondoli e Monteguidi e il suo sistema poderale. Monteguidi, Monte-castelli e la valle del Fosso Botrone, con il sistema dei campi aperti e le diffuse risor-give di acqua legate alla geolitologia del versante.
Cautele
Attenzione all’orientamento nel primo trat-to fino al Podere la Sala. In inverno il guado del fosso Botrone presso il Podere San Domenico può essere difficile. In estate il percorso è poco ombreggiato e quindi fa-ticoso per i bambini, soprattutto nella sua parte mediana e finale.
4544
la_guida_radicondoli.indd 44-45 01/09/14 12:19
Età
A
spe
tti
12
34
56
PR
EIS
TO
RIC
AE
TR
US
CO
-RO
MA
NA
ME
DIE
VA
LE
RIN
AS
CIM
EN
TO
XV
I-X
IX S
EC
OLO
CO
NTE
MP
OR
AN
EA
AG
EO
MO
RFO
LOG
IA2
0. L
ine
e d
i fa
glia
BG
EO
LO
GIA
15. G
rad
ino
te
tto
nic
o
Co
iolo
-Ma
tern
o
CID
RO
GR
AFIA
01.
Alta
Va
lle d
el F
oss
o
Ve
tria
lla17
. Fo
ssi V
etr
ialla
e S
ala
28
. Va
lle d
el C
ec
ina
DN
ATU
RA
07
. Fo
rest
a d
el B
e-
rign
on
e e
Mo
nte
S
old
an
o
EV
IAB
ILIT
À
FIN
SE
DIA
ME
NTI/
PA
ES
I2
3. M
on
tec
alv
aia
no
23
. Mo
nte
ca
lva
ian
o4
4. M
en
san
o5
0. M
on
teg
uid
i3
6. C
aso
le d
’Els
a5
6. S
an
Gim
ign
an
o4
8. M
on
tec
ast
elli
Pis
an
o
62
. Vo
lterr
a m
ed
ieva
le
GA
RC
HIT
ETTU
RA
HR
ES
TI/R
UD
ER
I
IE
CO
NO
MIA
B
OS
CO
/ P
AS
TO
RIZ
IA
69
. Tra
nsu
ma
nza
n
ell’
Ott
oc
en
to
LA
GR
ICO
LTU
RA
71.
La
me
zza
dria
MM
ETA
LLU
RG
IA
NIN
DU
STR
IA
RE
PE
RT
I NA
SC
OS
TI
11. G
eo
mo
rfo
log
ia C
ase
ttin
o3
0. I
nse
dia
me
nto
ro
ma
no
32
. To
mb
e e
tru
sch
e d
el C
olo
mb
aio
ne
34
. Vo
lterr
a E
tru
sca
3
7. C
aso
le d
’Els
a: l
’arc
hite
ttu
ra4
5. A
rch
itett
ura
a M
en
san
o: b
org
o e
pie
ve4
6. M
inie
re d
’Arg
en
to4
9. M
on
tec
ast
elli:
l’a
rch
itett
ura
54
. Ra
dic
on
do
li m
ed
ieva
le5
5. R
ad
ico
nd
oli:
via
Ga
zze
i ne
l Me
dio
evo
66
. Ra
dic
on
do
li rin
asc
ime
nta
le6
7. R
ad
ico
nd
oli:
via
Ga
zze
i rin
asc
ime
nta
le7
3. R
ad
ico
nd
oli:
via
Ga
zze
i ne
ll’O
tto
ce
nto
77
. La
na
scita
de
lla g
eo
term
ia7
8. P
ast
oriz
ia e
tra
nsu
ma
nza
la_guida_radicondoli.indd 46-47 01/09/14 12:19
Età
A
spe
tti
12
34
56
PR
EIS
TO
RIC
AE
TR
US
CO
-RO
MA
NA
ME
DIE
VA
LE
RIN
AS
CIM
EN
TO
XV
I-X
IX S
EC
OLO
CO
NTE
MP
OR
AN
EA
AG
EO
MO
RFO
LOG
IA14
. Ge
om
orf
olo
gia
Te
soro
21.
Lito
log
ia d
etr
itic
a
BG
EO
LO
GIA
CID
RO
GR
AFIA
06
. Fiu
me
Ce
cin
a17
. Fo
ssi V
etr
ialla
e S
ala
DN
ATU
RA
EV
IAB
ILIT
À
FIN
SE
DIA
ME
NTI/
PA
ES
I2
3. M
on
tec
alv
aia
no
23
. Mo
nte
ca
lva
ian
o4
4. M
en
san
o4
8. M
on
tec
ast
elli
Pis
an
o5
0. M
on
teg
uid
i5
4. R
ad
ico
nd
oli
me
-d
ieva
le
GA
RC
HIT
ETTU
RA
53
. Pie
ve V
ec
ch
ia d
i R
ad
ico
nd
oli
66
. Ra
dic
on
do
li rin
asc
i-m
en
tale
HR
ES
TI/R
UD
ER
I
IE
CO
NO
MIA
B
OS
CO
/ P
AS
TO
RIZ
IA
69
. Tra
nsu
ma
nza
-n
ell’
Ott
oc
en
to
LA
GR
ICO
LTU
RA
71.
La
me
zza
dria
MM
ETA
LLU
RG
IA
NIN
DU
STR
IA7
7. L
a n
asc
ita d
ella
g
eo
term
ia
RE
PE
RT
I NA
SC
OS
TI
19. I
nse
dia
me
nti
a C
oio
lo e
Ma
tern
o2
0. L
ine
e d
i fa
glia
28
. Va
lle d
el C
ec
ina
33
. Via
bilit
à r
om
an
a4
5. A
rch
itett
ura
a M
en
san
o4
9. M
on
tec
ast
elli:
l’a
rch
itett
ura
55
. Ra
dic
on
do
li: v
ia G
azz
ei n
el M
ed
ioe
vo7
8. P
ast
oriz
ia e
tra
nsu
ma
nza
la_guida_radicondoli.indd 48-49 01/09/14 12:19
ta in discesa. Effettuata una curva ampia a destra, si arriva allo spazio pubblico con panchine, di fianco alla strada, dove è in-stallato un cannocchiale panoramico fisso. Proseguiamo per la strada fino ad intersecare via dell’Olmo, svoltiamo a sinistra e arriviamo a uno slargo con balcone naturale, caratterizzato dalla presenza di una croce in metallo. Qui è situato il PP10, che abbraccia il panorama da E a SE e fino a SO. Si prosegue lungo la strada, in discesa, fino a intersecare via delle Ribat-ti che in ripida salita ci indirizza NE. Fatte alcune centinaia di metri si arriva all’incrocio, su di una curva molto stretta, tra la strada di accesso a Belforte (verso il parcheggio) e quelle per Falsini e Cornocchia. Qui si svolta a sinistra e si continua tra i cipressi in direzione del cimitero, dove, in fondo alla strada, percorsi circa 400 metri, si pone il PP 11. Dopo l’osservazione si torna indietro sulla stessa strada fino all’incrocio, si svolta a sinistra in via Roma e poi ancora a sinistra in via del Moro, raggiungendo il parcheggio.
Percorso 5 BELFORTE
Descrizione
L’itinerario inizia dal parcheggio in via delle Campane, posto dietro la chiesa del Crocifisso. Lasciata l’auto, si percorre la breve via del Moro che sfocia nella strada centrale di Belforte (via Santa Croce), nei pressi di uno dei palazzi rinascimentali, che ci rimane a destra. Si percorre via Santa Croce in dire-zione SE attraversando il tessuto urbano e osservandone gli edifici più significativi. Si raggiunge quindi, dopo circa 5-600 metri, piazza Dina Ferri, per continuare lungo la strada asfalta-
Lunghezza 1,3 km
Grado di difficoltà
Facile Medio Impegnativo Difficile
Tipo Ad anello
Dislivello totale 80 metri
Il percorso, nella prima parte, è caratterizzato dall’attraversa-mento del centro storico di Belforte. Il paese è raccolto intorno alla strada principale di crinale (via Santa Croce) e l’itinerario la percorre fino al PP 10, che apre il panorama sui territori a confine della Toscana meridionale, verso il Monte Amiata, che si intra-vede sullo sfondo a SE. Nel secondo tratto si segue il perimetro della cinta muraria che conserva una delle torri rotonde medie-vali. Nel centro del paese invece, presso la chiesa, anch’essa medievale, prospetta sulla via Santa Croce un interessante edi-ficio con torre in mattoni e porta ad arco acuto in pietra, dotata di mensole scolpite.
Luogo partenza Parcheggio in via delle Campane.
Lungo il percorsoVia del Moro, Via Santa Croce, Piazza Dina Ferri, Via dell’Olmo, Cimitero, Via Roma, Via del Moro, Parcheggio via delle Campane.
Elementi di interesse
Belforte si affaccia da un lato su Radicon-doli, a N; dall’altro sul territorio a SE verso la Toscana meridionale. A un’area panorami-ca più raccolta, sotto il Poggio di Montieri, fa da contraltare un paesaggio più aperto che arriva fino al Monte Amiata passando per il Pian di Feccia e la Val di Merse.
Cautele
Svolgendosi tutto su strada asfaltata, nell’ effettuare il percorso occorre far attenzio-ne alle rare automobili in transito. Tenere i bambini per mano.
50 51
la_guida_radicondoli.indd 50-51 01/09/14 12:19
Età
A
spe
tti
12
34
56
PR
EIS
TO
RIC
AE
TR
US
CO
-RO
MA
NA
ME
DIE
VA
LE
RIN
AS
CIM
EN
TO
XV
I-X
IX S
EC
OLO
CO
NTE
MP
OR
AN
EA
AG
EO
MO
RFO
LOG
IA0
4. C
orn
ate
di G
erf
alc
o
e P
og
gio
Ritr
ovo
li2
6. P
og
gio
di M
on
tieri
BG
EO
LO
GIA
22
. Mo
nte
Am
iata
CID
RO
GR
AFIA
DN
ATU
RA
EV
IAB
ILIT
À
FIN
SE
DIA
ME
NTI/
PA
ES
I
40
. Ch
iusd
ino
52
. Mo
ntin
ge
gn
oli
60
. Tra
vale
GA
RC
HIT
ETTU
RA
HR
ES
TI/R
UD
ER
I3
9. C
ast
ello
di E
lci
IE
CO
NO
MIA
B
OS
CO
/ P
AS
TO
RIZ
IA
LA
GR
ICO
LTU
RA
MM
ETA
LLU
RG
IA
NIN
DU
STR
IA7
5. C
en
tra
li g
eo
term
ich
e
RE
PE
RT
I NA
SC
OS
TI
10. G
eo
mo
rfo
log
ia B
elfo
rte
24
. Pia
ni d
i Fe
cc
ia e
de
l Me
rse
35
. Be
lfort
e m
ed
ieva
le4
6. M
inie
re d
’Arg
en
to4
7. M
on
ast
ero
cis
terc
en
se d
i Sa
n G
alg
an
o5
1. M
on
ticia
no
64
. An
qu
a: i
l bo
rgo
65
. Be
lfort
e r
ina
scim
en
tale
77
. La
na
scita
de
lla g
eo
term
ia
la_guida_radicondoli.indd 52-53 01/09/14 12:19
Età
A
spe
tti
12
34
56
PR
EIS
TO
RIC
AE
TR
US
CO
-RO
MA
NA
ME
DIE
VA
LE
RIN
AS
CIM
EN
TO
XV
I-X
IX S
EC
OLO
CO
NTE
MP
OR
AN
EA
AG
EO
MO
RFO
LOG
IA
10. G
eo
mo
rfo
log
ia
Be
lfort
e2
4. P
ian
i di F
ec
cia
e d
el
Me
rse
BG
EO
LO
GIA
22
. Mo
nte
Am
iata
CID
RO
GR
AFIA
DN
ATU
RA
EV
IAB
ILIT
À
FIN
SE
DIA
ME
NTI/
PA
ES
I
35
. Be
lfort
e m
ed
ieva
le4
0. C
hiu
sdin
o5
1. M
on
ticia
no
GA
RC
HIT
ETTU
RA
47
. Ill
mo
na
ste
ro
cis
terc
en
se d
i Sa
n
Ga
lga
no
65
. Be
lfort
e r
ina
sci-
me
nta
le
HR
ES
TI/R
UD
ER
I
IE
CO
NO
MIA
B
OS
CO
/ P
AS
TO
RIZ
IA
LA
GR
ICO
LTU
RA
MM
ETA
LLU
RG
IA
NIN
DU
STR
IA
la_guida_radicondoli.indd 54-55 01/09/14 12:19
Percorso 6 ANQUA
Descrizione
L’itinerario ha inizio dal pianoro su cui è adagiato il borgo stori-co, nel punto dove iniziano le basse costruzioni rurali (annessi della fattoria) che anticipano il grande complesso villa-fattoria di Anqua, di straordinaria bellezza, preceduto da una cancellata con stemma dei Pannocchieschi, proprietari dell’immobile. Di fronte alla villa, delimitato da un muretto e da una fila di alberi, si apre un piazzale dove è posizionato il PP 12. La vista, pur in parte occultata dagli alberi, si allarga a N attraverso i corridoi naturali rappresentati, a destra, dalla valle del fiume Cecina e, a sinistra, da quella del torrente Pavone. La prima, aggirando il poggio Scapernata si dispone in linea con chi osserva, aprendo il pano-rama sul versante orografico destro, costituito dalle colline dove sorgono i paesi di Radicondoli, Mensano e Casole d’Elsa. La valle del Pavone, invece, permette di allungare la visuale a NO e, quindi, sullo spartiacque tra i due fiumi. Dal PP si prende a piedi la strada asfaltata in direzione O, che si mantiene sul crinale posto
fra la valle del torrente Rimaggio a S, e quella del Ricavolo a N. Senza curve, la strada sale fino al podere Croci, dove è posto il PP 13. Da qui si può intravedere Anqua nella prospettiva che in-quadra Radicondoli. Il ritorno si effettua per la medesima strada.
Lunghezza 0,7 km Andata
Grado di difficoltà
Facile Medio Impegnativo Difficile
Tipo Andata e ritorno
Dislivello totale 35 metri
Percorso molto breve e adatto a tutti ma di grande intensità. La Fattoria e il Borgo di Anqua meritano di essere osservati da vicino per apprezzarne l’impianto rinascimentale. Il panorama si apre in direzione N con il paese di Radicondoli a destra in lonta-nanza. I preesistenti insediamenti etrusco-romani si sono inne-stasti sul tessuto medievale del paesaggio, successivamente arricchito dalla villa rinascimentale di Anqua. L’equilibrio tra storia, paesaggio e architettura è perfetto.
Luogo partenza Fattoria di Anqua
Lungo il percorsoFattoria di Anqua, Strada Comunale Pog-gione Colonna Sesta, Podere Croci.
Elementi di interesse
Prettamente paesaggistici.
CautelePrestare attenzione alle rare automobili e macchine agricole che possono transitare sulla strada asfltata.
56 57
la_guida_radicondoli.indd 56-57 01/09/14 12:19
Età
A
spe
tti
12
34
56
PR
EIS
TO
RIC
AE
TR
US
CO
-RO
MA
NA
ME
DIE
VA
LE
RIN
AS
CIM
EN
TO
XV
I-X
IX S
EC
OLO
CO
NTE
MP
OR
AN
EA
AG
EO
MO
RFO
LOG
IA
BG
EO
LO
GIA
CID
RO
GR
AFIA
6. F
ium
e C
ec
ina
DN
ATU
RA
EV
IAB
ILIT
À
FIN
SE
DIA
ME
NTI/
PA
ES
I
36
. Ca
sole
d’E
lsa
48
. Mo
nte
ca
ste
lli P
isa
no
50
. Mo
nte
gu
idi
54
. Ra
dic
on
do
li m
e-
die
vale
62
. Vo
lterr
a m
ed
ieva
le
72
. Po
ma
ran
ce
GA
RC
HIT
ETTU
RA
59
. Ro
cc
a d
i Silla
no
59
. Ro
cc
a d
i Silla
no
66
. Ra
dic
on
do
li rin
asc
i-m
en
tale
58
. Ch
iesa
di S
an
Lo
-re
nzo
a M
on
talb
an
o
HR
ES
TI/R
UD
ER
I3
1. P
od
ere
Bu
cig
na
no
IE
CO
NO
MIA
B
OS
CO
/ P
AS
TO
RIZ
IA
LA
GR
ICO
LTU
RA
42
. Fa
tto
ria d
i Te
go
ni
MM
ETA
LLU
RG
IA
NIN
DU
STR
IA
RE
PE
RT
I NA
SC
OS
TI
09
. Ge
om
orf
olo
gia
An
qu
a18
. Go
la d
el C
ec
ina
34
. Vo
lterr
a e
tru
sca
37
. Ca
sole
d’E
lsa
: l’a
rch
itett
ura
44
. Me
nsa
no
45
. Arc
hite
ttu
ra a
Me
nsa
no
: bo
rgo
e p
ieve
49
. Mo
nte
ca
ste
lli: l’
arc
hite
ttu
ra5
5. R
ad
ico
nd
oli:
via
Ga
zze
i ne
l Me
dio
evo
57
. Ca
ste
llo d
i Mo
nta
lba
no
63
. An
qu
a: l
’arc
hite
ttu
ra6
4. A
nq
ua
, il b
org
o7
6. F
att
ora
di A
nq
ua
og
gi
la_guida_radicondoli.indd 58-59 01/09/14 12:19
Età
A
spe
tti
12
34
56
PR
EIS
TO
RIC
AE
TR
US
CO
-RO
MA
NA
ME
DIE
VA
LE
RIN
AS
CIM
EN
TO
XV
I-X
IX S
EC
OLO
CO
NTE
MP
OR
AN
EA
AG
EO
MO
RFO
LOG
IA
BG
EO
LO
GIA
CID
RO
GR
AFIA
DN
ATU
RA
27
. Po
gg
io C
asa
lon
e
EV
IAB
ILIT
À
FIN
SE
DIA
ME
NTI/
PA
ES
I
35
. Be
lfort
e m
ed
ieva
le3
6. C
aso
le d
’Els
a4
4. M
en
san
o5
0. M
on
teg
uid
i5
4. R
ad
ico
nd
oli
me
-d
ieva
le
63
. An
qu
a: l
’arc
hite
ttu
ra6
4. A
nq
ua
: il b
org
o
GA
RC
HIT
ETTU
RA
HR
ES
TI/R
UD
ER
I
IE
CO
NO
MIA
B
OS
CO
/ P
AS
TO
RIZ
IA
LA
GR
ICO
LTU
RA
42
. Fa
tto
ria d
i Te
go
ni
MM
ETA
LLU
RG
IA
NIN
DU
STR
IA
RE
PE
RT
I NA
SC
OS
TI
09
. Ge
om
orf
olo
gia
An
qu
a2
5. P
ale
oc
ors
o d
el C
ec
ina
37
. Ca
sole
d’E
lsa
: l’a
rch
itett
ura
43
. In
sed
ima
ne
ti su
i Po
gg
i Sc
ap
ern
ata
e R
an
tìa4
5. A
rch
itett
ura
a M
en
san
o: b
org
o e
pie
ve5
5. R
ad
ico
nd
oli:
via
Ga
zze
i ne
l Me
dio
evo
57
. Ca
ste
llo d
i Mo
nta
lba
no
58
. Ch
iesa
di S
an
Lo
ren
zo a
Mo
nta
lba
no
65
. Be
lfort
e r
ina
scim
en
tale
66
. Ra
dic
on
do
li rin
asc
ime
nta
le7
6. F
att
ora
di A
nq
ua
og
gi
la_guida_radicondoli.indd 60-61 01/09/14 12:19
Visibilità
I reperti archeologici non sono percepibili nel paesaggio; an-che sul posto solo un occhio esperto è in grado di individuare i frammenti di selce sparsi nei pressi del podere e lungo le pendici della collina che scendono presso la confluenza tra il Vetrialla e il fiume Cecina.
Descrizione
Il Piano di Materno ha restituito resti che testimoniano inequi-vocabilmente la persistenza abitativa dell’uomo in questi luo-ghi dall’epoca neolitica alla tarda età imperiale. La presenza del fiume unita alla morfologia non aspra del territorio, versato quindi alla pratica dell’agricoltura, ha evidentemente permes-so nei secoli passati l’insediamento umano. Al di là dei ritrova-menti archeologici, la mancanza assoluta di studi approfonditi del territorio come quello realizzato sul comprensorio di Ra-dicondoli impedisce di chiarire le rispettive specificità di una zona rispetto all’altra. Questo vale ad esempio per i resti di una fattoria, circoscritti alla bassa collina situata presso il piano alluvionale del Vetrialla, riferibili alla tarda età imperiale (III-IV se-colo d.C.), la cui tipologia insediativa non sembra infatti differi-re dalle fattorie tipiche del I secolo d.C.. Tutto questo mentre in altre zone dell’Etruria si cominciano contemporaneamente a registrare i primi abbandoni e cali demografici. Se questa situazione, per certi versi “fossile”, sia tipica del solo territorio di Radicondoli, isolato, marginale e periferico, o se invece sia riscontrabile anche in altri territori, gli studiosi non sono attual-mente in grado di affermarlo. Il Piano di Materno ha restituito anche resti (accettine) del Neolitico e pure quelli di un piccolo abitato etrusco del tipo ‘“aperto”, posto sulla bassa pendice del pianoro di Casa Materno (cfr. C. CUCINI 1990, 149-153).
2. Archeologia paleolitica a Materno
Visibilità
Il fosso di Vetrialla è composto da tre tributari separati (Ripu-tine, Vetrialla mensanese e Cerniano) che confluiscono nella sua parte finale. I rilievi che separano questi tre piccoli corsi d’acqua – con le loro rispettive valli – sono il Poggio di Cal-vaiano e le propaggini nord-occidentali del Poggio Casalo-ne. I primi due fossi scendono dalle pendici sud-occidentali di Mensano in direzione NE-SO, mentre il Cerniano dal piccolo crinale che unisce l’abitato di Radicondoli al Poggio Casalone (direzione E-O). La valle si vede chiaramente dai PP 1, 2, 8.
Descrizione
Il Fosso Vetrialla scorre nei comuni di Casole d’Elsa e di Ra-dicondoli in parti pressoché uguali, per una lunghezza totale di circa 7 km. Il corso d’acqua si pone in corrispondenza di una linea di frattura tra due serie di sedimenti geologicamente più recenti del territorio radicondolese, e cioè quelli plioceni-ci e miocenici, al cui interno sono comprese anche le argille. Questa linea di frattura (detta anche faglia) caratterizza forte-mente la morfologia del luogo e le relative pendenze, condi-zionando l’uso del suolo e le sue caratteristiche pedologiche, nonché le colture e, dunque, anche la forma dell’insediamen-to. La linea di faglia assume la sua maggiore evidenza nella morfologia del fosso Vetrialla mensanese, dove si vede un profondo solco ricoperto interamente dal bosco. La strada provinciale delle Galleraie, di antico impianto, supera la stretta valle con un andamento tortuoso, appoggiandosi alle curve di livello, non costituendo così un elemento di disturbo del pae-saggio. Proprio per l’azione di scivolamento delle argille e dei terreni di sponda, recentemente il Fosso Vetrialla è stato og-getto di interventi di consolidamento realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica, nell’intento di preservare l’armonia del paesaggio (cfr. C. CUCINI 1990, 37-41).
1. Alta Valle del Fosso Vetrialla
Matrice H1
Argomento Resti / Ruderi
Età Preistorica
Latitudine 43.273712
Longitudine 11.008801
Distanza da... Radicondoli, 8 km in linea d’aria, in direzione NO
Matrice C1
Argomento Idrografia
Età Preistorica
Latitudine 43.282773
Longitudine 11.044164
Distanza da... Radicondoli, 2 km in linea d’aria, in direzione NE
1 2
64 65
la_guida_radicondoli.indd 64-65 01/09/14 12:19
4. Cornate di Gerfalco e Poggio Ritrovoli
Visibilità
Il massiccio delle Cornate e del Poggio Ritrovoli (quest’ultimo localmente conosciuto come le Carline) si staglia con impo-nenza verso S, come sfondo della valle del Cecina, guardan-do in direzione delle sue sorgenti. E’ visibile dai PP 5, 6 e 10. Le altezze raggiunte dal massiccio, unite al suo sviluppo, trasver-sale alla direzione di chi lo osserva da Radicondoli, ne accre-scono significativamente, per l’occhio, la massa complessiva, condizionando l’intero quadro paesaggistico della zona.
Descrizione
Il gruppo montuoso delle Cornate di Gerfalco (1.060 metri) e del Poggio Ritrovoli (1.014 metri) costituisce una delle rare aree delle province di Siena e di Grosseto con spiccate carat-teristiche montane a partire dall’altitudine. Qui infatti, a causa delle formazioni geologiche affioranti, della tettonica che le ha modificate e del combinarsi di queste con gli agenti erosivi (acqua e vento), la morfologia è caratterizzata da un aspetto particolarmente aspro, con rotture di pendìo e veri e propri strapiombi, che nella zona di Poggio Mutti e Fosini raggiungo-no il loro massimo effetto spettacolare. Ma è tutto il comples-so, insieme al vicino Poggio di Montieri, che emerge con forza dal territorio circostante profondamente solcato dal maggio-re fiume delle Colline Metallifere che qui ha origine, il Cecina. La presenza del suo profondo solco vallivo infatti, unita al fatto che l’altitudine media (circa 500 metri) del territorio posto a N di questo gruppo si mantiene costante - in riva destra orogra-fica del fiume - fino alla base del suo versante settentrionale, ne esaltano la capacità ‘impressionistica’ sull’occhio dell’os-servatore. La valle del Cecina, e la contermine valle del suo affluente Rimaggio, costituiscono infatti un corridoio visivo che rompe il grande bastione costituito dal prolungamento verso N di Poggio Ritrovoli e Poggio Torricella e avvicina note-volmente all’occhio di chi osserva quel paesaggio dalla zona di Radicondoli-Belforte, le masse montuose delle Carline e di Costa Salicastro. Queste infatti sono i primi contrafforti che lo sguardo incontra guardando in direzione S e che fondendosi, a causa della distanza, con il crinale retrostante (e trasversa-
3. Conglomerati
Visibilità
Il colle di Radicondoli, composto dai sedimenti plio-miocenici che comprendono i conglomerati di formazione lacustre, le argille e le evaporiti di formazione marina-evaporitica, è visibile da qualunque strada porti al paese. Questo tipo di sedimenti si individuano in modo evidente prima del PP5, in corrispon-denza dell’area di sosta dei camper (area alla quale facciamo riferimento per coordinate e distanza).
Descrizione
Il colle su cui sorge il paese di Radicondoli raggiunge un’alti-tudine di circa 510 metri s.l.m. e si eleva nettamente di circa 250-300 metri sui corsi dei tre fossi che lo circondano da N (il Vetrialla), da SE (il Lucignano) e da SO (il Quarantola). Tutti e tre questi corsi d’acqua sono tributari del Cecina e alcu-ni indizi geomorfologici li accomunano a quest’ultimo fiume per quanto concerne la variazione nel tempo del rispettivo reticolo idrografico, come testimonia la presenza dei terrazzi alluvionali disposti diversamente rispetto all’attuale corso del fiume maggiore. I conglomerati di età pliocenica (da 5 a 2 mi-lioni di anni fa) sono per lo più rappresentati nella zona di Ra-dicondoli da ciottoli di diversa grandezza, cementati fra loro da un composto di argilla e sabbia. Sotto questi conglomerati compaiono, e a volte sono messi in superficie dall’erosione delle acque piovane, dei detriti di calcare e delle argille di origi-ne marina. I detriti di calcare sono stati storicamente utilizzati come materiali da costruzione e anche per la produzione di calce, attraverso la cottura in fornace. Pure le argille hanno visto l’utilizzo come materiale da costruzione (mattoni e la-terizi cotti in fornace) per le case ed i palazzi a Radicondoli e Belforte, soprattutto in età moderna. La geolitologia del colle di Radicondoli ha fornito all’uomo nel corso del tempo anche molti altri materiali quali gesso, lignite e zolfo che hanno dato vita a produzioni anche serializzate. Nel ‘600, ad esempio, la presenza di botteghe di gessai in paese, fa presupporre lo sfruttamento dei gessi presenti in zona (cfr. C. CUCINI 1990, 39).
Matrice A1
Argomento Geomorfologia
Età Preistorica
Latitudine 43.158374
Longitudine 10.955057
Distanza da… Radicondoli, 13,5 km in linea d’aria, in direzione SO
Matrice B1
Argomento Geologia
Età Preistorica
Latitudine 43.258738
Longitudine 11.042803
Distanza da... Radicondoli, circa 450 metri
3 4
66 67
la_guida_radicondoli.indd 66-67 01/09/14 12:19
5. Emissioni geotermiche
Visibilità
Le emissioni geotermiche sono visibili in inverno, primavera e autunno come pennacchi bianchi di vapore acqueo sullo sfondo del paesaggio. In estate possono invece essere in-visibili. La vista dei pennacchi, da buona parte delle Colline Metallifere, è un ottimo punto di riferimento per orientarsi nel paesaggio, anche da distanze consistenti. Come riferimento per la distanza e le coordinate prendiamo il pozzo della cen-trale geotermoelettrica di Radicondoli, sotto Monte Gabbro.
Descrizione
Il territorio di Radicondoli è inserito nella cosiddetta “Regione Boracifera” dove è nato, e si è poi sviluppato, lo sfruttamento dei fluidi geotermici; prima per la produzione dell’acido borico, poi, a partire dagli anni Trenta del ‘900, per opera del nobile fiorentino Piero Ginori, per quella dell’energia elettrica. L’ener-gia geotermica deriva dal calore posseduto dalla terra e per questo motivo rientra tra le fonti “rinnovabili”. Il calore della ter-ra aumenta infatti normalmente di circa 1°C ogni 30 metri di profondità mentre in queste zone l’aumento di temperatura con la profondità è molto più rapido. Le emissioni geotermi-che naturali sono il fenomeno mediante il quale il calore na-turale delle rocce è portato in superficie dalle falde acquifere presenti in prossimità del giacimento geotermico. Nel 1860 nella zona di Travale venne ad operare la “Società Travalese”, di fresca istituzione, che impiantò un piccolo stabilimento per la produzione dell’acido borico. Come tutte le intraprese ‘in-dustriali’ che nella storia moderna si sono avvicendate nelle Colline Metallifere, anche questa ebbe vita breve e stentata e nel 1916 fu rilevata dalla “Società Boracifera” di Larderello. Ma è solo dopo il secondo conflitto mondiale che, grazie anche agli studi precedenti degli anni Trenta, furono raggiunte mag-giori profondità nelle perforazioni riuscendo così ad attingere dai grandi serbatoi profondi che hanno permesso negli anni Settanta del Novecento di impostare un piano di produzione elettrica di alcune centinaia di Megawatt. La ricostruzione del-la storia geologica del territorio contribuisce a chiarire i per-ché della presenza di una “Regione Boracifera” nelle Colline
le) delle Cornate, contribuiscono ad un’impressione visiva di grandiosità dell’intero gruppo. Le Cornate di Gerfalco e il vicino Poggio Mutti dalla caratte-ristica forma a cupola sono costituiti dalle formazioni che i geologi chiamano Calcare massiccio, i Diaspri e il Rosso am-monitico, rocce queste con molti fossili al loro interno come ad esempio le ammoniti da cui il nome Rosso ammonitico. La roccia invece che costituisce il Poggio Ritrovoli è molto diver-sa (trattandosi del Macigno) e molto più recente, così come è estremamente diversa la resistenza che le due famiglie di rocce oppongono alle acque piovane e agli agenti atmosfe-rici che tendono a disgregarle. È questo uno dei principali motivi, unito alla tettonica distensiva, per cui è così diverso il paesaggio delle Cornate che scende dolcemente verso Co-sta Salicastro, Anqua e Solaio da quello alpestre di Fosini che precipita invece verso il fosso Riponti ed il fiume Pavone. Il primo infatti è caratterizzato da grandi paleofrane detritiche che, accumulandosi alla base del versante, ne hanno addol-cito in maniera consistente la pendenza. La zona invece di Fosini e Poggio Mutti costituita da una litologia che ‘regge’ meglio le pendenze anche più accentuate e, diversamente dall’altra, libera da poggi confinanti, si caratterizza per rotture di pendìo improvvise e profili a cresta come quello caratteri-stico (a forma di falce) delle Cornate. Localizzato all’incrocio di tre province (Siena, Grosseto e Pisa), questo territorio ‘cer-niera’ risulta per le sue caratteristiche geografiche, ambientali e storico-insediative di grande interesse, oltre a rappresen-tare un vero e proprio ‘nodo’ paesaggistico dell’intere Colline Metallifere (cfr. GENNAI – LANDI – BAGGIANI 2004, 30).
Per approfondire
Notizie. Nel 1996 la provincia d Siena ha istituito undici Riserve Naturali tra cui anche “Cornate e Fosini”. I confini dell’area protetta abbracciano tutto il crinale delle Cornate e del vicino Poggio Mutti e contengono a N le pendici sudoccidentali di Costa Salicastro, dove si trova il castello di Fosini, nel territorio amministrativo di Ra-dicondoli. Presso la località di Campo alle Rose, posta sul versante meridionale delle Cornate, e le pendici di Poggio Mutti si individua-no ancora oggi i luoghi dove nel corso del Medioevo sono stati estratti il “marmo persichino” utilizzato per la facciata del duomo di Siena (Campo alle Rose), e la galena argentifera utilizzata dai Vescovi di Volterra per coniare moneta.
Gite. Recarsi a piedi sulla vetta della Cornate in una limpida gior-nata invernale regala emozioni intense e panorami superbi in dire-zione del vicino Tirreno. Sono infatti ben visibili, oltre ad una buona parte delle isole dell’arcipelago toscano, anche l’intero profilo se-ghettato delle montagne corse.
Matrice B1
Argomento Geologia
Età Preistorica
Latitudine 43.192919
Longitudine 11.044765
Distanza da… Radicondoli, 7,8 km le emissioni più prossime.
4 5
68 69
la_guida_radicondoli.indd 68-69 01/09/14 12:19
6. Fiume Cecina
Visibilità
La valle del fiume Cecina si identifica a sinistra del PP 1, sotto la linea delle colline che fungono da displuvio con la confinan-te valle del torrente Pavone. Il fiume Cecina scorre in questo tratto in direzione N, dove raccoglie le acque degli affluenti di destra, per poi piegare verso O, sotto Volterra, e raggiunge-re il mare. La valle è perfettamente visibile e identificabile da tutte le colline che formano la linea spartiacque con il con-termine bacino fluviale del Merse; queste colline accolgono i nuclei abitati della zona (Radicondoli, Belforte, Montingegnoli, Travale) collegati dalla viabilità principale che si è ‘appoggia-ta’ sul crinale medesimo. Insieme al gruppo delle Cornate di Gerfalco e Poggio Ritrovoli, la valle del Cecina costituisce l’e-lemento paesaggistico fondamentale dell’intera zona. E’ visi-bile, per tratti più o meno ampi, dai PP 1, 7, 8, 9 e 12.
Descrizione
Con i suoi 79 chilometri di lunghezza, il fiume Cecina è il ter-zo corso d’acqua della Toscana dopo l’Arno e l’Ombrone grossetano. Nelle foto satellitari la valle del Cecina si presenta come una depressione che prima si allunga per circa 50 km in direzione E-O all’interno della costa tirrenica, per poi dispor-si, nel restante tratto fino alle sorgenti, con andamento SN. Il corso d’acqua ha la sua origine dal gruppo montuoso delle Cornate di Gerfalco e Poggio Ritrovoli e si apre il passaggio in un territorio costituito da formazioni litologiche estremamente diverse. Una volta giunto alla fine del bacino tettonico di Radi-condoli-Monteguidi, il Cecina compie un’ampia curva in dire-zione NO, per poi superare la gola ofiolitica di Berignone. E’ a questo punto poi che, incontrando i cospicui depositi argillosi rappresentati dalle colline del Berignone, Volterra e Monteca-tini Val di Cecina, il fiume è costretto a piegare decisamente verso O. Giunto a Saline il suo corso si orienta in direzione EO percorrendo l’ultimo tratto verso Ponteginori e Casino di Terra, fino a gettarsi nel Tirreno. Alla complessità dell’assetto geologico-strutturale delle Colline Metallifere, nel cui com-prensorio scorre buona parte del Cecina, si deve attribuire
Matrice C1
Argomento Idrografia
Età Preistorica
Latitudine 43.227632 (Ponte sul Cecina)
Longitudine 11.014988
Distanza da…Radicondoli, 3,5 km in linea d’aria, in direzione E (punto più vicino)
Metallifere, particolarmente sviluppata fra Larderello, Monte-rotondo Marittimo e Radicondoli. La zona infatti rappresenta un tratto di una lunga fascia che, corrugatasi tra i 20 ed i 15 milioni di anni fa a causa delle spinte compressive dovute alla collisione dei margini continentali europeo e africano, fu suc-cessivamente sottoposta ad una serie di forze opposte do-vute ad una tettonica distensiva. Questa stirò la crosta della Toscana occidentale provocando collassi e sprofondamenti a più riprese, nonché un gran rimescolamento fra gli strati ge-ologici più giovani e più vecchi. Aspetto questo che ha costi-tuito per molto tempo un autentico rompicapo per i geologi che si apprestavano a studiare le Colline Metallifere. Alla tet-tonica distensiva si associò un consistente assottigliamento e fratturazione della crosta soprastante che determinò un ele-vato e anomalo flusso di calore proveniente dalle profondità della terra. Flusso che oltre a dare origine a tutti i fenomeni di magmatismo della costa tirrenica italiana (dalla Toscana alla Sicilia) fu alla base del fenomeno geotermico dove la risalita fino circa 10 km sotto la superficie di un grosso corpo mag-matico ha dato luogo, negli ultimi 3-4 milioni di anni, ad un “vasto e potente sistema idrotermale a vapore”. Fra le rocce che costituiscono il suolo e il sottosuolo di Radicondoli c’è an-che il Calcare massiccio, che affiora in maniera estesa sulle Cornate di Gerfalco e sul vicino Poggio Mutti. Questa roccia ospita mineralizzazioni di Argento e Zinco attivamente coltiva-te e utilizzate nei secoli passati e conserva negli strati profondi riserve idriche che sono di estrema importanza per la ricarica del sistema geotermico. È l’acqua, infatti, che, attraverso le falde freatiche profonde, entra in contatto con il calore geo-termico e si trasforma in vapore che riempie i grandi serbatoi ipogei in forma pressurizzata. Una volta che questi serbatoi sono perforati dalle sonde avviene l’emissione di vapore ad altissima pressione, il quale è incanalato e condotto in cen-trale, dove muove le turbine e produce energia elettrica (cfr. MARRUCCI – NANNONI 2003, 10-11).
Per approfondire
Museo della Geotermia di Larderello. Di proprietà dell’Enel, il Museo è stato di recente riaperto ed è attualmente dotato delle più moderne tecniche di museografia che ne facilitano la visita. Collegati al musei vi sono poi alcuni siti di interesse geotermico visitabili in giornata.
Trasferimenti, gite. Per raggiungere la centrale di Radicondo-li, dove sono anche alcuni pannelli esplicativi, si percorre la SP 3 delle Galleraie per circa 12,7 km; per quella di Travale si percorre la stessa provinciale in direzione di Montieri per circa 5 chilometri. Per arrivare a Castelnuovo Val di Cecina e vedere la centrale ge-otermica dei Lagoni occorre percorrere, per circa mezz’ora, 26 chilometri sulla stessa Strada Provinciale, in direzione O.
5 6
70 71
la_guida_radicondoli.indd 70-71 01/09/14 12:19
7. Foresta del Berignone e Monte Soldano
Visibilità
Il complesso boscoso del Berignone e del Monte Soldano si vede molto bene dal paese di Radicondoli e da tutto il ver-sante che dal paese scende verso il fondovalle del Cecina. E’ visibile quindi dai PP 1, 2, 3, 7 e 8.
Descrizione
A pochi chilometri a SE di Volterra, il complesso Berigno-ne-Tatti occupa il crinale Valdelsa-Valdicecina. Si tratta di una serie di estese colline poste a cavallo fra le comunità di Vol-terra, Pomarance e Casole d’Elsa che originano in corrispon-denza della riva destra del Cecina, nel punto in cui il fiume compie una decisa curva verso O. Di forma vagamente cir-colare, l’area (2.670 ettari) è delimitata dai corsi dei torrenti Sellate e Fosci, che rappresentano i due dei principali corsi d’acqua del complesso. I rilievi dell’area del Berignone non superano i 600 metri di altitudine e sono costituiti soprattutto dal Poggio Metato e dal Monte Soldano i quali contrassegna-no con le loro due punte arrotondate, separate da una sella, lo skyline del complesso da qualunque punto lo si osservi. Le pendenze sono di modesta entità, tranne che nella parte me-ridionale, dove l’erosione di alcuni torrenti ha profondamente inciso la spessa coltre di depositi sedimentari fluvio-lacustri del Miocene superiore (10 milioni di anni). La foresta del Beri-gnone costituisce da sempre per gli abitanti di Volterra, e an-che per quelli di una vasta area che arriva ad inglobare anche la media Valdelsa ed il territorio di Radicondoli, il sinonimo di boschi sterminati, dove animali selvatici vivono indisturbati e dove è possibile attingere ad una riserva di carbone presso-ché inesauribile. Di proprietà pubblica e adesso gestita dalla Uniune Montana dei Comuni della Val di Cecina con manda-to della Regione Toscana, la foresta del Berignone vanta una storia secolare che affonda le radici nella Volterra altomedie-vale. Molto più recentemente (inizi ‘900) questi territori hanno presentato anche motivi di interessi economici legati all’e-scavazione della lignite presto, però, rivelatasi non economi-camente produttiva (cfr. GENNAI 2004, 53-63).
Matrice D1
Argomento Natura
Età Preistorica
Latitudine 43.204940 (Monte Soldano)
Longitudine 10.575163
Distanza da… Radicondoli, 11 km in linea d’aria, in direzione NO
la configurazione decisamente irregolare del suo bacino che presenta un reticolo idrografico marcato da una profonda dissimmetria in senso trasversale con gli affluenti di destra che si caratterizzano per corsi brevi e pendenze maggiori ri-spetto a quelli di sinistra. Nella parte alta del suo corso, il Ceci-na presenta un fenomeno caratteristico di numerosi fiumi to-scani originatisi – come il Cecina - nel Miocene (circa 5 milioni di anni fa), quando potentissime forze distensive stirarono la crosta terrestre delle Colline Metallifere di almeno il 60%. L’a-rea del Cecina compresa fra Anqua e il Berignone, interes-sata da questa tettonica distensiva, sprofondò creando un vero e proprio bacino; questo fenomeno, come pure il suo ri-sultato geo-paesaggistico, ha assunto dei caratteri tipici nella storia geologica recente della nostra Regione come stanno a dimostrare altri esempi simili (Mugello, Lunigiana, Valtiberina, Valdarno di sopra, Garfagnana). Nel caso del territorio di Ra-dicondoli, in prossimità dei Piani di Coiolo e Materno, si formò quello che i geologi oggi chiamano gradino tettonico, cioè a dire una differenza improvvisa e geologicamente repentina di altitudine dell’alveo. Questa portò come risultato la cattura di altri corsi d’acqua limitrofi con conseguenti variazioni di ero-sione e di velocità di scorrimento delle acque di questi stessi fiumi. Una vera e propria modifica paesaggistica quindi, at-tuata secondo dinamiche esclusivamente naturali. Ma dalla creazione del bacino tettonico di Radicondoli-Monteguidi ha tratto vantaggio anche l’uomo nella sua storia insediativa, po-tendosi stanziare in questi luoghi grazie sia alle fertili pianure di fondovalle, createsi all’interno dello stesso bacino, che ai percorsi viari agevolati dalle linee dei crinali collinari circostanti (cfr. BIANCHI – GENNAI – BAGGIANI – MANFREDI 2008, 74; MARRUCCI - NANNONI (2003, 7-8).
Per approfondire
Altre notizie. L’alto corso del Cecina è interessato da una coppia di fenomeni che troviamo spesso su gran parte dell’Appennino settentrionale, consistente nella disposizione delle valli minori con decorso trasversale rispetto agli allineamenti principali. I torrenti di queste valli minori hanno successivamente inciso ed eroso, via via, gli affioramenti di rocce portate in superficie dalla tetto-nica distensiva. Una coppia di fenomeni che i geologi chiamano «antecedenza» e «sovraimposizione». Un esempio di questi in-teressanti fenomeni, è fornito da Rimaggio, affluente del Cecina.Dalla Cappella dell’Avveduta infatti, ha inizio un solco vallivo che si protende verso il vicino paese di Gerfalco, in direzione NO-SE. Raggiunte le prime case del paese il corso d’acqua volge brusca-mente a NE formando così la profonda Gola di Gerfalco. Proprio all’affioramento nel greto del torrente di una roccia facilmente erodibile come il calcare massiccio si deve l’andamento rettilineo del corso d’acqua, che scorre entro ripide pareti di «scaglia», una roccia più resistente ai processi erosivi.
6 7
72 73
la_guida_radicondoli.indd 72-73 01/09/14 12:19
9. Geomorfologia Anqua
Visibilità
Mentre il pianoro su cui si trova la villa di Anqua è difficilmen-te visibile da lontano, se ci si affaccia da questo si domina un vasto paesaggio che si sviluppa da NO a NE comprendendo al suo interno l’alta valle del Cecina e quella medio-bassa del Pavone, oltre ai colli di Volterra, Berignone e Poggio Casalone.
Descrizione
La collina dove sorge la villa-fattoria di Anqua e il suo borgo è posta sul versante N del gruppo Cornate di Gerfalco-Pog-gio Ritrovoli, denominato Costa Salicastro. L’altura è il risulta-to di grandi paleofrane detritiche di Macigno (la roccia che lo compone) e per questo digrada in maniera omogenea verso il fondovalle del Cecina (a E) e del Pavone (a O). Nei milioni di anni successivi le modifiche erosive apportate dalla rete idro-grafica superficiale hanno in parte modificato la pendenza per opera, ad esempio, di corsi d’acqua come il Rimaggio, il Fo-reste e il Brutamèlo. Gli ultimi due, il cui corso si sviluppa fra il terrazzo dove è adagiata la villa-fattoria di Anqua e la valle del Cecina, permettono all’osservatore di dominare la com-plessa morfologia di questa zona posta a cavallo fra Cecina e Pavone. Il terrazzo su cui sorge Anqua permette, quindi, ottime viste paesaggistiche in direzione N, verso Radicondoli a destra e Pomarance a sinistra. Il sottostante bacino tettoni-co di Anqua-Radicondoli, sul cui bordo nord-orientale, diame-tralmente opposto a quello dove è posizionata la villa-fattoria, sono adagiati i centri abitati di Montingegnoli, Belforte e Ra-dicondoli, ha costituito nel corso dei milioni di anni e durante i quali si è avuto la sua formazione, il luogo di sedimentazione di complessi litoidi a matrice prevalentemente argillosa, sia a carattere marino, che lacustre e lagunare. Queste argille han-no rappresentato per l’insediamento umano poi un ottimo materiale da costruzione, come dimostra la stessa villa di An-qua, la cui costruzione alterna, con evidente scopo croma-tico e ostentativo, il rosso del mattone al bianco della pietra calcare di travertino (ttcfr. MARRUCCI 2000 A, 89-136; MAR-RUCCI 2000 B, 53-96; MARRUCCI - NANNONI (2003, 11-12).
8. Fosso Lucignano
Visibilità
La valle del Fosso Lucignano si vede lungo il tratto del per-corso che va dal PP4 al PP5, sulla sinistra nel senso di per-correnza.
Descrizione
Lungo sei chilometri, il Fosso Lucignano scorre interamente nel comune di Radicondoli. Nasce nei pressi di Montesca-locchi, a circa 550 metri di altitudine e dopo un tratto di cir-ca cinque chilometri, lungo il quale scende fino a quota 236 metri, si immette nel Cecina, nei pressi della profonda gola scavata da quest’ultimo fra il Poggio Scapernata ed il Poggio di Mollerata. L’ultima parte del corso di questo fosso presen-ta una caratteristica geomorfologica degna di interesse per il mutamento che ha generato nella rete idrografica della zona intorno a Radicondoli e quindi nell’aspetto paesaggistico del comprensorio. Nelle ere geologiche passate il corso del pa-leo-Lucignano terminava all’incirca all’altezza del podere le Costaglie, dove si tuffava nel Cecina. Il fiume maggiore, infatti, aggirava da E il Poggio di Scapernata (invece che da O come oggi) e transitava in quello che è l’alveo attuale del Lucignano e, successivamente, del fosso Quarantola, per riprendere poi il corso attuale nei Piani di Coiolo e Materno. A causa di una diversa velocità di sollevamento fra i bacini del Cecina, del Lu-cignano e del Fodera (un altro affluente della zona, posto in riva sinistra orografica del fiume principale), il Cecina venne ‘catturato’ all’altezza del Molino delle Cerbaie da un affluen-te del Fodera, andando così ad occupare il corso di questo piccolo fosso. Secondo i geomorfologi, i terrazzi fluviali posti sul versante orientale del Poggio Scapernata indicano chia-ramente questo fenomeno di cattura, la cui conferma viene anche dalla consistenza dei terrazzamenti presenti lungo il corso finale del Lucignano e del Quarantola, di dimensioni sproporzionate per l’attuale consistenza di questi due piccoli fossi (cfr. CUCINI 1990, 42).tt
Matrice A1
Argomento Geomorfologia
Età Preistorica
Latitudine 43.213621
Longitudine 10.986257
Distanza da… Radicondoli, 6,7 km in linea d’aria, in direzione SO
Matrice C1
Argomento Idrografia
Età Preistorica
Latitudine 43.140900 (confluenza con il Cecina)
Longitudine 11.004824
Distanza da… Radicondoli, 1,2 Km in linea d’aria, in direzione SO
8 9
74 75
la_guida_radicondoli.indd 74-75 01/09/14 12:19
e Montingegnoli. Il secondo effetto è stato quello di ospita-re – queste stesse aree detritiche - una falda idrica in gra-do di alimentare tante piccole sorgenti di portata ridotta e di sfruttamento locale. C’è però un rischio collegato a questo secondo effetto e cioè l’innescarsi su questi terreni di un’e-rosione incanalata che produce solchi profondi nel terreno che quando giungono alle argille sottostanti accelerano i mo-vimenti di scivolamento delle stesse. Un rischio a cui sembra più soggetta la parte alta del bacino del Lucignano, piuttosto che il versante N del colle di Radicondoli. L’intera zona su cui si sviluppa l’itinerario, e anche le colline circostanti a partire da quella su cui sorge il centro di Radicon-doli, è caratterizzata da un esteso affioramento di argille che condiziona fortemente la morfologia dei luoghi, come anche il reticolo idrografico. Il passaggio netto, per quanto concerne le forme paesistiche immediatamente percepibili dall’occhio umano, che avviene percorrendo la strada che si avvicina alle colline di Belforte-Radicondoli, sia provenendo da Montieri che da Casole d’Elsa, ci testimonia la sostituzione delle dure rocce alle plastiche argille. Le forme del paesaggio infatti si addolciscono, il bosco lascia il posto ad un paesaggio aperto, costituito da radi coltivi e da pascoli; le nude colline mostrano diffusi segni di scivolamento a causa della notevole plastici-tà delle argille. Gli stessi paesi denunciano problemi di statica in alcuni edifici storici. La collina su cui sorge Belforte mostra in maniera evidente nella sua morfologia e nei suoi profili la presenza predominante, almeno in superficie, delle argille. Le rete idrografica, anche minore come i fossi Fiumarello, Quarta e Rancia, ha avuto nei milioni di anni buon gioco ad erodere e modificare questo paesaggio, come si evince chiaramen-te dal loro percorso che si diparte dalla stessa collina e da quella parallela che li separa dal corso del Feccia. Proprio la presenza in superficie delle argille ha condizionato anche l’utilizzo dei materiali da costruzione nel corso delle vicende costruttive storiche di Belforte, Radicondoli e Montingegnoli, tre borghi delle Colline Metallifere dove, singolarmente, molti edifici sono costruiti in cotto contribuendo a dare un tono ge-nerale all’immagine stessa del paese (cfr. CUCINI 1990, 43; BIANCHI – GENNAI – BAGGIANI- MANFREDI 2008, 120-123; LAZZARETTO 1993, 19-88).
10. Geomorfologia Belforte
Visibilità
L’area intorno al colle su cui sorge Belforte, ed il colle stesso, è visibile dal percorso 2, soprattutto nel corso della seconda parte (PP 5).
Descrizione
Il percorso di Belforte ruota intorno al paese posto sulla cima spianata e panoramica di una collina allungata in direzione NO-SE, cioè la stessa direzione della catena appenninica e delle principali dorsali che attraversano longitudinalmente la Toscana, alle quali l’accomuna la medesima origine geo-tet-tonica. Ma non è solamente la collina di Belforte a denunciare lo stretto legame con la catena appenninica e, in definitiva, con la tettonica recente della stessa Toscana, in quanto an-che l’alveo del torrente Feccia mostra lo stesso orientamen-to NO-SE, come pure i crinali dei rilievi culminanti con Pog-gio Casalone, che limitano a N-NE lo sguardo dalla collina di Belforte. Questa caratteristica morfo-tettonica della zona permette al turista osservatore del paesaggio, che percor-re a piedi questi luoghi, di allungare lo sguardo soprattutto in direzione SE e NO, usufruendo infatti dei bacini idrografici come veri e propri ‘binocoli’ sulle lunghe distanze. Diverso invece il discorso se ci riferiamo agli altri due punti cardinali di osservazione (cioè a NE e a SO) dove lo sguardo si fer-ma ai vicini crinali di Poggio Casalone e del gruppo Poggio di Montieri-Cornate di Gerfalco-Poggio Ritrovoli che, con le loro altitudini, nascondono al turista il paesaggio che si apre alle loro spalle. La collina di conglomerati pliocenici su cui sorge il paese di Belforte è bordata da vaste aree di detriti gene-rate da frane di crollo susseguitisi nei milioni di anni succes-sivi all’emersione di questo territorio, a causa del processo di scalzamento operato alla base dagli agenti erosivi. Questo fenomeno ha avuto due diversi effetti: il primo è stato quello di creare intorno alla collina ampie aree detritiche costituite da sabbie, argille e ciottoli che sono risultate particolarmente adatte all’uso agricolo perché fertili. E questo dà ragione an-che dell’edificazione avvenuta sulla soprastante sommità, sia per il caso di Belforte che per quelli analoghi di Radicondoli
Matrice A1
Argomento Geomorfologia
Età Preistorica
Latitudine 43.23251
Longitudine 11.062006
Distanza da… Radicondoli, 3,5 km in linea d’aria, in direzione SE
10 10
76 77
la_guida_radicondoli.indd 76-77 01/09/14 12:19
12. Geomorfologia Colombaione
Visibilità
Il percorso sfrutta la strada poderale molto panoramica che funge di collegamento fra i poderi Casa Nuova, Montemag-giori, Colombaione e Gatteresi, dirigendosi verso il fondovalle del Cecina. I Punti Panoramici 6 e 7 sono quelli da dove me-glio si apprezza la morfologia di questo paesaggio interposto fra le colline ed il fondovalle del Cecina.
Descrizione
Il percorso del Colombaione si sviluppa lungo un crinale di media collina, delimitata a S dal fosso Quarantola e a N da un tributario del fosso Vetrialla. La morfologia, ed anche l’i-drografia della zona, sono impostate su di una linea di faglia ad andamento appenninico NO-SE. Il percorso ricalca una viabilità antica, come testimoniato dalla presenza di fabbricati rurali non recenti e dall’acciottolato emergente sul fondo del-la strada. Siamo in presenza di suoli costituiti da argille e da conglomerati miocenici particolarmente adatti all’uso agrico-lo, anche in virtù della circolazione idrica sotterranea. La loro presenza è testimoniata dai pezzi lapidei a matrice calcitica che costituiscono buona parte dell’antico fondo stradale. Questa circolazione ipogea dà luogo a piccole sorgenti dif-fuse che hanno facilitato lo stanziamento dell’uomo e lo svi-luppo delle attività agricole. Quello che gli storici dell’ambiente e dell’agricoltura chiamano l’addomesticamento dell’acqua, cioè il prelievo dal luogo di origine e il successivo trasporto dove la pratica agricola lo richiedeva, ha costituto per l’uomo, nell’agricoltura secca della vite, dell’olivo e del grano, lo sfor-zo più ingente messo in campo per il proprio sostentamento. Fertilità dei suoli e presenza di acqua sono stati nel corso del-la storia insediativa due potenti fattori di sedentarizzazione; ciò è dimostrato anche dai reperti trovati nei pressi dei poderi Gatteresi e Colombaione, riferibili sia all’epoca preistorica che alla civiltà etrusca. Anche nel corso della prima Età moderna questa zona dovette ospitare insediamenti abitativi, come la-sciano supporre i numerosi reperti fittili rinvenuti nei pressi dei poderi Colombaione e Gatteresi (cfr. CUCINI 1990, 153-155).
11. Geomorfologia Casettino
Visibilità
L’orientamento del fosso Vetrialla, insieme alla sua morfologia aspra e ‘chiusa’, rendono difficoltosa la visibilità della piccola valle da lontano e, al contempo, quando ci si trova a percor-rerla a piedi, limitano quella godibile verso l’esterno.
Descrizione
L’area su cui si sviluppa l’itinerario fa riferimento a una circo-scrizione paesaggistica caratterizzata dalla presenza di una linea di frattura – detta faglia – che pone a contatto due fami-glie di rocce diverse. L’andamento della faglia coincide anche con un paesaggio estremamente diverso a causa delle diver-se tipologie di rocce che formano il substrato, appartenenti a due diverse epoche geologiche; quella più recente detta Pliocene (2,5-5 milioni di anni fa) e quella più antica, il Miocene (23-5 milioni di anni fa). Un modo agevole e immediato (an-che se un po’ approssimativo) per individuare questa linea di confine è quello di seguire il contatto fra il manto boschivo del fianco sud-occidentale del Poggio Casalone ed i sottostanti coltivi. Dove si è sviluppato il bosco troviamo suoli costituiti dal cosiddetto complesso alloctono (rocce verdi dette ofioliti e calcari marnosi), poco propenso ad ospitare i coltivi e dove le pendenze sono più consistenti. Sotto questa linea si sviluppa invece la più recente serie lacustre con le argille ed i conglo-merati, suoli cioè più versati all’uso agricolo. Avvicinandosi in direzione di Radicondoli, e quindi risalendo dal Fosso Cernia-no verso l’abitato, alle argille e ai conglomerati si sommano le coperture detritiche originate dalle frane di scalzamento della soprastante collina di Radicondoli, similmente a quanto avvenuto per il vicino Belforte. E’ qui infatti che troviamo la serie di abitati sparsi (Casettino, Sala, Saletta, Valle) un tempo adibiti a centri di lavorazione agricolo del podere circostante. Tutto il versante sinistro del bacino del Vetrialla è interessato da risorgive d’acqua, sorgenti, laghetti con i resti delle relative captazioni per usi agricoli. La presenza dell’acqua origina dal contatto fra la copertura detritica soprastante e quella argillo-sa sottostante (cfr. CUCINI 1990, 39-41).tt
Matrice A1
Argomento Geomorfologia
Età Preistorica
Latitudine 43.27124
Longitudine 11.006448
Distanza da… Radicondoli, 1,3 km in linea d’aria, in direzione O
Matrice A1
Argomento Geologia
Età Preistorica
Latitudine 43.2757 (fondovalle del Fosso Vetrialla)
Longitudine 11.0312
Distanza da… Radicondoli, 1,6 km in linea d’aria, in direzione N
11 12
78 79
la_guida_radicondoli.indd 78-79 01/09/14 12:19
14. Geomorfologia Tesoro
Visibilità
L’itinerario 4 interessa la bassa valle del Fosso Vetrialla e dei suoi affluenti Sala e Cerniano, in direzione dei Piani di Coiolo e Materno. La valle è visibile con diversa prospettiva dal PP 9.
Descrizione
Il podere Tesoro sorge sul crinale di una collina allungata e profondamente segnata nei suoi fianchi orientale e occiden-tale dai due rami del fosso Vetrialla. La collina risulta orientata da NE a SO, cioè a dire trasversale alla linea di faglia e al re-ticolo idrografico conseguente che interessano questa zona immediatamente a N del paese di Radicondoli. Proprio la sua disposizione geografica – naturalmente ‘indirizzata’ verso il paese di Mensano, unita alla sua morfologia non aspra, han-no costituito nei secoli passati le caratteristiche necessarie ad ospitare la viabilità principale di collegamento fra i due centri di Radicondoli e Mensano. Prima cioè che venisse realizza-ta quella che ora è la provinciale delle Galleraie, che, sebbe-ne di impianto antico, è più recente dell’altra come mostra il suo andamento che segue le curve di livello, mentre invece quella che passa per il podere Tesoro affronta le salite e le discese imposte dal reticolo idrografico del luogo. Le map-pe del catasto leopoldino di inizio Ottocento ci restituiscono quest’area di passaggio fra Radicondoli e Mensano come contrassegnata dai soli poderi di Fonte, Sala, Tesoro e Filica-ia uniti dalla “strada comunitativa”. Anche alla presenza della viabilità (potente volano di sviluppo economico-sociale), oltre che a quella (abbondante) dell’acqua sotto forma di risorgive e sorgenti, sono da far risalire sia le forme dell’insediamento sparso come anche l’uso del suolo. Nel Medioevo la zona del Vetrialla e la collina del Tesoro si uniformò a quella degli imme-diati dintorni del castello di Radicondoli - che vedeva un uti-lizzo più intenso delle colture specializzate e la presenza degli alberi da frutto - piuttosto che alle zone più marginali come l’alta valle del Cecina e la zona di Anqua, contrassegnate da pascoli e boschi. (cfr. CUCINI 1990, 362-363; http://web.rete.toscana.it/castoreapp/0_init-frame.htm).
13. Geomorfologia Lucignano
Visibilità
La parte alta e mediana della valle si vede bene dal PP 5 e in genere anche dalla strada provinciale delle Galleraie, nel trat-to compreso fra il bivio per Falsini e quello per Belforte.
Descrizione
Nel territorio circostante l’abitato di Radicondoli sembrano aver avuto effetto sulle forme del popolamento antico e mo-derno i fenomeni legati alle erosioni e alle frane. Ancora oggi, infatti, l’intera zona si contraddistingue per il marcato dissesto idrogeologico e per i fenomeni franosi, evidenti nella valle del fosso Lucignano. Tali fenomeni hanno avuto due diversi effetti sul territorio in esame, di cui uno positivo, ovvero la fertilità e la presenza di acqua nei terreni posti alla base delle colline, sedi di insediamenti almeno a partire dal Medioevo. L’altro invece di segno negativo, per l’aggravamento dell’instabilità dei terreni argillosi, già mobili per loro natura, attraverso frane soprattutto di scivolamento. È questo il caso dell’alta e me-dia valle del fosso Lucignano. Chi percorre la provinciale delle Galleraie giungendo al bivio del Casone per Radicondoli può notare due paesaggi diversi. Il diverticolo che unisce il trivio del Casone al paese di Radicondoli funge da confine fra que-ste due diversità geomorfologiche, paesaggistiche e insedia-tive. Tanto è boscosa, contraddistinta da marcate pendenze e punteggiata da un abitato sparso, che arriva fino ai sotto-stanti Piani di Coiolo e Materno, quella del Vetrialla, quanto è deserta, priva di alberi e caratterizzata da linee dolci e pen-denze morbide e poco accentuate quella del Lucignano. Qui l’erosione delle acque piovane provoca profondi solchi sul seminativo erbaceo, arrivando a scoprire la lente delle argille marine sottostanti, e provocando di conseguenza la nasci-ta, lo sviluppo e il moltiplicarsi dei “calanchi”, con devastanti effetti sulla stabilità dell’intera zona. Testimonia la precarietà di questi versanti, posti fra l’abitato di Radicondoli e la strada provinciale, l’assenza di abitato storico (cfr. CUCINI 1990, 42-50).
Matrice A1
Argomento Geomorfologia
Età Preistorica
Latitudine 43.276052
Longitudine 11.033485
Distanza da… Radicondoli, 2,1 km in linea d’aria, in direzione N
Matrice A1
Argomento Geomorfologia
Età Preistorica
Latitudine 43.255723
Longitudine 1.055912
Distanza da… Radicondoli, 1,1 km in linea d’aria, in direzione S
13 14
80 81
la_guida_radicondoli.indd 80-81 01/09/14 12:19
16. Fosso Quarantola
Visibilità
La valle del Fosso Quarantola, impostata secondo la direttrice NO-SE, si può osservare dai PP 6 e 7.
Descrizione
La zona compresa fra il corso del Cecina, il fosso Quarantola e la parte finale del fosso Lucignano presenta una caratteristi-ca geomorfologica degna di interesse per il mutamento che questa ha generato non solo nella rete idrografica del terri-torio intorno a Radicondoli, ma anche nell’aspetto generale dell’intera valle posta fra questo paese, il castello di Belforte, il piano del Cecina ed i poggi di Rantìa. Nelle ere geologiche passate il corso del paleo-Lucignano terminava all’incirca all’altezza del podere le Costaglie; era qui infatti che avveniva la sua immissione nel Cecina. Il fiume maggiore infatti ag-girava da E il Poggio di Scapernata (invece che da O come oggi) e transitava in quello che è oggi una parte del bacino del Lucignano e successivamente del fosso Quarantola, per riprendere poi il corso attuale presso la località Fantacci, ov-vero nei Piani di Coiolo e Materno. A causa di una diversa ve-locità di sollevamento fra i bacini del Cecina, del Lucignano e del Fodera (un altro affluente della zona, posto in riva si-nistra orografica del fiume maggiore), il Cecina fu ‘catturato’ all’altezza del Molino delle Cerbaie da un affluente del Fodera, andando così ad occupare il corso di questo piccolo fosso. Secondo i geomorfologi i terrazzi fluviali posti sul versante orientale del Poggio Scapernata indicano chiaramente que-sto fenomeno di cattura la cui conferma è data anche dalla consistenza dei terrazzi fluviali presenti lungo il corso finale del Lucignano e del Quarantola. Terrazzi le cui dimensioni sono sproporzionate rispetto all’attuale consistenza di questi due piccoli fossi. All’inizio dell’Ottocento le piante catastali ci resti-tuiscono un’organizzazione dello spazio agrario che ancora oggi appare immutata e che vede la viabilità locale appog-giata sul piccolo crinale posto fra il Quarantola ed il Vetrialla e lungo questa la maglia delle abitazioni isolate di coloro che lavoravano i campi (CUCINI 1990, 42-50).
15. Gradino tettonico di Coiolo/Materno
Visibilità
Il gradino tettonico si colloca in prossimità del letto del fiume Cecina, nel punto in cui la valle si restringe dopo Piani di Coio-lo e Materno. La zona è visibile dai PP 1, 7 e 8.
Descrizione
Al termine di un primo tratto ad andamento da S a N, all’altez-za del bacino tettonico di Radicondoli-Monteguidi, il Cecina compie un’ampia curva in direzione NO, per poi superare la gola di Berignone e circoscrivere da meridione il colle di Vol-terra. Secondo recenti studi geologici e geomorfologici, l’area corrispondente alla parte alta del bacino del Cecina è stata in-teressata da tre diversi eventi deformativi a partire da circa 20 milioni di anni fa; eventi che sarebbero tutt’ora in atto. Mentre i primi due hanno provocato nell’intera zona delle Cornate di Gerfalco e in quella geotermica di Larderello e Castelnuo-vo Val di Cecina uno stiramento della crosta superficiale di almeno il 60%, l’ultimo (iniziato 5 milioni di anni fa e tutt’ora in atto) è caratterizzato dallo sprofondamento di interi terri-tori che hanno dato origine a bacini interni, di solito orientati come l’appenninico (NO/SE), e che oggi sono un elemento caratteristico della geomorfologia regionale. Anche il bacino di Anqua-Radicondoli-Monteguidi, così come i più noti e este-si Garfagnana, Valtiberina, Lunigiana e Valdichiana, ha avuto quest’origine. Tale bacino ha i suoi due ‘gradini’ posti uno in prossimità del castello di Elci e l’altro presso i Piani di Coiolo e Materno. Dal PP7 si coglie benissimo la presenza, guardando i Piani, di antichi terrazzi che testimoniano la presenza di un bacino lacustre in questa zona. L’orografia pianeggiante del bacino e la presenza di suoli profondi e ben riforniti di acqua, hanno rappresentato per la storia insediativa dell’uomo un ottimo fattore di sviluppo potendo offrire pianure fertili, anche se non particolarmente estese, e percorsi viari agevolati. Il bacino ha infatti costituito fin dall’età etrusca un asse di pe-netrazione verso i territori dell’alta Val di Cecina (cfr. AA.VV., 2000, 21-27; BIANCHI – GENNAI – BAGGIANI – MANFREDI 2008, 74).t
Matrice C1
Argomento Idrografia
Età Preistorica
Latitudine 43.256771
Longitudine 11.019795
Distanza da… Radicondoli, 2 km in linea d’aria, in direzione O-NO
Matrice B1
Argomento Geologia
Età Preistorica
Latitudine 43.27124
Longitudine 11.006448
Distanza da… Radicondoli, 5,5 km in linea d’aria, in direzione NO.
15 16
82 83
la_guida_radicondoli.indd 82-83 01/09/14 12:19
18. Gola del Cecina
Visibilità
La gola del Cecina, per chi guarda il fiume dalle colline di Ra-dicondoli, Belforte e Montingegnoli resta occultata dalla mole tondeggiante del Poggio Scapernata anche se la si ‘intuisce’, subito dietro a questo. Appare invece evidente sia dai Piani di Coiolo e Materno che dal crinale che separa il fosso Quaran-tola dal Vetrialla, così come dalla collina di Calvaiano.
Descrizione
Nei pressi del molino delle Cerbaie, il corso del fiume Cecina compie un secca curva prima a sinistra e poi a destra (nel senso orografico), per poi infilarsi nella profonda incisione da lui stesso scavata fra i Poggi Scapernata e Pomaia ed i Mas-si di Rantìa. È questo un punto particolarmente importante nell’assetto geomorfologico dell’intera zona, sia per quan-to concerne l’antico percorso del Cecina ma anche perché qui avviene il contatto fra due famiglie di rocce diverse. Dalla parte dei Poggi Scapernata e Pomaia dominano rocce di età più antica (da 135 a 40 milioni di anni), mentre in riva sinistra affiorano i conglomerati più recenti (da 5 a 2 milioni di anni), che costituiscono l’ossatura del Poggio di Mollerata, in que-sto punto immediatamente a S del corso del Cecina. Sempre in riva sinistra orografica, ma in territorio amministrativo di Ca-stelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), i Poggi di Rantìa fronteggiano il pilastro tettonico di Scapernata, rinserrando il corso del Cecina in fondo ad una profonda incisione. At-tualmente la zona presenta una rada boscaglia su ambedue i versanti, alternata a piccoli seminativi e a tratti di incolto. La zona è attualmente spopolata. Nei secoli passati però l’area era di ben altra importanza a giudicare dai ritrovamenti di età etrusca, romana, medievale e post-medievale qui effettuati. Questi punteggiano le sommità dei poggi e i terrazzi fluviali posti alcune decine di metri sopra l’attuale corso del Cecina, lasciando supporre insediamenti apprezzabili, resti di abitati e di attività produttive (fornaci per laterizi e mulini), ruderi di fortificazioni e luoghi di culto che un tempo rendevano viva questa zona, oggi silenziosa ed appartata (cfr. CUCINI 1990, 173-180).
17. Fossi Vetrialla e Sala
Visibilità
La confluenza tra il Vetrialla ed il Sala si intravede dai PP 1, 8 e 9, a destra della collina che ospita il paese di Monteguidi.
Descrizione
La profonda valle del Fosso Vetrialla caratterizza morfologi-camente l’intera zona. I rami collaterali meridionali di questo piccolo corso d’acqua infatti, essendo impostati su linee di faglia, vanno a solcare profondamente la morbida coltre de-tritica che costituisce la base litologica delle colline poste a cavallo fra il Vetrialla e il fosso Lucignano. È proprio su que-sto breve allineamento di alture che sorge anche il paese di Radicondoli. Nella parte alta la valle del fosso Vetrialla assu-me l’aspetto di un ventaglio, aperto in direzione NO, per poi restringersi fino quasi a chiudersi nel punto dove il Poggio di Calvaiano fronteggia il poggio più basso dove si sviluppa l’iti-nerario 4. Superata la strettoia, la valle si apre poi sui Piani di Materno e di Coiolo dove il fosso Vetrialla si getta nel Cecina. Nel primo Ottocento il corso d’acqua doveva avere una por-tata maggiore dell’attuale come testimoniano le mappe ca-tastali che mostrano il Vetrialla, nel punto di confluenza con il Cecina, composto da almeno due grossi bracci che diverge-vano allargandosi nella campagna circostante e costringen-do la viabilità a ripetuti guadi. Il fosso della Sala, situato a fianco dell’itinerario del Tesoro, è impostato su di una linea di faglia orientata NO/SE ed è caratterizzato, a metà del suo breve corso (fra i poderi Saletta e San Pierino) da una brusca va-riazione di pendenza dovuta alla diversa risposta fornita dalla litologia del suolo all’azione erosiva degli agenti atmosferici. La faglia ci avverte di come in zona sia presente il contatto tra due unità litologiche diverse. A S, ovvero il colle su cui sorge il paese di Radicondoli, abbiamo la serie pliocenica costituita da conglomerati, calcari detritici e argille, mentre a N affiora la serie evaporitica più antica (Miocene), costituita da rocce che includono gessi e lignite (cfr. CUCINI 1990, 37-40).
Matrice B1
Argomento Geologia
Età Preistorica
Latitudine 43.241333
Longitudine 10.993953
Distanza da… Radicondoli, 4,6 km in linea d’aria, in direzione O-SO
Matrice C1
Argomento Idrografia
Età Preistorica
Latitudine 43.277394
Longitudine 11.033295
Distanza da…Radicondoli, 2,7 km in linea d’aria, in direzione del punto di confluenza (N)
17 18
84 85
la_guida_radicondoli.indd 84-85 01/09/14 12:19
20. Linee di faglia
Visibilità
Il corso del fosso Vetrialla segna il tracciato della linea di fa-glia. Pertanto, iniziando questo corso d’acqua sotto il paese di Mensano e terminando nel Cecina presso la collina del po-dere Tesoro, il reperto è inserito fra quelli nascosti del PP 9 in quanto celato alla vista dalla collina stessa, ma pur sempre ‘presente’ nel quadro paesaggistico del luogo.
Descrizione
La linea di frattura (faglia), in questo caso ad andamento ap-penninico (NO-SE), che si pone in corrispondenza del Fosso Vetrialla permette il contatto fra due famiglie di rocce diverse per tessitura e per età e cioè i sedimenti del Pliocene e quelli del Miocene. I primi sono caratterizzati in gran parte da pietre rotondeggianti (in gergo ciottoli o conglomerato) unite fra loro da argilla e sabbia, mentre ai secondi fanno capo altri con-glomerati inframmezzati da sabbie, argille, gessi e talvolta da sottili banchi di lignite. I sedimenti che appartengono al Plio-cene (da 5 a 2 milioni di anni fa) si sono formati in un ambiente marino non profondo, vicino cioè alla linea di costa a cui si deve la presenza dei ciottoli portati dalle antiche fiumane che riversavano in mare tutto il materiale asportato durante il loro impetuoso scorrimento. I sedimenti invece del Miocene (da 22 a 5 milioni di anni fa) si sono formati in ambiente lacustre, di acqua stagnante, e questa dà ragione della presenza di strati di lignite, un combustibile fossile derivato dalla fossilizzazione di resti vegetali. Sempre al Miocene è riferibile la cosiddetta serie evaporitica, presente nei dintorni del poggio di Radicon-doli, ovvero una successione di rocce in cui sono presenti il gesso, la sabbia e l’argilla grigio-azzurra. Alla presenza delle argille plioceniche – di origine marina – è dovuta l’edificazione, intorno al colle di Radicondoli, nel corso dei secoli, di forna-ci che producevano laterizi da copertura e da pavimenti. La carta geologica del territorio di Radicondoli mette in evidenza come questo è suddiviso in tre grandi zone, che racchiudono altrettante ‘famiglie’ di rocce diverse, da linee di faglia tutte orientate NO-SE (cfr. CUCINI 1990, 37-41; PARDI 2001).
Matrice A1
Argomento Geomorfologia
Età Preistorica
Latitudine 43.2757
Longitudine 11.0312
Distanza da… Radicondoli, 2 km in linea d’aria, in direzione NE
19. Insediamenti a Coiolo e Materno
Visibilità
Gli insediamenti preistorici non sono visibili, mentre lo sono quelli dell’età moderna.
Descrizione
I Piani di Coiolo e Materno, al limite nord-occidentale del terri-torio comunale, costituiti da depositi alluvionali recenti del Ce-cina e del suo affluente Vetrialla, sono caratterizzati da pochi insediamenti poderali, dai resti di un mulino e da terreni colti-vati. La caratteristica dei terreni e le moderne arature hanno condizionato i risultati delle campagne di indagine archeolo-gica, che hanno dato pochi esiti. I rinvenimenti etruschi fanno ipotizzare che la località sia stata popolata già in epoca proto-storica in prossimità delle vie di comunicazione verso l’interno delle Metallifere. La cartografia di inizio ‘800 mostra un asset-to paesistico che non doveva essere molto diverso da quello dei due secoli precedenti, basando questa supposizione sui risultati cui la recente storiografia è giunta occupandosi dell’a-gro volterrano. Mentre sulle pendici collinari che circondano l’abitato di Coiolo, così come le altre poste dirimpetto, in riva orografica destra del Quarantola, il particellato agrario è ca-ratterizzato da unità di ampie dimensioni e dalle forme varia-bili, il fondovalle mostra invece i segni di una messa a coltura più recente. Le unità agricole sono di forma allungata, dispo-ste secondo un ordine definito da linee matrici artificiali (canali idraulici e di scolo delle acque meteroriche di un vecchio mu-lino) frutto di sistemazioni agrarie. Oggi, su questi stessi piani, la meccanizzazione agricola e le monocolture hanno cancel-lato quasi del tutto la precedente sistemazione paesistica, che è stata ricostruita dalle indagini di archeologia agraria e di architettura del paesaggio (cfr. TOSCO 2009, 219-234).
Per approfondire
Gite. Con una breve a passeggiata si possono visitare i resti di un antico mulino e le strutture connesse posti immediatamente a NO del podere Coiolo.
Matrice H1
Argomento Insediamento / Paese
Età Preistorica
Latitudine 43.154269 (Pod. Coiolo)
Longitudine 11.002188
Distanza da… Radicondoli, 3,3 km ( linea d’aria), direzione NO-O.
19 20
86 87
la_guida_radicondoli.indd 86-87 01/09/14 12:19
22. Monte Amiata
Visibilità
Il Monte Amiata si vede chiaramente con la sua caratteristica doppia punta sullo sfondo dai PP 10 e 11, lungo l’itinerario di Belforte (il n. 5). Lo si vede però solamente nel corso delle giornate terse, mentre può rimanere nascosto in giornate piovose o di foschia a causa della sua rilevante distanza dal punto di osservazione (circa 64 km in linea d’aria).
Descrizione
Situato nell’estremo S della Regione, con le dolci colline di ar-gille e sabbie plioceniche che lo cingono da N a E/SE, il Monte Amiata occupa una superficie di circa 60 Kmq e con i suoi 1.748 metri è la più alta vetta della Toscana interna e compe-te direttamente con le montagne dell’Appennino toscano. La rilevante altezza, unita al suo isolamento come montagna cir-condata da colline più basse, giustifica la sua estrema visibilità da ogni angolo della Regione, compresa la zona di Radicon-doli-Belforte. La sua natura geologica di vulcano spentosi nel corso del Quaternario (gli ultimi 2 milioni di anni), condiziona fortemente le forme attuali che si distinguono nettamente da quelle dell’Appennino e ne fanno un ‘monumento’ naturale dell’intera zona posta a cavallo fra Toscana, Lazio e Umbria. Il profilo del Monte Amiata, a chi si dispone ad osservare il paesaggio della nostra Regione dai più disparati punti pano-ramici che essa offre, risulta infatti inconfondibile una volta fatta la sua ‘conoscenza’. La linea ascendente pressoché perfetta delle sue pendici, disegnata col passare del tempo e col contributo determinante degli agenti atmosferici, termina nella doppia punta separata da una sella, elemento questo che rende inconfondibile il profilo del grande vulcano spento. L’Amiata è stato infatti, nel corso della sua breve storia geo-logica, un vulcano caratterizzato da eruzioni effusive di lava (trachite e riolite soprattutto) più che di lapilli, distinguendosi in questo dal vicino vulcano volsineo. La base del cono amia-tino è costituita infatti da colate di notevole spessore. Que-sta caratteristica ha fatto sì che il materiale incandescente fuoriuscito dai crateri sommitali scivolasse verso il basso in vere e proprie giare di lava, disegnando così il futuro profilo
21. Litologia detritica
Visibilità
La conformazione detritica è visibile dal PP 9 e anche per-correndo l’itinerario 4, quando si transita nei pressi dei poderi Sala e Saletta. I campi attorno ai questi poderi infatti mostrano in modo evidente, nelle loro forme e nei cambi di pendenza, l’accumulo delle coltri detritiche accumulatesi nel corso dei milioni di anni lungo il versante O del colle di Radicondoli.
Descrizione
La zona dove l’itinerario 4 conclude la discesa dall’abitato di Radicondoli, quando si giunge all’altezza dei poderi Saletta e Sala, costituisce il lembo più avanzato (in direzione NO) della serie pliocenica, prima che questa ceda il passo alla sotto-stante serie evaporitica del Miocene. L’evidente cambio di pendenza che si riscontra nel pendio proprio in corrispon-denza dei poderi Sala e Saletta, è generato dal fatto che le abitazioni sono collocate su di un terrazzo di conglomerati molto ben cementati. Questo terrazzo sembra sia il risultato di antiche e ripetute frane detritiche che, accumulando mate-riale alla radice del poggio di Radicondoli, hanno addolcito la pendenza precedente con la presenza di piani debolmente inclinati. La minore inclinazione ha conseguentemente per-messo un accumulo maggiore di sostanze fertili meno sot-toposte alla dilavante azione delle acque meteoriche, agevo-lando così la formazione di suoli potenzialmente adatti all’uso agricolo. Su questi suoli poi l’uomo – guidato dalla sua espe-rienza selettiva – si è insediato definitivamente sfruttandone la buona fertilità. La “Tavola delle Possessioni” di inizio ‘300, mostra la singolarità della distribuzione dei tipi di coltura nella “curia” di Radicondoli dove, ad alcune caratteristiche proprie di zone prossime a Siena (insediamento sparso e colture specializzate come vite, olivo e alberi da frutto), unisce aspetti tipici di aree marginali (estesi boschi e incolti, scarsa diffusio-ne di coltivi). Gli oliveti e gli alberi da frutto erano l’elemento di maggior spicco del paesaggio agrario intorno Radicondoli concentrandosi nei pressi di questo abitato, soprattutto nella zone dei poderi Sala, Montemaggiori e San Piero (cfr. CUCINI 1990, 37-41; 353-363).
Matrice B1
Argomento Geologia
Età Preistorica
Latitudine 42.887694
Longitudine 11.624197
Distanza da… Radicondoli, 80 km in linea d’aria, in direzione SE
Matrice A1
Argomento Geomorfologia
Età Preistorica
Latitudine 43.26677
Longitudine 11.0404
Distanza da… Radicondoli, 4,2 km in linea d’aria, in direzione NO.
21 22
88 89
la_guida_radicondoli.indd 88-89 01/09/14 12:19
23. Montecalvaiano
Visibilità
Il Poggio di Calvaiano o Montecalvaiano si vede oltre il fosso Vetrialla, posto tra i paesi di Monteguidi e di Mensano, più ar-retrati.
Descrizione
Il poggio di Calvaiano è situato nell’estremo limite settentrio-nale del territorio comunale di Radicondoli e dista circa due chilometri e mezzo in linea d’aria dal capoluogo, separato da questo dalla profonda vallecola del fosso Vetrialla. Morfolo-gicamente ben delimitato dai corsi d’acqua che lo circon-dano su tre lati (fosso Riputine da NO a SO, fosso Vetrialla mensanese da NE a SE e fosso Vetrialla radicondolese da S), il poggio risulta anche dal punto di vista storico-insedia-tivo come caratterizzato da un continuum abitativo che lo marca nettamente rispetto alle zone pure immediatamente circostanti. Le indagini degli studiosi coordinati da Costanza Cucini hanno portato in luce infatti una serie di evidenze ma-teriali, distribuite lungo tutto il boscoso versante meridionale che scende verso il fondovalle del Riputine, che testimoniano la persistenza abitativa dell’uomo su questo poggio dal Pale-olitico medio (Musteriano) fino all’inizio dell’età moderna. Un particolare importante è rintracciabile nella storia medievale della villa di Monte Calvoli - identificazione, verso cui pro-pendono gli studiosi, dell’attuale sito abbandonato di Mon-tecalvaiano – perché testimonia come spesso la morfologia di un territorio possa orientare i rapporti politici, e soprattutto economici, di una comunità. Dai documenti infatti emerge chiaramente come Montecalvaiano abbia gravitato molto più sul borgo fortificato di Mensano che su quello di Radicondoli, forse perché dal primo non erano separati da una profonda valle, seppur piccola, come dal secondo. Le mappe catastali di inizio Ottocento riportano la strada che “da Radicondoli va a Mensano”; questa transitava lungo il crinale allungato della collina di Montecalvaiano come ancora oggi si può rintraccia-re (cfr. CUCINI 1990, 143-149).
del monte che stava alzandosi sempre più sopra le sotto-stanti argille. L’ultima eruzione risale a circa 430 mila anni fà. Per farsene un’idea abbastanza precisa possiamo pensare a Stromboli, ad oggi il vulcano in attività che più somiglia, quan-to a silhouette, all’Amiata. La sua collocazione geografica, a soli 56 km in linea d’aria dalla costa grossetana, il suo assetto geomorfologico, la natura geologica delle sue rocce ed il ri-goglioso mantello boschivo che ricopre i suoi versanti in ma-niera pressoché completa a partire dai 700-800 metri, fanno dell’Amiata un importante nodo orografico nel panorama di quella parte dell’Italia centrale che si affaccia sul Mar Tirreno. Quattro sono infatti i fiumi che da questa montagna isolata si dipartono secondo altrettanti sistemi ambientali ed antropici fortemente caratterizzati: il Fiora e l’Albegna, dai corsi paralleli con direzione meridionale; il Paglia e l’Orcia, separati dalla sel-la di argille plioceniche posta fra l’Amiata e il vecchio camino vulcanico di Radicofani, che si muovono rispettivamente in direzione SO e N/NO. Il grande cono trachitico appoggia, a partire appunto dai 700 metri circa, sul ‘mare’ di argille plioce-niche e pleistoceniche che lo circonda da tutti i lati. La conse-guenza idrologica di questo assetto geomorfologico ha avu-to un’importanza fondamentale nella storia degli insediamenti amiatini in quanto ha dotato di punti di approvvigionamento idrico tutta la circonferenza della montagna alla medesima altitudine. Nella fascia compresa fra i 750 ed i 900 metri in-fatti sono collocati tutti i maggiori centri abitati della regione amiatina (Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Seggiano, Arcidosso, Santa Fiora ecc.) in quanto proprio a quell’altitudi-ne ha luogo il contatto fra il soprastante cono trachitico (per-meabile) e i sedimenti argillosi (impermeabili) che provoca la fuoriuscita delle acque meteoriche attraverso copiosissime sorgenti (Santa Fiora e Vivo d’Orcia in primis). Sorgenti che sono state elemento attrattivo fondamentale per la storia in-sediativa del luogo. Una caratteristica della roccia amiatina è nota con il nome di “anime di sasso“. Si tratta di inclusioni rocciose di altra natura ottenute nella trachite del vulcano. La distanza non eccessiva dall’abitato di Belforte unita alla gran-de massa della montagna, soprattutto se confrontata a ciò che la circonda, fanno sì che nelle giornate terse dai due punti panoramici posti nei pressi dell’abitato di Belforte sia possibile scorgere la caratteristica silhouette del Monte Amiata. Com-plice di questo avvistamento è anche il fatto che fra il punto di osservazione e la montagna esiste un vero e proprio ‘varco’ visivo che si insinua fra i colli di Chiusdino e Montalcino (di po-chissimi metri più alti di quello di Belforte) ed il Monte Quoio (Valdifarma) permettendo l’avvistamento del profilo (AA.VV. 1986, 52-55; AA.VV. 1993; GENNAI-LANDI-BAGGIANI 2004, 111-112;).
Matrice F1/F3
Argomento Insediamenti/Paesi
Età Preistorica/Medievale
Latitudine 43.286522
Longitudine 11.029572
Distanza da… Radicondoli, 2,5 km in linea d’aria, in direzione NO.
22 23
90 91
la_guida_radicondoli.indd 90-91 01/09/14 12:19
25. Paleocorso del Cecina
Visibilità
Il paleocorso del Cecina è visibile dai PP 5, 6 e 7. Si tratta di tutti quei punti da cui si può osservare il medio e basso cor-so del Fosso Lucignano e anche quello del Quarantola, cioè i due corsi d’acqua un tempo occupati dall’alveo del Cecina.
Descrizione
La zona compresa fra il corso del Cecina, il Fosso di Quaran-tola e la parte finale del Fosso Lucignano ha una caratteristica geomorfologica interessante per il mutamento che ha ge-nerato nella rete idrografica intorno a Radicondoli. Nelle ere geologiche passate il corso del paleo-Lucignano terminava all’altezza del podere le Costaglie, dove si tuffava nel Cecina. Il fiume maggiore infatti aggirava da E il Poggio Scapernata (invece che da O come oggi) e transitava in quello che è oggi una parte del bacino del Lucignano e successivamente del Fosso Quarantola, per riprendere poi il corso attuale ai Fan-tacci, ovvero nei Piani di Coiolo e Materno. A causa di una diversa velocità di sollevamento fra i bacini del Cecina, del Lucignano e del Fodera (un altro affluente della zona, posto in riva sinistra orografica del fiume principale), il Cecina fu ‘cat-turato’ all’altezza del Molino delle Cerbaie da un affluente del Fodera, andando così ad occupare il corso di questo piccolo fosso. Secondo i geomorfologi i terrazzi fluviali posti sul ver-sante orientale del Poggio Scapernata indicano chiaramente questo fenomeno di cattura la cui conferma è data anche dalla consistenza di quelli presenti lungo il corso finale del Lu-cignano e del Quarantola, di dimensioni sproporzionate per l’attuale consistenza di questi due piccoli fossi. Gli straordinari mezzi che oggi l’informatica mette a disposizione consento-no a tutti di individuare immediatamente questo fenomeno geomorfoidraulico, un tempo riservato solo agli occhi esperti degli addetti ai lavori (cfr. CUCINI 1990, 42-50).
24. Piani di Feccia e del Merse
Visibilità
I Piani del Feccia e del Merse si vedono dal PP 11 grazie alla buona visibilità della collina di Belforte in direzione SE.
Descrizione
Nel tratto finale, prima di immettersi nel Fiume Merse, il Feccia incide un piano alluvionale che prende i nomi di Piano di Pape-na e di Spagna dai due poderi situati sui bordi della pianura. Il piano, orientato NO-SE, è circondato dalle colline di Pentolina e Frosini dalla parte settentrionale e da quelle (più basse) di Frassini e San Galgano (poste a Meridione) in modo che esso riceve le acque di scolo di questi bassi rilievi sia sotto forma di fossi e borri, che di veri e propri torrentelli come il Saio, il Rigo, il Quarta. Storicamente i piani di Feccia e del Merse hanno visto fin dai secoli centrali del Medioevo (XI-XII) la presenza dell’uo-mo che ha attinto alle sue risorse territoriali attraverso impian-ti produttivi (fornaci, ferriere, molini) che sfruttavano l’energia idraulica fornita dai due corsi d’acqua. I monaci cistercensi di San Galgano furono infatti gli artefici di questi impianti che poi si diffusero un po’ in tutto il bacino Feccia-Merse e oltre. Non sappiamo se il declino irreversibile a cui andò incontro l’ab-bazia di San Galgano durante l’età moderna influì sull’assetto idraulico del piano che certamente era ben mantenuto nel periodo medievale, come testimoniano alcuni recenti studi. Agli inizi dell’Ottocento la viabilità maggiore si manteneva sui bordi del piano alluvionale (poderi Papena, Novo, la Ripa) ol-trepassando il Feccia ed il Merse senza l’ausilio di ponti, no-nostante che la zona venisse attraversata dall’importante strada ‘statale’ che da Colle di Val d’Elsa conduceva a Massa Marittima (cfr. CORTESE 1997, 100-114).
Per approfondire
Notizie. Agli inizi degli anni ‘80 del ‘900 si tentò di riportare in voga un improbabile progetto che prevedeva un doppio sbarramen-to del Merse e del Farma con conseguenti invasi sui due corsi d’acqua. La protesta delle associazioni ambientaliste e del mondo della cultura sventò, per fortuna, l’assurdo proposito.
Matrice A1
Argomento Geomorfologia
Età Preistorica
Latitudine 43.251586
Longitudine 11.028972
Distanza da… Radicondoli, 1,8 km in linea d’aria, in direzione E-SE
Matrice A1
Argomento Geomorfologia
Età Preistorica
Latitudine 43.095175
Longitudine 11.100175
Distanza da… Radicondoli, 13,5 km in linea d’aria, in direzione SE
24 25
92 93
la_guida_radicondoli.indd 92-93 01/09/14 12:19
terizzato da quei profili di acciaio torriformi. Attorno al ‘cuore’ montuoso delle Colline Metallifere, quasi a volerlo protegge-re, si dispone a raggiera una nutrita serie di poggi più bassi, contornati da altrettanti rilievi che vanno a costituire una serie infinita di bacini e sottobacini, solcati da fiumi, torrenti e fossi. Questo territorio, anche dal punto di vista climatico, si distin-gue nettamente da quelli limitrofi e proprio questa sua singo-larità nel campo del clima costituisce una delle motivazioni di origine naturalistica che determinano poi aspetti del paesag-gio immediatamente percepibili quando ci si muove a piedi fra il complesso delle Cornate di Gerfalco-Poggio di Montieri e il territorio radicondolese. Se andiamo a vedere infatti tutti quei parametri che costituiscono il banco di lavoro dei clima-tologi e meteorologi, quali ad esempio le temperature medie mensili e annuali, i valori delle precipitazioni annue e gli indici di umidità e di evotraspirazione, ci accorgiamo che l’area sopra ricordata forma un tutt’uno che emerge nelle carte tematiche come un’isola rispetto ai territori circostanti. Per trovare valo-ri simili dobbiamo scendere al complesso del Monte Amiata oppure salire sulla catena appenninica. La profonda naturalità quindi di questo cuore delle Colline Metallifere ha dunque nei parametri naturali il suo primo motivo di esistenza (cfr. AA.VV. 1993, 141-172; GENNAI-LANDI-BAGGIANI 2004, 27; 30).v
Per approfondire
Notizie. Dominio dei potenti vescovi di Volterra fin dal secolo XII, Montieri si afferma come importante centro minerario legato all’e-strazione della galena argentifera. Fin dal ‘200 il Comune di Siena inizia ad esercitare crescenti pressioni tese a conseguire il con-trollo politico ed economico del ricco centro minerario. Contem-poraneamente, intorno alle maggiori famiglie di Montieri prende forma l’organizzazione comunale. A causa dei contrasti interni alla famiglia dei Pannocchieschi, alla quale appartenevano i vescovi di Volterra, le miniere di argento e di rame vennero via via appaltate e ipotecate ai ricchi banchieri fiorentini e senesi. Alla metà del ‘300 le miniere di Montieri avevano perso gran parte della loro impor-tanza strategica. Presso la vetta del monte, leggermente spostati sul versante sud-orientale, si trovano numerosi avvallamenti ro-tondi che sono da interpretare come antiche escavazioni “a gior-no”. Pozzi veri e propri si trovano invece sul versante settentrio-nale, in località Piano di Nebbiano, dove l’estrazione del minerale avveniva con bisacce di pelle di bufalo portate a spalla o passate di mano in mano a mezzo di “colonne” di cavatori assicurati in nicchie scavate nelle pareti dei pozzi. Quando il terreno lo permet-teva si scavavano anche pozzi comunicanti fra loro internamente attraverso gallerie dette “buctini”. Infatti sul versante occidentale del Poggio è rintracciabile il microtoponimo “Bottini”. La pelle del bufalo usata per le bisacce proveniva dagli allevamenti di questo animale allora situati nella palude della Ghirlanda (Piano della Ghir-landa) a NE di Massa Marittima, e del Piano del Bufalaio, nei pressi del Fiume Merse, subito a S di Chiusdino.
26. Poggio di Montieri
Visibilità
Il Poggio di Montieri, con la sua mole ed il suo profilo facilmen-te riconoscibile, grazie alle antenne poste sulla sommità, è uno degli elementi naturali che caratterizzano maggiormen-te il paesaggio di Radicondoli. Lo si individua infatti dai PP 4, 5, 6, 7 e 10.
Descrizione
Il Poggio di Montieri, con i suoi 1.051 metri s.l.m. costituisce insieme alle Cornate di Gerfalco e al Poggio Ritrovoli il cuore delle Colline Metallifere. Se da un punto di vista strettamente geografico questo gruppo di rilievi si può considerare come costituito da montagne, superando tutti e tre i mille metri di quota, in realtà è forse più appropriato parlare di alte colline, a causa dei dolci profili e della scarsità di rotture improvvise di pendìo. Questa caratteristica geografica contrasta però con il panorama che si offre agli occhi dell’osservatore posto sulle colline di Belforte e Radicondoli. Da qui infatti, per merito dei ripidi versanti settentrionali guardando quei poggi sembra di trovarsi di fronte a ben più considerevoli altitudini. A questa impressione contribuisce principalmente la lunga bastionata delle Cornate che, per effetto della vicinanza, incombe ‘mi-nacciosamente’ sulla sottostante valle del Cecina e sull’abi-tato di Anqua, sovrastandoli entrambi in modo considerevole. La vetta però, soprattutto del Poggio di Montieri, con la sua forma gibbosa e curvilinea, addolcisce di molto l’impressione di asprezza suscitata a prima vista dai ripidi versanti setten-trionali. La vetta del Poggio di Montieri è ricoperta quasi per intero dal folto bosco di castagni e giovani faggi (come il ver-sante settentrionale del monte) e non permette quelle viste panoramiche straordinarie che solitamente i poggi isolati della Toscana meridionale offrono all’escursionista che li conqui-sta. Questo perché la piccola spianata sommitale, oltre agli alberi, presenta anche un nutrito gruppo di antenne e ripeti-tori che con le loro strutture impediscono il libero movimento. Di converso però, questi manufatti posti dall’uomo, estranei alla naturalità di quei luoghi, consentono di riconoscere im-mediatamente ‘a vista’ il Poggio di Montieri da lontano, carat-
Matrice A1
Argomento Geomorfologia
Età Preistorica
Latitudine 43.133374
Longitudine 11.000011
Distanza da… Radicondoli, 17,5 km in linea d’aria, in direzione SO
26 26
94 95
la_guida_radicondoli.indd 94-95 01/09/14 12:19
plesso di Cerniano, situato su di un rilievo emergente posto fra i toponimi Pagliaia e il Casone. Il complesso di Cerniano, organizzato intorno alla chiesa di San Martino, già trasferita nel secondo decennio del Trecento all’interno di Radicon-doli, costituiva uno dei due nuclei più consistenti di insedia-mento sparso della curia di Radicondoli come testimoniano i numerosi frammenti edilizi, uniti a lacerti di murature, che emergono di poco dal terreno nel sito sopra ricordato. I resti analizzati e repertoriati parlano di un luogo abitato, noto dalla documentazione storica fin dalla metà del 1100, costituito da una chiesa e dai nuclei insediativi “aperti” (cioè non protetti da opere di difesa) di Colle, Bolli, Cerbaia, Pagliaio e le Perti. L’in-tero complesso contava più di trenta abitazioni, un numero assolutamente di rilevo per l’epoca e per questa tipologia di insediamento territoriale. All’inizio dell’Ottocento il Poggio era attraversato dalla strada comunitativa che univa Radicondoli a Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi e Siena e proprio nei pressi del sito di Cerniano è documentato un podere denominato Podere dei Frati (cfr. CUCINI 1990, 67-68; 353-374).
Per approfondire
Notizie. La “Tavola delle Possessioni” redatta tra il 1317 ed il 1322, costituisce una straordinaria fonte storica per ricostruire l’orga-nizzazione territoriale, la struttura sociale e demografica, l’uso del suolo e la distribuzione della proprietà nel territorio senese e quindi anche in quello di Radicondoli. L’assetto fondiario risultava fortemente caratterizzato dagli stessi abitanti di Radicondoli che possedevano i tre quarti circa di tutti gli immobili presenti sul terri-torio di riferimento (circa 2.470 ettari, un po’ meno di quelli attuali). La parte del leone fra i possedimenti dei radicondolesi la faceva lo stesso Comune che dimostrava in questo modo la sua vitalità ed il ruolo guida da lui detenuto nell’espansione economico-territo-riale dell’intera curia. Il Comune infatti era direttamente impegnato nell’attività produttiva e di trasformazione e possedeva una gual-chiera e tre mulini posti sul Cecina, due forni nel castello e anche la fonte pubblica, oltre ad alcuni frantoi. Anche le chiese aveva-no una certa quota di possedimenti fondiari e fra queste quella di San Martino a Cerniano si distingueva per la localizzazione del suo nucleo fondiario – alta valle del Vetrialla – e anche per la sua consistenza. Si è detto della particolarità che il territorio di Radi-condoli mostra nella distribuzione dei tipi di coltura. Se gli oliveti e gli alberi da frutto (peri e fichi) erano gli elementi di spicco del pae-saggio agrario prossimo all’abitato principale, si notano però degli addensamenti di queste colture anche in zone più lontane come la valle del Vetrialla o la parte alta del Fosso Quarantola. La vite era molto più diffusa dell’olivo e si legava strettamente alla rete insediativa del territorio tanto che si può affermare che nessun nucleo abitato fosse sprovvisto di vigne. La morfologia del territo-rio radicondolese consigliava di concentrare la cerealicoltura nelle poche aree pianeggianti, mentre lo sfruttamento degli incolti e del bosco caratterizzava le zone periferiche e marginali. E’ per questo che molta terra lavorativa era concentrata nei piani lungo il Cecina ed il Vetrialla.
27. Poggio Casalone
Visibilità
Il Poggio, alla stregua del Poggio di Montieri, rappresenta un altro degli elementi naturalistici che segnano profondamente il territorio di Radicondoli, in questo caso da N. E’ infatti visibile dai PP 2, 4, 5 e 13.
Descrizione
Con i suoi 722 metri di altitudine il Poggio Casalone separa i bacini della Val d’Elsa (a E), dell’alta Val di Merse (a S) e della Val di Cecina (a O) facendo da nodo orografico oltre che pa-esaggistico. Questa sua funzione è confermata anche dalla viabilità storica radicondolese che, nel primo Ottocento, sa-liva le sue pendici occidentali per poi diramarsi, fra i poderi Niccioli e Pagliaia, presso la sommità, nelle principali direzioni: verso Siena (O), verso Colle-Poggibonsi (NO) e verso Caso-le d’Elsa-San Gimignano (NE). La copertura vegetale pres-soché continua che oggi interessa questo piccolo crinale secondario, e che a S si collega a quella della Montagnola Senese e del bacino Farma-Merse, unita alla sua altitudine, contribuiscono a dare l’impressione al turista che osserva da lontano questi luoghi di una imponenza forse sproporzionata all’effettiva realtà geografica e geomorfologica. Poggio Ca-salone è compreso all’interno di un complesso demaniale forestale non esteso ma importante perché, insieme ai due complessi sopra ricordati, forma il principale mantello boschi-vo dell’intera Provincia di Siena. E’ quindi l’habitat ideale per varie specie di animali, migratori o stanziali, che trovano pro-prio nella sua estensione uno dei principali vantaggi ecologici che il territorio può offrire loro. La preminenza visiva sul pae-saggio del Poggio Casalone risulta accentuata anche da un altro fattore, quale la considerevole differenza di quota (oltre 500 metri) che separa la sua vetta dai vicini fondovalle del Ce-cina ad O e dell’Elsa a E. A questa importanza paesaggistica del Poggio Casalone, corrispondono caratteristiche storiche e insediative interessanti. Infatti, nei pressi dell’attuale toponi-mo “Le Bolli”, gli studi e i rilievi condotti hanno messo in luce la presenza di una zona densamente abitata nel primo Trecen-to (ma non fortificata) che faceva riferimento al vicino com-
Matrice D1
Argomento Natura
Età Preistorica
Latitudine 43. 2666667
Longitudine 11.0833333
Distanza da… Radicondoli, 4 km in linea d’aria, in direzione E
27 27
96 97
la_guida_radicondoli.indd 96-97 01/09/14 12:19
Visibilità
Il podere si vede chiaramente posto com’è in posizione rial-zata rispetto alla strada bianca che lo serve. Ad oggi la co-struzione è allo stato di rudere.
Descrizione
Attualmente il podere Gatteresi è in stato di abbandono, co-perto di rovi e con le mura scollegate, ormai prossimo al crollo totale. Lambito dalla strada bianca, trova nella sua posizione rialzata - posta lungo il crinale collinare che separa il Fosso Quarantola a S, i Piani di Coiolo e Materno a NO ed il Fosso Vetrialla a N – uno dei motivi principali che ne hanno fatto nei tempi passati un luogo non comune. Nei campi sottostanti il moderno podere sono stati ritrovati infatti dei materiali edilizi concentrati in una piccola area di circa 400 metri quadrati. Si tratta di frammenti di laterizi da copertura (tegole) che pre-sentano i classici bordi rialzati e gli incastri laterali per il loro posizionamento in situ. La presenza di materiali da copertura autorizza a pensare che si trattasse di un insediamento abita-tivo e non sepolcrale, forse legato all’altro insediamento i cui resti sono stati trovati proprio nel luogo dove oggi sorge il mo-derno podere Gatteresi. Questi ultimi sono costituiti, oltre che da frammenti di tegole da copertura, anche da ceramica da mensa. Il quadro d’insieme autorizza gli archeologi a ipotizza-re un piccolo abitato, forse del VI secolo d.C., in quanto l’in-tera zona risulta, in questo periodo, caratterizzata da piccoli insediamenti a carattere agricolo (cfr. CUCINI 1990, 153-154).
Matrice H2
Argomento Resti / Ruderi
Età Etrusco / Romana
Latitudine 43.261708
Longitudine 11.025892
Distanza da… Radicondoli,1,7 km in linea d’aria, in direzione O-NO
Visibilità
La valle del Cecina è il solco più profondo e più ampio che interessa l’intero territorio di Radicondoli e lo percorre quasi per intero da S a N. E’ quindi facilmente identificabile dal cri-nale collinare percorso dalla provinciale delle Gallerie, costi-tuendo questo lo spartiacque con il contermine bacino del Feccia-Merse. La valle del Cecina è visibile dai PP 1, 7 e 8.
Descrizione
Con i suoi 79 chilometri il fiume Cecina è per lunghezza il terzo corso d’acqua della Toscana dopo l’Arno e l’Ombrone gros-setano. Al termine di un primo tratto ad andamento da S a N, all’altezza del bacino tettonico di Radicondoli-Montegui-di, il Cecina compie un’ampia curva in direzione NO, per poi superare la gola di Berignone e circoscrivere da Meridione il colle di Volterra. Giunto a Saline si orienta poi decisamente a O percorrendo l’ultimo tratto verso Ponteginori e Casino di Terra, fino a sfociare nel mare Tirreno. L’alto corso del Cecina presenta un fenomeno geomorfologico caratteristico di nu-merosi fiumi toscani, che si relaziona strettamente all’epoca geologica detta Miocene (da 22 a 5 milioni di anni fa), quan-do potentissime forze distensive stirarono la crosta terrestre delle Colline Metallifere di almeno il 60%. L’area del Cecina compresa fra Anqua e il Berignone, interessata da questa tettonica distensiva, venne così sprofondando creando un bacino interno, una tipologia morfostrutturale tipica della no-stra Regione (altri esempi sono il Mugello, la Lunigiana, la Val-tiberina, il Valdarno di sopra, la Valdichiana). Tale bacino ha un suo vero e proprio ‘gradino’ (tettonico) in prossimità dei Piani di Coiolo e Materno ed ha rappresentato per la storia insedia-tiva dell’uomo un ottimo fattore di sviluppo. Ha infatti potuto offrire pianure fertili, anche se non particolarmente estese, e percorsi viari agevolati verso il cuore delle Colline Metallifere, ovvero il gruppo montuoso delle Cornate di Gerfalco e del Poggio di Montieri (cfr. BIANCHI-GENNAI-BAGGIANI-MAN-FREDI 2008, 74).
28. Valle del Cecina
Matrice C1
Argomento Idrografia
Età Preistorica
Latitudine 43.251586
Longitudine 11.028972
Distanza da… Radicondoli,4 km in linea d’aria, in direzione NO
29. Abitato etrusco di Gatteresi
28 29
98 99
la_guida_radicondoli.indd 98-99 01/09/14 12:19
periale Radicondoli sembra essere decollato come centro di produzione di laterizi che sorsero nella maggior parte dei casi senza sfruttare siti preesistenti. La distribuzione areale dei nuovi siti testimonia uno spostamento a E del popolamento, ovvero dalle valle del Cecina verso la valle del Feccia, lungo la linea di colline che fungono da spartiacque. Ciò in ragione della decadenza del territorio volterrano e del conseguente abbandono delle direttrici viarie fluviali, nonché dello sviluppo della colonia romana di Saena Iulia (Siena), che spostò verso Oriente i traffici commerciali gravitanti intorno a Radicondoli. In definitiva il territorio di Radicondoli, in considerazione del suo scarso popolamento e del mediocre rendimento agricolo dei suoli - che non permetteva un concentramento demico ele-vato - si organizzò in due diversi modi di conduzione del suo-lo. Per la parte più occidentale, quella gravitante sulla Val di Cecina, gli studiosi sono propensi a vedere un perdurare del-la conduzione latifondistica dei terreni dall’età repubblicana. Questa conduzione privilegiava grandi spazi incolti e boschi-vi ad uso pascolativo con una maglia rada di edifici abitativi. Più a E invece, nel bacino del Feccia e intorno a Radicondoli, si ebbe la nascita di vere e proprie fattorie, e non soltato di mediocre consistenza, collegate probabilmente ad un ceto di piccoli possidenti. Fattorie che però convivevano con “tuguri e capanne di pastori” (cfr. CUCINI 1990, 71-74; 243-251).
Per approfondire
Gite. Per comprendere meglio quello che dovette essere uno spostamento funzionale anche alla morfologia e alla conforma-zione paesistica generale della zona, verificatosi nel corso della romanizzazione del territorio radicondolese, risultano illuminanti una serie di brevi passeggiate in alcuni punti panoramici della Val di Feccia. Recandosi a Montalcinello, Castelletto e Frassini (ver-sante meridionale della valle) e presso il podere San Martino sul Poggio Carnevale (versante settentrionale), si intuisce subito la di-versa conformazione morfopaesistica di questa valle rispetto alla limitrofa Val di Cecina. La Val di Feccia è, per prima cosa, aperta ad E e riceve quindi una buona insolazione per tutto l’anno (diver-samente dai piccoli bacini imbriferi che da Radicondoli scendono verso il Cecina, tutti orientati a O e con forti pendenze). Inoltre è caratterizzata da pendenze blande e da un fondovalle pianeg-giante che risale il corso d’acqua spingendosi decisamente con i suoi fertili piani alluvionali (pur se di limitate estensioni) in direzione delle sorgenti. A questo si deve aggiungere un ulteriore aspetto, decisivo quando si parla di agricoltura, ovvero la disponibilità idri-ca. Il Feccia è caratterizzato, diversamente dai tributari del Ceci-na in area radicondolese, da sorgenti perenni come testimonia anche la presenza lungo il suo corso di opifici andanti ad acqua (ferriere, mulini, gualchiere) fin dall’età altomedievale.
30. Insediamento romano
Visibilità
Il reperto non è visibile direttamente all’osservazione. In ogni caso, l’area dell’insediamento - un piccolo terrazzo fluviale presso il Fosso Cerniano - fa parte dei reperti nascosti dei PP 1 e 8.
Descrizione
Sul terrazzamento ancora evidente vicino alla confluenza tra un piccolo fosso campestre ed il Fosso Cerniano, affiorano materiali fittili e laterizi (ceramiche e cotto) che testimoniano della presenza in loco di una fattoria romana. Leggermente spostati ad E, più vicini al podere Casettino, si trovano altri re-sti analoghi sparsi nei campi, costituiti da frammenti di tegole, coppi e ceramica comune di età romana, tutti appartenenti ad una antica fattoria. Gli archeologi lo considerano un sito di un certo interesse, per due motivi: il primo perché si trat-ta di una delle rare fattorie localizzate in questo versante del fiume Cecina; il secondo perché i materiali ceramici rinvenuti sono datati fra il II ed il IV secolo dopo Cristo. Nel territorio di Radicondoli la conquista romana – avvenuta nel corso del III secolo avanti Cristo - sembra non aver modificato sostanzial-mente la storia insediativa; nel senso che non si hanno testi-monianze di un incremento della presenza rurale, né di nuove aree messe a coltura o di una riorganizzazione particolare del popolamento. In sostanza, in epoca romana, il territorio con-tinuò ad essere, come nel periodo etrusco, poco popolato e poco sfruttato. Un territorio, dunque, rimasto periferico. An-che per questo territorio periferico però, le vicende sociali che interessarono il territorio della Volterra romana (guerra civile), costituiscono un punto di svolta importante per l’impatto che gli eventi ebbero sull’economia e sulla situazione politica di tutto il periodo successivo. Alle guerre civili infatti seguirono le pesanti rappresaglie di Silla (assedio di Volterra e del suo territorio) che determinarono la squalifica ad ager publicus di tutta la zona S di Volterra, destinata così a confische e espro-pri. E’ solo dall’età augustea che nel territorio di Radicondoli gli archeologi hanno cominciato a registrare qualche mutamen-to nella situazione territoriale. Soprattutto nella tarda età im-
Matrice F3
Argomento Insediamento / Paese
Età Etrusco / Romana
Latitudine 43.162004
Longitudine 11.32499
Distanza da… Radicondoli, 1,5 km in linea d’aria, in direzione NE
30 30
100 101
la_guida_radicondoli.indd 100-101 01/09/14 12:19
Visibilità
La zona circostante il moderno podere (ridotto allo stato di rudere) che ha restituito materiale archeologico, risulta fra i reperti nascosti dei PP 6, 7 e 8.
Descrizione
Oggi il Colombaione è un podere in rovina nelle forme che ha assunto nel corso dell’Ottocento, il secolo durante il quale la mezzadria arrivò al livello più maturo di sviluppo e di per-fezionamento tecnico-agricolo. Si potrebbe non notarlo tan-to appare insignificante nel paesaggio intorno, che sembra quasi disturbare. Si tratta invece di un sito importante. L’area compresa fra i poderi Colombaione e Gatteresi ed il Fosso Quarantola, cioè a dire tutto il versante sud-occidentale della lunga collina che funge da riva destra orografica al Fosso, è stata intensamente frequentata e sfruttata sia in epoca prei-storica che etrusca da piccoli abitati a carattere agricolo. I ter-razzi fluviali del paleocorso del Cecina, presenti nella valle del Quarantola, hanno dunque fornito una sistemazione abitativa sfruttata dall’uomo che si insediò in questi territori. Nei pres-si del podere Colombaione sono stati rinvenuti frammenti ceramici di varie epoche (preistoria, periodo etrusco e mo-derno) a testimonianza della persistenza abitativa pluriseco-lare del luogo. Nel secondo caso si tratta di una piccola area sepolcrale di età etrusca caratterizzata, sembra, da tombe a pozzetto come proverebbero i resti delle ceneri ritrovati in alcuni contenitori appositi (ziri). L’area dove affiorano i resti, di ridotte dimensioni, non ha restituito laterizi e neppure ce-ramiche ma solamente materiale fittile. Nel terzo caso, nei dintorni della casa colonica attuale, sono stati rinvenuti resti di ceramiche moderne costituiti da pentolame invetriato ed alcuni frammenti di maiolica arcaica senese. La confinante zona del podere Gatteresi invece ha restituito testimonianze del Paleolitico Medio e dell’età arcaica etrusca (cfr. CUCINI 1990, 154-155).
32. Tombe etrusche del Colombaione
Visibilità
L’attuale podere Bucignano si vede dal PP 12, in direzione NO e rappresenta l’evidenza moderna in elevato posta sul luogo dei preesistenti siti abitati; quello di età etrusca e quello me-dievale.
Descrizione
Sulla sommità di una collina (388m s.l.m.) che divide la val di Cecina dalla valle del Pavone, si trova quello che resta del castello di Bucignano, oggi trasformato in un moderno agri-turismo. Nel processo di primo incastellamento (IX-XI secc.), Bucignano fa la sua comparsa come castrum (residenza fortificata), insieme a svariati altri toponimi rintracciabili anche negli immediati dintorni. In questo complesso processo di or-ganizzazione del territorio si intrecciano famiglie comitali (Al-dobrandeschi e Pannocchieschi), enti ecclesiastici (monaste-ri e abbazie) e la cattedra volterrana (il Vescovo cioè), dando ognuno un contributo al generale processo di coagulazione demica che si verifica in quei secoli. I castelli che nascono in questo periodo nella Toscana centro-meridionale non sono di grande consistenza; sono inoltre quasi sempre ubicati sui crinali o su terrazzi a mezza costa ed hanno un sistema difen-sivo che consiste in un circuito murario e/o un fossato, che difende un’ulteriore zona fortificata (cassero) dove si trova la residenza signorile. La maggior parte dei castelli di questa prima fase nella zona di Radicondoli risultano abbandonati dopo la grande peste nera di metà ‘300, mentre Bucignano sembra costituire un’eccezione. Già all’inizio del ‘200 infatti, in piena espansione demografica, la sua popolazione viene trasferita (a forza?) nel vicino castello di Montecastelli Pisano, decretando così la fine del sito di Bucignano che non com-parirà più nei documenti trecenteschi. Come per molti altri siti della zona, le vicende di Bucignano nel corso dell’età moder-na sono del tutto oscure (cfr. M. GINATEMPO 1994, 19-73; ROTUNDO-FRANCALACCI 1999, 109-110).
31. Podere Bucignano
Matrice H2
Argomento Insediamenti / Paesi
Età Etrusco / Romana
Latitudine 43.260692
Longitudine 11.029283
Distanza da… Radicondoli, 1,5 km in linea d’aria, in direzione O
Matrice H2
Argomento Resti / Ruderi
Età Etrusco / Romana
Latitudine 43.244578
Longitudine 10.966065
Distanza da… Radicondoli, 6,6 km in linea d’aria, in direzione O
31 32
102 103
la_guida_radicondoli.indd 102-103 01/09/14 12:19
Visibilità
La Volterra etrusca non è visibile dal territorio di Radicondoli mentre lo è la città medievale dai PP 1, 2, 7 e 8.
Descrizione
Più ampia della cerchia medievale che ancora oggi si vede attorno alla città di Volterra è quella etrusca, magnificamente conservata e ammirabile in più punti. Ha circa 9 km di svi-luppo, contro i 3,2 di quella medievale. Tale differenza rende immediatamente evidente l’importanza e la forza di Velathri (questo era il nome della città etrusca, Volaterrae quello del-la città romana) nell’ambito della confederazione dello stato etrusco, composta da 12 città (dette lucumonie). Costruita in-torno al IV secolo a.C., la cinta doveva racchiudere anche ter-reni adibiti a pascolo e a coltivi in modo da assicurare la sus-sistenza ai suoi abitanti ed una preziosa autonomia in caso di assedi. La città invece vide la sua definizione nel corso del VII secolo a.C., quando gli Etruschi, concludendo il processo di aggregazione tra i vari insediamenti che punteggiavano il colle, dettero origine ad un vero e proprio polo demico. Il ter-ritorio di pertinenza di Velhatri aveva un’estensione straordi-naria andando dalle colline che dividono la Val di Pesa dalla Val d’Elsa fino al mar Tirreno (in senso EO), e dal corso del basso Val d’Arno al bacino del Cornia (in senso NS). Volterra infatti costituiva un autentico bastione di difesa dell’Etruria setten-trionale contro le offese dei Liguri e dei Galli provenienti da N. Le necropoli più antiche della grande lucumonia sono andate distrutte perché ingoiate dalle balze che vi incombevano. Re-stano invece, come vivida testimonianza dell’arte volterrana, molto influenzata da quella greca, quelle esposte al Museo “Mario Guarnacci” che si attestano a oltre 600, la maggior parte riferibili al III secolo a.C., in alabastro e panchina. Ben più scarsi i resti che ha invece restituito l’acropoli, posti sulla parte più alta della città, oggi grande parco pubblico. La Volater-rae romana, sui cui confini si plasmò la diocesi paleocristiana, ebbe un’estensione minore della lucumonia etrusca soprat-tutto nella parte orientale (cfr. FIUMI 1968, 50-60).
34. Volterra etrusca
Visibilità
Il reperto non è visibile se non nelle forme assunte dall’attua-le reticolo viario costituito da carrarecce e viottole campestri presso il podere Casettino. E’ inserito fra i reperti nascosti del PP 9.
Descrizione
L’itinerario del Podere Casettino utilizza parte di una viabilità secondaria che innerva da tutti i lati la collina su cui sorge il paese di Radicondoli. Alcuni studi indicano questa viabilità im-postata su un reticolo di età romana. Il suo andamento pre-valente è da E a O, in parallelo alle curve di livello. Serviva a unire più nuclei rurali che si trovavano lungo il corso d’acqua (opifici e molini) oppure su piccoli pianori, risultati da paleofra-ne, o ancora su antichi terrazzi fluviali generati dalle variazioni idrografiche susseguitesi nelle varie ere geologiche. In parti-colare, la strada vicinale in corrispondenza del bivio per il po-dere Casettino su cui corre parte dell’itinerario 1, era già attiva in età romana. Oggi questa viabilità è percorribile soltanto a piedi. Ne è un esempio il ripido tratto che da dietro la Pieve Vecchia della Madonna conduce all’intersezione con l’odier-na strada vicinale, per poi traversare la valle del Fosso Vetrialla e risalire verso il paese di Mensano, parallelamente all’odierna strada rotabile. Lo stesso vale per il percorso di collegamento tra Radicondoli e il paese di Monteguidi, più a O, parallelo al corso del fiume Cecina.
Per approfondire
Altre notizie. La viabilità extraurbana è stata recentemente rior-dinata (in parte) dal Comune di Radicondoli a fini di mantenimento e di miglioramento. Attraverso il censimento e un Regolamento, le strade vicinali sono state così confermate nel loro primigenio uso pubblico e garantite quanto a libertà di transito, in modo da conservare le percorrenze territoriali come storicamente definite. L’amministrazione comunale mantiene tali strade, identificandole con una specifica segnaletica verticale (Comune di Radicondoli, Regolamento per la gestione delle Strade Vicinali di uso pubblico, Del. CC n° 50 29.12.2008).
33. Viabilità romana
Matrice F2
Argomento Insediamenti / Paesi
Età Etrusco / Romana
Latitudine 43.401318
Longitudine 10.858068
Distanza da… Radicondoli, 27 km in linea d’aria, in direzione NO.
Matrice E2
Argomento Viabilità
Età Etrusco / Romana
Latitudine 43.264489
Longitudine 11.050504
Distanza da…Radicondoli, 1,2 km in linea d’aria alla confluenza di fondovalle con la strada vicinale, in direzione E
7733 34
104 105
la_guida_radicondoli.indd 104-105 01/09/14 12:19
presenta, infatti, un tentativo di alternanza cromatica realiz-zato attraverso l’utilizzo del travertino e della serpentina del vicino Monte Gabbro; nei corsi un po’ scomposti che costitu-iscono la muratura è possibile notare l’utilizzo di alcuni reperti di sicuro reimpiego come le mensole rozzamente stondate che campeggiano sotto gronda, oppure l’archetto monoliti-co posto sul retro dell’edificio. Sul corso principale - via Santa Croce - si affaccia un’altra costruzione, senza alcun dubbio la più importante dell’intero castello, unico esempio di edifi-cio con funzioni civili sopravvissuto nell’intera zona; è, infatti, possibile proporre l’identificazione di questo palazzotto con la casa del gastaldo del conte Guglielmo Aldobrandeschi, si-gnore del castello di Belforte agli inizi del Duecento. Si tratta di un edificio articolato su più piani, che presenta una muratura realizzata con tecnica molto accurata e con l’utilizzo di conci di calcare in basso e di laterizi in alto. Su questa muratura si apre uno stretto portale con arco a sesto acuto poggiante su mensole, che recano scolpite alcune figure di chiara deriva-zione medievale, da identificare forse come appartenenti allo stemma comitale degli Aldobrandeschi. In alto il palazzotto termina con un orologio. Nel corso del secolo XVIII era forse il palazzo adibito a sede del Vicario; all’epoca risultava “assai in disordine” e con “l’oriolo che non suona”. Numerosi altri edifici di età medievale sono distribuiti nel tessuto urbano d Belfor-te tanto da condizionarne decisamente la vista complessiva che risulta quella di un borgo fortificato, nonostante alcuni in-serti architettonici post-medievali presenti al suo interno (cfr. CUCINI 1990, 92-93; 428-432; CAMMAROSANO-PASSERI 1984, 149).
Per approfondire
Gite. La zona prospiciente il punto in cui la strada bianca che con-duce al castello di Falsini si stacca dalla provinciale delle Galleraie è di estremo interesse per la storia della comunità radicondolese, sia per quanto concerne la caratteristiche naturali che per le strut-ture produttive atte a sfruttare queste caratteristiche, laddove presenti. Ci riferiamo al complesso dei mulini che ancora negli anni Trenta dell’Ottocento la cartografia catastale riporta fedelmente con tutti i suoi apparati di servizio quali strade di collegamento, bottacci, canali di adduzione dell’acqua, canali di “rifiuto” ecc. La caratteristica naturale qui sfruttata dall’uomo è costituita da una serie di risorgive che hanno fornito l’acqua (perenne) necessaria a far muovere i ritrecini di questi molini da grano. Da questa zona ha origine il Fiume Feccia che, a dispetto della sua esiguità come corso d’acqua, ha una portata perenne almeno nel tratto iniziale del suo corso.
Visibilità
Il paese di Belforte si vede dai PP 5, 11 e 13. E’ presente invece come reperto nascosto nei PP 4 e 10.
Descrizione
L’impianto topografico di Belforte mostra molti elementi in comune con quello di Radicondoli, con il quale condivide sia la collocazione sommitale su una collina, che l’impostazione generale imperniata attorno ad un asse centrale con funzio-ne di matrice viaria del castello. In questo caso cambia però l’orientamento che è NO/SE. Il circuito murario, che nel Me-dioevo seguiva tutto il bordo della collina, è ancora oggi in buona parte rintracciabile; sul lato meridionale sono infatti visi-bili i resti di una torre rompitratta a sezione circolare e di alcuni contrafforti (a base quadrangolare) anch’essi con evidente funzione difensiva a supporto delle mura. Il materiale da co-struzione usato per il circuito difensivo è misto il che testimo-nia la presenza in loco sia di depositi di argilla (e di fornaci) per la produzione del laterizio, che di cave di pietra. Sull’asse viario principale che taglia in due il castello si affacciano gli edi-fici più prestigiosi come è consuetudine nell’urbanistica me-dievale italiana. Tra questi sono da ricordare la chiesa di Santa Maria Assunta, dalla metà del Trecento insignita del titolo di pieve e l’ospedale medievale, ricordato in alcuni documenti già all’inizio del Trecento. La prima mostra nel suo paramen-to l’alternanza della pietra (travertino) al mattone secondo un effetto cromatico comune nel contado senese (Strove, Montesiepi, Pieve a Conèo). L’utilizzo del travertino denun-cia una certa volontà di ostentazione da parte dei costruttori, poi ripresa nei secoli successivi per l’architettura dei palazzi di Radicondoli, non essendo questo materiale lapideo pre-sente nell’immediate vicinanze di Belforte (la zona di prelievo più vicina era infatti quella delle Galleraie). Secondo gli studi più recenti la chiesa di Santa Maria Assunta è da collocarsi, come datazione, intorno al secolo XIV. Per quanto riguarda l’ospedale invece è da notare la rudimentalità della tecnica costruttiva impiegata e anche il probabile riutilizzo di materiale di spoglio in alcuni casi di provenienza più antica. La muratura
Matrice F3
Argomento Insediamenti / Paesi
Età Medievale
Latitudine 43.232763
Longitudine 11.061552
Distanza da… Radicondoli, 3,7 km in linea d’aria, in direzione SE
35. Belforte medievale
7735 35
106 107
la_guida_radicondoli.indd 106-107 01/09/14 12:19
Visibilità
Come per il caso di Volterra etrusca, anche per l’architettu-ra di Casole d’Elsa il suo grado di apprezzabilità è insito nello skyline della parte sommitale della collina. Occorre quindi re-carsi dentro il borgo per apprezzarne i particolari architettoni-ci. Ecco, per tanto, che la visibilità di questo reperto è relegata nell’inserto dei “nascosti” relativo ai PP 1, 2, 8, 12 e 13.
Descrizione
La rocca di Casole, costruita in regolare filaretto di pietra che si alterna al mattone, presenta una porta ad arco acuto di im-pronta senese e due torrioni collocati negli angoli contrappo-sti di NO e SE. Uno di questi è caratterizzato da un regolare filaretto di pietra con uno zoccolo leggermente sporgente. Al centro del borgo è presente un’altra torre, anch’essa in pietra, con una porta questa volta ad arco ribassato e diverse aper-ture ricavate a livello del piano superiore. Le mura presentano alcuni elementi che, per una certa storiografia, denuncereb-bero la discendenza dall’opera di Francesco di Giorgio Martini, il celebre architetto militare al soldo della Repubblica senese. Questi elementi sono identificabili nei cordoni, nella base a scarpa e nei cornicioni. La pieve di Santa Maria Assunta, posta al centro del paese, si presenta attualmente con un tetto a capanna, transetto, coro e cappelle rettilinee, mentre in età romanica il suo aspetto doveva essere ben diverso, proba-bilmente una basilica absidata. La facciata, trasformata nelle attuali forme fra Due e Trecento, si presentava a salienti ed era il frutto di due distinte fasi costruttive. Alla prima fase ap-partengono l’ordine inferiore ed il campanile a torre, mentre alla seconda sarebbe riferibile l’ordine superiore realizzato completamente in mattoni. Il resto della facciata è il frutto della rilettura del monumento in chiave gotica (cfr. CAMMAROSA-NO-PASSERI 1986, 30; FRATI 1996, 70-72).
37. Casole d’Elsa: l’architettura
Matrice G3
Argomento Architettura
Età Medievale
Latitudine 43.340854
Longitudine 11.044078
Distanza da… Radicondoli, 8,7 km in linea d’aria, in direzione N
Visibilità
Il paese di Casole, adagiato su di una collina visibile anche da distanze rilevanti, grazie alla sua collocazione geografica, si vede dai PP 1, 2, 8, 12 e 13. La sagoma costituita dal profilo della collina e da quello del borgo con i suoi maggiori edifici civili e religiosi, è incuneata tra San Gimignano (più lontano) e Mensano (in primo piano).
Descrizione
La storia documentaria di Casole d’Elsa ce lo restituisce come un importante castello dei vescovi di Volterra fin dall’ini-zio dell’anno Mille. I Vescovi, ottenuto Casole da una conces-sione imperiale, vi risiedettero spesso, ulteriore testimonianza questa della sua importanza, forse perché situato sul confi-ne orientale con la diocesi di Siena. Alla metà del Duecento, la comunità di Casole si era già completamente strutturata come Comune, grazie anche alla collaborazione di Colle di Val d’Elsa. E’ proprio in questo periodo che il Comune di Siena inizia a mostrare i primi segni di interesse verso la neocomuni-tà approfittando anche del contemporaneo declino esercita-to fino ad allora dall’autorità dei Vescovi di Volterra, oppressa da una grave crisi finanziaria. Dopo la vittoria senese di Mon-taperti (settembre 1260) contro le truppe fiorentine, Casole d’Elsa passò decisamente sotto il dominio senese al quale restò soggetta fino all’inizio dell’età moderna nonostante al-cuni tentativi insurrezionali (1313, 1355, 1481), promossi anche dal soldo fiorentino. Proprio alla fine del Quattrocento sono da far risalire le fortificazioni erette a Casole dal celebre architetto militare senese Francesco di Giorgio Martini consistenti nelle mura, parapetti, merli e nel torrione. L’architetto militare era stato inviato a Casole dalla repubblica di Siena con l’incarico specifico di fortificare il sito (cfr. CAMMAROSANO-PASSERI 1984, 30).
36. Casole d’Elsa
Matrice F3
Argomento Insediamento / Paese
Età Medievale
Latitudine 43.340854
Longitudine 11.044078
Distanza da… Radicondoli, 8,7 km in linea d’aria, in direzione N
7736 37
108 109
la_guida_radicondoli.indd 108-109 01/09/14 12:19
Visibilità
Il reperto è individuabile dal Punto Panoramico 10, in direzione SO, ma solamente in giornate di buona visibilità. E’ posto alla base delle pendici boscose di Poggio Ritrovoli, sulla vetta di una collina isolata, anch’essa boscosa, e per questo di difficile localizzazione nella vista da lontano.
Descrizione
Se la prima notizia che abbiamo di Elci è datata al 988, dob-biamo aspettare un consistente lasso di tempo prima di leg-gere quella successiva essendo questa riferibile al 1156. In entrambi i casi si tratta di notizie che ci parlano del sito come di un possedimento in mano ora agli Aldobrandeschi (nel caso più antico), ora ai Pannocchieschi (nel caso più recen-te). Comunque sempre in un contesto in cui il castello appare conteso e ambìto da qualche potente famiglia comitale. Il ca-stello di Elci infatti è stato uno dei centri medievali più impor-tanti e popolosi dell’intero territorio di Radicondoli e la stessa famiglia Pannocchieschi, che nel XII secolo risiedeva anche alla cattedra volterrana, cioè un altro soggetto molto interes-sato ai possedimenti nelle Colline Metallifere, stabilì in questo castello la sede di un suo ramo (Pannochieschi d’Elci). Ma per il possesso di Elci, localizzato su di una collina dai ripidi ver-santi e circondata dai corsi d’acqua Cecina e Rimaggio, che proprio in quel punto uniscono le loro acque, si mossero fra fine XII e fine XIII ben altre famiglie comitali e nuovi attori come il Comune di Siena. Questo ci conferma la valenza strategica di questo sito. Sarà il Comune di Siena, nella sua politica di espansione, che entrerà più volte in contrasto con i signori di Elci i quali mantennero la loro signoria sul castello ben oltre la conquista dello stato senese da parte dei fiorentini (avvenuta alla metà del ‘500). Del tutto sconosciuta poi, come in mol-tissimi altri casi del territorio senese (si veda la scheda n. 38, Castello di Falsini), è la storia in epoca moderna del castello di Elci a cui forse non è estranea la trasformazione in grande fat-toria (cfr. CAMMAROSANO-PASSERI 1986, 148-149; CUCINI 1990, 203-204; FRANCALACCI-ROTUNDO 1999, 105-109).
39. Castello di Elci
Visibilità
Il reperto è visibile dai PP 4 e 5 e nei tratti iniziale e finale dell’i-tinerario 2.
Descrizione
Il complesso attuale, sede del Corpo Foretale dello Stato che gestisce un lembo della vicina foresta di Poggio Casa-lone, è caratterizzato da una massa imponente che si erge dalla collinetta su cui sorge alla fine di un bel viale alberato. Nelle forme odierne è il risultato di numerosi rimaneggiamenti che ne hanno alterato del tutto le forme medievali. A ricordo di queste resta infatti soltanto un grande torrione angolare in pietra che conserva alcune aperture in parte originarie ed in parte rifatte. La storia di Falsini è, ad oggi, del tutto sconosciu-ta. Sembra che già negli anni Ottanta del XII secolo fosse in stato di abbandono a causa del trasferimento della popola-zione che lo abitava all’interno del vicino castello di Belforte. La stessa struttura architettonica attuale non offre un valido appoggio ad un’indagine anche meramente estetica e di va-lutazione delle forme, utile a ricostruire le vicende anche solo costruttive del sito medievale. Più ampie sono invece le notizie deducibili dalle modifiche architettoniche avvenute nel corso dell’età moderna e contemporanea quando il castello subì una trasformazione radicale diventando un centro aziendale per la produzione agricola e silvo-pastorale. Un destino, que-sto, comune anche ad altri luoghi fortificati della zona (Palaz-zone) che meriterebbe di essere indagato, soprattutto in una dimensione comparativa utile a diradare le nebbie di un’età – quella moderna – che in questa parte del senese è pressoché tutta da studiare (cfr. CAMMAROSANO-PASSERI 1986, 30).
38. Castello di Falsini
Matrice H3
Argomento Architettura
Età Medievale
Latitudine 43.122815
Longitudine 10.003603
Distanza da… Radicondoli, 6,5 km in linea d’aria, in direzione SE
Matrice G3
Argomento Architettura
Età Medievale
Latitudine 43.245581
Longitudine 11.079533
Distanza da… Radicondoli, 3,6 km in linea d’aria, in direzione E-SE.
7738 39
110 111
la_guida_radicondoli.indd 110-111 01/09/14 12:19
Visibilità
Il complesso monastico è visibile lungo l’itinerario 2, dopo il Podere Giogliano. Non lo è invece daI vicinI PP 4 e 5 e per questo è inserito nei reperti nascosti.
Descrizione
Situato su di una bassa collina a S del paese di Radicondoli, il convento francescano dell’Osservanza ha avuto fin dalla sua origine tardo quattrocentesca una travagliata esistenza. La morte di San Bernardino, oltre a dare grande impulso e diffu-sione al movimento riformatore della regola francescana, se-gna anche l’inizio degli intenti edificatori del convento che non fu il primo della zona. In effetti, in località Montescalocchi, fin dai primi decenni del ‘400 era presente un convento, poi ab-bandonato perché ritenuto troppo distante da Radicondoli. La concessione di un terreno molto più vicino al paese, dette il via all’inizio della costruzione del convento francescano che poté usufruire anche di una fornace da calcina a piè d’opera di cui abbiamo notizie documentarie. Dalla metà del ‘600, e fino a tutto il ‘700, il complesso subì molte modifiche architettoni-che volte soprattutto ad ampliare gli spazi, adeguandoli alle nuove esigenze che via via si presentavano. Soppresso una prima volta nel 1808 con l’unificazione della Toscana all’Im-pero francese, il convento riuscì tuttavia a sopravvivere alla temperie napoleonica andando incontro ad una nuova chiu-sura nel 1867, in seguito all’alienazione dell’asse ecclesiastico ad opera del nuovo Stato unitario. La sua definitiva chiusura al culto è riferibile al 1928 quando fu venduto dal Fondo per il Culto alla Società Anonima Cooperativa San Bonavventura di Firenze. Le complesse vicende storiche sono ben docu-mentate dalle numerose fasi architettoniche che ancora oggi sono osservabili sia all’esterno che all’interno del complesso monastico. Attualmente è sede di una scuola di musica e non è visitabile (cfr. CUCINI 1990, 89-90; FRANCALACCI-ROTUN-DO 1999, 77-82).
41. Il Convento dell’Osservanza nel Medioevo
Visibilità
Dalla caratteristica forma allungata (la silhouette ricorda la tol-da di una nave), Chiusdino è visibile dai PP 10 e 11, in direzione SE.
Descrizione
Anche Chiusdino, come molti altri castelli presenti nel bacino Merse-Feccia, fu possedimento dell’episcopato di Volterra, che nel XII secolo controllava un territorio vastissimo, esteso sull’intero comprensorio delle Colline Metallifere. Per rende-re efficace il loro controllo sul territorio, i vescovi volterrani si appoggiavano alle famiglie aristocratiche locali dando loro in concessione beni immobili situati sia dentro le mura del ca-stello, sia nella sua corte esterna. Così successe anche per Chiusdino. Già nel corso dello stesso secolo però i vescovi volterrani dovettero fronteggiare forti concorrenti per il con-trollo del castello, come ad esempio l’abbazia di Serena (si-tuata molto vicino a Chiusdino), l’episcopato senese e anche il comune di Siena, che nel corso del ‘300 riuscì ad imporsi.Il castello (poi allargatosi a borgo murato) di Chiusdino si pone sulla panoramica collina orientata SO-NE, parte di un crinale che prende avvio dal piano di Feccia per poi collegarsi, salen-do di quota, al Poggio di Montieri. La sua posizione di sommi-tà permette al paese di godere di ampi panorami sulle sotto-stanti valli e, soprattutto, in direzione di NE, verso il crinale dei poggi della Selva, che anticipano la retrostante Montagnola Senese, verso Siena. La forma ellittica della collina ne ha con-dizionato l’assetto urbanistico; tanto che oggi, guardando da lontano, Chiusdino appare come la tolda di una nave, molto sviluppato in lunghezza. Il castello medievale, infatti, si è ve-nuto ampliando attorno a un primo nucleo posto sulla vetta del poggio, dove si conservano, oltre ad un fabbricato in fila-retto di pietra degradato, anche una porta e parte della cinta muraria (oggi inglobata nelle costruzioni esterne). Attorno a questa prima cinta ne sono state poi costruite altre due, che conferiscono a Chiusdino la caratteristica forma allungata (cfr. CAMMAROSANO-PASSERI 1984, 53-54).
40. Chiusdino
Matrice G3
Argomento Architettura
Età Medievale
Latitudine 43.152791 (chiostro)
Longitudine 11.023579
Distanza da… Radicondoli, 400 metri in linea d’aria, in direzione S
Matrice F3
Argomento Insediamenti/Paesi
Età Medievale
Latitudine 43.091520 (piazzetta panoramica)
Longitudine 11.051107
Distanza da… Radicondoli, 15,5 km in linea d’aria, in direzione SE
7740 41
112 113
la_guida_radicondoli.indd 112-113 01/09/14 12:19
Visibilità
Il Poggio di Scapernata si trova sulla riva destra orografica del fiume Cecina, mentre quello di Rantìa sulla riva sinistra, di fronte ad esso. Sono entrambi visibili dai PP 6 e 7.
Descrizione
Il Poggio Scapernata costituisce un vero e proprio pilastro tettonico, originato cioè dal fenomeno della tettonica disten-siva, ovvero il fortissimo stiramento in senso orizzontale che la crosta terrestre di questa zona ha subito circa 5 milioni di anni fa (fine del Miocene). Oggi Poggio Scapernata è tagliato dal corso del Cecina prima in senso EO, e poi SN, dopo che il fiume maggiore ha ricevuto le acque del suo affluente Fo-dera. Per i geologi ed i geomorfologi è indubbio che il Cecina un tempo aggirasse Poggio Scapernata da E attraversan-do l’area oggi occupata dai tratti finali dei fossi Lucignano e Quarantola. Il quadro del popolamento e dello sfruttamento delle risorse del territorio di Radicondoli si precisa a partire dalla piena età arcaica quando l’intera zona gravita nell’orbita della città di Volterra. Il modello insediativo predominante è rilevabile dalla omogeneità della collocazione dei siti abitativi; tutti sono posti infatti su terrazzi fluviali compresi fra i 250 e i 300 metri di altitudine, in luoghi ‘aperti’, di facile accesso e pri-vi di esigenze difensive. Diverge completamente da questo modello la struttura del popolamento presso l’oppidum del Poggio di Mollerata, sito militare e difensivo posto a guardia, sembra, della viabilità mineraria passante lungo il corso del Cecina. I poggi di Scapernata e di Rantìa hanno rilasciato te-stimonianze abitative importanti, che vanno dall’età romana a quella medievale, a indicare un continuum di insediamento, presenza umana e uso del suolo, in questa parte del fiume Cecina, dall’età arcaica fino all’età moderna (cfr. CUCINI 1990, 175-77).
43. Insediamenti sui Poggi Scapernata e Rantìa
Visibilità
La fattoria si osserva dai PP 12 e 13, in direzione N-NE.
Descrizione
La fattoria di Tegoni si trova nella zona dove il Fosso Ricavolo confluisce nel Fodera, a sua volta tributario del Cecina, proprio all’ingresso della ‘gola’ scavata dal fiume fra il Poggio Scaper-nata e i Massi di Rantìa. Si tratta di una zona ad alta densità abitativa sin dall’antichità, come testimoniato dai reperti ar-cheologici che sono stati rinvenuti presso la località i «Massi», vicino al Poggio di Santa Lucia (dov’è localizzato il Castello di Montalbano), e presso i poggi di Scapernata e di Mollerata. La Fattoria è situata a circa 300 metri s.l.m., sulla parte finale di un breve crinale di argille plioceniche – sopra il quale transita una strada rurale di accesso – che divide i due fossi seguendo la direzione SE. Il termine Tegoni individua questo sito dagli ini-zi del Trecento, nei libri delle «decime» della diocesi di Volterra, che la chiesa di «Tegone» pagava, in quanto suffraganea, alla pieve di San Giovanni di Sillano. È ipotizzabile che la chiesa facesse riferimento a un insediamento aperto circostante di poderi e case sparse. La chiesa attuale, come del resto la villa-fattoria, è stata riedificata nel Seicento, ma dai basamenti e dalle murature di fondazione si comprende che l’origine del castello è più antica. Nei campi argillosi prospicienti la fattoria, che sono in costante movimento franoso verso il fondovalle del torrente Fodera, la ricerca di superficie ha riscontato la presenza di strutture murarie di età moderna delle quali non è chiara la destinazione d’uso (forse canalette di scolo per le acque). Queste dimostrano l’organizzazione della zona per un uso continuativo che si è protratto nei secoli, fino all’età presente (cfr. CUCINI 1990, 177, 180; FRANCALACCI-RO-TUNDO 1991, 182).
42. La Fattoria di Tegoni
Matrice F2/F3
Argomento Insediamenti/paesi
Età Etrusco-Romana/Medievale
Latitudine 43.145502 (vetta Poggio Scapernata)
Longitudine 10.595440
Distanza da… Radicondoli, 3,5 km in linea d’aria, in direzione O-SO
Matrice L3/5
Argomento Agricoltura
Età Medievale/XVI-XIX secolo
Latitudine 43.134708
Longitudine 10.585072
Distanza da… Radicondoli, 6,1 km in linea d’aria, in direzione SO
7742 43
114 115
la_guida_radicondoli.indd 114-115 01/09/14 12:19
Visibilità
La pieve e i lacerti delle mura di cinta non sono visibili come singoli elementi architettonici, ma sono inseriti nello skyline del borgo sulla sommità della collina. Ecco perché questo reper-to è inserito come nascosto nei PP 1, 2, 8, 9, 12 e 13.
Descrizione
Il borgo di Mensano, collocato sulla vetta spianata di una ripi-da collina, ha forma semiellittica e denuncia immediatamen-te come la funzione difensiva costituisca il motivo principale della localizzazione dell’insediamento. La collina, infatti, subi-to alle spalle della bella chiesa, precipita per alcune decine di metri rendendo difficile la risalita dal fondo di questo stra-piombo. Per questo motivo la posizione della chiesa è molto suggestiva. All’interno dell’abitato numerosi sono gli edifici che denunciano la loro origine medievale (porte, finestre, e altre tipologie di aperture); fra questi un edificio spicca sugli altri, sia per la grandezza sia per la presenza di una coppia di portali con archi a sesto acuto. La stessa cerchia di mura si conserva per buon tratto sui lati settentrionale e occidentale, caratterizzata da torri cilindriche con base a scarpa cordona-ta. Sui restanti lati la vecchia cinta muraria è stata inglobata nelle costruzioni successive. Discorso a parte merita la bellis-sima pieve di San Giovanni Battista, sulla cui storia e architet-tura rimandiamo alla bibliografia specifica. Il primo documento attestante la sua esistenza è un’iscrizione che indica la pre-senza, nel corso della costruzione dell’edificio, del magister Bonamico, lo stesso che operò nel cantiere del Duomo di Pisa nel corso dell’ultima parte. Buonamico sembra essersi dedicato sicuramente alla scultura di alcuni capitelli, forse an-che alla direzione complessiva dei lavori. Il primo documento riferito alla chiesa è una bolla papale del 29 dicembre 1171, in cui viene confermata la proprietà della pieve ai vescovi di Vol-terra, proprietari anche del castello, almeno fino alla fine del secolo. La chiesa, che ha la facciata rivolta a E, presenta una
45. Architettura a Mensano: il borgo e la Pieve di San Giovanni
Matrice G4
Argomento Architettura
Età Medievale
Latitudine 43.300467
Longitudine 11.055225
Distanza da…Radicondoli, 4,5 km in linea d’aria, 9,5 km sulla strada asfaltata
Visibilità
Il borgo di Mensano è visibile dai PP 1, 2, 8, 9 e 13, mentre risulta fra quelli nascosti nel PP 12.
Descrizione
Già agli inizi del sec. XI Mensano era uno dei centri di potere della Diocesi di Volterra, e più precisamente della istituzione del Vescovado che estendeva la sua influenza su buona par-te della Toscana centro-meridionale. Nel corso del XIII sec. i vescovi di Volterra dovettero fronteggiare la politica espansi-va senese e quella di Colle Val d’Elsa. Successivamente fu la Repubblica Fiorentina a occupare il castello di Mensano alla metà del secolo XIII. Dopo la battaglia di Montaperti, Mensano ritornò sotto il dominio di Siena. Successivamente su Mensa-no dominarono le famiglie patrizie senesi degli Arzocchi, Sa-limbeni, Tolomei e Saracini. Ma nel ‘400 il castello si spopolò, subendo la crisi demografica generale. Mensano ha mantenuto fino ad oggi il suo aspetto medie-vale. L’attuale abitato ricalca, infatti, l’impianto fortificato me-dievale, con alla sommità della collina un cassero-castellare dominante del quale sono ancora visibili alcuni portali e archi-travi. La cerchia delle mura si conserva intatta su due lati, con le relative torri forate destinate ad accogliere le postazioni di tiro per gli archibugi. In cima alla collina si trova la chiesa, an-ch’essa di forme medievali, realizzata in nuda pietra, orientata inversamente rispetto al solito: ovvero con la facciata rivolta a E e l’abside a O. La pieve di San Giovanni Battista è famosa per il ciclo istoriato dei capitelli che ornano il colonnato della navata (cfr. CAMMAROSANO-PASSERI 1984, 319).
Per approfondire
Si consiglia una visita attenta a Mensano, paese che dista circa 10 km da Radicondoli Per recarvisi si esce sulla Strada Provinciale 35 in direzione O, e al bivio del Casone si svolta a sinistra sulla SP Galleraie peercorrendo circa 5,5 km. Al primo incrocio si svolta ancora a sinistra e, dopo circa 2 km, si gira a destra verso il paese (0,5 km).
44. Mensano
Matrice F3
Argomento Insediamenti / Paesi
Età Medievale
Latitudine 43.300467
Longitudine 11.055225
Distanza da… Radicondoli, 4,5 km in linea d’aria, in direzione N
7744 45
117116
la_guida_radicondoli.indd 116-117 01/09/14 12:19
Visibilità
Il reperto non è visibile nel paesaggio, ma se ne può intuire la ‘presenza’ osservando oltre la gola del fiume Cecina a SO, sulle pendici dei massiccio delle Cornate da cui nasce il fiume.
Descrizione
I castelli più importanti e antichi del territorio di Radicondo-li (Moltalbano e Elci) – e anche Bucignano, situato però nel territorio di Castelnuovo Val di Cecina, sono posti lungo la valle del fiume Cecina e sono da mettere in relazione all’im-portanza che soprattutto nei secoli XI-XII avevano le miniere di galena argentifera poste sul Poggio Mutti e sulle Cornate di Gerfalco. Miniere la cui proprietà era ascritta al Vescova-do di Volterra. Questa potente istituzione medievale utilizza-va, infatti, la vena argentifera per battere moneta propria, il cosiddetto «grosso» volterrano. Dal castello del Berignone – residenza fortificata dei vescovi – si dipartiva una strada, an-cora oggi in buona parte identificabile, che una volta valicate le colline poste fra le valli del Pavone e del Cecina, si infilava nei sottostanti Piani di Coiolo e Materno, per poi continuare la risalita della valle del Cecina fin sotto Gerfalco. La presenza di castelli come Elci, Bucignano e Montalbano, ma anche lo stesso Radicondoli, era di appoggio e di controllo al transito delle carovane che trasportavano il prezioso minerale argen-tifero a Volterra. Sul territorio si conservano visibili resti del-le escavazioni minerarie disseminati lungo le pendici NO del Poggio Mutti e nella profonda gola di uno dei fossi che inizia dalla Cappella dell’Avveduta e arriva a lambire a N il paese di Gerfalco (cfr. MARRUCCI-NANNONI 2003, 10-11).
Per approfondire
La Foresta del Berignone. A circa 8 km in linea d’aria da Volter-ra il complesso forestale di Berignone-Tatti è sede di una riserva naturale, utilizzato in passato come fonte di legname combustibile per le caldaie di evaporazione delle saline volterrane e dei forni fusori del minerale argentifero. Al suo interno si trova il Castello dei Vescovi (noto anche come “Torraccia”) (sec.X). L’area è sede di percorsi escursionistici.
46. Miniere di argento
Matrice M3
Argomento Metallurgia
Età Medievale
Latitudine 43.093409 (vetta Poggio Mutti)
Longitudine 10.560966
Distanza da… Radicondoli, 18,5 km in linea d’aria, in direzione SO
pianta a tre absidi, con copertura lignea e muratura a corsi orizzontali e paralleli di conci in calcare massiccio e conglo-merato. La facciata a salienti ha un profilo «quasi a capanna» dato che la parte centrale è di poco sopraelevata rispetto a quelle laterali. Presenta al suo centro un portale inquadrato da due semicolonne bicrome, mentre l’arco falcato è dotato di lunetta monolitica e poggia su di un architrave che sembra essere di epoca differente. Anche la parte alta della faccia-ta denuncia successivi rimaneggiamenti subiti nel corso dei secoli dall’edificio, e presenta un’apertura circolare e un paio di piccole finestre circondate da cornici. Sui fianchi si notano alcune aperture (monofore e portali) dotate di una bella pla-stica scultorea a motivi zoomorfi. L’interno della chiesa è divi-so in campate, l’ultima delle quali forma il presbiterio e mostra nei capitelli istoriati delle colonne gli elementi più interessanti dell’intero edificio. Al fianco meridionale della chiesa è stata addossata successivamente, nel ‘300, la cappella della locale Compagnia, che oggi appare purtroppo nello stato di rudere (cfr. CAMMAROSANO-PASSERI 1984, 31-32; FRATI 1996, 66-70; BIANCHI-GENNAI-BAGGIANI-MANFREDI 2008, 110-114).
Per approfondire
Il ciclo dei capitelli. Alcuni dei capitelli presenti nella pieve sono stati attribuiti a Bonamico, in forza delle somiglianze con un paio di sue plastiche presenti nel Camposanto monumentale di Pisa. Nella complessa iconografia dei capitelli (XII sec.) si è voluto ve-dere un significato escatologico altomedievale, coerentemente realizzato nel progetto complessivo e nell’opera degli artisti-scul-tori che vi hanno partecipato. Una possibile lettura è la seguente. Fiancata meridionale: I° capitello, Dio distende il padiglione dei cieli; II° capitello, Distesi i cieli, ai quattro angoli della terra compare l’uo-mo; III° capitello, Comparso l’uomo, avviene il peccato che porta alla morte; IV° capitello, Il peccato invade le due civiltà, Orientale e Occidentale; V° capitello, Davanti alle due civiltà si para il Capro espiatorio; VI° capitello, Il Capro espiatorio rende cadente l’Idola-tria; VII° e VIII° capitello, La cadente idolatria è foriera di duplici spe-ranze; IX° capitello, Le duplici speranze si realizzano nella pienezza dei tempi; X° capitello, La pienezza dei tempi origina la chiesa; XI° capitello, La Chiesa si schiude all’errante pellegrino; XII° capitello, Il pellegrino è irrorato dalla fede, speranza e carità; XIII° capitello, La carità lo rende sano; XIV° capitello, La consacrazione, al fine della vita, lo fa degno di un sol premio. Capitelli del cimitero: a Dio si giunge per la morte. Le decorazioni umane e animali. Da sinistra entrando: quattro teste umane, cervi pascolanti; II° capitello: mon-tone; III°: quattro teste umane (due rasate e due con la chioma), serpenti che si mordono la coda; IV°: pastorali fitomorfi e figura se-miumana dalla cui unica testa partono due busti che si incontrano ad angolo retto. Nella semicolonna sinistra dell’arco trionfale: due figure, una a mezzobusto e l’altra che si aggrappa ad un bastone. A destra: un arbusto tra due foglie a punte ricurve.
7745 46
118 119
la_guida_radicondoli.indd 118-119 01/09/14 12:19
Visibilità
Montecastelli Pisano, situato a quasi 500 metri di altitudine, gode di un’ottima visibilità dal territorio di Radicondoli, a causa della relativa vicinanza e, soprattutto, della posizione cacumi-nale. Il borgo è facilmente visibile dai PP. 1, 8, 9 e 12.
Descrizione
Montecastelli è collocato sulla cima di una ripida collina che si eleva dal torrente Pavone fronteggiandone un’altra, più alta e scoscesa, su cui svetta la Rocca di Sillano, vero e proprio «faro» delle Colline Metallifere. Il piccolo agglomerato è un ti-pico borgo murato medievale, stretto intorno al «mastio» e alla chiesa romanica. La storia medievale di Montecastelli non è molto conosciuta ed inoltre, per quel poco, scarsamente dettagliata. Secondo gli studi di Maria Ginatempo essa è ri-compresa in quella, più generale, del contado volterrano po-sto a SO della città, oggi circoscritto ai territori amministrativi di Monteverdi Marittimo, Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina. Si tratta di una storia di abbandoni e distruzioni. Nel 1380, dopo la peste e il declino demografico, furono evacuati moltissimi siti minori nel volterrano; agglomerati più o meno grandi che le fonti mostrano non essere più abitati all’inizio del XV secolo. La caduta demografica era stata preceduta, peraltro, da un lentissimo movimento di concentrazione in-sediativa, durato alcuni secoli, verso borghi fortificati difesi e meglio organizzati per le esigenze di sopravvivenza delle popolazioni. Questo movimento era legato all’abbandono delle pianure, [all’]incastellamento, [e alla] formazione di nuovi distretti signorili avvenuto durante l’Alto Medioevo. Il caso di Montecastelli si unisce con quello del vicino sito fortificato di Bucignano, i cui uomini furono trasferiti in massa, e di forza, nella nuova fondazione vescovile-signorile di Montecastelli. Si tratta di una storia – questa della demografia medievale – an-cora in buona parte da decifrare, i cui contorni cominciano ad uscire soltanto da poco tempo dal buio dei secoli (cfr. GINA-TEMPO 1994, 19-73).
48. Montecastelli Pisano
Visibilità
Il complesso cistercense di San Galgano, costituito dai ruderi della grandiosa abbazia e dalla soprastante ‘rotonda’ di Mon-tesiepi, è visibile unicamente dal PP 11, nelle giornate limpide. Dal PP 10 è invece celato dalla vegetazione presente, motivo per cui è stato inserito fra i reperti nascosti.
Descrizione
La grande abbazia di San Galgano, situata nel pian di Merse, in posizione isolata, ebbe la sua origine nella vicina cappella di Montesiepi, edificata sul luogo dove, secondo la leggenda, il nobile Galgano Guidotti di Chiusdino si ritirò a vita eremitica nel 1180. Nel solenne atto, Galgano infilò la spada nella roccia che lì rimase. La leggenda narra che Galgano visse in eremitaggio a Montesiepi circa un anno, morendovi nel dicembre del 1181, all’età di 33 anni. Fu il vescovo di Massa Marittima Ugo de’ Sa-ladini a promuovere la costruzione di una cappella di forma cir-colare in suo onore. Il cenobio dei monaci usufruì oltre che di privilegi e immunità papali e imperiali (tra i quali la concessione di battere moneta), di donazioni fondiarie da parte dei potenti vescovi di Volterra (Pannocchieschi) e da altri monasteri italiani (Fossanova). Ai primi del ‘200, dall’abbazia madre di Clairvaux (Francia) giunsero a Montesiepi nuovi monaci che si unirono agli appartenenenti a nobili famiglie toscane (conti d’Elci, Al-dobrandeschi, Guidi) i quali, secondo il costume dell’epoca, vestirono l’abito cistercense. Nella seconda metà del ‘200 i monaci di San Galgano erano circa 50. Alla fine del Settecento un incendio distrusse il tetto e l’intera Abbazia, che da allora in poi divenne un grandioso e mistico rudere (cfr. CANESTRELLI 1993, 1-64).
Per approfondire
Film. San Galgano è stato teatro di posa di numerosi film, tra i quali ricordiamo: Nostalghia di Andrej Tarkovskij (1983) e Il pazien-te inglese di Anthony Minghella (1996).
47. Il monastero cistercense di San Galgano
Matrice G3
Argomento Architettura
Età Medievale
Latitudine 43.085804 (abbazia)
Longitudine 11.091942
Distanza da… Radicondoli, 18,7 km in linea d’aria, in direzione S/SE
Matrice F3
Argomento Insediamenti/Paesi
Età Medievale
Latitudine 43.155488 (davanti alla chiesa)
Longitudine 10.572590
Distanza da… Radicondoli, 7 km in linea d’aria, in direzione O
7747 48
120 121
la_guida_radicondoli.indd 120-121 01/09/14 12:19
Visibilità
Il borgo di Monteguidi, rispetto gli altri centri d’altura, com-preso Radicondoli, è quello posizionato più in basso. La sua collina, infatti, supera, di non molto, i 400 metri s.l.m (421, per la precisione) a fronte di tutte le altre che ospitano centri som-mitali intorno ai 500 metri. Nonostante questo, Monteguidi ri-sulta uno dei siti più visibili in assoluto. Lo si vede dai Punti Panoramici numero 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 e 13. In pratica da tutti gli itinerari escluso Belforte.
Descrizione
Il castello di Monteguidi era un possedimento dei conti Al-dobrandeschi, poi ceduto in feudo a una famiglia magnatizia colligiana, i Tancredi. Dopo la battaglia di Montaperti del 1260 il centro seguì le sorti di Mensano, finendo soggetto a Siena e alle potenti famiglie dei Malavolti, Petroni e Saracini. Il castello aveva forma allungata N-S, con una dimensione di circa 130 metri per 40. Delle antiche mura restano poche tracce, men-tre si sono conservate le due porte alle estremità dell’asse maggiore. Quella settentrionale serba ancora oggi un arco in pietra a tutto sesto, mentre quella meridionale risulta meglio conservata e si compone di un arco esterno in pietra e di uno a volta, in mattoni, nella parte interna. Lungo la via centrale (via Cavour) sono schierate alcune case che mantengono ancora evidenti strutture medievali. La chiesa dei Santi An-drea e Lorenzo, situata presso la porta N, presenta particolari che rimandano alle primitive forme romaniche: l’antico arco in mattoni e conci di pietra circondato da un fregio in cotto, e il piccolo portale sul fianco sinistro, con l’architrave in pietra, sorretto da due mensole. Presso la porta S è posta la pic-cola chiesa della Visitazione. Nonostante questo però Mon-teguidi, fra tutti i centri fortificati del territorio di Radicondoli, è certamente quello che ha perso maggiormente l’aspetto medievale complessivo di borgo arroccato e difeso da mura (CAMMAROSANO-PASSERI 1984, 32).
50. Monteguidi
Visibilità
Come per il caso dell’architettura a Mensano (al quale si ri-manda), anche per Montecastelli vale lo stesso discorso. Questo reperto è stato quindi inserito come nascosto nei PP 1, 8, 9 e 12.
Descrizione
Il territorio di Montecastelli è conosciuto dall’antichità per le mi-neralizzazioni di rame e di argento esistenti nella gola formata dal torrente Pavone, proprio sotto il paese, che domina dall’alto. Quest’area mineraria è stata con ogni probabilità esplorata fin dall’epoca etrusca; sicuramente da quella medievale e anche durante il Rinascimento, quando le ricerche si concentrarono su un grosso filone di gabbro contenente mineralizzazioni cuprifere (rame) e argentifere. Le lunghe lotte cui il sito fortificato di Mon-tecastelli andò soggetto fin dall’alto medioevo, e per buona par-te del XII e XIII secolo, fra i vescovi volterrani e il nascente Comu-ne trovano spiegazione nella presenza di questa materia prima, utile per la monetazione argentifera. Parallelamente alle dispute per il predominio, non mancarono iniziative private di permute e acquisti che rendono la storia di questo borgo murato par-ticolarmente complessa e, a tutt’oggi, pochissimo conosciuta. La tipologia architettonica di Montecastelli è contrassegnata dalla rocca e dalla vicina chiesa. La rocca è analoga a quella di Montecatini Val di Cecina e domina non solo il paese ma l’inte-ra valle del Pavone, fronteggiando l’impressionante mole della Rocca di Sillano, posta sull’altro versante della valle, a controllo del sito. La chiesa, invece, in stile romanico-pisano e intitolata ai Santi Iacopo e Filippo ha una pianta basilicale e mostra, sia nella facciata sia sui muri perimetrali, regolari filaretti di pietra uniti da sottili giunti, caratteristici delle tecniche costruttive medievali. La facciata è rivolta, singolarmente, a E, come ad accogliere i fe-deli che giungono dall’interno del borgo, in contraddizione con la tradizione costruttiva romanica, che voleva l’abside orientata ad E la facciata ad O. (cfr. CACIAGLI 2001, 383-388; MARRUC-CI-NANNONI 2003, 41).
49. Montecastelli: l’architettura
Matrice F3
Argomento Insediamenti / Paesi
Età Medievale
Latitudine 43.299744
Longitudine 11.012893
Distanza da… Radicondoli, 5,3 km in linea d’aria, in direzione NO.
Matrice F3
Argomento Insediamenti/Paesi
Età Medievale
Latitudine 43.155488 (davanti alla chiesa)
Longitudine 10.572590
Distanza da… Radicondoli, 7 km in linea d’aria, in direzione O
77 7749 50
122 123
la_guida_radicondoli.indd 122-123 01/09/14 12:19
Visibilità
Il nucleo fortificato di Montingegnoli, vero e proprio gioiello ‘dimenticato’ del territorio di Radicondoli, si vede dai PP 5 e 10. Montingegnoli è posto alla sommità di un pianoro rialzato, contornato da alberi di alto fusto dai quali emerge il piccolo campaniletto della chiesa padronale presente al suo interno.
Descrizione
La storia del bel castello di Montingegnoli è pressoché scono-sciuta, sia per quanto attiene al periodo medievale che mo-derno. Numerosi reperti indicano che Montingegnoli sia nato come maniero, disposto a semicerchio sulla sommità della collina, attivo almeno fin dai secoli VIII-XI dell’Alto Medioevo. I rifacimenti della fine dell’Ottocento in stile rievocativo confer-mano, in un modo singolare, la volontà dei proprietari di allora di collegare Montingegnoli alla funzione di castrum svolta nel Medioevo, quando apparteneva, prima del ‘300, alla potente famiglia comitale dei Pannocchieschi d’Elci. La costruzione fortificata si sviluppa a semicerchio attorno a un cortile cen-trale che occupa buona parte della sommità spianata della collina, chiuso da una parte da una fila di basse case, forse adibite a servizio della fattoria. Una funzione questa che il ca-stello assunse una volta terminata quella difensiva-militare per la quale, probabilmente, era nato. Questo cambio di fun-zione (avvenuto nel Cinquecento?) ha determinato un rima-neggiamento generale di tutto il complesso, dal quale sono rimasti immuni solo pochi edifici o parti di essi, tra i quali la chiesa romanica, alcune aperture poi tamponate e una delle porte di accesso. Purtroppo, attualmente, il castello-fattoria di Montingegnoli, dopo essere passato di mano alcuni anni fa, versa nel più totale abbandono e le murature mostrano ormai fortissimi segni di degrado minacciando in più punti ad-dirittura la rovina definitiva. (CAMMAROSANO-PASSERI 1984, 150; FRANCALACCI-Rotundo, 1999, 35; 45; 102-103; 105; 11; 126-128; 132).
52. Montingegnoli
Matrice F3
Argomento Insediamenti/Paesi
Età Medievale
Latitudine 43.133840 (cortile castello)
Longitudine 11.023101
Distanza da… Radicondoli, 3,5 km in linea d’aria, in direzione S
Visibilità
Monticiano è collocato sui bordi meridionali dei piani di Feccia e Merse, appena rialzato dai piani alluvionali, con alle spalle le alte colline boscose della Val di Farma. Per questo motivo è possibile vederlo solo in giornate limpide dal PP 11. Dal PP 10, invece, lo nasconde la chioma di un albero in primo piano, e per queto motivo è stato inserito fra i reperti nascosti della Matrice del Paesaggio.
Descrizione
Monticiano – castello controllato dai vescovi volterrani e poi passato, dal primo ‘200, sotto il controllo di Siena – si trova sulle basse colline che fiancheggiano il fiume Merse lungo il versante orografico destro. In questo tratto di media val-le, il fiume circonda la zona collinare su cui sorge l’abitato, compiendo una larga curva che gli fa cambiare direzione. Il paese di Monticiano sovrasta la zona, un tempo paludosa e malsana, del torrente Feccia, ai margini della quale l’uomo ha costruito straordinari monumenti e dato vita a intense attività economiche: mulini, forge, impianti idraulici per la lavorazione di minerali, castagne e cereali. Appena superato Monticiano infatti, le colline accolgono vasti boschi di castagni dove per molti secoli (XI-XVIII) hanno operato insediamenti produttivi, serviti da strade di collegamento con i luoghi circonvicini, im-perniati sulle attività estrattiva e metallurgica e sulla raccolta dei prodotti del bosco. Una economia di servizio possibile per la disponibilità in loco di grandi quantità di combustibile (legno e carbone di legna) e di molte acque correnti (fiumi e torren-ti) a carattere semi-perenne (cfr. CAMMAROSANO-PASSERI 1984, 116; GENNAI 2013; CORTESE 1997).
Per approfondire
L’ambiente naturale. La biodiversità e le emergenze ambientali della zona hanno portato alla nascita nel comune di Monticiano di alcune riserve naturali (Alto e Basso Merse, Farma e Tocchi) che costituiscono un ambiente perfetto per attività di turismo attivo come il cicloturismo e l’escursionismo.
51. Monticiano
Matrice F3
Argomento Insediamenti/Paesi
Età Medievale
Latitudine 43.082283 (davanti alla chiesa)
Longitudine 11.104849
Distanza da… Radicondoli, 20 km in linea d’aria, in direzione S/SE
7751 52
124 125
la_guida_radicondoli.indd 124-125 01/09/14 12:19
to da enormi conci di conglomerati, sbozzati rozzamente e messi in opera con l’ausilio di zeppe in laterizio. Questi due fattori, uniti alla posizione impervia e all’orientamento, fan-no pensare che la pieve sia stata realizzata su preesistenze murarie che ne hanno condizionato lo sviluppo. Sotto il basa-mento absidale si notano le mura di fondazione della chiesa: il piano di campagna risulta, su questo lato, più basso di circa 1,5 metri rispetto al livello originario, forse come conseguenza dell’uso prolungato dell’area circostante in funzione di cimi-tero. Dall’analisi del paramento murario si può affermare che abside e transetto sono le parti più antiche dell’edificio. Il cor-po longitudinale della navata ha subito rimaneggiamenti nelle varie fasi costruttive. All’impianto più antico furono aggiunte nel corso del Trecento due campate, prolungamento reso evidente dalla netta linea di sutura tra i due corpi di fabbrica. Il basamento perimetrale presenta conci più piccoli rispetto alla zona absidale, con evidenti segni di uso della «gradina», strumento medievale utilizzato per sbozzare i blocchi di pie-tra. Sopra il basamento è posta una originale muratura in li-stelli di cotto in cui, a tratti, si inseriscono bande alternate di filaretti di pietra e altri di laterizio, secondo l’estetica semplice ma efficace tipica del romanico volterrano. Lo stesso croma-tismo esterno chiaro-scuro, pietra-cotto, è stato realizzato all’interno attraverso una pittura a fasce bianche e rosa che interessa le pareti e i semipilastri a fascio. Degni di nota i semi-capitelli che coronano gli archi del transetto; sono infatti ornati da figure zoomorfe e teste umane stilizzate, che mostrano la confluenza tra i canoni scultorii più raffinati della cultura pisa-no-lucchese e quelli più arcaici e incerti dello stile locale (cfr. CUCINI 1990, 274-276).
Per approfondire
Venerazione. Nella Pieve Vecchia, dal Medioevo, i Radicondolesi venerano un’antica immagine della Madonna che va sotto il titolo della Mercede; il quadro presente nella Pieve Vecchia è una copia, mentre l’originale si conserva nella Chiesa della Collegiata. Negli anni della predicazione di San Bernardino da Siena (XIV-XV secc.) la popolazione gli dedicò una cappella all’interno della chiesa. Fe-stival Estate a Radicondoli.
L’Associazione Culturale ‘Radicondoli Arte’ organizza ogni anno il festival estivo che si tiene nei giorni a cavallo dei mesi di luglio e agosto. Lunga è questa tradizione avvicinandosi ai trent’anni di storia. Gli spettacoli musicali e teatrali che lo animano sono di primo piano nel panorama italiano e internazionale, improntati a una dimensione artistica di alto livello. Il festival utilizza gli scenari naturali del paese, le sue piazze, i suoi monumenti ed il paesag-gio in genere, compresa la Pieve Vecchia, all’interno della quale si tengono pièce teatrali, musicali, jazz, performance e installazioni.
Visibilità
Il reperto è visibile dai PP 3 e 9 mentre risulta elencato fra quelli nascosti del PP 2.
Descrizione
Le vicende della pieve di Radicondoli, ricordata come Pieve Vecchia, sono collegate nel tempo a quelle del castello. La pieve più antica, citata a partire dal X sec., e di cui non restano tracce sul territorio, doveva trovarsi su un piccolo colle a SO del paese attuale, sito indicato attualmente sulla cartografia topografica come «La rocca». Secondo gli studi di Costan-za Cucini questa località sarebbe da identificare con Castel-vecchio, il sito fortificato altomedievale di Radicondoli, a cui fece seguito poi quello duecentesco. Nel corso del secolo X la pieve di Radicondoli fu una delle principali sedi pievane nella parte sud-orientale dell’estesa diocesi di Volterra, e for-se il suo importante ruolo era dovuto proprio a questa sua perifericità. Nel ‘300 la Pieve Vecchia del castello di Radicon-doli risulta abbandonata, mentre quella «nuova» (la chiesa attuale) fuori del nuovo castrum era invece in buono stato. Successivamente la sede plebana fu spostata all’interno delle mura castellane dove sorse l’odierna Collegiata, dedicata ai Santi Simone e Giuda, mentre la chiesa del cimitero, che da questo momento fu denominata «vecchia», rimase intitolata a San Giovanni Battista. A questo edificio si riferisce la presente scheda non essendo dell’altro, quello altomedievale, rimasta traccia alcuna. L’edificio è circondato su tre lati dal cimitero e, diversamente dalle altre pievi romaniche della diocesi vol-terrana, non presenta il tipico impianto basilicale a tre navate, ma uno schema a croce latina a unica navata, con transetto sporgente concluso da abside semicircolare. L’impianto così particolare, che sembra derivare dalla cultura monastica, non è la sola specificità di questa chiesa. Anche l’orientamento è anomalo: la zona presbiteriale è infatti spostata verso SE. Esternamente questa presenta un’alta muratura basamen-tale che, probabilmente, aveva la funzione di contrastare le spinte cui questa parte era sottoposta per la sua ubicazione di crinale, che la rendeva instabile. Tale basamento è forma-
53. La Pieve Vecchia di Radicondoli
Matrice G3
Argomento Architettura
Età Medievale
Latitudine 43.153823
Longitudine 11.025446
Distanza da… Radicondoli, 500 m in linea d’aria, in direzione E
7753 53
126 127
la_guida_radicondoli.indd 126-127 01/09/14 12:19
Visibilità
Via Tiberio Gazzei è la strada principale del paese, l’asse che taglia in due l’impianto urbanistico medievale. È visibile, natu-ralmente percorrendola; ma la sua ‘presenza’ si avverte an-che guardando il paese da lontano in quanto essa segue il crinale sommitale della collina sulla quale si distende. Il reperto è quindi indicato come nascosto nelle Matrici del Paesaggio dei Punti Panoramici 1, 2, 3, 9, 12 e 13.
Descrizione
Secondo Costanza Cucini la parte primitiva del castello di Ra-dicondoli è da identificarsi intorno alla Sedice, la via cioè che taglia ortogonalmente la collina in direzione S. Nella zona più alta, che oggi si apre su via Gazzei, si trovavano gli edifici e gli spazi pubblici più importanti, come la chiesa dei Santi Simone e Giuda e il Palazzo del Capitano. Le indagini archeologiche hanno individuato i resti di grosse fondazioni che sarebbero da ascrivere alla prima cinta muraria castellana, risalente al XIII secolo. A E e a O di Piazza Matteotti, su cui prospetta la chie-sa Collegiata, si trovano i cospicui resti di due case-torri due-centesche, con murature costituite da conci di pietra perfet-tamente squadrati, nelle quali si notano portali ad arco a sesto acuto molto simili, nelle forme e nelle dimensioni, a quelli os-servabili nella piazza e nella via centrale di Massa Marittima. Allontanandosi dalla Sedice gli edifici di impronta medievale si rarefanno man mano che si scende (cfr. CUCINI 1990, 393-401; FRANCALACCI-ROTUNDO 1999, 53-76).
Per approfondire
Gite. Una passeggiata nell’area della Sedice e nella zona del pa-ese posta fra Porta Olla e via Tiberio Gazzei dà conto al visitatore dell’assetto medievale di Radicondoli, ancora perfettamente ap-prezzabile. Senza timore di perdersi, tenendo a riferimento il punto più alto dove si pone la Collegiata con la piazza e il suo campanile, può essere interessante esplorare il paese cercando le strade, le scalinate, gli archi e le aperture panoramiche che ne fanno un palcoscenico naturale del paesaggio, di impronta medievale.
55. Radicondoli: via Gazzei nel Medioevo
Matrice G3
Argomento Architettura
Età Medievale
Latitudine 43.154051 (davanti alla Chiesa Collegiata)
Longitudine 11.023229
Distanza da… Belforte, 3,6 km (il linea d’aria)
Visibilità
Il borgo di Radicondoli - apprezzabile da lontano soprattutto nei profili di alcuni edifici, in quelli delle case nate sulle mura di cinta e negli scarsi resti delle torri rimasti - è presente in quasi tutti i PP: 3, 9, 12 e 13. È poi presente fra i reperti nascosti dei PP 1, 5, 7 e 8. Questa visibilità è data dall’altitudine del rilievo collinare su cui si distende il paese e dal fatto che, in direzione O, lo affianca l’ampia depressione del fiume Cecina, che ne migliora l’identificazione.
Descrizione
Sembra ormai accertato dagli studi di Costanza Cucini e dal-la sua equipe che il castello di Radicondoli, nel luogo e nelle forme in cui lo vediamo oggi, sia nato intorno ai primi decen-ni del XIII secolo come una fondazione ex-novo. L’assetto è dunque genuinamente medievale nell’urbanistica e nell’archi-tettura di base, sviluppandosi, il castello, lungo l’asse princi-pale di una collina orientata EO, sul quale corre interamente la via centrale del paese, l’attuale via Gazzei. Parallelamente a questo asse, in posizione più bassa, si sviluppano una serie di altri piani che costituiscono le curve di livello dei fianchi della collina stessa, sui quali sono impostate le altre strade e viuz-zi che intersecano la Sedice. Questa è la via che si sviluppa ortogonalmente a quella principale, con la funzione di porre in comunicazione i vari livelli sottostanti con la sommità del crinale edificato. Tali vie in Toscana presentano spesso delle scalette per la risalita del pendio, come anche a Radicondoli. Su via Gazzei si affacciano ancor oggi gli edifici più importanti e rappresentativi del microcosmo radicondolese: la chiesa, la piazza aperta di fronte a questa, il palazzo sede del potere ci-vile. Esigue sono le tracce rimaste della cinta muraria costrui-ta a inizio del ‘200; mentre ne restano nel tessuto abitativo di Radicondoli, specie nella zona centrale del paese. Fra la metà del ‘200 e del ‘300, come molti altri castelli toscani, il castello di Radicondoli conobbe un trend economico e demografico positivo che produsse una espansione dell’abitato verso E, facendo assumere al paese la caratteristica forma allungata che ancora oggi vediamo (cfr. CUCINI 1990, 393-401).
54. Radicondoli medievale
Matrice F3
Argomento Insediamenti/Paesi
Età Medievale
Latitudine 43.154051 (davanti alla Chiesa Collegiata)
Longitudine 11.023229
Distanza da… Belforte, 3,6 km (il linea d’aria)
7754 55
128 129
la_guida_radicondoli.indd 128-129 01/09/14 12:19
nella configurazione attuale del paese, mentre è ben ricono-scibile – sempre a chi si reca in paese – la seconda cinta mu-raria, costruita con un perimetro irregolare tale da adattarsi alla morfologia della collina. Molto ben conservate sono due delle quattro porte. San Matteo, rivolta a N, caratterizzata da poderosi rinfianchi laterali, da un arco acuto di stile senese ed il classico apparato a sporgere per la difesa piombante. Quest’ultimo è formato da archetti acuti, mensole stondate e piombatoi. San Giovanni, l’altra porta, rivolta invece verso S, è più articolata nella parte alta dove si colloca una guardiola in mattoni con archetti acuti su mensole lapidee. Le altre due porte della cinta muraria sono porta delle Fonti (rivolta a E) e porta di Quercecchio, rivolta a O. Dell’intero circuito murario si sono conservati molto bene i lati orientale e occidentale, anche se per ampi tratti le mura non hanno più l’altezza ori-ginale essendo state nel tempo abbassate. Presentano però alcune torri quadrate, diverse feritoie e anche adattamenti successivi all’evoluzione della tecnica bellica e all’introduzio-ne delle armi da fuoco. Nel nucleo più antico della città poi si conservano le torri e le case-torri delle famiglie nobili che si spartivano il potere civile. San Gimignano fu sede di un piccolo villaggio etrusco del pe-riodo ellenistico (III-II sec. a.C.), ma la sua storia si fa interes-sante intorno al 900-1000 d.C., quando il borgo fu attraversa-to dalla Via Francigena, un’arteria di collegamento tra i paesi del N Europa e la sede papale di Roma. Ciò ne determinò lo sviluppo economico, urbanistico e demografico fino a fare di San Gimignano una «quasi città». Nel 998 San Gimignano era già incastellata e nel prosieguo del tempo la cittadina incor-porò i due poggi che la circondavano (da N e da S), su uno dei quali, quello più alto, era già presente un cassero del Ve-scovado di Volterra. Alla metà del secolo XII gli abitanti di San Gimignano furono impegnati nella sottomissione dei gruppi signorili limitrofi e nella costituzione di un distretto territoriale dipendente dalla città. Le alleanze stipulate con i centri di Col-le di Val d’Elsa e di Poggibonsi (XII sec.) testimoniano i tentativi messi in atto dai sangimignanesi per sottrarsi all’ingerenza dei potenti vescovi volterrani. Lo sviluppo economico, sociale e demografico di San Gimignano - iniziato fin dal 1100, e per-durato nel ‘200 – e l’espansione mercantile poterono conta-re sul commercio e anche sull’efficienza dell’agricoltura del centro murato. Un’efficienza basata su cereali, ortaggi, olio e vino, nonché sulla produzione dello zafferano, esportato fino in Francia. La terribile pestilenza del 1348 e lo spopolamen-to che ne conseguì, facilitarono la sottomissione della ‘quasi città’ a Firenze, come accadde agli altri centri medievali della Val d’Elsa: Certaldo, Gambassi Terme, Castelfiorentino (cfr. BALESTRACCI 2007; CAMMAROSANO-PASSERI 1984, 159-165).
Visibilità
Il paese di San Gimignano è visibile sullo sfondo, in direzione N, dai PP 1, 2 e 8. Essendo abbastanza lontano da Radicon-doli però, lo si vede solamente nelle giornate sufficientemen-te limpide. Con un po’ di attenzione si possono riconoscere la forma a corona del paese e le sue famose torri. Interessante notare che dal PP 1 San Gimignano si colloca appena più in alto, sullo sfondo, a sinistra del paese di Casole d’Elsa, mentre dal PP 2, cambiando quindi la prospettiva, lo si vede collocato tra Mensano a destra e Casole d’Elsa a sinistra, esattamente in mezzo, in lontananza.
Descrizione
Di San Gimignano, in una vista da lontano, si notano in primo luogo le sue alte torri; se poi si indugia un attimo nell’osserva-zione si intravedono anche gli altri edifici di altezze consistenti che caratterizzano il paese, noto al mondo per questa sua caratteristica. Di San Gimignano sono conosciute infatti le 16 torri medievali che segnano lo skyline della Val d’Elsa. Ma un tempo le torri, o meglio, le case-torri, erano ben 72; già nel 1580 ne restavano solo 25 però. La più antica è quella del Podestà, detta “la Rognosa”, alta 51 metri. San Gimignano si erge su di un colle a soli 334 metri di altitudine (quindi più in basso rispetto a Radicondoli) a dominare il tratto intermedio della valle del fiume Elsa. Formatosi attorno a un più antico nucleo, l’abitato si è poi sviluppato nel Medioevo a partire dai quartieri di San Matteo e di San Giovanni, che sono stati suc-cessivamente racchiusi nella seconda cinta muraria, quella che ancora oggi vediamo. Il nucleo originario è da identificarsi sulla collina più alta, alla cui sommità si trova oggi la Rocca, uno degli edifici di San Gimignano il cui profilo è visibile in lon-tananza. La Rocca ha la forma di un pentagono irregolare e presenta tre angoli rivolti verso in tre punti cardinali. Due tratti di mura che si dipartono dalla Rocca, uniti ad altrettante torri rotonde, formavano una sorta di tenaglia, destinata a pren-dere tra due fuochi gli assalitori in caso di invasione e di at-tacco. Il tessuto edilizio di questo nucleo primitivo con fun-zione difensiva è visibile solo a chi ne cerchi le persistenze
56. San Gimignano
Matrice F3
Argomento Insediamenti/Paesi
Età Medievale
Latitudine 43.280279 (piazza della Cisterna)
Longitudine 11.023726
Distanza da… Radicondoli, 29,2 km in linea d’aria, in direzione N
7756 56
130 131
la_guida_radicondoli.indd 130-131 01/09/14 12:19
Visibilità
La chiesa di San Lorenzo a Montalbano è visibile dal PP 12, posizionato sulla ‘terrazza’ panoramica di Anqua, mentre è tra i reperti nascosti del PP 13.
Descrizione
È certo che l’attuale chiesa di San Lorenzo a Montalbano fu ri-edificata fra il 1864 ed il 1870, come testimonia un’epigrafe af-fissa nella controfacciata dell’edificio. L’attuale edificio mostra nelle sue murature l’uso di materiali di una costruzione prece-dente, probabilmente di età romanica. Le notizie certe sulla chiesa di San Lorenzo a Montalbano terminano qui, lasciando il posto a documentazione archivistica e bibliografica che aiu-ta a dirimere alcune questioni importanti. In primo luogo l’i-dentificazione della chiesa primitiva, che sarebbe stata situata nei pressi dell’omonimo castello, due chilometri più oltre. Le Rationes Decimarum del Trecento non indicano a quale delle due chiese fanno riferimento, a quella più vecchia del castello oppure all’altra situata presso l’attuale chiesa ottocentesca, che utilizza però, come detto sopra, materiale antico. L’attuale chiesa di San Lorenzo presenta un’aula unica (non divisa cioè da navate) a pianta rettangolare, alla quale è ad-dossata una costruzione più bassa (forse la cappella della compagnia). Il campanile fu costruito utilizzando il laterizio (fornaci storiche sono state rilevate dalla ricerca archeologica di superficie nei pressi del sito) e il travertino sfruttando così, da un punto di vista estetico, la bicromia dei due materiali da costruzione. Il travertino ricorre anche nella facciata attraver-so il cornicione con modanature che la inquadra insieme alle due paraste laterali è sostenuto il tetto attraverso una serie di volte a crociera che scaricano a loro volta il peso su semipila-stri addossati alle pareti laterali. La chiesa è attualmente priva degli arredi sacri un tempo presenti. (cfr. FRANCALACCI-RO-TUNDO 1999, 110-112).
58. Chiesa di San Lorenzo a Montalbano
Matrice G5
Argomento Architettura
Età XVI-XIX secolo
Latitudine 43.135573
Longitudine 10.574611
Distanza da… Radicondoli, 7 km in linea d’aria, in direzione O/SO
Visibilità
Il castello non è visibile data la scarsa consistenza architetto-nica dei suoi resti tanto che è stato inserito nei reperti nasco-sti dei PP 12 e 13. Si posiziona non lontano dalla chiesa di San Lorenzo a Montalbano, visibile quest’ultima dal percorso 6 e dai suoi PP.
Descrizione
Il Monte di Santa Lucia, insieme al vicino Poggio Auzzo, costi-tuisce la parte più bassa del lungo pendio che scende dalla vetta del Poggio Ritrovoli verso il fondovalle del torrente Pa-vone. Qui aveva sede il castello di Montalbano, posto a 644 metri s.l.m., ricordato nei documenti fin dal XII secolo e andato distrutto ad opera dei senesi nel 1314. I resti informi del ca-strum, costituiti da cumuli di materiali edilizi, pietre squadrate, conci e bozze, lastre di pietra usate come coperture, sono sparsi sulla parte sommitale di un rilievo del Monte, coprendo un’area abbastanza ampia. L’area è completamente circon-data da una cinta muraria che affiora di circa 1 metro dal ter-reno delimitando così l’intera spianata sommitale. Materiale lapideo lavorato, presumibilmente appartenente al castello, è stato usato anche per le murature del vicino e sottostan-te podere Casone. Il castello di Montalbano compare nella documentazione agli inizi del 1100 - quindi un secolo dopo il vicino centro di Bucignano (Scheda 31) – e nel corso del se-colo successivo entra nell’orbita dell’espansione senese, in quando diventato sede di una sua propria comunità, come indicano alcuni documenti del 1235. Nel 1313 le truppe senesi arsero e distrussero completamente il castello, che da allora è rimasto ignorato, fatto salvo tentativi di scavo clandestini. Il sito è occultato dalla vegetazione, tanto che neppure il rile-vamento aereo lo ha individuato; è stato grazie alla segnala-zione di un privato cittadino che gli archeologi hanno potuto trovare il sito. Il castello si trova inserito tra i possedimenti dei Conti Pannocchieschi d’Elci, poi passati nel Seicento in feudo alla famiglia Marescotti di Siena (cfr. CUCINI 1990, 209-210; FRANCALACCI-Rotundo 1999, 110-112).
57. Castello di Montalbano
Matrice H3
Argomento Resti/Ruderi
Età Medievale
Latitudine 43.125420
Longitudine 10.565523
Distanza da… Radicondoli, 9 km in linea d’aria, in direzione O/SO
7757 58
132 133
la_guida_radicondoli.indd 132-133 01/09/14 12:19
raggiungerla, si incontrano le prime difese del fortilizio, poste circa una trentina di metri più in basso; sono i resti della cinta muraria del borgo di servizio al forte militare. Le cortine mura-rie sono costruite in mattoni e pietrame sfuso e sono dotate di due porte urbiche, la porta Volterrana a NE e la porta San Rocco a O. Attraversandola, passando fra i resti del borgo tornati in luce grazie a recenti scavi archeologici, si raggiunge la sommità del colle sotto le mura bastionate della Rocca. Il panorama che si gode dai suoi spalti è fantastico, un vero e proprio ‘pugno emotivo’ nello stomaco, capace di lascia-re attonito il visitatore che ignaro di cosa lo aspetti, è salito fin lassù. Il moderno percorso di accesso costeggia le mura in mattoni, delle quali si può apprezzare il profilo obliquo ot-tenuto con una forte scarpatura in pietra, utile a respingere gli attacchi a fuoco. Sopra le mura si scorgono le torrette di guardia sui quattro angoli del fortilizio. Di recente la Rocca di Sillano è stata restaurata ed è stata aperta al pubblico. Visi-tarla – o recarsi sulla sommità che l’accoglie – è, in ogni caso, un’esperienza da non perdere.
Per approfondire
Recarsi alla Rocca di Sillano. Gite. La salita sulle mura della Rocca di Sillano è una straordinaria esperienza per chiunque. La modesta altitudine a cui è posto il fortilizio (poco più di 500 metri) non rende minimamente giustizia dell’amplissimo panorama che è possibile scorgere dalla sommità e dell’intensità emotiva che la vista del paesaggio circostante regala. Nelle terse giornate inver-nali sembra di toccare con mano Volterra (a NO), complice anche la vicinanza del colle su cui è adagiata la bella città. Dietro di essa, puntando lo sguardo a N, si scorge benissimo la lunga ‘cordigliera’ dell’Appennino pistoiese e, a sinistra, il tormentato bastione apua-no. Se la Montagnola Senese impedisce la vista delle valli e dei bassi colli che si estendono a Oriente di essa, sono ben evidenti (dietro) il Monte Maggio il Chianti, il lungo crinale del Pratomagno, e, più a SE, l’Appennino umbro-marchigiano. Verso SE sbuca l’Amiata con la sua doppia punta arrotondata e poi lo sguardo è costretto a fermarsi sui vicini rilievi delle Colline Metallifere come il Poggio di Montieri e le Cornate di Gerfalco. Completando il giro a 360° è la volta del breve crinale che separa la Val di Cornia dalla Val di Cecina (Aia dei Diavoli) e poi, l’ultimo scorcio che questa po-sizione regala, è sul mare. Quando il cielo è celeste e si distingue dal blu più intenso assunto dal mare, in direzione O si scorge be-nissimo la costa livornese e, al largo, l’isola di Gorgona. Altrettanto emozionante è il paesaggio della sottostante valle del Torrente Pavone che si gode sempre dalla Rocca di Sillano. Il tortuoso scorrere del fiume all’interno di un bacino boscoso e deserto, con i fianchi a tratti ripidi e franosi, unito ai resti degli impianti minerari sottostanti il bellissimo borgo di Montecastelli Pisano, posto sulla collina dirimpetto alla Rocca, completano questa spettacolare e unica vista. Un’escursione molto suggestiva (ma impegnativa) è quella ricavabile all’interno dell’alveo dello stesso Pavone, dal pon-te della strada che unisce Montecastelli a San Dalmazio fino alla confluenza dello stesso Pavone nel Cecina. E’ un’escursione rac-comandata solo a chi possiede buona esperienza di orientamen-to, gambe ben allenate e non disdegna di compiere i numerosi guadi che il tragitto impone.
Visibilità
La forma dominante del poggio su cui è posta la Rocca di Sillano, che con il suo massiccio corpo termina il profilo della collina, è facilmente visibile in direzione N dal PP 12, sul per-corso 6.
Descrizione
La Rocca di Sillano, o Silano – talvolta chiamata Rocca Sillana – si trova all’estremità orientale del territorio comunale di Po-marance (PI) ed è raggiungibile con una passeggiata di circa 15 minuti seguendo il percorso attrezzato che si diparte da un’abitazione sottostante il poggio dove è posizionata, pres-so il vicino paese di San Dalmazio. La Rocca si erge solitaria sopra un rilievo roccioso a 530 metri di altitudine, in una posi-zione tale da dominare un vasto territorio compreso allo sno-do tra le province di Siena, Pisa e Grosseto. Il sito è sempre stato strategicamente importante per il controllo della valle del fiume Cecina e delle circostanti valli minori, tanto che la leggenda vuole che il fortilizio sia stato eretto in epoca roma-na, durante la guerra civile fra Mario e Silla, e che da quest’ulti-mo derivi il suo nome (Silla=Sillano). Le testimonianze storiche fanno pensare che la Rocca sia stata costruita in una epoca molto meno antica: la torre, che conserva l’ingresso origina-rio, successivamente tamponato, posto all’altezza del primo piano, è datata all’anno 1067 circa, in un documento che menziona Sillano come sito fortificato. La parte interna del re-cinto murato è invece da ascrivere al secolo XIII. Il perimetro esterno bastionato, eseguito a rinforzo delle preesistenti cor-tine murarie, è più tardo e risale alla metà del ‘400. Gli storici attribuiscono la paternità del progetto al famoso architetto rinascimentale di Cosimo I de’ Medici, Giuliano da Sangallo, quando Pomarance passò sotto la giurisdizione fiorentina. La nuova architettura militare rinascimentale, di cui la Rocca di Sillano costituisce una delle maggiori espressioni in Toscana, si colloca nel momento di passaggio dell’armamento ‘dalla balestra alla bombarda’ che produsse il conseguente svilup-po di sistemi di difesa adeguati alla nuova potenza distruttiva delle armi da fuoco. Avvicinandosi a piedi alla Rocca, prima di
59 Rocca di Sillano
Matrice G3/4
Argomento Architettura
Età Medievale/Rinascimento
Latitudine 43.162858 (cortile interno)
Longitudine 10.560474
Distanza da… Radicondoli, 11,2 km in linea d’aria, in direzione O
7759 59
134 135
la_guida_radicondoli.indd 134-135 01/09/14 12:19
Visibilità
La viabilità mineraria non è visibile con chiarezza in quanto gli antichi percorsi non hano lasciato tracce evidenti sul pae-saggio, se non quando ad essi si sono soprammessi tracciati viari più recenti. Dal PP 7 è possibile apprezzare la porzione di paesaggio radicondolese (piani di Coiolo e Materno) che un tempo ha ospitato la viabilità mineraria.
Descrizione
In età etrusca il corso del Cecina fu un’area preferenziale per gli insediamenti di tipo «aperto», privi cioè di strutture difensi-ve, posti sui bassi terrazzi fluviali. Delle due tipologie insediati-ve etrusche – quella aperta e quella arroccata sui poggi – nel Medioevo si impone la seconda, più confacente alle esigenze e al clima dell’epoca. Fra i castelli medievali accertati del ter-ritorio radicondolese alcuni fra i più importanti e più antichi si collocano proprio lungo la valle del Cecina, posizionati o su colline che dominano dall’alto la vallata, fin quasi alla linea di spartiacque – ad esempio Bucignano (Scheda 31) e Montal-bano, oppure a ridosso dell’alveo fluviale, su sproni collinari muniti di pareti scoscese, ad esempio Elci. La loro presenza lungo l’asta fluviale è da mettere in relazione all’importanza che nei secoli XI-XII rivestirono le miniere di galena argenti-fera di Poggio Mutti e delle Cornate di Gerfalco, di proprietà del Vescovado di Volterra. Questi giacimenti minerari furono utilizzati per ricavare argento necessario a coniare il «grosso», la moneta allora in uso a Volterra. Dal castello del Berignone – residenza fortificata dei vescovi – si dipartiva una strada, an-cora oggi in buona parte identificabile, che una volta valicate le colline poste fra le valli del Pavone e del Cecina, scorreva nei sottostanti Piani di Coiolo e Materno, per poi continuare a risalire la valle fin sotto Gerfalco, incrociando altri percorsi ver-so l’interno delle Colline Metallifere. Lungo il tratto superiore del fiume Cecina la presenza di castelli come Elci, Bucigna-no e Montalbano – ma anche Radicondoli – era di appoggio e di controllo delle carovane che dall’interno trasportavano il prezioso minerale per la monetazione fino a Volterra dove avveniva il conio (cfr. CUCINI 1990, 262-272).
61. Viabilità mineraria nel Medioevo
Matrice E3
Argomento Viabilità
Età Medievale
Latitudine 43.154269 (mulino del Piano di Coiolo)
Longitudine 11.002188
Distanza da… Radicondoli, 3,5 km in linea d’aria, in direzione O
Visibilità
Travale è arroccato sulla sommità di una collina che precipita nel Cecina. Lo si vede dal PP 10, in direzione SO, un po’ na-scosto alla vista dalla copertura boschiva ininterrotta che am-manta i versanti settentrionali delle Cornate di Gerfalco e del Poggio di Montieri. Se la giornata non è limpida è impossibile identificare da lontano il paese.
Descrizione
Il castello di Travale, a pianta circolare, ha perso quasi tutta l’an-tica cinta muraria. Ma se il circuito difensivo non è più visibile, nel corso di una visita in loco l’intera massa architettonica medieva-le del sito è perfettamente riconoscibile. Le case costruite nei secoli successivi si sono installate sulle antiche mura, ingloban-dole completamente. Il risultato, al pari di tanti altri borghi for-tificati toscani, soprattutto dell’area grossetana, è che visto da lontano Travale rimane un paese ‘medievale’ anche se in loco vi sono poche testimonianze. Tra queste una porta collocata sul versante settentrionale della collina e rivolta a E, dotata di un arco in travertino (materiale da costruzione questo reperibile presso la vicina località delle Galleraie) e una torre a base roton-da, sempre in pietra. Il castello di Travale, come molti altri vicini, era nelle mani della potente famiglia comitale dei Pannocchie-schi (gli stessi possidenti di Anqua) nel 1135; saranno loro che, nel corso dello stesso secolo, si contenderanno il possesso di Travale su diversi fronti: su quello del vescovado volterrano, che aveva rappresentanti dei Pannocchieschi; su quello della con-tea imperiale, proprietaria di molti siti in varie parti delle Colline Metallifere. Con il tramonto dell’egemonia comitale, esercitata non solo dai Pannocchieschi ma anche da altre famiglie di antico lignaggio (Aldobrandeschi, Guidi, Gherardeschi), Travale cadde sotto il dominio della Repubblica Sense, la quale, nel corso del XIII secolo, allargò all’intero contado meridionale la sua influen-za. In ogni caso, attaverso le cariche della cittadinanza senese, i Pannocchieschi continuarono a dominare il castello di Travale almeno per tutto il XIV secolo (cfr. CAMMAROSANO-PASSERI, 1984, 119).
60. Travale
Matrice F3
Argomento Insediamenti/Paesi
Età Medievale
Latitudine 43.100255 (piazza)
Longitudine 11.003071
Distanza da… Radicondoli, 13,2 km in linea d’aria, in direzione S
7760 61
136 137
la_guida_radicondoli.indd 136-137 01/09/14 12:19
Matrice G4
Argomento Architettura
Età Rinascimento
Latitudine 43.124817 (punto panoramico)
Longitudine 10.590504
Distanza da… Radicondoli, 7 km in linea d’aria, in direzione SO
Visibilità
Volterra è uno dei reperti eminenti del paesaggio radicondo-lese. La cittadina si vede da quasi tutti i PP (1, 2, 7, 8 e 12) che si aprono a Occidente, essendo posta a oltre 500 metri di al-titudine, sulla piatta collina che la ospita. L’altitudine permette a chi guarda di superare le colline spartiacque tra la valle del Pavone e quella del Cecina. In condizioni di scarsa visibilità, per contro, Volterra può essere nascosta dalla foschia data la non lieve distanza da Radicondoli.
Descrizione
Dopo essere stata una delle più potenti lucumonie etrusche, Volterra ebbe un lungo periodo oscuro che si riflette anche sulle attuali scarse conoscenze della vita di questa cittadina durante tutto il periodo che va dall’età barbarica all’Alto Me-dioevo. È solo con il sec. XI che la storia di Volterra torna a essere più ricca di avvenimenti nel contesto del governo dei Vescovi. Esiste tuttavia una continuità storica tra la lucumo-nia etrusca, la città federata romana, il municipio e la diocesi medievale, soprattutto riguardo all’ampiezza e ai confini ter-ritoriali, di grande importanza per comprendere le persisten-za tra la Volterra medievale e la Velathri etrusca. Il sec. XI si contraddistingue per l’egemonia su questo territorio dei Conti Pannocchieschi – una delle più grandi e potenti famiglie comi-tali della Toscana altomedievale – che mantengono la catte-dra episcopale volterrana per lungo tempo, contribuendo ad ampliare la loro influenza, grazie agli estesi possedimenti che giungevano fino al territorio di Radicondoli, inserito nella dio-cesi volterrana. Restavano compresi in questo territorio am-ministrativo della diocesi anche quelli dov’erano presenti le miniere di argento di Poggio Mutti e delle Cornate di Gerfalco. Nel Trecento il governo dei Vescovi decade per i colpi inferti dal Comune e dalle maggiori città toscane interessate a Vol-terra quali Firenze, Pisa e Siena. Proprio la ricchezza mineraria del territorio volterrano determinò la capitolazione della città, che passò sotto il dominio fiorentino nel 1472, ad opera di Lo-renzo dei Medici (VOLPE 1962, 143-313; FIUMI 1968).
62. Volterra medievale
Matrice F3
Argomento Insediamenti/Paesi
Età Medievale
Latitudine 43.401318
Longitudine 10.858068
Distanza da… Radicondoli, 28,7 km in linea d’aria, in direzione NO
Visibilità
L’architettura di Anqua è stata inserita tra i reperti ‘nascosti’ poiché il borgo si colloca in corrispondenza del Punto Pano-ramico 12 e costituisce un approfondimento della Scheda de-dicata al Borgo di Anqua n° 64.
Descrizione
Nel 1572 il conte Marcello Pannocchieschi d’Elci costruì la Villa di Anqua sul pianoro che già ospitava una piccola co-munità rurale. Ce lo ricorda l’epigrafe posta in facciata della Villa, sotto il grande stemma della famiglia comitale. La Villa, di grande eleganza, è inserita in un complesso architettonico composto da un corpo centrale, con cortile laterale, e da altre quattro unità immobiliari coeve di servizio. È completata poi da un bel giardino all’italiana che guarda in direzione S, invisi-bile dalla strada. Anticipa il giardino un cortile con un pozzo in travertino, di fattezze rinascimentali, decentrato rispetto allo spazio aperto e realizzato nel 1789. Nel tempo si sono sus-seguiti molti interventi di restauro eseguiti dai discendenti di Marcello Pannocchieschi d’Elci. Il complesso villa-fattoria, in-fatti, è ancora di proprietà della medesima famiglia, che si oc-cupa con cura e dedizione della conservazione. Alcuni storici attribuiscono il progetto della Villa al noto architetto senese Baldassarre Peruzzi, in base ad analogie con altre costruzio-ni; ma non è mai stata fatta luce sulla reale paternità stilistica del complesso, almeno in maniera inoppugnabile. Sia come sia, l’edificio ha, comunque, una solennità e un’armonia che lo apparentano, più che ad una villa rurale, a un palazzo cit-tadino, secondo un modello ispiratore che trova riscontro nei materiali nobili da costruzione, i quali indicano una specifica volontà ostentativa. Il mattone rosso, ad esempio, caratteri-stico di Siena, costituisce il paramento della facciata, in con-trasto con il bianco del travertino utilizzato per tutte le finiture, com’è nei grandi palazzi cittadini. Il portale di accesso poi, le fasce marcapiano e marcadavanzale e le aperture dei piani, accolgono lo stemma gentilizio e le iniziali del committente (cfr. FRANCALACCI-ROTUNDO 1999, 134-139).
63. Anqua: l’architettura
7762 63
139138
la_guida_radicondoli.indd 138-139 01/09/14 12:19
Visibilità
Il reperto appartiene a quelli non immediatamente visibili ma ‘integrati’ in altri che li comprendono al loro interno; in questo caso si tratta del paese medievale che, quasi sempre, occul-ta la vista diretta su quello rinascimentale. Infatti, tranne che nei PP 5 e 11 dove sono evidenti architetture rinascimentali, il reperto compare come nascosto nei PP 4, 10 e 13.
Descrizione
Anche per Belforte si ripropone il problema comune ai centri forti-ficati delle Colline Metallifere, ovvero della misconoscenza relativa alla loro storia post-medievale. Gli anni del Rinascimento non sono stati infatti molto studiati in riferimento alle vicende insediative del-la Toscana centro-meridionale. L’assenza di studi e ricerche per i secc. XVI-XVII inerenti gli agglomerati urbani localizzati nella regio-ne metallifera, limita l’interesse per una parte della Toscana che ebbe una fondamentale funzione di cerniera tra le due realtà più dinamiche, ed economicamente intraprendenti, della regione: la costa e il bacino dell’Arno, con i loro centri politicamente più atti-vi. Nello specifico caso di Belforte, rimasto escluso da approfon-dimenti anche nel ricchissimo studio di Costanza Cucini, si deve lamentare la sconfortante assenza di minime notizie in riferimento ai secoli che coprono il periodo del Granducato Mediceo e Lore-nese (XVI-XVIII). Le poche notizie che provengono da studi eru-diti dell’Ottocento indicano una realtà rurale fatta di semplice vita contadina e di decadenza, rispetto a un periodo immediatamente precedente sicuramente più prospero, che vide l’arricchimento estetico del borgo ad opera di capitali senesi. Nel 1617 e nel 1676, nel corso di due visite pastoriali effettuate a Belforte, le sue mura vengono descritte «in stato poco buono», spia di un livello sociale ed economico di difficoltà e trascuratezza. Ma nel Rinascimento non fu così. In via Santa Croce, infatti, come oggi si può ancora apprezzare, sono presenti un paio di palazzi di pregio, di cui uno dalla singolare pianta a trapezio con un impianto che risale al tardo Cinquecento, risultato di un accorpamento di preesistenti edifici medievali. L’altro, a pianta rettangolare, si sviluppa su due piani e mostra una muratura mista di mattoni e pietre. (cfr. FRANCALAC-CI-ROTUNDO 1999, 83-99).
65. Belforte rinascimentale
Visibilità
Il borgo di Anqua è visibile dai PP 6 e 13, mentre risulta fra quelli nascosti nei PP 10 e 12.
Descrizione
Il borgo di Anqua si trova su di una collina panoramica in riva oro-grafica sinistra dell’alto corso del Cecina, leggermente arretrata rispetto al corso del fiume, come fosse un’isola di coltivi in mez-zo alla foresta. Nel luogo dove oggi sorge la Villa cinquecentesca (Scheda 63), esisteva, già nel secolo XIV, una chiesa attorno alla quale si era polarizzato nel corso del periodo di forte crescita de-mografica (XII-XIII) un abitato rurale aperto. Studi recenti hanno indicato come nel corso del Quattrocento l’architettura religiosa del territorio senese subisca una battuta di arresto; in alcuni casi si trattò di un vero e proprio abbandono, testimoniato oltre che dal trasferimento delle chiese rurali all’interno dei vicini paesi, anche dal resoconto delle visite pastoriali di quegli anni di crisi. Molte de-scrizioni conservate nelle carte vescovili, infatti, narrano di chiese rurali - in questo settore della diocesi di Volterra - abbandonate o in rovina. È il caso anche di San Rufo ad Anqua, che nel 1443 viene assegnata al ministero del parroco di Belforte a condizione che fosse restaurata. Se la chiesa di San Rufo versava a metà Quat-trocento in condizioni critiche, vista la sua funzione di polo di ag-gregazione demica, si può ragionevolmente immaginare lo stato di spopolamento delle campagne d’intorno. Con l’inclusione dello Stato senese nel Granducato mediceo nel 1559, le campagne radicondolesi si rivitalizzano, grazie soprattutto ai cospicui inve-stimenti attuati dalle ricche e potenti famiglie cittadine senesi. Nel nostro caso furono i Pannocchieschi d’Elci a restaurare e riedifica-re San Rufo, alla metà del ‘500, contestualmente all’ampliamento della loro villa. Presumibilmente, tutto il borgo rurale di Anqua e molte case sparse ad esso appartenenti, furono migliorate con il rientro dalla città in campagna di una frangia della famiglia Pan-nocchieschi, che riportò in questa splendida porzione del territorio radicondolese – dal XVI secolo in avanti – lavoro e qualità della vita (cfr. FRANCALACCI-ROTUNDO 1999, 44-45).
64. Anqua: il borgo
Matrice G4
Argomento Architettura
Età Rinascimento
Latitudine 43.135301 (punto panoramico)
Longitudine 11.034585
Distanza da… Radicondoli, 3,5 km in linea d’aria, in direzione S/SE
Matrice F4
Argomento Insediamenti/Paesi
Età Rinascimento
Latitudine 43.124817 (punto panoramico)
Longitudine 10.590504
Distanza da… Radicondoli, 7 km in linea d’aria, in direzione SO
7764 65
141140
la_guida_radicondoli.indd 140-141 01/09/14 12:19
Visibilità
Via Gazzei partecipa all’assetto urbanistico rinascimentale di Radicondoli, costituendone l’asse centrale. È citata come re-perto nascosto nei PP 1, 2, 3 e 8.
Descrizione
Lungo quella che è ancora oggi la via principale del paese di Radicondoli – via Tiberio Gazzei cioè – si trovano i palazzi più prestigiosi, pubblici e privati, del paese. La via dovette vive-re fra Cinquecento e Settecento momenti di intensa attività edilizia che la trasformarono significativamente intervenendo sul primitivo aspetto medievale. All’estremità orientale del-la via sorge la chiesa del Crocifisso, un tempo annessa allo spedale medievale; le sue forme risalgono alla ristrutturazio-ne del 1724. Sempre su via Gazzei si affaccia il palazzo detto del Poggiarello, che si sviluppa su tre piani, caratterizzato da cornici bugnate laterali e portale d’ingresso anch’esso bu-gnato. Altri elementi decorativi che emergono dal paramento murario, a vista, in pietra e mattoni, sono i marcadavanzali e le cornici delle finestre. Quasi di fronte alla chiesa Collegiata troviamo palazzo Pierallini, appartenuto alla famiglia Bizzarrini e acquistato dal Comune all’inizio dell’Ottocento. La faccia-ta principale si articola su tre livelli scanditi da cornici marca-piano e dalle bugne del portale e delle finestre in travertino. Della famiglia Bizzarrini sappiamo che alcuni suoi esponenti ricoprirono importanti ruoli presso la corte medicea fiorentina, ricavandone prestigio e soldi, che poi reinvestirono nella loro terra di origine. Palazzo Bizzarrini si articola su tre piani, con aperture incorniciate da modanature e con un portale bu-gnato al centro della facciata principale. Il paramento murario è in laterizio, uno dei materiali caratterizzanti l’architettura e il paesaggio senese. Le fornaci di laterizio sono state impor-tanti nell’economia locale; e il mattone è un simbolo dell’iden-tità senese, che persiste con continuità tra l’età moderna e contemporanea. Anche la casa Beccantini Spazzini, pur con-servando caratteri medievali, mostra nelle sue forme la tra-sformazione subita nel ‘500 (cfr. FRANCALACCI-ROTUNDO 1999, 57-61).
67. Radicondoli: via Gazzei rinascimentale
Matrice G4
Argomento Architettura
Età Rinascimento
Latitudine 43.154051 (davanti alla Chiesa Collegiata)
Longitudine 11.023229
Distanza da… Belforte, 3,6 km (in linea d’aria)
Visibilità
Radicondoli rinascimentale si nota percorrendo il paese e no-tandone alcune architetture residenziali.
Descrizione
Nel corso dei secoli XV e XVI il borgo di Radicondoli fu ogget-to di alcune trasformazioni edilizie che, pur non cancellando la struttura urbanistica disegnata nei secoli medievali, intro-dussero cambiamenti architettonici consistenti e visibili, so-prattutto lungo l’asse viario centrale (via Gazzei). Il principale intervento si verificò nei decenni a cavallo fra il Cinquecento e il Seicento e riguardò la chiesa Collegiata che si affaccia sulla piazza centrale, oggi piazza Matteotti. Protagonista della mo-dificazione di assetto fu Simone Nerini, parroco di Radicondoli dal 1566 al 1616. Il nuovo edificio religioso fu ispirato ai gusti rinascimentali, che cancellarono le preesistenze medievali, con il risultato di un ampliamento della prospettiva in termini di apertura della chiesa su di una piazza centrale. Durante i lavori per la nuova chiesa furono inglobate alcune parti della prece-dente costruzione, in particolare due cappelle, e ciò compor-tò un diverso orientamento dell’edificio religioso, che assunse una forma irregolare. Il drastico cambiamento fu completato con un nuovo campanile, molto armonico e caratterizzante, con la parte sommitale in cotto invece che in pietra. Altri inter-venti architettonici furono realizzati lungo l’asse principale del paese, dove si affacciarono nuovi palazzi, anch’essi di fattez-ze rinascimentali, che ricordano da vicino l’assetto dei palazzi cittadini della capitale senese. Questi nuovi palazzi furono do-tati di soluzioni estetiche notevoli per un paese rurale, come bugne per i portali, cornici marcapiano, modanature intorno alle finestre, realizzati con un ampio uso del travertino, in fun-zione sia decorativa che ostentativa. Si trattava infatti di una evidente dimostrazione di ricchezza e potere. Sono questi i palazzi Berlinghieri, Bizzarrini, Pierallini e del Poggiarello, che ognuno può osservare ancora oggi camminando dentro al borgo di Radicondoli. (cfr. FRANCALACCI-ROTUNDO 1999, 54-76).
66. Radicondoli rinascimentale
Matrice G4
Argomento Architettura
Età Rinascimento
Latitudine 43.154051 (davanti alla Chiesa Collegiata)
Longitudine 11.023229
Distanza da… Belforte, 3,6 km (in linea d’aria)
7766 67
142 143
la_guida_radicondoli.indd 142-143 01/09/14 12:19
Matrice I5
Argomento Economia del bosco/Pastorizia
Età XVI-XIX secolo
Latitudine 43.154269 (presso podere Coiolo)
Longitudine 11.002188
Distanza da… Radicondoli, 1,5 km in linea d’aria, in direzione N
Visibilità
La villa di Olli è visibile dai PP 5, 6 e 7.
Descrizione
L’interesse per l’origine germanica del toponimo «Olli» non trova riscontro nei documenti altomedievali, ma solo in alcu-ni del XII secolo. L’antichità del sito è peraltro sicura, anche se nelle sue forme attuali la Villa di Olli si mostra per l’asset-to rinascimentale ricevuto con gli interventi del Cinquecen-to e del Seicento, quando – come avvenne in altre ville rurali appartenenti alla nobilità comitale inurbata, ad esempio per Cornocchia, all’interno dello stesso territorio di Radicondoli – l’architettura rurale di alto rango imitò i canoni dei palazzi cit-tadini di Siena. I lavori di ampliamento e abbellimento, infatti, in quegli anni, misero mano più volte alle strutture medievali preesistenti, adeguandole alle esigenze di gusto e di osten-tazione del tempo. Il complesso di Olli, posto in aperta cam-pagna, isolato da Radicondoli, ma visibile da molte parti del suo territorio, fu aggiornato a partire da un impianto edilizio regolare, organizzato in due parti principali – la Villa, di forma quadrangolare, e la piccola cappella – tra loro collegate da un corridoio. La facciata della Villa è scandita da due ordini di fa-sce marcadavanzale in travertino con cornice sgusciata nella parte inferiore, che ripartiscono i tre piani residenziali. Que-sto ricercato motivo estetico insiste tanto sulla forma quanto sul materiale costruttivo usato (il travertino), che fu importato da altre zone senesi esclusivamente per usi decorativi, non essendo disponibile in loco. Anche le aperture del piano no-bile – il primo – utilizzano la medesima soluzione estetica, in quanto sede residenziale della famiglia, mentre il piano terra e il terzo erano destinati ad altri usi. Anche sotto gronda passa una cornice di generose dimensioni che contribuisce a dare tono alla facciata e a ricavare nel paesaggio l’idea di una re-sidenza importante. L’Oratorio fu invece costruito nell’800 e accoglie le spoglie dell’allora proprietario Odoardo Berlinghie-ri. E’ titolato alla Madonna e ai Santi Odoardo Re e Girolamo (cfr. CUCINI 1990, 175-77; FRANCALACCI-ROTUNDO 1999, 132-133).
68. Villa di Olli rinascimentale
Matrice G4
Argomento Architettura
Età Rinascimento
Latitudine 43.145826
Longitudine 11.010692
Distanza da… Radicondoli, 2,2 in linea d’aria, in direzione SO
Visibilità
La transumanza è una caratteristica specifica del territorio ra-dicondolese, quello posto oltre il ponte sul fiume Cecina in direzione del territorio grossetano. Le greggi provenienti dal-la Valdelsa infatti guadavano il fiume per recarsi nelle Colline Metallifere e nelle pianure intorno a Grosseto nel corso dell’ inverno. Tale caratteristica territoriale è visibile dai PP 1, 2, 7, 8 e 9.
Descrizione
Fra i tanti percorsi utilizzati dai pastori per portare a svernare le loro greggi dall’Appennino toscano alla Maremma, alcuni interessavano la zona di Radicondoli. Secondo le ricerche storiche più recenti, si trattava di un paio di itinerari che divi-dendosi, una volta superato il paese di Colle di Val d’Elsa, si riunivano in prossimità di Radicondoli, e precisamente in lo-calità Casone. Quello più occidentale transitava per Badia a Conèo, Quartaia, Casole d’Elsa e Mensano; da qui, attraverso la valle del Fosso Vetrialla mensanese (Scheda 1), lambiva i poderi Pasturecci, Filicaia e Tesoro, scendeva ai mulini posti sul Vetrialla radicondolese (di Mezzo e della Ricciaia) e risali-va al Casone toccando i poderi Colle e Torre. Nell’Ottocento questo tragitto diventerà la «Via doganale» verso Mensano, a testimoniare il doppio uso del percorso, di controllo e di tra-sferimento delle greggi. L’altro itinerario, il più agevole, sfrut-tava l’alta valle dell’Elsa e passando dal borgo di Paurano e da Molino d’Elsa, saliva il Poggio Sermena e rasentava i po-deri Niccioli e Pagliaia per poi scendere al Casone, seguendo, cioè, l’itinerario della «strada comunitativa che da Radicondoli va a Poggibonsi». Da qui, i due percorsi riprendevano quello che è oggi il tracciato della Strada Provinciale che toccava i Bagni delle Galleraie per poi inerpicarsi verso Montieri. Dal borgo di Travale, arroccato sul Cecina, un tracciato divergeva da quelli descritti scendendo fino al greto del fiume e risalen-done il corso fin sotto il massiccio delle Cornate, da dove, con una ripida salita, arrivava a Gerfalco. Proseguiva poi in dire-zione del Piano dei Mucini e Massa Marittima, verso le zone aperte sul mare (cfr. MARCACCINI-CALZOLAI, 2003).
69. Transumanza nell’Ottocento
7768 69
144 145
la_guida_radicondoli.indd 144-145 01/09/14 12:19
Visibilità
La struttura mezzadria della campagna radicondolese si ap-prezza dai PP 1, 3, 8 e 9. La zona è quella posta tra i corsi d’acqua Vetrialla, Sala (Scheda 17) e Quarantola (Scheda 16).
Descrizione
La carta di uso del suolo di Radicondoli mostra la suddivisio-ne in due zone principali: il bosco e l’agricoltura. Le economie rurali sono invece quattro: economia del bosco, pastorizia, agricoltura e attività di trasformazione. L’assetto mezzadrile, pur non essendo esclusivo, come in altre zone della Tosca-na, è stato comunque importante per lo sfruttamento e lo sviluppo agricolo e per il contributo da esso offerto al pae-saggio. La mezzadria è stata favorita dalle buone caratteristi-che geomorfologiche, pedologiche e litologiche dei terreni, soprattutto nella fase precedente al meccanizzazione dell’a-gricoltura. A Radicondoli alla mezzadria era un istituto giuridi-co attivo fin dai secoli medievali, che prevedeva la conduzio-ne dei fondi di proprietà padronale a contandini-mezzadri cui era dato obbligo di consegnare la metà dei raccolti e delle produzioni al proprietario, che metteva a loro disposizione l’alloggio, i terreni e gli attrezzi agricoli. L’istituto della mezzadria è stato in Toscana un regime so-ciale applicato allo sfruttamento agricolo di territori impervi che non si prestavano all’agricoltura estensiva e specializ-zata. Nella mezzadria, infatti, l’agricoltura è promiscua, vale a dire realizzata attraverso una produzione varia e articolata intorno alle esigenze primarie di sostentamento locale, che genera pochi scambi di mercato essendo disponibili poche eccedenze. La mezzadria è stata abolita solo nel 1964 e so-stituita da contratti di affitto. Sul territorio ne rimane evidente testimonianza nell’architettura del paesaggio e nella forma e suddivisione dei terreni tra un podere e l’altro. Le ricerche di archeologia agricola permettono di configurare i musei all’a-perto o i musei della memoria, che rappresentano delle ri-sorse per il turismo sostenibile (cfr. CUCINI 1990, 42-50; BINI 2011; NARDI 2004, passim).
71. La mezzadria
Matrice L5
Argomento Agricoltura
Età XVI-XIX secolo
Latitudine 43.160646 (presso pod. San Pierino)
Longitudine 11.015977
Distanza da…Radicondoli, 1,2 km in linea d’aria (Pod. S.Pieri-no), in direzione NO
Visibilità
Il complesso monastico si intravede appena dal PP 5, occul-tato dalla boscaglia di lecci che si frappone fra l’osservatore ed il Convento. Anche nel PP 4 il convento è inserito nei re-perti nascosti.
Descrizione
La configurazione originaria tardo-quattrocentesca del Con-vento dell’Osservanza fu modificata intorno alla metà del ‘600, quando al corpo centrale della chiesa e del convento furono aggiunti gli spazi complementari resi necessari dall’at-tività agricola annessa a quella prettamente religiosa e mona-stica. Sorsero così, lungo il lato occidentale, la stalla e il fienile, mentre su quello meridionale si costruirono «le cucine nuove con forno e legnaia», e più ampi dormitori dotati di spazi co-muni (logge). Anche la chiesa subì un ampliamento, con la creazione di due cappelle e di un portico antistante la fac-ciata, mentre l’interno fu dotato di altari barocchi, secondo il gusto dell’epoca. Lo stesso chiostro fu ingrandito con la cre-azione di un secondo spazio. All’inizio del ‘700 l’aumentato numero dei frati rese necessari ampliamenti che interessaro-no i dormitori, con annessi vani agricoli; l’interno della chiesa subì altre modifiche legate al gusto artistico in evoluzione. A metà del secolo XVIII i due chiostri furono uniti in un unico e più grande spazio di forma rettangolare, suddiviso da un co-lonnato in mattoni che ancora oggi supporta una serie di archi a tutto sesto in cotto, anche se tamponati. (cfr. CUCINI 1990, 89-90; FRANCALACCI-ROTUNDO 1999, 77-82).
Per approfondire
Attività culturali. Nel sito dell’ ex-Convento dell’Osservanza si svolgono attività culturali e scientifiche (musica, etologia, ecolo-gia), corsi, seminari, convegni, concerti. Le attività musicali sono svolte a cura della Dulcimer Fondation pour la Musique (http://www.dulcimerfondation.org/). Le attività scientifiche sono orga-nizzate dal Centro Studi Etologici e dalla Società Ethoikos (http://www.ethoikos.it/).
70. Convento dell’Osservanza nel ‘600
Matrice G5
Argomento Architettura
Età XVI-XIX secolo
Latitudine 43.152791 (chiostro)
Longitudine 11.023579
Distanza da… Radicondoli, 400 metri in linea d’aria, in direzione S
7770 71
146 147
la_guida_radicondoli.indd 146-147 01/09/14 12:19
Visibilità
Il reperto non è visibile nel paesaggio ma fa parte integrante del Percorso 1. È stato, per questo motivo, inserito tra i reperti nascoti segnalati nelle Matrici del Paesaggio relative ai PP 1,2, 3 e 8.
Descrizione
Il principale asse viario del paese, oggi via Tiberio Gazzei, ha visto un continuo adeguamento dei palazzi e delle chiese che vi si affacciano ai gusti che via via col tempo si sono modificati. Percorrendo oggi a piedi questa strada possiamo seguire il cammino architettonico e artistico dei singoli edifici civili o re-ligiosi, protagonisti della storia plurisecolare del paese. Ecco che, oltre alle emergenze cinquecentesche e seicentesche già richiamate (Schede 66, 67) osserviamo la Chiesa del Cro-cifisso, posta all’ingresso del borgo, un tempo detta di San Giovanni e annessa allo spedale per pellegrini. Completata all’inizio del Settecento, essa presenta oggi la tipica facciata a capanna in laterizio con paraste ai lati e timpano superio-re. Oppure il Palazzo Lolini, già Bizzarrini, edificato nelle for-me cinquecentesche su preesistenze medievali; la facciata, delimitata dal bugnato laterale, presenta due grandi portali anch’essi bugnati e tre piani separati da cornici marcapiano su cui si aprono sette finestre per ogni livello. L’interno del Pa-lazzo è però di gusto neoclassico essendo stato ristrutturato completamente alla fine dell’Ottocento. Oppure si veda an-che la chiesa tardo-gotica di Santa Caterina delle Ruote che, pur presentando una facciata del secolo XIV, mostra la pro-fonda manomissione cui fu sottoposta, soprattutto all’inter-no, a seguito di alcuni danni provocati da un fulmine. A questi edifici si deve aggiungere tutta una serie di case distribuite lungo la via principale di Radicondoli che furono ristruttura-te nel corso dell’8oo e del ‘900 ma che mostrano, al piano terreno, impronte medievali quali archi, portali e logge tam-ponate. Ad esempio, casa Beccantini Spazzini, oppure quella al numero civico 8 (FRANCALACCI-ROTUNDO 1999, 57-76).
73. Radicondoli: via Gazzei nell’Ottocento
Visibilità
Pomarance si intravede in lontananza dal PP 12 (posto sulla ‘terrazza’ panoramica di Anqua), in direzione NO ma sola-mente nelle giornate limpide o di scarsa foschia.
Descrizione
Pomarance è situato su di una collina a 375 metri s.l.m. sulla riva sinistra orografica del fiume Cecina e rappresenta la ‘porta d’in-gresso’ ufficiale alle Colline Metallifere attraverso la strada statale 439 di vecchia costruzione. Comune storicamente importante per lo sviluppo e lo sfruttamento dell’energia geotermica nella fra-zione di Larderello, così chiamata in onore dell’ingegnere france-se François Jacques de Larderel del XIX secolo che ne promosse lo sfruttamento, Pomarance ha visto nel corso della sua storia secolare la valorizzazione anche di altre risorse oltre a quelle lega-te alla geotermia. Nel corso dei primi secoli dell’età moderna, ad esempio, la costituzione litologica del territorio, soprattutto nella sua parte nord-orientale, favorì la nascita di diverse fornaci dove si producevano maioliche e ceramiche da parte di un coeso e ben sviluppato ceto di stovigliai del paese. Ancora la natura del territorio favorì la comunità di Pomarance all’indomani della co-stituzione dello Stato regionale mediceo, allorquando ebbe inizio una stagione di intense ricerche minerarie. In località La Corte ad esempio, nel 1558, il tecnico granducale Alessandro Cini vi scoprì un giacimento di rame che dette origine ad una vera e propria miniera la quale ebbe però breve vita a causa della scarsità del potenziale cuprifero. Oltre a questa si ebbero escavazioni in altre località del territorio come ad Acquarella (Montecerboli) per la li-gnite (negli anni 1916-1917), a Monterufoli per i calcedoni scavati dall’Opificio granducale delle Pietre dure (metà ‘500-metà ‘800), nel fosso Linari per i minerali cupriferi (metà ‘800). La vicenda ot-tocentesca di de Larderel portò un’iniezione di nuova vita nella comunità di Pomarance come testimoniano ancora oggi alcuni palazzi dentro il centro urbano fra i quali il teatro. Oltre a questi sono sopravvissute due porte medievali, alcuni torrioni cilindrici ed il Palazzo Pretorio munito del marzocco fiorentino (cfr. MARRUC-CI-NANNONI 2003, 58-66).
72. Pomarance
Matrice F5
Argomento Insediamenti/Paesi
Età XVI-XIX secolo
Latitudine 43.175857 (piazza)
Longitudine 10.522535
Distanza da… Radicondoli, 18,7 km in linea d’aria in direzione O
Matrice F5
Argomento Insediamenti/Paesi
Età XVI-XIX secolo
Latitudine 43.153823 (piazza Matteotti)
Longitudine 11.023229
Distanza da… Belforte, 3,6 km (in linea d’aria)
77 7772 73
148 149
la_guida_radicondoli.indd 148-149 01/09/14 12:19
75. Centrali geotermiche
Matrice N6
Argomento Industria
Età Contemporanea
Latitudine 43.123784
Longitudine 11.015181
Distanza da… Radicondoli, 8 km in linea d’aria, in direzione S
Visibilità
La viabilità odierna – definita nel XIX secolo – si scorge soprat-tutto dai PP 2, 3 e 5.
Descrizione
Le pendici nord-occidentali del Poggio Casalone accolgono un tratto della Strada Provinciale delle Galleraie che, assecon-dando le due curve di livello dei 375 e 400 metri di altitudine, compie un lungo e tortuoso giro intorno alla stretta valle dove nasce il fosso Vetrialla, per poi transitare di fronte al castello di Radicondoli a una distanza di circa 2 km. Il tracciato di que-sta SP ha origini antiche, come lascia intuire il suo andamento tortuoso, essendo stata progettata e realizzata in età lorene-se, nel secolo XVIII, su alcuni preesistenti tratti e tracciati. È più pertinente parlare di «area di strada» quando si cercano le origini della viabilità che interessa il crinale che divide Val d’Elsa, Val di Cecina e Val di Merse; ovvero quando si esami-na la serie di colline che uniscono gli abitati di Monteguidi e Mensano a Radicondoli, Belforte, Travale e Montieri. Lungo questo crinale, infatti, la sede della viabilità è cambiata molto nel corso dei secoli XVI-XIX. Già sotto Pietro Leopoldo, alla fine del ‘700, fu preparato dai tecnici-funzionari granducali un progetto che aveva l’obiettivo di collegare Colle di Val d’El-sa – fiorente centro manifatturiero della carta e del vetro – a Follonica, destinata a diventare, sotto Leopoldo II, il centro si-derurgico più importante della regione. Questo collegamento fra il bacino dell’Elsa e la costa tirrenica prevedeva lo sviluppo di una dorsale di transito orientata E-O molto complessa per via di una morfologia collinare che non agevolava tale colle-gamento. Intorno a metà ‘800 la Strada progettata poté es-sere realizzata unendo i capitali privati e pubblici. L’obiettivo era quello di valorizzare le risorse economiche, agricole ed estrattive di questa porzione del territorio regionale rimasta sempre appartata rispetto alla costa e alle zone ‘metropolita-ne’ dislocate lungo il fiume Arno.
74. Viabilità ottocentesca
Matrice E5
Argomento Viabilità
Età XVI-XIX secolo
Latitudine 43.155828 (loc. Fabbrica)
Longitudine 11.034665
Distanza da…Radicondoli, 1,7 km in linea d’aria (loc. Fabbrica), direzione E
Visibilità
Le emissioni geotermiche delle centrali sono visibili dai PP 5 e 10. Può capitare che d’estate, complice una temperatura più alta, non sia possibile avvistare i pennacchi di vapore acqueo.
Descrizione
Nel 1860 nella zona di Travale venne ad operare la «Società Travalese», che impiantò un piccolo stabilimento per la pro-duzione dell’acido borico. Ma solo in tempi recenti l’impianto venne ampliato. Dopo il secondo conflitto mondiale, grazie a varie esperienze precedenti, allo sviluppo degli impianti ge-oelettrici di Larderello e agli studi degli anni Trenta, poterono essere raggiunte maggiori profondità nelle perforazioni, riu-scendo così ad attingere ai grandi serbatoi di vapore naturale che hanno permesso, negli anni Settanta, di impostare nella zona delle Galleraie un piano di produzione elettrica di alcune centinaia di Megawatt. Attualmente, la centrale geotermica di Radicondoli raggiunge con i suoi pozzi i 60 MW di potenza installata. L’impianto produce oltre 140 milioni di kWh di ener-gia elettrica ‘verde’ e sostenibile, cioè a dire che impiega ri-sorse naturali riproducibili. Tale produzione viene utilizzata da oltre 55 mila famiglie. La Centrale Geotermica consente un risparmio di CO2 che si aggira sulle 200 mila tonnellate, men-tre il risparmio in termini di combustibili fossili si aggira intor-no alle 55 mila TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) all’anno (cfr. MARRUCCI 2000A, 89-136; MARRUCCI 2000B, 53-96; MARRUCCI-NANNONI 2003, 11-12).
Per approfondire
Notizie. Il sistema di produzione dell’energia geotermica è illu-strato, attraverso pannelli esplicativi, a Radicondoli presso il Mu-seo delle Energie del Territorio, situato in via T. Gazzei, 2.
7774 75
150 151
la_guida_radicondoli.indd 150-151 01/09/14 12:19
Visibilità
Il reperto si riferisce geograficamente all’area di Larderello. E’ visibile dai PP 5 e 9, mentre risulta fra quelli nascosti nei PP 1, 8 e 10.
Descrizione
Nel 1777 la scoperta dell’acido borico da parte di Uberto Ho-fer, chimico granducale e medico personale di Pietro Leopol-do, avvenuta presso Monterotondo Marittimo, in un lagone ancora oggi visitabile, segna il momento di avvio dell’industria geotermica. L’acido borico era usato come fondente nei pro-cessi di saldatura e come componente indispensabile nell’in-dustria della porcellana. La relativa facilità di estrazione permi-se di rinunciare all’importazione del borace proveniente dalla Cina e dal Tibet, noto come tinkal. Fu questo l’inizio della gran-de avventura destinata a cambiare il volto di un intero terri-torio. Nel 1817 l’industriale francese Francesco De Larderell iniziò a sfruttare la presenza nell’area di Larderello del campo geotermico (che si manifestava con putizze, mofete, emis-sioni, lagoni e sorgenti termali) per la produzione dell’acido borico. Poi, nel 1914, il principe Pietro Ginori Conti, cognato di un discendente di De Larderel, ebbe il geniale intuito di sfrut-tare la forza dei vapori per la produzione di energia elettrica. Larderello cominciò a diventare quello che è oggi, ovvero la “capitale mondiale della geotermia”. Sotto Larderello, a cir-ca 5 chilometri di profondità ma con il tetto che arriva a soli 600-700 metri sotto i nostri piedi si trova una massa di granito semifusa, dell’età di circa 3 milioni di anni, di forma simile ad un cilindro lungo circa 20 km per 15 di diametro, che ha una temperatura di circa 600°C. Questa enorme massa riscalda le acque ipogee costringendole ad un circuito convettivo che raggiunge una profondità massima di circa 4 km. Con il contributo di una sorta di tetto o ‘cappello’ costituito da uno strato di argille impermeabili, la massa cilindrica surriscaldata trasforma le acque ipogee in vapore che rimane sigillato nelle cavità rocciose. Quando i pozzi perforano il cappello il vapore esce a gran forza e per rendere questa forza visibile a tutti
77. La nascita della geotermia
Visibilità
La fattoria di Anqua è situata alla partenza del Percorso 6, alle spalle del PP 12, e quindi visibile anche dal PP 13. Tuttavia è stata inserita fra i reperti nascosti perché la sua veste ar-chitettonica rimanda alla storia del borgo e si integra con le Schede nn. 63 e 64.
Descrizione
La fattoria di Anqua è ancor oggi di proprietà della famiglia dei Pannocchieschi di Elci. La fattoria assunse importanza alla fine del ‘500, nel clima di generale trasformazione dei siti fortificati rurali e delle «case da signore» quattrocentesche in centri aziendali e produttivi, nonché in residenze di lusso, se-condo un percorso di valorizzazione caratteristico di buona parte della Toscana collinare interna. Posta al confine di tre province, immersa tra verdi oliveti e con una vasta foresta che la circonda da tre lati, la Fattoria di Anqua è oggi un’a-zienda moderna, dotata di un territorio di circa 910 ettari dove si producono vino, olio e cereali soprattutto. L’allevamento, oltre all’agricoltura e alla gestione forestale, è il terzo settore di lavoro della fattoria. Vi si allevano suini della specie tipica locale detta «cinta senese», ed equini. La Fattoria di Anqua è anche una residenza agrituristica di alto livello, potendo offrire alla sua clientela un’accoglienza particolare grazie alla disposizione di immobili di alto pregio storico e architettonico, immersi in un paesaggio rurale poco interessato dagli stra-volgimenti dell’agricoltura meccanizzata. L’isolamento e la collocazione paesistica su di un naturale terrazzo che domina un vasto territorio infine ne accentuano considerevolmente il fascino.
Per approfondire
Notizie. Alle spalle della Villa si trova la valle del torrente Rimaggio conosciuta localmente come “valle dell’aeroplano”. La tradizione vuole che nel corso del secondo conflitto mondiale nella valle pre-cipitasse un aereo da caccia i cui resti sarebbero sempre sparsi nel bosco, presso il luogo dell’impatto.
76. Fattoria di Anqua oggi
Matrice I6
Argomento Economia del bosco/Pastorizia
Età Contemporanea
Latitudine 43.124817 (punto panoramico)
Longitudine 10.590504
Distanza da… Radicondoli, 7 km in direzione SO
Matrice N6
Argomento Industria
Età Contemporanea
Latitudine 43.123784
Longitudine 11.015181
Distanza da…Radicondoli, 5 km in linea d’aria (centrale Galle-raie), in direzione S, Larderello
7776 77
152 153
la_guida_radicondoli.indd 152-153 01/09/14 12:19
Visibilità
Nel territorio di Radicondoli la zona interessata dalla transu-manza storica è quella posta a NO, ovvero verso il confine con la comunità di Casole d’Elsa, in prossimità dei centri di Monteguidi (Scheda 50) e Mensano (Schede 44, 45). Questa zona è visibile dai PP 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9.
Descrizione
Il trasferimento stagionale del bestiame, composto in pre-valenza da pecore, ma comprendente anche asini, cavalli e bovini, in terreni più ospitali è una pratica molto antica, già in uso nel periodo etrusco, che si protrasse poi lungo il volge-re dei secoli, terminando, almeno per ciò che riguarda quello in larga scala, solo con l’appoderamento seguito alla riforma fondiaria degli anni Cinquanta del Novecento e con l’avvento dei mezzi motorizzati. Tipico di molte zone d’Italia, in Tosca-na questo spostamento di animali e persone ha assunto nel tempo proporzioni quasi bibliche, giungendo a interessare in alcuni periodi centinaia di migliaia di capi di bestiame, che per sfuggire ai rigori e alla scarsezza di erbaggi dell’inverno montano, venivano portati in zone più temperate e ricche di pascoli. Si tratta di un’attività che ha sempre avuto la fisiono-mia di «impresa privata» a carattere speculativo, la quale nei secoli ha coinvolto feudatari, conti, grandi istituzioni religiose e tutti i soggetti in grado di anticipare gli ingenti capitali che era necessario investire per spostare verso il mare (d’inver-no) e verso la montagna (d’estate) grandi masse di armenti. Le istituzioni, prima i liberi Comuni, poi le Città, le Signorie e in-fine i Principati, non persero l’occasione di trasformare quello che un tempo era l’originario diritto collettivo delle Comunità in un patrimonio demaniale, con lo scopo di fornire – con le tasse di transito – un grosso cespite di entrata per le finanze pubbliche. In Toscana questo processo di demanializzazio-ne interessò le due aree geografiche marginali della regione: l’Appennino, da un lato, e la fascia costiera dalla foce del fiu-me Serchio a quella del Fiora, dall’altro. La nascita, a metà del 1500, della realtà politico-territoriale del Granducato Mediceo
78. Pastorizia e transumanza
Matrice I6
Argomento Economia del bosco / Pastorizia
Età Contemporanea
Latitudine 43.164087 (pod. Materno)
Longitudine 11.004528
Distanza da…Radicondoli, 3 km in linea d’aria (loc. Materno) in direzione O/NO
presso il Museo della Geotermia è stato allestito un soffione che viene aperto ai turisti in visita al Museo. Si tratta di un son-daggio profondo circa 740 metri, con una portata di 20 ton-nellate l’ora di vapore, una temperatura di uscita dello stesso di circa 220°C, una pressione di 5 bar e una velocità di uscita di 400 metri al secondo. Il rumore, certamente l’aspetto più impressionante per i turisti, è di circa 130 dB paragonabile ad un jet in decollo. Attualmente l’area interessata dalle perfo-razioni si estende per alcune centinaia di chilometri quadrati sommando circa 180 pozzi produttivi d cui una buona parte si spinge fino a profondità di 3-4.000 metri, per cercare vapori a più alte pressioni e a temperature più elevate. Ai pozzi di perforazione vanno sommati quelli di reinezione attraverso i quali si reintroduce vapore esausto per ricaricare le camere ipogee giacché la maggior parte del vapore deriva da acqua meteoriche. Uno dei grossi bacini di ricarica è infatti costituito dal complesso calcareo delle Cornate di Gerfalco e del Pog-gio Mutti (MARRUCCI-NANNONI 2003, 67-72).
Per approfondire
La ricerca geologica. Nella zona di Larderello, dove l’estrazione del vapore avviene da più tempo, le ricerche geologiche, geofisi-che, geomagnetiche e chimiche del territorio hanno permesso di accumulare una massa impressionante di notizie sul sottosuolo. Ad esempio, indagini isotopiche hanno messo in risalto che il Tri-zio (un isotopo dell’idrogeno) è presente nel vapore in quantità trascurabili. L’assenza di questo elemento, che è presente invece maggiormente nelle acque meteoriche della terra a partire dalle esplosioni nucleari degli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, indica, che il vapore oggi estratto ha un’età di almeno 50 anni e che le con-nesse circolazioni idrologiche si svolgono su tempi molto lunghi.
7777 78
154 155
la_guida_radicondoli.indd 154-155 01/09/14 12:19
AndriolA l., MAnente M. (2000), Turismo durevole e sviluppo sostenibile: il quadro di riferimen-to italiano, Roma ENEA.
AA.VV., (2000), Alle sorgenti del Cecina. Nascita ed evoluzione del reticolo torrentizio e fluviale del fiume Cecina, in Dalla parte del fiume, a cura di B. Piccolini, Pontedera.
AA.VV., (1993), La storia natu-rale della Toscana meridionale, Cinisello Balsamo, Monte dei Paschi di Siena.
AA.VV., (1986), La Toscana vola-ndo, Firenze , Sansoni.
BAlestrAcci d., (2007), Breve storia di San Gimignano, Pisa, Pacini.
BArsAnti d., (1987), Allevamen-to e transumanza in Toscana, Firenze, Ed. Medicea.
Bini M. (a cura di) (2011), Il paes-aggio costruito della campagna toscana, Firenze, Alinea.
BiAnchi s., GennAi P., BAGGiAni d., MAnfredi A. (2008), Volterra Ma-ter A piedi e in bici per le pievi dell’antica diocesi, Montesper-toli, MIR Edizioni, 2008.
BiMonte s., Punzo l. (a cura di) (2003), Turismo, sviluppo eco-nomico e sostenibilità: teoria e pratica, Siena, Protagon.
Bonelli conellA l., Brilli A., cAn-telli G. (a cura di) (2004), Il paes-aggio toscano. L’opera dell’uo-mo e la nascita di un mito, Siena, Cinisello Balsamo, Monte dei Paschi di Siena - Silvana Editori-ale
cAciAGli G. (2001), La provincia di Pisa Da Bientina a Casteln-uovo Val di Cecina, Pisa, Arnera Edizioni.
Bibliografia
cAMedieri P. (2006), Educazione al paesaggio e sostenibilità, in “Spazio ambiente” (Rivista delCridea-Umbria) XI.
cAMMArosAno P., PAsseri V., (1984), Città borghi e castelli dell’area senese-grossetana. Repertorio delle strutture fortificate dal me-dioevo alla caduta della Repub-blica senese, Siena, Amminis-trazione Provinciale di Siena.
cAMPoresi P. (1993), Le belle con-trade. Nascita del paesaggio ital-iano, Milano, Garzanti.
cAnestrelli A. (1993 rist. an.), L’abbazia di San Galgano, Firen-ze, Barbera.
cAstiGlioni G.B. (1985), Geomorf-ologia, Torino, Utet.
cAstiGlioni G.B. (2003), L’ l’ed-ucazione al paesaggio per comunicare con il mondo, in G. cAlAfiore, G. PAlAGiA-no, G. PArAtore (a cura di), Atti del XX-VIII congresso geografico italiano (Roma, 18-22 giugno 2000), II, Roma, Edigeo, pp. 2278-2289.
cortese M.e., (1997), L’acqua, il grano, il ferro. Opifici idraulici me-dievali nel bacino Farma-Merse, Firenze, All’Insegna del Giglio.
cucini c. (1990), Radicondoli: Storia e Archeologia di un Co-mune senese, Roma, Multigrafi-ca Editrice.
dell’oModArMe o., (1996), Le Dogane di Siena, di Roma e di Foggia., Un raffronto dei sistemi di “governo” della transuman-za in età moderna, in “Ricerche Storiche” , XXVI, pp. 259-303.
deMetrio d. (2005), Filosofia del camminare. Esercizi di med-itazione mediterranea, Milano, Raffaello Cortina Editore.eco
consentì la diminuzione e la redistribuzione del controllo fisca-le dei flussi armentizi e, contemporaneamente, la regolamen-tazione dei percorsi che le greggi utilizzavano per spostarsi, specialmente nella zona di attraversamento delle colline più interne della Toscana, già strutturate a mezzadria. Le impre-se armentizie – dette «masserie» – organizzavano lo spo-stamento di grandi greggi lungo percorsi di centinaia di chi-lometri al comando di pastori professionisti (detti «vergari»), che riversavano in Maremma, ogni anno, decine di migliaia di capi di bestiame, secondo un calendario strettamente rego-lamentato. I percorsi erano precisi. Infatti, diversamente dalla transumanza praticata nell’area pugliese e abruzzese, in To-scana le strade preposte allo spostamento delle greggi erano per lo più le stesse su cui si svolgeva il traffico quotidiano delle merci. Per raggiungere, quindi, dai pascoli appenninici la Ma-remma, i pastori utilizzavano in molti punti la viabilità ordinaria, non mancando di allontanarsene laddove la morfologia del territorio permetteva tragitti più brevi, rimanendo peraltro ob-bligati a confluire presso punti di controllo dediti alla conta del bestiame e al pagamento di una tassa, detta «fida». Luogo di arrivo, dunque, e di stazionamento per decine di migliaia di capi ovini (ma anche porcini, bufalini e cavallini) la Marem-ma offriva alle greggi un vastissimo territorio dove svernare, quando i pascoli appenninici erano inutilizzabili per motivi cli-matici. Su questa viabilità pastorale si muovevano non solo pastori e greggi ma anche un variopinto mondo fatto di lavo-ratori stagionali provenienti dall’Appennino, che cercavano di integrare così le magre risorse che la montagna offriva loro con prestazioni di servizio ai pastori e alle masserie. Assieme ai boscaioli, carbonai, mietitori e sterratori, tanti altri soggetti, spesso operanti al confine della legalità, si recavano in Ma-remma al seguito delle greggi, contribuendo alle difficoltà or-ganizzative e di ordine pubblico che si avevano durante le fasi di transito del bestiame. Anche Radicondoli e le sue strade rurali, quindi, erano mèta di questo mondo seminomade di impronta pastorale, che in due momenti dell’anno, all’andata in autunno e in primavera al ritorno, entrava in contatto con il mondo sedentarizzato dei contadini e dei mezzadri, cau-sando interazioni e scambi sociali di vario tipo, non sempre pacifici. Una parte degli itineranti costituiva, infatti, un sotto-bosco ambiguo di figure al seguito dei pastori dalla presenza talvolta inquietante, che incuteva timore alle popolazioni rurali in occasione del loro passaggio e dell’alloggio nelle osterie e nelle taverne locali. (BARSANTI 1987; DELL’OMODARME 1996, 259-303; GENNAI 2005, 145-162; MARCACCINI-CAL-ZOLAI 2003).
78
156 157156
la_guida_radicondoli.indd 156-157 01/09/14 12:19
sierrA P. (2011), La géographie: concepts, savoirs er en-seigne-ments, Paris, Armand Colin 2011.
solnit r. (2000), Storia del cam-minare, Milano, Bruno Mon-dadori 2005.
teofili c., clArino r. (a cura di) (2008), Riconquistare il paesag-gio. La Convenzione Europea del Paesaggio e la Conservazi-one della Biodiversità in Italia, Roma, WWF Italia – MIUR.
tosco c. (2009), Il paesaggio storico. Le fonti e i metodi di ricerca, Roma-Bari, Editori Lat-erza.
turri e. (2001), Il paesaggio come teatro. Dal territorio vis-suto al territorio rappresentato, Venezia, Marsilio.
turri e. (2008), Antropologia del paesaggio, Venezia, Marsilio.
VittA M. (2005), Il paesaggio. Una storia fra natura e architet-tura, Torino, Einaudi.
VolPe G., (1962), Volterra medi-evale. Massa Marittima, Volterra, Sarzana, Firenze, Sansoni.
u. (1975), Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani 2005.
fiuMi e., (1968), I confini della dicesi ecclesiastica del municip-io romano e dello stato etrusco di Volterra, Firenze, Olschki.
frAti M. (1996), Chiese medi-evali della Val d’Elsa I territori della via Francigena. Tra Siena e San Gimignano, Empoli, Editori dell’Acero.
GennAi P., (2004), Per una storia del bosco Berignone-Tatti. Ap-punti per una ricerca interdisci-plinare, in “Ricerche Storiche”, XXXIV, pp. 53-63.
GennAi P., (2005) Bandite, pascoli e miniere a Roccastra-da. Cenni di economia rurale e strutture di un territorio delle Colline Metallifere tra XVI e XIX secolo, in Roccastrada e il suo territorio – Insediamenti, arte, storia, economia, Banca Credito Cooperativo di Sovicille, Firenze, pp. 145-162.
GennAi P., (2013) (in corso di stampa) La siderurgia nel territo-rio di Monticano fra età mediev-ale e moderna (secc. XIII-XVIII), in AA.VV. Atti della Giornata di Stu-di, Comune di Monticiano.
GennAi P., BAGGiAni d., lAndi s. (2004), Toscana ignota. Il senso di un territorio in 64 escursioni, Montespertoli, MIR Edizioni.
GinAteMPo M., (1994), Il popol-amento del territorio volter-rano nel basso Medioevo, in “Rassegna Volterrana”, LXX, pp. 19-73.
JAkoB M. (2009), Il paesaggio, Bologna, Il Mulino.
lAnzA A. (2006), Lo sviluppo sostenibile, Bologna, Il Mulino.
lAzzAretto A. (1993), Elementi di geologia, in La storia natu-rale della Toscana meridionale, Cinisello Balsamo, Monte dei Paschi di Siena, pp. 89-136.
Marcaccini P., Calzolai L., (2003),
I percorsi della transumanza in Toscana, Firenze, Polistampa.
MArrone G. (2001), Corpi sociali, Torino, Einaudi.
MArrucci A. (2000-A), Geologia della Val di Cecina, in Ritratto di una valle, a cura di B. Piccolini, Pontedera, pp. 89-136.
MArrucci A. (2000-B), Idrologia della Val di Cecina: fonti, moje, sorgenti calde, in Dalla parte del fiume, a cura di B. Piccolini, Pont-edera, pp. 53-96.
MArucci A., nAnnoni r. (2003) Tesori sepolti. Guida la patrimo-nio minerario e mineralogico del territorio della Comunità Mon-tana dell’alta Val di Cecina, Pisa, Pacini.
MArrucci A., trinciArelli V. (1990), Le rocce del volterrano, Ponted-era, Consorzio Gestione Museo e Biblioteca Guarnacci.
MeschiAri M. (2008) Sistemi sel-vaggi. Antropologia del paesag-gio scritto, Palermo, Sellerio.
MeschiAri M. (2010), Terra sapi-ens. Antropologie del paesag-gio, Palermo, Selle-rio.
nArdi e. (2004), Musei e pubbli-co. Un rapporto educativo, Mi-lano, FrancoAngeli.
PAndAkoVic d., dAl sAsso A. (2009), Saper vedere il paesag-gio, Biella, Città Studi.
PArdi f. (2001), L’osservazione geomorfologica del paesaggio, in Magnaghi A., Rappresentare i luoghi. Metodi e tecniche, Firen-ze Alinea, pp. 1-75.
rosArio A. (2006), Il paesaggio e l’estetica, Palermo, Novecento.
roMei P. (a cura di) (2009), Turi-mo sostenibile e sviluppo locale, Padova, Cedam.
rotundo f., frAncAlAcci P. (1999), Radicondoli e il suo territorio. Paesaggio e itinerari culturali (introduzione di Mariella Zoppi), Siena, Nuova Immagine Editrice.
158 159
la_guida_radicondoli.indd 158-159 01/09/14 12:19
Indice delle Schede di approfondimento
Le schede sono presentate raggruppate secondo la crono-logia storica cui appartengono e, secondariamente, per ordi-ne alfabetico.
1. Alta Valle del Fosso Vetrialla
2. Archeologia paleolitica a Materno
3. Conglomerati
4. Cornate di Gerfalco e Poggio Ritrovoli
5. Emissioni geotermiche
6. Fiume Cecina
7. Foresta del Berignone e Monte Soldano
8. Fosso Lucignano
9. Geomorfologia Anqua
10. Geomorfologia Belforte
11. Geomorfologia Casettino
12. Geomorfologia Colombaione
13. Geomorfologia Lucignano
14. Geomorfologia Tesoro
15. Gradino tettonico di Coiolo / Materno
16. Fosso Quarantola
17. Fossi Vetrialla e Sala
18. Gola del Cecina
19. Insediamenti a Coiolo e Materno
20. Linee di faglia
21. Litologia detritica
22. Monte Amiata
23. Montecalvaiano
24. Piani di Feccia e del Merse
25. Paleocorso del Cecina
26. Poggio di Montieri
27. Poggio Casalone
28. Valle del Cecina
64
65
66
67
69
71
73
74
75
76
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
96
98
ETÀ I ERA/PREISTORIA
161
la_guida_radicondoli.indd 160-161 01/09/14 12:19
63. Anqua: l’architettura
64. Anqua: il borgo
65. Belforte rinascimentale
66. Radicondoli rinascimentale
67. Radicondoli: via Gazzei rinascimentale
68. Villa di Olli rinascimentale
69. Transumanza nell’Ottocento
70. Convento dell’ Osservanza nel ‘600
71. La mezzadria
72. Pomarance
73. Radicondoli: via Gazzei nell’Ottocento
74. Viabilità ottocentesca
75. Centrali geotermiche
76. Fattoria di Anqua oggi
77. La nascita della geotermia
78. Pastorizia e transumanza
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
ETÀ IV. RINASCIMENTO
ETÀ V. XVIII-XIX SECOLO
ETÀ VI. CONTEMPORANEA
35. Belforte medievale
36. Casole d’Elsa
37. Casole d’Elsa: l’architettura
38. Castello di Falsini
39. Castello di Elci
40. Chiusdino
41. Il Convento dell’Osservanza nel Medioevo
42. La Fattoria di Tegoni
43. Insediamenti sui Poggi Scapernata e Rantìa
44. Mensano
45. Architettura a Mensano: borgo e Pieve di San
Giovanni
46. Miniere di argento
47. Il monastero cistercense di San Galgano
48. Montecastelli Pisano
49. Montecastelli: l’architettura
50. Monteguidi
51. Monticiano
52. Montingegnoli
53. La Pieve Vecchia di Radicondoli
54. Radicondoli medievale
55. Radicondoli: via Gazzei nel Medioevo
56. San Gimignano
57. Castello di Montalbano
58. Chiesa di San Lorenzo a Montalbano
59. Rocca di Sillano
60. Travale
61. Viabilità mineraria nel Medioevo
62. Volterra medievale
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
130
132
133
134
136
137
138
ETÀ II. ETRUSCO/ROMANA
ETÀ III. MEDIOEVO
29. Abitato etrusco di Gatteresi
30. Insediamento romano
31. Podere Bucignano
32. Tombe etrusche del Colombaione
33. Viabilità romana
34. Volterra etrusca
99
100
102
103
104
105
162 163
la_guida_radicondoli.indd 162-163 01/09/14 12:19
Indice delle Schede per argomento
Argomento Scheda/reperto
ITINERARIO/Punto Panoramico
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ge
om
orf
olo
gia
4 Cornate e Poggio Ritrovoli
9 Geomorfologia Anqua
10 Geomorfologia Belforte
11 Geomorfologia Casettino
12 Geomorfologia Colombaione
13 Geomorfologia Lucignano
14 Geomorfologia Tesoro
20 Linee di faglia
21 Litologia detritica
24 Piani di Feccia e del Merse
25 Paleocorso del Cecina
26 Poggio di Montieri
Geologia
3 Conglomerati
5 Emissioni geotermiche
15 Gradino Coiolo/Materno
18 Gola del Cecina
22 Monte Amiata
Idrografia
1 Alta valle del Fosso Vetrialla
6 Fiume Cecina
8 Fosso Lucignano
16 Fosso Quarantola
17 Fossi Vetrialla e Sala
28 Valle del Cecina
Natura7 Foresta Berignone e Soldano
27 Poggio Casalone
Viabilità
33 Viabilità romana
61 Viabilità mineraria medioevo
74 Viabilità Ottocentesca
Insedia-menti/
Paesi
19 Insediamenti a Coiolo Materno
23 Montecalvaiano
29 Insediamento romano
32 Tombe etrusche Colombaione
34 Volterra etrusca
35 Belforte medevale
36 Casole d’Elsa
40 Chiusdino
43 Insediam. Scapernata e Rantìa
Argomento Scheda/reperto
ITINERARIO/Punto Panoramico
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inse
dia
me
nti/
Pa
esi
44 Mensano
48 Montecastelli pisano
49 Montecastelli: l’architettura
50 Monteguidi
51 Monticiano
52 Montingegnoli
54 Radicondoli medievale
56 San Gimignano
60 Travale
62 Volterra medievale
64 Anqua: il borgo
72 Pomarance
73 Radicondoli: via Gazzei ‘800
Arc
hite
ttu
ra
37 Casole d’Elsa
38 Castello di Falsini
39 Castello di Elci
41 Convento Osservanza med.
45 Mensano: borgo e pieve
47 Il monastero di S. Galgano
53 Pieve Vecchia di Radicondoli
55 Radicondoli: via Gazzei med.
58 S. Lorenzo a Montalbano
59 Rocca di Sillano
63 Anqua: l’architettura
65 Belforte rinascimentale
66 Radicondoli rinascimentale
67 Radicondoli: Gazzei rinasc.
68 Villa di Olli rinascimentale
70 Convento Osservanza ’600
Re
sti/
Ru
de
ri
2 Archeologia paleolitica Materno
29 Abitato etrusco di Gatteresi
31 Podere Bucignano
57 Castello di Montalbano
65 Belforte rinascimentale
Bosco/Pastorizia
69 Transumanza nell’Ottocento
76 Fattoria di Anqua oggi
78 Pastorizia e transumanza
Agricoltura42 La fattoria di Tegòni
71 La mezzadria
Metallurgia 46 Miniere di Argento
Industria75 Centrali geotermiche
77 La nascita della geotermia
reperto visibile reperto nascosto
la_guida_radicondoli.indd 164-165 01/09/14 12:19
Indice dei luoghi
A Abbadia San Salvatore: 90.Aia dei Diavoli: 135.Albegna (fiume): 90.Amiata (monte): 17; 50; 89-90;
95; 135.Anqua (fattoria e borgo): 9; 14;
19; 56; 68; 72; 75; 81-82; 94; 98; 133; 139-140; 148; 152.
Appennino: 72; 89; 135; 145; 155.
Arno (fiume): 71; 98; 150.Arno (vallata/valle/bacino): 72;
98; 105; 141.Auzzo (poggio): 132.
BBadia a Conèo: 145.Baldi Luigi (via): 24.Basilico (podere): 38.Becucci (piazza): 14-15; 18; 24;
44.
Belforte: 9; 14; 15; 19; 32-33; 50-51; 67; 71; 75-78; 80; 83; 85; 89-90; 92; 94; 106-107; 110; 123; 128-129; 141-142; 150.
Berio Luciano (viale): 32.Bolli le: 96-97. Bottone (podere): 44.Brutamèlo (podere): 75.Bucignano: 102; 119; 121; 132;
137.
CCalvaiano (poggio di): 64; 84-85;
91.Campane (via delle): 50.Campo alle Rose: 68.Canterie (podere): 24-25.Cappella dell’Avveduta: 72; 119.Carnevale (poggio): 101.Casalone (poggio): 33; 64; 75-
76; 78; 96; 110; 150.Casa Nuova (podere): 38; 79.Casettino (podere): 14-15; 24;
25; 78; 100; 104.Casettone (podere): 24-25.Casina la (podere): 44.Casino di Terra: 71; 98.Casole d’Elsa: 12; 44-45; 56; 64;
73; 96; 108-109; 130; 145; 155.Casone (podere): 32-33; 80; 97;
116; 132; 145.Castelfiorentino: 131.Castelletto: 101.Castelnuovo Val di Cecina: 38;
70; 82; 85; 119; 121.Cecina (fiume): 10-11; 18; 32; 38-
39; 44; 56; 65; 67; 71-72; 74; 79; 81-87; 93; 96-98; 100-101; 103-104; 111; 114-115; 119; 128; 134-137; 145; 148.
Cecina (vallata/valle/bacino): 71; 73; 75; 94; 96; 98; 101-102; 119; 137-138; 140; 150.
Cerbaia: 97.Cerniano (fosso): 45; 78; 81; 100.Cerniano (podere): 97.Certaldo: 131.Chianti: 135.Chiusdino: 90; 95; 112; 120.Cina: 153.Clairvaux (abbazia): 120.Colle (podere): 97; 145.
167
1 L’indice non considera i topo-nimi riportati sulle matrici del paesaggio e non prende in con-siderazione Radicondoli giac-ché questo è presente in quasi ogni pagina. L’indice distingue invece fra fiume e vallata dello stesso corso d’acqua riportan-do per ognuno: la pagina in cui tale toponimo è presente con quel significato (ad es.: Cecina fiume; Cecina valle/bacino/val-lata). Lo stesso vale per il nome riferito a un poggio/monte/pro-montorio oppure a una località (Montieri poggio; Montieri pae-se). Sono indicati anche i nomi di chiese/palazzi/ville isolati che hanno funzione di località. Non si elencano invece i toponimi in-seriti nel tessuto urbano del pa-ese (ad es.: Palazzo Bizzarrini). Quando fra un numero e quello successivo è riportato il trattino (-) si intendono tutte le pagine comprese fra quelle due citate; quando è presente il punto e virgola (;) ci si riferisce alle sole pagine esplicitamente ricordate.
la_guida_radicondoli.indd 166-167 01/09/14 12:19
Montalcinello: 101.Montalcino: 90.Montecalvaiano: 91.Montecalvoli: 91.Montecastelli Pisano: 39; 44;
102; 121-122; 135.Montecatini Val di Cecina: 71;
122.Monteguidi: 10; 12; 24-25; 44-
45; 71-72; 82; 84; 91; 98; 104; 123; 150; 155.
Montemaggiori (podere): 18; 38-39; 79; 88.
Monterotondo Marittimo: 69; 153.
Montescalocchi: 74; 113.Montesiepi: 106; 120.Monteverdi Marittimo: 121.Monticiano: 124.Montieri: 95; 145; 150.Montieri (poggio): 50; 67; 70; 76;
94-96; 98; 112; 135-136.Montingegnoli: 32; 71; 75; 77; 85;
125.Moro (via del): 50.Mugello: 72; 82; 98.Mutti (poggio): 67-68; 70; 119;
137; 154.
NNiccioli (podere): 96.Niccoli (podere): 145.Novo (podere): 92
OOlla (porta): 32; 33; 129.Olli (tenuta/villa): 39; 144.Olmo (via dell’): 15; 50-51.Ombrone grossetano (fiume):
71; 98.Orcia (fiume): 90.Osservanza (convento dell’):
32-33; 113; 146.
PPaglia (fiume): 90.Palazzone: 110.Pagliaia (podere): 96-97; 145.Papena (podere): 92.Pasterucci (podere): 145.Paurano: 145.Pavone (fiume): 56; 68; 71; 75;
121-122; 132; 135.Pavone (valle): 102; 119; 122;
137-138.Pentolina: 92.Peri le: 97.
Colle di Val d’Elsa: 92; 96-97; 108; 116; 131; 145; 150.
Colline Metallifere: 7; 67-72; 77; 86; 94-95; 98; 11-112; 121; 135-137; 141; 145; 148.
Colombaia (podere): 44-45.Colombaione (podere): 14; 38-
39; 79; 103.Colonna (strada della): 56.Cornate di Gerfalco: 10; 67-68;
70-71; 75-76; 82; 94-95; 98; 119; 135-137; 145; 154.
Cornocchia (fattoria): 51; 144.Costaglie (podere delle): 74; 83;
93.Crete senesi: 7.Croci (podere): 56-57.
DDomenico San (podere): 45.
EElci (ruderi castello): 82; 111; 119;
137.Elsa (fiume): 96; 130.Elsa (vallata/valle/bacino): 73;
96; 105; 130; 145; 150.Elsa molino d’: 145.Etruria: 65; 105.
FFalsini: 32-33; 51; 80; 107; 110-11.Fantacci: 83; 93.Farma (fiume): 92; 124.Farma (vallata/valle/bacino): 90;
96; 124.Feccia (torrente): 76-77; 92; 107;
124.Feccia (vallata/valle/bacino): 98;
101; 112.Ferri Dina (via): 15; 50.Filicaia (podere): 81; 145.Fiora (fiume): 90; 155.Firenze: 131; 138.Fiumarello (fosso): 77.Fodera (fosso): 74; 83; 93; 114-
115.Follonica: 150.Fonte la (podere): 44-45; 81.Fontina (del Trabocco): 24.Foreste (fosso): 75.Fosci (torrente): 73.Fosini (castello): 67-68.Fossanova (abbazia): 120.Francia: 131.Frassini: 92; 101.Frati (podere dei): 97.
Piancastagnaio: 90.Piani di Coiolo e Materno: 10; 39;
65; 72; 74; 80-86; 93; 98-99; 119; 137.
Piani di Papena: 92.Piani di Spagna: 92.Piano del Bufalaio: 95.Piano di Feccia: 50; 92; 112; 124.Piano del Merse: 92; 124.Piano dei Mucini: 145.Piano di Nebbiano: 95.Pierino San (podere): 84; 88.Pieve Vecchia: 24; 32; 104; 126-
127.Pieve a Conèo: 106.Pisa: 68; 85; 117-118; 134; 138.Poggibonsi: 96-97; 131; 145.Pomaia (poggio): 85.Pomarance: 73; 75; 121; 134; 148.Ponteginori: 71; 98.Pratomagno: 135.
QQuarantola (fosso): 11; 67; 74; 79;
83; 85-86; 93; 97; 99; 103; 115; 147.
Quarta (fosso): 77; 92.Quartaia: 145.Quoio (monte): 90.
RRadicofani: 90.Rancia (fosso): 77.Rantìa (massi di): 83; 85; 114-115.Regolino San (podere): 24.Ribatti (via delle): 51.Ricavolo (fosso): 57; 114.Ricciaia (molino della): 145.Rigo (fosso): 92.Rimaggio (torrente): 57; 67; 72;
75; 111; 152.Ripa la (podere): 92.Riponti (fosso): 68.Riputine (fosso): 64; 91.Ritrovoli (poggio): 67-68; 71; 75-
76; 94; 111; 132.Rocca di Sillano: 121-122; 134-
135.Roma: 131.Roma (via): 50-51.
SSaio (fosso): 92.Sala (fosso): 25; 81; 84; 147.Sala la (podere): 44-45; 78; 81;
88.Saletta (podere): 44-45; 78; 84;
Frosini: 92.
GGabbro (monte): 69; 107.Galgano San (resti abbazia): 17;
120.Galleraie (bagni): 10; 106-107;
135; 145; 151.Galleraie (strada delle): 64; 70;
80-81; 98; 116; 150.Gambassi Terme: 131.Garfagnana: 72.Gatteresi (podere): 38-39; 79;
99; 103.Gazzei Tiberio (via): 24; 32; 128-
129; 142-143; 149.Gerfalco: 72; 119; 137; 145.Ghirlanda (piano della): 95.Giogliano (podere): 32-33; 113Gorgona (isola9: 135.Gramsci Antonio (piazza): 15; 24;
32.Grosseto: 67-68; 134; 145.
LLagoni: 70.Larderello: 69; 82; 151; 153-154.Lazio: 89.Lunigiana: 72; 82; 98.Lucignano (fosso): 14; 32-33; 66;
74; 77; 80; 83-84; 93; 115.
MMaggio (monte): 135.Marconi G. (via): 24; 32.Maremma: 145; 156.Massa Marittima: 92; 95; 120;
129; 145.Materno (podere): 65.Matteotti G. (piazza): 129; 142.Mensano: 10-12; 24; 44-45; 56;
64; 81; 87; 91; 104; 108; 116-117; 122-123; 130; 145; 150; 155.
Merse (fiume): 92; 95; 124.Merse (vallata/valle/bacino): 50;
71; 96; 98; 112; 120; 150.Metato (poggio): 73.Mezzo (molino di): 145.Molino delle Cerbaie: 74; 83; 85;
93.Mollerata (poggio): 74; 85; 114-
115.Montagnola senese: 96; 112; 135.Montalbano (castello): 114; 119;
132; 137.Montalbano (chiesa): 132.
168 169
la_guida_radicondoli.indd 168-169 01/09/14 12:19
Glossario
a.C. Avanti Cristo. denota la fase iniziale di un sistema di datazione temporale con al centro la nasci-ta di Gesù Cristo. La locuzione deriva dal latino Christum natum (prima della nascita di Cristo) abbreviata in a.C.n. e, a volte, in a.C. nel senso di ante Christum.
Alto Medioevo. È, per conven-zione, quella parte del Medioevo che va dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente, nel 476, all’anno 1000 circa (o 1066). Tale periodo si può talvolta sovrap-porre al periodo precedente della tarda antichità, mentre l’ul-timo secolo a quello successivo del Basso Medioevo.
Archetipo. Deriva dal greco an-tico ὰρχέτυπος col significato di immagine: arché (“originale”), tipos (“modello”, “marchio”, “esemplare”). Il termine è usato per indicare, in ambito filosofico, la forma preesistente e primitiva di un pensiero.
Arco monolitico. Arco di soste-gno a una sola apertura realiz-zato con unico blocco di pietra.
Argilla. Roccia sedimentaria composta di particelle estre-mamente piccole, con diametro minore di 1/256 di millimetro. È generalmente tenera, plastica, modellabile e impermeabile, di colore grigio o azzurrognolo. Esempio tipico è la creta usata dagli scultori.
Bacino fluviale. In idrografia il bacino idrografico è l’area to-pografica (solitamente identifi-cabile in una valle), delimitata da uno spartiacque topografico, di raccolta delle acque che scor-rono sulla superficie del suolo confluenti verso un determinato corpo idrico recettore (fiume, lago o mare interno) che dà il nome al bacino stesso.
Basso Medioevo. Periodo del-la storia europea e del bacino del Mediterraneo compreso tra l’anno 1000 circa e la scoperta dell’America nel 1492.
Calcare massiccio. Formazione rocciosa costituita in gran parte da carbonato di calcio (CaCO3), formatasi fra 195 e 175 milioni di anni fa in ambiente marino poco profondo quale scogliere coralli-ne e lagune.
Cassero. Parte elevata di una for-tificazione, ad esempio di un ca-stello o di una cinta di mura.
Cistercense. Ordine monastico di diritto pontificio originato dall’ab-bazia di Cîteaux (in latino Cister-cium), in Borgogna, fondata da Roberto di Molesmes nel 1098. L’Ordine sorse all’interno della congregazione cluniacense in osservanza della regola di San Benedetto: ora et labora. L’or-dine è organizzato in monasteri autonomi riuniti in congregazioni, ciascuna delle quali dotata di co-stituzioni proprie.
Conglomerato. Roccia sedimen-taria composta da frammenti ar-rotondati della dimensione della ghiaia o dei ciottoli, spesso con matrice sabbiosa, cementata da argilla indurita o calcite a formare un corpo unico.
Costrutto. Locuzione o idea con una struttura o un ordine più o meno saldi e funzionali di parole che configurano un senso che si regge da sé. Sinonimo di “con-cetto”.
Crosta terrestre. Uno degli involu-cri concentrici di cui è costituita la Terra: per la precisione, lo strato più esterno della Terra solida, avente uno spessore medio va-riabile fra 5 (crosta oceanica) e 35 chilometri (crosta continentale).
88.Salicastro (Costa): 67-68; 75.Saline di Volterra: 71; 98.San Dalmazio: 134-135.San Galgano: 92.San Gimignano: 12; 17; 44; 96;
108; 130-131.San Martino (podere): 101.San Martino a Cerniano (ruderi):
97.Santa Croce (via): 50; 107; 141.Santa Fiora: 90.Santa Lucia (poggio di): 114; 132.Scapernata (poggio): 11; 74; 83;
85; 93; 114-115.Sedice (via): 128-129.Seggiano: 90.Sellate (torrente): 73.Selva (poggi della): 112.Serchio (fiume): 155.Sermena (poggio): 145.Sesta (strada della): 56.Sicilia: 70.Siena: 10; 67-68; 88; 96-97; 101;
111-112; 116; 124; 132; 134; 138-139.
Solaio: 68.Soldano (monte): 72-73.Stromboli: 89.Strove: 106.
TTegolaia (podere): 44.Tegoni (fattoria): 114.Tesoro (podere): 14; 44-45; 81;
84; 87; 145.Tibet: 153.Tirreno (mare): 68; 71; 90; 98;
105.Tocchi: 124.Torre (podere): 33; 145.Torricella (poggio): 67.Toscana: 7; 10-11; 70-71; 76; 89;
98; 102; 113; 128; 134; 141; 147; 152; 155-156.
Travale: 11; 69-71; 136; 145; 150-151.
UUmbria: 89.
VVal di Chiana: 82; 98.Val di Cornia: 105; 135.Val di Pesa: 105.Valle (podere): 78.Valtiberina: 72; 82; 98.
Vetrialla (fosso): 24-25; 64-66; 78-81; 83-86; 91; 97; 99; 104; 145; 147; 150.
Vivo d’Orcia: 90.Volterra: 12; 17; 39; 68; 71; 73; 75;
82; 95; 98; 100; 105; 108; 114; 116; 119-120; 126; 135; 137-138; 140.
170 171
la_guida_radicondoli.indd 170-171 01/09/14 12:19
Curve di livello. Con particolare riguardo alla cartografia, la curva di livello, detta anche isoipsa (dal greco isos=uguale e hypsos=al-to), unisce punti con uguale quota, ovvero uguale distanza verticale dal piano di riferimento al quale è stato attribuito quo-ta zero (generalmente il livello medio del mare). Esse vengono adottate per rappresentare l’al-timetria in una superficie piana, com’è quella di un foglio. L’uso delle isoipse è uno dei metodi usati in cartografia per rappre-sentare le tre dimensioni su un foglio bidimensionale, in modo che chi osserva una mappa pos-sa farsi un’idea della morfologia superficiale del territorio e delle sue asperità.
d.C. Dopo Cristo. Denota la fase finale di un sistema di datazione temporale con al centro la (pre-sunta) data di nascita di Gesù Cristo.
Decima. Tributo di “un decimo” degli abitanti di un territorio all’i-stituzione amministrativa che lo regge. Nell’antica Roma, era la decima parte del reddito che l’a-gricoltore doveva all’erario come imposta. Nella Bibbia, la decima è l’offerta regolare al Tempio nel-la misura della decima parte dei prodotti del suolo e del gregge. Con il V ed il VI secolo, la pratica della decima si stabilisce in tutta la Chiesa occidentale. Nell’VIII secolo, i governanti carolingi de-finiscono la tassa della decima come legge civile. La decina è alla base del moderno sistema di tassazione erariale.
Diaspro. Roccia sedimentaria mo-no-mineralogica, ossia formata da un unico minerale, composta da quarzo(SiO2), e contenente alcune impurità, solitamente ato-mi di ferro, che le conferiscono vi-vaci colorazioni, rendendola ricer-cata come pietra semi-preziosa per la lavorazione in opificio, per gioielleria o decorazione.Discorso. Successione di segni
che comunicano o sollecitano un pensiero. Costruzione linguistica (segnica) dotata di un significa-to complessivo, determinata da specifici rapporti sintattici.
Estetica. Branca della filosofia che studia le ragioni del bello natura-le, artistico e scientifico; nonché del suo giudizio morale e spiri-tuale.
Età imperiale. Con riferimento all’Impero romano e al suo pe-riodo cronologico, questa Età va dal I secolo avanti Cristo al IV se-colo dopo Cristo.
Evapotraspirazione. Grandezza fisica usata in agrometeorologia che consiste nella quantità di acqua (riferita a un’unità di tem-po) che dal terreno passa all’aria sotto forma di vapore. Questo per effetto congiunto della tra-spirazione delle piante e dell’e-vaporazione diretta dal terreno medesimo.
Faglia. Indica la frattura o una zona di frattura tra due grandi blocchi di roccia, in cui si verifica (o si è verificato) il movimento relativo fra le due parti. La su-perficie lungo la quale si verifica lo scorrimento è detta piano di faglia.
Famiglie comitali. Dinastie familiari proprie nell’Alto Medioevo, in pos-sesso del titolo feudale di Conte e di amplissimi possedimenti fon-diari di concessione sovrana, in-caricate del governo del territorio.
Fluido geotermico. Acqua che si infiltra nella profondità della terra e che subisce un processo di riscaldamento naturale a causa della temperatura cedutale dalle rocce profonde con cui l’acqua stessa entra in contatto prima di risalire in superficie. Le acque ter-mali calde ed i vapori geotermici ne sono un classico esempio.
Formazione marina-evaporitica. Roccia formatasi in condizioni di mare poco profondo o in lagune
comunque sovra-salate sotto-poste a forte evaporazione, con la conseguente separazione dell’acqua dai suoi sali minerali, che si depositano sul fondo a costituire depositi di roccia.
Geolitologia. Disciplina che stu-dia la distribuzione spaziale sulla superficie terrestre delle varie tipologie di rocce.
Geologia. Dal greco gê, “terra” e logos, “studio”), è branca del-le scienze che studia la Terra e i processi che la plasmano e la cambiano. La geologia è impor-tante per la valutazione delle ri-sorse idriche, per la previsione e la comprensione dei pericoli naturali, per l’individuazione e il risanamento dei problemi am-bientali, per la pianificazione territoriale e la realizzazione di opere pubbliche e private, per l’estrazione di molti materiali d’u-so commerciale e industriale.
Geomorfologia. Disciplina del-la geografia fisica che studia la forma della superficie terrestre e i rilievi del territorio per compren-derne l’origine e l’evoluzione.
Ingegneria naturalistica. Discipli-na tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo a fini co-struttivi del materiale vegetale vivo (piante o parti di esse) in abbinamento con altri materiali inerti non cementizi quali il pie-trame, la terra, il legno, fibre ve-getali e sintetiche ecc. L’ambito storico di applicazione di tale di-sciplina è la prevenzione del dis-sesto idrogeologico. Trova am-pia applicazione nelle operazioni di consolidamento, stabilizzazio-ne, idraulica, drenaggio e ri-na-turalizzazione dei terreni in ottica di protezione dall’erosione, di sviluppo di ambienti naturali, e di salvaguardia del paesaggio.
Lucumonia. La carica rivestita dal Lucumone, il sovrano della città stato etrusca e, per esten-sione, il territorio a lui soggetto.
Tale territorio era formato da un centro direzionale e da villaggi sparsi nell’ambito di una unità spaziale per la quale valeva le decisione unitaria di leggi, ini-ziative commerciali, guerre... Le Lucumonie dell’Etruria di epoca etrusca erano dodici e si riuniva-no in occasione di particolari fe-ste religiose o di gravi insidie per decidere le strategie comuni da adottare a salvaguardia di una specifica ‘civiltà’.
Lignite. Carbone fossile conten-te dal 55% al 75% di carbonio, con potere calorifico più basso dopo l’Antracite e la Litantrace.
Macigno. Roccia sedimentaria a cemento calcareo-argilloso, appartenente alla famiglia delle Arenacee, tipica dell’ Appennino settentrionale, largamente im-piegata in Toscana come pietra da costruzione, dal caratteristi-co colore marrone chiaro. Pie-tra peraltro friabile e soggetta a erosione.
Mastio. Sinonimo di cassero, cioè parte più interna e, solita-mente, più difesa di una struttu-ra fortificata.
Medioevo. Periodo storico con-venzionale che va dall’età bar-barica (successiva alla caduta dell’impero romano d’Occiden-te) fino alla scoperta delle Ame-riche (1492).
Miocene. Epoca geologica che va da circa 22 milioni di anni fa a circa 5 milioni di anni fa.
Neolitico. Periodo più recente dell’età della pietra, distinto dal Paleolitico perché alla pietra scheggiata si sostituisce quella levigata. Nel Neolitico l’uomo viveva già in capanne (special-mente palafitte) ed inizia a prati-care l’agricoltura e l’allevamento di animali.
tOfioliti. Gruppo di rocce di ori-gine vulcanica (sottomarina) di colore scuro di cui la più nota e
172 173
la_guida_radicondoli.indd 172-173 01/09/14 12:19
diffusa nel territorio delle Colline Metallifere è la Serpentinite.
Paesaggio. Una determinata parte di territorio così come è percepita dalle persone, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (CONVENZIO-NE EUROPEA DEL PAESAGGIO, 2000). Per dire altrimenti, il pa-esaggio è la percezione visiva di una particolare porzione di territorio con sue determinate caratteristiche fisiche, antropi-che, biologiche ed etniche. È imprescindibile dall’osservatore il modo in cui il paesaggio è per-cepito e vissuto.
Pedologia. Disciplina scientifica che studia il suolo, cioè lo strato superficiale della crosta terre-stre.
Paleofrane detritiche. Antiche frane di crollo staccatesi da un costone soprastante e caratte-rizzata da blocchi in maggioran-za non di dimensioni enormi.
Paleolitico. Periodo più antico dell’età della pietra, sviluppatosi durante il Pleistocene (periodo geologico che va da 2 milioni a 100.00 fa) durante il quale l’uo-mo praticava esclusivamente la caccia e la raccolta e utilizzava la pietra scheggiata come ma-nufatto.
Pliocene. Epoca geologica che va da circa 5 milioni di anni fa a circa 2 milioni di anni fa.
Punto Cardinale. Punti utilizzati per l’orientamento sulla superfi-cie terrestre, determinati dall’in-contro dell’orizzonte col meri-diano (Nord e Sud) e col primo verticale (Est e Ovest).Reperti fittili. Resti di oggetti di fabbricazione umana costituiti da terracotta (argilla indurita a fuoco).
Reticolo idrografico. Serie di cor-si d’acqua, dai più piccoli ai più consistenti, che convergono
in un corso d’acqua maggiore che definisce l’estensione di un bacino.
Rinascimento. Periodo storico fissato tra la metà del secolo XV e la metà del secolo XVI. Il Rina-scimento fa parte dell’Età Mo-derna. Successivo al Medioevo, va convenzionalmente da 1492, anno della scoprta delle Ame-riche, alla Rivoluzione francese del 1789.
Roccia sedimentaria. Roccia derivata dalla deposizione e dall’accumulo di sedimenti in ambiente marino o continenta-le. Le rocce sedimentarie sono il più delle volte stratificate e con-tengono fossili (talora visibili solo al mircroscopio).
Rosso ammonitico. Formazio-ne rocciosa calcarea non ben stratificata, contraddistinta da una tessitura nodulare, formata per deposito di materiali in parte organici e in parte lapidei. Così detta per la frequenza con cui si individuano in questa tipologia di roccia fossili di Ammoniti.
Sedimenti. Materiali solidi deri-vanti dall’erosione, trasportati dal vento o dall’acqua e depo-sti sulla superficie terrestre o su fondali di fiumi, laghi e oceani.
Sedimenti mio-pliocenici. Mate-riali solidi derivanti dall’erosione, trasportati dal vento o dall’ ac-qua e deposti nel periodo che interessa il Miocene e il Plioce-ne, quindi da 22 a 2 milioni di anni fa.
Semantico. Relativo al significato.
Semiotica. Disciplina che studia i segni e il modo con il quale essi formano un senso (significazio-ne). Se il segno è qualcosa che rinvia a qualcos’altro (aliquid stat pro aliquo), la semiotica studia i fenomeni di significazione e di comunicazione. Per significa-zione si intende le relazioni che legano qualcosa di material-
mente presente a qualcos’altro di assente. Ogni relazione di significazione messa in pratica attiva un processo di comunica-zione. Lo stesso fa il paesaggio in quanto testo.
Semiotica del paesaggio. Studia il paesaggio in quanto testo, insieme di segni che costitui-scono una realtà significante, espressione di un senso. Il pa-esaggio è quindi una variante di un testo, che analogamente a un testo scritto, o a un’opera d’arte, può essere letta e inter-pretata a partire dai segni che la compongono e dal loro signi-ficato.
Strada Vicinale (SV). Nel caso di Radicondoli, strada soggetta a uso pubblico inclusa nell’elenco istituito presso il Comune. L’uso pubblico soddisfa i seguenti re-quisiti: (1) il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone apparte-nenti a un gruppo territoriale; (2) l’idoneità della strada per le esigenze di collegamento con la pubblica via; (3) il suo uso da parte della collettività da tempo immemorabile.
Terrazzo fluviale / alluvionale. Superfici pianeggianti delimitate da scarpate che costituiscono l’espressione di episodi più o meno prolungati di deposizione e poi di erosione da parte di un corso d’acqua.
Testo. Ogni insieme organizzato di segni – unitario e completo – significante, in grado di comu-nicare qualcosa a qualcun altro. Un tessuto di segni che hanno significato e che possono esse-re compresi nella loro interezza e nelle loro relazioni.
Tettonica. Termine generale che indica le deformazioni della crosta terrestre, le loro cause, la loro evoluzione e il loro studio.
Travertino. Roccia sedimentaria
calcarea formatasi per deposito di acque con altissima concen-trazione di carbonato di calcio. Il T. è caratterizzato da una strut-tura vacuolare e porosa dovuta per gran parte ai vuoti lasciati dai vegetali inglobati al momento della deposizione.
Vulcano volsineo. Vulcano un tempo presente nell’area oggi occupata dal lago di Bolsena che ne costituiva il cratere prin-cipale, poi collassato e riempito-si d’acqua.
174 175
la_guida_radicondoli.indd 174-175 01/09/14 12:19