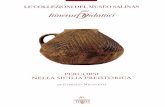Percorsi didattici in rete: produrli, consultarli, condividerli
Medicina e religione: percorsi di lettura
Transcript of Medicina e religione: percorsi di lettura
MEDICINA E RELIGIONE:PERCORSI DI LETTURA
MARIA PIA DONATO
Qualche decennio fa, proporre una riflessione sui rapporti tra medicina e religione cattolica dal Medioevo al contemporaneo sotto il segno di una dinamica tra collaborazione, competizione e conflitto non sarebbe stato così ovvio di quanto non lo renda oggi la profonda ristrutturazione dei campi storiografici in questione e, almeno per ciò che riguarda la storia della medicina, la revisione degli assiomi sui quali si fondava in quanto disciplina accademica.
Non intendo dire che le implicazioni ideologiche di un tema del genere si siano del tutto esaurite, sebbene si declinino diversa-mente nei vari contesti nazionali e confessionali. È negli Stati Uniti, dove il ruolo delle chiese nel sistema ospedaliero e universitario è molto incisivo, che la problematica continua ad essere affrontata nei suoi termini più ampi1. Nella particolare configurazione della formazione e dell’esercizio della professione medica negli Stati Uniti, la storia della medicina ha storicamente rappresentato, ben prima del formidabile sviluppo degli science studies, un importante spazio di orientamento e mediazione culturale in risonanza con le istanze civili della composita società nord-americana.
Diversa, invece, la situazione in Europa dove, pur con sensibili variazioni da paese a paese, il ruolo delle chiese, per quanto impor-tante, resta sussidiario dei sistemi statali di istruzione ed assistenza. Ciò ha contribuito a rendere la storia della medicina poco perme-abile a questioni formulate genericamente in termini di incorag-giamento ed ostacoli frapposti al progresso della scienza medica (diversamente, per altro, da ciò che è avvenuto per altre scienze naturali2). La storia della medicina, per altro, è rimasta a lungo in
1 Resta di riferimento R. L. Numbers, D. W. Amundsen (a cura di), Caring and curing : Health and medicine in the Western religious traditions, New York, 1986.
2 A. Romano, La science moderne, ses enjeux, ses pratiques et ses résultats en contexte catholique. Réflexions romaines, in A. Romano (a cura di), Rome et la science moderne : entre Renaissance et Lumières, Roma, 2008, p. 3-44 ; sul più celebre dei casi di conflitto cfr. ora M. Bucciantini, M. Camerota, F. Giudice (a cura di), Il caso Galilei. Una rilettura storica, filosofica, teologica, atti del convegno internazionale, Firenze, 2011.
10 MEDICINA E RELIGIONE: PERCORSI DI LETTURA
ambito specialistico. Così in Italia, dove pure non si può sottovalu-tare il peso della Chiesa nell’istruzione e nell’assistenza: qui la storia della medicina, in sé piuttosto marginale, si è prevalentemente connotata in senso positivistico, come ricostruzione regressiva delle attuali conoscenze, mentre l’interesse degli organismi culturali cattolici s’indirizza prevalentemente verso la bioetica e l’antropo-logia medica, rispetto alle quali la storia resta ancillare3. All’estremo opposto, in Gran Bretagna, lo sviluppo rigoglioso della storia della medicina, inizialmente connesso alla riforma del National Health Service, si è caratterizzato per l’apporto di studiosi esterni alla professione medica, il che ne ha comportato lo slittamento verso la storia tout court, polarizzata intorno ad altre questioni e dibattiti.
Negli ultimi trent’anni, lo spostamento istituzionale della storia della medicina verso la storia generale si è verificato in altri paesi occidentali, seppur in misura più contenuta e con specificità nazionali, e l’ha radicalmente trasformata4. Sarebbe impossibile ripercorrere qui le mutazioni, talvolta contraddittorie, intervenute dalla fine degli anni Settanta, ma si può dire sinteticamente che la storia sociale e culturale della medicina – sia che le si considerino complementari o invece alternative l’una all’altra5 - hanno rinno-vato la ricerca sia sul piano tematico che metodologico, aprendola a una molteplicità di oggetti e di attori nuovi. Ciò ha modificato la nozione stessa di medicina in quanto corpo di conoscenze progres-sive e di tecniche di cura da parte di praticanti riconosciuti, che l’aveva orientata sin dalla sua istituzione come disciplina accade-mica. Una nozione che guidava tutti i grandi padri fondatori, da Osler a Singer, da Daremberg a Sigerist, da Temkin a Ackerknecht, nonostante la squisita sensibilità storica, la forte motivazione etico-politica e la curiosità antropologica che li animavano, e che, malgrado la denuncia del punto di vista iatrocentrico da parte degli eredi diretti di quella tradizione6, è ancora sottesa a molta lettera-tura ad uso delle facoltà di medicina.
3 Si veda per esempio G. Tanzella Nitti, A. Strumia (a cura di), Dizionario inter-disciplinare di scienza e fede, Città del Vaticano, 2002; un panorama sull’antro-pologia medica e le varie istanze che vi sono confluite in G. Pizza, Antropologia medica : saperi, pratiche e politiche del corpo, Roma, 2008.
4 Per un approfondito panorama, declinato nei diversi contesti nazionali, F. Huisman, J. H. Warner (a cura di), Locating medical history. The stories and their meaning, Baltimora-Londra, 2004.
5 L. Jordanova, Has the social history of medicine come of age?, in Historical Journal, 36, 1993, p. 437-449; R. Cooter, Framing the end of the social history of medi-cine, in F. Huisman, J. H. Warner (a cura di), Locating medical history…cit., p. 309-337.
6 M. D. Grmek (a cura di), Storia del pensiero medico occidentale, 3 voll., Roma-Bari, 1993-1998.
11MARIA PIA DONATO
Le conseguenze sui modi in cui può essere concepita una storia delle relazioni tra medicina e religione sono profonde, e sono amplificate dalle trasformazioni che, in maniera speculare e non del tutto indipendente seppur specifica, hanno all’incirca nello stesso periodo investito la storia religiosa sotto la sollecitazione della sociologia e dell’antropologia.
In effetti, la nuova storia della medicina, portando in primo piano il sofferente, il malato largamente ignorato dalla storia della medicina tradizionale centrata piuttosto sui medici e la scienza medica, si è posta il problema delle credenze e delle rappresentazioni intorno alla vita e alla morte, alla salute, alla malattia e alla cura, e ha cosi reintegrato la religione in una dialettica assai più sfumata e pluralistica. Ciò non vale solo per il Medioevo, quando le interpre-tazioni religiose e mediche di malattia e guarigione si intrecciano in maniera manifesta, come già nel mondo antico7, bensì ancora per l’epoca moderna e contemporanea. Se inizialmente gli studi si sono concentrati su contesti nei quali la storica presenza di una pluralità confessionale incoraggiava una narrazione a più voci8, un approccio analogo si è esteso a paesi con una confessione dominante. A metà degli anni Novanta era possibile, nell’alveo della «scoperta del paziente» e nella parallela affermazione della nozione (anch’essa intrinsecamente pluralista) di medical marketplace in sostituzione o almeno ad integrazione di quella di professione, realizzare un’ope-razione come la conferenza internazionale Healing, magic and belief in Europe, 15th-20th centuries, impostata sul presupposto che «la storia della medicina e la storia della magia e stregoneria investono un campo comune, ossia la costruzione socio-culturale della salute, malattia e guarigione», e durante la quale specialisti di diversa formazione si confrontavano per indagare il ruolo di credenze in «forze superiori» nell’esperienza della malattia, con una spiccata propensione per quelle figure e terapie che, per amor di brevità, si possono definire alternative9.
7 La messa a punto di H. King, Comparative perspectives on medicine and reli-gion in the ancient world, in J. R. Hinnells, R. Porter (a cura di), Religion, health and suffering, Londra, 1999, p. 276-294, può essere corroborata da studi ormai clas-sici come O. Temkin, Hippocrates in a world of pagans and Christians, Baltimora-Londra, 1991; J. Jouanna, Hippocrates, Parigi, 1992; V. Nutton, Ancient medicine,Londra-New York, 2004.
8 W. J. Sheils (a cura di), The Church and healing : Papers read at the twentieth summer meeting and the twenty-first winter meeting of the Ecclesiastical History Society, Oxford, 1982.
9 Healing, magic and belief in Europe, 15th-20th centuries, new perspectives, Conference, 21-25 September 1994, Centre Woudschoten Zeist, Netherlands [1994] ; una selezione dei saggi è stata poi pubblicata da M. Gijswijt-Hofstra, H. Marland,
12 MEDICINA E RELIGIONE: PERCORSI DI LETTURA
In effetti, paradossalmente, in quest’orizzonte dilatato e in questo polifonico mercato della salute, rischiavano di eclissarsi i medici, i professionisti riconosciuti e patentati. La storia sociale della medicina, prima e dopo il suo cultural turn, si è accompa-gnata a un certo disinteresse per il contenuto teorico delle dottrine mediche e le sottigliezze del sapere del dottore in medicina, che gli storici lasciavano volentieri agli studiosi di formazione scientifica o agli storici della filosofia e del pensiero scientifico per interessarsi piuttosto alla cultura condivisa da laici e profani. Per certi versi, qualcosa di simile si verificava con le dottrine teologiche. Come se l’allargamento del campo disciplinare a nuovi studiosi e a un nuovo pubblico comportasse il prezzo di un offuscamento della dimensione intellettuale, e non tanto per una presa di posizione interpretativa esplicita quanto per tacito abbandono.
A correggere tale spostamento è intervenuto più recentemente un forte rilancio della storia intellettuale. Non che non esistes-sero pregevoli studi di taglio storico-filosofico per l’età medievale e moderna e storico-scientifico internalista per il contemporaneo, al contrario, ma qui alludo all’assottigliamento del confine tra i campi disciplinari e alla maggiore circolazione di temi e di quesiti tra quelli, la storia socio-culturale e una storia della scienza sempre più incline verso una storia dei saperi e delle forme di conoscenza10.Ciò è stato specialmente fertile per gli studi medievistici e moderni-stici, nell’ambito dei quali più sensibile è stato l’effetto dell’affievo-lirsi di un concetto di scienza orientato sulle scienze pure (la fisica, soprattutto) per far posto ad altre branche della conoscenza della natura, nonché il venir meno di un paradigma della modernità centrato sulla Rivoluzione scientifica. Tale revisione, essa stessa collegata al ripensamento in chiave sociale della produzione della conoscenza scientifica, ha avuto tra i suoi esiti una riabilitazione delle scientiae aristotelico-scolastiche come oggetto a tutto tondo, il che ha permesso di interrogare con nuove domande e strumenti le aree di contatto tra filosofia naturale, medicina e teologia nella loro tecnicità11.
H. de Waardt (a cura di), Illness and healing alternatives in Western Europe, Londra, 1997, sul quale cfr. G. Fiume e D. Gentilcore, Salute e malattia, medicina e guarigione nell’Europa moderna e contemporanea, in Quaderni storici, 105, 2000, p. 835-860.
10 La più acuta riflessione su tale evoluzione è forse quella di J. Vogel, Von der Wissenschafts- zur Wissensgeschichte. Für eine Historisierung der „Wissensgesellschaft“, in Geschichte und Gesellschaft, 30, 2004, p. 639-660.
11 In questa nuova storia intellettuale va ricordata in primo luogo la rivista Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies, Journal of the International Society for the Study of the Latin Middle Ages, promossa nel 1993 da A. Paravicini Bagliani, affiancata dal 1998 da una collezione editoriale che ha costituito un fertile
13MARIA PIA DONATO
In altre parole, avvalendosi dei risultati della storia sociale e culturale (non contro di essa), è stato possibile espandere la comprensione del comune ceppo da cui si dipartono la teologia e la medicina, il che ha contribuito non poco ad affievolire quella dico-tomia razionale/irrazionale che, come si ricorda già nell’introdu-zione di questo volume, ha per lungo tempo orientato questo tema di studio, non solo contrapponendo medicina e religione, cure mediche e interventi magico-religiosi, ma anche tagliando trasver-salmente il campo della medicina in «pre-scientifica» e «scienti-fica». Se negli anni Novanta era ancora necessario sottolineare la razionalità del ricorso alle cure spirituali o delle spiegazioni demo-nologiche12, oggi si può lasciare lo sguardo libero di posarsi su ogni aspetto senza simili avvertenze, come mostrano molti studi recenti su terapie sacre e guarigioni mirabili13, grazie all’interiorizzazione di un atteggiamento che, in fin dei conti, è il rifiuto dell’anacro-nismo e della teleologia.
Miracoli e medicina, miracoli medici
I contributi di questo volume dimostrano nel complesso quanto sia avanzata l’ibridazione di storia sociale e storia intellettuale. La scelta degli argomenti trattati non esaurisce lo spettro delle questioni riconducibili ad un tema tanto complesso e poliedrico come medicina e religione, né gli autori si muovono in una dire-zione interpretativa e metodologica unitaria. Nondimeno, privile-giando di volta in volta il rapporto tra medici ed ecclesiastici, tra istituzioni ecclesiastiche e mediche, o tra dottrine mediche e teolo-giche, lasciano intravedere dei nodi problematici ricorrenti che si riallacciano alla trama della storiografia internazionale.
Un percorso di lettura in trasversale attraverso i saggi qui riuniti deve giocoforza prendere avvio dai miracoli di guarigione, un tema sul quale si è ormai accumulata una considerevole mole di studi. Da diversi anni, infatti, la letteratura agiografica, i documenti canonici e i processi di beatificazione e canonizzazione, le testimonianze
terreno d’incontro tra antichisti, medievisti e modernisti. Tra i lavori degli autori che contribuiscono al presente volume, ricordo J. Agrimi, C. Crisciani, Edocere medicos : medicina scolastica nei secoli XIII-XV, Milano, 1988 ; C. Crisciani, Il Papa e l’alchimia : Felice V, Guglielmo Fabri e l’elixir, Roma, 2002 ; J. Ziegler, Medicineand religion, c.1300 : The case of Arnau de Vilanova, Oxford, 1998 ; L. Moulinier, Le manuscrit perdu à Strasbourg : enquête sur l’œuvre scientifique de Hildegarde,Parigi, 1995.
12 G. Fiume, op. cit.13 Riprendo la bella espressione di G. Fiume (a cura di), Guarigioni mirabili,
in Quaderni storici, 112, 2003.
14 MEDICINA E RELIGIONE: PERCORSI DI LETTURA
iconografiche e materiali del culto dei santi sono utilizzati per illu-minare aspetti diversi del contatto tra medicina e religione, e tra Chiesa e professioni sanitarie. Gli stessi documenti si prestano a un uso creativo tanto ai fini della paleopatologia e dello studio della diffusione e incidenza di diverse malattie in tempi passati14, quanto per impostare una storia delle malattie come costruzioni sociali e culturali.
In quest’ottica, essi confermano che i repertori a cui attingono gli individui e le comunità intrecciano elementi religiosi ed elementi naturali, tanto nelle spiegazioni e rappresentazioni, quanto nelle pratiche. Certo, in linea generale, non poteva essere altrimenti in una società cristiana nella quale, in fin dei conti, dipende da Dio la possibilità umana di comprendere il male e di curare15. Né può essere altrimenti in epoca contemporanea nella misura in cui tali documenti sono prodotti per lo più dalle istituzioni ecclesiastiche stesse. Nondimeno, vi si possono analizzare finemente le posizioni degli attori coinvolti e come si evolvano nel tempo. Se è vero che attraverso il miracolo si possono ricostruire le tappe fondamentali della storia della santità16, e persino vedervi in controluce i passaggi epocali della cultura religiosa occidentale17, vi si possono di sicuro cogliere le interazioni tra medici, ecclesiastici, fedeli.
In primo luogo, la letteratura agiografica e i processi di beatifi-cazione restituiscono il pluralismo sanitario e aprono uno scorcio sul modo in cui, nel quotidiano, il consumo del sacro e del medi-
14 In particolare, sull’uso delle fonti iconografche e materiali cfr. B. Cousin, Le miracle et le quotidien: les ex-voto provençaux images d’une société, Aix-en-Provence, 1983; F. Mormando, Piety and plague : From Byzantium to the Baroque,Kirksville, 2007; in generale su questo aspetto M. D. Grmek, D. Gourevitch, Les maladies dans l’art antique, Parigi, 1998.
15 J. Ziegler, Introduction, in P. Biller, J. Ziegler (a cura di), Religion and medi-cine in the Middle Ages, Woodbridge, 2001, p. 9. Su questo punto si vedano le osser-vazioni di J. Agrimi, C. Crisciani, Medicina del corpo e medicina dell’anima: note sul sapere del medico fino all’inizio del secolo XIII, Milano, 1979; D. W. Amundsen, Medicine and faith in early Christianity, in Bulletin of the History of Medicine,52, 1982, p. 326-350; per una recente rilettura della patristica M. Dörnemann, Krankheit und Heilung in der Theologie der frühen Kirchenväter, Tubinga, 2003.
16 A. Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge : d’après les procès de canonisation et les documents hagiographiques, Roma, 1981 (Bibliothèque des écoles d’Athène et de Rome 241; tr. it. La santità nel Medioevo,Bologna, 1989) ; S. Boesch Gajano, M. Modica (a cura di), Miracoli : dai segni alla storia, Roma, 1999.
17 A. Boureau, Miracle, volonté et imagination: la mutation scolastique, in Miracles, merveilles et prodiges au Moyen Âge, Parigi, 1995, p. 159-172; Id., De l’en-quête au soupçon. La fondation de la discipline théologique à l’université de Paris (1200-1350), in J. Boutier, J.-C. Passeron, J. Revel (a cura di), Qu’est-ce qu’une discipline?, Parigi, 2006, p. 213-228.
15MARIA PIA DONATO
cinale non fossero alternativi. Nelle fonti si osserva chiaramente come i malati si rivolgessero a curatori dell’uno e dell’altro ordine18.Non sarebbe azzardato dire che, tra i due, sorprende forse di più il ricorso ai medici. Le fonti agiografiche successive all’XI secolo confermano, pur tenendo conto delle amplificazioni strumentali a far poi meglio risaltare l’intervento miracoloso, un aspetto messo in luce dagli storici della medicina per alcune realtà urbane19, ossia la precoce medicalizzazione della società, almeno nell’Europa meri-dionale, nella quale i medici, e non solo le figure delle arti sanitarie minori, sono ben presenti, almeno nelle città (alle quali comunque i documenti si riferiscono in prevalenza). Nell’infermità le persone ricorrono senza troppa esitazione alle cure corporee, per quanto non tralascino le risorse della devozione.
Che l’arte medica non possa curare tutto è una verità ben salda, certo più nella medicina ippocratico-galenica che in quella trionfante contemporanea, che come ricorda qui Duffin «fa mira-coli». Ciò che preme qui sottolineare è che da parte degli infermi l’atteggiamento messo in luce da questo tipo di fonti è assai meno rinunciatario di ciò che si era postulato. Lo mostrano bene gli studi sull’infanzia, che spostando l’attenzione dal miracolo in quanto tale alle azioni che lo procedono, sia mediche che rituali, hanno conte-stato l’idea di un’accettazione passiva della malattia e della morte20.
18 In riferimento all’età moderna e prevalentemente per il contesto italiano, si possono leggere in quest’ottica D. Gentilcore, Healers and healing in early modern Italy, Manchester, 1998; A. Burkardt, Les clients des saints : maladie et quête du miracle à travers les procès de canonisation de la première moitié du XVIIe siècle en France, Roma, 2004 (Collection de l’Ecole française de Rome 338) ; G. Sodano, Il miracolo nel Mezzogiorno d’Italia dell’età moderna: tra santi, madonne, guaritrici e medici, Napoli, 2010.
19 Per esempio I. Naso, Medici e strutture sanitarie nella società tardo-medievale : il Piemonte dei secoli 14. e 15., Milano, 1982; K. Park, Doctors and medicine in early Renaissance Florence, Princeton, 1985; M. McVaugh, Medicine before the plague: Practitioners and their patients in the Crown of Aragon, 1285-1345, Cambridge, 1993.
20 P. Ellinger (a cura di), L’enfant et la mort, Reims, 1997, specialmente D. Lett, Dire la mort de l’enfant qui va ressusciter dans quelques récits de miracles des XIIe-XIIIe siècles, p. 137-155, corretto su alcuni punti da D. Alexandre-Bidon, Signes cliniques et protocoles de vérification du décès avant l’inhumation ou l’ouverture du corps (XIIe-XVIe siècle), in F. Collard, E. Samama (a cura di), Le corps à l’épreuve : poisons, remèdes et chirurgie : aspects des pratiques médicales dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Langres, 2002, p. 147-175; R. C. Finucane, The rescue of the innocents : Endangered children in medieval miracles, New York, 1997; J. Gélis, Les enfants des limbes. Mort-nés et parents dans l’Europe chrétienne, Parigi, 2006; sul punto anche R. Wood, Children remembered : Responses to untimely death in the past, Liverpool, 2007. In un’ottica analoga si può leggere N. Archambeau, Healing options during the plague : Survivor stories from a fourteenth-cenutry canonization inquest, in Bulletin of the History of Medicine, 85, 2011, p. 531–559.
16 MEDICINA E RELIGIONE: PERCORSI DI LETTURA
Il decentramento del punto di vista, dunque, avvicinando medici, ecclesiastici e profani di fronte ai prodigi di guarigione, getta luce sul livello condiviso delle concezioni e aspettative in materia di salute, dando corpo alla nuova storia culturale. Un passo oltre nella revisione metodologica, un’analisi incrociata delle fonti in termini di agency, invece che di mentalità, permette poi di chiamare in causa le periodizzazioni consolidate.
Mettendo da parte per un attimo i malati, è del tutto manifesto che la questione della natura miracolosa dell’intervento divino serve come insostituibile spia del complesso equilibrio tra istitu-zioni mediche ed ecclesiastiche.
I miracoli di guarigione rappresentano la stragrande maggio-ranza delle manifestazioni prodigiose di Dio, specialmente in relazione all’intercessione dei santi. L’importanza delle guarigioni nell’economia della santità si accresce nel corso dei secoli, a misura che cresce la necessità di una verifica, di una certificazione della realtà del miracolo : nei processi di canonizzazione rimodellati dopo Trento, quindi, il miracolo di guarigione prende decisamente il sopravvento rispetto al prodigioso antico e medievale che si manifesta in modi più vari e spesso in relazione alla natura, senza bisogno di incarnarsi sempre in un fedele particolare che diventa al tempo stesso il beneficiario e la testimonianza vivente duratura del miracolo21. Di conseguenza si modifica il ruolo del medico, da semplice testimone a testimone esperto e perito, nella non agevole posizione di dover dichiarare la propria impotenza e tuttavia di farlo in nome di un sapere che non viene messo in discussione22.Al contrario : è ben noto che con la revisione delle procedure di beatificazione e canonizzazione della Controriforma e in modo definitivo nel XVIII secolo con l’opera di Prospero Lambertini, Benedetto XIV, De servorum Dei beatificatione et beatorum cano-nizatione (1734-38), che riordina la dottrina e la giurisprudenza in materia (e che è oggetto oggi di nuovi studi23), entrano defini-
21 S. Boesch Gajano, M. Modica, op. cit. ; J. Duffin, Medical miracles. Doctors, saints and healing in the modern world, Oxford, 2009.
22 J. Ziegler, Practitioners and saints : Medical men in canonization processes in the Thirteenth to Fifteenth centuries, in Social History of Medicine, 12, 1999, p. 191-225; A. Burkardt, op. cit. ; F. Vidal, Miracles, science, and testimony in post-Tridentine saint-making, in Science in Context, 20, 2007, p. 481-508.
23 Integrano ormai la datata sintesi di D. Gorce, L’oeuvre médicale de Prospero Lambertini (pape Benoît XIV) 1675-1758, Bordeaux 1915, G. Dalla Torre, Santità ed economia processuale. L’esperienza giuridica da Urbano VIII a Benedetto XIV, in G. Zarri (a cura di), Finzione e santità tra medioevo ed età moderna, Torino, 1991, p. 231-263; C. Santing, Tiramisù: Pope Benedict XIV and the beatification of the flying saint Giuseppe da Copertino, in O. P. Grell, A. Cunningham (a cura di), Medicine
17MARIA PIA DONATO
tivamente nella definizione del miracolo criteri come l’inguaribi-lità misurata attraverso il tempo e i tentativi terapeutici, ossia dei criteri elaborati dai medici e ai quali attingono la canonistica e la teologia. Studi recenti hanno permesso di estendere le nostre conoscenze sulle categorie concettuali e i dispositivi epistemolo-gici attraverso i quali funzionava la perizia medica, conducendo fuori dalle secche in cui si può talvolta incorrere limitandosi all’al-ternativa tra credulità e scetticismo24.
E’ stata attirata l’attenzione sul fatto che la nuova posizione del medico nei processi di canonizzazione rientra nel più generale passaggio dalle testimonianze di fede alle testimonianze giuridiche che toccano anche altre figure peritali come i notai25, e che, pur basandosi sulla crescente istituzionalizzazione scientifica e profes-sionale della medicina, si risolve in una subordinazione all’auto-rità ecclesiastica, la quale si accaparra la definizione del miraco-loso. D’altro canto, accanto alla relazione diretta all’interno delle istituzioni del sacro sotto il segno della subordinazione, i medici restano così un ganglio del più ampio reticolo della santità e del miracolo che innerva la società, proponendosi attraverso la certi-ficazione del miracolo come uno degli attori della mediazione tra i diversi soggetti politici e sociali coinvolti nella costruzione della santità, come mostra qui il saggio di Bouley. Il fatto che al medico sia richiesto sempre meno di pronunciarsi sulla natura miracolosa di una guarigione, bensì di attestarla a contrario nei limiti dell’arte propria, può essere inteso come una limitazione dell’autorità della professione, oppure come una sorta di clausola di salvaguardia.
and religion in Enlightenment Europe, Aldershot, 2007, p. 79-120; L. Dacome, The anatomy of the Pope, in M.P. Donato, J. Kraye (a cura di), Conflicting duties. Science, medicine and religion in Rome, 1550-1750, Londra, 2009, p. 355-376.
24 V. Marchetti, L’invenzione della bisessualità : discussioni fra teologi, medici e giuristi del 17. secolo sull’ambiguità dei corpi e delle anime, Milano, 2001; A. Pastore, Il medico in tribunale : la perizia medica nella procedura penale d’antico regime (secoli 16.-18.), Bellinzona, 1998; A. Pastore, G. Rossi (a cura di), Paolo Zacchia : alle origini della medicina legale, 1584-1659, Milano, 2005; S. De Renzi, La natura in tribunale. Conoscenze e pratiche medico-legali a Roma nel XVII secolo,in Quaderni Storici, 108, 2001, p. 799-822; ead., Witnesses of the body. Medico-legal cases in seventeenth-century Rome, in Studies in History and Philosophy of Science,33a, 2002, p. 219-242. Si veda inoltre I. MacLean, Logic, signs and nature : Learned medicine in the Renaissance, Cambridge, 2001.
25 R. Michetti (a cura di), Notai, miracoli e culto dei santi : pubblicità e auten-ticazione del sacro tra 12. e 15. secolo : atti del Seminario internazionale, Roma, 5-7 dicembre 2002, Milano, 2004 (Studi storici sul notariato italiano, 12) ; S. Boesch Gajano, Guarigioni di fede. Testimonianze, certificazioni e riconoscimento ecclesia-stico del miracolo, in M. Borsari (a cura di), Salute e salvezza : l’elaborazione reli-giosa della malattia e della guarigione, Modena, 2001, p. 105-131.
18 MEDICINA E RELIGIONE: PERCORSI DI LETTURA
Essa permette alla medicina di mantenere il proprio registro di verità fino a ridefinire nel tempo i termini del «contratto» con la Chiesa ben oltre la fine dell’antico regime.
La convergenza tra medicina e teologia intorno al miracolo, in effetti, avviene storicamente sul comune substrato aristotelico, ma è messa in crisi nel Seicento per lo sviluppo del meccanicismo, che accantonando l’ilemorfismo aristotelico-galenico propone una nuova visione fondamentalmente monistica del corpo, dei processi normali e patologici e della vita stessa. Il mutamento dei presup-posti metafisici ed epistemologici della medicina dei Moderni, meccanicista o vitalista che sia (rifiuto dell’ilemorfismo, somatiz-zazione dei fenomeni biologici, integrazione della morte nella defi-nizione di vivente), non equivale necessariamente al materialismo né all’ateismo, ma rende più problematica la validazione scienti-fica dei fenomeni sovrannaturali, se non, appunto, come fenomeno inspiegabile dalla scienza.
Molti di questi meccanismi si prolungano nel mondo contem-poraneo, sebbene le istituzioni della scienza non derivino la legitti-mità sociale dalle istituzione religiose (neanche tra i credenti) né i propri presupposti metafisici dalla teologia, quindi gli elementi di tensione intrinseci si accentuino, come mostrano qui i contributi di Duffin e di Di Marco: entrambi sono focalizzati su un periodo di cerniera come il XIX secolo, quando, sullo sfondo di stati secolariz-zati seppur non ancora di società scristianizzate, resta la necessità di provare scientificamente il miracolo senza che a dichiararlo tale debba e possa essere la scienza, che ormai, come la società tutta, è apertamente polarizzata tra credenti ed agnostici.
Ricorda giustamente Gentilcore che definire il miracoloso è sempre una faccenda di potere26. In una certa misura, sono sempre le mutevoli alleanze tra i miracolati e il loro entourage, i medici (e le altre figure sanitarie) e le gerarchie ecclesiastiche che restringono o allargano il campo del sovrannaturale e definiscono il miracolo, sospingendo il resto nella superstizione. Si è individuato nella diffe-renziazione sociale della cultura così come si dispiega intorno ai miracoli uno dei meccanismi della modernità27. In una certa misura
26 D. Gentilcore, Salute e malattia…cit.27 M. de Certeau, L’inversion du pensable. L’histoire religieuse du XVIIe siècle, in
Id., L’écriture de l’histoire, Parigi, 1975, p. 154-177 (tr. it. La scrittura della storia,Roma 1977) ; P. Burke, Popular culture in early modern Europe, Londra, 1978;Scienze, credenze occulte, livelli di cultura. Convegno internazionale di studi, Firenze, 26-30 giugno 1980, Firenze, 1982; J. Revel, Forms of expertise : Intellectuals and ‘popular’ culture in France (1650-1800), in Understanding popular culture : Europe from the Middle Ages to the ninenteenth century, Berlino-New York, 1984, p. 255-273.
19MARIA PIA DONATO
ciò vale anche oggi28, e Duffin lo conferma riflettendo sulla sua personale esperienza di medico, di esperta in una causa di beatifi-cazione e di storica nel confrontarsi con i suoi colleghi clinici.
Corpi santi, fisiologie mirabili, autopsie devote
Si potrebbe pensare che l’accresciuta importanza del mira-colo contraddica la ridefinizione dei canoni di santità della Controriforma, la santità eroica della chiesa Tridentina incentrata piuttosto sull’azione di riforma e di servizio alla chiesa e alla società. In realtà i due ambiti sono comunque sovrapposti e si incarnano nel corpo del santo, che è esso stesso un miracolo. Come sottolinea S. Boesch Gajano,
Il corpo è la realtà fisica in cui si iscrive il percorso spirituale. La capa-cità di dominare il proprio corpo, vivendo oltre quelli che vengono conside-rati i limiti della natura, contribuisce in modo decisivo al riconoscimento sociale di un’eccezionalità soprannaturale [...] Il santo, che ha vinto la natura nel suo spirito e nel suo corpo, può dominare la natura, può proteg-gere, guarire e perfino vincere la morte29.
Il corpo smagrito del santo/a, segnato dall’ascesi e dai tormenti mistici, stigmatizzato, frammentato e poi ispezionato post mortem,è un aspetto costitutivo della santità, alla cui costruzione storica i medici contribuiscono in vario modo, e che è oggetto di un certo numero di studi che si situano all’intersezione della storia religiosa, della storia culturale del corpo, della storia di genere.
Corpo smagrito, prima di tutto. Il cibo, come altre aree della vita quotidiana rilevanti per la salute – i cosiddetti «non naturali» –, è oggetto di precetti religiosi e medici, connotati primariamente secondo criteri di genere, che ancora nelle società secolarizzate di oggi si rinforzano mutualmente ancorché implicitamente30.
Dal punto di vista medico, l’igiene o dietetica, che accompagna l’istituzionalizzazione stessa della medicina secolare almeno dal XII secolo, si basa su un ovvio assunto mondano come l’impor-tanza del benessere fisico, pur integrando più o meno esplicita-mente divieti e ripulse di matrice religiosa. In età medievale e
28 C. Gallini, Lourdes e la medicalizzazione del miracolo, in Ricerca folklorica, 29, 1994, p. 83-94; R. B. Mullin, Miracles and the modern religious imagination, New Haven, 1996; J. Szabo, Seing is believing? The form and substance of French medical debate over Lourdes, in Bulletin of the History of Medicine, 76, 2002, p. 199-230.
29 S. Boesch Gajano, Santità e miracolo : un rapporto tormentato, in G. Fiume (a cura di), Il santo patrono e la città, Venezia, 2000, p. 357-371, qui p. 361.
30 Cfr da ultimo E. Burns Coleman, K. White (a cura di), Medicine, religion, and the body, Leida-Boston, 2010.
20 MEDICINA E RELIGIONE: PERCORSI DI LETTURA
moderna, il punto di equilibrio per non ledere la gerarchia dei valori della società cristiana né l’autonomia del medico consiste nell’adattare il regimen ad ogni paziente, o più spesso a categorie di pazienti, per meglio dosare obblighi religiosi di ogni stato e consigli medici31, secondo un approccio casuistico che i dottori in medicina condividono con i dottori in teologia e in legge, almeno fino all’introduzione della farmacologia industriale32. In questo quadro, come hanno suggerito diversi studiosi prevalentemente in chiave di storia di genere33, e come mostra qui Andretta a propo-sito di Ignazio di Lojola e Filippo Neri, si potrebbe definire il santo una negoziazione fallita.
Oltre le cure dietetiche, i trattamenti medicinali e chirurgici possono contribuire alla costruzione della santità, una via dolorosaalla perfezione, sia che l’(aspirante) santo vi si sottometta pazien-temente ed eroicamente, sia che li rifiuti con disdegno: un atteg-giamento frequente nella Chiesa primitiva, ma mai del tutto scom-parso, e anzi rinnovato nella pietà barocca34 e rinverdito nell’Otto-cento in dichiarato rifiuto della modernità35.
Corpo segnato, dunque. Il meraviglioso fisiologico, però, oltre-passa le ordinarie afflizioni somatiche e relative cure, ancorché atroci, e si manifesta in ben altri segni, a cominciare dalle stim-mate, che accompagnano il processo di interiorizzazione (e dunque di corporeizzazione) della santità. Da Francesco a padre Pio, rievocato qui da Desmazières attraverso la critica di Agostino Gemelli, costituiscono il crisma più cristico e mirabile, e al tempo
31 M. Nicoud, Les régimes de santé au Moyen âge : naissance et diffusion d’une écriture médicale, XIIIe-XVe siècle, Roma, 2007 (Bibliothèque des écoles d’Athène et de Rome 333), a cui si rimanda per gli studi precedenti ; per la dieta dei papi E. Andretta, Roma medica. Anatomie d’un système médical au XVIe siècle, Roma, 2011 (Collection de l’Ecole française de Rome 448) ; D. Gentilcore, The Levitico, or how to feed a hundred Jesuits, in Food & History, 8, 2010, p. 87-120.
32 H. J. Cook, Good advice and little medicine : The professional authority of early modern English physicians, in Journal of British Studies, 33, 1994, p. 1-31.
33 R. Bell, Holy anorexia, Chicago-Londra, 1985 (tr. it. La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo ad oggi, Milano, 1987) ; C. Walker Bynum, Holy feast and holy fast : The religious significance of food to medieval women, Berkley, 1987 (tr. it. Sacro convivio, sacro digiuno: il significato religioso del cibo per le donne del Medioevo, Milano, 2001). Un panorama su questo e altri aspetti in J. Gélis, Le corps, l’Église et le sacré, in A. Corbin, J.-H. Courtine, G. Vigarello (a cura di), Histoire du corps, 1, De La Renaissance aux Lumières, a cura di G. Vigarello, p. 17-107.
34 Stigmates, n. monografico di L’Herne, 75, 2001, in cui si veda soprattutto J. Le Brun, Le discours de la stigmatisation au XVIIe siècle, p. 103-118.
35 R. D. E. Burton, Holy tears, holy blood: Women, Catholicism and the culture of suffering in France, 1840-1970, Ithaca, 2004; v. anche M. Caffiero, La politica della santità : nascita di un culto nell’età dei lumi, Roma-Bari, 1996.
21MARIA PIA DONATO
stesso, nella sua terribile semplicità, particolarmente sospetto di simulazione36.
Simulazione, ovviamente, è il termine che potrebbe da solo incapsulare l’evoluzione del rapporto tra medici ed ecclesiastici intorno al corpo del santo. Il problema della falsa santità è connatu-rato all’istituzione dei processi canonici nel XII secolo e ancor più alla sua riforma tra Cinque e Seicento, e in quell’orizzonte giuridico, teologico e culturale si definisce il ruolo del medico. Resta certo un problema di fonti, poiché non si esce di fatto dall’alternativa tra fonti agiografiche e canoniche da un lato, e fonti inquisitoriali dall’altro. Dal XVII secolo, la necessità di sorvegliare i fenomeni preternatu-rali e perseguire l’affettata santità fa del medico una presenza certa-mente più costante presso le persone che presentano sul loro corpo segni e sintomi prodigiosi (sempre sotto il controllo del confessore e dell’inquisitore), e nondimeno le tracce restano assai disperse e frammentarie, il che spiega almeno in parte perché gli storici non si siano finora impegnati in una ricerca sistematica su questo aspetto37.
Perciò, la malattia, che pure è una possibile spiegazione, resta in ombra, e non è evocata che in pochi casi, ed è semmai applicata a posteriori alle fonti storiche come diagnosi regressiva, particolar-mente di tipo psico-patologico, sui cui tornerò oltre. Solo nell’Otto e Novecento diventa più agevole studiare tempi e modi della presenza medica su fonti più varie, dato che si instaura un disposi-tivo di triplo controllo, per così dire, di Chiesa, Stato e professione, ormai divisa, come si è detto.
Il corpo del santo, naturalmente, continua ad esser prodi-gioso dopo la morte, e non solo come reliquia che, sin dalla prima Cristianità, guarisce, converte e protegge38, ma come cada-
36 L’espressione meraviglioso fisiologico di A. Vauchez è sviluppata da S. Cabibbo, Il ‘meraviglioso fisiologico’ di Veronica Giuliani fra modello francescano ed erudizione barocca, in I Cappuccini nell’Umbria del Settecento, Roma, 2008, p. 169-184. Inoltre G. Zarri, Le sante vive. Profeti di corte e devozione femminile tra ’400 e ’500, Torino, 1990; S. Luzzatto, Padre Pio: miracoli e politica nell’Italia del Novecento, Torino, 2007.
37 Ma cfr. V. Marchetti, La simulazione di santità nella riflessione medico-legale del sec. XVII, in G. Zarri (a cura di), Finzione e santità…cit., p. 202-227; J. Pardo Tomas, A. Martinez Vidal, Victims and experts : Medical practitioners and the Spanish Inquisition, in J. Woodward, R. Jütte (a cura di), Coping with sickness. Medicine, law and human rights. Historical perspectives, Sheffield, 2000, p. 11-27 ; A. Keitt, The miraculous body of evidence : Visionary experience, medical discourse, and the Inquisition in seventeenth-century Spain, in Sixteenth Century Journal, 36, 2005, p. 77-96; F. Barbierato, Il medico e l’inquisitore. Note su medici e perizie mediche nel tribunale del Sant’Uffizio veneziano fra Sei e Settecento, in A. Pastore, G. Rossi (a cura di), Paolo Zacchia...cit., p. 266-285.
38 A. Angenend, Heilige und Reliquien: die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, Monaco, 1997; L. Canetti, Frammenti di eternità :
22 MEDICINA E RELIGIONE: PERCORSI DI LETTURA
vere incorruttibile, che emana profumo, sanguina, piange39. In quest’ambito, per certi aspetti le cose sono più semplici. Almeno per odore e conservazione del cadavere, la simulazione si riduce a credulità e imbroglio, senza necessità di discrezione degli spiriti da parte dei teologi e di complesse valutazioni da parte dei medici per dirimere tra malattia e stato preternaturale. Ciò non vuol dire che venga meno il compito di attestare se e quando avvengano feno-meni soprannaturali40, facendo fronte alle aspettative politiche e sociali come mostra qui Bouley.
Un discorso a parte meritano le «autopsie sante», che sono state oggetto di studi non numerosi ma decisivi per la nuova storia culturale e sociale della medicina perché hanno messo a nudo le possibili radici e le implicazioni religiose di una pratica come la necroscopia che ha sempre funzionato come una sorta di binario della modernità sul quale far scorrere la storia progressiva della medicina come scienza empirica41. Se, da un lato, è significativo che si ricorra sin dal XIV secolo all’apertura post mortem del corpo per (testimoniare di) cercare prove inoppugnabili della santità (e Vauchez ha fatto notare che ciò inizia nella prima grande esplo-sione mistica e per una donna, Chiara da Montefalco, nel cui processo di canonizzazione per la prima volta si registra una testi-monianza negativa42), e se ciò è anche un sintomo della legittima-
corpi e reliquie tra Antichità e Medioevo, Roma, 2002. Rinnova ora la questione delle reliquie in età moderna e contemporanea P. Boutry, P.-A. Fabre, D. Julia (a cura di), Reliques modernes : cultes et usages chrétiens des corps saints des Réformes aux révolutions, Parigi, 2009.
39 A. Vauchez, La sainteté…cit. ; G. Sodano, ‘Sangue vivo, rubicondo e senza malo odore’. I prodigi del sangue nei processi di canonizzazione a Napoli nell’età moderna, in Campania sacra, 26, 1995, p. 293-310; J.-P. Albert, Odeurs de sainteté: la mythologie chrétienne des aromates, Parigi, 1990; M. Roch, L’intelligence d’un sens: odeurs mira-culeuses et odorat dans l’Occident du haut Moyen Âge, Ve-VIIIe siècles, Turnhout, 2009.
40 G. Pomata, Malpighi and the holy body: Medical experts and miraculous evidence in seventeenth-century Italy, in Renaissance Studies, 21, 2007, p. 581-582.
41 K. Park, The criminal and the saintly body: Autopsy and dissection in Renaissance Italy, in Renaissance Quarterly, 47, 1994, p. 1-33; ead., Secrets of women: Gender, generation, and the origins of human dissection, New York, 2006; N. Siraisi, Signs and evidence : Autopsy and sanctity in late sixteenth-century Italy, ora in ead., Medicine and the Italian universities, 1250-1600, Boston, 2001, p. 356-380; sulla scia di questi studi : C. Santing, ‘De affectibus cordis et palpitatione’. Secrets of the hearth in Counter Reformation Italy, in W. de Blécourt, C. Ousborne (a cura di), Cultural approaches to the history of medicine. Mediating medicine in early modern and modern Europe, New York, 2004, p. 11-35; E. Andretta, Anatomie du Vénérable dans la Rome de la Contre-réforme. Les autopsies d’Ignace de Loyola et de Philippe Neri, in M. P. Donato, J. Kraye (a cura di), Conflicting duties…cit., p. 255-280.
42 A. Vauchez, La nascita del sospetto, in G. Zarri (a cura di), Finzione e santità…cit., p. 29-58.
23MARIA PIA DONATO
zione sociale delle tecniche di indagine medica, dall’altro lato è vero che ciò che si cerca e si trova, ciò che si vede anche quando sono i medici ad ispezionare i cadaveri, è sempre il meraviglioso fisiologico.
Anche per il cadavere, comunque, alla fine del Seicento con la crisi dell’aristotelismo si offusca il quadro filosofico entro il quale tali fenomeni erano intelligibili in quanto sovrannaturali, mentre la sempre maggiore frequenza delle sezioni cadaveriche mette in prospettiva ciò che è davvero straordinario e ciò che ricorre in rela-zione a determinate patologie o formazioni mostruose. Almeno le spoglie mortali dei santi cessano così di rappresentare un luogo di sovrapposizione tra medicina e religione.
I viaggi dell’anima e gli abissi della mente
Miracolo, impostura o malattia sono gli schemi esplicativi che coesistono a fronte del meraviglioso somatico: schemi esplica-tivi validi sia per gli attori storici, sia retrospettivamente per gli studiosi di epoche successive. C’è poi un altro termine esplicativo, o per meglio dire due: possessione demoniaca e stregoneria.
La ricerca in questo campo, che è stato anche uno dei principali terreni di incontro tra storia e antropologia, si accresce e si diver-sifica incessantemente. Ai nostri fini, preme sottolineare che alcuni studi recenti hanno ampliato la comprensione storica delle «fisio-logie spirituali» che formano il substrato della demonologia, o per meglio dire con quello che potrebbe sembrare un gioco di parole, chiariscono le dottrine metafisiche e fisiche che portavano il corpo a fare da substrato di forze e enti spirituali, ma non per questo sono meno reali, e anzi sempre sul punto di acquisire una qualche materialità43. Si chiarisce quindi il regime di scientificità all’interno del quale vengono articolati i fenomeni e le relative interpretazioni. Si può misurare in ciò il rinnovato contributo della storia intellet-tuale cui si è alluso sopra, che integra l’apporto dell’antropologia, a dir poco dirompente nella precedente stagione di studi (non senza qualche fraintendimento, e Merluzzi ne richiama alcuni nel suo contributo). Si può aggiungere che la discrezione spirituale è un
43 Tra i lavori più recenti ricordiamo almeno N. Caciola, Discerning spirits : Divine and demonic possession in the Middle Ages, Ithaca-Londra, 2003; A. Boureau, Satan hérétique. La naissance de la démonologie dans l’Europe médiévale (1260-1350), Parigi, 2004 (tr. it. Satana eretico : nascita della demonologia nell’occidente medievale (1280-1330), Milano, 2006) ; N. G. Siraisi, The clock and the mirror : Girolamo Cardano and Renaissance medicine, Princeton, 1997; M. van der Lugt, Le ver, le démon et la vierge : les théories médiévales de la génération extraordinaire : une étude sur les rapports entre théologie, philosophie naturelle et médecine, Parigi, 2004.
24 MEDICINA E RELIGIONE: PERCORSI DI LETTURA
tema di ricerca in rapida evoluzione anche sul versante della storia religiosa, specialmente in età moderna44.
Innegabilmente, comprendere la razionalità del complesso magico-demoniaco è un passo necessario ma non sufficiente. La dimensione intellettuale non esaurisce quella che è, e drammati-camente, un’altra faccenda di potere. Lavenia lo ricorda in questo volume giustapponendo filoni diversi della cultura aristotelica e del galenismo sulle «malattie sacre» e mettendoli in controluce all’azione dell’Inquisizione. La tendenza verso una considerazione sfumata dell’apporto rispettivo di teorie scientifiche e sensibilità religiose nell’indagare la «fine della magia», che caratterizza un intero filone di studi per l’ambito riformato soprattutto inglese45, si è ora delineata negli studi sulla crisi della demonologia scolastica e neo-scolastica tra XVII e XVIII secolo in riferimento all’Inquisi-zione romana46.
Dare spessore alle dinamiche interne alla cultura e alle istitu-zioni religiose non può mettere in ombra l’innegabile fatto che la rivoluzione cartesiana induca un ripensamento radicale della rela-zione soma/psiche, anima/corpo, con lo svuotamento del contenuto scientifico delle fisiologie spirituali tradizionali e le diverse conse-guenze sul piano teologico e religioso47. E’ superfluo ricordare che
44 A. J. Schutte, Aspiring saints. Pretense of holiness, Inquisition, and gender in the Repubblic of Venice, 1618-1750, Baltimora, 2001; M. Sluhovsky, Believe not every spirit. Possession, mysticism and discernment in early modern Catholicism,Chicago-Londra, 2007; G. Zarri (a cura di), Storia della direzione spirituale, vol. 3, L’età moderna, Brescia, 2008. Sul tema rimando alla messa a punto di S. Cabibbo, Discretio spirituum, in A. Prosperi, J. Tedeschi, V. Lavenia (a cura di), Dizionario storico dell’Inquisizione, I, Pisa, 2010, p. 24-25.
45 Oltre ai classici K. Thomas, Religion and the decline of magic : Studies in popular beliefs in sixteenth and seventeenth century England, Londra, 1971 (tr. it. La religione e il declino della magia : le credenze popolari nell’Inghilterra del Cinquecento e del Seicento, Milano, 1985), e S. Clark, Thinking with demons. The idea of witch-craft in early modern Europe, Oxford, 1996, cfr. P. Elmer, ‘Saints or sorcereres’ : Quakerism, demonology and the decline of witchcraft in seventeenth-century England, in J. Barry et al. (a cura di), Witchcraft in early modern Europe. Studies in culture and belief, Cambridge, 1996, p. 145-179; M. Gijswijt-Hofstra, B. P. Levack, R. Porter, Witchcraft and magic in Europe : The eighteenth and nineteenth centuries,Londra, 1999; O. P. Grell, A. Cunningham (a cura di), Medicine and religion…cit.
46 E. Brambilla, Corpi invasi e viaggi dell’anima. Santità, possessione, esorcismo dalla teologia barocca alla medicina illuminista, Roma, 2010.
47 Tradizionalmente, lo sviluppo storico delle teorie inerenti al rapporto tra anima e corpo, con un’intermittente attenzione per le relative implicazioni teolo-giche, è appannaggio degli storici della filosofia o, viceversa, degli specialisti di (storia della) neurologia e psicologia, e anzi l’attuale portentoso sviluppo delle neuroscienze si accompagna a una proliferazione di articoli, per lo più diretti a medici, su prece-denti e precursori, nella vena tipica della storia specialistica della medicina.
25MARIA PIA DONATO
le polemiche settecentesche su stregoneria e possessione si alimen-tano delle tendenze rigoriste e illuminate interne alla Chiesa ma le sorpassano ampiamente.
L’«eclissi dell’anima», o per meglio dire, l’eclissi delle anime e delle facoltà, apre per la Chiesa di Roma problemi di natura dottrinale, politico-culturale e pastorali che sono particolarmente stridenti nel XVIII secolo, e che per la possessione restano aperti, pur in nuovi termini, con la secolarizzazione dello stato dopo la Rivoluzione francese (che invece assesta un colpo definitivo alla stregoneria in direzione di ridurla a truffa). Già in epoca rivolu-zionaria e napoleonica, anzi, vengono alla ribalta filosofie mediche materialiste che propongono schemi esplicativi e terapeutici per le manifestazioni soma-spirituali, carichi di risvolti metafisici ed etici, come il magnetismo animale studiato qui da Armando. Nel XX secolo, saranno le psicologie del profondo a sollecitare una difficile reazione che, come mostra qui Desmazières, passa pure attraverso la fascinazione per le possibili applicazioni pastorali48.
Armando e Demazière rimangono aderenti ad un’analisi storica delle categorie degli attori e sollevano così implicitamente un’impor-tante questione metodologica. In effetti, la scoperta dell’inconscio, per echeggiare il titolo di un famoso libro di Henri Ellenberger49,è un problema storico di grande complessità, ma è al tempo stesso un intricato problema critico e storiografico. Com’è noto, infatti, la moderna psicologia clinica, la psichiatria e tutta la scienza dell’in-conscio si sono storicamente definite anche in contropiede alle inter-pretazioni religiose delle manifestazioni fisiche del misticismo, per usare l’espressione del gesuita Herbert Thurston50 – Di Marco accenna nel suo saggio ad alcuni pionieri –, contendendosi poi il governo di tali fenomeni51. Tra Otto e Novecento, anzi, con una circolazione di suggestioni e inquietudini ben al di fuori del mondo medico, l’appli-cazione di categorie psicologiche e psico-patologiche relative ai feno-
48 H. Guillemain, Diriger les consciences, guérir les âmes : une histoire comparée des pratiques thérapeutiques et religieuses 1830-1939, Parigi, 2006; J. Bourke, Divine madness : The dilemma of religious scruples in twentieth-century America and Britain, in Journal of Social History, 42, 2009, p. 581-604.
49 H. F. Ellenberger, The discovery of the unconscious. The history and evolution of dynamic psychiatry, Londra, 1970 (tr. it. La scoperta dell’inconscio. Storia della psicologia dinamica, Torino, 1976)
50 H. Thurston, The physical phenomena of mysticism, Chicago, 1952 (tr. it. Fenomeni fisici del misticismo: levitazione, stigmate, telecinesi, odore di santità, incorruzione, prodigi di sangue, moltiplicazione del cibo, fenomeni luminosi, sala-mandre umane, Alba, 1956).
51 J. Carroy-Thirard, Le mal de Morzine. De la possession à l’hystérie, Parigi, 1981; N. Edelman, Les métamorphoses de l’hystérique. Du début du XIXe siècle à la Grande Guerre, Parigi, 2003.
26 MEDICINA E RELIGIONE: PERCORSI DI LETTURA
meni mistici e diabolici si estende a fonti e fatti storici, risalendo al primo Cristianesimo. Del resto, ciò è all’origine della psicologia reli-giosa in quanto tale, e, come accennato, di una psicologia religiosa cattolica attenta a non esprimere valutazioni sul trascendente52.
Ora, tali riflessi interpretativi non sono del tutto scomparsi, e su due livelli. Da un lato, la vera e propria diagnosi retrospettiva non si ritrova solo nelle opere di studiosi dichiaratamente impe-gnati sul fronte della cosiddetta psychohistory e della psicanalisi storica53 ; dall’altro lato, un settore importante della storia della scienza (più che della medicina) come è la storia della psicologia tende ancora talvolta ad appropriarsi dei complessi teorici e cultu-rali del passato in una costruzione disciplinare del proprio oggetto. D’altro canto, è vero anche che, portate su un terreno storico e applicate ai meccanismi sociali invece che agli individui come ha fatto magistralmente Michel de Certeau, le suggestioni della psicanalisi hanno rappresentato una risorsa preziosa per fare della possessione un oggetto storico a tutto tondo54.
Emerge dunque quanto ancora una volta sia importante prose-guire nell’ibridazione tra la storia sociale e la storia intellettuale interrogando la teologia, la filosofia naturale e la teoria medica più tecnica senza teleologismi. Su queste basi può essere riformulata un’agenda di ricerca propriamente storica sulla malattia mentale e sulla cura spirituale e sacramentale esulando da un’analisi nei termini antropologici o psico-patologici verso i quali talvolta gli stessi ecclesiastici tendono a spingerla55. Sulla stessa base potrà essere più agevolmente riformulata l’intera questione della guari-gione spirituale56.
52 G. Hatfield, Psychology : Old and new, in T. Baldwin (a cura di), The Cambridge history of philosophy 1870-1945, Cambridge, 2003, p. 93-115; G. Cimini, N. Dazzi (a cura di), La psicologia in Italia. Protagonisti e i problemi scientifici, filosofici e istituzionali (1870-1945), Milano, 1998; J. Carroy, A. Ohayon, R. Plas, Histoire de la psychologie en France, XIXe-XXe siècles, Parigi, 2006; A. Demazière, L’inconscient au paradis. Comment les catholiques ont reçu la psychanalyse, Parigi, 2011.
53 Rimando a titolo di esempio ad un classico come J. Maître, ‘L’orpheline de la Bérésina’ : Thérèse de Lisieux (1873-1897) essai de psychanalyse socio-historique,Parigi, 1985.
54 M. de Certeau, La possession de Loudun, Parigi, 1970 (che è stato appena ritradotto in italiano dall’editrice Clueb, Bologna, 2011) ; id., Histoire et psycha-nalyse entre science et fiction, Parigi, 1987.
55 Su questo punto attira l’attenzione il recente F. Chave-Mahir, L’exorcisme des possédés dans l’Eglise d’Occident (Xe-XIVe siècle), Turnhout, 2011.
56 Sulla questione, pur focalizzato sullo spiritual healing tra gli evangelici, apporta un contributo interpretativo notevole J.W. Opp, The lord for the body. Religion, medicine, and Protestant faith healing in Canada, 1880-1930, Montreal-Kingston, 2005.
27MARIA PIA DONATO
Luoghi e momenti della cura
Il complesso alternarsi di collaborazione, competizione e conflitto tra medicina e religione, tra medici ed ecclesiastici emerge con forza quando si oltrepassano le mura dei luoghi della cura.
Abitualmente, questo percorso di ricerca conduce verso l’ospe-dale, nel quale religione e medicina sono consustanziali sin dall’An-tichità : dai santuari e xenodochia alle infermerie monastiche fino agli ospedali che si sviluppano dal XII a seguito delle trasforma-zioni connesse all’urbanesimo, e lo sono tanto nella sovrapposi-zione tra cure corporali e cure spirituali, quanto nell’intreccio istituzionale e sociale. Ciò non è appannaggio della Cristianità, e anzi le istituzioni assistenziali potevano rappresentare concreti spazi di incontro interconfessionale57 e, come mostra Ziegler nel suo saggio, tra le religioni monoteiste esisteva una circolazione di saperi, operatori e pratiche mediche.
Per la natura anfibia che mantengono ben oltre il Medioevo, le istituzioni ospedaliere sono state ampiamente studiate sia nell’ot-tica della storia delle medicina (sono anzi il tema che tradizional-mente invitava anche gli specialisti più internalisti sul terreno della storia sociale della medicina), sia della storia religiosa in relazione allo slancio caritativo di chierici e laici e con riguardo a ordini, persone, città. Nella gestione degli ospedali, inoltre, si consolida l’intreccio tra élites ecclesiastiche e civili e potere politico che gli storici hanno indagato sia in una prospettiva di storia della Chiesa che di storia sociale ed urbana, e che si prolunga in varie configu-razioni fino al welfare contemporaneo58.
Ai nostri fini, si può aggiungere per inciso che resta da appro-fondire l’analisi dell’interazione tra medici e religiosi e le altre figure presenti in ospedale, maschili e femminili59, prestando attenzione
57 M. Bonner, M. Ener, A. Singer (a cura di), Poverty and charity in Middle Eastern contexts, Albany, 2003.
58 Almeno per l’ambito italiano cfr. M. L. Betri, E. Bressan (a cura di), Gli ospedali in area padana fra Settecento e Novecento : atti del 3. Congresso italiano di storia ospedaliera : Montecchio Emilia, 14-16 marzo 1990, Bologna, 1992; S. Cavallo, Charity and power in early modern Italy : Benefactors and their motives in Turin, 1541-1789, Cambridge, 1995; A. Pastore, M. Garbellotti (a cura di), L’uso del denaro : patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia, secoli 15.-18., Bologna, 2001; J. Barry, C. Jones (a cura di), Medicine and charity before the welfare state, Londra, 2003; in prospettiva comparativa cfr. J. Henderson, P. Horden, A. Pastore (a cura di), The impact of hospitals, 300-2000, Oxford, 2007.
59 La storiografia più interessante riguarda in effetti le religiose perché integra diverse prospettive anche nei lavori di qualche anno fa come J.-P. Rouleau, La religieuse hôspitalière canadienne dans une société en transformation, Quebec, 1974; Y. Knibiehler e al., Cornettes et blouses blanches : les infirmières dans la
28 MEDICINA E RELIGIONE: PERCORSI DI LETTURA
alle pratiche senza una rigida dicotomia tra cure spirituali e corpo-rali, le quali non corrispondono in maniera automatica all’am-bito religioso e al medico, ma hanno delle valenze terapeutiche più complesse e integrate. Tale indicazione vale sia per il periodo medievale e moderno60, sia per il contemporaneo, specie se si mette in conto la rivendicazione di un valore curativo della fede (la reli-gione come medicina) che ha animato in particolare il nursingcattolico e di altre confessioni sin da quando si è definito come tale sullo sfondo della modernizzazione delle professioni infermie-ristiche61. Del resto, se si volesse rimarcare una volta di più quanto siano stretti i nessi che l’agenda storiografica intrattiene con l’at-tualità, l’integrazione delle pratiche di cura ora definite comple-mentari invece che alternative nella routine ospedaliera, comprese quelle schiettamente religiose, è materia di dibattito, almeno negli Stati Uniti62.
In questo volume, tuttavia, la strada intrapresa è diversa, e conduce verso un altro luogo topico nel quale l’elaborazione di conoscenze sul corpo, la vita e la salute si intreccia con le regole e i valori religiosi : i conventi e le case generalizie degli ordini.
I monasteri medievali, che come tutti sanno hanno giocato un ruolo fondamentale nella trasmissione dell’eredità intellettuale antica compresa quella medica e farmacologica, sono oggetto di una consolidata tradizione di studi, che negli ultimi decenni ha visto l’innesto di nuove tematiche sul fusto rigoglioso delle ricerche di taglio storico-filologico. Un’attenzione alle tematiche di genere,
société française, 1880-1980, Parigi, 1984; U. Stepsis, D. Liptak (a cura di), Pioneer healers : The history of women religious in American health care, New York, 1989. Per l’età moderna, limitatamente alla Francia, L. S. Greenbaum, Nurses and doctors in conflict : Piety and medecine in the Paris Hôtel-Dieu on the eve of the French Revolution, in Clio Medica, 13, 1978-1979, p. 247-268; C. Jones, The chari-table imperative : Hospitals and nursing in ancien régime and revolutionary France,Londra, 1989; id., Sisters of Charity and the ailing poor, in Social History of Medicine,2, 1989, p. 339-348.
60 J. Henderson, The Renaissance hospital : Healing the body and healing the soul, New Haven, 2006; B. S. Bowers (a cura di), The medieval hospital and medical practice, Aldershot, 2007.
61 G. B. Risse, Mending bodies, saving souls : A history of hospitals, New York, 1999; B. Mann Wall, American Catholic hospitals : A century of changing markets and missions, New Brunswick-Londra, 2011. Cfr. anche, seppur solo in parte rela-tivi agli ospedali, P. Gouk (a cura di), Musical healing in cultural contexts, Aldershot, 2000; P. Horden (a cura di), Music as medicine : The history of music therapy since Antiquity, Aldershot, 2000.
62 A seconda dei punti di vista, poi, se religioso e clinico, o se con l’intenzione di unirli come nel recente M. H. Cohen, Healing at the borderland of medicine and religion, Chapel Hill, 2006, si pone in modo diverso se e con quali parametri clinici valutare la loro efficacia.
29MARIA PIA DONATO
in particolare, si è accompagnata a una revisione implicita della concezione della medicina come corpus di teorie e conoscenze, ampliando lo sguardo verso le pratiche e investendo criticamente la già accennata dicotomia tra cure corporali e spirituali63 ; inoltre si esplorano aspetti integranti dei saperi medicinali già spesso espunti dalle storie classiche della medicina come la divinazione rileggendo vari tipi di fonti64. Viene così indebolita l’abitudine consolidata di distogliere lo sguardo dalle istituzioni monastiche dopo il XIII secolo per rivolgere l’attenzione a quelle secolari in via di affermazione (scuole, università, organizzazioni collegiali etc.)65. Su tali questioni interviene qui Moulinier utilizzando il prisma della medicina divinatoria e mettendo in dubbio l’opportu-nità di operare cesure nette in un lungo Medioevo.
Per quanto riguarda le epoche successive, invece, le case reli-giose sono un argomento davvero secondario nella storia del sapere medico, se si esclude un interesse mirato verso la produ-zione medicinale (botanica e chimica). Comunque, a stimolare nuove riflessioni interviene il rinnovato slancio delle ricerche sugli ordini religiosi, che si concentrano ora volentieri sul loro ruolo culturale. Così, in questo volume Andretta entra nelle case reli-giose della Roma della Controriforma per indagare quali saperi del corpo circolassero tra spazi ecclesiastici e spazi secolari e come.
Passando dai luoghi ai momenti della cura, innegabilmente i momenti cruciali per la compresenza di aspetti religiosi e medici, e per la compresenza non sempre pacifica del prete e del medico (o di un altro operatore sanitario), sono soprattutto l’inizio e la fine della vita. E qui si distende un altro complesso panorama storiografico, continuamente rimodellato dalle sollecitazioni del presente.
La morte, come è noto, è diventato un tema storiografico a tutto tondo con la storia delle mentalità negli anni Sessanta e Settanta, grazie ai magistrali lavori di Philippe Ariès, di Michel Vovelle e di
63 C. Burnett, P. Dronke (a cura di), Hildegard of Bingen: The context of her thought and art, Londra 1998; A. Haverkamp (a cura di), Hildegard von Bingen in ihrem historischen Umfeld : Internationaler wissenschaftlicher Kongress zum 900jährigen Jubiläum, 13-19 September 1998, Bingen am Rhein, Magonza, 2000; H. Strickerschmid, Geerdete Spiritualität bei Hildegard von Bingen: neue Zugänge zu ihrer Heilkunde, Berlino, 2008.
64 N. Weill-Parot, Les ‘images astrologiques’ au Moyen Âge et à la Renaissance. Spéculations intellectuelles et pratiques magiques, Parigi, 2002; G. Xhayet, Médecine et arts divinatoires dans le monde bénédictin médiéval à travers les réceptaires de Saint-Jacques de Liège, Parigi, 2010.
65 Cfr. anche il recente contributo di A. Montford, Health, sickness, medicine and the Friars in the thirteenth and fourteenth centuries. The history of medicine in context, Aldershot, 2004; ead., ‘Brothers who have studied medicine’ : Dominican friars in thirteenth-century Paris, in Social History of Medicine, 24, 2011, p. 535-553.
30 MEDICINA E RELIGIONE: PERCORSI DI LETTURA
altri, in un’epoca in cui le scienze umane prendevano ad occupar-sene ispirate dalle trasformazioni sociali e dai progressi tecnolo-gici sorprendenti (il primo trapianto di cuore risale al 1967)66. Da allora è rimasto un argomento di ricerca importante e sempre più poliedrico67.
In quella stagione, gli storici della medicina non hanno mancato di indagare i risvolti religiosi della deontologia dei medici in prospettiva storica e continuano a farlo, prendendo parte – talvolta in modo partigiano, dato anche l’incardinamento istituzionale in cui resta gran parte della storia della medicina a cui si è alluso all’inizio – a un dibattito pubblico sul fine vita che è costantemente ravvivato dagli avanzamenti della ricerca e delle tecniche di inter-vento e di mantenimento biologico artificiale68. In questo volume, Crisciani affronta lo studio della morte dalla visuale medievale del dibattito sulla prolongatio vitae. L’analisi delle dottrine filosofiche in filigrana a quelle teologiche rivela come la cultura scolastica tre-quattrocentesca sia caratterizzata da una marcata autonomia tra medicina e teologia, che condividono interrogativi, categorie inter-pretative e regole ermeneutiche di matrice aristotelica senza però confondersi l’una nell’altra.
Nella Controriforma, quando la Chiesa si propone come arbitra, oltre che delle anime, dei corpi e di chi ne ha le cure, la pressione confessionale sui dottori in medicina (e sui mestieri sanitari inferiori) si accentua. La difficoltà di misurarne gli esiti è commisurata alla natura composita di ciò che si intende comune-mente per medicalizzazione; inoltre, si presta ad interpretazioni dissonanti a seconda che si privilegi la letteratura deontologica,
66 A. Tenenti, Il senso della morte e l’amore nella vita del Rinascimento, Torino, 1957; R. Favre, La mort dans la littérature et la pensé française au siècle des Lumières, Lyon, 1978; P. Ariès, L’homme devant la mort, Paris, 1977 (tr. it. L’uomo e la morte dal medioevo a oggi, Roma-Bari, 1980) ; J. McManners, Death and the Enlightenment : Changing attitudes to death among Christians and unbelievers in eighteenth-century France, Oxford, 1981 (tr. it. Morte e illuminismo: il senso della morte nella Francia del 18° secolo, Bologna, 1984) ; M. Vovelle, La mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Paris, 1983 (tr. it. La morte e l’Occidente : dal 1300 ai giorni nostri, Roma-Bari, 1993).
67 M. Sozzi, Reinventare la morte. Introduzione alla tanatologia, Roma-Bari, 2009.68 Tra i contributi in tal senso v. D. A. Amundsen, Medicine, society, and faith
in the ancient and medieval worlds, Baltimora, 1996; H. Flashar, J. Jouanna (a cura di), Médecine et morale dans l’Antiquité, Ginevra, 1997; D. Jacquart, Le difficile pronostic de mort (XIVe-XVe siècles), in Médiévales, 46, 2004, p. 11-22. In tutt’altra ottica, invece, si sono mossi quanti hanno indagato le pratiche mediche post mortem con attenzione alla dimensione religiosa (riparatoria o contempla-tiva), ricordo qui almeno A. Carlino, La fabbrica del corpo: libri e dissezione nel Rinascimento, Torino, 1994.
31MARIA PIA DONATO
la trattatistica scientifica oppure la relazione clinica attraverso fonti diverse capaci di includere il punto di vista del paziente69.Considerare la medicalizzazione dell’esperienza umana solo un effetto del crescente ruolo ed efficacia della medicina può essere fuorviante perché diversi aspetti hanno una radice religiosa, come ho cercato io stessa di mostrare in relazione alla rianimazione70,sebbene in prospettiva si traducano in un potenziamento dell’au-torità del medico, rispetto alla quale l’autorità religiosa si deve riposizionare. Così, la possibilità di prolungare la vita con l’ausilio medico ai fini sacramentali si carica per la Chiesa e la medicina cattolica nel corso dell’Ottocento e del Novecento di una sfumatura schiettamente antiumanistica e antitecnologica71, e oggi si identi-fica sostanzialmente con l’indisponibilità della vita per il soggetto. In altre parole, è una questione di alleanze.
In verità, per quanto riguarda la nascita, storicamente la conver-genza tra medico e parroco – e lo stato - si realizza agevolmente almeno su un terreno che è insieme religioso, sociale e di genere, e che è stato perciò oggetto di attenzione soprattutto nell’ambito della storia delle donne e del genere. Mi riferisco alla regolazione e limitazione dell’attività delle protagoniste femminili del parto, sia in senso stretto con riguardo a levatrici e ostetriche, che in senso più ampio, riguardo alla gestante/partoriente72. La storia del parto cesareo, che sin dagli esordi è un parto a tutti gli effetti medi-
69 È soprattutto la storiografia inglese ad aver ampliato il ventaglio delle fonti per lo studio dell’atteggiamento verso la morte e della relazione tra medico e paziente, come D. Porter, R. Porter, Patient’s progress : Doctors and doctoring in eighteenth-century England, Oxford, 1989; I. Mortimer, The dying and the doctors : The medical revolution in seventeenth-century England, Woolbridge, 2009.
70 M. P. Donato, Morti improvvise. Medicina e religione nel Settecento, Roma, 2010.71 A. Carol, Les médecins et la mort : XIXe-XXe siècle, Parigi, 1994; G. Cosmacini,
G. Vigarello (a cura di), Il medico di fronte alla morte (secoli XVI-XXI), Torino, 2008.72 La bibliografia su questo aspetto è molto ampia, sebbene per la verità non
sempre dedichi particolare attenzione all’interazione tra ecclesiastici e medici, ricordo comunque C. Pancino, Il bambino e l’acqua sporca. Storia dell’assistenza al parto dalle mammane alle ostetriche (secoli XVI-XIX), Milano, 1984; J. Gélis, La sage-femme ou le médecin : une nouvelle conception de la vie, Parigi, 1988; M. Greilsammer, The midwife, the priest, and the physician: The subjugation of midwives in the Low Countries at the end of the Middle Ages, in Journal of Medieval & Renaissance Studies, 21, 1991, p. 285-329; A. Wilson, The making of man-midwifery : childbirth in England, 1660-1770, Cambridge (Mass.), 1995; S. Fluegge, Hebammen und heilkundige Frauen: Recht und Rechtswirklichkeit im 15. Und 16. Jahrhundert,Frankfurt, 1998; B. Duden, J. Schlumbohm, P. Veit (a cura di), Geschichte des Ungeborenen: zur Erfahrungs- und Wissenschaftsgeschichte der Schwangerschaft, 17.-20. Jahrhundert, Gottinga, 2002; A. Prosperi, Dare l’anima: storia di un infan-ticidio, Torino, 2005; M. Green, Making women’s medicine masculine : The rise of male authority in premodern gynaecology, Oxford, 2008.
32 MEDICINA E RELIGIONE: PERCORSI DI LETTURA
calizzato e che si afferma in parallelo al trasferimento di diritto dalla madre al nascituro, illustra come istanze religiose e istanze mediche possano alimentarsi vicendevolmente a condizione che la donna vi soccomba73.
La dottrina cattolica rimarrà ancorata, più o meno rigida-mente, ad una visione oblativa della donna, indipendentemente dai progressi della medicina e dell’ostetricia74. La categoria di diritto riproduttivo, analizzata qui da Turina, è oggi diventata il crinale su cui si è assestato lo scontro/confronto tra Magistero pontificio e organizzazioni politiche secolari, che concerne comunque la disponibilità del corpo femminile.
E’ chiaro che i termini della questione mutano in relazione alle possibilità medico-tecniche di manipolazione, incommensu-rabilmente superiori nella biomedicina contemporanea che apre scenari completamente inediti. Così, se dalla nascita si risale alla generazione, l’armonia tra precetti medici e religiosi che caratte-rizzava la genetica avant-la lettre75, cede il passo al sospetto e al rifiuto appena l’intervento del medico si profila come un intervento davvero attivo, come mostra qui Betta a proposito delle prime tecniche di fecondazione artificiale nel XIX secolo.
La medicalizzazione della nascita e della morte, dunque, segue binari solo apparentemente paralleli. A fronte di processi storici non lineari, il contributo degli storici può essere quello di artico-lare con finezza le scansioni temporali, cogliendo i momenti e i modi in cui gli equilibri vengono rimessi in discussione, in uno o più aspetti simultaneamente o successivamente.
73 N.M. Filippini, La nascita straordinaria : tra madre e figlio la rivoluzione del taglio cesareo, sec. 18.-19., Milano, 1995.
74 J. Ryan, The chapel and the operating room: The struggle of Roman Catholic clergy, physicians, and believers with the dilemmas of obstetric surgery, 1800-1900,in Bulletin of the History of Medicine, 76, 2006, p. 461-494; E. Betta, Animare la vita : disciplina della nascita tra medicina e morale nell’Ottocento, Bologna, 2006. In un contesto molto mutato e con le dovute differenze, l’incerta determinazione dei diritti e la gerarchia tra i soggetti di diritto è oggi al centro dei dibattiti circa le cure neonatali dei cosiddetti grandi prematuri, cfr. per la situazione italiana il pano-rama (nell’ottica medica e bioetica) di M. L. Pignotti, All’alba della vita. Gli incerti confini delle cure intensive neonatali, Firenze, 2008; P. Guarnieri (a cura di), In scienza e coscienza. Maternità, nascite e aborti tra esperienza e bioetica, Roma, 2009.
75 J. Roger, Les sciences de la vie dans la pensée française du XVIIIe siècle : la génération des animaux de Descartes à l’Encyclopédie, Parigi, 1963; utile, seppur sul contesto riformato, M. E. Fissel, Vernacular bodies : The politics of reproduction in early modern England, Oxford, 2004.
33MARIA PIA DONATO
Un programma di lavoro
I contributi di questo volume mostrano come, in maniera mute-vole, ogni epoca abbia sperimentato dei conflitti di competenza tra la sfera religiosa e il mondo medico circa la conoscenza fisiologica, biologica e clinica del corpo e più in generale la comprensione della natura. Mostrano anche come, nel tempo lungo, i rapporti tra religioso e medico si possano concepire anche in termini di compe-tizione e di collaborazione.
E’ chiaro che l’adozione di un arco cronologico ampio non deve in nessun modo obliterare le incommensurabili asimmetrie tra i periodi. Anche dal punto di vista epistemologico, il rapporto tra medicina e religione non ha gli stessi enjeux a seconda del momento storico in cui si situa, né ha lo stesso potenziale euristico. Come ha scritto de Certeau, «ciò che gli uomini del passato dovevano spie-gare attraverso una verità (Dio, la provvidenza), è diventato ciò che ci rende intelligibili le loro spiegazioni»76.
Nondimeno, gli studi qui riuniti mostrano come la medi-cina e la religione possano proficuamente essere considerate due sistemi – dalla coerenza variabile nel tempo – che tendono a rego-lare le pratiche sociali, informarle e dirigerle secondo i principi del proprio sapere, organizzandosi per controllare l’accesso alle conoscenze e all’esercizio di specifiche competenze. Sistemi rivali che tuttavia condividono i meccanismi della loro funzione sociale, che hanno per secoli condiviso gli strumenti intellettuali e cognitivi con cui operavano, e che si sono incontrati e continuano ad incon-trarsi nel vivo del corpo sociale, operando nelle istituzioni di cura, insegnamento e governo dei bisogni.
Si tratta insomma, per usare un termine foucaultiano, di dispo-sitivi di sapere/potere all’interno dei quali lo storico può porsi l’obiettivo di valutare l’autonomia relativa e rispettiva dei saperi e delle pratiche che ogni volta sono in una modalità di relazione tanto nella riflessione teorica quanto nell’ambito, assai più arti-colato e dinamico, della pratica sociale. Nella consapevolezza che si tratta di dispositivi instabili, al centro di negoziazione costante tra attori diversi anche esterni alle due sfere in questione – tra i quali certamente il potere politico, sia esso pre-statale o statuale moderno – e che danno luogo a fenomeni mutevoli di adattamento e resistenza. Un programma ambizioso, innegabilmente.
Maria Pia DONATO
Università di Cagliari
76 M. de Certeau, L’inversion du pensable…cit., p. 148.