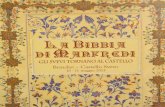Vetri iscritti da Copia-Thurii. Ultimi bagliori da una città del Bruzio (con S. Luppino)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Vetri iscritti da Copia-Thurii. Ultimi bagliori da una città del Bruzio (con S. Luppino)
RICERCHE
C!""#$# %&" D'(#)*'+&$*! %' A),-&!"!.'# & S*!)'# %&""& A)*'
VII
Il vetro in Italia:testimonianze, produzioni, commerci
in età basso medievale.
Il vetro in Calabria:vecchie scoperte, nuove acquisizioni.
Atti XV Giornate Nazionali di Studio sul Vetro A.I.H.V.
Università della Calabria
2012
a cura diA%&"& C!/,#)&""#
Università della CalabriaAula Magna, 9-11 giugno 2011
II
C!!"#$%&'(%)! *+$(%)$,$+!: Ermanno A. Arslan, Maurizio Buora, Adele Coscarella,Maria Grazia Diani, Annamaria Larese, M. Giuseppina Malfatti, Luciana Mandruzzato,Cesare Moretti+, Francesca Seguso, M. Cristina Tonini, Marina Uboldi
C!'$)&)! !"-&%$..&)!"(: Adele Coscarella, Maria Grazia Diani, Cesare Moretti+
C!'$)&)! #$ "(/$*$!%( *+$(%)$,$+& #($ )(*)$: Adele Coscarella, Maria Grazia Diani,Luciana Mandruzzato, Teresa Medici, M. Cristina Tonini, Marina Uboldi
E#$)!" '&%&-(": Giuseppe Francesco Zangaro
C!!"#$%&'(%)! &0)!"$: Anna Caputo
D$"())!"( #(11& C!11&%&: Giuseppe Roma
R(+&2$)$:Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti - Università della CalabriaPonte P. Bucci, Cubo 21b - 87036 Arcavacata di Rende (Cs) - Tel. 0984 494315 - Fax 0984 494313
©2012. Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti - Università della Calabria.È vietata la riproduzione non espressamente autorizzata anche parziale o ad uso internoo didattico con qualsiasi mezzo e3ettuata.
Volume pubblicato con il contributo della Facoltà di Lettere e Filoso4ae del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell'Università della Calabria.
ISBN 978-88-903625-76
In copertina: Calice da Celico, chiesa di San Michele. Curia arcivescovile di Cosenza (foto G. Archinà per StudioPrimoPiano).
Enti promotori Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti - Università della Calabria, Comitato Nazionale Italiano Association Internationale pour l’Histoire du Verre (A.I.H.V.)
Con il contributo di
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti - Università della Calabria Facoltà di Lettere e Filoso4a - Università della Calabria
Istituti Riuniti di Vigilanza
Impresa Regionale Servizi
Studio Consenso
353
Vetri iscritti da Copia !urii. Ultimi bagliori da una città dei BruttiiAlessandro D’Alessio, Silvana Luppino
!e excavations carried out on several occasions from 1969 to the present day in the site of the Roman city of Copia have returned a signi"cant amounts of glass materials, whose state of preservation, usually fragmentary, induced to operate a strict selection of the most signi"cant pieces already at the time of the edition of the 5 preliminary reports in Notizie degli Scavi. From recent excavations, instead, come the two "nds subject of this paper, that the intrinsic characte-ristics and context of discovery clearly isolate themselves from the others of di#cult assignment.
!e "rst of them is what remains of a beaker due to the well known production of the so-cal-led “sidonian” masters ("rst century AD), bearing an inscription surely integrable Ȁǹȉǹȋ [ǹǿȇǼ Ȁǹ, ǼȊĭȇǹǿȃȅȊ], the only of its kind, with the exception of another from the necropolis of Cornus in Sardinia, found in Southern Italy.
To the Late Antiquity is dating the second "nding: a fragmentary bottle Isings 103, on whi-ch are preserved the remains of a very interesting Greek inscription, only partly intelligible, but without doubt one of the oldest evidence of spread of Christianity in Calabria.
Le campagne di scavo condotte a più riprese dal 1969 ad oggi nel sito della colonia latina di Copia (193 a.C.), municipium dall’89 a.C. ed in vita -no al VII secolo d.C., hanno restituito rilevanti quantità di reperti vitrei riconducibili a svariate tipologie, il cui stato di conservazione, generalmente frammen-tario, indusse ad operare una rigida selezione degli esemplari più signi-cativi già all’epoca dell’edi-zione dei 5 rapporti preliminari in Notizie degli Scavi1. Per dare un’idea, si segnala il totale di 1.381 frammenti censiti qualche anno fa da D. De Presbiteris2, provenienti da una sola delle tre grandi aree scavate nella campagna del 1975, rimasta inedita, ovvero l’area di Parco del Cavallo, che rappresenta il centro di Copia .urii ("g. 1).
Da scavi più recenti3 provengono invece i due reperti oggetto del presente contributo, che per le loro peculiarità intrinseche e per il contesto di rinvenimento, si distaccano nettamente dalla congerie di frammenti vitrei di di/cile attribuzione morfologica, presenti sopratutto nei livelli di abbandono della città. Si tratta, infatti, di un bicchiere e di una bottiglia frammentari, entrambi con iscrizioni in greco, ben inquadrabili sul piano sia tipologico che cronologico.
Per quanto riguarda il bicchiere, che tratteremo nelle pagine immediatamente seguenti, esso è sta-to rinvenuto nel 1999 nel corso degli scavi condotti all’esterno della Porta Nord di Copia, nell’area a destinazione funeraria ubicata lungo i lati Est e Ovest della plateia A ("g. 2). La necropoli presenta almeno due diverse fasi di utilizzo, di cui la prima con grandi mausolei databile tra I e II secolo d.C.,
1 Sibari I, 1969; Sibari II, 1970; Sibari III, 1972; Sibari IV, 1974; Sibari V, 1988-89.2 Luppino, De Presbiteris 2003: 496 ss.3 Greco, Luppino 1999.
355
Fig. 3. Sibari-.urii-Copia. Mausolei e tombe fuori Porta Nord (da Greco, Luppino 1999).
Fig. 2. Sibari-.urii-Copia. Porta Nord: pianta dell’area funeraria.
356
la seconda con gruppi di sepolture ad inumazione di varia tipologia (cassa di laterizi con copertura di tegole piane, alla cappuccina, cassa di tegole o fossa terragna), disposte intorno ai mausolei e, nel settore occidentale, anche all’interno dell’edi-cio settentrionale, a partire dalla -ne del II e per tutto il III secolo d.C. e oltre ("g. 3)4. Alcune delle tombe si presentavano già manomesse in antico e per lo più depredate, per cui in genere non molto signi-cativi sono i resti dei corredi funerari. In particolare, l’US 77, da cui proviene il manufatto in esame, è indicativa della situazione stratigra-ca relativa ai livelli di abbandono della necropoli: il materiale ceramico recuperato si dispone infatti in un arco cronologico piuttosto ampio: dal vasellame in terra sigillata italica all’anfora Dressel 2-4, -no alla coppa in terra sigillata africana A 1/2 (Hayes 10) ed alle patine cinerognole5.
S. L.
Il primo rinvenimento che presentiamo è un frammento di bicchiere iscritto in vetro so/ato a stampo bipartito, di colore verde chiaro trasparente ("g. 4), riconducibile alla ben nota produzione dei c.d. maestri “sidonii” del I secolo d.C. Si tratta infatti di un vaso con orlo lievemente esoverso tagliato a spigolo vivo, del diametro ricostruibile di cm 7,2, e corpo cilindrico decorato a rilievo; l’altezza del frammento conservato (a sua volta ricomposto da quattro frammenti combacianti) è pari a cm 4,8 su un totale presumibile di 7,8, mentre lo spessore massimo della parete eccede appena il millimetro. In base ai numerosi confronti con altri manufatti analoghi, la decorazione può essere così integralmente ricostruita: due palmette stilizzate verticali, poste in posizione simmetrica lungo la circonferenza del vaso (alle linee di giuntura dello stampo), ne suddividono la sintassi in parti eguali; dall’alto verso il basso si susseguono due listelli paralleli e una duplice coppia di palmette stilizzate e contrapposte, le quali si stendono orizzontalmente al di sopra di un’iscrizione o motto certamente integrabile in Ȁǹȉǹȋ[ǹǿȇǼ Ȁǹ, ǼȊĭȇǹǿȃȅȊ@ (Rallegrati e sii di buon animo); subito al di sotto, nella porzione non conservata del vaso, correvano altri due listelli paralleli e un ramo orizzontale continuo a piccole foglie oblique, posto immediatamente sopra il fondo.
Ora, la tipologia di questi piccoli ed eleganti vasi, già impostata da D. B. Harden negli anni ‘30 e ‘40 del secolo scorso6, si è via via arricchita di nuove testimonianze, che non hanno tuttavia in-ciato il quadro sostanziale tracciato dallo studioso, semmai integrandolo e precisandolo. Conseguentemente, anche il nostro bicchiere viene a inserirsi a pieno titolo nel Gruppo F della sua sinossi, e precisamente nel sotto-gruppo F ii, i cui esemplari recano appunto la più corretta forma verbale ȀǹȉǹȋǹǿȇǼ, laddove nella pur di3usa serie F i ricorre invece ȀǹȉǹǿȋǹǿȇǼ7. Altra caratteristica distintiva, che pure ci consente di assegnare lo specimen di Copia al secondo ambito tipologico/paleogra-co, è poi costituita dalla forma della ǹ, lettera che ricorre cinque volte nell’iscrizione e che presenta una barretta risalente dall’estremità inferiore del tratto obliquo di sinistra negli esemplari del sottogruppo F ii8, mentre in quelli della serie F i essa assume le sembianze di una minuscola ‘v’ ("g. 5). In-ne, l’appartenenza al repertorio F ii è conferma-ta anche dalle proprietà dimensionali del manufatto, il cui diametro all’orlo è come detto ricostruibile in
4 P. Munzi, in Greco, Luppino 1999: 131, 136; M. T. Granese, ibidem: 141 ss.5 L’US 77 corrisponde al livello di accumulo individuato all’interno del perimetro del monumento funerario con fac-ciata ad esedra. Era uno strato di terreno bruno scuro, ricco di materiali ceramici, molto simile a quello soprastante e che copriva le rasature delle strutture.6 Harden 1935, con bibl. precedente; Id. 1944-45.7 Harden 1935: 171-173. Per una rassegna pressoché completa dei bicchieri del Gruppo F si vedano inoltre McClellan 1983: 76-77, Stern 2000, Ead. 2001: 53-55, 125-126; von Saldern 2004: 251 e Arveiller-Dulong, Nenna 2005: 183, tutti con bibl. Più in generale sulla produzione in vetro so/ato dentro matrice v. tra gli altri Stern 1995, Wight 2001 e la bibliogra-a citata infra, nota 12.8 «An upward-slanting slash» in Stern 2000: 166.
357
cm 7,2, in perfetta corrispondenza con gli esemplari integri del medesimo tipo, a fronte di un diametro lievemente maggiore (cm 7,5/7,6) in quelli F i, nei quali è pure attestato il basso piede ad anello.
Nel complesso, i vasi del Gruppo F mostrano una discreta di3usione geogra-ca a partire dalla metà e seconda metà del I secolo d.C. In Italia e lungo la costa orientale dell’Adriatico, bicchieri come questi sono notoriamente attestati in diverse zone del centro-Nord (da Tarquinia a Castelleone di Suasa presso Ancona, dalla necropoli di Craveggia in Piemonte -no a Zara in quella di Nona per quanto concerne la serie F i)9, mentre il vaso di Copia e un altro da Cornus in Sardegna10 sono a quanto ci consta gli unici ritrovati al sud e i soli peraltro della varietà F ii. Più numerosi risultano invece i rinve-nimenti e3ettuati altrove e gli esemplari conservati in Musei e collezioni private europei, statunitensi e del Vicino Oriente: dalla Svizzera al Mar Nero, in Grecia e specialmente a Cipro e in Palestina e
9 Tarquinia-Corneto: Fiorelli 1876: 38; Castelleone di Suasa: Helbig 1884: 203 s.; Zara-necropoli di Nona: Ravagnan 1994a: 17, 124, n. 232; cfr. Larese 2004: tav. VII, n. 232. A questi si aggiunge un esemplare al Museo di Firenze: Laviosa 1958.10 Taramelli 1914: 271, -g. 30.
Fig. 5. Bicchieri iscritti “Harden F i e ii” (da Stern 2000).
Fig. 4. Sibari-.urii-Copia. Area funeraria fuori Porta Nord (scavi 1999, US 77): frammento di bicchiere con iscrizione Ȁǹȉǹȋ>ǹǿȇǼ�Ȁǹ,�ǼȊĭȇǹǿȃȅȊ@ (foto A. D’Alessio, dis. L. Di Santo).
358
Siria11, dove l’intera produzione “sidonia” ebbe origine nel secondo quarto del I secolo d.C.12. Di qui essa si irradiò nel bacino del Mediterraneo e in area continentale con percorsi e modalità di di3usio-ne che restano ancora da precisare, ma che vertono in sostanza sull’esportazione, nei diversi mercati dell’Impero, di manufatti realizzati in un singolo centro (Sidone?) o in una serie di centri locali collegati, e/ovvero sulla migrazione di artigiani e botteghe, e dunque degli stampi necessari alla fabbricazione dei vasi, a Cipro e in Grecia, in Italia e altrove13.
A questo interrogativo è evidentemente legata anche l’interpretazione del bicchiere di Copia – l’u-nico del genere, come si è già sottolineato, rinvenuto -nora in Italia meridionale dopo quello di Cornus. Ci riferiamo chiaramente alle ragioni della presenza di un vaso “sidonio” iscritto ȀǹȉǹȋǹǿȇǼ�Ȁǹ,�ǼȊĭȇǹǿȃȅȊ in una periferica seppur gloriosa città dei Bruttii. Sebbene non direttamente associato a una sepoltura14, la sfera funeraria sembra in ogni caso probabile per il contesto di utilizzo ultimo, o meglio di deposizione, del prezioso manufatto, in linea con quanto veri-cato per altri bicchieri dello stesso tipo: pensiamo ad esempio a quello della serie F i dalla necropoli di Nona a Zara e, di nuovo, a quello F ii dalla necropoli sarda di Cornus. Del resto, la cronologia stessa dei mausolei di Porta Nord appare largamente compatibile con la datazione del vaso, come di altri vetri rinvenuti nell’area15. Di certo, la funzione primaria del bicchiere con il relativo motto non doveva però essere che potoria e con-viviale, legata al consumo del vino e beneaugurante – di sapore “epicureo” saremmo tentati di dire. Ma appunto di un’ispirazione che travalica i piaceri e i con-ni stessi dell’esistenza, per dilatarsi nell’oscuro regno dell’oltretomba in una pur ricercata prospettiva di vita ultraterrena.
Altra questione è invece se il bicchiere sia stato importato a Copia direttamente dall’Oriente – come riteniamo probabile, vista la singolarità stessa del rinvenimento nell’intero panorama dell’Italia meridio-
11 V. supra bibliogra-a di riferimento.12 McClellan 1983: 71 ss. Questa risulta costituita allo stato attuale da un repertorio di 13 gruppi, variamente apparentabili per forma, stile della decorazione ed epigra-a.13 Sintesi della problematica (a partire dall’attività del vitrarius siriaco Ennione) in Harden 1935 e Id. 1987: 153, McClellan 1983, Ravagnan 1994b: 376-377, Bonomi 1996: 15-16, Stern 2001, von Saldern 2004: 237-245.14 Ma v. supra riguardo la destinazione funeraria dell’area fuori Porta Nord.15 Fra i quali si segnalano due bicchieri di diversa tipologia dalla stessa US 77.
Fig. 6. Sibari-.urii-Copia. Parco del Cavallo (scavi 1994, Saggio 10, US 1):frammenti di bottiglia iscritta tipo Isings 103 (foto A. D’Alessio).
359
nale –, o attraverso la mediazione di un diverso mercato, o se non si debba addirittura pensare a una sua produzione in loco. Se così fosse, dovremmo ipotizzare la presenza a Copia, se non di artigiani “sidonii”, quantomeno degli stampi fabbricati da quelli, o riprodotti altrove, e giuntivi in qualche modo entro la -ne del I secolo. Un’ipotesi, però questa, allo stato attuale indimostrabile e tutto sommato remota, a cui resta più in generale preferibile quella di un’importazione di prodotti e merci, anche di pregio, che poneva la città lungo le principali rotte commerciali del Mediterraneo nella prima età imperiale.
Alla tarda antichità e oltre – all’alba di un mondo nuovo, è lecito dire – ci riporta invece il secondo rinvenimento che qui presentiamo ("g. 6). Si tratta di 17 frammenti parzialmente ricomponibili (frr. I, II, III,1-3, IV,1-2, V,1-5, VI e VII,1-4) di una bottiglia in vetro di un intenso colore verde, realizzata con la tecnica della so/atura libera, su cui si conservano gli scarsi resti di una complessa e interessan-tissima iscrizione in greco a lettere maiuscole incise, solo in parte intellegibile. Infatti, se la notevole frammentarietà e la parziale alterazione della super-cie del vetro non impediscono di ricostruirne con una certa precisione forma, tipologia e schema della decorazione, ben più ardue risultano la trascrizio-ne e comprensione del testo superstite. Ma procediamo con ordine.
La forma della bottiglia è di certo quella di una Isings 103 ("g. 7)16, come indica il pro-lo sia dei fram-menti della pancia e della spalla – sui quali ultimi (III,1-3) si riconosce anche l’attacco del collo –, sia di quelli in cui si conserva una limitatissima parte del fondo (V,1-5)17. Il diametro massimo del contenitore è così ricostruibile in cm 10 ca., quello del fondo a 4 ca., mentre qualche dubbio permane sull’esatto pro--lo e le dimensioni e3ettive del collo, e dunque sull’altezza complessiva del manufatto. La sopravvivenza di due piccoli frammenti del collo stesso (I-II), solcato da due scanalature orizzontali (una posta imme-diatamente sotto l’orlo, l’altra più in basso a una distanza di cm 2) e il confronto con altri oggetti simili (v. infra), ci consentono comunque di proporre una restituzione integrale della bottiglia, per uno sviluppo verticale massimo pari a cm 14 ca. Una restituzione che può essere altresì estesa allo schema decorativo del vaso, costituito, dall’alto verso il basso e senza soluzione di continuità, da due scanalature parallele
16 Isings 1957: 121-122.17 Lo spessore dei frammenti varia da mm 2 del collo e della spalla a mm 1 della parte inferiore della parete.
Fig. 7. Sibari-.urii-Copia. Parco del Cavallo (scavi 1994, Saggio 10, US 1):disegno ricostruttivo della bottiglia (A. D’Alessio, G. Troiano).
360
poste all’altezza della spalla e da tre sottostanti solcature ravvicinate18, cui seguono sei serie accostate di cerchi concentrici centrati sul diametro della pancia19, e in-ne una triplice solcatura e due scanalature parallele poste in prossimità del fondo, con sequenza dunque speculare a quella della spalla.
Su questo articolato registro, realizzato con un sapiente lavoro di intaglio a rotina, sia gli spazi com-presi tra le scanalature e solcature, sia quello subito soprastante la scanalatura alta della spalla, sia anco-ra le aree delimitate dai cerchi concentrici, vengono a costituire i campi epigra-ci di altrettante iscrizioni incise in lettere greche di altezza diversa a seconda della posizione e della super-cie disponibile. I testi si sviluppano di conseguenza su cinque righi sovrapposti e apparentemente continui (rr. a-b-c + e-f)20, con la sola eccezione di quelli all’interno dei cerchi (d1-3
I-VI), distribuiti a loro volta su tre righi21.Ora, sfortunatamente, la scarsa percentuale di conservazione della bottiglia fa sì che l’apparato
epigra-co si presenti pesantemente mutilo e, pertanto, di lettura ed esegesi estremamente di/coltose. Tuttavia, dopo un’attenta osservazione dei frammenti e delle caratteristiche paleogra-che delle iscri-zioni, se ne può tentare quantomeno una trascrizione e una prima, benché parziale interpretazione22.
In base all’esame autoptico dei frammenti, dunque, malgrado non se ne colga ancora l’esatta dispo-sizione sulla tettonica del vaso, i testi possono essere così trascritti:
Fr. III,1-3 Fr. IV,1-2 )U��9���� )U��9,
a. ���@ȂǼǿȃǹ�Ȁǹǿ�Ȉ>���
b. ���@�ǹǼǿȂȃǾȈȉǼ�ȌȊȋǾ�Ȁǹǿ�Ȃȃ>��� >���@
c. ���@ǾȈǿȂǼ�ȀȊȇǿȍ�>���@�ǹ�Ȁǹǿ�ȈȍĬȍ>��� >���@�ǿǻȍ>���@
d.
1
2
3
>���@
>���@ǾȇǼ
>ǽ@ȍǾ
ȀǹȁǼǿ
ǻǼȀǹ
ȁǼ
e. ���@��=+Ȉȍĭ,ȁ>��� ���@72Ȉ�ǻ,$>������@ȃȅȃǿȃǹ�.>���@ ���@721�$17,ȁ$�>���
f. ���@ȍ�Ȇȇ2Ȉ�Ȉ�YHO�2�>��� ���@�.$,�$Ȅ,2Ȉ�ǽȍ+Ȉ�(>���
a. ---]MEINA kaˆ S[---
b. ---] ¢eimn»ste yuc» kaˆ mn[hsqÍ ---
c. ---]»sime kur…ñ [---].A kaˆ swqî[men --- ---].I∆W[---
d. [---] / [---]HRE / [z]w»; kale‹ / DEKA / LE
e. ---]. zÍ Sèfil[--- (vel zÍj vel z»j(aij) ï f…l[e ---]) ---]TOS DIA[--
----]NON INA K[--- ---]TON ANTILA[---
f. ---]W prÕj S(vel O)[--- ---] kaˆ ¥xioj zwÁj E[---
18 La distanza tra le scanalature e solcature è rispettivamente pari a cm 0,5 e 0,6.19 Ciascuna serie è costituita da -tte linee concentriche, comprese tra due ampie scanalature pure circolari, poste a delimitare una super-cie libera di cm 3,1 di diametro. Il diametro complessivo di ogni cerchio è pari a cm 5,1.20 Altezza delle lettere: rigo a. mm 4; rigo b. mm 5; rigo c. mm 6; rigo e. mm 2,5; rigo f. mm 3.21 Altezza delle lettere nei cerchi: mm 4.22 A questo proposito colgo l’occasione per ringraziare sentitamente, per gli utili suggerimenti, i colleghi G. Bevilacqua, A. Coscarella, A. E. Felle, L. Saguì e A. Zumbo, e ancora i Professori V. von Falkenhausen e D. Feissel, fermo restan-do ovviamente che quanto di seguito dirò ricade sotto la mia esclusiva responsabilità scienti-ca.
361
Ebbene, come si vede, gli elementi per una lectio pro-cua dei testi non sono molti, né dirimenti. Tralasciando per ora il rigo a. perché eccessivamente mutilo23, nel rigo b. del frammento III,1-3 si legge chiaramente ¢eimn»ste yuc», ovvero “anima indimenticabile”, “eternamente memorabile”, cui segue un kaˆ MN[--- solo ipoteticamente integrabile in mn[hsqÍ (“che sia ricordata”, “che se ne conservi la memo-ria”), il che manifesterebbe una speranza e un auspicio di ricordo, di nuovo, dell’anima, come riscontrabile in altri casi analoghi: ad esempio nell’iscrizione sepolcrale dall’area sopraterra del cimitero di Pan-lo a Roma, dove ricorre appunto la formula mnhsqÍ yuc¾ per il Karikos lì sepolto nel IV secolo d.C.24. Il tema della morte e della (auspicata) rimembranza dell’anima sembra dunque attestato sulla bottiglia; così come quello della salvezza eterna e dell’invocazione al Signore per conseguirla, quali si ravvisano nel kur…ñ [---].A kaˆ swqî[--- (verosimilmente swqî[men) del rigo c. del medesimo frammento III,1-325.
Più complicata è la lettura e traduzione delle poche parole superstiti di quelle incise all’interno dei cerchi concentrici, che potrebbero individuare brevi motti isolati o una più lunga frase scaglionata lungo la circonferenza del vaso. Ce ne restano comunque solo due serie su sei, per così dire “impaginate” – a quanto pare entrambe – su tre righi sovrapposti (d.1-3): certamente quella nel cerchio del frammento V,1-5; pro-babilmente anche l’altra del frammento IV,1-2. Questa, infatti, conserva soltanto parte del secondo e terzo rigo, dove si riconosce abbastanza facilmente, sotto un non meglio identi-cato tronco di parola [---]HRE, il nominativo [z]w». Di cosa precisamente si tratti non ci arrischiamo a dire, ma per quanto sopra eviden-ziato – e per la frequenza evidentemente elevatissima dell’associazione di termini quali yuc», sèzw nelle sue diverse 9essioni, kÚrioj e appunto zw» nella letteratura e fraseologia patristica26 –, è possibile e forse ragionevole pensare che ci si riferisca qui, ancora una volta, alla vita eterna (dell’anima).
Non meno ardua risulta la cognizione di quanto è scritto nell’altro cerchio superstite (fr. V,1-5), dove si osserva un kale‹, e poi DEKA / LE, ma francamente, a parte il “chiama” del primo rigo, sul resto si può dire al momento ben poco. Innanzitutto non è chiaro se la lettura debba essere dška / LE, oppure DE KA/LE (che avrebbe forse ancor meno senso), o se piuttosto quanto inciso qui non continuasse nel successivo cerchio perduto27.
Venendo in-ne agli ultimi due righi, e. ed f., l’analisi testuale si complica ulteriormente. Nel rigo e., il zÍ Sèfil[---] del frammento IV,1-2 potrebbe indicare un nome proprio, quello di un So-lo al quale, o alla cui anima, nuovamente, viene indirizzato un augurio di vita (eterna)28; a meno che – e sarebbe forse più congruo – non debba leggersi zÍj (o z»j[aij]) ï f…l[e], ovvero un più comune
23 Ma vi si potrebbe riconoscere, nel ---]MEINA kaˆ S[---, quanto resta di due nomi di persona, forse una donna e un uomo (che sia quest’ultimo il presunto Sèfil[---] del rigo e. al frammento IV,1-2 ? V. infra).24 V. più di recente Velestino 2000: 514 (con bibl.), dove si richiama opportunamente l’opinione del Marucchi in merito al valore dogmatico dell’espressione “che sia ricordata la sua anima” e alla nota iscrizione latina di Agape nel cimitero di Priscilla a Roma, in cui si rivolge l’invito ai fratelli riuniti in preghiera a ricordarsi (meminisse) di pregare anche per la cara defunta, onde ottenere da Dio la sua salvezza (... ut Deus omnipotens Agapen in saecula servet). In Calabria può citarsi invece, anche questa a puro titolo di esempio, un’iscrizione in greco su lastra marmorea frammen-taria da Reggio della metà circa del V secolo, in cui mn»sqhti k(Úri)e ... individua un’espressione «molto comune (ed in numerose varianti) sia nei documenti cristiani che in quelli bizantini …», Buonocore 1988: 5.25 Qui, inoltre, ---]HSIME è con ogni probabilità integrabile in cr»sime, o meglio Ñn»sime, ossia con un’aggettiva-zione elogiativa relativamente comune nelle iscrizioni funerarie, espressa in questa sede al vocativo e riferibile eviden-temente a un nome maschile; non, tuttavia, al seguente kur…..., la cui ultima lettera, sebbene fratturata, non può che essere W, da cui appunto il dativo kur…ñ.26 Basti sfogliare ad esempio il Patristic Greek Lexicon edito da G. W. H. Lampe nel 1961 per averne immediata contezza.27 Forse dška – se così deve assumersi –, potrebbe alludere al numero sacro e perfetto, simbolo di perfezione, pure at-testato nella patrologia e in taluni passaggi neotestamentari (v. ancora A Patristic Greek Lexicon di Lampe, s.v.), ma è ovvio che si tratta in questo caso di una pura suggestione, che andrà eventualmente vagliata nel prosieguo dello studio.28 Si veda, a titolo puramente indicativo, il zÍ KÚrioj kaˆ zÍ ¹ yuc» sou nei Settanta Interpreti dell’Antico Testamento, 1, Re, 25-26.
362
esclamativo “vivi o caro/amato !”29. Pressoché incomprensibili appaiono d’altro canto le lettere [---]TOS DIA[---] [---]NON INA K[---] del frammento V,1-5, mentre [---]TON ANTILA del frammen-to VI potrebbe ipoteticamente restituire tÕn ¢ntila[bÒnta (“… Dio piacendo”). Al rigo f. invece, oltre al [---]W prÕj S(vel O)[---] del frammento IV,1-2, si riconosce un ---] kaˆ ¥xioj zwÁj E[---] (“e degno/meritevole di vita”) nel frammento V,1-5. Anche in questo punto tornerebbe pertanto un probabile riferimento alla vita (eterna).
Fin qui la possibile trasposizione di quel che resta delle iscrizioni. Vediamo ora di trarre brevemen-te, se non delle conclusioni – che sarebbero a questo stadio premature e rischiose –, almeno qualche spunto di ri9essione.
Innanzitutto la datazione della bottiglia. Come noto, la forma Isings 103 con decorazioni a fasce e/o cerchi o meno, o con decorazioni -gurate, individua una produzione variegata e di lunga durata che dal tardo II (se non già dalla -ne del I secondo S. Bonomi30) si protrae ininterrottamente -no al IV/V secolo d.C.31. A fronte dei rinvenimenti numerosissimi e3ettuati nei diversi territori dell’im-pero, nei Bruttii, e più in particolare sul versante ionico della regione, si conosce a quanto ci consta una sola bottiglia simile iscritta, proveniente da una tomba femminile della necropoli di Cugno dei Vagni (Nova Siri, MT): bottiglia decorata con solcature orizzontali sulla spalla e da quattro serie di cerchi concentrici sul corpo, provvista di una breve iscrizione in latino di carattere commemorativo e augurale, databile alla prima metà del III secolo d.C.32; ovvero in un orizzonte cronologico, storico e specialmente socio-culturale ben diverso da quello cui rinvia il vaso di Copia. In questo caso, infatti, le peculiarità intrinseche all’oggetto e il confronto strettissimo con un esemplare pressoché identico (ma in vetro blu) da una collezione privata Israeliana33, il quale presenta la stessa successione di linee e cerchi concentrici pur essendo anepigrafe ("g. 8), inducono a datare la bottiglia di Copia a non prima del IV secolo d.C.34. Un rimando tanto stringente, questo con l’area siro-palestinese – dove con ogni probabilità tali suppellettili venivano prodotte35 –, da lasciar ipotizzare una medesima provenienza anche per il nostro pezzo.
Vi è tuttavia di più. In base al confronto proposto, si può ritenere che il vaso sia stato importato a Copia direttamente dal Vicino Oriente o per il tramite di un qualche mercato “intermedio”, e forse che solo dopo il suo arrivo in città vi siano state apposte le iscrizioni (per così dire “caratterizzando-lo” e “personalizzandolo”). Diversamente, si dovrebbe immaginare che l’oggetto sia giunto a Copia già iscritto, o che ve l’abbiano portato gli stessi ‘incisori’ o committenti dei testi, o i suoi acquirenti36.
29 In entrambi i casi si tratterebbe comunque di un’esortazione-augurio che trova confronto in Calabria, ad esempio, in una più antica iscrizione latina (IV secolo d.C.) dalla necropoli di Lazzàro presso Reggio, dove compare l’espres-sione bi/bas in Deo rivolta al defunto, Ionisi (per Dionysi), menzionato anche qui al vocativo: v. da ultimi Buonocore 1988: 6-7 e Costabile 1988: 255 ss., con bibl. L’espressione dulcis anima, associata all’acclamazione pie zeses e alla croce monogrammatica, ricorre invece su una lampada vitrea incisa del tardo IV - inizi V secolo d.C. dalla villa tardo-antica di Faragola (Ascoli Satriano): Turchiano c.s. Cfr. più in generale Vattuone 2006: 752-754.30 Bonomi 1986: 437-438; cfr. Ead. 1996: 141, n. 324.31 Per un elenco ancorché incompleto di bottiglie Isings 103 con decorazione a cerchi concentrici o a fasce intersecantisi, provenienti non di rado da contesti funerari, si veda Paolucci 1997: 114 ss., nota 105; inoltre Larese 2004, p. 81.32 Giardino, Alessandrì 1999. L’iscrizione recita (H)EMINIS APRILL(A)E PROPINAVIT VIVE ZESES: (Questa bottiglia) ha versato (vino) in quantità ad Aprilla. Bevi e vivi.33 V. Christie’s Antiquities, .ursday 10 June 2010: 43, n. 64.34 Più che la paleogra-a, sono lo stile di scrittura e la fraseologia che pure orientano verso questa datazione, o non molto oltre (debbo tale notazione al Professor Feissel, che ringrazio).35 Cfr. ancora Bonomi 1986 e Arveiller-Dulong, Nenna 2005: 474 ss.36 La risposta a tali interrogativi potrebbe risiedere nell’interpretazione tecnica delle iscrizioni, ovvero se esse siano stata apposte sulla bottiglia in fase di produzione, oppure incise a freddo con uno strumento a punta sottile, o ancora rilavorandone (o meglio “ritemprandone”) la super-cie.
363
Chiedersi chi fossero costoro, o comunque i possessori della bottiglia – semplici fedeli o importanti esponenti della locale comunità cristiana, se non del clero –, induce inoltre a ri9ettere sulla funzione, il signi-cato e il contesto d’appartenenza e impiego del pregiato manufatto. Sfortunatamente, le con-dizioni del suo rinvenimento non ci aiutano molto in questo senso: come si dirà più avanti, infatti, i frammenti del vetro sono stati recuperati in uno strato sicuramente riferibile alle fasi di abbandono della città. Malgrado le alterne e tormentate vicissitudini che debbono aver interessato i materiali già in uso a Copia durante la sua agonia e il successivo oblio, il fatto che la bottiglia sia stata ritrovata presso l’ambitus B1/3 a Est del c.d. Emiciclo-Teatro (v. "g. 1) – cioè in un’area abitativa e che non sembra essere mai stata destinata a luogo di sepoltura –, porterebbe ad escludere che essa facesse parte del corredo di una tomba. E tuttavia, la destinazione funeraria del vaso, con i suoi espliciti e reiterati richiami alla memoria e alla salvezza dell’anima e con l’invocazione al Signore, non può essere rigettata tout court37, sebbene lasci spazio anche ad altre interpretazioni, come quella di un possibile utilizzo in ambito liturgico-cerimoniale38.
37 Bottiglie in vetro in corredi tombali di V-VI/VII secolo d.C., alcune delle quali avvicinabili alla forma Isings 103, sono attestate in Calabria in diversi contesti funerari: dalla necropoli di Santa Maria del Mare a Stalettì a quelle di Roccelletta di Borgia, di c.da Basilicata a Cropani, di Marina di Bruni a Botricello e ancora di Piano della Tirena a Nocera Terinese (CZ): cfr. Papparella 2009, con documentazione e bibl.38 In ogni caso, sarebbe decisamente interessante sapere se e cosa la bottiglia abbia mai contenuto. Il saggio 10, che l’ha restituita, cade in corrispondenza dell’edi-cio posto immediatamente a Ovest dell’ambitus B1/3, adombrando la pos-sibilità che il vaso fosse custodito al suo interno; dal che si aprono diversi interrogativi in merito alla sua appartenenza e ai soggetti proprietari o utilizzatori dell’edi-cio stesso (cfr. infra, osservazioni di S. Luppino).
Fig. 8. Bottiglia tipo Isings 103 da una collezione privata Israeliana.
364
Come che sia, la bottiglia restituisce senza dubbio una vivida e originale testimonianza del Cristianesimo dei primi secoli a Copia .urii39 e nell’intera regione40: sorta di palinsesto, salvi-co e “dogmatico” al tempo stesso, che nel radicale cambiamento di prospettiva rispetto alle pur immanenti istanze escatologiche del paganesimo, ben documenta – se mai ce ne fosse bisogno – la straordinaria carica rivoluzionaria del nuovo euanghèlion di Cristo.
A. D.
E’ dunque all’annuncio di Cristo che rimanda in tutta evidenza, benché mutilo, l’apparato epigra--co della bottiglia di Copia: un credo e una fede che avevano trovato un saldo radicamento in città probabilmente già sullo scorcio del IV secolo, quando diverse strutture risalenti alla prima e media età imperiale furono riadattate proprio appannaggio della locale comunità cristiana, con signi-cative ripercussioni sullo spazio e sullo scenario urbano.
39 Non si tratta ovviamente dell’unico reperto ‘cristiano’ dalla città. Al IV secolo sembra risalire ad esempio un piccolo disco in ceramica (tappo?) con chrismòn gra/to, rinvenuto nel 1969 al Parco del Cavallo (Sibari I, 1969: 99, n. 10, -g. 98; Guzzo 1979: 22; Buonocore 1988: 60), mentre tra V e VI secolo si datano una lucerna con la ra/gurazione della colonna con capitello sorreggente una colomba ad ali spiegate (Sibari V, 1988-89: 410, n. 159, -gg. 387, 496) e un’altra con chrismòn gemmato (Sibari V, 1988-89: 390, n. 76, -gg. 387, 491), entrambe dal cantiere di Prolungamento Strada.40 Sulle tradizioni, non certamente a/dabili, di una di3usa evangelizzazione dei Bruttii sin dalla seconda del I secolo, ovvero dal devenimus Rhegium di S. Paolo del 61 d.C. (Atti 28, 13), cfr. tra gli altri Buonocore 1988: XV ss. (con bibl.), il quale sottolinea però giustamente come dalla documentazione epigra-ca e monumentale si evinca una pre-senza e3ettiva del Cristianesimo e una relativa organizzazione ecclesiastica solo a partire dalla metà del IV secolo.
Fig. 9. Sibari-.urii-Copia. Parco del Cavallo: scavi 1994, Saggi 8, 10 e 11 (ril. e dis. P. Vitti).
365
Come si è accennato, i frammenti della bottiglia iscritta sono stati trovati al Parco del Cavallo nel corso di un saggio e3ettuato nel 1994 all’interno e a ridosso dello stretto ambitus (vicolo di m 1,90) denominato B1/3, delimitato dai muri di due edi-ci attestati sulla plateia B ("gg. 1 e 9-10), e punto di scorrimento in senso Nord-Sud verso la stessa. L’US 1, da cui provengono, si caratterizzava per l’estrema eterogeneità dei materiali (databili dall’epoca arcaica a quella tardo-imperiale), testimonianza di ciò che resta dell’ultimo livello relativo all’abbandono della città, scavato nella campagna del 1972 senza raggiungere alcun piano di calpestio41.
Ben più complessa si presentava la stratigra-a sottostante, una volta asportata l’US 1, a documentare i numerosi interventi di sistemazione (canalette e basolato) che vi si sono succeduti ("g. 11). Per quanto riguarda gli edi-ci che a/ancano l’ambitus, essi rispecchiano puntualmente la situazione già nota nelle altre zone della città: pur con molti e comprensibili rifacimenti e adattamenti, e con massicci reimpieghi di materiali, si continua infatti ad abitare, -no all’abbandono, in aree che insistono su strutture dei primi secoli d.C. e, senza soluzione di continuità, di epoca ellenistica. In particolare, resti di apparati decorativi (a3reschi ed elementi architettonici di riuso) ed una accurata tecnica costruttiva caratterizzano gli am-bienti della casa posta immediatamente a ovest dell’ambitus, sì da mostrare una residenza non modesta del II/III secolo d.C.42, che ha subito molte trasformazioni nella sua ultima fase di vita, ipoteticamente proprio in ragione di una sua appartenenza a un importante personaggio di fede cristiana.
A questo proposito, sembra lecito riallacciarsi agli esiti delle campagne di scavo condotte nei primi anni 2000 nell’area delle terme pubbliche di Copia, che dopo la metà del IV secolo d.C., forse a seguito di un evento traumatico (bellico o sismico), furono forti-cate e profondamente ristrutturate ad uso della comunità cristiana, secondo le più recenti ipotesi di G. Noyé, che ringraziamo per le cortesi anticipazioni sugli scavi da lei condotti nell’area delle terme di Copia dal 2000 al 200443. Com’è noto, la studiosa pro-pone infatti la creazione della sede vescovile di .urii prima della più antica data documentata della -ne del V secolo44, ovvero l’insediamento nell’area delle terme del primo gruppo episcopale precedentemente
41 Cfr. S. Luppino, in Greco, Luppino 1999: 123 s.42 P. G. Guzzo, in Sibari III, 1972: 296 ss.43 Notizie preliminari in Lattanzi 2004: 1024-1025; cfr. inoltre Noyé 2001: 606-607.44 Per quanto riguarda la torre, la sua realizzazione si inquadra perfettamente nel clima storico e culturale dell’epoca. In non poche città e campagne dei Bruttii, come di tutta la parte occidentale dell’impero, vengono infatti erette ora una serie di strutture di difesa costituite sia da recinti murari, quali l’oppidum di Reggio nel cuore della città, sia da vere e proprie cittadelle come i praetoria di Scolacium e Vibona, posti sulle colline sovrastanti gli abitati. Per una messa a punto generale delle problematiche in questione si vedano Noyé 2001, E$%. 1991 e Martin, Noyé 1988.
Fig. 10. Sibari-.urii-Copia. Parco del Cavallo:fronte degli edi-ci sul lato nord della plateia E-O,subito a ovest dell’ambitus B1/3 (foto A. Tosti).
Fig. 11. Sibari-.urii-Copia. Parco del Cavallo (scavi 1994, Saggio 8): ambitus B 1/3, visto
da sud (da Greco, Luppino 1999).
366
Fig. 13. Sibari-.urii-Copia. Parco del Cavallo (scavi 2000-2004): la trasformazione delle Termein complesso ecclesiastico, residenziale e artigianale. La chiesa I (foto G. Noyé).
Fig. 12. Sibari-.urii-Copia. Parco del Cavallo (scavi 2000-2004): la trasformazione delle Termein complesso ecclesiastico, residenziale e artigianale (G. Noyé).
367
Fig. 14. Sibari-.urii-Copia. Parco del Cavallo (scavi 2000-2004): la trasformazione delle Terme in complesso ecclesiastico, residenziale e artigianale. Localizzazione delle fornaci per la produzione ceramica e del vetro (G. Noyé).
Fig. 16. Sibari-.urii-Copia. Porta Nord (scavi 1974): iscrizione funeraria in lingua
greca (foto A. D’Alessio).
Fig. 15. Sibari-.urii-Copia. Parco del Cavallo(scavi 2000-2004): fornace per la produzione del vetro
(foto G. Noyé).
368
alla -ne del IV, con l’erezione di una probabile torre forti-cata, la sistemazione di due edi-ci di culto con battistero e di altre strutture di servizio ed abitazioni ("gg. 12-13). La presenza di due fornaci circondate da muretti a secco, in uso accanto alle chiese tra la -ne del IV e il V secolo ("g. 14), ha inoltre indotto ad ipotizzare il controllo da parte del clero della produzione artigianale (o industriale?) della città.
La prima fornace ("g. 15), collocata tra la forti-cazione ed il battistero, protetto all’esterno da un grosso spessore di intonaco, fu utilizzata a lungo per la fusione del vetro. Essa è costituita da un semicerchio di pietre di dimensioni medio-piccole, legate con malta e circondato da strati sovrapposti di carbone, cenere e concotto. Due muretti costruiti con materiali molto eterogenei la isolavano dallo spazio circostante. La stes-sa fornace sembra essere stata interamente rifatta dopo una prima fase di utilizzo e ha sicuramente funzio-nato per la realizzazione della vetrata sovrastante l’altare della vicina chiesa, come attestano i numerosissimi frammenti rinvenuti. Si ricordano, inoltre, all’interno della chiesa medesima, piccoli oggetti preziosi in pasta di vetro policroma ornata di -li dorati. La seconda fornace, in mattoni refrattari, istallata nelle vicinanze, era usata invece per la produzione di ceramica e, come l’o/cina dei vetrai, è delimitata da blocchi di reimpiego.
Il V secolo segna insomma una chiara e perentoria appropriazione degli spazi urbani da parte della Chiesa e del clero. Sarà solo a partire dalla metà circa del VI secolo che i vescovi di .urii, i quali si recheranno a Roma per partecipare ai concili -no alla -ne del VII, si trasferiranno con buona parte della popolazione sul sito vicino dell’anonimo phroúrion citato da Procopio45.
Prima di concludere, un’ultima considerazione si desidera avanzare in merito alla presenza nella città romana di Copia di reperti che a partire dall’età imperiale e -no ad epoca tarda, tramandano la soprav-vivenza della lingua greca: non soltanto i vetri che sono stati qui presentati, ma anche un epita/o mutilo inciso su una lastra marmorea, trovato nel 1974 e datato tra II e III secolo d.C., proveniente dalla necropoli di Porta Nord46 ("g. 16). Tale sopravvivenza, peraltro attestata altrove nei Bruttii (largamente a Reggio e nel suo territorio ad esempio), comprova non soltanto la coesistenza di elementi greci e latini dopo l’istitu-zione del municipium, ma anche il perdurare della cultura e della tradizione greca sia in documenti privati (iscrizioni funerarie) che a carattere più propriamente “pubblico”. In particolare, la testimonianza della bottiglia iscritta, pur nella sua lacunosità, sembrerebbe ridimensionare quanto sostenuto da G. Fiaccadori circa una progressiva estraneità all’uso della lingua greca da parte dei ceti dirigenti (latifondisti, gerarchie ecclesiastiche e funzionari imperiali) delle città della Magna Grecia nei secoli dal III al VI47. Per quel che concerne l’area di Reggio, ad esempio, è stato ben dimostrato che se per tutta l’età giulio-claudia e oltre il greco continua a rappresentare, accanto al latino e in maniera all’incirca paritetica, la lingua u/ciale dei tituli pubblici del municipium, come pure degli epita/ privati, non di meno in seguito, tra III e V secolo, la documentazione epigra-ca rivela un persistente e di3uso bilinguismo, mentre sarà la conquista bizantina del 536/7 d.C. a riportare de-nitivamente nella regione l’uso anche u/ciale del greco48.
A Copia .urii d’altra parte, come già osservava Guzzo, «la denominazione dell’abitato nella piana, lontano erede della Sibari achea, sembra essere stata .urii, così come tramanda Procopio: la menzio-ne, al tempo presente (Bell. Goth. VII, XXVIII, 3 Loeb), è la più recente (547 d.C.) che se ne abbia … In Procopio non c’è memoria, come d’altronde in scrittori più antichi di lui, eccettuato Strabone, della denominazione u/ciale di Copia … [mentre] la persistenza del nome .urii è [evidentemente] dovuta alla vitalità del sostrato italiota»49.
S. L.
45 Procop. VII, XXVIII, 8 (ed. Loeb).46 Sibari V, 1988-89: 266, n. 82, -g. 247.47 Fiaccadori 1994.48 Documentazione, discussione e bibliogra-a in Costabile 1988; cfr. inoltre I%. 1989, Rohlfs 1972: 199 ss., I%. 1974, Mosino 1988.49 Guzzo 1979: 23.
369
BIBLIOGRAFIA
Arveiller Dulong V., Nenna M. D. 2005, Les verres antiques du Musée du Louvre, II. Vaiselle et conte-nants du Ier siècle au début du VIIe siècle après J.-C., Paris.
Bonomi S. 1986, Note su alcuni vetri romani dal basso Polesine, “Aquileia Nostra”, LVII, cc. 437-451.Bonomi S. 1996, Vetri antichi del Museo Archeologico Nazionale di Adria. CCAVV-CNI AIH, 2,.Buonocore M. 1988, ICI V. Regio III: Regium Iulium. Locri. Taurianum. Trapeia. Vibo Valentia. Copia
!urii. Blanda Iulia, Bari.Costabile F. 1988, Testimonianze paleocristiane e giudaiche da Leucopetra (Regium Iulium), “Rivista
Storica Calabrese” n. s., IX, pp. 255-265.Costabile F. 1989, Un librarius notarius ed un paedagogus a Regium Iulium. L’epita#o di M. Fabius
Colendus, “Panorami”, I, 1, pp. 41-47.Fiaccadori G. 1994, Calabria tardoantica, in Settis S. (ed.), Storia della Calabria antica, II. Età italica e
romana, Roma, pp. 707-762.Fiorelli G. 1876, “Notizie degli Scavi di Antichità”, pp. 33-46.Giardino L., Alessandrì S. 1999, I vini lagarini e un’iscrizione funeraria da Cugno dei Vagni, in Il vino di
Dioniso. Dei e uomini a banchetto in Basilicata (cat. mostra Roma, Museo Barracco, 8 luglio-28 novembre 1999), Roma, pp. 37-40.
Greco E., Luppino S. 1999, Ricerche sulla topogra"a e sull’urbanistica di Sibari-!uri-Copiae, “AION”, 6, pp. 115-164.
Guzzo P. G. 1979, Tracce archeologiche dal IV al VII sec. d.C. nell’attuale provincia di Cosenza, “Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Age”, 91, 1, pp. 21-39 (= Guzzo P. G., L’attuale provincia di Cosenza tra tardo antico ed alto Medioevo, in Testimonianze cristiane antiche ed altomedievali nella Sibaritide, Atti Convegno nazionale (Corigliano-Rossano 1978), “Vetera Christianorum. Scavi e ricerche”, 3, 1980, pp. 23-50).
Harden D. B. 1935, Romano-Syrian Glasses with Mould Brown Inscriptions, “Journal of Roman Studies”, 25, pp. 163-186
Harden D. B. 1944-45, Two Tomb-Groups of the First Century A.D. from Yahmour, Syria, and a Supplement to the List of Romano-Syrian Glasses with Mould Brown Inscriptions, “Syria”, 24, pp. 81-95.
Harden D. B. 1987 (ed.), Glass of the Caesars, cat. mostra, Milano.Helbig W. 1884, Antichità di Casteleone di Suasa, “Bull. Inst.”, pp. 201-204.Isings C. 1957, Roman Glass from Dated Finds, Gröningen-Djakarta.Larese A. 2004, Vetri antichi del Veneto. CCAVV – CNI AIHV, 8.Lattanzi E. 2004, L’attività archeologica in Calabria nel 2003, in “Atti XLIII Convegno di Studi sulla
Magna Grecia”, Taranto, pp. 1009-1028.Laviosa C. 1958, Un nuovo bicchiere romano-siriaco con iscrizione, “Bollettino d’Arte”, XLIII, IV, pp. 171-173.Luppino S., De Presbiteris D. 2003, Suppellettili vitree da Copia-.urii: primi dati per un inquadra-
mento del materiale inedito dallo scavo di Parco del Cavallo (1975), in Coscarella A. (ed.), Il vetro in Calabria. Contributo per una carta di distribuzione in Italia, Atti del Convegno Nazionale di Cosenza, Soveria Mannelli, pp. 493-501.
McClellan M. C. 1983, Recent Finds from Greece of First-Ceentury A.D. Mold-Brown Glass, “Journal of Glass Studies”, 25, pp. 71-78.
Mosino F. 1988, Storia linguistica della Calabria, I, Rovito (CS).Noyé G. 2001, Economia e società nella Calabria Bizantina (IV-XI secolo), in Placanica A. (ed.), Storia
della Calabria medievale. I quadri generali, Reggio Calabria, pp. 579-655.Noyé G., Les Bruttii au Ve s., in La Calabre, de la "n de l’antiquité au Moyen Age, Atti Tavola rotonda,
“Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Age”, 103, 1991, 2 [1992], pp. 505-551.Martin J.-M., Noyé G. 1988, Guerre, forti"cations et habitats en Italie meridionale du Ve au Xe siècle, in
Bazzana A. (ed.), Castrum, 3. Guerre, forti"cations et habitats dans le monde méditerranéen au Moyen Âge, “CollEFR”, 105, pp. 226-236.
Papparella F. C. 2009, Calabria e Basilicata: l’archeologia funeraria dal IV al VII secolo, Rossano.
370
Paolucci F. 1997, I vetri incisi dall’Italia settentrionale e dalla Rezia nel periodo medio e tardo imperiale, Firenze.
Ravagnan G. L. 1994, Vetri antichi del Museo vetrario di Murano. Collezioni dello Stato. CCAVV - CNI AIHV, 1, (a).
Ravagnan G. L. 1994, Due coppette so#ate a stapo di Altino, in Studi di archeologia della X regio in ricordo di Michele Tombolani, Roma (b), pp. 373-383.
Rohlfs G. 1972, Studi e ricerche su lingue e dialetti d’Italia, Firenze.Rohlfs G. 1974, Dizionario topogra"co e onomastico della Calabria, Ravenna.von Saldern A. 2004, Antikes Glas, München.Stern E. M. 1995, !e Toledo Museum of Art. Roman Mold-Blown Glass. !e First through Sixth Centuries,
Rome/Toledo (Ohio).Stern E. M. 2000, !ree Notes on Early Roman Mold-Blown Glass, “Journal of Glass Studies”, 42, pp.
165-167.Stern E. M. 2001, Roman, Byzantine and Early Medieval Glass. 10 B.C.E. - 700 C.E., Ost-ldern, Hatje
Cantz.Taramelli A., 1914, La collezione di antichità sarde dell’Ing. Leon Gouin, “Bollettino d’Arte”, VIII, pp.
251-272.Turchiano M., Lampade vitree incise dalla villa tardoantica di Faragola (Ascoli Satriano), in Coscarella
A., De Santis P. (eds.), Martiri Santi Patroni. Per un’archeologia della devozione, X congresso nazionale di archeologia cristiana (Università della Calabria, aula magna, 15-18 settembre 2010), in c.s.
Vattuone L. 2006, I vetri ‘cristiani’ in Vaticano, in Harreither R., Pergola Ph., Pillinger R., Pülz A. (eds.), Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Christliche Archäologie (Wien, 19-26 settembre 1999), Città del Vaticano-Wien, I, pp. 749-765.
Velestino D. 2000, Lastra con iscrizione cristiana in lingua greca, in Ensoli S., La Rocca E. (eds.), Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana (cat. mostra Roma), Roma, p. 514, nr. 140.
Wight K. 2001, !e Production of Mold-Blown Glass in the First Century A.D., Actes I Jornades Hispàniques d’hisòria del vidre, Barcelona, pp. 44-49.