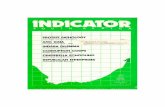« Il Tristan en prose tra Francia e Italia: note su due nuovi testimoni Bnf fr. 94 e Bnf fr. 1434...
-
Upload
univ-lille -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of « Il Tristan en prose tra Francia e Italia: note su due nuovi testimoni Bnf fr. 94 e Bnf fr. 1434...
BAGATTO LIBRI
«Pueden alzarselas gentiles palabras»
per Emma Scoles
a cura di Ines Ravasini e Isabella Tomassetti
Stampato con il contributo del Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali dellaSapienza - Università di Roma
In copertina: Nicola Cabibbo, L’orchidea di Emma
ISBN
© Bagatto Libri
Via Pavia 38 - 00161 Roma
INDICE
Paola CABIBBO
L’orchidea di Emma. Una storia a trama stretta
Ines RAVASINI e Isabella TOMASSETTI
«Possono levarsi le gentili parole…»
PUBBLICAZIONI DI EMMA SCOLES
Amicizia lungamente
Vicenç BELTRAN
Els trobadors, la política i el pensament
Alessio BERGAMO
Per una poetica dello sguardo in macchina (ovvero sull’a parte). Secondo epi-
sodio:Wile E. Coyote e Road Runner
Lorenzo BLINI
La Celestina in versi di Juan Sedeño (1540)
Corrado BOLOGNA
«Sancio, non più, oggi impazzir bisogna!». L’Orlando e il Chisciotte “furio-
si” di Paisiello
Giuseppina BRUNETTI
Asombro:‘stupore’. Per La voz a ti debida, LIX, 31
Pedro Manuel CÁTEDRA
La Década de la pasión de Juan Coloma (1576) y el género pasional en la
encrucijada de los cambios poéticos del siglo XVI
María Luisa CERRÓN PUGA
Los peligros de la pluma. Notas sobre Alfonso de Ulloa y la censura
Giovannella DESIDERI
Dante, Fortuna e Francesco da Barberino
Giuseppe DI STEFANO
L’edizione dei romances viejos. Sul testo del Gaiferos libertador deMelisendra nelle stampe cinquecentesche
Anatole Pierre FUKSAS
Medicina d'amore e amplessi paradossali nella tradizione polimorfica delle
conte infantili
Antonio GARGANO
«Sacarle he lo suyo y lo ajeno del buche». Segretezza d’amore e desiderio di
vendetta nella Celestina
Francesco GENOVESI
Lungo la rotta delle navigazioni quattrocentesche. Il viaggio del veliero Tartan
Annalisa LANDOLFI
Salinas lettore di Shelley
Roberto MERCURI
Lieve come… Scoles
Antonio MONTEFUSCO
Indagine su un fraticello al di sopra di ogni sospetto: il caso di Muzio da Peru-
gia (con delle prime osservazioni su Tomasuccio, frate Stoppa e i fraticelli di Fi-
renze)
Gioia PARADISI
Tristano nelle Bienveillantes di Jonathan Littel
Inoria PEPE SARNO
Gli Emblemata di Alciato nella Philosophia vulgar di Juan de Mal Lara
Blanca PERIÑÁN
Flores para Emma
Carlo PULSONI
Dediche all’editore Vanni Scheiwiller
Arianna PUNZI
La memoria dell’amore: il Tristan di Thomas
Ines RAVASINI
Una glosa «rara e curiosa» di Eugenio de Salazar
Antoni ROSSELL
La música del Amadís de Gaula: la “Leonoreta” y su tradición métrico-melódica
Giovanna SANTINI
Il frammento manoscritto della Nuova cronica di Giovanni Villani dell’Ar-
chivio Monaci
Elisabetta SARMATI
Nubes de color de rosa en El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite
Isabella TOMASSETTI
Parole condivise: un episodio di imitazione poetica fra le corti iberiche del
Quattrocento
Riccardo VIEL
Edizione di frammenti inediti della Commedia dantesca
Raffaella ZANNI
Il Tristan en prose tra Francia e Italia: note sui manoscritti Paris, BnF fr.
94 e BnF fr. 1434
Le parole
Paolo CANETTIERI
Il biancospino del conte
Simone CELANI
Pura saudade da poesia. Itinerari metapoetici nella lirica di Baltasar Lopes
Francesco FAVA
Soy eco de algo: una poetica del desiderio in Luis Cernuda.Traduzioni da
La realidad y el deseo (1936)
Luisa VALMARIN e Angela TARANTINO
Sguardi di donna: Eta Boeriu, Grete Tartler, Magda Cârneci, Doina Ioanid
Sì, tutto con eccesso
Roberto ANTONELLI
Filologia
Fabrizio BEGGIATO
Un prologo per Emma
Rosalba CAMPRA
Dos textos para Emma Scoles
Gustav SIEBENMANN
¿Una endoscopia de los españoles?
Norbert von PRELLWITZ
Fotogrammi
Intera cade la pietra!
CANZONI
A brisa do coração
Conradiana
A solidão de amar
Desculpa a dor dos meus olhos doentes
Raffaella ZANNI
Il Tristan en prose tra Francia e Italia: note sui manoscritti Paris, BnFfr. 94 e BnF fr. 1434 *
1. Per cominciare
Ciò che intendo proporre con il mio contributo è una storia, e riguardadue testimoni del Tristan en prose. Una storia animata da alcuni personaggi,che in realtà sono protagonisti a loro volta di storie diverse: è la storia di duetestimoni che riconduco oggi alla tradizione italiana del Tristan en prose; unastoria fatta di uomini al lavoro, di committenze, di materiali (e loro composi-tori) in viaggio, tra Francia e Italia. Un percorso quindi altamente complesso eaffascinante, che si cela dietro ogni singolo testimone componente la tradizio-ne manoscritta di qualsiasi genere di testo (sia esso di carattere documentario,letterario ecc.); una storia animata da uomini e vicende varie che faticosa-mente hanno concorso alla realizzazione del prodotto finito, del libro chepossiamo consultare nelle più grandi biblioteche europee, e non solo: i singolimanoscritti non costituiscono quindi statici anelli della catena chiamata edi-zione critica, ma organismi, “viventi” quasi e molto spesso parlanti, comevedremo in seguito, dotati di autonomia e di specifiche peculiarità. Elementidistintivi ai quali ritengo sia necessario dare piena dignità nell’attività di ricer-ca, considerando ogni singolo testimone nella sua personale e complessavicenda editoriale, in relazione e in sinergia con l’intera tradizione di cui essostesso faccia parte.
* Questo contributo è uno dei frutti di una ricerca che sto conducendo da alcuni anni sui mano-scritti della tradizione italiana del Tristan en prose. Il lavoro è cominciato nel corso del Dottorato inFilologia romanza alla “Sapienza”, Università di Roma; è poi proseguito nell’ambito di un perfeziona-mento postdottorale a Parigi; continua tuttora, in modi e forme non necessariamente istituzionalizzati.Lo dedico a Emma Scoles, che in veste di coordinatrice del dottorato,ma non solo, ha sempre incorag-giato questa e altre ricerche d’oltralpe; in particolare a Parigi, per entrambe «l’occhio sul mondo».Desidero ringraziare Attilio Bartoli Langeli, Fabrizio Cigni, Marco Cursi, Daniela Delcorno Branca,Marie-Thérèse Gousset e Arianna Punzi, con i quali ho potuto discutere in diverse occasioni il miolavoro, e dai quali ho ricevuto consulenze e suggerimenti preziosi. Un ricordo affettuoso e grato vainfine a Thierry Delcourt, che in qualità di Directeur du Département des Manuscrits dellaBibliothèque nationale de France e quale fine studioso della tradizione manoscritta tristaniana hanotevolmente agevolato il mio lavoro e la consultazione dei manoscritti in originale.
La tradizione italiana del Tristan en prose appare assai prolifica1. La circolazionee produzione in terra italiana di testimoni in lingua antico-francese delle vicen-de di Tristano cavaliere, com’è noto, osserva oltre venticinque testimoni super-stiti (collocabili tra la seconda metà del XIII e l’inizio del XV), testimoniappunto di questo proficuo scambio tra Francia e Italia (o meglio di materiali inarrivo dalla Francia e posseduti in Italia, o ancora di copisti italiani del testofrancese o copisti italiani esuli in Francia ecc.), per la metà conservati nelle mag-giori biblioteche italiane, per il resto fondamentalmente su territorio francese (eil fondo maggiormente cospicuo è quello della Bibliothèque nationale deFrance di Parigi); ad essi andranno aggiunti una serie di importanti frammenti,di reperimento più o meno recente, conservati negli Archivi di numerose cittàitaliane: si tratta di frammenti di testo tristaniano, su supporto prevalentementepergamenaceo, rinvenuti all’interno dei registri di notai e giudici italiani, comecarte di guardia o direttamente come coperte del registro stesso.
L’Italia costituisce quindi territorio privilegiato della diffusione e circolazio-ne del Tristan en prose, con associata una rilevante stratificazione delle modalitàdi conservazione e trasmissione del testo; tali elementi possono costituire a lorovolta dei marker della tipologia di pubblico, della fruizione, ma anche dellacommittenza: dal libro di lusso, il cui destinatario andrà riconosciuto nellegrandi biblioteche delle corti italiane (soprattutto del Nord) – rispondente allerichieste di gusto di famiglie mecenatizie come Visconti, Gonzaga o Carafa –,alle singole carte sciolte, sottounità di fascicoli o codici ormai perduti, divenuteparte integrante dei registri dei notai, non estranei alla produzione letteraria (ascopo privato), come ampiamente dimostrato dalle trascrizioni liriche in volga-re di sì ad opera dei notai bolognesi (nei Memoriali).
Tale ampia circolazione, in corrispondenza alla mobilità dei copisti a cavallo diXIII-XIV secolo (non di rado per ragioni politiche, legate alle vicende di corte,ma soprattutto del comune), quindi la varietà dei committenti e dei bacini geo-grafici di provenienza rendono la tradizione estremamente mobile e varia, carat-terizzata da varianti redazionali proprie, a prescindere dalla altrettanto nota ediscussa suddivisione in V.I e V.II del romanzo, che specificamente in territorio ita-liano osserva la sua “fallibilità”2; maggiormente fruttuosa, come ho già provato a
Raffaella Zanni
1 Mi limito a citare gli studi più recenti sulla tradizione italiana del romanzo, a partire dal volumedi D. Delcorno Branca, Tristano e Lancillotto in Italia. Studi di letteratura arturiana, Ravenna 1998; Ead.,Lecteurs et interprètes des romans arthuriens en Italie: un examen à partir des études récentes, in MedievalMultilingualism.The Francophone World and its Neighbours, eds. C. Kleinhenz, K. Busby,Turnhout 2011,pp. 155–186; F. Cigni, Per un riesame della tradizione del Tristan in prosa alla luce di vecchie e nuove edizio-ni, con nuove osservazioni sul ms. Paris, BnF fr. 756-757 in Culture, livelli di cultura e ambienti nel Medioevooccidentale, Atti del VII Convegno triennale della Società Italiana di Filologia Romanza (Bologna, 5-8ottobre 2009), c. s.; si veda inoltre A. Punzi, Tristano cavaliere: Il Roman de Tristan en prose dallaFrancia all’Italia, in Ead., Tristano. Storia di un mito, Roma 2006.
2 Il nuovo contributo di Cigni, Per un riesame della tradizione cit., avanza con solida argomentazio-
dimostrare attraverso lo studio di un altro testimone della tradizione italiana delTristan en prose, il ms.Barb. lat. 3536 della Biblioteca Apostolica Vaticana (Città delVaticano)3, appare la possibilità di individuare redazioni testuali caratterizzanti laricezione italiana del testo, che spesso si costruiscono interpolando le scelte di V.Ie V.II all’interno di ogni testimone e di ogni episodio in esso contenuto. In talsenso appare importante un’indagine approfondita del singolo testimone, a livellodocumentario, per ciò che esso rappresenta come oggetto materiale, e a livellotestuale,per la redazione della quale esso è portatore.
Si affaccia inoltre una figura importantissima all’interno di tale scenario, quelladell’assemblatore, ovvero colui che ha dato vita materialmente al libro manoscrit-to, selezionando, scegliendo, giuntando, se non addirittura trascrivendo di propriamano, i fascicoli (o porzioni di essi) che andranno poi a costituire il prodotto fini-to, con azioni varie di cucitura che risultano essere allo stato attuale in alcuni casiassolutamente evidenti ed inequivocabili; tali cuciture, che costituiscono operazio-ni secondarie alla copia, da parte di chi stia ragionando su come dare uniformità ecoerenza a materiali diversi,di differente provenienza, attestano una profonda con-sapevolezza da parte dell’assemblatore stesso degli snodi episodici del romanzo.Egli quindi finisce per sostituirsi all’autore stesso, divenendo quindi un autore alsecondo grado, perfettamente in grado di rispondere, attraverso il proprio manufatto,alle scelte di gusto del pubblico del tempo.A ciò si unisce il riscontro di una cir-colazione autonoma degli episodi a fascicoli o a gruppi di fascicoli all’internodelle botteghe di copia, fenomeno che ha fattivamente contribuito alla compre-senza di differenti redazioni testuali dello stesso episodio sul tavolo del copista,nonché la conseguente possibilità da parte del copista e dell’assemblatore stesso diusufruire di differenti redazioni della stessa porzione narrativa.
Questi spunti di riflessione servono ad introdurre la storia dei “personaggi”cheaffido a queste pagine. Si tratta in realtà di un primo contributo di ricognizione,che getta nuova luce su due testimoni del Tristan en prose, entrambi conservati al-la Bibliothèque nationale de France di Parigi, che riconduco per la prima voltaall’area italiana. Il primo (fr.94) risulta italiano quanto a confezione effettiva,quin-di a provenienza (come mostrano l’assetto generale, la grafia, l’apparato iconogra-fico, il contenuto ecc.). Il secondo (fr. 1434) testimonia di un passaggio in Italiaavvenuto in seconda istanza, dopo la confezione dei singoli fascicoli che lo com-pongono: quindi verosimilmente assemblato in Italia, come dimostrano elementiparatestuali di primaria rilevanza, spia dell’opera di assemblaggio stessa (una serieomogenea in tutto il codice di richiami fascicolari di mano corsiva italiana, unaaggiunta a completamento di lacuna in minuscola posata italiana e una prova di
Il Tristan en prose tra Francia e Italia
ne la possibilità di riconoscere in V.I in realtà la redazione caratterizzante del solo fr. 756-757 (e chedunque al di fuori del solo fr. 756-757 V.I non sia mai esistita).
3 Mi permetto pertanto di rinviare a R. Zanni, Il Barberiniano latino 3536 e la tradizione italiana delTristan en prose, in «La parola del testo», 14, 1 (2008), pp. 35-67.
penna in minuscola notarile “spoletina”); per concludere pienamente risponden-te, come prodotto finito, alle esigenze e al gusto del pubblico italiano a cavallo diXIII e XIV secolo. La descrizione dei due personaggi sarà seguita da alcune ipo-tesi di ricostruzione dell’origine, dell’assemblaggio ecc., che aprono in realtà pistedi lavoro successive.
2. Un libro di lusso incompleto e un nuovo testimone italiano: Paris, BnF fr. 94
Il manoscritto fr. 94 della Bibliothèque nationale de France (Anc. 6768)4
costituisce un nuovo testimone della tradizione italiana del Tristan en prose,esemplato verosimilmente in Italia nordorientale entro il primo trentenniodel XIV secolo. Il codice, di grandi dimensioni (450x298 mm) e in ottimostato di conservazione, pergamenaceo (di charta ovina, come dimostrerebbel’orientamento trasversale dei bulbi piliferi, la forte tendenza al giallo, lospessore della carta e la porosità), è costituito da 367 carte numerate da un’u-nica mano attraverso numerazione antica a numero romano5; le carte sonoraggruppate in 46 quaternioni6, aperti e chiusi da una carta di guardia perga-menacea:
I + I8(1-8v); II8(9-16v); III8(17-24v); IV8(25-32v);V8(33-40v);VI8(41-48v);VII8(49-55v);VIII8(56-63v); IX8(64-71v); X8(72-79v); XI8(80-87v);XII8(88-95v); XIII8(96-103v); XIV8(104-111v); XV8(112-119v);XVI8(120-127v); XVII8(128-135v); XVIII8(136-143v); XIX8(144-151);XX8(152-159v); XXI8(160-167v); XXII8(168-175v); XXIII8(176-183v);XXIV8(184-191v); XXV8(192-199v); XXVI8(200-207v); XXVII8(208-215v); XXVIII8(216-223v); XIX8(224-231v); XXX8(232-239v);XXXI8(240-247v); XXXII8(248-255v); XXXIII8(256-263v);XXXIV8(264-271v); XXXV8(272-279v); XXXVI8(280-287v);XXXVII8(288-295v); XXXVIII8(296-303v); XXXIX8(304-311v);XL8(312-319v); XLI8(320-327v); XLII8(328-335v); XLIII8(336-343);XLIV8(344-351v); XLV8(352-359); XLVI8-1(360-366) + I.
La rilegatura è moderna, rivestita in pelle rossiccia su assi, con impresse in oro(su entrambi i piatti) l’arme della Bibliothèque Royale e sul dorso nervato il titolo
Raffaella Zanni
4 Il ms. è ora consultabile on-line al seguente indirizzo http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059584w.
5 Sono numerate 366 carte, per ripetizione nella numerazione della c. 53; la guardia finale, utilizzatada una mano posteriore per completare la sezione mancante alla fine del periodo nella conclusionedell’ultimo fascicolo (come vedremo a breve), è quindi numerata 367 (a numero arabo). La numera-zione a numero romano parzialmente leggibile nell’intervallo cc. 209-283 è sostituita, invece, da nume-razione moderna araba.
6 Dei quali l’ultimo manca di una carta.
dell’opera «HIST. DE s. GRAAL ET . DE .TRISTAN.»7. I resti dell’antica rilegatura (8reperti, in pergamena con annotazioni in corsiva indecifrabile dall’inchiostropiuttosto sbiadito), risalente al XV secolo con ogni probabilità, sono stati direcente restaurati (nel 2010) e raccolti in una cartellina a parte, contenente anchedue guardie cartacee,verosimilmente d’apertura e chiusura del volume8.
L’aspetto esterno molto curato e regolare è confermato anche all’internodella singola pagina. La mise en page è bicolonnare, con uno specchio di scrit-tura di 51 righe per colonna (con rigatura a inchiostro); il valore dell’interli-neo appare piuttosto regolare (6/7 mm pieno; 3 mm vuoto); la pagina è dota-ta di ampi margini (deputati forse ad accogliere un successivo apparato icono-grafico, come cercherò di dimostrare in seguito)9. Il regolare rispetto di tuttigli elementi, l’ariosità e l’ordine della pagina, il gran formato, autorizzano asospettare una confezione di lusso (in associazione alla rifilatura in oro dellecarte). Il codice è redatto con ogni probabilità da una mano unica in unabuona gotica textualis di tipo italiano. Rimandano alla realizzazione italianadella tipologia grafica la quasi assente spezzatura delle curve, l’impiego di unmodulo fortemente tondeggiante, scarsamente contrastato; fungono da lettereguida la a di tipo minuscolo carolino, la d onciale con asta schiacciata sul rigo,la nota tironiana per et a forma di “7”, senza taglio orizzontale. Nello specifi-co, allego una sintetica scheda di descrizione della grafia (Tavola I, c. 112r):
� a regolarmente forma minuscola (carolina);� h con asta dritta ed esilissima proboscide al limite minimo del margine
di scrittura orientata verso sinistra;� d onciale con asta verticale moderatamente obliqua rispetto al rigo – si
registra in alcuni casi un aumento della schiacciatura dell’asta verticale,parallelamente al rigo;
� g minuscola carolina con occhiello sul rigo e pancia aperta leggermentesviluppata al di sotto del rigo (formando un’ansa) – in posizione inizia-
Il Tristan en prose tra Francia e Italia
7 Il recto della seconda guardia cartacea volante presenta al di sotto del sommario del volume incorsiva moderna una nota in minuscola moderna dal tratto posato: «Volume de 367 feuillets/ 28Avril 1887»; essa potrebbe rappresentare la data di acquisizione da parte della Bibliothèque du Roy.
8 Probabilmente il ms. prevedeva originariamente due guardie cartacee in apertura e chiusura (orastaccate) e una guardia pergamenacea in apertura e chiusura. Sulla guardia cartacea anteriore una manocorsiva moderna annota il contenuto del volume; la stessa mano appone saltuariamente nel codicepostille marginali indicanti snodi episodici o lacune (cc. 25v A; 30v A; 40v A; 64r B; 109r A; 118r A;253r B; 327v B). La stessa mano si riscontra in diversi testimoni parigini della tradizione tristaniana:non è escluso che possa trattarsi della mano del Löseth che raccorda tra di loro i manoscritti, in fase dicollazione (che ha dato vita alla paragrafatura del Tristan en prose tuttora vigente); la stessa mano delresto appone note di contenuto e di raccordo con altri testimoni del romanzo conservati alla BnFanche nel fr. 1434 di cui parlerò a breve.
9 Margine inferiore: 85-88 mm; superiore: 43 mm; interno: 38-40 mm; esterno: 64-67 mm (finoa 80-84 mm). Intercolumnio: 20 mm.
le, soprattutto nelle iniziali dei nomi dei personaggi, assume forma adalambicco;
� alternanza di s minuscola (tonda, a forma di “8”, schiacciata sul rigo) edalta in fine parola, sempre alta all’interno e all’inizio – unici casi ditonda all’inizio dopo punteggiatura, indicante maiuscola;
� y resa bassa sul rigo con asta verticale ridottissima e terminante in unaproboscide esilissima orientata verso destra (chiarissimo nel nome yselt);
� generale distinzione grafica u/v per posizione (tuttavia non semprecoerente, laddove invece facilmente coincidenti il tratto di u/ n/ m);
� fusione delle curve convessa-concava al loro incontro in fase di scrittura;� generale rispetto della regola del Meyer per la r dopo lettera terminan-
te con curva convessa – possibile svolazzo di ridottissime dimensioni efiliforme al di sotto del margine di scrittura nella r a forma di “2”;
� presenza oscillante di apici sulle i;� presenza di apici d’attacco orizzontali a forma triangolare ai margini
superiori delle aste verticali (l, h, j, i);� presenza di prolungamenti filiformi, discendenti in verticale, del tratti-
no orizzontale di r, t, e in posizione finale e della proboscide della h;� nota tironiana per et resa uniformemente a forma di “7”.
L’impressione generale è di una buona omogeneità e di un complessivo ordi-ne, nel rispetto pressoché costante delle caratteristiche indicate come distintivedella tipologia grafica in questione. In altre parole non si ravvisano effettivi cambidi mano, e il volume può con buona probabilità essere ricondotto ad un unicoatelier. Si avverte tuttavia in alcuni luoghi una discreta variazione del moduloscrittorio (le più evidenti a cc. 48r; 102r; 160r; 329v10, 336r B; 360r), oscillante inaumenti ed allungamenti e successive compressioni e diminuzioni, non delimita-bile tuttavia alla conclusione delle unità fascicolari (o a gruppi di esse: la possibi-lità di una confezione a fascicoli del testimone risulterebbe quindi scarsamenteipotizzabile). La variazione di modulo, concentrata soprattutto ai margini supe-riore ed inferiore, potrebbe essere normalmente ascritta alla variazione dell’anda-mento scrittorio, dovuta a stanchezza, interruzioni o a qualsiasi accidente cheprovochi rallentamento o accelerazione del processo di copia.Ad ogni modo sipotrebbero individuare due “mani” principali (o semplicemente due diverse rea-lizzazioni “calligrafiche” della stessa tipologia grafica), perfettamente coordinatenell’esecuzione e regolarmente alternanti: una dal modulo più piccolo, compattoe serrato, l’altra dal modulo più grande, allungato ed arioso. È ravvisabile ancorauna certa variazione di intensità nell’inchiostro, tendente al seppia nel lato pelo,più brillante e nero nel lato carne. Anche tale oscillazione potrebbe non esserecaratteristica di mani differenti (o meglio di momenti cronologicamente diffe-
Raffaella Zanni
10 Qui potrebbe essere avvenuto un cambio di penna o di inchiostro con conseguenti leggerevariazioni di modulo scrittorio (nella pienezza del tratto e della spezzatura delle curve): la colonna Bvede a e b più snelle e alte sul rigo, p e b più dritte, la f tracciata in due tempi.
renti di copia), quanto di una naturale diversità materiale dei supporti scrittori:più ruvidi e porosi nel lato pelo (quindi maggiormente assorbenti), più sottili elisci nel lato carne. L’impressione di una variazione della mano soprattutto a par-tire dalla seconda parte del volume, sulla base degli elementi addotti, potrebbeinvece corrispondere esclusivamente ad una variazione dell’inchiostro stesso, infase di trascrizione di un manoscritto così grande e ampio.
Le sei righe sul recto della guardia pergamenacea finale (numerata 367 in alto adestra, a numero arabo), a completare il periodo rimasto interrotto nel fascicoloche conclude il volume, mutilo per mancanza dell’ultima carta (come mostra l’e-vidente taglio lungo la cucitura centrale dei fascicoli)11, sono invece effettivamente
Il Tristan en prose tra Francia e Italia
11 Una carta è stata tagliata: la legatura del fascicolo è intatta e visibile (fuoriesce un fiocco); il mar-gine tagliato è visibile. Resta irrisolto se il taglio sia avvenuto prima o dopo la compilazione delfascicolo, quindi se la lacuna corrisponda a mancanza di spazio (quaternione fornito dalla bottega già
Tavola I. Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 94 112r; 367r
apposte da una mano differente e cronologicamente più tarda, almeno di un seco-lo (ex. XIV-in. XV). L’aggiunta è redatta in una minuscola posata, con evidentitratti umanistici dall’ariosità delle forme alla buona separazione delle singole unitàgrafiche: si distingue il tratteggio della s alta (che forma con la sua asta verticaleuna sorta di cappello al di sopra della lettera successiva), che sembrerebbe riman-dare all’uso grafico umanistico quattrocentesco d’area veneta (Tavola I, c.367r)12.
Il complesso grafico del codice rimanda quindi con estrema certezza all’areaitaliana.A ciò si aggiunge anche l’abbozzo di apparato iconografico che corredail volume: esso appare estremamente interessante, nonostante l’esiguità, in quantofornisce alcuni elementi alla comprensione di come avesse operato il copista,anzitutto, e, in secondo luogo, permette di avanzare qualche ipotesi sull’originegeografica del manufatto e sulla fruizione che esso stesso avrebbe potuto avereuna volta concluso. Il manoscritto si apre con uno scudo, verosimilmente rappre-sentante l’arme di Tristano che occupa i tre quarti della carta iniziale (Tavola II)13.L’arme con fondo non riempito da colore, tracciata a penna e sormontata da unacroce nella metà della cornice superiore, contiene il leone (tradizionalmenterampante) tinteggiato di rosso, armato di nero (come mostrano gli artigli) e vero-similmente lampassé (ovvero con la lingua fuoriuscente di smalto diverso rispettoal corpo dell’animale), seppur il riempimento di colore della lingua non è statocompletato (come del resto i peli che accompagnano le zampe anteriori e poste-riori). L’écu au lion costituisce una delle forme più arcaiche della rappresentazionefrancese delle arma tristaniana, fin dalle prime versioni del mito,quelle in versi. Sitenga presente che l’arme di Tristano osserva una certa instabilità (a dispetto del-l’estrema notorietà dell’eroe) e una varietà di soluzioni (letterarie e iconografi-che) nel periodo di diffusione del Tristan en prose (a partire dal 1220); la sua rap-presentazione giunge a stabilizzarsi entro la prima metà del XV secolo, in Franciasoprattutto, come un écu de sinople au lion d’or (come attesta il ms. BnF fr. 1437, c.58r, che contiene una raccolta di 166 arme dei cavalieri della Tavola Rotonda,miniata attorno al 1490, o anche le raccolte più antiche conservate allaBibliothèque de l’Arsenal di Parigi)14.
Raffaella Zanni
incompleto?) o a identico stato della tradizione (quindi a taglio corrispondente a quanto presuppo-sto come completo, per non lasciare spazi bianchi in esubero); ancora, se ci sia stata caduta accidenta-le dell’ultima carta, che abbia imposto, in fase di rilegatura, la trafilatura della sezione mancante –elemento che giustificherebbe la perfetta visibilità attuale del taglio.
12 Ringrazio Marco Cursi del suggerimento.13 Una mano corsiva più tarda annota il titolo dell’opera nel margine superiore sinistro della c. 1
(Tristany); a destra sono ancora visibili le antiche segnature del manoscritto: 6768 a numero arabo,che costituisce la numerazione dell’antico fondo francese; in corsivo quatrieme huit e 899 a numeroarabo all’interno dello scudo. Sul contropiatto anteriore (nella controguardia) si trovano due indica-zioni corsive: in alto al centro st graal e a capo Trystan (di mano differente da quella che ha appostol’intitulatio sul margine superiore del foglio iniziale).
14 Bibl. de l’Arsenal, ms. 4800, c. 20v (1450ca.); ms. 5024, c. 1v (1460-1470); ms. 4613, c. 12r (1470-
L’armoirie, evidentemente fittizia(non potendo riconoscervi alcun trat-to di colore, o elementi geometrici,ecc. che siano riconducibili a qualsivo-glia stemma araldico – oltre al fattoche il leone appare assai di frequentenei blasoni familiari italiani), in posi-zione incipitaria e quasi a piena paginacostituisce un’assoluta rarità, rispettoad una più consueta rappresentazionedell’arme di Tristano costituita da scudiapposti a margine o inseriti in un piùampio contesto figurativo. L’écu au lionè apposto su rasura di un precedentescudo: i margini attuali del disegnosono molto ripassati e la pergamenausurata lascia trasparire, nel verso, lamano di inchiostro rosso.Problematicostabilire a che livello della confezionedel manufatto sia intervenuta la rasurae ridisegnatura: il colore rosso sembrerebbe stridere con la tradizionale rappre-sentazione di fine Quattrocento-inizio Cinquecento, e forse può essere fattarisalire ad una fase precedente, e far pensare che essa sia stata redatta in parallelocon la compilazione del testo (che comincia senza irregolarità al di sotto delloscudo). Del resto la posizione pienamente verticale e centrale del leone nelloscudo, l’assenza di marcatura di peli e criniera (solo esclusivamente abbozzata),costituiscono tutti elementi di arcaicità nella raffigurazione, che inducono a col-locarla entro la fine del XIII secolo, massimo agli inizi del XIV15. Anche laforma dello scudo «a mandorla» è circoscrivibile entro il XIV secolo16. Il mano-scritto è corredato da un’unica capitale ornamentale (A), redatta a penna, al disotto dello scudo, non riempita da colore. L’abbozzo di capitale ornamentalesembrerebbe presentare delle similarità “grafiche” con l’apparato iconograficodel ms. Paris, BnF lat. 10326, che trasmette il Polydoreis di Antonio Baratella –prodotto in area veneta (tra Padova e Feltre) entro la prima metà del XV secolo
Il Tristan en prose tra Francia e Italia
1480); ms. 4976, c. 24r (1500). Sulle armi di Tristano e la rappresentazione letteraria e iconografica siveda lo studio di M. Pastoureau, Les Armoiries de Tristan dans la littérature et l’iconographie médiévales, in«Gwéchall: Penn-ar-Bed: Finistère d’Autrefois» (Bulletin de la Société Finistérienne d’Histoire etd’Archéologie), 1 (1978), pp. 9-32, ora anche Id., Armorial des chevaliers de la Table ronde: étude sur l’héral-dique imaginaire à la fin du Moyen Âge, Paris 2006, in particolare pp. 45-53; p. 164, n. 170.
15 M. Pastoureau, Traité d’Héraldique (1979), Paris 20085, pp. 193-196.16 G. C. Bescapè, M. Del Piazzo, L. Borgia, Insegne e simboli. Araldica pubblica e privata medievale e
moderna, Roma 1983, p. 486.
Tavola II. Paris, Bibliothèque nationalede France, fr. 94 1r
(1439-1442?)17. Nello specifico, per quanto riguarda le capitali ornamentali, ilparticolare tracciato delle nervature della foglia e nel complesso il motivo florealeche avvolge l’asta lunga sembrerebbero molto simili (ad es. c. 9; c. 13v). L’assenzadel riempimento di colore e l’unicità del reperto non permettono di andareoltre nella possibilità di attribuire ad una mano quattrocentesca d’area veneta ladecorazione del fr. 94. Ciò tuttavia costituisce un importante elemento per rico-noscere nel volume un incompleto intento di lusso, forse riconducibile nellacommittenza al Nord-est italiano.Tale affermazione costituisce solo un’ipotesi,una pista per un successivo approfondimento: risultati degni di nota potrannovenire solo da un’approfondita stratigrafia della lingua del testimone (dagli italia-nismi nel dettato alla patinatura “dialettale” caratteristica del copista), l’imponenzadel quale renderà necessario uno studio puntuale,ben oltre la campionatura.
L’intento di corredare l’intero volume di un apparato iconografico è confer-mato tuttavia dalla presenza di ampi margini (laterali e inferiori) e soprattutto dallapresenza di riquadri lasciati vuoti dal copista per i capolettera ornamentali. Essirispondono quanto a dimensioni ad una precisa gerarchia della funzione svoltadalla lettera stessa all’interno del testo (inizio episodio, paragrafo esottoparagrafo)18; gli spazi per le iniziali di episodio e paragrafo sono numerati anumero arabo; presenti, ma non sempre leggibili, le letterine guida per il rubrica-tore in minuscola, che sono poste nel margine estremo destro dello spazio bianco.I riquadri bianchi sono perfettamente rispettati dal copista, che appare sempre più(come vedremo anche a livello testuale) rispettoso con estremo rigore di unmodello di copia; la presenza di spazi bianchi deputati all’ornamentazione deicapolettera, gli ampi margini e il monumentale blasone iniziale, insieme ad unaspetto grafico e d’impaginazione pulito,ordinato,quasi privo di rasuree correzio-ni, autorizzerebbe ad ipotizzare una confezione (e una committenza) di lusso, dabiblioteca personale di qualche importante famiglia delle corti italiane del Nord.
Il volume contiene una silloge tristaniana assolutamente in linea con la selezio-ne episodica caratterizzante la tradizione italiana: essa prende le mosse dall’inizio, apartire dalla storia degli antenati di Tristano, fino alle soglie della conclusione delTorneo del Louvezerp19. Ho individuato almeno tre grossi blocchi narrativi(seguendo la paragrafatura del Löseth20), a partire dal prologo in incipit, senza lamenzione dell’autore (come il ms.Paris,BnF fr.334):
Raffaella Zanni
17 Ringrazio Marie-Thérèse Gousset del suggerimento e di avermi fornito i materiali ancora ine-diti da lei redatti della schedatura e descrizione dell’apparato iconografico del codice BnF lat. 10326.
18 Inizio episodio/capitolo: 70x70 mm, particolarmente esteso a c. 153, organizzato su due livelli[85x85 mm sopra e 40x40 mm sotto]; inizio paragrafo: 40x40 mm circa; inizio sottoparagrafo:10x15 mm.
19 Incipit: «Apres ce que j’ai leu / et releu et pourueu / par maintes fois le / grant liure en latin(…)»; explicit: «messire tristan qui vait par la meslsée si/ armes comme je vous di».
20 E. Löseth, Le roman en prose de Tristan, le roman de Palamède et la compilation de Rusticien de Pise.Analyse critique d’après les manuscrits de Paris, Paris 1890 (réimpression Genève 1974).
� cc. 1-143v Löseth 1-75a (dalle origini [le vicende degli antenati trista-niani] fino alle avventure nel deserto del Darnantes [Löseth 71a-75a]);
� cc. 144r-327v Löseth 92-280 (dal combattimento di Lancillotto conNeroneus fino all’esposizione del Lai Voir disant, poi lacuna – fa seguitouna colonna bianca21);
� cc. 328r-367r Löseth 338b, 352-379 (Torneo del Louvezerp; mutiloalla fine)22;
Il codice fa parte della fam. c individuata dalla Curtis (fino a Löseth 75a)23,insieme ai mss. Chantilly, Musée Condé, 315-317, Genève, Bodmer, Philipps8383, Paris, BnF fr. 99 e n. a. fr. 6579; con quest’ultimo forma un sottogruppoben individuato (al quale ho dimostrato legarsi, nella sezione Löseth 20-41,anche il codice Barb. lat. 353624). Esso è classificato come appartenente alla V.IIdel romanzo (a partire da Löseth 182). La porzione narrativa Löseth 18-74a(75a) che raccoglie alcuni episodi celebri della vicenda biografica di Tristano,dalla nascita alla rivelazione della sua prodezza al mondo arturiano (i natali, l’in-namoramento per Isotta, il soggiorno degli amanti al Chastel des Pleurs, il duellocon Galeotto, l’episodio della liberazione di Artù nel deserto del Darnantes; conassenza delle avventure del Servaggio [Löseth 61-70 ca.]) costituisce una dellesezioni del romanzo che ha avuto maggiore diffusione in Italia in una varietànotevole di redazioni, in lingua francese e in volgarizzamento: essa accomuna icodici del gruppo pisano-genovese (WHVeM1), un buon numero diframmenti25; si riproduce quindi nel volgarizzamento del Tristano Veneto esostanzialmente nella cosiddetta redazione R entro la quale rientrano numerosivolgarizzamenti26; ancora tale sezione è inserita nei completi Genève, Bodmer164 e BnF fr. 756, e con una redazione particolare in BnF fr. 12599.
Il montaggio dell’episodio del Torneo è scorciato e unisce le prime lineedi Löseth 338b giungendo direttamente a Löseth 352-356 (la proclamazione
Il Tristan en prose tra Francia e Italia
21 La lacuna cade all’altezza del § 264, 4 dell’edizione Le roman de Tristan en prose, publié sous ladirection de Philippe Ménard, tome IV, Du départ de Marc vers le royaume de Logres jusqu’à l’épisode dulai «Voir disant», éd. par J.-C. Faucon, Genève 1991. Sul ms., nel margine inferiore della colonna B dic. 327v, la solita corsiva moderna annota la presenza della lacuna e rimanda a fr. 99, c. 376.
22 Cfr. § 1-202, dell’edizione Le roman de Tristan en prose cit., tome V, De l’arrivée des amants à laJoyeuse Garde jusqu’à la fin du tournoi de Louveserp, éd. par D. Lalande,Th. Delcourt, Genève 1992.
23 R. L. Curtis, Le roman de Tristan en prose, vol. II, Leiden 1976, pp. 36-41.24 Zanni, Il Barberiniano latino 3536 cit., p. 53 ss.25 Si tratta dei frammenti Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, mss. Casini, cart. XVIII;
Innsbruck, Biblioteca universitaria, ms. Fragment B.4; Udine,Archivio di Stato, Fondo notarile antico,busta 5221;Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 3953. Si vedano la schedatura e le indi-cazioni bibliografiche fornite da Delcorno Branca, Tristano e Lancillotto cit., pp. 51-57; sul frammentoudinese si veda R. Benedetti, Un frammento del Roman de Tristan en prose fra tradizione toscana e tradi-zione veneta (Udine,Archivio di Stato, fr. 110), in «Studi mediolatini e volgari», 49 (2003), pp. 47-70.
26 Delcorno Branca, Tristano e Lancillotto cit., p. 73, nn. 76-79.
del Torneo da parte di Artù e la vita degli amanti alla Joyeuse Garde), per poiproseguire fino a Löseth 379 (generalmente in Italia la vicenda arriva finoalmeno a Löseth 384, alla conclusione delle tre giornate di Torneo, ma il ms. èmutilo alla fine, come dimostrano le righe apposte da altra mano a completa-mento del periodo, di cui parlerò a breve). Il fr. 94 condivide con i mss. di V.IIla redazione del Torneo (mancando infatti tutta la sezione Löseth 301-350, eincludendo solo Löseth 338b, ovvero l’arrivo di Tristano e Isotta nel Logres,alla Joyeuse Garde); tale “scorcio” è comune anche al sottogruppo ycxn di V.Irappresentato dai codici (praticamente tutti italiani, come vedremo a breve)Modena, Biblioteca Estense E, 40 [y]; Paris, BnF fr. 760 [c], 1434 [n] e 755 [x](l’unico a presentare una redazione diversa in V.I è in realtà il solo fr. 757, checontiene la digressione Löseth 345-351). La presenza a livello contenutisticodi tali episodi incoraggerebbe a collocare il testimone in area italiana. Il com-plesso grafico e iconografico del testimone permettono invece di affermarnel’italianità con un altissimo margine di probabilità (quasi una certezza).
Il manoscritto presenta qua e là delle righe o segmenti di parole lasciati in bian-co: più evidente il caso della riga e 1/2, causa anche lo spazio da lasciare al rubri-catore per il capolettera ornamentale,a c.354r A,20-21;ho individuato almeno unmacroscopico caso di lacuna27: il copista lascia in bianco l’intera colonna B di c.327v.Da un punto di vista materiale ciò costituisce un indizio di copia (fedele) daantigrafo ugualmente lacunoso: il copista ha a disposizione un modello che ripro-duce fedelmente in tutte le sue parti; si tratta probabilmente di un copista di profes-sione, non necessariamente addentro alla materia, ma attentissimo alla perfetta rea-lizzazione di un duplicato dell’originale. Egli infatti conserva inalterati tutti i tratticaratterizzanti, siano essi lo spazio deputato alla miniatura che eventuali spazi bian-chi,per lacune o salti:dimostra ciò chiaramente anche quanto avviene a c.295v A,ove viene lasciato lo spazio per la miniatura e nel margine estremo sinistro del ri-quadro il copista comincia a riempirlo con il testo, che proseguirà poi distesamen-te a partire dalla riga successiva (l’inizio della frase è quindi a ridosso dell’inqua-dramento vuoto deputato alla miniatura). In tale contesto si spiega anche il fattoper cui il testimone presenti esclusivamente due rubriche, in inchiostro rosso a c.336v A,50-51 e a c. 348r B, 2-3: tale singolarità risponde pienamente ad una co-pia fedelissima di un modello,probabilmente senza troppa cognizione di causa,daparte di un copista professionale (giusta un’ottima realizzazione calligrafica).
Il fatto che il copista seguisse pedissequamente il proprio antigrafo sembre-rebbe essere confermato anche dal fatto che nella colonna B lasciata per inte-ro bianca a c. 327v si riscontra un richiamo fascicolare (di mano identica aquella che esegue il volume, poco leggibile in quanto al margine della rifilatu-
Raffaella Zanni
27 Il puntuale spoglio del contenuto e degli episodi, al fine di individuare eventuali lacune interneo redazioni differenti, costituisce il naturale e necessario prosieguo della ricerca.
ra della pagina) che corrisponde esattamente a quanto viene trascritto nelfoglio iniziale del fascicolo successivo: «[???]Hi endroit» (ovvero l’attacco del-l’episodio del Torneo del Louvezerp). Ciò vuol dire che nell’antigrafo dicopia la situazione era assolutamente identica: episodio Löseth 280 lacunoso acui doveva far seguito Löseth 338b ovvero l’attacco del Torneo. Da un puntodi vista più specificamente testuale invece, la lacuna o piuttosto l’interruzionea Löseth 280 ca. potrebbe non costituire un elemento attribuibile esclusiva-mente a fattori meccanici in fase di copia. Il salto Löseth 282a (racconto scor-ciato delle due prigionie di Tristano) – 338b (arrivo degli amanti alla JoyeuseGarde) non è isolato nella tradizione del romanzo e vanta due testimoni diorigine italiana: tale sequenza si osserva infatti in fr. 12599 (Löseth 282a-338b,nel passaggio tra II e IV spezzone, della stessa mano28) ma soprattutto nel ms.Aberystwyth, National Library of Wales, 5667 E (Löseth 282a-338b), che uni-sce al suo interno mani francesi e italiane, risale allo stesso torno d’anni(XIV in.) e presenta a c. 89r lo stemma dei Visconti29. La comparazione èsignificativa: il salto potrebbe da un lato contribuire all’attribuzione all’Italiadel testimone, a livello di selezione episodica, dall’altro potrebbe esso stessocostituire un nuovo punto di giunzione di episodi non contigui del romanzo,caratterizzante la tradizione italiana.
Allo stato attuale della ricerca, queste rimangono ipotesi fruttuose. Il mag-gior numero di elementi probanti la provenienza italiana del testimone esoprattutto una precisa collocazione geografica verrà esclusivamente attraversoun’approfondita analisi del diasistema del manoscritto (che permetterà diindividuare degli italianismi o meglio un primo strato tipico delle redazionifranco-italiane del Tristan e un secondo strato pertinente la scripta propria delcopista). Il fr. 94 sembra costituire ad ogni modo la “bozza” di un manoscrittotristaniano di lusso, trascritto e assemblato in Italia, che ha visto, per ragioni almomento ignote, una gestazione lunga, mai giunta a conclusione: contempo-ranea probabilmente la composizione grafica del testo, l’assemblaggio deifascicoli e la redazione dello scudo (forse incompleto nella pigmentazione);quindi successivo un primo abbozzo di ornamentazione dei capolettera inparallelo all’aggiunta a mano della sezione mancante e alla rilegatura (ex. XV-in. XVI). Confezione e assemblaggio possono essere collocati in area veneta,come dimostra invece il particolare tratteggio della s alta da parte della manoche ha chiuso il volume con l’aggiunta e l’ornamentazione floreale del capo-lettera incipitario.
Il Tristan en prose tra Francia e Italia
28 Ciò potrebbe significare che i due spezzoni fossero giunti sotto mano dell’assemblatore cosìappaiati, in quanto copiati da una stessa mano da un modello che presentava tale successione-giun-zione episodica.
29 Delcorno Branca, Lecteurs et interprètes cit., p. 161.
3.Nuovamente un assemblatore, tra Francia e Italia, e una nota di possesso:BnF fr.1434.
Il secondo personaggio che presenterò costituisce invece un interessantissi-mo testimone della circolazione del Roman de Tristan tra Francia e Italia: unaserie di elementi materiali inequivocabili attestano l’avvenuto passaggio e, conun buon margine di verosimiglianza, l’assemblaggio del manufatto in Italia.
Il ms. fr. 1434 conservato alla Bibliothèque nationale de France (Anc.7527)30, databile entro la fine del XIII secolo, pergamenaceo, di medie dimen-sioni (290x250 mm)31, in pessimo stato di conservazione32, è composto da 156carte, numerate, raggruppabili in 21 fascicoli, per lo più quaternioni; due guar-die cartacee aprono e chiudono il volume. La prima guardia cartacea è staccata.Il verso della prima guardia e il recto della seconda contengono un riassunto delcontenuto in una minuscola corsiva moderna solo parzialmente decifrabile,della stessa mano che appone anche all’interno del codice note di contenuto osegnalazioni di lacune33.
La consistenza dei fascicoli è stata di difficile determinazione in alcuni casi, perevidenti lacune meccaniche. Si intravede sulla pagina a sinistra in basso, al marginedella cucitura, una numerazione progressiva a numero arabo dei fascicoli (il trattosembrerebbe moderno e apposto a matita: forse in conseguenza del restauro del-l’antica legatura e della cucitura dei fascicoli). Il volume è mutilo all’inizio (e allafine) in base all’attacco evidentemente senza incipit e senza capolettera ornamenta-le che come vedremo inaugura in tutto il manoscritto l’apertura di paragrafo.Nello specifico il volume è mutilo delle prime 10 carte, come è possibile desume-re in virtù di una numerazione a numero arabo apposta nel margine inferioredella pagina, al centro, al limite della rifilatura della pagina: essa presenta il numero13 nel terzo foglio; da ciò se ne deduce che la prima dovesse costituire la numero11 e la seconda la 12 di una serie originaria con dieci pagine ormai perdute
Raffaella Zanni
30 Il ms. è ora consultabile on-line al seguente indirizzo http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90069238.
31 La rifilatura delle pagine in altezza non risulta perfettamente omogenea: tra i 286 e i 290 mm:286x250 mm (cc. 38 e 21); 290x250 mm (cc. 129 e 156).
32 Le prime sei carte risultano sensibilmente danneggiate, strappate lateralmente (lo strappo va a for-mare quasi un’ansa interna), al punto da intaccarne la leggibilità; carte strappate lungo i margini esternisi ravvisano qua e là anche all’interno del ms. Evidenti segni di cucitura si riscontrano, ad esempio, allecc. 6 e 134; si evidenziano inoltre forature, di diversa dimensione e ampiezza, attribuibili alla presenza ditarli (cc. 41, 62, 96, 130, 141, ad es.), o macchie di umidità, che spesso arrivano ad interessare lo spec-chio di scrittura. Il verso del foglio conclusivo (c. 156v) si presenta molto usurato: l’inchiostro è eviden-temente sbiadito, al punto da limitare al massimo la leggibilità di intere porzioni di testo.
33 Sulla carta incipitaria nella sezione superiore dell’intercolumnio (c. 1r); alla fine della colonna Bdella c. 8v, ad indicare lacuna; ancora nell’intercolumnio superiore della successiva c. 9r; nel margineinferiore di c. 38r B (ad indicare lacuna e connessione con altri mss. della tradizione tristaniana); 94vB. Il tratto è il medesimo di quello già riscontrato, tra gli altri, nel ms. fr. 94 appena presentato (attri-buibile alla mano moderna di qualche studioso che, come il Löseth, ha collazionato l’intera tradizio-ne del Tristan en prose conservata alla BnF).
(verosimilmente un quinione). L’unità fascicolare minima idealmente seguente,quella che effettivamente apre il codice, è con buona probabilità un quaternione,notevolmente danneggiato,con strappi e fori, e lacunoso all’inizio e alla fine34:
II + I8 (1-8v); II8 (9-16v)35; III8 (17-24v); IV8 (25-32v);V6(8-2?) (33-38v)36;VI8(39-46v);VII8 (47-54v);VIII6 (55-60v); IX8 (61-68v); X10 (ff. 69-78v)37; XI8(ff. 79-86v); XII8 (ff. 87-94v)8; XIII2 (ff. 95-96v); XIV8 (ff. 97-104v); XV8 (ff.105-112v); XVI8 (ff. 113-120v); XVII8 (ff. 121-128v); XVIII8 (ff. 129-136v);XIX8 (ff. 137-144v);XX4 (ff. 145-148v);XXI8 (ff. 149-156v)+ II.
Il codice è dotato di un complesso di quattro numerazioni differenti (permano e tipologia grafica). La prima a numero arabo ma antica (a partire dal XIIIsecolo) è visibile, come già detto, a partire dalla terza carta (13), ma non è leggi-bile su tutte le carte, in quanto apposta al margine inferiore della rifilatura dellapagina. Si sovrappongono ad essa una seconda numerazione ancora antica anumero arabo, apposta nel margine angolare superiore destro, al margine dellarifilatura, che condivide alcuni tratti caratteristici con la precedente nel margineinferiore38; quindi altre due numerazioni a numero arabo moderne, sempreapposte nell’angolo superiore destro, differenti per tratto e inchiostratura (ten-dente al seppia il primo e dal tratto più grande, al grigio il secondo e più picco-lo), ma entrambe corrispondenti al numero progressivo dei fogli effettivamentepresenti nel manoscritto.
La rilegatura è moderna, rivestita in pelle rossiccia su assi, con impresse in oro(su entrambi i piatti) l’arme della Bibliothèque Royale e sul dorso nervato il titolo
Il Tristan en prose tra Francia e Italia
34 La minuscola corsiva moderna, di cui s’è già parlato, annota nel margine inferiore destro dellacolonna B di c. 8v lo snodo narrativo mancante e la connessione (verosimilmente in lacuna) ad unaltro testimone del Tristan en prose conservato alla BnF (fr. 101).
35 A tale altezza si osserva il primo sensibile cambio di mano; verosimile anche il cambio di fasci-colo, seppur non siano più visibili, per i primi tre fascicoli, i richiami fascicolari.
36 La lacuna o un salto, esplicitato anche da un’annotazione marginale della solita mano moderna(che anche in tal caso rimanda a fr. 101), rende ragione dell’incompletezza del quaternione: si intra-vede infatti il lembo di un bifolio strappato.A c. 39r cambia nuovamente la mano.
37 La situazione è particolare: sembrerebbe trattarsi di un unico fascicolo (un quinione) quandoinvece è visibile al margine interno della cucitura nello snodo cc. 75v-76r il segno di taglio/strappo diuna carta nel margine inferiore; nel margine superiore sporge un filo verde, verosimilmente la cucitu-ra delle carte. La combinazione 7+3 risulta assolutamente particolare (mentre molto più accettabile lapresenza di un unico quinione): da capire se la caduta riguarda una o più carte e soprattutto se si èprodotta lacuna; in apparenza non vi sono salti, quindi si potrebbe pensare ad un aggiustamento deifogli necessari alla porzione di testo trascritta da parte dell’estensore del fascicolo in questione.
38 Le due numerazioni definite antiche procedono di pari passo lasciandosi sempre un’unità discarto; il salto di una carta sembra tuttavia “apparente”; non sembra essere avvenuto alcun guasto(ma resta da verificare tuttavia puntualmente). L’antichità delle due numerazioni è data dalla condi-visione del tratto di alcune cifre, in particolare il 5, con tratteggio simile alla “g” aperta, l’8 conocchiello superiore schiacciato (realizzato come un triangolo rovesciato), il 3 a “z”.
dell’opera «Partie du roman de Tristan»; la cucitura dei fascicoli è semipercettibilea causa del progressivo distaccamento delle assi dal dorso; la rilegatura del restoappare anch’essa nel complesso molto danneggiata con piatto anteriore e primaguardia completamente distaccati, seconda carta e piatto posteriore praticamentein via di distaccamento.
L’apparato grafico complessivo del codice rimanda alla Francia. Ho potutoindividuare sette cambi di mano, che permettono di raggruppare omogenea-mente i fascicoli in sette gruppi diversi, per grafia e assetto della mise en page:
1° mano: fasc. I (cc. 1-8v);2° mano: fasc. II-V (cc. 9-38v);3° mano: fasc.VI-VIII (cc. 39-60v);4° mano: fasc. IX (cc. 61-68v);5° mano: fasc. X (cc. 69-78v);6° mano: fasc. XI-XIII (cc. 79-96v);7° mano: fasc. XIV-XXI (cc. 97-156v).
I sette gruppi di fascicoli sono dunque redatti da mani differenti in goti-chette non professionali di provenienza francese (collocabili entro l’ultimoquarto del XIII secolo): seppure l’attribuzione geografica sia maggiormentedifficile e problematica in casi di grafie non formalizzate, rimandano general-mente alla Francia i seguenti caratteri: una discreta spezzatura delle curve, ilcontrasto del modulo, la spatolatura delle aste lunghe; ancora la caratteristicanota tironiana abbreviativa per et a 7 tagliato da un trattino orizzontale,costante in tutti i diversi gruppi di fascicoli. Quanto alle lettere caratteristichesi registra un’alternanza fra la realizzazione tipicamente francese della a (a“doppia pancia”, come un “8”), accanto alla classica di forma onciale e unaparticolare realizzazione della g, con occhiello inferiore chiuso e schiacciatosul rigo. Minimi prolungamenti delle aste lunghe al di sopra e al di sotto delrigo si registrano, in maniera saltuaria, lungo le righe iniziali e finali di colon-na. La mise en page, su due colonne con rigatura a secco o ad inchiostro (inalcuni fascicoli convivono entrambe), osserva un’oscillazione delle linee discrittura (dalle 33 alle 36), del valore dell’interlineo, dell’intercolumnio e deimargini, ma anche nella maggiore o minore ariosità (e viceversa compressio-ne) del modulo scrittorio39; tutti elementi che variano evidentemente aseconda dei gruppi di fascicoli redatti dalla stessa mano, se non addirittura dafascicolo a fascicolo redatto nello stesso atelier.
Un rozzo sistema di ornamentazione va a corredare in maniera pressoché
Raffaella Zanni
39 Ad esempio, l’ultimo gruppo di fascicoli (XIV-XXI) provenienti da medesimo atelier risultaredatto da una mano per così dire “dissociata”, incerta, che produce un progressivo restringimento erimpicciolimento del modulo scrittorio, comunque costante, piccolo, fortemente contrastato (se nonfratto), con apici sulle aste lunghe a spatola.
omogenea tutto il manoscritto; la decorazione, caratterizzata da una palette limita-ta al rosso, verde e turchino, sembrerebbe derivare da medesimo atelier, verosimil-mente di origine o ispirazione francese (come dimostrerebbe la particolare fili-granatura delle capitali ornamentali). L’ornamentazione si articola in capoletteraornamentali semplici di modesta fattura deputati all’inizio di capoverso o para-grafo; esse sono ripassate in rosso o turchino e possono presentare allungamenti efregi laterali minimamente sviluppati e astrattizzanti (in rosso o verde); si osserva-no riempimenti a colore nelle lettere tonde, specialmente nella modalità della“faccina con barba”.Alcune grandi capitali filigranate (45x50 mm ca.), di mag-gior pregio decorativo, aprono di norma i capitoli; esse sono ripassate in rosso,verde o turchino, con fioriture di riempimento a colore tipo nodi e gemme, eprolungamenti marginali di tipo vegetale astrattizzanti in rosso o verde40. Unminimo tratto di minio (rosso) correda in maniera pressoché uniforme le maiu-scole e le iniziali di personaggio abbreviate all’interno della narrazione.Si ravvisa-no qua e là richiami fascicolari minimamente rubricati (inquadrati in una corni-ce rossa), della stessa mano di quella che ha composto il gruppo di fascicoli (adesempio a c. 86v, a collegare XI e XII fascicolo redatti dal medesimo copista). Ilmanoscritto è punteggiato infine da un sistema non professionale di marginaliafigurati: maniculae (c. 72v; 75r) e segni di richiamo (a c. 43v un mezzobusto conmano destra alzata), spesso con prolungamenti in motivi floreali e fantastici; parti-colarmente degni di nota appaiono gli allungamenti marginali di tipo figurativodei capolettera ornamentali a c. 129r rappresentanti animali fantastici (rispettiva-mente una chimera zoomorfa ed una figura antropozoomorfa)41.
Ciò che appare assai interessante ai fini della nostra storia (tra Francia e Italia)è la visibilità delle operazioni di cucitura compiute dall’assemblatore del volume;tali operazioni rimandano a mio avviso con un buon margine di certezzaall’Italia, come tenterò di dimostrare in questa sede. Del resto il fr. 1434 rappre-senta nel suo complesso un testimone che potrebbe stare particolarmente acuore ad un pubblico o ad un utente italiano: esso contiene quasi esclusivamenteil torneo del Louvezerp, uno degli episodi caratterizzanti la selezione operata daicompilatori dei testimoni italiani. Il ms., mutilo all’inizio e alla fine42, contienealle cc. 1-61rA, 3 il preludio al Torneo (da Löseth 313, con Gauvain in cerca di
Il Tristan en prose tra Francia e Italia
40 Con minima gerarchizzazione delle dimensioni in base al contenuto (verosimilmente iniziali dicapitolo): di maggiori dimensioni alle cc. 2r A; 9r A; 39r A; 55v B [40x40mm]; 72r A [60x60mm];122v A; 132v B [50x50mm]; 149r A [55x55mm]; 156v A; di dimensioni più ridotte alle cc. 47r B;50v B; 79r A; 95v B [25x25mm ca.].
41 L’intera pagina bianca a c. 38v per lacuna già dell’antigrafo è riempita nel margine inferiore daun disegno di modesta fattura, realizzato a matita o inchiostro (dal tratto pesante e scolorito), raffi-gurante un cavaliere (come rilevano l’elmo e l’armatura) sul dorso di un cervo tenuto per le corna.
42 Incipit: «ss voie mesire tristan gauvain gesir aterre que ne / facoit nul semblant de soi releuer (…)»;explicit: «que ge sai tout certainement que le / ne uint a ceste assemblée fors le mout / por moi ueoir(…) me dist a cui ele le».
Perceval a Löseth 348, frammentario)43; quindi l’episodio del Torneo alle cc.61rA,4-156v, che dalla fine di Löseth 344 (episodio delle immagini) salta diretta-mente a Löseth 352-381 (al solito la proclamazione del Torneo, il breve accennoal soggiorno degli amanti alla Joyeuse Garde e il compimento delle giornate,sezione narrativa che accomuna il sottogruppo ycxn di V.I, del quale fr. 1434 faparte, e V.II, come visto per il fr. 94)44. Il ms. si interrompe all’inizio di Löseth 381,che vede Palamèdes abbandonare il Torneo e lanciare la sfida a Tristano.
I fascicoli che compongono il ms. fr. 1434, verosimilmente esemplati e dotatidi ornamentazione in Francia, sarebbero stati poi assemblati in Italia.La confezio-ne ultima del volume sarebbe quindi avvenuta in Italia,magari attraverso l’arrivo,per ragioni attualmente ignote, di materiali sciolti dalla Francia, o, viceversa, permano italiana soggiornante in Francia (magari qualche notaio/poeta bandito inseguito alle lotte di parte che videro protagonisti i comuni italiani?)45 Rimandaall’Italia anzitutto un sistema di richiami fascicolari redatti in una minuscola cor-siveggiante, con tratti grafici italiani (come l’abbreviazione que, con titulus abbre-viativo a cappello; o la presenza di elementi cancellereschi, come la d a “d”, o la siniziale di parola molto alta sul rigo o in posizione secondaria e finale con mini-mo sviluppo a proboscide), riscontrabili a partire da c. 16v: essi sono apposti inmodo tale da collegare tra loro, in maniera coerente, senza salti, sovrapposizioni oinversione dell’ordine, i sette gruppi di fascicoli redatti da mani e atelier differentievidentemente giunti in bottega come fascicoli sciolti. I richiami, quasi illeggibilialle volte, sono posti al margine della rifilatura della pagina46. L’inserimento deirichiami è avvenuto con tutta evidenza successivamente all’attività di copia deisingoli fascicoli e dei gruppi redatti dalla stessa mano (non corrispondendo inalcun modo il richiamo alla resa grafica di ogni gruppo di fascicoli); inoltre ilfatto che tali richiami siano scollegati all’attività di copia è dimostrabile ancoraosservando che l’ultimo gruppo di fascicoli – il più cospicuo, che consta di ottounità codicologiche di base redatte dalla stessa mano – presenta al cambio difascicolo il richiamo “originale” a lettera minuscola apposto dal suo copista, al
Raffaella Zanni
43 Cfr. Le Roman de Tristan en prose: version du manuscrit fr. 757 de la Bibliothèque nationale de Paris,tome II, éd. par N. Laborderie et Th. Delcourt, Paris 1999, § 70, 20-217, 26.
44 Cfr. Le Roman de Tristan cit., tome III, éd. par J.-P. Ponceau, Paris 2000, § c, 10-402, 14 (la reda-zione alternativa del § 1 che accomuna ycxn è contenuta nella lista delle varianti a pp. 411-422).
45 Non rappresenterebbe del resto un caso isolato, considerando che già altri mss. attribuiti alla tra-dizione italiana del Tristan hanno unito al loro interno mani italiane e francesi, come i già menzio-nati Genève, Bodmer 164 (Delcorno Branca, Tristano e Lancillotto cit., p. 52) e Aberystwyth, NationalLibrary of Wales, 5667 E (ibid., p. 51; Ead., Lecteurs et interprètes cit., p. 161), magari per concludere ilproprio viaggio in qualche biblioteca di corte (come quella dei Visconti per il ms. gallese).
46 Riproduco di seguito tali richiami fascicolari dal tratto “italiano”: «et lor crie» (c. 16v); 2. «on ditque le lignages li roi ban» (c. 46v); 3. «puent aler» (c. 54v); 4. «or laissent la parole» (c. 60v); 5. «Etquant il ot prise» (c. 96v); 7. «plaist alom ueoir» (c. 104v); 8. «valut ia aucune foie» (c. 112v); 9. «grantvolonte» (c. 120v); 10. «que gendoie dire» (c. 128v); 11. «a trop gran defaute» (c. 136v); 12. «et mesiretristan ausint» (c. 144v); 13. «semblee» (c. 148v); 14. «dist de sa bouche» (c. 156v).
quale si è sovrapposto il richiamo esteso corrispondente a quanto segue all’iniziodel fascicolo successivo, della stessa tipologia di quelli riscontrati a partire di c.16v.Attribuirei con un buon margine di probabilità tali richiami alla mano del-l’assemblatore che opera in tal senso al fine di non danneggiare in nessun modola continuità logico-narrativa della porzione di romanzo trascritta nel gruppo(giunto in bottega come fascicoli sciolti, privi di cucitura). Era verosimilmenteprevisto, da assemblare al volume, anche un ulteriore fascicolo, contenente lachiusura dell’episodio: il margine inferiore dell’ultima carta ospita a destra unrichiamo fascicolare della stessa specie dei precedenti, che indica quanto dovesseseguire (e che corrisponde a quanto effettivamente segue a livello narrativo)47.
A tale elemento, assai esiguo quanto a porzioni grafiche redatte in corsiva ita-liana, si aggiunge un dato maggiormente probante: a c.96v, all’altezza nuovamentedi uno snodo tra fascicoli di differente provenienza, si osserva sul finire dellacolonna A un evidente cambiamento del tratto grafico (oltre all’intensità dellatinta d’inchiostro, che tende maggiormente al seppia) che impegna le ultime setterighe (seppur l’impressione generale sia di complessiva omogeneità;Tavola III).Ad esso fa seguito una colonna lasciata bianca, quindi l’inizio del nuovo gruppo
Il Tristan en prose tra Francia e Italia
47 Il ms. si interrompe a c. 156v B nell’ultima riga, lacunosa, con l’espressione «moi ueoir (…) me distacui ele le». Il richiamo «dist de sa bouche» prelude a quanto effettivamente segue: «dit (de sa boce)»;cfr.LeRoman de Tristan, III cit., § 402, 13-14 (lezione particolare del gruppo ycxn di V.I, riportata nella lista dellevarianti a p.460;n, il nostro fr.1434 si interrompe prima,ma yx presentano il sintagma «de sa boce»).
Tavola III. Paris, Bibliothèque nationale de France fr. 1434 96v B
di fascicoli, questa volta privo del grande capolettera ornamentale che normal-mente si trova in apertura di ogni sezione differente per mano e provenienza (igruppi di fascicoli differenti coincidono generalmente con gruppi di paragraficompleti dell’episodio del Louvezerp). Siamo ai preparativi del Torneo, al prelu-dio del combattimento di Palamèdes alla Cité Vermeille per vendicare l’uccisionedel re. Confrontando il testo con il rispettivo paragrafo dell’edizione modernavediamo che al passaggio di pagina non corrisponde alcuna interruzione testua-le, che la lacuna è solo apparente, causa colonna bianca, ma che la narrazionesegue senza alcun salto:
Fr. 1434, c. 96v A, 27-33-c. 97r A, 1-3Li ii serf qui conseil auoient ensenble do/ cire lor segnor se trindrent toutce/ lui ior moult pres del roi que onques nellais/ sirent lirois estoit moultbien montez/ et li ii serf autresi lirois entendi asa/chace et tant quil perditouz sez conpangnoz/ fors que soulament li deuz serf // et quant il ot prisesa chace il ot chaut/ et uolente de boire si descends devant une/ fontaine…
Li dui cerfs, qi conseill avoient ensemble d’ocirre lor seignor, se tindrenttout celui jor pres del roi, qe oucqes ne le lessierent. Li rois estoit moult bienmontéz et li dui sers autresint. Li rois entendi en sa chace et perdi touz cesconpaignons fors qe solement le .II. serfs et, quant il ot grant piece mainte-nu sa chace, il ot chaut et talant de boire; si descent devant une fontaine.48
A conferma dell’assenza di lacuna, del resto, va anche la presenza a conclu-sione di fascicolo, nel margine inferiore destro, al di sotto della colonna bian-ca, del solito richiamo fascicolare della stessa mano che produce gli altri (apartire da f. 16v), che introduce esattamente ciò che segue trascritto da caponel fascicolo seguente («et quant il ot prise…»). Ciò che cambia è invece larealizzazione grafica delle sette righe (96v A, 27-33). La mano che completa lacolonna A è differente da quella che produce il gruppo di fascicoli successivi49
e da quella che ha redatto i fascicoli precedenti50: il tratto è evidentementeitaliano, caratterizzato da una ridotta spezzatura delle curve, da un modulotondeggiante con contrasto ridotto al minimo; si riscontra la tradizionalealternanza tra la forma minuscola carolina e quella onciale della a, la g a “8”
Raffaella Zanni
48 Ibid., § 134, 1-7, p. 190. Il passaggio di pagina cade tra la linea 5 e la linea 6 dell’edizione moderna.49 Nuovamente fanno da guida la g (di differente modalità esecutiva, ma della stessa tipologia gra-
fica, nel primo caso più tondeggiante a “8”, nel secondo a “8” ma più schiacciata e squadrata), la a,ma soprattutto il maggiore innalzamento nel primo caso delle aste lunghe sul rigo: l, f, s, molto piùcompatte e ridotte in innalzamento sul rigo, nel secondo caso.
50 Fanno da guida la a, nel primo caso sempre di tipo onciale,nel secondo alternante onciale alla minu-scola carolina (seppur mai con chiusura dell’occhiello superiore), ma soprattutto la s ad inizio parola, nelprimo caso minuscola carolina (17, «somez»,ma 13 «serf») e alta sul rigo,nel secondo sempre alta sul rigo.
schiacciata sul rigo, e soprattutto, unico caso in tutto il manoscritto, la notatironiana abbreviativa per et a forma di “7”, senza trattino orizzontale. È datoriscontrare qualche spia grafematica italianeggiante (in particolare si noti laforma dell’articolo determinativo «del roi» [96v A, 29]; l’avverbio «soulament»[96v A, 33]); la mano sembrerebbe invece assimilabile nel tratto d’esecuzionealla minuscola corsiva che appone i richiami fascicolari a partire da f. 16v.
Ipotizzo quindi che tali righe costituiscano un’aggiunta apposta dall’assem-blatore del volume, che rivela la sua presenza proprio attraverso tale segmentotestuale e i richiami fascicolari in minuscola corsiveggiante apposti a collega-mento di sezioni graficamente diverse (dei quali ho appena parlato).Nuovamente quindi, in parallelo a quanto ho già dimostrato in altra sede esse-re avvenuto per il Barb. lat. 353651, un assemblatore di origine italiana, consa-pevole dello sviluppo della vicenda, ha giuntato fascicoli diversi (per prove-nienza e mano), ovvero i diversi capitoli di un unico episodio (il torneo delLouvezerp). Per far proseguire la storia senza lacune o salti, in presenza di unfascicolo originariamente mutilo, l’assemblatore aggiunge di propria mano lasezione mancante (corrispondente all’inizio del paragrafo che viene trascritto apartire da f. 97r, che appunto non prevede alcun capolettera ornamentale tipi-co dell’inizio del paragrafo) sullo spazio bianco che ha a disposizione alla finedel precedente fascicolo: per quest’ultimo, probabilmente, il suo compilatorenon aveva ben calcolato il numero di colonne necessarie e, arrivato alla con-clusione della copia, si trovava costretto a lasciare bianche le ultime sette righedella colonna A e l’intera colonna B. L’assemblatore è quindi intervenuto sulfascicolo, riempiendo quanto necessario a dare continuità a ciò che segue senzasalti o incongruenze narrative.
L’elemento indiscutibilmente probante del resto il passaggio in Italia delvolume è dato da un’annotazione marginale redatta in una minuscola di tiponotarile stiracchiata al massimo entro la prima metà del XIV, ripetuta due volte,con minime variazioni, nel margine superiore della c. 83v (Tavola IV): «Coramvobis sapienti et discreto viro domino Iacobo Cole de Spoleto legum do(t)tor».Si tratta di una formula incipitaria attestata nei registri di notai e giudici nelleistanze processuali di natura civile di parte. Iacobo Cole de Spoleto è giudice, ela parte agente, rappresentata verosimilmente da un ignoto notaio (colui cheappone la prova di penna, in duplice copia, sul Tristan) gli si rivolge per denun-ciare qualcun altro o per esporre le proprie posizioni (in materia civile)52.
Il Tristan en prose tra Francia e Italia
51 Zanni, Il Barberiniano latino 3536 cit., pp. 49-58.52 Ringrazio Attilio Bartoli Langeli di aver preso visione con me della sottoscrizione e di avermi aiu-
tato a sciogliere il significato della nota. Purtroppo la ricerca nei registri di giudici e notai non ha datorisultati fruttuosi, calcolando l’altissima incidenza del nome Iacobus. Si noti inoltre che, a chiusura delvolume (peraltro mutilo), a c. 156v si ha una sottoscrizione/firma o piuttosto nuovamente una prova di
Ricondurrei tale annotazione al possessore, o forse committente, del libromanoscritto un notaio impegnato, entro la prima metà del XIV secolo, in uncontenzioso di natura civile in area mediana, più precisamente umbro-spoletina(considerata generalmente la stabilità di notai e giudici in area civile, legati stretta-mente al distretto territoriale, laddove il penale permetteva invece lo spostamentodei giudici per l’Italia, a servizio di podestà e capitani del popolo), appassionatoverosimilmente di letteratura romanzesca in volgare d’oltralpe.Tale elemento èmolto importante se legato alla scoperta fatta da Arianna Punzi e Gioia Paradisinelle carte di guardia di protocolli notarili presso l’Archivio di Stato di Todi di unvolgarizzamento italiano dell’episodio del torneo del Louvezerp (al culminedella gloria cavalleresca di Tristano), riconducibile agli anni ’30-’40 delTrecento53: l’unione dei dati dimostrerebbe quindi una precoce circolazione,ancora in lingua originale come dimostra il fr. 1434, entro la fine del XIII (ulti-mo quarto), massimo inizi del XIV secolo, di materia tristaniana in area umbra,in particolare dell’episodio del Torneo, come marca distintiva dello specifico ita-liano, fra lingua d’oil e volgarizzamenti italiani. Il prosieguo della storia potrebbequindi prendere le mosse da qui, mettendo in relazione il frammento con lasezione del fr. 1434, al fine di identificare un possibile antecedente della redazio-
Raffaella Zanni
penna dal tratto evidentemente cancelleresco/notarile, tuttavia non decifrabile (ma vicina alla prova dipenna appena descritta).
53 G. Paradisi - A. Punzi, La tradizione del Tristan en prose in Italia e una nuova traduzione toscana, inActes du XXe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, Université de Zurich (6-11avril 1992), publié par G. Hilty,Tübingen-Basel 1993, tome V, pp. 321-337. L’edizione del frammen-to è fornita dalle due studiose nel contributo: Il ‘Tristano’ dell’Archivio di Stato di Todi. Edizione, in«Critica del Testo», 5 (2002), 2, pp. 541-546.
Tavola IV. Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 1434 83v
ne italiana todina (che rivela a sua volta rapporti di congruenza testuale con il fr.12599 e con il Panciatichiano 33).
4. Qualche conclusione
I due personaggi e le due storie giungono per il momento a conclusione.Dalla prima ricognizione che ho proposto in queste pagine possiamo osservarecome essi rappresentino pienamente due differenti tipologie di manufattolibrario, corrispondenti entrambe alle differenti modalità di circolazione italia-na del Tristan en prose, o meglio, strettamente conformi ad una richiesta e frui-zione specificamente italiana del romanzo antico francese. Il fr. 94 ben si iscriveinfatti nella tradizione del libro di lusso (epigono del libro universitario), ingotica textualis, con mise en page bicolonnare e ampi margini, dall’aspetto pulito,finemente miniato o predisposto al corredo iconografico (successivo all’opera-zione di copia), legato alla committenza delle biblioteche principesche, quindidelle grandi famiglie mecenatizie (specialmente dell’Italia del Nord). Il fr. 1434sembra invece inserirsi all’interno dell’assai variegata tipologia di libro “perso-nale” (di lettura e “portatile”), di modesta fattura e corredato di rozza orna-mentazione, generalmente redatto in gotichette non professionali, spesso com-posito, o con fascicoli di differente origine, con evidenti segni di “cucitura”, macoerente a livello narrativo, legato al gusto e agli interessi personali di specifichefigure professionali, come notai, giudici, poi mercanti, ecc.: forse i veri respon-sabili del passaggio culturale e materiale, insieme, a livello di redazione testuale,della materia romanzesca antico-francese ai volgarizzamenti in lingua italiana.
Il Tristan en prose tra Francia e Italia