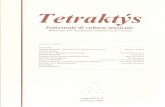Musica e tradizioni narrative: Turandot
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Musica e tradizioni narrative: Turandot
“PER UNA SEVERA MAESTRA”DONO A DANIELA ROMAGNOLI
Prime pagine Severa Maestra:01-prime pagine 20-06-2014 15:01 Pagina 1
ISBN: 978-88-6261-437-5
Di questo volume sono stati impressi 200 esemplari
Di cui uno numerato 00 per la festeggiata
Dodici numerati da I a XII per gli Autori dei Saggi
Nove numerati da 01 a 09 per gli Autori dei Ricordi
Novantotto numerati da 1 a 98 per i sottoscrittori della Tabula Gratulatoria
Finito di stampare nel Luglio 2014
presso Mattioli 1885 - Fidenza
Copia n.
Prime pagine Severa Maestra:01-prime pagine 20-06-2014 15:01 Pagina 2
I N D I C EI N D I C EI N D I C EI N D I C E
VITTORIO SCOTTI DOUGLAS, Non è un libro, ma un dono d’amore 7
SSSSAGGIAGGIAGGIAGGI
JACQUES LE GOFF, Le rire dans la Légende dorée 15
PAULA GERSON, Abbot Suger’s central portal bronze doors: A study in text and image 19
ADELAIDE RICCI, Sant’Antonio, la magnolia e un’autoscuola. (Lo sto-rico fa due passi in città) 31
GIAN LUCA POTESTÀ, «Gli spiriti dei profeti sono soggetti ai profeti». Da Giovanni di Rupescissa a Pietro Galatino 47
BARBARA H. ROSENWEIN, Circumstantiae locutionis at the Court of Toulouse c. 1200: Good Manners without a Courtesy Book 61
ALBERTO GIL NOVALES, Dimensiones urbanas e historia moderna 73
ELIZABETH A. R. BROWN, Saint Carpus, Saint Denis and Benign Je-sus: The Economy of Salvation at Saint-Denis 83
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI, «Ponere una certa regola et mo-destia». Il canone del consentito e del proibito nei banchetti cittadini fra Medioevo ed Età moderna 121
GIUSEPPA Z. ZANICHELLI, Osculetur me osculo oris sui: immagini del matrimonio nel XII secolo 135
ELVIRA GANGUTIA ELÍCEGUI, De la lírica y el drama grecolatinos a La Celestina 149
GIUSEPPE GATTO, Musica e tradizioni narrative: Turandot 165
MARIATERESA FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI, Storia e filosofia 187
4
RRRRICORDIICORDIICORDIICORDI
FRANCA GIORGI 193
GIANLUCA BATTIONI – LAURA BIGOI 197
PAOLA ERICOLI 203
GIOVANNA BRAGADINI 207
LUCILLA AMENTA 209
FABRIZIA DALCÒ 211
LAURA BANDINI 215
LICIA MASONI 219
IIIINDICE DENDICE DENDICE DENDICE DEGLI GLI GLI GLI AAAAUTORI CITATIUTORI CITATIUTORI CITATIUTORI CITATI 223
Musica e tradizioni narrative: Musica e tradizioni narrative: Musica e tradizioni narrative: Musica e tradizioni narrative: TurandotTurandotTurandotTurandot
Giuseppe Gatto
Che Daniela sia una medievista, è pacifico; ma non è solo medievista: fra i suoi molti interessi ha un posto di rilievo il mondo della musica. Chi scrive invece non è un medievista, e l’omaggio che intende rivolgerle è in relazione proprio con la musi-ca; ma dato che l’autore non è nemmeno un musicologo, ciò che proporrà sarà sotto una angolazione particolare, attraverso l’esame delle tradizioni narrative, orali e scritte, da cui un’opera musicale emerge, e senza limitarsi alle fonti letterarie o co-munque “culte”, ma spingendosi fino all’esplorazione di un territorio periferico su cui i musicologi in genere non si avventurano (del resto, non è di loro competenza): il rapporto della musica con il mondo della fiaba tradizionale.
Sia chiaro: non intendo scoprire l’acqua calda; che la musica abbia più di una volta tratto ispirazione dalla fiaba è ben noto: La Cenerentola di Rossini, Hänsel e Gretel di Humperdinck, L’amore delle tre melarance di Prokofiev…Ma in questi casi in genere si fa riferimento alla fonte immediata, di solito un testo più o meno letterario: le fiabe teatrali di Carlo Gozzi, i “cunti” di Giambattista Basile, le fiabe dei fratelli Grimm o di Perrault, i racconti delle Mille e una notte ecc. La mia inten-zione è di andare oltre, di tentare di aprire uno spiraglio sull’ampiezza della tradi-zione culturale, scritta e orale, sulle molteplici varianti in cui quei racconti si sono per così dire incarnati nel corso di vari secoli.
Prenderò in esame l’opera Turandot di Puccini. La fonte è nota: la Turandotte
di Carlo Gozzi (1762)1, apprezzata e tradotta in tedesco con qualche modifica da Schiller (18022; non è la prima traduzione tedesca: c’era già stata la «traduzione in-
1 Si può leggere il testo in CARLO GOZZI, Fiabe teatrali, a cura di Paolo Bosisio, Roma, Bul-
zoni, 1984, pp. 225 ss.; o in IDEM., Fiabe teatrali, a cura di Stefano Giovannuzzi, Milano, Mursia, 1998, pp. 93 ss.
2 FRIEDRICH SCHILLER, Turandot Prinzessin von China. Ein tragicomisches Märchen nach Gozzi von SCHILLER, Tübingen, in der Cotta’schen Buchandlung, 1802. Se ne può vedere una traduzione inglese in SABILLA NOVELLO, Turandot: The Chinese Sphinx, London, S. French, 1872.
Giuseppe Gatto
166
terpretante», cioè molto libera di Friedrich August Clemens Werthes tra il 1777 e il 1779)3 e poi ritradotta in italiano con ulteriori modifiche da Andrea Maffei (1863)4.
Per quanto riguarda le fonti di Carlo Gozzi, a volte si fa riferimento alle Mille e una notte 5. Ma le Mille e una notte tradotte da Antoine Galland all’inizio del ’7006 non contengono la storia di Turandot; il Gozzi la riprende invece dalla Histoire du Prince Calaf et de la Princesse de la Chine che è presente nei Mille et un Jours7, raccolta compilata e tradotta da François Pétis de La Croix nei primi anni del ’700, e confluita poi nel Cabinet des fées, la cui ultima e completa pubblicazione avviene ad Amsterdam e Ginevra tra il 1785 e il 17898.
La riprende, e ovviamente la modifica: il lungo racconto di Pétis de La Croix viene trasformato in un’opera teatrale in cinque atti; l’azione inizia con il principe che è già in Pechino; dal suo racconto nell’Atto I siamo informati sugli avvenimenti della parte iniziale, che viene omessa (la perdita del regno da parte di Timur, padre di Calaf, e la famiglia reale superstite ridotta alla mendicità, al punto che Calaf pro-pone di farsi vendere come schiavo perché i genitori possano vivere con il ricavato; proposta rifiutata dal padre, che si dice pronto piuttosto ad essere venduto lui9); le risposte agli enigmi posti dalla principessa Tourandocte (il sole, il mare, l’anno) vengono in parte modificate (il sole, l’anno, il leone dell’Adria); Calaf propone il suo: la principessa dovrà indovinare non solo il suo nome, ma anche quello di suo padre; tra i personaggi il Gozzi, fedele al suo programma anti-goldoniano, introduce le maschere della vecchia Commedia dell’arte (Brighella, Pantalone, Truffaldino,
3 RITA UNFER LUKOSCHIK, “La bella infedele”. La Turandot nella versione di F.A.Cl. Wer-
thes, in BODO GUTHMÜLLER e WOLFGANG OSTHOFF (eds.), Carlo Gozzi. Letteratura e musica, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 143-167.
4 ANDREA MAFFEI, Turandot, Principessa della China, fiaba tragicomica, in Macbeth, trage-dia di Guglielmo Shakespeare; Turandot, fola tragicomica di Carlo Gozzi; imitate da Federico Schiller e tradotte dal Cav. ANDREA MAFFEI, Firenze, Le Monnier, 1863, pp. 163 ss.
5 MOSCO CARNER, Puccini. A Critical Biography, New York, Knopf, 1959, p. 441; BURTON
B. FISCHER, Puccini Companion: The Glorious Dozen, Miami, Opera Journeys Publishing, 2004, p. 691.
6 Les Mille et une Nuit. Contes arabes. Traduits en françois par M. GALLAND, Paris, Barbin, 1704-1717. Una edizione recente: Les Mille et une Nuits. Contes arabes. Traduction d’Antoine Galland, 3 vols., Paris, GF Flammarion, 2004.
7 Les Mille et un Jours. Contes persans, traduits en françois par M. PETIS DE LA CROIX, Pa-ris, Clouzier, 1710-1712. V. la recente edizione critica: FRANÇOIS PETIS DE LA CROIX, Les Mille et un Jours. Contes persans, Édition critique par Christelle Bahler-Porte et Pierre Brunel, Paris, Honoré Champion, 2011.
8 Le Cabinet des fées, ou Collection choisie des contes des fées, et autres contes merveilleux. Ornés de Figures, Amsterdam-Genève, 1785-1789. La Histoire du prince Calaf… è nel vol. XIV, pp. 265-281 e 345-453; nella citata edizione critica alle pp. 244-254 e 295-361. Sulle diverse edi-zioni del Cabinet v. ANNE DEFRANCE, Les premiers recueils de contes de fées, in “Féeries”, 1, 2004, pp. 27-48.
9 F. PETIS DE LA CROIX, Les Mille…, ediz. critica cit., p. 298.
Musica e tradizioni narrative: Turandot
167
Tartaglia)10, che a tratti si esprimono in lingua veneziana. Nel finale Adelma, la principessa tartara schiava di Turandot tenta il suicidio per amore e per gelosia, ma Calaf la trattiene dal compiere il gesto, e l’imperatore Altoum la libera dallo stato di schiavitù e le restituisce il regno (nei Mille et un Jours il suo nome è Adelmulk, e il suicidio viene realmente compiuto).
Ci sono poi le modifiche operate da Schiller, lievi, come rileva il Maffei («mi venne desiderio di rileggerne l’originale italiano [il testo del Gozzi] per vedere e no-tare i passi dallo Schiller mutati; e con mio stupore trovai che ben di poco il poeta straniero si era allontanato dal nostro»11); la modifica più evidente riguarda gli e-nigmi: le soluzioni sono l’anno, l’occhio, l’aratro12; e tali restano anche nel testo del Maffei13.
Ben più profonde sono le modifiche apportate dai due librettisti Renato Simoni e Giuseppe Adami in collaborazione con lo stesso Puccini. Spariscono le quattro maschere, sostituite dai tre dignitari di corte Ping, Pang, Pong14, che agiscono in gruppo; le soluzioni degli enigmi sono di nuovo diverse: la speranza, il sangue, Tu-randot; c’è poi il mutamento più rilevante, l’introduzione del personaggio della gio-vane schiava Liù15, «a true Puccinian heroine»16, «la dernière de ces ‘petites femmes’ au destin tragique chères à Puccini»17, che nella sua devozione al vecchio re cieco Timur per qualcuno richiama la coppia Antigone – Edipo18; Liù certamente rie-cheggia Adelma, ma il suo suicidio è dettato soltanto dall’amore per Calaf, per non essere costretta a rivelarne il nome sotto tortura.
Una differenza importante è riscontrabile anche nel carattere e nel divenire di Turandot; nel testo di Carlo Gozzi il mutamento è graduale, anche se sofferto: già dal primo momento in cui si trova davanti Calaf la principessa avverte un turbamen-
10 Le maschere hanno anche la funzione di contrappunto comico alle vicende tragiche dei
personaggi principali; in questa pluralità di toni è stata vista «un’idea di teatro globale, davvero molto prossima a Shakespeare» (C. GOZZI, Fiabe teatrali, a cura di S. Giovannuzzi, cit., p. 24).
11 A. MAFFEI, Turandot…, cit., p. 321. 12 S. NOVELLO, Turandot…, cit., pp. 25 ss. 13 A. MAFFEI, Turandot…, cit., pp. 213 ss. 14 Già il Maffei, in fondo all’elenco dei personaggi, aveva prospettato l’opportunità di un
qualche intervento: «Qualora si volesse mettere sulle nostre scene la Turandot, converrebbe dar altro nome alle quattro maschere oggidì non tollerabili». A. MAFFEI, Turandot…, cit., p. 165. Anche i tre dignitari sono pensati secondo il modello dei fools shakespeariani secondo PAOLO
BOSISIO, Turandot tra fiaba drammatica e opera lirica: gli spazi della drammaturgia, p. 8: <http://www.paolobosisio.eu/turandot.pdf>.
15 “L’elemento decisivo e più marcatamente originale nella ricreazione pucciniana del plot” per P. BOSISIO, Turandot…, cit., p. 13.
16 M. CARNER, Puccini…, cit., p. 447. 17 HELENE CAO, Commentaire musical, in «L’Avant-Scène Opéra», n. 220, “Turandot”, Pa-
ris, 2004, p. 7. 18 IRIS J. ARNESEN, The Romantic World of Puccini. A New Critical Appraisal of the Op-
eras, Jefferson e London, McFarland & Co., 2009, p. 258.
Giuseppe Gatto
168
to mai provato prima; nel melodramma di Puccini invece il mutamento per cui «Tu-randot principessa crudelissima diviene Turandot principessa innamorata» (sono pa-role dello stesso Puccini)19 è improvviso, istantaneo. Nel II atto, nel formulare il ter-zo enigma, lei stessa si definisce irrimediabilmente algida: «Gelo che ti dà foco e dal tuo foco più gelo prende!» E ancora nel III atto, dopo che il principe sconosciuto ha risolto gli enigmi, Turandot è apostrofata da Liù: «Tu che di gel sei cinta», e da Ca-laf dopo il suicidio di Liù: «Principessa di morte! Principessa di gelo!». Il “miracolo” si compie in seguito al bacio appassionato di Calaf (ma ricordiamoci che Puccini non ha potuto gestire questo mutamento decisivo).
Altra novità: il rifiuto del matrimonio (ché di questo si tratta: nel II atto, dopo che Calaf ha risolto gli enigmi, Turandot ribadisce: Mai nessun m’avrà!»), che nelle versioni precedenti si fonda sul desiderio di non essere sotto il dominio di un uomo, nel melodramma ha una motivazione ben più precisa: vendicare l’offesa arrecata alla sua antenata Lo-u-Ling, violentata e uccisa dal re dei Tartari invasori (Atto II: «E Lo-u-Ling, la mia ava, / trascinata da un uomo, / come te, come te, straniero, / là nella notte atroce, / dove si spense la sua fresca voce!... O Principi, / che a lunghe carovane / d’ogni parte del mondo / qui venite a gettar la vostra sorte, / io vendico su voi / quella purezza, quel grido / e quella morte!»)20. Mosco Carner nella sua clas-sica monografia su Puccini rileva la somiglianza con l’antico mito delle Amazzoni, almeno con la versione su cui sarebbe basata la Pentesilea di Kleist (1808), e consi-dera ciò come prova del fatto che i librettisti abbiano avuto presenti altre fonti oltre al testo del Gozzi21. Carner può aver ragione sulla pluralità delle fonti, ma è neces-saria una correzione: il racconto che Pentesilea fa ad Achille nella scena 15 del dramma di Kleist per rispondere alla domanda dell’eroe sul motivo del rifiuto del matrimonio da parte delle Amazzoni (il loro regno pacifico invaso in tempi remoti dagli Etiopi che lo devastano, massacrando gli uomini e violentando le donne; la re-gina della Amazzoni Tanais costretta alle nozze con il re etiope Vexoris, che durante la notte viene da lei pugnalato a morte, come tutti gli altri “mariti” da parte delle al-tre Amazzoni; la decisione di costituire un regno di sole donne, con a capo una regi-na che si sarebbe data soltanto a chi l’avrebbe conquistata vincendola in combatti-mento) non è un mito greco, ma un’invenzione, geniale se vogliamo, dello stesso
19 RICHARD SPECHT, Giacomo Puccini. The Man His Life His Work, trad. ingl., New
York, Alfred A. Knopf, 1933, p. 228. 20 Uno studio sull’ “entrata in scena” di Turandot, con analisi musicologica di questa aria in
WOLFGANG OSTHOFF, Turandots Auftritt – Gozzi, Schiller, Maffei und Giacomo Puccini, in BODO GUTHMÜLLER e WOLFGANG OSTHOFF (eds.), Carlo Gozzi. Letteratura e musica, cit., pp. 255-281.
21 M. CARNER, Puccini…, cit., p. 442. Per la verità i librettisti lavorano sul testo di Andrea Maffei.
Musica e tradizioni narrative: Turandot
169
Kleist, modellata in parte sul mito delle Danaidi22. Naturalmente non è escluso che Roberto Simoni e Giuseppe Adami possano essersi ispirati al testo del poeta roman-tico tedesco nel caratterizzare Turandot come vendicatrice della grave offesa subita dalla lontana antenata.
È ora opportuno dire qualche parola sulla preistoria del racconto. Il poeta persiano Nizami, vissuto nel XII secolo (1141-1209), nel suo poema
Haft Paikar mette in scena il re Sassanide Bahram V con le sue sette mogli, ognuna delle quali gli racconta ogni giorno una storia: il martedì la moglie slava narra di un re di una città della Russia che aveva una figlia meravigliosamente bella e dotata di grande cultura in tutti i campi del sapere, ma che non voleva saperne di sposarsi. Di fronte alle insistenze del padre, pone delle condizioni perché accetti di farlo: andare a vivere in un castello fatto costruire in un luogo isolato, con gli accessi custoditi da automi in forma umana che avrebbero ucciso chiunque avesse tentato di entrare. A-vrebbe sposato un “vero uomo”, capace di superare gli ostacoli, e di rispondere cor-rettamente ai suoi enigmi. Molti ci provano: le loro teste decorano le mura; finché un giorno arriva un principe che seguendo i suggerimenti di un saggio eremita riesce a superare l’ostacolo degli automi, trova l’ingresso segreto, penetra nel cortile, dà la giusta risposta all’enigma proposto dalla principessa, e la sposa23.
Nel secolo successivo Marco Polo quasi verso la fine del Milione, nel capitolo 195, «De la Grande Turchia»24, scrive di Aigiarne25, figlia di Qaidu, nipote di Qu-bilai Khan:
Ora sappiate che questo re Caidu si avea una sua figliuola, la quale si era chiamata in tarteresco Aigiarne, cioè viene a dire i ’latino “lucente luna”. Questa donzella si era sì forte che non si trova(va) persona che vincere la potesse di veruna pruova. Lo re suo padre sì la volle maritare; quella disse che mai non si mariterebbe s’ella non trovasse alcuno gentile uomo che la vincesse di forza [o] d'altra pruova. … [Quan-do si presentava un pretendente, avveniva lo scontro secondo la regola] che se 'l donzello la vincesse, [la] donzella lo dovea prendere per suo marito, ed egli dovea
22 APOLLODORO, Biblioteca. Introduzione, traduzione e note di Marina Cavalli, Milano,
Mondadori, 1998, pp. 65 ss. Non è proprio esatto quindi ciò che scrive P. BOSISIO, Turandot…, cit., p. 1, che oltre tutto definisce le Amazzoni figlie di Danao.
23 JOHANN CHRISTOPH BÜRGEL, Turandot – Von Nizami to Puccini, in «Quaderni di Studi Indo-Mediterranei», I, 2008, pp. 347-364.
24 Il nome indica il Türkistan: MARCO POLO, Il Milione. Versione toscana del Trecento. E-dizione critica a cura di Valeria Bertolucci Pizzorusso, Milano, 2008(4a edizione), pp. 642-643.
25 Aigiarne o Aigiaruc o Aï-yaruq è nota anche con il nome di Qutulun: PAUL PELLIOT, No-tes on Marco Polo. Ouvrage Posthume Publié Sous Les Auspices de L'Académie Des Inscriptions Et Belles-lettres Et Avec Le Concours Du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Librairie Adrien-Maisonneuve, I, 1959, p. 15. Cfr. HENRY YULE (ed.), The Book of Ser Marco Polo, II, London, John Murray, 1903, p. 465 n. 1; M. POLO, Il Milione, cit., p. 532.
Giuseppe Gatto
170
avere lei per sua moglie; e se cosa fosse che la donzella vincesse l'uomo, si convenìa che l'uomo desse a lei c. cavagli.
Aigiarne ha già guadagnato 10.000 cavalli, quando si presenta un «donzello» tal-mente sicuro di sé da offrire mille cavalli invece dei soliti cento. Li perde; e Agiarne continua a seguire il padre nelle campagne militari e a combattere al suo fianco26.
Qualche decennio dopo Ibn Battuta nel descrivere il suo soggiorno nel paese di Ţawālisī27, parla della principessa Urdūjāh, che ai principi che la chiedono in moglie risponde che lei sposerà colui che la vincerà in combattimento; ma nessuno osa af-frontare la prova, per paura della vergogna che deriverebbe da una eventuale sconfit-ta28.
Alla fine del secolo XVII, nel terzo volume della Bibliothèque Orientale di Bar-thélemy D’Herbelot, completata da Antoine Galland nel 1697, compare per la pri-ma volta in un testo occidentale il nome di Tourandokht, riferito a due personaggi, una regina di Persia e una principessa moglie di un califfo29. Siamo ormai alle soglie di quella che sarà una vera e propria moda orientaleggiante che si imporrà per vari decenni in Europa, cui contribuirà in modo decisivo proprio la “traduzione” delle Mille e una notte da parte dello stesso Galland30.
Ma è opportuno fare un passo indietro: le vicende della principessa russa, di Ai-giarne, di Urdūjāh ci richiamano miti dell’antichità greca. Quello di Atalanta, che sollecitata dal padre a sposarsi, sfida i pretendenti a una gara di corsa nello stadio: lei correrà davanti, armata, e chi non riuscirà a raggiungerla, sarà da lei ucciso; se qual-cuno la raggiunge, sarà il suo sposo31. O quello di Ippodamia, in cui è il padre Eno-mao – si diceva perché innamorato della figlia32 – che pone ostacoli al suo matri-monio; il pretendente viene sfidato a una gara: deve prendere sul suo carro Ippoda-mia e correre fino all’istmo di Corinto; Enomao lo insegue con il suo carro trainato dai cavalli donatigli da Ares, e se lo raggiunge lo uccide. Solo Pelope riuscirà con
26 M. POLO, Il Milione, cit., pp. 301 ss. 27 IBN BATTUTA, I viaggi. A cura di Claudia M. Tresso, Torino, Einaudi, 2006, p. 691: paese
del sud-est asiatico di localizzazione incerta. Il testo francese Voyages d’Ibn Batoutah, texte arabe accompagné d’une traduction par CHARLES DEFREMERY et le Dr. BENIAMINO RAFFAELLO
SANGUINETTI, t. IV, Paris, À L’Imprimerie Nationale, 1879, p. 248 propone: «au pays de Thaouâlicy (peut-être l’île de Célèbes ou ploutôt le Tonkin)».
28 IBN BATTUTA, I viaggi, cit., p. 694. 29 Bibliothèque Orientale, par Mr. D’HERBELOT, t. III, La Haye, J. Neaulme e N. Van Daa-
len, 1778, p. 536. 30 JEAN-FRANÇOIS PERRIN, L’invention d’un genre littéraire au XVIIIe siècle. Le conte ori-
ental, in «Féeries», 2, 2005, pp. 9-27. La moda orientaleggiante non interessa solo l’Europa: SUSAN NANCE, How the Arabian Nights Inspired the American Dream, 1790-1935, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2009.
31 APOLLODORO, Biblioteca, cit., p. 161. 32 Anche sul padre di Aigiarne circolava una simile voce: PELLIOT, Notes on Marco Polo …,
cit., p. 15.
Musica e tradizioni narrative: Turandot
171
l’inganno a vincere la gara e a sposare Ippodamia, convincendo l’auriga di Enomao a sabotare il carro del re, non fissando bene i chiodi dei mozzi delle ruote33.
L’ostacolo al matrimonio, e questa volta proprio sotto forma di indovinello, si ritrova in un testo latino della tarda antichità (V-VI secolo; ma derivato da un origi-nale greco forse del III secolo): la Storia di Apollonio re di Tiro34. Il racconto ha i-nizio con la vicenda di Antioco, re di Antiochia, che dopo aver violentato la figlia intrattiene con lei una relazione incestuosa, e per evitare di dover porre fine a questa convivenza, dichiara che chiunque voglia sposare la principessa dovrà risolvere un enigma da lui proposto: chi non ci riesce sarà decapitato. Quando già molte teste decorano le mura, si presenta Apollonio per tentare la sorte; il re gli propone l’enigma: “Sono trascinato dal male, mi nutro della carne della madre, cerco mio fratello, figlio di mia moglie, marito di mia madre, e non lo trovo”35. Apollonio ne comprende in senso e dichiara che il re evidentemente si riferisce a sua figlia. Antio-co afferma che la risposta è sbagliata, ma gli concede trenta giorni di tempo per tro-vare la giusta soluzione; in realtà intende farlo assassinare… Il resto del romanzo, con le varie peripezie di Apollonio, si può tralasciare36. Ritroviamo la storia di Apol-lonio nei Gesta Romanorum, collezione di racconti la cui prima redazione risalireb-be alla fine del XIII secolo37: è il racconto n. 15338; la stessa storia sarà poi ripresa all’inizio del ’600 da Shakespeare nel dramma Pericle, Principe di Tiro.
Un altro racconto dei Gesta Romanorum, il n. 70, narra di un certo re che aveva una figlia bellissima, che però aveva fatto voto di accettare come sposo solo chi aves-se soddisfatto tre condizioni: 1) essere in grado di dire qual è la dimensione dei quattro elementi; 2) far mutare direzione al vento del Nord; 3) portare del fuoco sul proprio petto senza subirne danno alcuno. Promulgato il decreto, molti si presenta-no e falliscono. Arriva infine, accompagnato da un servo, un cavaliere che si dice pronto a risolvere i tre problemi. 1) Misura il corpo del servo fatto stendere per terra e dichiara che la dimensione dei quattro elementi è di sette piedi (il corpo umano è composto dei quattro elementi, quindi…); 2) somministra al suo cavallo imbizzarri-to una pozione che lo fa ammansire, quindi lo gira con la testa verso oriente (la vita di ogni essere vivente non è che vento…); 3) si pone in seno dei rami accesi senza
33 APOLLODORO, Biblioteca, cit., p. 203-204. 34 GIOVANNI GARBUGINO (ed.), La storia di Apollonio re di Tiro, Alessandria, Edizioni
dell’Orso, 2010, pp 123 ss. 35 LUCA SACCHI, Variazioni enigmatiche per Apollonio di Tiro, in “L’Immagine riflessa”,
N.S., XIX, 2010, pp. 93-117. Il testo dell’enigma è a p. 97; l’originale latino (Scelere uehor, ma-ternam carnem uescor, quaero fratrem meum, meae matris uirum, uxoris meae filium: non inue-nio) a p. 96.
36 Enigmi ci saranno anche nel seguito, proposti ad Apollonio da Tarsia, e saranno lo stru-mento attraverso cui avverrà il riconoscimento dei due come padre e figlia.
37 HERMANN OESTERLEY (ed.), Gesta Romanorum, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1872. Per la prima redazione, p. 256.
38 Ibi, p. 510.
Giuseppe Gatto
172
riportare alcuna bruciatura; perché, spiega, porta sempre con sé una pietra che ha il potere far sì che chiunque l’abbia non possa mai subire alcun danno dal fuoco. Il re approva le soluzioni e gli dà in sposa la principessa39.
Il racconto n. 251 dei Gesta Romanorum narra dell’imperatore Onorio che per porre fine a una guerra con un certo re accetta la proposta di quest’ultimo di far spo-sare la propria figlia con il figlio dell’imperatore. Dopo varie peripezie la principessa raggiunge la corte imperiale; ma l’imperatore le dichiara che prima di darle il figlio come marito intende sottoporla a una prova. Fa preparare tre scrigni, uno d’oro (pieno di ossa di morti), uno d’argento (pieno di terra), il terzo di piombo (con all’interno tre anelli preziosi), e la invita a sceglierne uno: se sceglierà bene, otterrà come marito il figlio dell’imperatore. La fanciulla sceglie lo scrigno di piombo; viene quindi celebrato il matrimonio40.
La prova cui l’imperatore sottopone la principessa sarà ripresa da Shakespeare nel Mercante di Venezia (1596-1598): per disposizione del padre defunto Porzia dovrà sposare l’uomo che farà la scelta giusta fra i tre scrigni; e Bassanio nella scena II dell’Atto III sceglie proprio quello di piombo, ottenendo così di sposare la giova-ne. E dato che siamo in tema di testi letterari, è il caso di ricordarne uno posteriore di alcuni decenni rispetto al Mercante di Shakespeare: La Princesse d’Elide di Mo-lière (1664): ritroviamo un padre preoccupato perché la figlia non intende sposarsi e respinge tutti i pretendenti, un padre che indice un torneo sperando che la figlia possa trovare tra i principi che vi partecipano uno di suo gradimento; ritroviamo la netta opposizione al matrimonio (il «Mai nessun m’avrà» di Turandot) espressa nella forma dell’equazione matrimonio-morte (Atto II, scena IV: «je regarde l'hyménée ainsi que le trépas, et qu'il m'est impossible de forcer cette aversion naturelle: me donner un mari, et me donner la mort c'est une même chose»). Si può aggiungere che secondo Paolo Bosisio il Gozzi può avere avuto presente anche La Princesse de Carizme di Alain-René Lesage (1719): la principessa è di una tale bellezza che chi la vede impazzisce, e i molti che hanno subito questa sorte sono ospitati in torri co-struite allo scopo; alla fine il principe di Persia perde sì momentaneamente il senno, ma poi lo riacquista sposando la principessa41.
Siamo con questi testi di nuovo vicini e anche dentro al Settecento e alla moda orientaleggiante che lo percorre. E incontriamo questa volta Le Mille e una notte, anche se in versioni posteriori rispetto a quella di Galland.
Nella versione curata da Francesco Gabrieli troviamo un personaggio per alcuni versi affine alla Aigiarne di Marco Polo e alla Urdūjāh di Ibn Battuta: un re ha una figlia bellissima, Datmà, che intende sposare solo chi riuscirà a vincerla in un torneo, a spada e lancia; chi sarà sconfitto, sarà da lei marchiato a fuoco in fronte come suo liberto. Molti ci provano, e falliscono. Arriva anche il figlio di un re della Persia, che
39 H. OESTERLEY (ed.), Gesta Romanorum, cit., p. 383 ss. 40 Ibi, p. 655 ss. 41 C. GOZZI, Fiabe teatrali, a cura di P. Bosisio, cit., p. 223.
Musica e tradizioni narrative: Turandot
173
sta per sopraffare Datmà, ma lei gioca d’astuzia: si scopre il volto sollevando il velo (come la Turandotte di Gozzi nel proporre il terzo enigma, nell’Atto II, scena V) e il principe, abbagliato dalla bellezza perde le forze e viene sconfitto. Riuscirà poi lo stesso a sposare la principessa, giocando anche lui d’astuzia42.
Nella edizione curata da Richard Burton troviamo il racconto di un re che fa educare il figlio facendogli dare una buona istruzione in tutti i campi del sapere. In seguito la situazione cambia, e la famiglia reale è ridotta a un tale stato di povertà da accettare il suggerimento del figlio di allontanarsi dalla loro città, dove per loro non c’è futuro. Arrivano in un’altra città, dove il figlio propone ai genitori di venderli come schiavi al sultano locale, e con il ricavato cercare fortuna e poi riscattarli; pro-posta che loro accettano. Condotti i genitori dal sultano, chiede come prezzo per il padre una giumenta sellata e provvista di tutto il necessario, e cede la madre in cam-bio di un completo di vestiti della migliore qualità. Il sultano accetta, e aggiunge an-che cento dinar. Il giovane parte e a un certo punto incontra un cavaliere che dice di provare simpatia per lui e perciò gli consegna una lettera, raccomandandogli di pre-sentarla al re della città in cui arriverà: gliene verrà un gran bene. Dopo un po’ il giovane ha molta sete, ma non trova acqua da nessuna parte; si accorge che la cavalla è coperta di un sudore diverso dal solito; smonta, prende l’involucro in cui è avvolta la lettera, raccoglie con esso il sudore e strizzandolo in una tazza può dissetarsi. Quindi pensa di aprire la lettera, e scopre che contiene l’ordine di uccidere imme-diatamente chi la presenta, dopo adeguata tortura.
Arrivato in una grande città, apprende che la bellissima figlia del re ha deciso che sposerà solo un uomo che saprà superarla in sapienza e darà una giusta risposta a tutte le sue domande; chi fallirà, sarà decapitato. Già novantanove giovani hanno subito questa sorte. Il principe decide di tentare; il mattino seguente viene ammesso alla presenza della principessa; ha quindi inizio un torneo di domande e risposte (le domande le pone la “Linguist-dame” come portavoce della principessa) che dura tre giorni. Il giovane risponde a tutte le domande, poi chiede di poter proporre lui una domanda alla principessa: se lei saprà rispondere, lui seguirà la sorte di coloro che lo hanno preceduto, in caso contrario lei sarà la sua sposa. La proposta viene accolta e il principe espone il suo enigma: che la principessa dica chi è l’uomo che, nato e cre-sciuto nella più grande ricchezza, si ritrova in povertà, deve montare suo padre e ve-stirsi con sua madre; partito in cerca di felicità, incontra la morte, ma il suo cavallo lo salva perché lui beve acqua venuta né dal cielo né dalla terra.
La Principessa è in difficoltà, rinvia la risposta all’indomani. La sera insieme alla sua Duenna (chaperon) e alcune ancelle si reca nel quartiere dove alloggia il giovane e si fa presentare da una schiava come una donna che si è innamorata di lui veden-dolo a corte, e che è disposta a tutto. Il giovane la fa entrare, e mentre i due mangia-no e conversano la Duenna gli dà del vino fino a farlo ubriacare, poi la principessa si
42 FRANCESCO GABRIELI (ed.), Le Mille e una notte, Torino, Einaudi, 1969, II, pp. 130 ss.
Giuseppe Gatto
174
sdraia sul divano in modo da accendere il desiderio del giovane, che le svela la solu-zione dell’enigma. La principessa è soddisfatta, a tal punto da dimenticare lì parte dei suoi vestiti e i resti del pranzo che aveva portato con sé. Al risveglio il giovane vede i capi di abbigliamento, i gioielli, i resti del pranzo e comprende ciò che è acca-duto: si presenta a corte dicendo di aver ricevuto la visita di un uccello bellissimo (l’inglese usa poi il pronome femminile she), che avevano mangiato e bevuto insie-me, ma che durante la notte se ne era andato con un battito d’ali; e se lo avesse ne-gato, avrebbe mostrato al re e a tutti gli altri le sue piume. Il re comprende, dichiara vincitore il giovane principe, si celebra il matrimonio. Il principe in seguito libera i genitori dalla schiavitù43.
Il racconto si ritrova quasi identico, con qualche variante, nell’edizione delle Mille e una notte curata da Mardrus: manca l’episodio delle lettera; è accentuato il clima di terrore che regna nella città, anche con la descrizione delle teste penzolanti dei decapitati; la principessa parla personalmente, senza intermediari; quando il gio-vane pretendente propone a sua volta il suo enigma, lei si dichiara subito vinta44.
Questi due ultimi testi (Burton e Mardrus) contengono il racconto nella versio-ne più vicina a quella che secondo Christine Goldberg45 sarebbe la forma originaria della storia (vendita dei genitori, enigma costruito con allusione al ricavato di questa vendita, episodio della lettera traditrice, novantanove pretendenti già uccisi, visita notturna della principessa con dimenticanza di un capo di vestiario…), che sarebbe nata in un’area tra il Mediterraneo e il fiume Tigri, tra il I secolo a.C. e il I d.C., in arabo, poi tradotta in aramaico, indi ritradotta in arabo e infine confluita nel grande mare delle Mille e una notte.
Fino ad ora siamo stati in presenza di tradizioni testuali. È ora arrivato il mo-
mento di varcare la frontiera e di entrare nel territorio periferico di cui si parlava all’inizio: il territorio della fiaba tradizionale. Per la verità ci siamo già entrati, anche se di poco e quasi di soppiatto, da clandestini: quando Bassanio o la principessa del racconto 251 dei Gesta Romanorum scelgono lo scrigno di piombo, seguono quella che è stata definita come la seconda delle norme che regolano il comportamento dell’eroe della fiaba: Si deve scegliere l’oggetto più ordinario, la via più rischiosa, quella che appare come l’alternativa peggiore46. Non solo: gli enigmi, le gare, le lot-
43 RICHARD BURTON (ed.), The Book of The Thousand Nights and a Night (Supplemental
Nights), XII, London, H. S. Nichols, 1897, pp. 65 ss. Sul racconto v. ULRICH MARZOLPH and
RICHARD VAN LEEUWEN (eds.), The Arabian Nights Encyclopedia, I, Santa Barbara – Denver – Oxford, ABC-CLIO, 2004, pp. 269 ss.
44 JOSEPH CHARLES MARDRUS, Le Livre des Mille Nuits et une Nuit, t. XIII, Paris, Char-pentier et Fasquelle, 1903, pp. 217 ss.
45 CHRISTINE GOLDBERG, Turandot’s Sisters: A Study of the Folktale AT 851, New York & London, Garland Publishing, 1993, pp. 25 ss.
46 ELEAZAR M. MELETINSKIJ, S. JU. NEKLIUDOV, E. S. NOVIK, D. M. SEGAL, Problems of the Stuctural Analysis of Fairytales, in PIERRE MARANDA (ed.), Soviet Structural Folkloristics,
Musica e tradizioni narrative: Turandot
175
te, tutte le prove cui il pretendente è sottoposto, richiamano la funzione 25 della Morfologia di Propp, il “compito difficile” che l’eroe deve superare per accedere al matrimonio con la principessa47. E Luciano Berio faceva riferimento alla Morfolo-gia per osservare come la struttura del dramma di Carlo Gozzi rispetti le regole fondamentali della fiaba: «la jeune fille qui doit se marier, parce que la famille le veut ainsi, mai qui s’oppose à ce souhait et met les prétendants à l’épreuve»; mentre l’introduzione del personaggio di Liù rende la versione Puccini più complicata48. L’osservazione è legittima, come è legittima quella di Paolo Bosisio sul ritmo terna-rio, tipico delle fiabe49; ma il rapporto con il mondo della fiaba può essere visto più da vicino.
Chiunque si occupi di fiabe tradizionali sa che nel catalogo internazionale dei tipi di fiaba esiste il tipo ATU 851: The Princess Who Cannot Solve the Riddle50. Per la verità le edizioni precedenti dello stesso catalogo distinguevano due tipi: AT 851 e AT 851A, per un motivo preciso, perché il racconto presenta le varianti in due grandi gruppi: da un lato un insieme di storie con uno svolgimento analogo a quello di Turandot (la principessa propone gli enigmi, AT 851A), dall’altro il grup-po più diffuso a livello di tradizione orale, in cui lo svolgimento è invertito (la prin-cipessa deve risolvere l’enigma – o gli enigmi – proposto dall’eroe della fiaba, AT 851). L’editore dell’ultima edizione ha deciso di unificare il tutto sotto l’unico tipo ATU 851, ma resta comunque la presenza delle due direttrici della narrazione.
Vedremo diversi racconti, con struttura abbastanza stabile ma con differenze a volte anche notevoli tra di loro, per via di quella variabilità che è caratteristica es-senziale delle fiabe trasmesse oralmente51. Ma osserveremo anche come spesso riaf-fiorano in queste fiabe motivi già visti ora in uno ora in un altro dei testi presi in considerazione fin qui; riaffiorano, ma con colorazione diversa, un po’ più rustica: dopo tutto, si tratta di racconti trasmessi, narrati, vissuti in ambiente essenzialmente rurale, e questo si sente nei testi.
The Hague-Paris, Mouton, 1974, pp. 73-139 (le norme sono a p. 107). Una trad. it.: IID, La struttura della fiaba, Palermo, Sellerio, 1977.
47 VLADIMIR JA. PROPP, Morfologia della fiaba, trad. it., Torino, Einaudi, 1966, p. 65. 48 DEREK WEBBER, TURANDOT se termine “pianissimo”. Entretien avec Luciano Berio, in
«L’Avant-Scène Opéra», n. cit., pp. 92-93. 49 P. BOSISIO, Turandot…, cit., p. 1. 50 HANS-JÖRG UTHER, The Types of International Folktales. A Classification and Biblio-
graphy, FFC 284, 285, 286, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, 2004, I, p. 478 ss. Le sigle citate nel testo rinviano a questa edizione (ATU, Aarne-Thompson-Uther) o alle edizioni prece-denti del catalogo (AT, Aarne-Thompson).
51 VERONIKA GÖRÖG-KARADY (ed.), D’un conte … à l’autre. From one Tale… to the O-ther, Paris, Éditions du CNRS, 1990; GIUSEPPE GATTO, La fiaba di tradizione orale, Milano, LED Edizioni, 2006, pp. 20 ss.
Giuseppe Gatto
176
Una serie di fiabe ha per protagonista un eroe “non nato”; tipo di narrazione questa che dovrebbe aver avuto origine proprio in territorio italiano52. Un racconto registrato in Sardegna (La principessa indovina):
Un uomo molto ricco si accorge che la moglie sta per morire di parto, allora ne «apre la pancia» e salva il bambino, conservando la placenta essiccata. Una volta cre-sciuto, il ragazzo apre la pancia di una cavalla gravida e ne estrae il puledrino; quan-do il puledro è abbastanza grande, il giovane parte a cavallo per girare il mondo, portando con sé i guanti che il padre aveva fatto con la placenta della madre. Per strada scaglia una pietra contro un merlo, ma l’uccello vola via, e la pietra colpisce una lepre; il giovane ne apre la pancia ed estrae tre leprotti, che cuoce bruciando dei libri presi in una chiesa diroccata. Ha sete, e beve acqua delle lampade che pendono dal soffitto della chiesa; arriva presso un fiume in piena e vede sull’acqua galleggiare un cavallo morto e due o tre corvi che lo becchettano.
Arrivato in città viene a sapere che la principessa ha dichiarato che sposerà chi proporrà un indovinello che lei non riuscirà a risolvere; nel caso in cui lei ci riesca, il pretendente sarà messo a morte. Decide di tentare; si presenta a corte ed espone il suo enigma:
Non nato sono io, né il mio cavallo; e porto mia mamma nelle mani; miro a chi vedo e uccido chi non vedo; carne fatta e non nata, trovata e cotta con parole. Bevo acqua né in cielo né in terra. Il morto porta i vivi.
La principessa chiede tre giorni di tempo, ma non trova la soluzione; quindi si traveste da uomo, e va nell’osteria dove alloggia il giovane. Nella notte lo interroga sul significato dell’indovinello, lui capisce che è una donna, per cui sul momento non risponde, poi vanno a letto, e solo allora le svela la soluzione. La mattina la principessa rivestendosi in fretta dimentica la camicia. A corte lei dà la risposta, ma lui dice che ne manca un pezzetto: Viene una capretta, sparo alla capretta, se ne va la capretta, mi lascia la pelle insanguinata. Di nuovo la principessa dopo tre giorni non riesce a trovare la soluzione; allora il giovane viene obbligato a spiegare il nuovo enigma, e lui racconta che la principessa aveva dormito con lui e fa vedere la camicia insanguinata. Il re decide che la figlia deve sposarlo53.
In un racconto dell’isola di Lesbo (Les deux énigmes)54 dei briganti saccheggia-no un palazzo, uccidono la regina e vendono come schiava la sua bambina di sette anni a un altro re. Quando la ragazza è cresciuta viene data in dono al re suo padre che, non sapendo che si tratta di sua figlia, la sposa. Quando si rende conto della re-altà, fa uccidere la figlia/moglie ed estrarre il bambino di cui era incinta; fa lo stesso anche con una cavalla. Dopo qualche tempo fa fare per il figlio dei guanti con la pel-
52 C. GOLDBERG, Turandot’s Sisters…, cit., pp. 46 ss. 53 ENRICA DELITALA, Fiabe e leggende nelle tradizioni popolari della Sardegna, Sassari, Car-
lo Delfino Editore, 2000, pp. 108-111. 54 G. GEORGEAKIS et LÉON PINEAU, Le folklore de Lesbos, Paris, Maisonneuve, 1894, pp.
105 ss.
Musica e tradizioni narrative: Turandot
177
le della madre. Conosciuta l’orribile verità, il giovane si allontana da casa, e arriva in una città dove apprende che la principessa sposerà colui che riuscirà a risolvere un suo enigma; in caso di insuccesso, la morte. Quando la principessa espone il suo enigma (Je piétine ce avec quoi je mange; je porte aux doigts ce avec quoi je vois, et j'ai la cervelle de ce dans quoi je bois), il giovane risponde che lo risolverà se lei ri-solverà il suo (Mon cheval et moi, nous ne sommes pas nés; et, en marchant, je porte ma mère)55. La principessa, non trovando la soluzione, deve spiegare il senso dell’enigma: era innamorata di un negro che non aveva accettato il suo amore; lo a-veva fatto uccidere, e con i denti di lui aveva ornato le sue scarpe, con gli occhi i suoi anelli, beveva nel suo cranio56. Il principe spiega a sua volta il suo enigma. Si sposa-no. Interessante, e atipico, in questa fiaba è lo scambio di enigmi: il principe propo-ne un suo indovinello, ma non si tratta di offrire, con apparente generosità, una pos-sibile via d’uscita alla principessa (se Turandot indovina il nome di Calaf, non sarà obbligata a sposarlo…), ma di un vero e proprio scambio: tu risolvi il mio, io risolvo il tuo.
Dal Monferrato proviene una fiaba (L’enimma) in cui invece l’incesto è volon-tario: un ricco signore rimasto vedovo va a letto con la figlia; questa rimane incinta, e in seguito viene ordinato a un servo di portarla in cantina, ucciderla, ed estrarre vivo il bambino che porta in grembo. Una volta cresciuto, il giovane viene a cono-scenza dei fatti, trova in cantina il cadavere quasi intatto della madre, le taglia le mammelle e se ne fa dei guanti. L’indovinello che proporrà alla principessa sarà: Io son nato e non son nato. Porto in mano mia madre che fu figlia di mio padre. La principessa non riesce a risolvere l’enigma; segue l’episodio notturno dell’osteria, e quindi il matrimonio57.
Un gruppo folto di storie è caratterizzato da un motivo particolare: la madre del
protagonista tenta di avvelenare il figlio quando questi parte per tentare l’avventura dell’indovinello da proporre alla principessa. Come esempio tipico, ecco una versio-ne bolognese pubblicata nel 1883 da Carolina Coronedi Berti (La fola d’i indvini):
Un re è crucciato perché la figlia bellissima rifiuta tutti i pretendenti, finché la convince ad accettare che sia emanato un bando: colui che proporrà un indovinello che lei non saprà risolvere, quello sarà suo marito. Il figlio di una povera donna de-cide di tentare; la madre non riesce a dissuaderlo dal correre il rischio, e piuttosto che saperlo condannato a morte dalla principessa preferisce farlo morire lei stessa. Gli prepara quindi una focaccia avvelenata; durante il viaggio il giovane dà la focac-
55 G. GEORGEAKIS et L. PINEAU, Le folklore..., cit., pp. 106-107. 56 Un enigma analogo, ma in un contesto non relativo alla conquista della principessa, in E-
MILE LEGRAND, Recueil de contes populaires grecs, Paris, Ernest Leroux, 1881, pp. 29 ss. 57 DOMENICO COMPARETTI, Novelline popolari italiane, Torino, Loescher, 1875, pp. 259
ss.
Giuseppe Gatto
178
cia al cane, che muore; ciò gli suggerisce la prima parte dell’indovinello: Chi m’amava mi tradì / Can fedel per me morì.
Mentre beve a una fontana, vede la pietra scavata dall’acqua; altro pezzo dell’indovinello: Ho visto il tenero forare il duro.
Lancia una pietra verso un melo per far cadere qualche frutto, ma la pietra rica-dendo colpisce e uccide una pecora gravida: Butto a chi vedo / e colgo a chi non ve-do.
Estrae l’agnellino dal ventre della pecora e lo fa cuocere accendendo il fuoco con dei fogli di carta stampata: Ho mangiato carne non nata / cotta con delle parole.
La principessa non trova la soluzione; segue l’episodio della notte passata nella locanda per carpire il segreto, del lembo della camicia che il giovane l’indomani pre-senta al re come prova che lei è già di fatto sua sposa, e quindi il matrimonio58.
Un racconto trascritto da Giuseppe Ferraro nel Monferrato nel 1869 (Le rispo-ste impossibili)59 ha inizio con la triplicazione tipica delle fiabe: due fratelli hanno già trovato la morte presentando alla principessa degli indovinelli piuttosto stupidi, facilissimi da risolvere. Parte il terzo, malgrado il parere negativo della madre, che per il viaggio gli dà una focaccia avvelenata. Seguono le vicende solite: morte del cane e dell’asino, leprotto arrostito con libri da messa bruciati ecc.; infine, le nozze.
Struttura analoga, ma senza triplicazione iniziale, hanno una fiaba toscana rac-colta da Carlo Lapucci (La novella dell’enigma)60, una fiaba istriana (Bierde)61, e una lucana (Fortuna)62. Lo stesso si può dire per due racconti siciliani pubblicati dal Pitrè, uno di Palermo (La Rigginedda chi s’avia a maritari)63 e uno di Prizzi (Lu Cacciaturi)64, con la differenza che il pane che il protagonista porta con sé è avvele-nato, ma non si dice da chi e perché. Un racconto toscano pubblicato dal Pitrè (Soldatino) presenta invece delle caratteristiche particolari: gli indovinelli sono tre, proposti in tre giorni consecutivi; la struttura è complicata dall’inserimento di moti-vi tipici del tipo ATU 853 (The Hero Catches the Princess with Her Own Words)65: alla fine, di fronte alle resistenze della principessa che non vorrebbe spo-sare quello zotico, lui si dice disposto a rinunciare al matrimonio, e chiede al re di poter dormire solo una notte con lei, che però dovrà rispondere sempre no a qua-lunque sua domanda. Le domande saranno tante, e l’ultima, quando già sono a let-
58 CAROLINA CORONEDI BERTI, Favole bolognesi (Al sgugiol di ragazù), Bologna, 1883,
rist. anast. Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 2000, pp. 59 ss. 59 GIAN LUIGI BECCARIA (ed.), Fiabe piemontesi, Milano, Mondadori, 1982, pp. 147 ss. 60 CARLO LAPUCCI (ed.), Fiabe toscane, Milano, Mondadori, 1984, pp. 31 ss. 61 THOMAS FREDERICK CRANE, Italian Popular Tales, Boston, Houghton, Mifflin and Co.,
1885, pp. 55 ss. 62 D. COMPARETTI, Novelline popolari …, cit., pp. 106 ss. 63 GIUSEPPE PITRÈ, Fiabe e leggende popolari siciliane, Palermo, Pedone Lauriel, 1888, pp. 1
ss. 64 Ibi, pp. 7 ss. 65 H.-J. UTHER, The Types of International Folktales…, cit., pp. 481 ss.
Musica e tradizioni narrative: Turandot
179
to: «Ma si sta bene a non essere abbracciati?»; la risposta obbligata è no, e quindi il mattino seguente si dichiarano già sposi66.
Sviluppi particolari anche in una fiaba bretone (Petit Jean et la Princesse devi-neresse): la figlia del re di Francia sposerà chi proporrà un indovinello che lei non riuscirà a risolvere nel giro di tre giorni; se ci riesce, il pretendente sarà impiccato. Un cavaliere ci vuole provare, riuscendo a evitare di morire avvelenato dalla madre già al momento della partenza. Si hanno più o meno le solite avventure, e alla fine la principessa, non essendo in grado di risolvere l’enigma, nelle due notti successive invia prima una e poi una seconda femme de chambre perché si facciano rivelare il segreto. Le due donne falliscono, e al mattino con un trucco sono costrette a correr via nude, abbandonando i vestiti nella locanda; lo stesso succede alla principessa, che la terza notte decide di provarci personalmente. Allora lei accetta di sposarlo, ma a una condizione: che lui riesca a riempire un sacco di verità. Il giorno dopo il cavaliere si presenta a corte con un sacco e comincia a tirar fuori i vari capi di abbi-gliamento delle donne; la principessa si affretta a impedirgli di arrivare in fondo al sacco, accettando di sposarlo67.
Il gesto della madre che tenta di avvelenare il figlio deve essere apparso a più di un narratore come assurdo, senza senso, addirittura inquietante; e abbiamo quindi dei racconti in cui si cerca di attenuarne la portata negativa. Una fiaba greca non nega il gesto, ma gli toglie l’intenzione omicida: la madre mette sì nella focaccia del veleno per i topi, ma dice al figlio di darla da mangiare alla cagna che lui porta con sé, e se per caso dovesse succedere qualcosa di strano all’animale, di tornare a casa e non andare a proporre indovinelli alla principessa68. In altri casi il gesto viene attri-buito a persona estranea alla famiglia: in una delle fiabe di Montale Pistoiese rac-colte da Gherardo Nerucci (Il figliuolo del Mercante di Milano) il tentato avvele-namento è opera di una contadina che ospita il giovane per la notte69; nella fiaba n. 22 dei Grimm (Das Rätsel) chi agisce è una strega70; estranei agiscono anche in rac-conti islandesi71.
66 G. PITRÈ, Novelle popolari toscane, Firenze, Barbera, 1885, pp. 107 ss. 67 FRANÇOIS-MARIE LUZEL, Contes populaires de Basse-Bretagne, Paris, Maisonneuve et
Ch. Leclerc, 1887, t. III, pp. 326 ss. Le visite notturne delle chambermaids e della stessa princi-pessa sono presenti anche in una fiaba russa, che non contiene il motivo del tentato avvelenamen-to: Russian Fairy Tales. Collected by Aleksandr Afanas’ev, New York, Pantheon Books, 1973, pp. 115 ss. (The Princess Who Wanted to Solve Riddles).
68 E. LEGRAND, Recueil de contes populaires…, cit., pp. 39 ss. 69 GHERARDO NERUCCI, Sessanta novelle popolari montalesi, Firenze, Le Monnier, 1880,
pp. 177 ss. 70 BRÜDER GRIMM, Kinder- und Hausmärchen. Jubiläumsausgabe zu der 200. Geburtstag
der Brüder Grimm, 1985/86, herausgegeben von HEINZ RÖLLEKE, Stuttgart, Reclam, 1984, n. 22. Una trad. it.: JACOB e WILHELM GRIMM, Fiabe, Milano, Fabbri Editori, 2001, I, p. 176 ss. (L’indovinello).
71 C. GOLDBERG, Turandot’s Sisters…, cit., p. 67.
Giuseppe Gatto
180
Fino ad ora abbiamo visto nelle fiabe la principessa come destinataria degli e-
nigmi, e in qualche raro caso come colei che li propone; esistono però racconti in cui è in primo piano il re. In un racconto toscano (L’indovinello e gli animali rico-noscenti) il figlio di un pecoraio parte con il pane avvelenato ecc. e propone al re di Firenze (sic) il suo indovinello, che il re non riesce a trovare nel suo registro, e quindi gli deve dare in sposa la figlia72. In una fiaba della Corsica (La bête à sept tê-tes) per sposare la principessa bisogna combattere e vincere contro il serpente con sette teste che ha ucciso molte persone, e quindi proporre un indovinello che il re non sappia risolvere. Tre fratelli partono all’avventura: il primo e il secondo vengo-no uccisi per strada da ladri; parte allora il terzo contro il parere della madre che gli prepara delle focacce avvelenate ecc. Il re non risolve l’enigma, il giovane uccide il mostro con sette teste, e quindi sposa la principessa73 (il racconto contiene il motivo della lotta con il drago, appartenente al tipo ATU 300, The Dragon Slayer74). In una fiaba lituana (Gli indovinelli del figlio del guardaboschi) la vicenda è ancor più al maschile: il tentato avvelenamento è opera non della madre ma del padre, che versa il veleno nell’idromele che dà al figlio. Si succedono gli avvenimenti che già conosciamo (muore il cavallo, tre corvi beccano la carcassa ecc.); il re non riesce a risolvere l’indovinello, ed è ancora lui che ha l’idea di suggerire alla figlia di scoprire la soluzione con l’inganno. L’una dopo l’altra sei bellissime serve della principessa vanno a letto con il giovane, ma riescono a rimediare solo una frustata sulla schiena e corrono via abbandonando i loro abiti. Alla fine ci va la principessa in persona, che malgrado le frustate resta a letto; passano la notte assieme e il giovane le rivela la soluzione. La mattina seguente il re è sicuro di essere in possesso della risposta al problema, ma il giovane gli fa capire di aver ricevuto la visita notturna di sette don-ne, e di essere stato tutta la notte con la settima; gli fa vedere il sacco con gli abiti, il re li riconosce e nomina suo genero il figlio del guardaboschi75.
Al re viene proposto l’indovinello anche nelle Antille, dove il colore locale e-merge chiaramente nella figura del protagonista: Anansi, il cui nome rinvia al tri-ckster di origine africana76.
72 ANGELO DE GUBERNATIS, Le novelline di Santo Stefano, Torino, Negro Editore, 1869,
pp. 49 ss. 73 FREDERIC ORTOLI, Les contes populaires de l’île de Corse, Paris, Maisonneuve, 1883, pp.
123 ss. 74 H.-J. UTHER, The Types of International Folktales…, cit., pp. 174 ss. 75 JOCHE D. RANGE, Märchen aus Litauen, Frankfurt am Main, Fischer Verlag, 1994, trad.
it., Fiabe lituane, Milano, Mondadori, 1997, pp. 92 ss. 76 ROGER D. ABRAHAMS, The Riddle of the Poisoned Animals, in “Western Folklore” 36,
1977, 2, pp. 163-168; IDEM, A Note on Neck-Riddles in the West Indies as They Comment on Emergent Genre Theory, in «Journal of American Folklore» 98, 1985, 387, pp. 85-94. Sul trick-ster v. PAUL RADIN, The Trickster. A Study in American Indian Mythology (1956), New York, Schocken Books, 1972; WILLIAM J. HYNES e WILLIAM G. DOTY (eds.), Mythical Tricksters Fig-
Musica e tradizioni narrative: Turandot
181
La fantasia dei narratori popolari ha creato diverse variazioni sul tema di fondo.
A volte c’è il tema dell’enigma, ma è assente la principessa: in un racconto algerino (Le cadi et la fille du marchand de savon) il cadì annuncia che proporrà un enigma, e chi non lo indovinerà sarà decapitato. L’enigma: Il y a un arbre très élevé, l'arbre a douze branches, chaque branche a trente feuilles, chaque feuille a cinq fruits. Tutti si ritirano, terrorizzati per quello che succederà il giorno dopo; un venditore di sapone racconta disperato la cosa alla figlia, che risolve immediatamente l’enigma: l’albero è il mondo, i rami i mesi, le foglie i giorni, i frutti le cinque preghiere. Quando l’indomani l’uomo dà la giusta risposta e rivela che è stata la figlia a suggerirgli la soluzione, il cadì decide di sposare la ragazza77. Non c’è la principessa, ma comun-que l’indovinello prelude a un matrimonio.
Altre volte il racconto presenta una vena di umorismo, come in un racconto por-toricano: […] the king had a beautiful daughter who was blind in one eye and cross-eyed in the other [...]; la promette in sposa a chiunque risolverà un indovinello pro-posto da lei e sarà in grado di proporre a sua volta un indovinello che lei non riuscirà a risolvere. Juan Bobo parte; segue una serie di avvenimenti, al termine dei quali Juan Bobo sposa la principessa, non prima di aver dovuto individuarla frammista a molte ragazze tutte somiglianti e tutte strabiche78.
L’indovinello può essere sostituito da un gioco, che è comunque un gioco ad al-to rischio: la morte. In una fiaba siriana (Il taglialegna e la principessa che amava giocare a nascondino) un taglialegna arriva davanti a un castello costruito con teste umane, e apprende che la figlia del re «si diverte a giocare a nascondino con gli uo-mini» e ha proposto una sfida: se qualcuno riesce a nascondersi in modo che lei non possa trovarlo, la sposerà, altrimenti verrà ucciso. Il taglialegna decide di affrontare il rischio; un mago lo aiuta nascondendolo prima in fondo al mare e poi nel settimo cielo; ogni volta la principessa lo vede nella sua sfera di cristallo, ma gli fa grazia del-la vita. Quando si presenta a sfidarla per la terza volta, lo avverte che non sarà di nuovo indulgente; il mago lo trasforma in un filo di cotone che depone sulle spalle della principessa, che non riesce a trovarlo e quindi deve sposare il taglialegna79.
Altre varianti contengono doppi sensi, temi erotici o francamente osceni. Co-squin segnala un racconto lorenese (La princesse et les trois frères) in cui tre fratelli
ures, Tuscaloosa, Univ. of Alabama Press, 1993. Sulla presenza del trickster nella tradizione occi-dentale, dal Medioevo europeo ai cartoons americani, si può vedere anche MATHIAS GUENTHER, The Bushman Trickster: Protagonist, Divinity, and Agent of Creativity, in «Marvels & Tales», 2002, 1, pp. 13-28.
77 JOSEPH RIVIÈRE, Recueil de contes populaires de la Kabylie du Djurdjura, Paris, Ernest Leroux, 1882, pp. 159 ss.
78 WILLIAM BERNARD MCCARTHY, Juan Bobo and the Riddling Princess: A Puerto Rican Folktale, in «Marvels & Tales», 2005, 2, pp. 295-302.
79 MARIA ANTONIETTA CARTA (ed.), Fiabe siriane, Milano, Mondadori, 1997, pp. 173 ss.
Giuseppe Gatto
182
partono per conquistare una principessa dont la main n’était pas facile à gagner. Il più giovane, un po’ sciocco, per strada si ferma a raccogliere un fondo di bottiglia, un uccello morto, un corno di bue. Si presentano l’uno dopo l’altro alla principessa, osservano che fa molto caldo, e quando lei dice: Oh!, pas encore si chaud qu’en haut de mon château, i primi due non capiscono e rinunciano. Il terzo invece: Bon!, dit le sot, j’y ferai donc cuire mon oiseau – Et dans quoi le mettras-tu? – Je le mettrai dans ce cul de bouteille – Mais dans quoi mettras-tu la sauce? – Je la mettrai dans cette corne. La principessa approva le risposte e decide che sarà lui suo marito80. In un racconto simile proveniente dall’Austria i doppi sensi sono ancora più spinti: una principessa è disposta a sposare solo chi saprà rispondere bene alle sue domande. I due figli maggiori di un contadino falliscono. Il terzo vuole provarci anche lui; lungo il cammino raccoglie un chiodo e un uovo. Ed ecco il dialogo con la principessa: J’ai du feu dans le corps. – Et moi, dit le garçon, j’ai un œuf dans mon sac; nous pour-rons le faire cuire. – Notre pôele a un trou. – Et moi, j’ai un clou; nous pourrons avec cela boucher le trou, ecc. Si celebra il matrimonio81.
È da osservare che questi ultimi racconti con variazioni oscene appartengono al citato tipo ATU 853 più che all’ATU 851. In un testo registrato in Toscana da Ga-stone Venturelli (Gli indovinelli) invece un giovane di famiglia poverissima vive prima le solite avventure del tipo 851 (focaccia avvelenata preparata dalla madre, morte del cavallo, tre corvi ecc...) e poi gli capitano gli “incidenti” del tipo 853: trova un chiodo e un uovo, e inoltre quando è già davanti al palazzo reale ha un gran mal di pancia e «fece i suoi bisogni dentro il cappello», coprendo il tutto con un fazzolet-to. Prima ancora che vengano proposti i tre indovinelli ha luogo un dialogo con la principessa punteggiato di espressioni oscene e scatologiche. I tre indovinelli poi non vengono risolti e la principessa, che non vorrebbe subire l’umiliazione di sposare quel pretendente, è costretta dal padre a rispettare i patti82.
Alcune considerazioni per concludere. L’elemento essenziale, caratterizzante, di questi racconti è costituito dagli osta-
coli da superare per accedere al matrimonio; e di questi ostacoli ci interessano parti-colarmente, e sono in effetti i più rappresentati, gli enigmi; ma non da soli: gli e-nigmi, in relazione con l’alternativa matrimonio o morte. Si tratta di indovinelli di tipo particolare: non appartengono al patrimonio tradizionale di una determinata comunità, ma sono costruiti da chi li propone, come “wisdom questions”83 (come è il
80 EMMANUEL COSQUIN, Contes populaires de Lorraine (1886), Arles, Éditions Philippe
Picquier, 2003, pp. 454-455. 81 Ibi, pp. 455-456. Il Cosquin segnala racconti analoghi inglesi, tedeschi, lituani... 82 GASTONE VENTURELLI, Leggende e racconti popolari della Toscana, Roma, Newton
Compton, 2006, pp. 197 ss. 83 ANNIKKI KAIVOLA-BREGENHØJ, Riddles. Perspectives on the use, function and change in
a folklore genre, Helsinki, Finnish Literature Society, 2001, p. 68.
Musica e tradizioni narrative: Turandot
183
caso degli enigmi di Turandot...), e spesso sulla base di esperienze che il proponente stesso ha vissuto, che solo lui conosce, e sono quindi senza possibilità di soluzione da parte di altri (come del resto l’enigma proposto da Calaf...). Nelle fiabe in parti-colare gli indovinelli nascono dalle vicende narrate dalla fiaba stessa, non sono un elemento a sé, ma sono «firmly embedded» in questi «riddle fairy tales»84. Inoltre, si tratta di indovinelli la cui soluzione, o la mancata soluzione, comportano conse-guenze non indifferenti: eventualmente la vita o la morte. Appartengono a quella categoria che Archer Taylor ha definito come «neck-riddle», riferendosi a quegli in-dovinelli che consentono a chi li propone di salvare il collo, di sfuggire alla morte85; ma oggi la definizione è ormai usata per qualunque indovinello proposto in un con-testo in cui si può perdere la vita o comunque si corre un rischio gravissimo86. Sotto questo profilo i nostri tipi 851 e 853 non sono isolati, ma sono all’interno di una rete narrativa di cui fanno parte anche il tipo ATU 927, Out-Ridling the Judge87, in cui un condannato ottiene la libertà perché il giudice non riesce a risolvere gli indovinel-li che l’imputato gli propone; il tipo ATU 812, The Devil’s Riddle88, in cui un uomo può sfuggire alle conseguenze del patto col diavolo se risolve gli indovinelli che que-sti gli propone; o ATU 1178, The Devil Outriddled89, in cui al contrario è l’uomo che propone enigmi che il diavolo non può risolvere, e così guadagna la salvezza.
Enigmi, si diceva, in relazione con l’alternativa matrimonio o morte. Già Alan Dundes osservava come non sia casuale il fatto che indovinelli siano
presenti nel contesto dei riti matrimoniali e funerari90; gli indovinelli, soprattutto quelli che Dundes stesso definiva «casual contradictive oppositional riddles»91, han-no una struttura che riflette quella di questi fatti sociali: mettono in relazione realtà distinte (un uomo e una donna, la vita e la morte), come già nella definizione aristo-telica (Poetica, 22: «Il principio dell’enigma è infatti proprio quello di collegare at-traverso la parola ciò che è impossibile collegare; cosa che, non essendo in grado di
84 MAX LÜTHI, Once upon a time. On the Nature of Fairy Tales, Bloomington and Indian-
apolis, Indiana University Press, 1976, pp. 123 e 131. 85 ARCHER TAYLOR, English Riddles from Oral Tradition, Berkeley, University of California
Press, 1951. Sul neck-riddle v. la monografia di ROGER D. ABRAHAMS, Between the Living and the Dead, FFC 225, Academia Scientiarum Fennica, 1980; e JOHN D. DORST, Neck-riddle as a Dialogue of Genres. Applying Bakhtin’s Genre Theory, in «Journal of American Folklore», 1983, pp. 413-433.
86 ELEANOR COOK, Enigmas and Riddles in Literature, Cambridge University Press, 2006, p. 119.
87 H.-J. UTHER, The Types of International Folktales…, cit., pp. 563 ss. 88 Ibi, pp. 453 ss. 89 Ibi, II, pp. 63 ss. 90 ALAN DUNDES, Texture, Text and Context, in IDEM, Interpreting Folklore, Bloomington,
Indiana University Press, 1980, pp. 20-32. 91 ROBERT A. GEORGES e ALAN DUNDES, Toward a Structural Definition of the Riddle, in
«Journal of American Folklore», 1963, pp. 111-118.
Giuseppe Gatto
184
farla con le altre parole, facciamo con le metafore»92). Per questo gli indovinelli sono stati considerati un modello in miniatura del matrimonio93; essi «combinent des non-combinables»94, costituiscono perciò «un linguaggio […] grazie al quale un gruppo dice ciò che pensa dell’azione sociale fondamentale: l’unione di un uomo e di una donna»95.
E nei nostri racconti la relazione con il matrimonio è evidentissima: tutto ruota intorno alla principessa che rifiuta le nozze e agli indovinelli che sono lo strumento per forzare la sua volontà e letteralmente costringervela. Tutto ciò sullo sfondo di una relazione indovinello-sessualità che è decisamente complessa: se in questi rac-conti l’indovinello è il passaggio attraverso cui il protagonista accede al matrimonio, il fatto che sia quasi sempre la principessa a porre la condizione del test degli enigmi porta in primo piano il loro valore come simbolo della verginità: è la barriera che la principessa pone tra se stessa e il matrimonio96. E nel quadro di questa relazione si colloca anche qualcosa che viene rivelato già dalla storia di Edipo: nel mito antico chi risolve l’enigma evita la morte, e al tempo stesso gli si apre la via a un matrimo-nio che è un incesto97. E l’incesto non è estraneo ai nostri racconti: in alcuni è il pa-dre che pone ostacoli per non interrompere la relazione incestuosa con la figlia, in altri il protagonista è il frutto di un incesto padre-figlia. Le storie cioè si muovono tra due poli opposti, entrambi caratterizzati da un eccesso: da un lato il rifiuto del rapporto uomo-donna, dall’altro l’esistenza di questo rapporto all’interno dello stes-so nucleo familiare.
E altrettanto evidente è il rapporto con la morte: il gioco dell’indovinello è un gioco terribile, ad alto rischio, come sottolineato fin dalla scena d’apertura del melo-dramma pucciniano. Valenza funebre che nelle fiabe è spesso messa in risalto dallo stesso contenuto dell’indovinello, dalle immagini di cui è intessuto, che sono appun-to immagini di morte. In questo contesto il tentato avvelenamento da parte della madre, e il suo fallimento, acquistano il significato di un preannuncio di ciò che av-verrà più tardi: è uno sfuggire alla morte che anticipa il momento in cui il protago-
92 ARISTOTELE, Poetica, 22, trad. e introd. di Guido Paduano, Roma-Bari, Laterza, 1998, p.
49. 93 A. DUNDES, Texture…, cit., pp. 24-25. 94 ELLI KÖNGÄS MARANDA, Structure des enigmes, in “L’Homme”, 1969, 3, pp. 5-48. 95 Ibi, p. 8. 96 KIMBERLY J. LAU, Structure, Society and Symbolism: Toward a Holistic Interpretation of
Fairy Tales, in “Western Folklore”, 1996, 3, pp. 233-243. Cfr. GÉZA RÓHEIM, Wedding Cere-monies in European Folklore, in «Samiksa: Journal of the Indian Psychoanalytical Society», 1954, pp. 137-173, poi in A. DUNDES (ed.), International Folkloristics. Classic Contributions by the Founders of Folklore, Lanham e Oxford, Rowman & Littlefield, 1999, pp. 197-230.
97 R. D. ABRAHAMS, Between the Living…, cit., pp. 19 ss., che rinvia a G. RÓHEIM, The Riddle of the Sphinx, London, Hogarth Press, 1934, il primo a trattare del rapporto tra l’indovinello e l’incesto. Su enigma e incesto sono importanti le osservazioni di CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Antropologia strutturale due, trad. it., Milano, Il Saggiatore, 1978, pp. 56-59.
Musica e tradizioni narrative: Turandot
185
nista affronterà di nuovo il rischio fatale nel confronto con la principessa, e di nuovo lo supererà98.
È da mettere in rilievo infine come il rapporto non sia separatamente tra l’indovinello e il matrimonio o tra l’indovinello e la morte, ma simultaneamente con l’alternativa matrimonio-morte; ed è stato osservato come il matrimonio comporti spesso una simbologia di morte, dello sposo o della sposa, e come nelle aree in cui è diffuso il tipo ATU 851 la simbologia riguardi la donna: il pretendente evita la mor-te e si sposa; la donna invece è costretta a rinunciare al suo rifiuto del matrimonio99.
* * *
Quanto precede non è ovviamente e non voleva essere uno studio musicologico;
mia intenzione era solo dare un’idea delle dimensioni dell’iceberg la cui punta splen-didamente visibile è costituita dalla Turandot di Puccini100.
Resta ovviamente compito dei musicologi leggere gli echi e gli influssi di altre opere e altri compositori: dal Flauto magico di Mozart all’Otello di Verdi, dal Boris Godunov di Mussorgsky alla Elektra di Strauss; segno, la presenza di questi echi, dell’apertura di Puccini non solo alla grande tradizione, ma anche alle voci nuove del discorso musicale europeo.
Tutto questo è appunto di competenza dei musicologi, come spetta ai musicolo-gi – e agli ascoltatori? – decidere se Turandot «is undoubtedly one of the greatest operas written in the twentieth century»101, fino a che punto è «a work that looks simultaneously forwards and backwards»102, ed eventualmente ammirarne il «superb degree of cohesion»103, o porsi il problema di come rispondere alla domanda di Isa-belle Mondriot: «Un opéra manqué?»104.
98 C. GOLDBERG, Turandot’s Sisters …, cit., p. 113. 99 K. J. LAU, Structure, Society and Symbolism..., cit., pp. 236 ss. 100 Un andare oltre rispetto al pur pregevole studio di ROBERT AUBANIAC, La légende de la
Princesse Cruelle, des origines à Puccini, in «L’Avant-Scène Opéra», n. cit., pp. 74-81. 101 CHARLES OSBORNE, The Opera Lover’s Companion, New Haven and London, Yale
University Press, 2004, p. 352. 102 ALEXANDRA WILSON, The Puccini Problem. Opera, Nationalism and Modernity, Cam-
bridge University Press, 2007, p. 193. 103 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Oxford University Press, 2004(2a
edizione), s.v. “Puccini”. 104 ISABELLE MONDRIOT, Mortelles énigmes, in «L’Avant-Scène Opéra», n. cit., pp. 70-73.